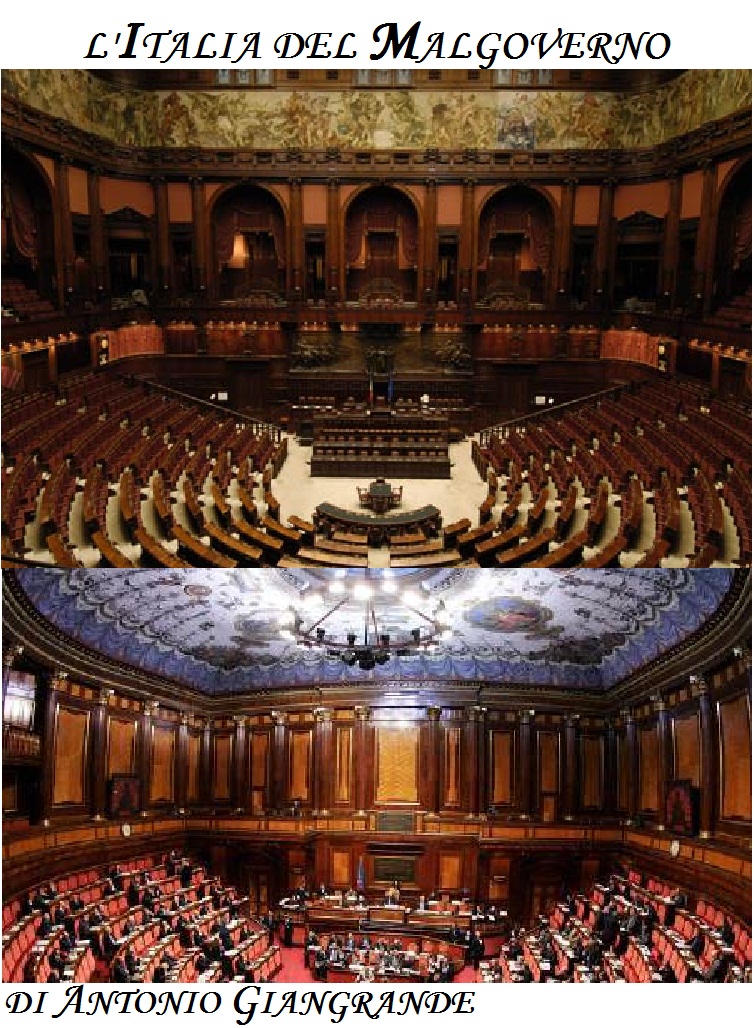Denuncio al mondo ed ai posteri con i miei libri tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del 1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica, discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e censurato. Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per quello che scrivo i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la fonte. Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare per potermi mantenere. Non vivo solo di aria: Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a: ANTONIO GIANGRANDE, VIA MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601 - CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
versamento in bollettino postale sul c.c. n. 92096221. intestato a: ANTONIO GIANGRANDE, VIA MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
![]()
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE: CONTROTUTTELEMAFIE - MALAGIUSTIZIA - TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi) ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE - TELE WEB ITALIA
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine) GIANGRANDE LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
GOVERNOPOLI
SECONDA PARTE
DI ANTONIO GIANGRANDE
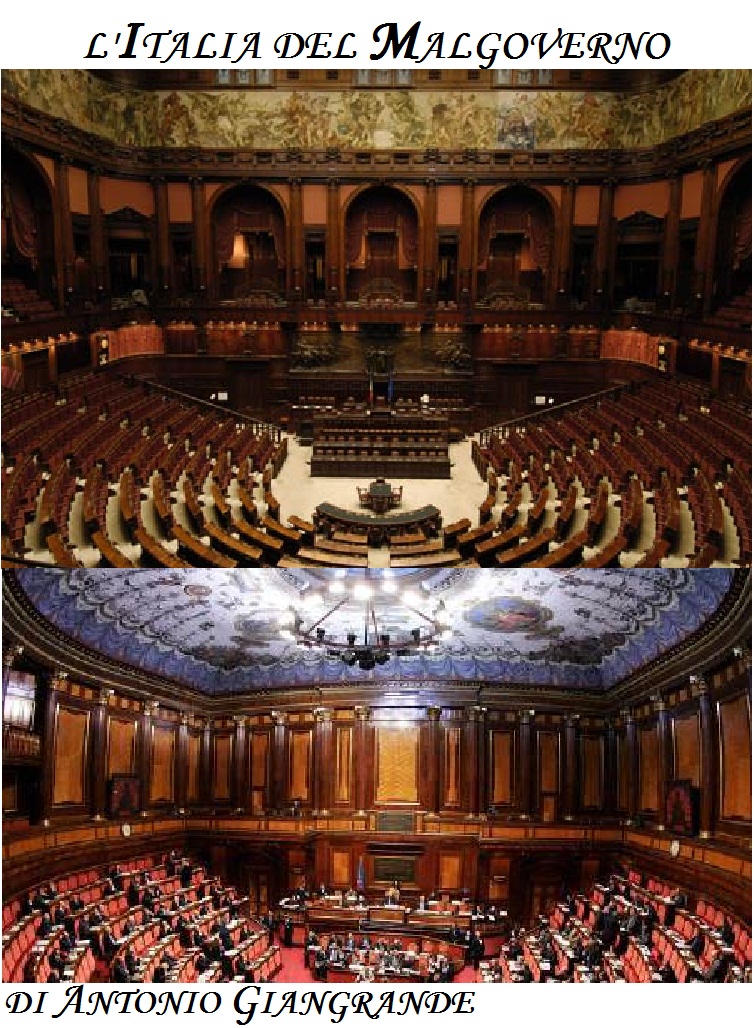
L’ITALIA DEL MALGOVERNO,
OSSIA, LA POLITICA COME ESEMPIO DI MORALITA’
TIRANNIDE indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
"Art. 1 della Costituzione: L’ Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (non sulla libertà e la giustizia). La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. (I limiti stabiliti al potere popolare indicano una sudditanza al sistema di potere. Il potere popolare è delegato ai Parlamentari e agli organi da questi nominati: Presidente della Repubblica, Governo, organi di Garanzia e Controllo. La Magistratura è solo un Ordine Costituzionale: non ha un potere delegato, ma una funzione attribuita per pubblico concorso. In realtà si comporta come Dio in terra: giudica, ingiudicata).
Un'Italia tenuta al guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobby, mafie e massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere. La “Politica” deve essere legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge, vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed istituzionale per incapacità o per collusione. Così come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione.
l'Italia sia una repubblica democratica e federale fondata sulla Libertà e la Giustizia. I cittadini siano tutti uguali e solidali.
I rapporti tra cittadini e tra cittadini e Stato siano regolati da un numero ragionevole di leggi, chiare e coercitive.
Le pene siano mirate al risarcimento ed alla rieducazione, da scontare con la confisca dei beni e con lavori socialmente utili. Ai cittadini sia garantita la libera nomina del difensore o l'autodifesa personale, se capace, ovvero il gratuito patrocinio per i poveri. Sia garantita un'indennità e una protezione alla testimonianza.
Sia garantita la scusa solenne e il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, al cittadino vittima di offesa o violenza di funzionari pubblici, di ingiusta imputazione, di ingiusta detenzione, di ingiusta condanna, di lungo o ingiusto processo.
Sia garantita a tutti ogni garanzia di accesso al credito per meritevoli finalità economiche o bisogni familiari necessari.
Sia libera ogni attività economica, professionale, sociale, culturale e religiosa. Il sistema scolastico o universitario assicuri l'adeguata competenza, senza vincoli professionali di Albi, Ordini, Collegi, ecc. Il libero mercato garantirà il merito. Le scuole o le università siano rappresentate da un preside o un rettore eletti dagli studenti o dai genitori dei minori. Il preside o il rettore nomini i suoi collaboratori, rispondendo delle loro azioni.
Lo Stato assicuri ai cittadini ogni mezzo per una vita dignitosa.
Ai disabili sia garantita l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità dei luoghi di transito o stazionamento.
Il lavoro subordinato pubblico e privato sia remunerato secondo efficienza e competenza.
Lo Stato chieda ai cittadini il pagamento di un unico tributo, secondo il suo fabbisogno, sulla base della contabilità centralizzata desunta dai dati incrociati forniti telematicamente dai contribuenti, con deduzioni proporzionali e detrazioni totali. Agli evasori siano confiscati tutti i beni. Lo Stato assicuri a Regioni e Comuni il sostentamento e lo sviluppo.
Sia libera la parola, con diritto di critica, di cronaca, d'informare e di essere informati, così come sia libero l'esercizio della stampa da vincoli di Albi, Ordini e collegi.
I senatori e i deputati, il capo del governo, i magistrati, i difensori civici siano eletti dai cittadini con vincolo di mandato. Essi rappresentino, amministrino, giudichino e difendano secondo imparzialità, legalità ed efficienza in nome, per conto e nell'interesse dei cittadini. Essi siano responsabili delle loro azioni e giudicati e condannati. Gli amministratori pubblici nominino i loro collaboratori, rispondendone del loro operato.
Il difensore civico difenda i cittadini da abusi od omissioni amministrative, giudiziarie, sanitarie o di altre materie di interesse pubblico.
Il Parlamento voti e promulghi le leggi propositive e abrogative proposte dal Governo, da uno o più parlamentari, da una Regione, da un comitato di cittadini".
di Antonio Giangrande
SOMMARIO I PARTE
UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
INTRODUZIONE
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
ITALIA. DEMOCRAZIA COL BROGLIO.
AI MIEI TEMPI...AI MIEI TEMPI...
COS’E’ LA POLITICA OGGI?
LA LUNGA STORIA DEI POPULISMI.
IL POLITICAMENTE CORRETTO. LA NUOVA RELIGIONE DELLA SINISTRA.
PARLIAMO DI LEGALITA'. LA REPUBBLICA DI ZALONE E DI FICARRA E PICONE.
LA MORALITA' DEGLI UOMINI SUPERIORI.
A MIA INSAPUTA. QUELLI CHE NON SANNO.
L’ITALIA E LE RIVOLUZIONI A META’.
C'ERA UNA VOLTA LA SINISTRA. LA SINISTRA E' MORTA.
LA DIFFERENZA TRA LA POLITICA DEI MODERATI E L'INTERESSE PRIVATO DEI COMUNISTI.
IL TRAVESTITISMO.
C'ERA UNA VOLTA LA DESTRA.
C’ERANO UNA VOLTA I LIBERALI.
LA RIVOLUZIONE CULTURALE DA TENCO A PASOLINI, DA TOTO’ A BONCOMPAGNI.
MAI NULLA CAMBIA. 1968: TRAGICA ILLUSIONE.
1977: LA RIVOLUZIONE ANTICOMUNISTA.
FASCISTI-COMUNISTI PER SEMPRE.
L'ITALIA ANTIFASCISTA.
MALEDETTO 25 APRILE.
PRIMO MAGGIO. FESTA DEI LAVORATORI: SOLITA LITURGIA STANTIA ED IPOCRITA.
LA FINE DELLA DEMOCRAZIA.
IL COMUNISMO, IL FASCISMO ED I 5 STELLE: LA POLITICA COL VINCOLO DI MANDATO.
DEMOCRAZIA: LA DITTATURA DELLE MINORANZE.
LE DONNE (DI IERI E DI OGGI) PIÙ IMPORTANTI E BELLE DELLA POLITICA ITALIANA.
GLI ULTIMI 25 ANNI DEGLI ITALIANI.
IL LIMBO LEGISLATIVO. LE LEGGI TEORICHE.
LA REPUBBLICA GIUDIZIARIA, ASPETTANDO LA TERZA REPUBBLICA.
IL PARTITO DELLE MANETTE COL CULO DEGLI ALTRI.
STORIA DELL’AMNISTIA.
I TRADITORI, OSSIA I FRANCHI TIRATORI.
LE FAKE NEWS DEL CONTRO-REGIME.
LA DEMERITOCRAZIA.
IN QUESTO MONDO DI LADRI.
CHI FA LE LEGGI?
I PEONES DEL PARLAMENTO.
"PADRI DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA NOSTRA ROVINA.
MAFIA, PALAZZI E POTERE.
MAFIA DEMOCRATICA.
BUROCRAZIA. LA DITTATURA DEI BUROCRATI.
LO STATO STA CON I LADRI. OVVIO SONO COLLEGHI!
LA LIBERTA'.
LA DEMOCRAZIA E' PASSATA DI MODA?
A PROPOSITO DI TIRANNIDE. COME E QUANDO E' MORTO HITLER?
L'ANTIPOLITICA E L'ASTENSIONISMO.
L’ANTIPOLITICA E LE SUE VITTIME. IL PACIFISMO.
IL PARTITO INVISIBILE. ASTENSIONISMO, VOTO MIGRANTE E VOTO DI PROTESTA: I MOTIVI DI UNA DEMOCRAZIA INESISTENTE.
E’ STATO LA MAFIA!
ITALIA MAFIOSA. IL PAESE DEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA SE AMMINISTRATI DALL’OPPOSIZIONE DI GOVERNO.
LEZIONE DI MAFIA.
DEMOCRAZIA A SINISTRA. VOTI TRUCCATI, ELEZIONI TAROCCATE.
I DEBITI SI PAGANO, ANCHE IN GRECIA !!!
POLITICA E SPETTACOLO: DIETRO LA MASCHERA C'E' IL NULLA.
E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.
IL MONDO SEGRETO DEGLI ITALIOTI.
IL MONDO SEGRETO DELLE CASTE E DELLE LOBBIES.
IL MONDO DEI TRASFORMISTI.
IL MONDO DELLE CRICCHE.
I MEDIA ED I LORO PECCATI: DISINFORMAZIONE, CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.
PER UNA LETTURA UTILE E CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.
POLITICA, GIUSTIZIA ED INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE VERGINELLE.
LA REPUBBLICA DELLE MANETTE.
TUTTI DENTRO CAZZO!
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI.
ITALIA PAESE DELL’IMMUNITA’ E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.
STATO DI DIRITTO?
CHI E’ IL POLITICO?
CHI E’ L’AVVOCATO?
DELINQUENTE A CHI? CHI E’ IL MAGISTRATO?
DUE PAROLE SULLA MAFIA. QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
CARMINE SCHIAVONE. LA VERA MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
2 OTTOBRE 2013. LE GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.
ITALIA DA VERGOGNA.
ITALIA BARONALE.
CASA ITALIA.
ITALIA. SOLIDARIETA’ TRUCCATA E DI SINISTRA.
LA GUERRA TRA ASSOCIAZIONI ANTIRACKET.
ITALIA: PAESE ZOPPO.
QUANDO I BUONI TRADISCONO.
DUE COSE SU AMNISTIA, INDULTO ED IPOCRISIA.
FACILE DIRE EVASORE FISCALE A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN E MARADONA.
ANCHE GESU' E' STATO CARCERATO.
ANCHE GLI STUDENTI SONO UNA CASTA.
QUANTO SONO ATTENDIBILI LE COMMISSIONI D’ESAME?
LO STATO CON LICENZA DI TORTURARE ED UCCIDERE.
27 NOVEMBRE 2013. LA DECADENZA DI BERLUSCONI.
FIGLI DI QUALCUNO E FIGLI DI NESSUNO.
LA TERRA DEI CACHI, DEI PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.
LO SPRECO DI DENARO PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.
SONO BRAVI I COMUNISTI. NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.
MENTRE PER LE LOBBIES LE PORTE SONO SEMPRE APERTE.
LA LOBBY DEI DENTISTI E LA MAFIA ODONTOIATRICA.
UNIONE EUROPEA: ITALIA 60 MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?
FATTI DI CRONACA, DISFATTI DI GIUSTIZIA.
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO ARRIVA LA PREDICA, SE LO STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?
L’ITALIA, IL PAESE DEI NO. LA SINDROME DI NIMBY.
L’ITALIA DEI COLPI DI STATO.
PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.
NON VI REGGO PIU’.
BELLA ITALIA, SI’. MA ITALIANI DEL CAZZO!!!
FENOMENOLOGIA RANCOROSA DELL’INGRATITUDINE.
SE NASCI IN ITALIA…
DIRITTO E GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.
GIUSTIZIA DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.
L’ANTIMAFIA DEI RECORD.
LA CHIAMANO GIUSTIZIA, PARE UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI TESTIMONI.
LA VERA MAFIA: LO STATO ESTORTORE E CORROTTO.
LA VERA MAFIA E’ LO STATO. E PURE I GIORNALISTI? DA ALLAM ALLA FALLACI.
MAFIA E TERRORISMO DA QUALE PULPITO VIEN LA PREDICA. L’ITALIA CODARDA ED IL PATTO CON IL DIAVOLO. MEGLIO PAGARE IL PIZZO.
SOMMARIO II PARTE
PROFESSIONE PORTAVOCE E PORTABORSE: CHE DOLORI...
L'AGIT-PROP, OSSIA, "L'AGITAZIONE E LA PROPAGANDA".
GLI SPIN DOCTOR. PERSUASORI DEI GOVERNI.
GLI INFLUENCER.
LE SOLITE FAKE NEWS DEI MEDIA DI REGIME.
LE FAKE NEWS DEL CONTRO-REGIME.
MAGISTRATI: FACCIAMO QUEL CHE VOGLIAMO!
GUERRA DI TOGHE. ANCHE I MAGISTRATI PIANGONO.
ANCHE BORSELLINO ERA INTERCETTATO.
TANGENTI: CORRUZIONE E COLLUSIONI. LA STORIA SCRITTA DAI VINCITORI.
CORRUZIONE A NORMA DI LEGGE.
IL SUD TARTASSATO.
DISSERVIZI A PAGAMENTO.
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
LA PATRIA DELLA CORRUZIONE.
LE BUGIE DEI POLITICANTI CHE SCHIAVIZZANO I NOSTRI GIOVANI.
MINISTRI. UNA IMPUNITA' TUTTA PER LORO.
PER GLI ONOREVOLI...NON C'E' FRETTA.
LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA.
CITTADINI. MANIFESTARE E DEVASTARE. IMPUNITA’ CERTA.
LA SCUOLA DELL'INDOTTRINAMENTO IDEOLOGICO.
L’ISLAM, LA SINISTRA E LA SOTTOMISSIONE.
LA VERA MAFIA E’ LO STATO. E PURE I GIORNALISTI? DA ALLAM ALLA FALLACI.
INCOSCIENTI DA SALVARE? COME SI FINANZIA IL TERRORISMO ISLAMICO.
IL BUSINESS DEGLI ABITI USATI.
COME SIAMO O COME CI HANNO FATTI DIVENTARE.
MILANO: DA CAPITALE MORALE A CAPITALE DEL CAZO.
IL DUALISMO MILANO ROMA. LA RIVALITA' TRA DUE METROPOLI IN SOSTANZA UGUALI NEL DELINQUERE.
L’INTELLIGENZA E’ DI SINISTRA?
L'UGUAGLIANZA E L’INVIDIA SOCIALE.
GLI INTOCCABILI E LA SOCIETA’ DELLE CASTE.
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO: LITURGIA APPARISCENTE, AUTOREFERENZIALE ED AUTORITARIA.
COME TI GABBO IL POPOLINO. RIFORMA FARLOCCA DELLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.
POTENTE UGUALE IMPUNITO.
AMMINISTRATORI SOTTO ATTACCO.
DETENUTO SUICIDA IN CARCERE? UNO DI MENO!!!
BENI CONFISCATI ALLA MAFIA: FACCIAMO CHIAREZZA! NON E’ COSA LORO!
IL BUSINESS DEI BEI SEQUESTRATI E CONFISCATI.
USURA ED ESTORSIONE: CONVIENE DENUNCIARE? RISPONDONO LORO. ANTONIO GIANGRANDE. PINO MANIACI E MATTEO VIVIANI DE LE IENE PER I FRATELLI CAVALLOTTI E L'ITALGAS. FRANCESCO DIPALO. LUIGI ORSINO. PINO MASCIARI. COSIMO MAGGIORE. LUIGI COPPOLA. LUIGI LEONARDI. TIBERIO BENTIVOGLIO. IGNAZIO CUTRO'.
MAI DIRE MAFIA. FRANCESCO CAVALLARI E LA SFIDUCIA NEI MAGISTRATI.
E POI PARLIAMO DELL'ILVA.
EQUITALIA. STROZZINI DI STATO.
CONCORSI ED ESAMI. LE PROVE. TRUCCO CON I TEST; TRUCCO CON GLI ELABORATI.
SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO.
USURA BANCARIA: I MAGISTRATI STANNO CON LE BANCHE.
CORRUZIONE NEL CUORE DELLO STATO.
COSI' HANNO TRUFFATO DI BELLA.
GIUDICI SENZA CONDIZIONAMENTI?
A PROPOSITO DI RIMESSIONE DEL PROCESSO ILVA. ISTANZA RESPINTA: DOVE STA LA NOTIZIA?
CALABRIA: LUCI ED OMBRE. COME E' E COME VOGLIONO CHE SIA. "NDRANGHETISTI A 14 ANNI E PER SEMPRE.
I TRIBUNALI PROPRIETA' DEI GIUDICI.
LA BANDA DEGLI ONESTI E MAFIA CAPITALE.
QUANTI GUAI CON LA GIUSTIZIA PER GLI EX AN.
IL PARLAMENTO DEI PRIVILEGI E DEI POMPINI AI COMMESSI.
A PROPOSITO DI COMMESSI PARLAMENTARI E DEI LORO STIPENDI.
L’ITALIA COME LA CONCORDIA. LA RESPONSABILITA’ DELLA POLITICA.
ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO BISIO.
LA CASTA VIEN DA LONTANO.
ITALIA. NAZIONE DI LADRI E DI IMBROGLIONI.
PARLAMENTARI SENZA ARTE NE' PARTE. COME DA POVERI SI DIVENTA MILIONARI.
LA POLEMICA SULLA NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E DEGLI SCRUTATORI.
LA VITTORIA CENSURATA DEL PARTITO DEL NON VOTO.
IL BERLUSCONI INVISO DA TUTTI.
LA DEMOCRAZIA SOTTO TUTELA: ELEZIONI CON ARRESTO.
L’ITALIA DEI PAZZI. UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SULLA BUROCRAZIA. CANCELLATE 10 LEGGI, NE NASCONO 12.
GIUSTIZIA E POLITICA MADE IN SUD.
BUROCRAZIA E DISSERVIZI. IL SUPPLIZIO DEGLI ITALIANI.
LO STATO DELLA CASTA: COME EVADE LE TASSE E COME TRUFFALDINAMENTE SI FINANZIA.
LO SPRECO DELLA CARTA PARLAMENTARE.
IL PAESE DELLE STAZIONI FANTASMA.
IL PARLAMENTO DEI POMPINI E DELLE BOTTE DA ORBI.
MAI DIRE MAFIA: IL CALVARIO DI ANTONIO GIANGRANDE.
E LA CHIAMANO GIUSTIZIA. CHE CAZZO DI INDAGINI SONO?
IL SEGRETO DI PULCINELLA. LA MAFIA E’ LO STATO.
TUTTO IL POTERE A TOGA ROSSA.
GIUDICI IMPUNITI.
PERCHE’ I REFERENDUM ABROGATIVI SONO UNA STRONZATA.
C’E’ UN GIUDICE A BERLINO!
IL PAESE DEL GARANTISMO IMMAGINARIO.
I GIOVANI VERGINELLI ATTRATTI DAL GIUSTIZIALISMO.
MAGISTRATI? SI', COL TRUCCO!!
MANETTE FACILI, IDEOLOGIA ED OMICIDI DI STAMPA E DI STATO: I PROCESSI TRAGICOMICI.
LA VERITA’ NON E’ UGUALE PER TUTTI.
PARLIAMO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESCO COSSIGA: TRA GLI ITALIOTI UOMO SOLO CONTRO LO STRAPOTERE DELLA MAGISTRATURA.
MENZOGNE DI STATO. DOVE VANNO A FINIRE I NOSTRI SOLDI?
LA TRUFFA DEI CONCORSI PUBBLICI E DELLA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI.
COSTITUZIONE ITALIANA: COSTITUZIONE MASSONICA.
APOLOGIA DELLA RACCOMANDAZIONE. LA RACCOMANDAZIONE SEMPLIFICA TUTTO.
LA STRATEGIA DELLA TENSIONE: TERRORISTICA E GIUDIZIARIA.
GLI INNI DEI PARTITI ED I PENTITI DEL PENTAGRAMMA.
ED I 5 STELLE...STORIE DI IGNORANZA.
ED I LIBERALI? SOLO A PAROLE.
POPULISTA A CHI?!?
LA CASTA CORROTTA E SFRUTTATRICE.
LA CASTA ASSENTEISTA.
LA CASTA PERSEGUITATA ED INETTA. SE SUCCEDE A LORO…FIGURIAMOCI AI POVERI CRISTI.
CASTA SENZA VERGOGNA.
CASTA ANTICASTA.
BEPPE GRILLO ANTI CASTA ED ANTI LOBBY? MA MI FACCIA IL PIACERE!!!!
PAGARE LE TASSE: SI’, MA PERCHE’?
PARLIAMO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA.
ISTITUZIONI, LEGALITA' E MORALITA'
PARLIAMO DI VOTO DI SCAMBIO IN PARLAMENTO: NATURALMENTE IMPUNITO!
PARLIAMO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO.
LA CASTA DEI TESORIERI DI PARTITO.
IL PARLAMENTO DEGLI INQUISITI.
GLI IMPRESENTABILI, SE LI CONOSCI, LI EVITI: IN TUTTI I PARTITI.
RISSE PARLAMENTARI.
VOTI NOSTRI.
ROBA NOSTRA.
NOMINATI ED ASSENTI. IL PARLAMENTARE NON RISPONDE ALLE E-MAIL.
SCRANNI VUOTI, PIANISTI, RISSE. ECCO L’ESERCITO DEGLI ASSENTEISTI.
CASA NOSTRA.
PAPPONI DI STATO.
PRIVILEGI E BENEFITS.
ENNESIMO RICORSO AL GOVERNO CONTRO I CONCORSI FORENSI TRUCCATI, INVIATO PER CONOSCENZA AI 630 DEPUTATI, AI 320 SENATORI, AI 72 PARLAMENTARI EUROPEI. RISULTATO: LETTERA MORTA.
RICORSO ALLE ISTITUZIONI CONTRO GLI INSABBIAMENTI.
RICORSO MINISTERIALE CONTRO GLI INSABBIAMENTI.
DENUNCIA PENALE AL CSM CONTRO GLI INSABBIAMENTI.
ESPOSTO ALLE ISTITUZIONI CONTRO GLI INSABBIAMENTI.
UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande)
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Tra i nostri avi abbiamo condottieri, poeti, santi, navigatori,
oggi per gli altri siamo solo una massa di ladri e di truffatori.
Hanno ragione, è colpa dei contemporanei e dei loro governanti,
incapaci, incompetenti, mediocri e pure tanto arroganti.
Li si vota non perché sono o sanno, ma solo perché questi danno,
per ciò ci governa chi causa sempre e solo tanto malanno.
Noi lì a lamentarci sempre e ad imprecare,
ma poi siamo lì ogni volta gli stessi a rivotare.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Codardia e collusione sono le vere ragioni,
invece siamo lì a differenziarci tra le regioni.
A litigare sempre tra terroni, po’ lentoni e barbari padani,
ma le invasioni barbariche non sono di tempi lontani?
Vili a guardare la pagliuzza altrui e non la trave nei propri occhi,
a lottar contro i più deboli e non contro i potenti che fanno pastrocchi.
Italiopoli, noi abbiamo tanto da vergognarci e non abbiamo più niente,
glissiamo, censuriamo, omertiamo e da quell’orecchio non ci si sente.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Simulano la lotta a quella che chiamano mafia per diceria,
ma le vere mafie sono le lobbies, le caste e la massoneria.
Nei tribunali vince il più forte e non chi ha la ragione dimostrata,
così come abbiamo l’usura e i fallimenti truccati in una giustizia prostrata.
La polizia a picchiare, gli innocenti in anguste carceri ed i criminali fuori in libertà,
che razza di giustizia è questa se non solo pura viltà.
Abbiamo concorsi pubblici truccati dai legulei con tanta malizia,
così come abbiamo abusi sui più deboli e molta ingiustizia.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Abbiamo l’insicurezza per le strade e la corruzione e l’incompetenza tra le istituzioni
e gli sprechi per accontentare tutti quelli che si vendono alle elezioni.
La costosa Pubblica Amministrazione è una palla ai piedi,
che produce solo disservizi anche se non ci credi.
Nonostante siamo alla fame e non abbiamo più niente,
c’è il fisco e l’erario che ci spreme e sull’evasione mente.
Abbiamo la cultura e l’istruzione in mano ai baroni con i loro figli negli ospedali,
e poi ci ritroviamo ad essere vittime di malasanità, ma solo se senza natali.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Siamo senza lavoro e senza prospettive di futuro,
e le Raccomandazioni ci rendono ogni tentativo duro.
Clientelismi, favoritismi, nepotismi, familismi osteggiano capacità,
ma la nostra classe dirigente è lì tutta intera da buttà.
Abbiamo anche lo sport che è tutto truccato,
non solo, ma spesso si scopre pure dopato.
E’ tutto truccato fin anche l’ambiente, gli animali e le risorse agro alimentari
ed i media e la stampa che fanno? Censurano o pubblicizzano solo i marchettari.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Gli ordini professionali di istituzione fascista ad imperare e l’accesso a limitare,
con la nuova Costituzione catto-comunista la loro abolizione si sta da decenni a divagare.
Ce lo chiede l’Europa e tutti i giovani per poter lavorare,
ma le caste e le lobbies in Parlamento sono lì per sé ed i loro figli a legiferare.
Questa è l’Italia che c’è, ma non la voglio, e con cipiglio,
eppure tutti si lamentano senza batter ciglio.
Che cazzo di Italia è questa con tanta pazienza,
non è la figlia del rinascimento, del risorgimento, della resistenza!!!
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Questa è un’Italia figlia di spot e di soap opera da vedere in una stanza,
un’Italia che produce veline e merita di languire senza speranza.
Un’Italia governata da vetusti e scaltri alchimisti
e raccontata sui giornali e nei tg da veri illusionisti.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma se tanti fossero cazzuti come me, mi piacerebbe tanto.
Non ad usar spranghe ed a chi governa romper la testa,
ma nelle urne con la matita a rovinargli la festa.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Rivoglio l’Italia all’avanguardia con condottieri, santi, poeti e navigatori,
voglio un’Italia governata da liberi, veri ed emancipati sapienti dottori.
Che si possa gridare al mondo: sono un italiano e me ne vanto!!
Ed agli altri dire: per arrivare a noi c’è da pedalare, ma pedalare tanto!!
Antonio Giangrande (scritta l’11 agosto 2012)
SECONDA PARTE
PROFESSIONE PORTAVOCE E PORTABORSE: CHE DOLORI...
Professione portavoce. Che dolori…, scrive Francesco Damato il 25 Settembre 2018 su "Il Dubbio".
IL RACCONTO. Non ditelo, per favore, a Rocco Casalino perché potrebbe montarsi la testa, e fare chissà quali altri bizzarrie o provocare chissà quali altre polemiche come portavoce del presidente del Consiglio. O potrebbe cadere in depressione sapendo di quanti lo hanno preceduto senza riuscire a cambiare il corso degli eventi politici, sviluppatisi nel bene e nel male a prescindere dal suo omologo di turno. Direttamente o indirettamente di portavoce di governo e oltre, e di segretari di partito, arrivati o non a Palazzo Chigi o al Quirinale, o passativi solo come interlocutori, ne ho conosciuti e sperimentati un centinaio. Il più influente di tutti è stato anche il più lontano dallo stile e dalle tentazioni di Casalino, non foss’altro per ragioni scientifiche, diciamo così. Mancavano ai tempi di Nino Valentino, il portavoce del presidente della Repubblica Giovanni Leone, i maledetti telefonini e varianti di oggi, a usare i quali la tua voce e i tuoi sfoghi, insulti, minacce e quant’altro finiscono in rete e ti fanno rischiare la destituzione, magari dopo una prima solidarietà o copertura, come quella non mancata a Casalino. Che Conte e il capo formale dei grillini, Luigi Di Maio, hanno difeso dagli attacchi procuratigli dal proposito imprudentemente confessato di farla pagare cara, quando verrà il momento, ai dirigenti del Ministero dell’Economia contrari, sino al sabotaggio, al programma di spese in deficit datosi dal governo gialloverde. Giovanni Leone si fidava a tal punto di Nino Valentino, un funzionario erudito e riservato di Montecitorio conosciuto quando il giurista napoletano era presidente della Camera, da delegargli compiti politici che sorpresero, a dir poco, la delegazione democristiana recatasi nella sua abitazione nel dicembre del 1971 per comunicargli la candidatura al Quirinale. Era ormai fallita la lunga corsa del presidente del Senato Amintore Fanfani ed era sopraggiunto anche il no opposto per pochi voti, a scrutinio segreto, dai parlamentari dello scudo crociato ad Aldo Moro, allora ministro degli Esteri e già segretario del partito e presidente del Consiglio. “Parlatene pure col buon Valentino”, disse Leone ai dirigenti della Dc che lo invitavano a prepararsi agli effetti politici della sua elezione, largamente prevedibili per la rottura intervenuta proprio sulla successione al Quirinale col partito socialista guidato da Giacomo Mancini. Bisognava mettere nel conto una crisi di governo e un turno di elezioni anticipate, utile anche a rinviare non di uno ma di due anni lo scomodissimo referendum contro la legge sul divorzio. Che la Dc avrebbe perduto nel 1974 compromettendo il ruolo centrale conquistato nelle elezioni storiche del 18 aprile 1948.I fatti furono più forti della buona volontà e delle relazioni di cui era capace Valentino. Che nel 1977 preferì farsi assegnare la segreteria generale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro piuttosto che rimanere nell’ultimo anno del mandato del Quirinale, peraltro interrotto anticipatamente di sei mesi con le dimissioni imposte a Leone dai due partiti maggiori – la Dc e il Pci – e dal governo monocolore democristiano di Giulio Andreotti che ne dipendeva in Parlamento. Il povero Valentino si era speso inutilmente dietro e davanti alle quinte per difendere il suo presidente dal fango di una campagna denigratoria conclusasi nei tribunali a suo vantaggio, ma dopo ch’egli era stato sfrattato dal Quirinale, una volta venutagli a mancare con la morte per mano delle brigate rosse la difesa di Moro. Per la cui liberazione dalla prigione dei terroristi, peraltro, Leone aveva deciso di sfidare la linea della cosiddetta fermezza predisponendosi alla grazia per una dei tredici detenuti con i quali i sequestratori del presidente della Dc avevano reclamato di scambiare l’ostaggio. Tutt’altro profilo, quello di un semplice passa parola, ebbe il portavoce del successore di Leone al Quirinale: il simpatico Antonio Ghirelli, scelto d’istinto, proprio per la sua simpatia e per la colleganza professionale di giornalista, da Sandro Pertini. Che però, molto più realista o meno sensibile di quanto non lasciasse trasparire pubblicamente, non esitò a sacrificarlo due anni dopo, destituendolo durante una visita ufficiale a Madrid. Ai giornalisti che si erano radunati davanti all’albergo per chiedergli clemenza per il collega, appena invitato a rientrare a Roma coi propri mezzi, Pertini rispose con il pollice verso, come se fosse al Colosseo nei panni di un imperatore romano. Il povero Ghirelli aveva fatto le spese di una intemerata romana dell’allora segretario della Dc Flaminio Piccoli. Che aveva protestato contro l’opinione di Pertini, espressa dalla Spagna e riferita da Ghirelli ai colleghi, che il presidente del Consiglio Francesco Cossiga dovesse dimettersi per il procedimento d’incolpazione in corso in Parlamento con l’accusa di avere favorito la latitanza di un figlio terrorista del collega di partito Carlo Donat– Cattin. Al quale invece Cossiga riteneva di avere solo consigliato di indurre il figlio Marco, se avesse avuto modo di contattarlo, a consegnarsi spontaneamente alla polizia per l’uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, avvenuta a Milano l’anno prima. Consapevole di avere addebitato a torto a Ghirelli il suo giudizio su Cossiga, il presidente Pertini colse la prima occasione che gli capitò per ripararvi, ma solo dopo tre anni, nel 1983. Quando Bettino Craxi formò il suo primo governo, fallito il tentativo compiuto nel 1979 di approdare a Palazzo Chigi, fu proprio Pertini a raccomandargli come portavoce Ghirelli. Che si rivelò con Bettino tanto leale quanto efficace nel segnalargli tempestivamente agguati, come quello che stava compiendo silenziosamente la sinistra democristiana nel 1985 boicottando la campagna referendaria sui tagli alla scala mobile contestati dal Pci. Per rianimare un appuntamento con le urne che rischiava l’indifferenza Ghirelli improvvisò a pochi giorni dal voto a Palazzo Chigi una conferenza stampa in cui Craxi rialzò la posta in gioco avvertendo che avrebbe aperto la crisi di governo, con le dimissioni, “un minuto dopo” l’eventuale sconfitta. Che non arrivò anche per effetto di quel monito. Per tornare al Quirinale, dopo Pertini fu la volta di Francesco Cossiga. Che, anziché richiamare Luigi Zanda, suo portavoce negli anni tragici trascorsi al Viminale, e sfociati nel sequestro di Moro, scelse come portavoce il diplomatico Ludovico Ortona, rimasto afono per un bel po’ di tempo, al pari del presidente, sino alla svolta improvvisa e profonda delle picconate. Una svolta gestita interamente dal capo dello Stato, che telefonava di persona a giornalisti e a redazioni sconvolgendo le prime pagine già confezionate in tipografia. Fu una stagione pirotecnica che Ortona visse con una sofferenza, a dir poco, di cui fui testimone e anche partecipe, avendo più volte tentato, su sua richiesta, e sempre inutilmente, di fermare il presidente sulla strada di un attacco al presidente del Consiglio in carica Andreotti, o al capo dell’opposizione comunista Achille Occhetto o al troppo timido, secondo lui, segretario della Dc e mio amico personale Arnaldo Forlani. Quest’ultimo aveva allora come portavoce Enzo Carra, abbastanza allineato alla sua forte alleanza di governo con i socialisti, contrariamente alla precedente esperienza come segretario del partito di maggioranza, fra il 1969 e il 1973. Allora Forlani, costretto dagli eventi a sospendere il centrosinistra e a riesumare il centrismo con la formula della “centralità”, si era curiosamente tenuto come portavoce un giornalista per niente convinto di quella linea: Mimmo Scarano. Di cui molti sospettavano nella Dc che fosse addirittura iscritto al Pci. Il fatto è che Forlani sapeva fare benissimo, quando occorreva, il portavoce di se stesso smentendo la pigrizia attribuitagli dai fanfaniani di più stretta osservanza, che ripetevano la rappresentazione fatta di lui da Fanfani in persona: “una mammoletta che non vuole essere colta per non appassire”. Arnaldo invece a tempo debito gli si sarebbe rivoltato contro dimostrando di sapere camminare bene sulle proprie gambe. Anche Moro e Andreotti, pur così diversi fra loro, facevano uso molto parco dei loro portavoce. I quali non a caso scherzavano con chi li assillava di richieste e chiarimenti dicendo di essere piuttosto dei portasilenzio. Il portavoce storico di Moro fu Corrado Guerzoni. Andreotti ne avvicendò nei sette governi presieduti nella sua lunga carriera almeno tre: l’amico Giorgio Ceccherini, che aveva a lungo confezionato con lui la rivista quindicinale “Concretezza”, Stefano Andreani e Pio Mastrobuoni. Che, ancora convinto nella primavera del 1992 che Andreotti potesse essere eletto al Quirinale dopo la strage di Capaci, rientrando come presidente del Consiglio fra le soluzioni “istituzionali” imposte dall’urgenza dell’attacco terroristico– mafioso allo Stato, si sentì annunciare da lui con voce sommessa: “Guarda che domani eleggeranno Scalfaro”. Il quale si portò sul colle come portavoce Tanino Scelba, nipote dell’uomo alla cui scuola il capo dello Stato era cresciuto nella Dc, facendone da giovane il sottosegretario al Ministero dell’Interno: Mario Scelba. Ne avrebbe poi preso anche il posto, nel 1983. Tanino, pace all’anima sua, era di una tale disciplina e devozione come portavoce da interrompere anche vecchi rapporti di amicizia personale con giornalisti ed altri che entrassero in polemica con Scalfaro, peraltro in un momento in cui era facile che ciò accadesse per l’eccezionalità degli avvenimenti. Erano, in particolare, gli anni terribili di “Mani pulite”, quando il Quirinale tutelava come santuari le Procure di Milano e di Palermo, di punta nell’offensiva, rispettivamente, contro tutto ciò che sapeva, prima ancora di essere davvero, corruzione e mafia. In materia di disciplina e devozione Tanino Scelba riuscì a superare anche Giampaolo Cresci, che da portavoce di Fanfani una volta lo tolse d’impaccio in auto assumendosi la responsabilità di un soffietto d’aria che era sfuggito al capo, e scusandosene. Ma un ricordo particolare merita, da parte di un vecchio cronista politico, Antonio Tatò, Tonino per gli amici, portavoce del segretario del Pci Enrico Berlinguer. Lo chiamavamo ironicamente “fra Pasqualino”, versione maschile della storica suor Pasqualina di Papa Pacelli, Pio XII. Lui, Tonino, ne rideva, ammettendo di svolgere un ruolo ben più ampio e solido di quello ufficiale. Con quella stazza fisica che aveva, il doppio quasi di Berlinguer, che era timido quanto Tonino spavaldo, più che il portavoce Tatò sembrava il pretoriano del segretario comunista. Al quale non si accedeva se non si superava l’esame preventivo del portavoce, fosse pure in attesa di incontro o di intervista il più orgoglioso o prestigioso giornalista su piazza. Lo raccontò con dovizia felice di particolare Giampaolo Pansa, mandato dal “Corriere della Sera” alle Botteghe Oscure per una intervista che avrebbe terremotato la politica con la confessione di Berlinguer di sentirsi “più sicuro”, per l’autonomia del suo partito da Mosca, sotto l’ombrello dell’alleanza atlantica. Di tutt’altra pasta si sarebbe rivelato nell’ormai ex Pci Fabrizio Rondolino, che da portavoce di Massimo D’Alema ne divenne uno dei critici più acuminati, al pari di Claudio Velardi, anche lui dello staff dalemiano nella breve esperienza di “Max” a Palazzo Chigi. Una menzione a parte, infine, e forse allettante per Casalino, è dovuta ai portavoce destinati a diventare anch’essi politici: Francesco Storace per Gianfranco Fini e Paolo Bonaiuti, ormai ex anche come deputato, ma soprattutto Antonio Tajani per Silvio Berlusconi. Che lo ha appena promosso delfino anche per la posizione apicale assunta nel Parlamento europeo.
Il portavoce che abbaia, scrive il 22 settembre 2018 -Eugenio Giudice su Nuova Società. Il caso sollevato dalle cattive maniere, oltre che dal lauto stipendio, di Rocco Casalino, l’ex gieffino portavoce del premier e stratega della quasi vincente campagna elettorale Cinque Stelle non è il caso di Rocco Casalino, ma di un sistema che ha sempre più bisogno di pugili che di comunicatori. È facile pensare anche a Torino, ai piccoli Casalino di casa nostra, ai portavoce di presidenti di Regione e di sindaci del capoluogo, ma anche di importanti istituzioni finanziarie, di società, che fanno e disfano informazione, che provano a fare e disfare carriere, e che poi, se spogliati delle loro funzioni tornano ad essere il poco che sono sempre stati. Alcuni si nascondono, altri prendono di petto l’interlocutore, minacciano, alludono. Eppure, giornalisti “tutti d’un pezzo”, se li disputano come fossero loro i sindaci, i premier, gli ad, dimostrando poca considerazione per la propria professione. Altri – bel coraggio – li affrontano a colpi di “testata”: grazie al peso del giornale per cui lavorano riescono a essere un tantino meno proni, anche se non sempre. Ma è la morale di Sergio Leone, ricordate? «Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile…». C’entra il potere, la forza. La professione ancora una volta, è coinvolta solo per inciso. Per i giornalisti dei piccoli giornali – o del web, dove spesso il traguardo è già soltanto avere una dichiarazione, per lo più inutile, del potente di turno – invece, l’alternativa è tra soccombere e l’emarginazione. Basterebbe invece ricordare almeno alcune cose elementari. I portavoce non danno quasi mai notizie. Potrebbero invece confermarle, e sarebbe già tanto, o smentirle. Sarebbe sufficiente che i portavoce anziché tentare di dettare gli articoli, dessero semplicemente le informazioni che possono dare in modo trasparente, magari nero su bianco. E che i giornalisti non li utilizzassero come fonte riservata. Ce ne sarebbe comunque abbastanza per scrivere cose interessanti. Ma la responsabilità di un portavoce che è costretto dall’indole o dal contratto, spesso molto più sostanzioso di un redatore, a fare il pit bull, non è del tutto sua. È di un committente che non ha una buona opinione dell’informazione, che ha qualcosa da nascondere, magari anche la sua insicurezza, e cerca di tenere i giornalisti a distanza. E in questo caso basterebbe un servizio d’ordine, non un iscritto all’Ordine. Come si dice ai giardini, la colpa non è mai del cane, ma del padrone.
Movimento 5 Stelle: "Abolire l'Ordine dei Giornalisti", scrive Federico Sanapo, Esperto di Cronaca, Autore della news (Curata da Maurizio Ribechini), il 25/09/2018 Blasting News. Il Movimento ritorna sulla questione dell'abolizione dell'Odg dopo la vicenda che ha visto coinvolto Rocco Casalino, portavoce del premier Conte. Ordine dei giornalisti: M5S sostiene l'abolizione. Sarebbe già sul tavolo del governo giallo-verde il provvedimento con il quale si darebbe il via all'abolizione dell'Ordine dei Giornalisti. Lo si apprende proprio dal blog del Movimento 5 Stelle, che in una nota pubblicata sulla propria piattaforma web, ha criticato aspramente l'operato dello stesso Ordine. La vicenda incriminata dal M5S è quella che ha visto protagonista qualche giorno fa il portavoce del premier Conte, vale a dire Rocco Casalino. Come si ricorderà infatti, il portavoce, durante una telefonata con un collega che, come lui stesso, svolge la professione di giornalista, ha usato alcune frasi poco felici nei confronti dei funzionari del Ministero dell'Economia. Le motivazioni del M5S per l'abolizione dell'Ordine. Per il M5S l'Ordine dei Giornalisti dovrebbe essere abolito, soprattutto alla luce di quanto accaduto dopo i fatti qui esposti. Infatti per i pentastellati tale Ordine non sanzionerebbe quei giornalisti che, come in questo caso, avrebbero agito solo per interessi di parte e non per dare una notizia e informare i cittadini. Almeno questo è quanto dichiarato sul blog dei Cinque Stelle. Per dovere di cronaca, Rocco Casalino è stato attualmente deferito e non sanzionato, proprio dell'Odg della Lombardia che, nei suoi confronti, ha aperto un'istruttoria con la quale si dovrà analizzare il linguaggio utilizzato dallo stesso nella conversazione telefonica, per capire se quest'ultima violi la deontologia professionale a cui tutti i giornalisti sono chiamati ad attenersi, secondo quanto stabilito dalla legge n.69 del 1963 che disciplina la professione giornalistica. In poche parole, sempre a detta del Movimento, l'Ordine avrebbe sanzionato (in realtà, come visto, per adesso solo sottoposto ad un normale giudizio) Casalino, e non invece i giornalisti che hanno divulgato l'audio. Difatti si trattava di una conversazione privata che, secondo le regole deontologiche del giornalismo, non si dovrebbe mai divulgare.
Elvira Savino (FI): "Grillini allergici alla democrazia". Sulla dichiarazione da parte dei Cinque Stelle di voler abolire l'Ordine dei Giornalisti, è intervenuta anche la deputata di Forza Italia Elvira Savino. Infatti, secondo quanto affermato al Corriere dalla stessa esponente di Forza Italia, in corso ci sarebbe una vera e propria rappresaglia dei "grillini", i quali secondo la Savino, non amerebbero la democrazia, a cui sarebbero “allergici!”. Per la deputata, sarebbe in pericolo la libertà di stampa nonché di informazione. Anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in una nota diramata sul proprio sito web a firma del direttore Carlo Verna, ha preso le distanze dall'atteggiamento avuto nel blog dai pentestellati. Lo stesso Casalino ieri si è difeso davanti a Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato il classico Tapiro d'Oro: "Mi sono lasciato un po' andare", ha ammesso il portavoce di Conte.
Tutte le volte che in 70 anni la politica ha tentato di abolire l'Ordine dei giornalisti. Il Movimento 5 stelle non è il primo partito a dichiararlo inutile. Dal presidente Luigi Einaudi a Sergio Mattarella, passando per repubblicani, radicali, leghisti, post-comunisti e liberali, tutte le volte che la politica ha provato ad abolire l'albo professionale, scrive Arcangelo Rociola il 26 settembre 2018 su Agi.
ALBO GIORNALISTI. Il Movimento 5 stelle non è il primo partito a proporre l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti (Odg). Quella che si sta consumando in queste ore è solo l’ultima di una serie di battaglie che vanno avanti da più di 65 anni, ovvero già da prima che l’ordine stesso esistesse. Molti anni prima che l’abolizione dell’ordine arrivasse sui tavoli del governo Conte, come ha annunciato il Movimento in queste ore dopo il caso scoppiato per la pubblicazione dell’audio del portavoce del premier Rocco Casalino (Repubblica).
Breve storia dell'Albo (poi Ordine) dei giornalisti. Quaranta anni prima, nel 1925, fu istituito l’ “Albo generale dei giornalisti professionisti”. Progenitore di quello che oggi chiamiamo Odg, istituito dal regime fascista, regolava l’accesso alla professione, i requisiti per farla, i contratti, istituiva la figura del direttore responsabile e chi poteva diventarlo (solo i professionisti). Modificato, riformato durante i primi anni della Repubblica, non senza un’epurazione temporanea dei giornalisti che si erano compromessi con il regime fascista, conclusasi nel 1946 con il loro reintegro in massa deciso dal segretario del Partito comunista Palmiro Togliatti, l’albo è stato sempre oggetto di dibattito, alcune volte di scontro, anche aspro, nel mondo politico. A dire il vero, se lunga è la fila dei suoi detrattori, non ci sono stati suoi grandi sostenitori. Tra di loro c’è Antonio Gramsci che ne vedeva uno strumento necessario per insegnare strumenti di comunicazione alle masse popolari. E ovviamente del fascismo, da cui l’intellettuale marxista mutuò l’idea della necessità di creare "nuovi giornalisti" (Odg). A memoria di rete, ma confermata dai libri di storia del giornalismo italiano, il primo attacco all’albo è di Luigi Einaudi. Secondo presidente della Repubblica Italiana (1948-1955), nel 1945, mentre era presidente della Banca d’Italia, alla vigilia della Costituente, scrisse in un passo molto citato: “Albi di giornalisti! Idea da pedanti, da falsi professori, da giornalisti mancati, da gente vogliosa di impedire altrui di pensare colla propria testa”. Convinto sostenitore delle idee liberali, Einaudi era convinto che “giornalisti sono tutti coloro che hanno qualcosa da dire o che semplicemente sentono di poter dire meglio o presentar meglio la stessa idea che gli altri dicono o presentano male…Giudice della dignità o indegnità del giornalista non può essere il giornalista, neppure se eletto membro del consiglio dell’ordine od altrimenti chiamato a dar sentenza sui colleghi”. Da notare il fatto che nei passaggi citati di questa lettera non ci sia mai alcun accenno alla veridicità dei fatti (Il buongoverno, Laterza 1973, Vol. II pagg. 627-629, dalla lettera pubblicata da Il Fatto quotidiano).
Nasce l'ordine dei giornalisti, e subito la prima proposta di abolirlo. L’ordine per come lo conosciamo noi è nato nel 1963. Diventa un ente pubblico con funzione di vigilare sull’operato dei giornalisti e di tutelarli. Tra le novità rispetto alla sua prima forma, c’è nell’articolo due della legge che lo istituisce l’obbligo al “rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. Insieme ad una serie di norme che regolano l’accesso alla professione, l’albo dei professionisti e dei pubblicisti, diritti e doveri del giornalista, e la vigilanza del ministero della Giustizia sull’ordine stesso.
Tutte le volte che la politica ha provato ad abolire l'Ordine dei giornalisti:
Gli anni '70: il Partito Repubblicano. Da lì a cinque anni cominciano le prime battaglie anti-corporative. Il primo partito a condurla è quello Repubblicano, guidato allora da Ugo La Malfa. Tre parlamentari, tutti giornalisti, professionisti o pubblicisti, nel 1973 chiesero l’immediata abrogazione della legge approvata qualche anno prima (Linkiesta). La loro proposta però non venne approvata in Parlamento. Ma già in questi anni cominciano a cavalcare questa battaglia un altro partito, che la porterà avanti per altri 20 anni almeno: I radicali. “Nel 1974 iniziarono una forma di disobbedienza civile, sostituendo i direttori dei giornali di partito con persone non iscritte all’albo, violando così un articolo della stessa legge 69” (Lettera43).
Gli anni '80: il Partito Radicale. Ma sono stati gli Anni 80 quelli delle grandi battaglie del leader Marco Pannella. Strenuo oppositore degli ordini professionali, in particolare si scaglio più volte contro quello dei giornalisti. Da parlamentare, insieme a Francesco Rutelli, propose di sostituire l’albo obbligatorio con una ‘carta d’identità professionale’ sul modello francese (Linkiesta).
Gli anni '90: il referendum, Berlusconi, D'Alema e la proposta di Mattarella. Nel 1992 l’idea fu mutuata e rilanciata dal deputato del Movimento Sociale Italiano Pinuccio Tatarella: “Gli albi hanno una sola ragion d'essere, quando siano non solo aperti ma facoltativi e quando l'esercizio della professione giornalistica sia libero a tutti”, diceva (Il Foglio). Cinque anni dopo la proposta diventò uno dei sette quesiti del referendum abrogativo voluto dai Radicali. Le cronache del tempo raccontano che a firmare per questo referendum si recò anche, in piazza Duomo a Milano, anche il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, sostenuto da tutto quello che allora era chiamato il Polo delle Libertà. La domanda sulla scheda recitava così: “Volete voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964 n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308 e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento della professione di giornalista”?”. Risultato? 8,5 milioni di italiani votarono a favore, il 65% circa, ma il referendum non raggiunse il quorum e non se ne fece nulla. Sulla stessa linea di Berlusconi e Pannella c’era anche la Lega Nord di Umberto Bossi, anche lei da sempre a favore dell’abolizione dell’ordine come un po’ tutti i partiti di destra. Fece quindi scalpore al tempo anche la dichiarazione a sostegno dell’abrogazione dell’ordine dell’allora segretario dei Democratici di Sinistra Massimo D’Alema: “Ho votato per l'abrogazione dell'Ordine dei giornalisti insieme a 14 milioni di cittadini”, disse, secondo quanto si legge nell’archivio di Repubblica, causando polemiche con alcuni esponenti della allora maggioranza di governo, in particolare a sinistra tra Verdi e Rifondazione comunista.
Nel 1997 invece fu l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quattro anni dopo aver dato il nome alla legge elettorale del 1993, il Mattarellum, a proporre il superamento dell'Ordine dei giornalisti proponendo, con con altri deputati dell’Ulivo, la creazione di un “Consiglio superiore dell’informazione”. Un organo di controllo, come il Csm, che avesse il compito di tutelare l'autonomia professionale dei giornalisti e vigilare sulla loro deontologia. Ma anche in quel caso non se ne fece nulla (Lettera43).
Gli anni 2000: la proposta del Pdl dopo il caso Boffo. Un sostegno piuttosto trasversale quindi. Ma da allora di abrogazione dell’ordine non si parlò quasi più, seppure l’argomento rimase sullo sfondo del dibattito politico. Poi verso la fine del 2010, con Berlusconi al governo, torna il tema dell’abrogazione dell’ordine con il Popolo delle Libertà che crea un gruppo di lavoro incaricato di redigere una legge per cancellare l’ordine dei giornalisti (Reuters). Anche allora fu un provvedimento disciplinare a riattivare i politici contrari all’ordine: si trattava della vicenda Dino Boffo, allora direttore di Avvenire, oggetto di un dossier pubblicato da Vittorio Feltri, allora direttore de Il Giornale, ritenuto compromettente ma la cui veridicità non fu mai provata. Feltri fu sospeso dalla professione per sei mesi, su decisione dell’Ordine. Per Fabrizio Cicchito (Pdl), che ne diede notizia alla stampa, quel provvedimento contro Feltri fu “la goccia che fa traboccare il vaso”. Da lì ad un anno il governo Berlusconi cadde, e anche questa proposta di abolizione si concluse con un nulla di fatto.
Gli anni 2010: Grillo, Renzi, Crimi. Ultimo in ordine di tempo, ma prima dei 5 stelle, è stato il segretario del Partito democratico, e allora presidente del Consiglio Matteo Renzi a dire apertamente di volere l’abolizione dell’Odg. Nel dicembre 2015, davanti all’allora presidente dell’Ordine Vincenzo Iacopino, esordì dicendo: “Come tutti voi sapete seguendomi da qualche anno la mia posizione sull’Ordine è una posizione per la quale, toccasse a me, lo abolirei domani mattina”. Quel toccasse a me probabilmente implicava la sua ammissione di difficoltà nell’abrogazione dell’ordine, da un giorno all’altro, quasi a paventare troppe resistenze in Parlamento. Nella rosa di contrari all’Ordine dei giornalisti sono presenti da sempre anche i 5 stelle. Beppe Grillo, fondatore e garante del Movimento è stato da sempre tra i più attivi fautori dell’abolizione dell’albo. Prima con la raccolta di firme e poi con l’ingresso in parlamento grazie ad una serie di proposte di legge: una al Senato “sottoscritta da 53 senatori penta stellati e con primo firmatario Vito Crimi” (Il Foglio), oggi sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, e alla Camera. Era l’aprile 2013.
Anno 2018: nuove gocce da nuovi vasi, stessa proposta. Oggi con i 5 stelle al governo, e la Lega, l’abolizione dell’Ordine sembra cosa assai fattibile. Anzi, già sul tavolo del governo, stando a quanto ha detto lo stesso Movimento sul blog del partito. Questa volta è la decisione dell’Ordine di valutare l’audio del portavoce del Premier Rocco Casalino ad aver fatto traboccare il vaso della politica. Il governo ha i numeri per farlo. E forse mettere fine ad un ordine professionale (e una polemica) che dura da quasi settant’anni.
Io, che ho raccontato la casta, vi spiego la differenza dalle élite, scrive il 19 settembre 2018 Sergio Rizzo su "La Repubblica". Serve una classe dirigente onesta, capace e consapevole del proprio ruolo di tutela dell’interesse pubblico. Con meccanismi di selezione trasparenti e credibili. Non serve l’ondata di epurazioni e nomine eseguite dal nuovo Governo seguendo il medesimo metodo della cooptazione acritica che ha innescato la mediocrazia. Il manifesto della rivoluzione sovranista è la seguente frase attribuita a Matteo Salvini: “Non esistono destra e sinistra, esiste il popolo contro le élite”. Dice molto, al proposito, il curriculum del perito elettronico Simone Valente, sottosegretario grillino alla Presidenza incaricato di gestire il dossier Olimpiadi, che si definisce “dipendente pubblico” (in quanto parlamentare?). Eccolo: uno stage alla Virgin active, un secondo stage alla scuola calcio della Juve, tre mesi da venditore a Decathlon. Valente contro il sindaco milanese Giuseppe Sala, già dirigente della Pirelli, direttore generale di Telecom Italia, direttore generale del Comune di Milano, amministratore delegato dell’Expo 2015. L’immagine plastica del popolo (Valente) contro le élite (Sala). La tesi che i Paesi sviluppati non soltanto possano ormai fare a meno delle “élite intellettualoidi” (formula coniata da Luigi Di Maio), ma che le stesse élite vadano necessariamente spazzate via in quanto nemiche del popolo e amiche dello spread, ormai dilaga ovunque. Anche se qui la guerra si serve di un’arma ancor più micidiale. L’idea che si va affermando è che le élite si identifichino con ciò che viene ormai comunemente definita la casta. Ovvero, quella consorteria politica ingorda, autoreferenziale e incapace di risolvere i problemi della società, ripiegata sui propri interessi personali e di bottega e concentrata sulla difesa di inaccettabili privilegi. Che è cosa, però, ben diversa dalle vere élite, le quali dovrebbero coincidere con l’intera classe dirigente. Burocrati, imprenditori, professionisti, manager, medici, artisti, politici: indipendentemente dalle colorazioni, ciascun Paese democratico ha le proprie élite. E la storia dimostra che la crescita e lo sviluppo di ogni società civile è direttamente proporzionale alla loro qualità. Per questo ci sono nazioni, come la Francia, che hanno sempre dedicato risorse importantissime alla formazione delle classi dirigenti. Anche durante le rivoluzioni, quando una élite sostituiva quella precedente, rivelandosi spesso più efficiente. L’Europa ha dato il meglio di sé nei momenti in cui le oggi tanto vituperate élite erano formate da veri statisti, peggiorando poi in modo radicale quando il loro posto è stato occupato da personaggi via via sempre più modesti. Un processo lungo ma inesorabile, rivelato dai politologi Andrea Mattozzi e Antonio Merlo, che nel 2007 hanno sviluppato la teoria della mediocrazia: il meccanismo che ha determinato il degrado delle nostre classi dirigenti politiche, dove il processo di selezione meritocratica è stato sempre più rapidamente soppiantato dalla cooptazione. Al posto dei capaci, i fedeli. Nella politica, nella burocrazia, nelle aziende pubbliche e private, nelle banche, perfino nelle istituzioni in teoria più impermeabili, come le autorità indipendenti. Fermando l’ascensore del merito, si è fermato anche l’ascensore sociale e il ricambio di sangue. Il risultato è stato il calo verticale delle competenze in tutti i gangli cruciali, dall’amministrazione alle professioni. Gran parte dei problemi del nostro Paese sono strettamente legati al fallimento delle élite. Ma per tentare di risolverli in modo strutturale non c’è che una strada: ricostruire una classe dirigente, onesta, capace e consapevole del proprio ruolo nella tutela dell’interesse pubblico. Con meccanismi di selezione trasparenti e credibili. La missione spetta ora a chi occupa la stanza dei bottoni e fa parte, volente o nolente, proprio di una élite. Anche se questa è diversa da tutte le altre: una élite che ha l’obiettivo di distruggere il concetto stesso di élite. L’argomento dunque non è all’ordine del giorno della maggioranza gialloverde, né è previsto dal contratto di governo. Emerge invece una preoccupante avversione ideologica per la scienza, dimostrata in modo plateale dal caso vaccini. Con la verità della Rete che sovrasta quella della competenza, dello studio faticoso e della preparazione. Coerentemente, stiamo assistendo a un ulteriore impoverimento della qualità di chi è investito del compito di decidere. Abbiamo avuto un primo assaggio con la formazione del governo, dove accanto a residui della seconda Repubblica e figure improvvisate non manca un sottosegretario agli Esteri convinto che l’uomo non sia mai andato sulla Luna. Quindi un secondo assaggio con l’ondata di epurazioni e nomine eseguite seguendo il medesimo metodo della cooptazione acritica che ha innescato la mediocrazia. Esattamente come la politica italiana ha sempre fatto, con rare eccezioni. Senza verificare qualità e attitudini, ma solo appartenenza e fedeltà. E sorvoliamo, per carità di patria, sul curriculum.
Il super stipendio di Rocco Casalino: guadagna più di Conte. I costi dello staff di Palazzo Chigi. In ritardo rispetto a quanto prescritto dalla legge sulla trasparenza (e dopo varie richieste dell'Espresso), il governo pubblica finalmente i nomi e gli emolumenti dei collaboratori della Presidenza del Consiglio. I più fortunati? Il capo della comunicazione 5 Stelle e tutti i Casaleggio boys, scrive Mauro Munafò il 20 settembre 2018 su "L'Espresso". Meglio fare il portavoce che fare il premier. Si potrebbero riassumere così i dati sugli stipendi dello staff della presidenza del Consiglio del governo Conte che l'Espresso è ora in grado di rivelare. Sì, perché il portavoce e capo ufficio stampa del presidente del Consiglio Rocco Casalino, già numero uno della comunicazione dei 5 Stelle e partecipante alla prima edizione del reality show “Grande Fratello”, con i suoi 169mila euro lordi annui è di gran lunga il dipendente più pagato tra quelli che lavorano negli “uffici di diretta collaborazione” di Palazzo Chigi. Lo stipendio di Rocco Casalino si compone di tre voci: 91mila euro di trattamento economico fondamentale a cui si aggiungono 59mila euro di emolumenti accessori e 18mila di indennità. Per un totale, appunto, di poco inferiore ai 170mila euro annui. Una cifra assai più alta di quella che spetta allo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il quale, non essendo deputato, deve accontentarsi di 114mila euro lordi all'anno. Una gigantesca macchina acchiappa consenso. Anzi, due: quella di Salvini e quella di Di Maio. Che lavorano divise per colpire unite. Vi raccontiamo chi c’è dietro e quali strategie mediatiche usa. «Oggi noi costruiamo la realtà più credibile». Questa curiosa disparità di trattamento non è però un inedito. Anche nel caso del governo Renzi infatti l'allora presidente del Consiglio, non ancora parlamentare, si ritrovò a guadagnare meno del suo portavoce, e oggi deputato del Pd, Filippo Sensi. Anche in quella circostanza le cifre erano le stesse previste dal governo Conte: 114mila euro per Renzi e 169mila per Sensi. Il "governo del Cambiamento" spende però di più per il totale degli addetti alla comunicazione, come spiegheremo più avanti.
I Casaleggio boys all'incasso. Secondo solo a Casalino, ma comunque meglio remunerato di Conte, è Pietro Dettori, altro big della comunicazione 5 Stelle e fedelissimo di Davide Casaleggio. Per lui, assunto nella segreteria del vicepremier Luigi Di Maio come “responsabile della comunicazione social ed eventi” ci sono 130 mila euro annui. Vicecapo di quella stessa segreteria è Massimo Bugani, 80 mila euro all'anno, altro nome di rilievo della galassia pentastellata. I due sono infatti tra i quattro soci dell'associazione Rousseau che gestisce le piattaforme del Movimento 5 Stelle ed è diretta emanazione della Casaleggio associati (il fondatore è Gianroberto Casaleggio e l'attuale presidente è il figlio Davide). Il primo giorno al Viminale il ministro dell'Interno ha assunto come collaboratori tutti i membri dello staff di comunicazione, incluso il figlio di Marcello Foa. Aumentando a tutti lo stipendio (tanto non sono soldi suoi). E sull'Espresso in edicola da domenica, l'inchiesta su come funziona la propaganda grilloleghista. Non mancano nell'elenco altri nomi di ex dipendenti della Casaleggio che da anni compongono gli staff dei deputati e senatori 5 stelle: uno tra tutti Dario Adamo, responsabile editoriale del sito e dei social di Conte, pagato 115mila euro l'anno. Quanto conta la comunicazione. La pubblicazione degli stipendi permette di fare anche un primo confronto tra le spese di questo governo e quelli precedenti quando si parla di staff. Un confronto che tuttavia, è importate specificare, può essere solo parziale per due ragioni: non sono ancora noti tutti gli stipendi dei collaboratori (alcuni sono ancora in fase di definizione, come quelli della segreteria di Salvini) e va inoltre precisato che ogni governo tende sempre con il passare dei mesi e degli anni ad aggiungere ulteriore personale e relativi costi. Detto questo, le cifre più interessanti e significative sono quelle alla voce comunicazione, su cui questo governo sta spendendo più di tutti gli altri esecutivi di cui sono reperibili i dati. L'ufficio stampa e del portavoce di Giuseppe Conte ha in organico 7 persone per un costo complessivo di 662 mila annui, di cui 169 mila vanno come già detto al portavoce Rocco Casalino. Secondo in classifica il governo Letta, che contava 7 persone nello staff comunicazione per un costo totale di 629mila euro annui e con il portavoce pagato 140mila euro. L'esecutivo di Paolo Gentiloni poteva invece contare su una struttura di sette persone per un costo di 525 mila euro. Più complesso il calcolo per il governo di Matteo Renzi: appena insidiato il team dell'ufficio stampa si basava su 4 persone tra cui il già citato Filippo Sensi come portavoce e un costo complessivo di 335mila euro. Ma alla fine del mandato i costi erano saliti fino ai 605mila euro per un organico di sette persone. Trasparenza a passo di lumaca. La pubblicazione dei dati sui collaboratori della presidenza del Consiglio si è fatta attendere ben oltre i limiti previsti dalla normativa. La legge sulla trasparenza 33/2013 prevede infatti che le pubbliche amministrazioni aggiornino le informazioni sui titolari di incarichi dirigenziali o di collaborazione entro 3 mesi dal loro insediamento, termine rispettato da quasi tutti i ministeri dell'attuale esecutivo. A dare il cattivo esempio è stata proprio la presidenza del Consiglio, che ha invece impiegato 110 giorni e nell'ultima settimana è stata "pungolata" da due richieste di accesso civico avanzate dall'Espresso affinché venissero pubblicati i dati in questione.
In difesa di Rocco Casalino (ma il M5S e lui stesso si facciano un esame di coscienza), scrive il 21 settembre 2018 Mauro Muunafò su "L’Espresso". Sono l'autore dello scoop pubblicato dall'Espresso sui costi dello staff di Palazzo Chigi, che includono anche la retribuzione del portavoce del premier Conte e capo ufficio stampa Rocco Casalino. E oggi, il giorno dopo, mi ritrovo incredibile ma vero a dover difendere lo stesso Casalino. L'articolo in questione ha avuto infatti un'enorme eco mediatica ed è finito anche su altri siti, giornali e nelle trasmissioni tv. L'indignazione di molti lettori per le cifre percepite da Casalino è stato il sentimento principale emerso dai commenti sui social e dalle chiacchierate in giro. Casalino oggi, in un'intervista sul Corriere della Sera, difende il suo stipendio: «Ho una paga alta ma è una questione di merito dice». Se la prende ovviamente con i giornali che hanno riportato la notizia («stanno giocando sporco») e prova ad abbozzare una debole linea di difesa: «Sono ingegnere elettronico e giornalista professionista, parlo 4 lingue. Ho diretto per 4 anni l'ufficio comunicazione M5S del Senato e sono stato il capo comunicazione di una campagna elettorale al termine della quale il Movimento ha preso quasi il 33%. Se parliamo di merito e lo confrontiamo con lo stipendio dei miei predecessori non ho nulla di cui vergognarmi...anzi». Tra gli altri spunti interessanti dichiara anche: «Dopo 20 anni - aggiunge - ancora si parla di me come di quello che ha partecipato a un reality (il Grande Fratello ndr), come se nella mia vita non avessi fatto altro. E invece per arrivare dove sono ho sempre studiato e lavorato tanto e onestamente». Lo dico senza tanti giri di parole: Rocco Casalino ha ragione su tutta la linea. E, visto che sono quello che gli è andato a fare i conti in tasca, lo posso dire senza che a nessuno venga il sospetto che lo faccio per ingraziarmi le simpatie del potente di turno (se cercate sul blog o sull'Espresso troverete tanti miei articoli molto critici nei confronti dei 5 Stelle). Casalino si porta dietro chiaramente il pregiudizio legato alla sua partecipazione al Grande Fratello e certe sue uscite folli dette in quel periodo della sua vita (tipo che i poveri hanno un odore da poveri). Tuttavia si tratta di un'esperienza del passato: nel frattempo ha contribuito non poco al successo di quello che oggi è, piaccia o non piaccia, il primo o secondo partito italiano. Lo stipendio che oggi percepisce per il suo lavoro alla presidenza del Consiglio secondo me è davvero meritato e non mi scandalizza affatto che si tratti dello stesso emolumento percepito in passato da chi lavorava per altri esecutivi (cosa che ho scritto io stesso nell'articolo diventato virale, riportando cifre e facendo confronti che a oggi nessuno ha ancora smentito). Trovo inoltre surreale che a cavalcare la protesta e l'indignazione per il suo stipendio ci siano esponenti di quegli stessi partiti che retribuivano allo stesso modo i loro collaboratori. Ma... E arriviamo al sodo della questione...Davvero Rocco Casalino e il partito per cui lavora credono di essere innocenti di fronte alla gazzarra che si è scatenata alla notizia del suo stipendio? Fanno finta o non si rendono davvero conto che le folle urlanti e indignate a comando che oggi si lanciano sul suo portafoglio sono le stesse che negli ultimi anni hanno cavalcato e fatto crescere con le loro campagne ad alzo zero contro chiunque non la pensasse come loro? Urlare continuamente contro la Casta fino a far credere che tutto è Casta, additare sempre gli oppositori come "servi di qualcuno" prezzolati per esprimere il loro dissenso, svilire qualsiasi tipo di professionalità buttando sempre tutto sul piano economico (certo con la complicità del mondo dell'informazione di cui io stesso faccio parte). Scegliere come unica stella polare il pauperismo, parlare solo di scontrini, biglietti in economy, autobus e pizze al posto dei ristoranti. Ecco, alla fine si arriva qua, alla totale e generica incapacità di capire che le competenze si devono pagare perché sono frutto di lavoro e fatica. Benvenuto nella Casta, Rocco.
Rocco, dalla "puzza dei poveri" all'odore dei soldi. Quell'intervista choc alle «Iene» contro indigenti e immigrati: anche se si lavano sono diversi, scrive Patricia Tagliaferri, Domenica 23/09/2018, su "Il Giornale". Non è solo questione di soldi, ma anche di naso. Perché se sei povero, c'è poco da fare, hai un odore diverso da chi se la passa bene. Almeno così la pensa (o almeno la pensava) il grillino Rocco Casalino, portavoce del premier Conte, che prima ancora dell'audio choc con le minacce al ministro Tria e al suo staff, regalava ai suoi fan pillole di saggezza in un'intervista alle Iene che continua a rimbalzare sul web e adesso aiuta ad inquadrare il personaggio di uno che da allora ne ha fatta di strada, fino a diventare il boss della comunicazione di Palazzo Chigi con stipendio più alto del premier. Era uscito da poco dal Grande Fratello quando, in mutande e stravaccato su un divano con i piedi in mano, Casalino rispondeva alle domande della iena Marco Berry senza filtri, con toni più da militante di estrema destra che di uno in procinto di cominciare la sua ascesa nel Movimento Cinque Stelle. «Il povero ha un odore molto più forte del ricco, più vicino a quello del nero», diceva, chiedendo all'intervistatore se avesse mai provato a portarsi a letto un romeno o uno dell'Est: «Anche se si lava o si fa dieci docce continua ad avere un odore agrodolce, non so che cavolo di odore è, però lo senti». Toni decisamente lontani dal politicamente corretto. Parlando dei migranti, poi, il portavoce del premier diceva che il «loro vero problema è quello dei meno ambienti (testuale, ndr) che vivono in zone invase dagli extracomunitari». Per concludere con il Casalino-pensiero sull'immigrazione: «Investiamo tantissimi soldi per rendere gli italiani civili e invece poi abbiamo sta gente che non ha questo tipo di preparazione di base, sta gente è tutta gente senza istruzione. Noi li stiamo facendo entrare, è un pericolo». Dismessi gli abiti del concorrente di reality e cominciata la sua scalata al potere, Casalino ha sentito l'esigenza di spiegarlo il contenuto di quella vecchia intervista divenuto nel frattempo imbarazzante. E lo ha fatto pubblicando la sua versione dei fatti sul blog di Beppe Grillo. Una spiegazione decisamente creativa, la sua: in quell'intervista, in pratica, stava recitando. Interpretava un personaggio snob, classista, xenofobo e omofobo che gli era stato affidato dal corso di recitazione che stava frequentando. «Per sbeffeggiare l'ipocrisia di molti personaggi pubblici - spiegò - interpretai questo ruolo politicamente scorretto utilizzando lo studio fatto nel corso».
Era una finzione, dunque, o almeno così Casalino ha cercato di metterci una toppa adesso che certe affermazioni sarebbero decisamente inappropriate per il portavoce del presidente del Consiglio.
Mal di pancia grillino: "È un sopravvalutato e anche strapagato". I colleghi contro Casalino: non è il primo errore che commette. La paura di ritorsioni, scrive Domenico Di Sanzo, Domenica 23/09/2018 su "Il Giornale". Casalino contro tutti. Tutti contro Casalino. Nel giorno in cui salta fuori un audio del portavoce del Presidente del Consiglio che minaccia ritorsioni nei confronti dei tecnici del ministero dell'Economia, evocando scenari da notte dei lunghi coltelli, il M5s si riscopre meno monolitico del solito. In chiaro la posizione ufficiale dei pentastellati, espressa in un post sul Blog delle Stelle, è di rivendicazione della linea Rocco Casalino. «La linea del MoVimento non è mai cambiata - scrive lo Staff - siamo assolutamente convinti che nei ministeri c'è chi rema pesantemente contro: uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento». Sottotraccia, l'ennesima «forzatura» dell'ex concorrente del Grande Fratello, ha scatenato mal di pancia sopiti da tempo. Soprattutto tra i colleghi di Casalino, dislocati nelle varie strutture che si occupano della comunicazione M5s. Sia nei gruppi parlamentari, sia nei ministeri. Il portavoce di Conte, nonostante l'incarico istituzionale, è ancora il dominus della comunicazione politica dei Cinque Stelle. E l'atteggiamento mostrato nella conversazione «rubata» e consegnata ai cronisti da una «manina» sconosciuta ne è la prova. Proprio quel «mettetela come fonte parlamentare» che si ascolta nell'audio, ha fatto saltare sulla sedia più di qualche collaboratore dei grillini. Il concetto espresso dagli spin doctor malpancisti suona più o meno così: «Casalino è un accentratore, guadagna una cifra spropositata, viene considerato più bravo di come è in realtà e non è la prima volta che commette degli errori gravissimi». Non tutti, nello stesso staff parlamentare grillino, condividono i metodi «muscolari» di Rocco. Chi, invece, sfugge alle domande, è imbarazzato e lascia trasparire la paura di ritorsioni da parte dei massimi vertici politici del Movimento, tutti compatti intorno a Casalino, a partire dal vicepremier Luigi Di Maio. Mentre nelle chat dei parlamentari, non mancano le voci critiche. L'unica a metterci la faccia è la senatrice Elena Fattori, con un articolo sul suo blog ospitato dall'Huffington Post. La Fattori parla di Casalino come di «un professionista della comunicazione eccezionalmente brillante», salvo poi dire che «personalmente da libera cittadina trovo orribili le sue parole». In conclusione una stilettata a Di Maio: «Il problema dello strapotere di chi si occupa di comunicazione nel M5s non è di Rocco Casalino o chi per lui, è di chi questo grande potere glielo lascia. E su questo occorrerebbe interrogarsi, come molti di noi stanno chiedendo da anni senza risultati apprezzabili». Ma, a quanto pare, tra i comunicatori non tutti hanno lo stesso strapotere di Casalino. Giudicato «sopravvalutato» e super pagato dai colleghi critici. Con le obiezioni che si concentrano su tre episodi specifici, avvenuti negli ultimi mesi. La pubblicazione del video in cui il portavoce di Conte invia un sms a Enrico Mentana, dandogli la notizia in diretta tv del raggiungimento dell'accordo di governo tra Lega e M5s. Con annesso sberleffo al direttore del Tg di La7, un po' lento nel leggere l'importante velina. A giugno, al G7 in Canada, c'è stato lo strattonamento del premier Conte, portato via quasi di forza da Casalino durante un punto stampa con i giornalisti. Un mese dopo, la frase al cronista del Foglio Salvatore Merlo: «Adesso che il tuo giornale chiude, che fai?». Così Rocco è finito in nomination.
Portaborse. Torino, sorpresa a 5 Stelle: lo staff della sindaca Appendino costa 1,5 milioni in più di quello di Fassino. Un esercito di quasi 300 persone per gli undici assessori e la prima cittadina che in campagna elettorale aveva promesso un fondo per i giovani disoccupati grazie al taglio dei portaborse, scrive Diego Longhin il 28 settembre 2018 su "La Repubblica". Non è solo questione di promesse elettorali mancate, come l’istituzione di un fondo di 5 milioni di euro per i giovani disoccupati alimentato con i risparmi da un ipotetico taglio del 30 per cento degli staff rispetto alla giunta Fassino, cavallo di battaglia di Appendino nel 2016. Ma di piccoli eserciti di staff, tra segreterie e portaborse, che occupano le stanze accanto a quella della sindaca e degli undici assessori. Quasi 300 persone, secondo i calcoli fatti dal capogruppo della Lista Civica, Francesco Tresso, sulla base di un accesso agli atti e del paragone con gli anni di amministrazione di Piero Fassino. Nel primo anno di amministrazione Appendino il numero di occupati nelle segreterie della sindaca e degli assessori è stato di 286, di cui 21 staffisti esterni. Se si considerano gli anni di Fassino, la media del numero di collaboratori occupati nelle segreterie era di 210, di cui 30 esterni. La differenza è di una settantina di persone in più nell’era pentastellata. "Com’è possibile che dodici persone, tra cui la sindaca, ne debbano avere come contorno 300 per gestire l’attività amministrativa ed essere di raccordo tra la parte politica e quella amministrativa?" ripete Tresso. I Cinque Stelle hanno in effetti rispettato l’impegno di ridurre gli ingressi esterni di staffisti, preferendo l’utilizzo di personale interno. Questo però non ha ridotto i costi, anzi: i dipendenti ricevono un’indennità di ruolo e alla fine, facendo le somme, Appendino ha speso un milione e mezzo in più per le segreterie rispetto all’amministrazione di centrosinistra. La sindaca di Torino, insomma, non ha potuto rispettare la promessa di creare il fondo per i giovani disoccupati non perché i soldi siano finiti nel bilancio generale per coprire i buchi ereditati dal passato, ma perché i risparmi annunciati nella campagna elettorale non si sono realizzati. Anche prendendo l’anno in cui la precedente amministrazione ha assunto più collaboratori, il 2015, con un totale tra interni ed esterni di 214 persone, la spesa è sempre stata inferiore di oltre un milione rispetto all'era Appendino. Nonostante le polemiche per gli stipendi d’oro, in particolare del portavoce di Fassino, Gianni Giovannetti. Per Tresso, che ha presentato un’interpellanza firmata da tutta l’opposizione per chiedere conto della questione alla prima cittadina e dibattere della promessa mancata in Consiglio, non è solo una questione di soldi e di promesse mancate. "Stiamo parlando di circa 25 persone in media per ogni assessorato. Troppe. Un’organizzazione mastodontica e inconcepibile considerando che il numero dei dipendenti del Comune continua a diminuire e che alcuni servizi sono al collasso, come l’anagrafe". L'anagrafe, appunto. A Torino c’è una lista di attesa lunga mesi per riuscire a fare la carta di identità elettronica e c’è gente che aspetta da luglio per un cambio di residenza. Per ora tutti i correttivi messi in campo dall’amministrazione non hanno prodotto effetti. Il Comune non è riuscito nemmeno a garantire l'annunciato trasferimento di 22 persone agli sportelli: si è fermato a 7. L’assessora Paola Pisano è stata messa sotto accusa non solo dalle opposizioni, ma anche da un gruppo di consiglieri Cinque Stelle che hanno firmato, insieme con la minoranza, un’interpellanza generale proposta dal capogruppo Pd Stefano Lo Russo. Forse, sottolinea Tresso, "si potrebbe spostare qualcuno dalle segreterie degli assessori a Cinque Stelle e della sindaca per riuscire a fare qualche carta di identità e qualche cambio di residenza in più. Anche i servizi sociali e le Circoscrizioni sono in sofferenza. Invece il personale sta nelle segreterie degli assessori. È la vittoria della burocrazia: incredibile che questo accada con la sindaca Appendino, che si era presentata come l’alternativa, come il cambiamento".
Quanti furbetti sul portaborse. Lo Stato paga ai parlamentari oltre 3.500 euro al mese per l'assistente. Ma c'è chi se li intasca. Chi assume la moglie. E chi con quei soldi ingrassa le casse del suo partito. Mentre ai collaboratori vanno solo le briciole, scrive Primo Di Nicola su “L’Espresso” con la collaborazione di Giorgio Caroli, Cristina Cucciniello e Michela Giachetta. Ci sono quelli che non ce l'hanno, come il deputato del Pdl Simone Baldelli, e che i soldi del fondo per il portaborse se li mettono direttamente in tasca: "Sono vicecapogruppo alla Camera e non ho bisogno di assistenti personali", spiega: "Se mi serve qualcosa, mi affido ai collaboratori che lavorano per il gruppo". Ci sono gli altri che invece ce l'hanno, li contrattualizzano, ma con compensi da fame. È il caso di Soaud Sbai, parlamentare del centrodestra eletta in Puglia, che di collaboratori ne ha tre, uno dei quali, Nicola Nobile, pagato appena 500 euro al mese. E ci sono quelli, come il presidente della Camera Gianfranco Fini, già dotati di uno stuolo di segretari e collaboratori a carico del bilancio di Montecitorio, che non avendo bisogno di altri assistenti i soldi li destinano interamente al proprio partito: "Per un movimento politico nuovo come Futuro e Libertà", chiarisce, "è una risorsa importante visto che non percepisce neanche un centesimo di finanziamento pubblico". Ecco tre casi dalla giungla dei portaborse, assistenti, segretari, portavoce ed esperti dai titoli e incombenze tra le più strane e variegate, per i quali gli eletti ricevono ogni mese una ricca prebenda. Soldi in abbondanza, 3.690 euro per i deputati, 4.180 per i senatori (e vai a capire il perché di questa differenza) che dovrebbero consentire di stipulare contratti di lavoro regolari e soprattutto adeguatamente compensati. Invece, sia a Montecitorio che a Palazzo Madama le cose vanno in maniera del tutto diversa, con molti casi di lavoro in nero e compensi prossimi alla fame. Una vera macchia per il Parlamento che Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera, nel 2007 provò a cancellare imponendo ai deputati il deposito di regolari contratti per concedere agli assistenti gli ambiti accrediti e i relativi badge per l'ingresso al palazzo di Montecitorio. Risultato? Un clamoroso fiasco, visto che ad avere depositato i contratti con i portaborse sono stati solo 236 su 630. Un andazzo che, sotto la spinta delle lamentele e delle denunce di alcuni assistenti ha spinto l'ufficio del lavoro di Roma ad aprire un'inchiesta, acquisire documenti e contratti da Camera e Senato e a convocare gli stessi portaborse. Le risultanze dell'ispezione dovrebbero arrivare entro tempi brevi, nel frattempo Fini e Renato Schifani, il presidente del Senato, hanno annunciato novità importanti sul trattamento degli assistenti che, sulla scorta di quanto succede al Parlamento europeo, a partire dalla prossima legislatura, grazie anche ad una apposita leggina, dovrebbero essere pagati direttamente dal Parlamento previo deposito dei regolari contratti. Ma sinora non si è visto niente. La legge per i portaborse è ancora allo studio mentre l'unica cosa certa è che i parlamentari dovranno rendicontare al massimo il 50 per cento del fondo erogato dalle Camere. Sul resto tutto rimarrà come prima. Già, ma come sono andate sinora le cose? Come si regolano gli onorevoli con questo fondo? Lo utilizzano davvero per assumere un assistente? Che tipo di contratto scelgono e quanto li pagano? "L'Espresso" ha interpellato un centinaio di parlamentari. Non tutti hanno risposto. Le spiegazioni fornite offrono comunque uno spaccato interessante sugli usi e gli abusi del fondo per i portaborse. Certo, sarebbe bello in epoca di invocata trasparenza, di tagli ai servizi e di grandi sacrifici richiesti ai cittadini, se i soldi stanziati per uno scopo preciso, come quello dell'assunzione di un assistente, venissero restituiti quando non sono utilizzati. Invece, ai vertici delle due Camere, tra coloro che si avvalgono di personale stipendiato direttamente dal Parlamento e che non hanno bisogno di altro personale (presidenti e vicepresidenti di Camera e Senato, segretari d'aula, questori, presidenti di commissioni, capigruppo), le cose vanno in maniera diversa. Come nel caso del presidente del Senato Schifani che a "l'Espresso" spiega di dedicare ("Nel pieno rispetto dell'attuale disciplina", puntualizza) una parte del fondo "a tutte le iniziative politiche e culturali che il parlamentare assume sul territorio quale rappresentante della nazione", mentre un'altra parte, "mediante ritenuta diretta sul proprio conto corrente", viene dal presidente del Senato versata al Pdl. Come se i partiti non ricevessero già dallo Stato, attraverso i cosiddetti rimborsi elettorali, cifre da capogiro ad ogni tornata elettorale. Sono infatti molti i parlamentari che destinano una parte del fondo alla forza politica di appartenenza. Gli eletti nel Pd e nell'Udc staccano ogni mese un assegno di 1.500 euro, 800 versano mediamente i parlamentari del Pdl, molto di più quelli della Lega. Spiega Massimiliano Fedriga, deputato del Carroccio: "Non ho un collaboratore a Roma, il servizio mi viene fornito dal gruppo parlamentare". E i soldi dei portaborse? Al partito, al quale versa circa 3 mila euro al mese, come tutti i colleghi lumbard. E non è finita. A Trieste, "dove sono coordinatore provinciale", aggiunge Fedriga, "usufruisco invece dei servizi di una società di comunicazione con una persona che mi segue e che rilascia regolare fattura". Al partito, ma non solo. Confessa Beatrice Lorenzin, deputata berlusconiana del Lazio: "Ho un assistente parlamentare che pago a fatica. E la ragione è presto detta: con i soldi del plafond della Camera finanzio la mia scuola di formazione politica e molte attività sul territorio, per le quali sono arrivata persino a dover andare a comprare i gazebo all'Ikea. Comunque", aggiunge la Lorenzin, "il mio collaboratore ha un contratto co.co.pro che mi è stato indicato dagli uffici della Camera, dove l'ho anche depositato". Il compenso? "Prende sui mille euro al mese, più bonus". Neanche Linda Lanzillotta, esponente dell'Api rutelliana spende tutto il fondo disponibile per pagarsi il portaborse. Attualmente, Lanzillotta dice di avere una giovane assistente, con contratto a tempo determinato e contributi previdenziali pagati. Sul trattamento economico non aggiunge di più anche se, afferma, "certamente non spendo tutto il contributo per l'assistente". Dove finiscono allora gli altri denari? Una parte, afferma, va all'attività di "documentazione ed elaborazione per il lavoro parlamentare"; il restante all'associazione Glocus di cui è presidente. Simone Baldelli non è il solo a mettersi in tasca tutti i soldi dei portaborse. A fare la cresta ci sono anche altri personaggi molto conosciuti. Come Andrea Ronchi, ex ministro per le Politiche comunitarie, da poco riapprodato nel Pdl: "Non ho collaboratori, faccio tutto da me", giura: "La mia attività è prevalentemente di livello europeo, investo in viaggi legati all'attività politica". O della levatura di Angelino Alfano. Il segretario del Pdl ha due collaboratori storici, un segretario particolare e una portavoce. Fino a qualche mese fa, cioè sino a quando è stato ministro della Giustizia, i due erano pagati direttamente dal ministero. Diventato segretario del Pdl, sono invece passati a carico del partito. Quando divenne Guardasigilli, inoltre, Alfano annunciò anche la chiusura del suo storico ufficio di Agrigento: "Per non rischiare contatti con ambienti strani", disse. Morale: senza spese sul territorio e con i collaboratori pagati prima da via Arenula e poi da via dell'Umiltà, Alfano ha potuto intascarsi comodamente l'intero ammontare del fondo. Anche quando va bene, cioè nei casi in cui contrattualizzano i portaborse, deputati e senatori non si rivelano però molto generosi. Rita Bernardini, deputata radicale che negli ultimi anni ha fatto le pulci al bilancio della Camera denunciandone sprechi e spese pazze, dice di avere due contratti depositati alla Camera. Uno di consulenza con l'avvocato Alessandro Gerardi, pagato 1.200 euro lordi, che per un legale non è certo un granché; l'altro, a progetto, con Valentina Ascione, compensata addirittura con meno: appena 900 euro lordi mensili. "Ma è tutto in regola", spiega l'onorevole, che rivela di aver superato brillantemente l'esame dell'Ispettorato del lavoro a cui ha inviato i contratti. Ciononostante, non prende bene l'intrusione de "l'Espresso": "Ma perché non chiamate anche chi fa battaglie sulla legalità e poi non ha nessun collaboratore?". Molto generoso con i portaborse è invece il senatore del Pdl Lucio Malan che alle due persone assunte nella propria segreteria in questa legislatura devolve in pratica l'intero importo del fondo per gli assistenti. Ma la ragione c'è: una, Maria Termini, è la moglie; l'altra, Ilenia, è la nipote dell'amata consorte. Ma per carità, nessuno scandalo a sentire Malan, che si giustifica dicendo di avere assunto la signora nel 2006 su richiesta del gruppo parlamentare di Forza Italia di cui era dipendente. Volendo il gruppo sfoltire i ranghi, aveva chiesto ai propri senatori di assorbire qualche segretaria. Malan ha preso la consorte ("Bravissima") e successivamente, la di lei nipote, di cui ha sempre rivendicato la grande professionalità. E poi dicono che i parlamentari non hanno fantasia. Per risparmiare, in molti si sono inventati il portaborse-sharing, l'assistente condiviso. A illustrare l'innovazione è il senatore democratico Roberto Della Seta che racconta di avere due contratti depositati. Uno con una collaboratrice in esclusiva, Sonia Pizzi; l'altro con Daniele Sivori, collaboratore a metà con il collega Francesco Ferrante, eletto in Umbria. Entrambi gli assistenti hanno un contratto a tempo determinato fino alla scadenza della legislatura, spiega Della Seta. Quanto al guadagno, portano a casa appena mille euro lordi al mese. Davvero poco, considerando che nel caso della Sivori lo stipendio è pagato a metà dai due senatori. Sono quelli che affermano di impiegare le risorse erogate dalle Camere interamente per il portaborse. Qualcuno, anzi, fa di più. Ermete Realacci, storico ambientalista democratico, ha due collaboratori contrattualizzati, Matteo Favaro e Francesca Biffi. La somma dei loro compensi, parola dell'onorevole, sarebbe addirittura superiore a 3.600 euro lordi. "Esattamente, spendo di più di quello che mi danno alla Camera". Realacci ha poi un altro giovane che lavora per lui a Pisa, suo collegio elettorale: a costui vanno invece solo 300 euro netti al mese. Anche Barbara Pollastrini ha due collaboratori con regolare contratto a progetto. Uno dei due, Ettore Siniscalchi, giornalista, spiega che l'onorevole versa 1.300 euro netti a ciascuno di loro. Calcolando tutti i costi, compresi quelli contributivi, i due assistenti finiscono per far spendere alla Pollastrini più dei 3 mila 600 euro erogati per i collaboratori dalla Camera: "Proprio così", dice Siniscalchi, "l'onorevole ci rimette". Veri maestri nell'arte di arrangiarsi con i portaborse sono gli avvocati-parlamentari, anche quelli di grido. Tra questi, il senatore Piero Longo, con Niccolò Ghedini storico difensore di Silvio Berlusconi. "Certo che ce l'ho", dice Longo: "Il mio collaboratore parlamentare è una collega di studio, l'avvocatessa Anna Desiderio". Una collega di studio? "Non c'è niente di strano, il rapporto è passato al vaglio della commissione del Senato ed è stato ritenuto congruo", spiega Longo senza fornire altre spiegazioni su questa fantomatica "commissione". Aggiunge il senatore: "A fine mese la collega rilascia regolare fattura anche per l'attività di mia assistente parlamentare. Lavora a Padova, non è necessario che venga a Roma, non mi serve ancora che mi si porti la borsa. Lei deve tenere i rapporti politici con la base e fungere da segreteria politica". Altro caso da manuale quello di Pierluigi Mantini, deputato eletto nel Pd ma passato all'Udc, professore universitario e avvocato residente a Milano. Mantini confessa con candore di avvalersi, per la sua attività parlamentare, dei ragazzi del suo studio legale. Li tiene a progetto o a partita Iva, dice. Sui dettagli, a cominciare dagli importi dei compensi, preferisce sorvolare, inutile insistere: "Scusatemi, non ho tempo, sono in palestra". Beato lui. Sono i parlamentari che, agganciati telefonicamente, accettano a malincuore di rispondere cercando comunque di tagliare la conversazione con vaghe promesse di continuare successivamente. Qualche caso: Ignazio Abbrignani, deputato del Pdl: "Ho un collaboratore con contratto depositato". Tipo di contratto? Retribuzione? "Non lo so, se ne occupa il mio commercialista. Glielo chiedo, la richiamo". Entro breve? "Sì sì, certamente...". Stiamo ancora aspettando. Peppino Calderisi, ex radicale, eletto nelle liste del Pdl: " Sono impegnato...", "richiami...". Lo abbiamo fatto, non ha più risposto. Colomba Mongiello, senatrice democratica: "Sono nel traffico, richiamatemi". Dopo più di un'ora il telefono squilla ma la senatrice nemmeno risponde. Michaela Biancofiore, altra berlusconiana. Dice di avere un collaboratore nel collegio di Bolzano, con un contratto a tempo indeterminato. Non dice il nome, né la retribuzione: "Non lo vengo certo a a dire a voi quanto pago i miei collaboratori". E a Roma, com'è organizzata? "Sto per fare un contratto ad un assistente". Di che tipo? "Non ho tempo, arrivederci...".
2015. I portaborse: "Siamo sfruttati e umiliati". Intanto l’onorevole fa la cresta sul rimborso. Collaboratori costretti a pagare le bollette. Altri inquadrati come colf per pagare meno contributi. Malgrado i parlamentari ricevano oltre 3500 euro al mese per regolarizzarli. E adesso gli assistenti chiedono di modificare la normativa. Per una maggiore trasparenza nell’uso dei soldi pubblici, scrive Paolo Fantauzzi su “L’Espresso”. Marta tutte le mattine varca l’ingresso della Camera dei deputati. Consegna la sua carta d’identità e riceve il badge di “ospite”. In realtà sarebbe una collaboratrice parlamentare a tutti gli effetti. Una portaborse, insomma. Per l’onorevole con cui lavora scrive discorsi, comunicati e prepara le interrogazioni. Ma lui non ne ha voluto sapere: troppi contributi da pagare. E così Marta si è dovuta piegare e ha firmato un contratto da colf, che prevede invece oneri fiscali e previdenziali bassissimi. Collaboratrice sì, ma familiare. E per andare al lavoro, nel tempio della democrazia, deve sottoporsi quotidianamente all’umiliazione della finta visitatrice accreditata come ospite. Nel luogo in cui si fanno le leggi Marta (il nome è di fantasia) è in buona compagnia: sia alla Camera che al Senato sono diverse le ragazze, tutte laureate come lei, formalmente assunte con un contratto da donna delle pulizie. Eppure i loro datori di lavoro ricevono in busta paga un apposito “rimborso delle spese per l’esercizio del mandato parlamentare” (quindi esentasse) con cui pagare i collaboratori, oltre che gestire l’ufficio e affidare consulenze e ricerche. Non si tratta di spiccioli: 3.690 euro al mese per i deputati e addirittura 4.190 per un senatore. Moltiplicando per il totale degli eletti, fanno 44 milioni l’anno. E il bello è che per avere diritto a queste somme basta rendicontare metà delle spese, il resto viene erogato forfettariamente. Insomma, come nel caso del finanziamento pubblico ai partiti formalmente abolito ma di fatto reintrodotto con un altro nome - si tratta di rimborsi di nome ma non di fatto. Ma proprio per questo l’onorevole con cui lavora Marta si comporta così: perché tutto quello che risparmia, se lo può mettere in tasca. Ed è grazie a questo perverso meccanismo che, nel tempio dove si fanno le leggi, ancora accade che i portaborse siano lavoratori in nero, inquadrati con finti contratti a progetto o pagati con stipendi da fame. Nel 2012 un’inchiesta dell’Espresso fece luce sul modo in cui venivano spesi questi soldi extra e scoprì tanti “furbetti” che facevano la cresta su questi fondi. Oggi non molto sembra essere cambiato, come racconta Andrea (nome di fantasia), che alla soglia dei 40 anni lavora per un parlamentare dell’opposizione a 600 euro al mese: «Pago regolarmente le sue bollette ma mi è anche capitato di andare a ritirare pacchi natalizi che gli avevano spedito. E non è nemmeno il peggio che possa capitare. Un collega è costretto a fare la spesa per la deputata che lo ha assunto e un altro ha perfino presentato delle pratiche di invalidità, come se fosse un’agenzia di servizi». Adesso qualcosa forse si muove. Stanchi di questa situazione, i collaboratori parlamentari si sono riuniti in associazione (Aicp, un’ottantina gli aderenti) e hanno deciso di uscire allo scoperto, chiedendo espressamente una modifica della normativa. Così da tutelare il loro lavoro, spesso indispensabile all’attività legislativa degli onorevoli, e far gestire in maniera trasparente i soldi pubblici. «Non abbiamo modo neppure di sapere quanti siamo esattamente» spiega Francesca Petrini, portavoce dell’Aicp al Senato: «Per far rilasciare ai loro assistenti il badge per l’accesso a Montecitorio o Palazzo Madama, i parlamentari devono depositare i contratti. Ma gli uffici di Questura, formalmente per motivi di privacy, non ci hanno mai voluto dare il numero preciso». Il modello vagheggiato è quello del Parlamento europeo: un contratto con maternità, ferie, contributi previdenziali pagati e livelli retributivi rispettosi delle mansioni svolte. Senza più dover dipendere dalla magnanimità del politico di turno né doversi ridurre a fare i collaboratori familiari, più che parlamentari. La soluzione sarebbe semplice: l’onorevole indica il collaboratore da contrattualizzare ma a pagare sono direttamente Camera e Senato. Risultato: niente più cresta né abusi. Soprattutto, senza spendere un euro in più di quanto avviene nella giungla attuale perché basterebbe prevedere come soglia massima lorda quella già attualmente erogata sotto forma di rimborso. Ci vorrebbe anche poco, fra l’altro, in virtù dell’autonomia che i due rami del Parlamento rivendicano ogni vota che si tratta di toccare qualche privilegio: una delibera degli Uffici di presidenza, come accaduto con la revoca dei vitalizi ai condannati. Del resto l’Italia, al contrario di Francia e Regno Unito, è l’unico Paese dove vige ancora il far west: per gli assistenti non è previsto alcun nessun riconoscimento giuridico, nessuna voce di spesa specifica o vincolata, controlli solo formali e in particolar modo zero trasparenza. Facile immaginare, però, che le resistenze sono fortissime, perché quei soldi extra fanno comodo a tutti: a chi se li mette in tasca così come a chi li versa ai partiti di appartenenza, a corto di risorse col taglio dei contributi pubblici (che finiranno definitivamente nel 2017). Non a caso il Parlamento sta facendo di tutto per non muovere un dito. Nel 2012 a Montecitorio fu approvata una proposta di legge che cercava di mettere ordine, ma a causa delle elezioni anticipate il provvedimento non è stato ratificato dal Senato. Nel 2013, con la nuova legislatura, si è deciso di seguire la strada degli ordini del giorno in occasione dell’approvazione dei bilanci. Ne sono stati approvati addirittura 4 per “disciplinare tempestivamente” la materia ma sono rimasti tutti lettera morta. Stessa scena l’estate scorsa al Senato, dove è stato approvato un generico odg della maggioranza per “valutare ulteriori misure idonee a disciplinare in modo trasparente il rapporto coi collaboratori”. Ma la valutazione evidentemente è ancora in corso…
L'AGIT-PROP, OSSIA, "L'AGITAZIONE E LA PROPAGANDA".
Per affermare la propria opinione, o essere strumento inconsapevole della volontà del leader, si arriva ad annientare il nemico, nel suo modo di pensare e di essere.
Quanti di noi hanno assistito agli atteggiamenti di prevaricazione di esagitati guastatori durante le fasi delle elezioni, sia durante la campagna elettorale Porta a Porta o nei comizi elettorali dei candidati avversi, sia nei seggi delle votazioni, invasi da rappresentanti di lista a fare propaganda ed a impedire la convalida delle schede opposte.
Quanti di noi hanno assistito alla demonizzazione mediatica degli avversari politici attraverso la stampa partigiana e quanti di noi hanno subito inconsciamente il lavaggio del cervello di un pseudo cultura fatta passare per arte nella saggistica, nel teatro, nel cinema e nei programmi e spettacoli di intrattenimento.
Si può fare giornalismo sbeffeggiando la verità? Sempre più spesso i giornali offrono ai lettori non delle notizie, ma dei commenti fondati sul ribaltamento delle notizie, scrive Piero Sansonetti il 31 Marzo 2018 su "Il Dubbio". È giusto chiedere che tra il giornalismo e i fatti realmente accaduti ci sia un qualche collegamento? O è una fisima da vecchi, legata a un’idea novecentesca e sorpassata di informazione? Ieri ho dato un’occhiata ai giornali – diciamo così – populisti, quelli più vicini, cioè, alla probabile nuova maggioranza di governo, e ho avuto l’impressione di una scelta fredda e consapevole: separiamo i fatti dalle opinioni – come dicevano gli inglesi – ma separiamoli in modo definitivo: cancellando i fatti, e permettendo alle opinioni di vivere in una propria piena e assoluta autonomia dalla realtà.
Trascrivo alcuni di questi titoli, pubblicati in prima pagina a caratteri cubitali.
Libero: «Scoprono solo ora che siamo pieni di terroristi bastardi». (Sopratitolo, piccolino: “Retata di musulmani violenti”). La Verità, titolo simile: «Così importiamo terroristi». Sopratitolo: “Presi i complici di Anis Amri». Fermiamoci un momento qui. Qual è il fatto al quale ci si riferisce? La cattura, da parte delle autorità italiane, di una serie di persone di origine nordafricana sospettate di essere legate al terrorismo. Noi non sappiamo se effettivamente queste persone siano colpevoli. Ogni tanto – sapete bene vengono arrestati, o inquisiti, anche degli innocenti. E’ successo appena una settimana fa a un tunisino, che è stato linciato (dai mass media) lui e la famiglia prima che si scoprisse che non c’entrava niente. Ma ora non è questo il punto. Proviamo a capire quali sono le cose certe in questa vicenda. Che i servizi segreti italiani, o la polizia, hanno trovato dei sospetti terroristi. Che è in corso una operazione volta a sventare attentati. Che finora l’Italia è l’unico grande paese europeo che non è stato colpito da attentati. Che l’Italia è l’unico paese che ha catturato diversi sospetti terroristi. Che, tra l’altro, l’Italia è il paese che ha preso quel famoso Anis Amri (del quale parla La Verità) e cioè l’uomo accusato di una strage in Germania. E’ sfuggito alla polizia e agli 007 tedeschi ma non ai nostri. Punto.
Traduzione in lingua giornalistica dell’arresto di Amri e di alcuni suoi probabili complici? “Importiamo terroristi”. Voi penserete: li importiamo dal mondo arabo. No, dalla Germania. In Germania loro sono liberi, qui vengono fermati.
Traduzione Invece dell’azione del governo, degli 007 e della polizia per fermare il terrorismo arabo (che ci fa invidiare da tutti gli altri europei): «Scoprono solo ora che siamo pieni di bastardi islamici». C’è una barzelletta famosa, che qualche anno fa fu polemicamente raccontata ai giornalisti da Mitterrand, il presidente francese, e qualche anno dopo da Clinton (cambiando il protagonista). In mare c’è un ragazzo che sta affogando. Mitterrand lo vede e inizia a camminare sul pelo dell’acqua, arriva fino a lui ormai allo stremo, con un braccio lo tira su, se lo carica sulle spalle e lo riporta a riva. Salvandogli la vita. Tutto ciò, come avete capito, lo fa camminando sull’acqua, e non nuotando. Il giorno dopo i giornali francesi titolano: «Mitterrand non sa nuotare».
Mi pare che la barzelletta calzi bene e possa essere riferita ai titoli di Libero e della Verità Il Fatto invece non si occupa dei terroristi ma del Pd (il grado di ossessione di Libero e Verità per i terroristi, che, come è noto, negli ultimi vent’anni hanno messo a ferro e fuoco l’Italia, è simile al grado di ossessione del Fatto per il Pd). Titola: «Rivolta anti- Renzi: “Basta Aventino vogliamo giocare”». La parola giocare è usata in senso positivo: partecipare, essere attivi. La rivolta in corso sarebbe stata avviata da Franceschini e Orlando. In cosa consisterebbe? Nel chiedere un atteggiamento amichevole del Pd verso i 5 Stelle, in contrasto con Renzi che invece vuole che il Pd resti all’opposizione. Dopodiché uno legge l’articolo del direttore, cioè di Travaglio, e scopre che Orlando e Franceschini se ne stanno in realtà zitti zitti e rintanati. E per questo Travaglio li rimprovera. Cioè li rimprovera proprio per non aver dato il via ad alcuna rivolta, che invece servirebbe. E servirebbe allo scopo di bloccare l’Aventino e di spingere il Pd ad una scelta simile a quella dei socialdemocratici tedeschi, i quali hanno chiamato i loro elettori ad un referendum interno per avere il permesso di collaborare con la Merkel. Travaglio dice che il Pd deve fare la stessa cosa. Però ci sono due imprecisioni, nel ragionamento. La prima è che il Pd non ha scelto l’Aventino, ma l’opposizione. Sono due cose molto, molto diverse. L’Aventino (cioè il ritiro dei propri deputati dal Parlamento) fu scelto dai socialisti e dai liberali, dopo l’assassinio di Matteotti (segretario del Psi). Socialisti e liberali, guidati da Giovanni Amendola, decisero di disertare il parlamento per delegittimarlo e dunque delegittimare il fascismo. I comunisti (guidati da Gramsci) fecero una scelta diversa. Dissero: restiamo dentro a combattere. Cioè rifiutarono l’Aventino e scelsero l’opposizione. In realtà andò male a tutti e due: il fascismo non fu delegittimato da Amendola e Turati né fermato da Gramsci, e finì per fare arrestare sia i socialisti sia i comunisti. Ma che c’entra tutto questo con l’attuale situazione? Niente. Qualcuno forse pensa – o ha detto che il Parlamento non è legittimo, e che le elezioni non valgono, e che i vincitori non sono legittimati a governare? Hanno detto tutti l’esatto contrario.
Quanto all’alleanza tra Merkel e Spd è una alleanza che è impossibile paragonare a una possibile alleanza tra 5 Stelle e Pd. La Spd ha accettato di sostenere la Merkel esattamente con l’idea opposta a quella di Travaglio: e cioè per sbarrare la strada ai populisti. La Merkel e i socialdemocratici hanno già governato insieme e dunque non solo affatto incompatibili. Ma lasciamo stare la polemica politica, nella quale, effettivamente, è ovvio che le opinioni prevalgano su tutto. Restiamo nel campo del giornalismo. La domanda che mi tormenta è sempre la stessa: il giornalismo moderno ha bisogno dei fatti, delle notizie vere, delle verifiche, della somiglianza con la realtà, o invece si è trasformato in una specie di nuovo genere letterario, basato sulla fantasia, e volto esclusivamente a costruire polemiche politiche o culturali e ad influenzare, indirizzare, spostare l’opinione pubblica?
Naturalmente nel giornalismo c’è stata sempre questa componente e questa aspirazione: di influenzare lo spirito pubblico. In tutte le attività culturali c’è questa aspirazione. Anche nella pittura, anche nel cinema. Però, fino a qualche anno fa, il giornalismo aveva – come la fotografia – la caratteristica di essere una attività intellettuale legata strettamente alla realtà, e il cui grado di autorevolezza si misurava esclusivamente valutando la sua vicinanza alla verità. Sempre meno è così. I giornali populisti vengono confezionati con un metodo che si fonda sul disprezzo per la realtà. La loro forza è direttamente proporzionale alla lontananza dalla realtà. Gli altri giornali oscillano, tentati dai vecchi valori e dai vecchi schemi del giornalismo europeo e americano, ma alla fine rassegnati a inseguire Vittorio Feltri. In dieci anni – cifra approssimativa – il giornalismo italiano ha completamente cambiato faccia. E le possibilità per i cittadini di essere informati si è enormemente ridotta. Dobbiamo prenderne atto e basta? Cioè considerare il divorzio tra giornalismo e verità e la sua trasformazione in genere letterario fantasioso, come un’inevitabile conseguenza della modernità? Se è così però bisognerà trovare qualche altro modo per informare e informarsi. La ricerca di questo nuovo modo dovrebbe essere la preoccupazione principale dei politici e degli intellettuali. E anche dei tantissimi giornalisti che sono stati tagliati fuori da questa nuova tendenza. La preoccupazione principale: perché nessuna democrazia può sopravvivere, senza una informazione decente.
Le parole degli agit- prop, scrive Piero Sansonetti il 2 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Molti di voi non sapranno neanche che vuol dire quella parolina che ho scritto nel titolo: «agitprop». Era il modo nel quale, nel partito comunista, si chiamavano gli attivisti che si occupavano delle campagne elettorali e in genere dell’attività di propaganda del partito. Agit- prop era l’abbreviazione di “agitazione e propaganda”, e “agitazione e propaganda” era la denominazione di un dipartimento, molto importante, che aveva una sua struttura nazionale e poi nelle singole regioni, nei Comuni, e in tutte le sezioni di partito. Il dirigente che aveva il compito di coordinare questo dipartimento era uno dei personaggi che più contavano nel partito. I capi nazionali degli agit- prop sono stati nomi molto famosi nel Pci, a partire da Amendola e Pajetta e in tempi più recenti il giovanissimo Veltroni. Mi è venuto in mente questo termine perché mi sembra che torni attuale. Questa campagna elettorale ricorda un po’ le origini, gli anni 40 e 50. Molta agitazione e molta propaganda. E non nel senso migliore di questi due termini. Tutta la campagna elettorale si è sviluppata su due direttrici: la prima è stata quella del fango sugli avversari, azione condotta con la partecipazione attiva, o addirittura sotto la guida di alcuni giornali. La seconda, quella della presentazione di programmi, o addirittura di risultati, del tutto improbabili o forse anche impossibili. Proviamo a dare un’occhiata alle parole chiave di questa campagna elettorale.
Cinque Stelle. Il partito nuovo, o se volete il movimento, non ha dato grande importanza al suo programma elettorale. Che in buona parte, peraltro, ha copiato un po’ dal Pd, un po’ da Wikipedia, un po’ dai giornali. L’unica proposta comprensibile è stata il reddito minimo garantito, ma i 5 Stelle non hanno spiegato come renderlo possibile, anche perché il reddito minimo è immaginabile solo aumentando la pressione fiscale, e questa è una cosa che – salvo la Bonino – nessuno osa prospettare. I Cinque Stelle hanno puntato tutto sulla squadra di governo. Che hanno presentato ieri, cioè quasi alla fine della battaglia, ed è composta interamente da nomi assolutamente sconosciuti all’elettorato (e non solo) tranne un nuotatore un po’ più famoso degli altri. Il problema però non è la qualità della squadra (che nessuno, nemmeno Di Maio, è in grado di valutare) ma la assoluta certezza che nessuno, o quasi nessuno, di quei nomi farà parte del futuro governo. Per la semplice ragione che il futuro governo sarà di coalizione e dunque andrà negoziato da vari partiti e i nomi dei ministri dovranno rappresentare diversi partiti. Compresi, eventualmente, i 5 Stelle. Diciamo pure che anche questa trovata della squadra di governo è un po’ una presa in giro. La squadra di governo la si può presentare in un sistema politico presidenziale, come quello americano. Non certo in un paese dove Costituzione e legge elettorale prevedono che sia il Presidente della Repubblica a scegliere il premier e a concordare con lui una coalizione in grado di sostenerlo.
Inciucio. La seconda grande bugia. Che accomuna tutti. Tutti dicono: l’inciucio mai. Inciucio – lo abbiamo scritto qualche settimana fa – è un modo dispregiativo per indicare un’intesa politica tra forze distinte. Cioè è la base della democrazia parlamentare italiana. L’inciucio fu inaugurato nel 1943, dopo l’armistizio, da democristiani, socialisti, comunisti e liberali, e poi è proseguito senza soluzione di continuità, escluso il breve periodo del bipolarismo, nel quale un sistema elettorale maggioritario, o a premio di maggioranza, permise il governo di uno solo dei due schieramenti. La fine del sistema a premio di maggioranza, la sconfitta di Renzi al referendum, e la nascita del tripolarismo, hanno reso di nuovo indispensabile una intesa tra forze diverse, cioè l’inciucio. Tutti i partiti ne sono consapevoli, e tutti fingono di essere fieramente contrari.
Immigrazione. È stato il tema chiave della battaglia politica. I partiti del fronte populista (in particolare la Lega e Fdi, un po’ meno i 5Stelle), ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia. Il centrodestra moderato è stato costretto, almeno in parte, a inseguire o ad adattarsi. Il centrosinistra ha trattato il tema con più prudenza, ma comunque senza denunciare la falsità del problema. Tanto che, alla vigilia delle elezioni, si è rifiutato di approvare lo Ius Soli, e ancora in questi giorni (per le stesse ragioni, e cioè il timore della propaganda populista) ha rinviato la riforma dell’ordinamento carcerario. Il ritornello dei populisti è stato: «È in corso un’invasione, la quantità di immigrati sta aumentando in modo esponenziale, l’immigrazione porta delinquenza e questo è il motivo dell’aumento continuo della criminalità. Fermiamo l’immigrazione, cacciamo i clandestini, riprendiamoci l’Italia, impediamo la “sostituzione etnica”». Non è vero che è in corso un’invasione, visto che gli immigrati sono ancora largamente al di sotto del 10 per cento della popolazione. L’immigrazione è in aumento ma è assolutamente sotto controllo. Non è vero che la delinquenza è in aumento, anzi da quindici anni è in continua e progressiva diminuzione. Tanto che gli omicidi sono scesi, dalla fine degli anni novanta, dalla cifra di quasi 2000 a meno di 400 all’anno. E non è vero neanche che l’aumento dell’immigrazione aumenta la criminalità. I detenuti stranieri nel 2007 erano il 32 per cento della popolazione carceraria. Oggi sono ancora il 32 per cento, sebbene il numero degli immigrati sia quasi raddoppiato. L’uso della paura dell’immigrato come strumento di campagna elettorale ha prodotto una gigantesca disinformazione di massa. Giornali e Tv si sono sottomessi. Sarà difficilissimo correggere questa disinformazione.
Economia. Di economia si è parlato pochissimo. I partiti di opposizione non ne hanno voluto parlare soprattutto perché i dati ultimi sono positivi per l’economia italiana. Il partito di governo ne ha parlato di sfuggita, forse perché non ha molte proposte concrete per intervenire. Forza Italia è l’unica che si è occupata della questione, ma con la proposta della Flat Tax e cioè di una soluzione che nessun grande paese occidentale ha mai adottato, e che anzi, tutti, hanno considerato irrealizzabile.
La Giustizia. È stata la grande assente. Nessuno osa parlare di giustizia. Lega e 5Stelle hanno in serbo un programma di stretta e di riduzione drastica dello Stato di diritto. Non hanno mai nascosto di considerare lo Stato di diritto un orpello ottocentesco. Però in campagna elettorale hanno evitato di parlarne troppo. Persino Il Fatto ha messo la sordina. Forza Italia e Pd, partiti più garantisti, non hanno trovato il coraggio di porre seriamente la questione sul tappeto, perché temono di perdere voti. Mi fermo qui. Credo di avere spiegato perché questa campagna elettorale mi porta al tempo degli agit-prop. Con una differenza: allora i partiti avevano anche dei programmi politici, ed erano programmi politici alternativi e chiari. Oggi no.
La faida Renzi-D'Alema è l'omicidio-suicidio che ha ucciso gli ex Pci. La sinistra italiana è la più debole d'Europa dopo quella francese: è la vendetta di Baffino, scrive Roberto Scafuri, Martedì 06/03/2018, su "Il Giornale". Parlandone da vivi, i due s'assomigliavano come gocce d'acqua. Correva la primavera 2009 e in un'accaldata sala di militanti il presidente della Provincia fiorentina, Matteo Renzi, ancora si rivolgeva al «caro Massimo, punto di riferimento del passato, del presente e del futuro». Il caro Massimo, lì da presso, mani giunte a mo' di preghiera, era assorto come inseguendo sfuggenti presagi. Renzi è uno di quei giovani - ebbe a dire benedicendone l'approdo a Palazzo Vecchio - «dei quali ci si può chiedere solo se batterà il record della pista oppure no». Sorrisi, applausi. Ma anche cordialità pelosa: diffidenza a pelle, senza motivo, tra animali che fiutano il pericolo. Il partito (ancora) c'era, la sinistra italiana non era, come oggi, la seconda più debole d'Europa dopo quella francese (studio Cise-Luiss). Che cosa inquietava D'Alema? Gli avevano già parlato di Matteo, il fiorentino. In particolare Lapo Pistelli, che l'aveva portato a Roma come portaborse nel '99, fatto promuovere segretario provinciale e, tre anni dopo, accompagnato nella scalata alla presidenza della Provincia. Qui il capo della segreteria di Matteo sarà Marco Carrai; i suoi cugini Paolo e Leonardo pezzi grossi della ciellina Compagnia delle opere. Ce n'è quanto basta e avanza per alimentare la diffidenza di chiunque, figurarsi D'Alema. Alle primarie per sindaco, nel febbraio '09, il giovanotto ha surclassato Pistelli (40% contro 26), poi ha infierito con un foglio di sfottò lasciatogli sulla porta di casa. L'ambizione sbandierata di Matteo è ciò che stuzzica il vecchio, la mancanza di buon gusto ciò che lo repelle. L'omicidio perfetto di Renzi giungerà a maturazione qualche anno dopo; dopo gli anni buoni da sindaco, quando l'ambizione incontrollabile (più sponsor influenti) suggeriscono che il partito erede della tradizione catto-com può essere scalato. Occorre un «simbolo», il gesto eclatante e dimostrativo, il parricidio che renda dirompente il cambio di stagione. È la nascita della «rottamazione»: D'Alema si vede tirato in ballo a ogni pie' sospinto, sempre più attonito di fronte a quella rottura imprevista delle vigenti regole di bon ton. L'attacco alla classe dirigente berlingueriana è scientifico, ma si concentra molto sul togliattiano D'Alema per salvare il prodiano Veltroni («il più comunista di tutti noi», ha detto di recente Bettini). D'Alema reagisce come elefante ferito. Quando Renzi gli farà lo sgarbo definitivo, facendogli credere prima di poterlo sostenere come commissario alla politica estera Ue per poi umiliarlo nominando l'inesperta Mogherini, l'ex leader è pugnalato al cuore. La vendetta è pietanza fredda, però. Di fronte alle pulsioni suicide di Renzi, plateali durante la roulette russa del referendum, D'Alema torna ad annusare il buon sapore della vendetta. La minoranza bersaniana, dopo anni di derisioni e umiliazioni, è ormai cotta a puntino. Gianni Cuperlo, che ben conosce l'insidiosa persuasività di quel Grillo parlante che li convince uno a uno, non riesce a trattenere la diga. Ultimo dei sedotti Bersani, per il quale l'uscita dalla ditta di una vita è un evento tragico. La sgangherata parabola di Mdp e Leu è sotto i nostri occhi, quella del Pd storia che finalmente s'azzera. Ma Berlusconi dovrebbe ripartirne i meriti dando a Cesare ciò che è di Cesare. Se Renzi ha fatto fuori i comunisti, l'ultimo martire dell'orgoglio comunista non ha esitato a sacrificarsi nel vecchio bunker di Nardò pur di vedere l'usurpatore schiacciato dal macigno del 18% dei voti. Per poi cadere a sua volta trafitto da 10.552 schede pietose: il 3,9 per cento. Più che una percentuale, un epitaffio.
La sinistra cadavere, scrive il 5 marzo 2018 Augusto Bassi su "Il Giornale". Seguire la maratona Elezioni 2018 di Enrico Mentana a volume alzato è stato superfluo. Si sarebbe rivelato sufficiente osservare i volti del ricco parterre per comprendere con vividezza l’andamento degli exit poll. Già torvi e un po’ scrofolosi per natura, si facevano tesi, poi allarmati, quindi sconsolati, infine sepolcrali. Il pensiero levogiro, antiorario al senno, testimone in diretta della propria morte. Che macabra pagina di televisione verità! E via via che i dati si facevano indiscutibili, i malcapitati sono stati chiamati a riconoscerne il cadavere. Gente che ha sempre capito nulla, per lustri e fino a pochi minuti prima dei risultati elettorali, come Annunziata, Giannini, Sorgi, Cerasa, in diretta a commentare il trapasso delle proprie stesse sentenze. Ma se il piglio di Mentana – in grandissima forma per tutta la nottata, fino a dragare la venustà della Dragotto con aria da stracciamutande emerito – si è mantenuto friccicarello malgrado il cordoglio in studio, il volume è servito per intercettare i flebili aliti dei traumatizzati ospiti. La chiacchiera tremolante di Giannini, fino a ieri sprezzante verso i populismi, intraprende l’operazione di riabilitazione dell’insulto, affrancandolo in «popolarismi»; Marco Damilano, aggrappato a una conversione pro-sistema dei 5Stelle, si dichiara sorpreso dall’avanzare della Lega nelle periferie metropolitane; Sorgi scompare inghiottito dal suo tablet, per poi riemergere con il titolo «Vince Di Maio, Italia ingovernabile». Cazzullo, dall’inflessione sua, ci ricorda dell’esistenza dei mercati, della grande Europa, mentre gli elettori italiani hanno appena risposto con meno Europa e un eloquente sticazzi! dei mercati. Per il bene della stabilità, gli scambisti non vorrebbero si votasse; malauguratamente per loro, una volta ogni tanto anche da noi si va alle urne… e può succedere che un pernacchione elettorale li destabilizzi. Irriverente Benedetto Della Vedova, intervenuto a commentare la sciagura della Bonino, che si vende come coraggioso ambasciatore anti-mainstream. Irresistibile osservare l’Annunziata che prende appunti con il lapis sull’agendina di una disfatta scolpita nella pietra con una verga di boro, e imperterrita commenta con il tono di chi la spiega. Lucia bacchetta addirittura Marine Le Pen, festante su Twitter per una consultazione italiana aculeo nel culo flaccido di Bruxelles, suggerendole di star buona perché trombata a casa propria e aggiungendo: «Ci vorrebbe un po’ di sale in zucca sulle previsioni e chi le fa». Se l’inclemente conduttrice applicasse a se stessa i parametri che riserva agli altri, oggi venderebbe carciofi e zucchine a Osci e Sanniti. Per fortuna arriva Alessandra Sardoni, in diretta dalla sede del Partito Democratico, che sembra balbettare in un regime di quarantena, coraggiosa inviata sulla scena di una terrificante pandemia. «Siamo un grande partito», «A Renzi e alla classe dirigente del PD non c’è alternativa credibile per gli italiani», erano soliti tuonare da quelle stanze e dalle testate assoldatine. Mecojoni! Il Bomba, futuro senatore del Senato che voleva abolire, dopo aver accusato gli avversari di scappare dal confronto, assorbe con il medesimo ardimento il tracollo, arrivando per commentare a caldo la sconfitta con la baldanza di un coniglio palomino. L’indispensabile, la necessaria classe dirigente – dei Gentiloni, dei Minniti, dei Gori, dei Franceschini, dei Rosato, dei Martina, dei Poletti, delle Fedeli – è stata trattata dai votanti come pattume pronto per l’inceneritore. L’eredità culturale dell’assemblea costituente ha uno scatto d’orgoglio solo nel padre nobile del partito, nell’immarcescibile campione della sinistra di governo, Pier Ferdinando Casini, che trionfa disdegnoso nella sua Bologna. Nel frattempo, la marea nera che doveva investire l’Italia, gli inquietanti rigurgiti neofascisti pronti a deflagrare, i temibilissimi blitz di Forza Nuova e Casa Pound raccontati sulla stampa dai GEDI, via radio da Vittorio Zucconi e in tv da Corrado Formigli, stanno sotto l’1%: perché “la realtà è la loro passione”. Di Stefano si vede per la prima volta in un salotto di Mentana, benché in collegamento, e si lamenta di essere stato trascurato dai media durante tutta la campagna elettorale. Risposte piccate in studio, specie da una Lucia molto indispettita. I sobillatori di mestiere che hanno tirato la volata ai propri campioncini di triciclo fino a un traguardo di paracarri, oracoleggiano ora sui futuri scenari, sugli equilibri di domani, sulla temperie a venire, smarcandosi dalla putrefazione con guizzi alla Margheritoni. E sempre indietro come la coda del maiale. In chiusura, un minuto di silenzio per Morti e uguali, come anticipato l’11 febbraio in questi quaderni. Boldrini, Bersani, D’Alema, Grasso… dal regno della pace e della serenità veglieranno sui propri cari.
D’Alema è la causa della crisi Pd. Il Dio della politica lo ha punito, scrive Sergio Carli il 5 marzo 2018 su "Blitz Quotidiano”. D’Alema è la causa principale della crisi del Pd. Il Dio della Politica, o il Dio che atterra e suscita di Manzoni, insomma proprio quel Dio là, l’ha severamente e giustamente punito. La punizione divina si è manifestata con la clamorosa sconfitta nel suo collegio di casa, in Puglia, dove non ha raccolto nemmeno il 4 per cento dei voti e è arrivato ultimo in graduatoria. Così cade chi peccò di superbia. E dire che motivò la sua candidatura come la risposta a un imperativo categorico, una richiesta che saliva dalla piazza italiana che lo voleva ancora in politica, impegnato a salvare l’Italia. Quella bella Italia di pseudo sinistra che pensa ai poveri invece che alla crescita, a ridistribuire quello che non è stato accumulato, a proteggere i privilegi della casta, di cui lui e i suoi compagni di partito sono colonna. Come nella Unione Sovietica, che lui frequentò da ragazzo come pioniere. Giusto che questa sinistra, un po’ salottiera e un po’ saccente, sia finita come è finita, sotto il 4 per cento, altro che il 10. Come l’Unione Sovietica, appunto. Fu Massimo D’Alema a fermare Matteo Renzi sulla strada delle riforme. Fu lui il grande vecchio che orchestrò la campana contro il referendum costituzionale, scatenando i suoi agit prop. È stato lui la mente della scissione a sinistra del Pd che è finita come è finita ma che, nel processo, ha trascinato quasi nel baratro il Pd stesso. Il Pd è una forma di miracolo italiana. L’unico caso al mondo di un partito comunista che, attraverso successive mutazioni nonché lo sterminio di avversari a catena (Psi, Dc, Forza Italia e Craxi e Berlusconi), è riuscito a sopravvivere alla caduto del muro di Berlino e ottenere, quasi 30 anni dopo, un bel quasi 20 per cento dei voti. Ma quel vizietto tutto comunista che consentì la vittoria di Franco grazie alla strage operata nella sinistra non comunista, alla fine ha prevalso. Così D’Alema e il suo gregario Pierluigi Bersani non hanno resistito e hanno portato al disastro. C’è una forma di perversità crudele nel Destino dell’ex Pci, manifestazione tangibile della volontà divina. Nella sua prima mutazione, il Pds guidato prima da Achille Occhetto e poi soprattutto da Massimo D’Alema, guidò la lotta a Bettino Craxi e al Psi e alla Dc. Il risultato fu che all’Italia fu riservato il regalo di essere guidata da Silvio Berlusconi. Poi il Pd, nuova mutazione, guidò la guerra senza quartiere a Berlusconi. Il risultato fu Beppe Grillo. In questi 20 anni che tanti hanno definito età Berlusconiana, in realtà l’Italia è diventata sempre più un paese di Socialismo reale. Metà di noi non pagano tasse, non perché evasori ma perché esonerati dalla legge. La propaganda pauperistica del Pd, accompagnata dai disastrosi errori di Mario Monti e l’inefficacia delle sue poche iniziative positive (pensate al ritardo biblico dei pagamenti della PA) hanno fornito argomenti e brodo di cultura alla protesta grillina. Se non sarà ripescato per qualche miracolosa procedura. D’Alema finalmente uscirà di scena. Finalmente, ma forse troppo tardi.
Agit-Prop. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Agitprop è l'acronimo di отдел агитации и пропаганды (otdel agitatsii i propagandy), ossia Dipartimento per l'agitazione e la propaganda, organo del comitato centrale e regionale del Partito comunista dell'Unione sovietica il quale fu in seguito rinominato «Dipartimento ideologico». Nella lingua russa il termine «propaganda» non presentava nessuna connotazione negativa, come in francese o inglese, significava «diffusione, disseminazione, d'idee ». Attività e obbiettivi dell'Agitprop erano diffondere idee del marxismo-leninismo, e spiegazioni della politica attuata dal partito unico, oltre che in differenti contesti diffondere tutti i tipi di saperi utili, come per esempio le metodologie agronome. L'«agitazione» consisteva invece nello spingere le persone ad agire conformemente alle progettualità d'azione dei dirigenti sovietici.
Forme. Durante la Guerra civile russa l'Agitprop ha assunto diverse forme:
La censura della stampa: la strategia bolscevica fin dall'inizio è stata quella di introdurre la censura nel primo mezzo di comunicazione per importanza, ovvero il giornale. Il governo provvisorio, nato dalla rivoluzione di marzo contro il regime zarista, abolì la pratica secolare della censura della stampa. Questo creò dei giornali gratuiti, che sono sopravvissuti con il loro proprio reddito.
La rete di agitazione orale: la leadership bolscevica capì che per costruire un regime che sarebbe durato, avrebbero avuto bisogno di ottenere il sostegno della popolazione russa contadina. Per farlo, Lenin organizzò una festa comunista che attirò i soldati smobilitati (tra gli altri) ad assumere un'ideologia e un comportamento bolscevico. Questa forma si sviluppò soprattutto nelle zone rurali e isolate della Russia.
L'agitazione di treni e navi: per espandere la portata della rete di agitazione orale, i bolscevichi usarono i mezzi moderni per raggiungere più in profondità la Russia. I treni e le navi effettuarono agitazioni armate di volantini, manifesti e altre varie forme di agitprop. I treni ampliarono la portata di agitazione in Europa orientale, e permisero la creazione di stazioni di agitprop, composte da librerie di materiale di propaganda. I treni furono inoltre dotati di radio e di una propria macchina da stampa, in modo da poter riferire a Mosca il clima politico di una determinata regione, e di ricevere istruzioni su come sfruttare al meglio ogni giorno la propaganda.
Campagna di alfabetizzazione: Lenin capì che, al fine di aumentare l'efficacia della sua propaganda, avrebbe dovuto aumentare il livello culturale del popolo russo, facendo scendere il tasso di analfabetismo.
L'AGIT-PROP. Questa pagina è tratta da: La Turbopolitica, sessant'anni di comunicazione politica e di scena pubblica in Italia: 1945/2005 (riassunto) di Anna Carla Russo. L’agit-prop (Agitazione e Propaganda). I militanti costituiscono l’esercito dei partiti di massa e le caratteristiche del militante sono la spinta ideologica, dedizione alla causa, rispetto della disciplina interna, ampia disponibilità e proprio su questo si fonda l’organizzazione e la sua presenza sul territorio, vivacità e visibilità. L’attività del militante è molto preziosa, ma non ha un prezzo il militante infatti dedica la sua esistenza alla causa politica ed è sempre attivo in qualsiasi luogo, è l’anima dell’organizzazione e delle associazioni, circoli, polisportive, dopolavori, insomma tutto ciò che coinvolge la vita dell’iscritto. La campagna elettorale per le elezioni del 1948 trasforma i partiti in giganti macchine propagandistiche che coinvolgono migliaia di militanti; la Dc mobilita tutte le province giungendo a 90. Attivisti; più estesa è la macchina propagandista dei Comitati civici che coinvolgono anche i fedeli arrivando a 300.000 volontari, anche Pci e Psi uniti nel Fronte democratico popolare nel 1948 hanno oltre due milioni di iscritti al partito di Togliatti organizzati in 10.000 sezioni che sovrintendono oltre 52.000 cellule; anche i numeri del Psi sono notevoli, il partito infatti si afferma nel 1946 con oltre quattro milioni e mezzo di voti come secondo partito italiano e primo nel Nord-Italia. Secondo il Pci la crescita politica deve procedere di pari passo con la crescita dell’individuo e con il raggiungimento di un suo maggior livello di istruzione e quindi lo sforzo educativo- organizzativo del partito richiede modalità diverse, tra il 1945 e il 1950 coinvolgono 52.713 partecipanti. Anche per i socialisti e le organizzazioni cattoliche i militanti devono crescere sia nel numero che nella preparazione; nel 1948 i Comitati civici improvvisano un corso per migliaia di volontari e dieci anni dopo nasce l’Unione Nazionale degli Attivisti Civici ossia una rete ben organizzata che nel 1958 raduna a Roma 1500 responsabili di una capillare attività di formazione svolta mediante corsi zonali e rurali. I corsi sono tenuti da Dirigenti della URA Campania che sviluppano argomenti quali: l’antimarxismo; al dottrina sociale della Chiesa: gli enti di Previdenza e Assistenza in Italia e la struttura e l’inserimento nella vita italiana del Comitato Civico. La stessa Azione cattolica intensifica l’opera di apostolato e formazione dando vita in tutta Italia a missioni religioso-sociali i cui responsabili vengono preparati in tre corsi nazionale di aggiornamento. Anche la Dc si occupa di formare i militanti organizzando 31 corsi provinciali; secondo Fanfani i contatti instaurati tramite le sezioni non erano efficaci quanto il colloquio personale, la riunione familiare o il dibattito amichevole al circolo e quindi il contatto personale e l’azione assidua dei militanti ricopriva un ruolo centrale. Alla metà degli anni ’60 i militanti dei due fronti sono coloro che dedicano tempo ed energie all’animazione del partito e aderiscono a un ideale politico applicandosi per la sua realizzazione. Le basi militanti cattolica e comunista differiscono per il significato che attribuiscono alla militanza e nel loro gradi di politicizzazione. Per gli attivisti del Pci la partecipazione militante coinvolge l’intera sfera degli interessi e delle attività individuali; per gli attivisti democristiani l’integrazione con il partito coinvolge solo in parte la vita privata del singolo; il militante comunista basa la sua azione sulla fedeltà al partito e non esistono al di fuori del partito altre autorità se non sovranazionali, mentre l’azione del militante democristiano è sostenuta dalla convinzione di essere l’unico depositario di una verità a cui gli altri si devono convertire e oltre al partito esistono altre sorgenti autoritarie a cui fare riferimento. Ci sono differenze profonde che vedono un Pci più attivo. Anna Carla Russo
Agit-Prop. Scrive Massimo Lizzi il 24 ottobre 2015. Agit-prop: Dipartimento per l’agitazione e la propaganda, organo del comitato centrale del partito comunista dell’Urss. In russo, dice Wikipedia, propaganda, significa diffusione di idee e di saperi utili, senza la connotazione negativa che ha in francese, inglese e in italiano; una connotazione che credo influenzi molto la percezione di sé dei nostri propagandisti. Agit-prop definisce bene un certo modo di fare opinione e informazione al servizio di un leader, un partito, uno stato, una chiesa, una causa. Fabrizio Rondolino, nel confronto con Marco Travaglio, da Lilli Gruber, ha definito agit-prop il Fatto Quotidiano, giornale allarmista per una democrazia sempre messa in pericolo e per una politica sempre corrotta e impunita. Ha ragione. I toni del Fatto erano, secondo me, adeguati contro Silvio Berlusconi, non solo capo, ma padrone del centrodestra, non solo leader e premier, ma padrone della TV commerciale, disposto a commettere reati, ad usare la politica per tutelarsi da inchieste e processi, a delegittimare la magistratura e la stampa. Oltre e dopo Berlusconi, il Fatto si è rivelato monocorde. Stessi toni nei confronti dei leader del centrosinistra e dei successori al governo del cavaliere. Toni che consistono nel rappresentare i politici avversari come dei disonesti o degli imbecilli, o entrambi. Più la simpatia per Beppe Grillo. Agit-prop definisce bene anche il giornalismo di Fabrizio Rondolino. Poco importa che abbia cambiato riferimenti nel corso della sua carriera professionale, da D’Alema, a Mediaset, al Giornale, ad Europa e ora all’Unità a sostegno di Renzi, perché si può cambiare idea o mantenere la stessa idea e vederla di volta in volta incarnata in soggetti diversi. Conta lo stile che si mantiene uguale: l’enfasi con cui sostiene il suo leader, la violenza con cui contrasta gli avversari del suo leader. Tweet oltre il limite della provocazione contro i meridionali, perché il rapporto Svimez mette in difficoltà il governo, o contro le insegnanti, per le proteste contro la riforma della scuola; un blogper bastonare la minoranza PD; una rubrica sull’Unità per dileggiare il Fatto tutti i giorni. Anche Rondolino in fondo dice dei suoi avversari che sono dei disonesti o degli imbecilli. A me piace il conflitto, lo scontro, la polemica, però resto perplesso di fronte ad un modo di confliggere che nega alla controparte rispetto, autorevolezza, valore, e conduce una dissacrazione totale e permanente nei confronti di chiunque sia fuori linea: politici, giornalisti, magistrati, costituzionalisti, intellettuali. Lilli Gruber ha chiesto conto a Marco Travaglio di una didascalia molto evidente a lato di una foto di Maria Elena Boschi, pubblicata sul Fatto. “La scollatura di Maria Elena Boschi è sempre tollerata. Magari non il giorno della legge che porta il suo nome e stravolge la Costituzione”. Travaglio non ha saputo darne una giustificazione sensata e ha riproposto il solito ritornello, per cui non si può criticare una donna senza essere accusati di misoginia, per poi aggiungere che se una donna si veste in un certo modo, non deve lamentarsi dei commenti che riceve. Come se la critica ad una scollatura sia pertinente con la critica all’attività di una donna in politica e come se l’abbigliamento di una donna sia di certo concepito per compiacere lo sguardo maschile, sempre autorizzato a commentare, anche a sproposito. Rondolino ha paragonato Travaglio ai personaggi di Lino Banfi, che guardano nelle scollature, come a dargli dello sfigato, ma quella didascalia per la quale Lillì Gruber ha manifestato il suo fastidio, non è solo sfigata, è anche molesta e viene pubblicata su un giornale che ha nel sessismo il suo più importante punto debole.
ItaliaOggi. Numero 231 pag. 6 del 29/09/2009. Diego Gabutti: Non è il pluralismo che riesce a garantire l'obiettività. L'opinione pubblica, cara a tutti, è stata liquidata col colpo alla nuca della propaganda. Non è libertà di stampa e d'opinione, e non è neppure disinformazione (ci mancherebbe) ma pura e semplice indifferenza per la realtà, quella che ha corso da noi, nell'Italia delle risse da pollaio tra direttori di giornale, del conflitto d'interesse e di Michele Santoro che, credendosi un santo, si porta in processione da solo (i ceri li paga Pantalone). È una libertà di stampa in stile agit-prop: votata, in via esclusiva, all'agitazione e alla propaganda. Apposta è stata coniata l'espressione «pluralismo»: voce da dizionario neolinguistico se ce n'è mai stata una. Con «pluralismo», parola rotonda, non s'intende l'obiettività famosa (sempre che esista e c'è da dubitarne). Il «pluralismo dell'informazione» non garantisce l'informazione ma soltanto il «pluralismo». Vale a dire unicamente il diritto, assicurato a tutte le parti politiche, d'esprimersi liberamente e senza rete attraverso stampa e tivù. Non è in questione, col «pluralismo», la qualità dell'informazione, se cioè l'informazione sia attendibile e non manipolata, ovvero falsa o vera, ma soltanto la sua spartizione, affinché a tutte i racket politici sia riconosciuto il privilegio di lanciare messaggi a proprio vantaggio. Come in una satira illuminista, la libertà di stampa s'identifica con la libertà di dedicarsi anima e corpo alla propaganda: una specie d'otto per mille da pagare a tutte le chiese, sia a Bruno Vespa che a Marco Travaglio. È un concetto stravagante, ma più ancora grottesco e deforme: il «pluralismo» complicato e trapezistico sta alla libertà di stampa propriamente detta come la donna barbuta e l'uomo con due teste del luna park stanno a Naomi Campbell e a Brad Pitt. Non allarga il raggio delle opinioni ma è un guinzaglio corto che lascia campo libero soltanto alle idee fisse. Attraverso il «pluralismo» si stabilisce inoltre il principio dadaista che la sola informazione che conta è quella politica. Tutto il resto è pattume e tempo sprecato: l'occhio del giornalista, sempre più addomesticato e deferente, s'illumina soltanto quando il discorso finalmente cade sulle dichiarazioni del capopartito o sulle paturnie dell'opinion maker, cioè sul niente. È in onore del niente che da noi si esaltano le virtù del «pluralismo». Se ne vantano i meriti, lo si loda, e presto forse lo si canterà negli stadi sulle note dell'Inno di Mameli, o di Va' pensiero, come se davvero l'opinione pubblica fosse la somma di due o più opinioni private, utili a questo o quel potentato economico, a questa o quella segreteria di partito. Ascoltate con pazienza tutte le campane, ci dicono i maestri di «pluralismo», quindi fatevi un'opinione vostra, scegliendo l'una o l'altra tra quelle che vi abbiamo suonato tra capo e collo, nella presunzione che non ci sia altra opinione oltre a quelle scampanate per lungo e per largo dai signori della politica e dell'economia. Suprema virtù dell'informazione è diventata così l'equidistanza: l'idea, cioè, che il buon giornalismo illustri senza prendere partito tutte le opinioni lecite, e che non ne abbia mai una propria, diversa da quelle angelicate. In ciò consisterebbe, secondo chi se ne vanta interprete e campione, l'opinione pubblica famosa, il cui fantasma viene evocato ogni giorno (esclusivamente per amore della frase a effetto) proprio da chi l'ha liquidata col colpo alla nuca della propaganda e dell'agitazione di parte e di partito: gl'intellettuali snob che celebrano messa nelle diverse parrocchie ideologiche, le star miliardarie dei talk show, i fogli di destra e di sinistra che hanno preso a modello la «Pravda» (e, per non farsi mancare niente, anche la stampa scandalistica inglese).
Il falso allarme antifascismo: l'onda nera è una pozzanghera, scrive Francesco Maria Del Vigo, Martedì 06/03/2018, su "Il Giornale". Più che un'onda alla fine si è capito che era una pozzanghera. Quella nera. Vi ricordate la campagna ossessiva che per quasi un anno ci ha tambureggiato nelle orecchie? «All'armi tornano i fascisti!». Giornali e media di sinistra avevano scoperto un filone sempreverde, garanzia di perenne polemica: cioè terrorizzare l'opinione pubblica convincendola del ritorno delle squadracce di Benito Mussolini. Ora, per smontare questa fake news, sarebbe bastato un po' di buon senso. Non sembra che negli ultimi anni si siano impennate le vendite di orbace, fez, manganelli e olio di ricino. Certo, come coraggiosamente svelato da Repubblica, in Veneto c'era un bagnino che aveva tappezzato il suo stabilimento di cimeli (di pessimo gusto) del Ventennio. Ma anche in questo caso il buonsenso non è stato reperito. Fino a quando un giudice ha derubricato l'episodio all'innocua categoria del folclore. E poi, decine e decine di accorati articoli sull'irresistibile ascesa delle tartarughe di Casapound e sui camerati di Forza Nuova. Sociologi e psicologi in campo per spiegare questo ritorno al passato: disagio sociale, periferie, mancata scolarizzazione, emarginazione. Persino la stampa estera - abbindolata da quella nostrana - si era interessata allo strano morbo passatista che sembrava aver infettato lo Stivale, nella memoria del celeberrimo portatore di stivali rigorosamente neri. Ecco, ora possiamo dire che dove non è arrivato il buonsenso sono arrivate le urne. Perché se ci fosse stata una proporzione tra lo spazio mediatico concesso al «pericolo fascista» e il successo elettorale dello stesso, Casapound sarebbe dovuta essere almeno il terzo partito in Parlamento e Simone Di Stefano avrebbe dovuto stappare bottiglie di autarchico prosecco. E invece, la maiuscola deriva mussoliniana si è scoperta soffrire di nanismo. Con il suo 0,9 per cento di preferenze raccolte, Casa Pound smonta la più grande balla della campagna elettorale. Una manciata di mani tese si sono abbassate per infilare la loro scheda nell'urna. Si sgonfia e precipita l'aerostato, pompato ad arte, della marea nera. Il ritorno del fascismo era solo un maldestro tentativo di tenere insieme una sinistra fratturata e scomposta. Il babau non esiste. O, quanto meno, esiste ma non è certo una marea. Si è trattato solo di un procurato allarme. Il paradosso è che a questo giro non solo non sono entrati in Parlamento i nipotini del Duce, ma non è entrato nemmeno un partito che porti la parola sinistra nel nome e nella ragione sociale. Uno scherzo della storia. Un bello scherzo.
GLI SPIN DOCTOR. PERSUASORI DEI GOVERNI.
Dr. Facebook e Mr. Hide, scrive il 24 marzo 2018 Roberto Sommella (Direttore Relazioni Esterne Autorità Antitrust, fondatore de La Nuova Europa) su "Il Corriere del Giorno". Le relazioni digitali sarebbero quindi “legate a una minore depressione, a una ridotta ansia e a un maggior grado di soddisfazione alla propria vita”. Quando su Facebook si ricordano i 50 milioni di morti della seconda guerra mondiale e qualcuno grida alla propaganda invece di ripassare la storia, emerge con nettezza qual è il vero problema dell’abuso dei social network: la perdita della memoria collettiva e l’avvento di un nuovo senso delle cose. C’entra poco per chi si vota e come si può essere influenzati dall’uso distorto dei dati personali che si regalano ogni secondo alla rete. È stato ormai dimostrato come il web amplifichi i propri pregiudizi, piuttosto che sfatarli. Se uno nasce trumpiano difficilmente diventa democratico a colpi di “like”. Forse va più volentieri alle urne, ma non cambia idea. Piuttosto le ultimissime ricerche in questo campo del mondo di mezzo, tra il reale e il virtuale, si sono concentrate sulla modifica della percezione di se stessi, un aspetto molto più importante perché costituisce la base della società in tutte le manifestazioni della vita quotidiana. Per questo, fatte le dovute verifiche sul reale utilizzo dei 50 milioni di profili effettuato dalla Cambridge Analytica, che avrebbe influenzato le elezioni americane, la Brexit, forse anche le consultazioni italiane, e incassate le previste scuse del patron del gigante blu, Mark Zuckerberg, terrorizzato di veder sgonfiare il suo mondo dorato a colpi di ”delete”, occorre spostare il tema su almeno tre piani, relativi alla riservatezza dei propri profili, agli aspetti psicanalitici e a quelli economici.
Dal punto di vista della privacy, come ha sottolineato un esperto del settore quale Claudio Giua, per quanto riguarda l’Italia e l’Europa, il nodo da affrontare e sciogliere è la mancata applicazione da parte di Facebook di adeguate misure di sicurezza emersa dalla vicenda, “che nulla ha a che fare con la completezza finanche eccessiva dei dati personali raccolti”. C’è da chiedersi se a ribaltare la situazione basterà l’applicazione, prevista per il 25 maggio, della GDPR, la General Data Protection Regulation, il complesso di norme messe a punto dall’Unione Europea al fine di garantire un quadro entro il quale i dati degli utenti siano immagazzinati in modalità corrette e trattati nel rispetto della volontà delle parti coinvolte. Il regolamento comunitario rafforza le informative per la raccolta dei consensi, limita il trattamento automatizzato dei dati personali, stabilisce nuovi criteri sul loro trasferimento fuori dell’Unione e, soprattutto, colpisce le violazioni. In sostanza pone le basi per il riconoscimento di una sorta di diritto d’autore sui Big Data. Sarebbe un passo decisivo, perché risulta difficile accusare qualcuno di aver utilizzato la propria auto come un taxi, intascando i profitti, senza poter dimostrare la proprietà del mezzo. È proprio quello che sta accadendo con il “caso Datagate”, che potrebbe risolversi in un nulla di fatto e solo qualche scossone in borsa. Se davvero passerà una simile interpretazione, per la prima volta, queste norme sulla tutela dei dati personali nell’Unione Europea, che ha progettato anche una web tax sul fatturato, saranno pienamente valide anche per chi ha sede extracomunitaria, come Facebook, Google, Twitter, Amazon, Apple, cui risulterà più difficile eludere le responsabilità finora solo formalmente assunte nei confronti degli utenti.
Per quanto riguarda il secondo punto di vista che si deve affrontare, viene in aiuto una recentissima pubblicazione di una neuro scienziata, ricercatrice al Lincoln College dell’Università di Oxford, Susan Grenfield. In “Cambiamento mentale” appena tradotto in italiano, questa baronessa premiata con la bellezza di 31 lauree honoris causa in mezzo mondo, esamina come le tecnologie digitali stiano modificando il cervello. E a proposito dei social network, Grenfield scrive: ‘‘gli utilizzatori di Facebook sono più soddisfatti delle proprie vite quando pensano che i propri amici di Facebook siano un pubblico personale a cui trasmettere unilateralmente informazioni, rispetto a quando hanno scambi reciproci o più relazioni offline con contatti ottenuti online”.
Le relazioni digitali sarebbero quindi “legate a una minore depressione, a una ridotta ansia e a un maggior grado di soddisfazione alla propria vita”. Esattamente quello che intendeva Zuckerberg quando stilò il suo Manifesto, dove parlava della possibilità di governare gli effetti nefasti della globalizzazione attraverso la rete, esaltando le relazioni personalivirtuali: “Tutte le soluzioni non arriveranno solo da Facebook ma noi credo che potremo giocare un ruolo”. Un po’ quello che temeva George Orwell in 1984. Il problema è capire che ruolo ha la rete nei disturbi della personalità.
Nel campo della salute mentale, secondo lo psichiatra Massimo Ammaniti, si tende a valorizzare l’uso dei Big Data in quanto offrono nuove opportunità per la ricerca data, l’ampiezza sconfinata dei campioni, ma allo stesso tempo vengono sollevate perplessità sulla “veracity” e sulla “unreliability” delle informazioni provenienti da varie fonti. Riguardo alla “veracity”, la “veridicità”, ci si chiede se i dati raccolti senza una prospettiva di ricerca possano essere utilizzabili. Avere un valore in quanto fonte di informazioni rilevanti come pesa sull’immagine di sé e sulla propria autostima?
Non ci si valuta come persona, ma come “informant” che serve al mercato, non ci si valuta per quello che si è ma per quello che ognuno vale. Quando si entra in un data base fornendo le proprie informazioni personali – per esempio come quello di Cambridge Analytica – si accede a un universo di categorie che verranno definite. Forse ci si potrà chiedere che uso verrà fatto delle informazioni che ci riguardano e chi saranno coloro che utilizzeranno questi dati per pianificare le nostre vite. Può prendere corpo uno scenario appunto orwelliano, un mondo distopico, in cui si è costretti a vivere dove viene meno il senso agente di sé perché qualcun altro decide del nostro futuro senza che ne abbiamo consapevolezza. In campo psichiatrico per descrivere l’esperienza di spersonalizzazione vissuta dai malati mentali si è fatto riferimento al concetto di “pseudo comunità paranoide”, nella quale ci si sente preda di cospirazioni e raggiri senza sapere chi siano gli attori e i protagonisti, per cui è impossibile riuscire ad orientarsi e difendersi. Un articolo dell’American Journal of Epidemiology, citato in un’inchiesta della London Review of Books, ha sostenuto che a un aumento dell’1% dei like su Facebook, dei click e degli aggiornamenti corrisponde un peggioramento dal 5 all’8% della salute mentale. Difficile pensare che tutte queste informazioni possano servire a sovvertire i regimi democratici, magari si vende più pubblicità.
La domanda più pragmatica da porsi è perciò un’altra. Se cambia la personalità usando internet, cambiano anche le scelte commerciali?
Questa è la terza frontiera che si deve analizzare. Oggi si conosce cosa accade in sessanta secondi sul web. In un giro di lancette, si effettuano 900.000 login su Facebook, si inviano 452.000 “cinguettii” su Twitter, si vedono 4,1 milioni di video su YouTube, si effettuano 3,5 milioni di ricerche su Google, si postano 1,8 milioni di foto su Snapchat, si inviano 16 milioni di messaggi.
I calcoli del World Economic Forum fanno riflettere ma non dicono quanto di se stessi si lascia nel momento in cui si riversano nell’agorà digitale inclinazioni, paure, desideri. Una risposta l’ha fornita proprio l’ex socio di Mark Zuckerberg, Sean Parker, ben prima che scoppiasse il Datagate: Facebook sarebbe un loop di “validazione sociale basato su una vulnerabilità psicologica umana che cambia letteralmente la relazione di un individuo con la società e con gli altri’‘. Proprio quello che sostengono luminari come Grenfield e Ammaniti. È del tutto evidente che non esiste quindi soltanto il problema di come trattare e proteggere i dati personali ma anche di valutarne a questo punto l’affidabilità e la veridicità in tutti i gesti quotidiani. Quando si acquista un bene e si viene profilati, quando si esprime un parere e ci si sottopone al giudizio del pubblico virtuale, quando si esercita la massima espressione delle libertà personali in democrazia, il voto. Se dietro a tutte queste manifestazioni c’è ormai una sagoma sbiadita di un’identità, qualcosa la cui verosimiglianza è a rischio, il lavoro controverso e criticato di Cambridge Analytica e di chissà quante altre società, diventa solido come un castello di carte. La fake news saremo noi.
Ma Cambridge Analytica e Facebook non hanno eletto Trump. Le manipolazioni e l'uso dei dati del social non è detto siano così efficaci politicamente. E non dovrebbero diventare un alibi per le difficoltà elettorali del liberalismo e dei difensori delle società aperte, scrive Luigi Gavazzi il 21 marzo 2018 su "Panorama". È il caso di ribadirlo. Donald Trump e la Brexit non dovrebbero essere spiegati solo con la manipolazione dei dati sottratti a Facebookda Cambridge Analytica (CA). L'azione di quest'ultima, sicuramente preoccupante per la democrazia e le libertà individuali, compreso l'incubo per l'abuso dei dati conferiti a Facebook dagli utenti, difficilmente è stata davvero efficace come sostengono sia i dirigenti di CA, sia Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato all'Observer e al New York Times il lavoro fatto per Steve Bannon - stratega della campagna elettorale 2016 di Donald Trump - e per il Leave in Gran Bretagna. Indagare e scoprire violazioni di legge e pericoli politici di questa attività è doveroso. Sarebbe meglio però non venisse usata da partiti, gruppi sociali e culturali sconfitti da Trump e dalla Brexit come alibi per ignorare le proprie debolezze e l'inefficacia degli argomentiusati a favore della società aperta e del liberalismo. Insomma, evitiamo di rispondere alle minacce e alle sfide del populismo parlando solo di social network.
Se Cambridge Analytica fosse inefficiente e avesse venduto fumo. I signori di CA da anni - come ricorda David Graham su The Atlantic - cercavano di piazzare i propri servizi, dicendo che avrebbero fatto cose miracolose. Nel 2015 Sasha Issenberg di Bloomberg scrisse di CA e delle promesse della loro profilazione “psicografica”, oggi alla ribalta, con una certo scetticismo, per esempio perché il profilo ricavato dal test sullo stesso Issenberg era risultato molto diverso da quello prodotto dal Psychometrics Centre dell’Università di Cambridge (il test originale sul quale si basava l'app di usata da Aleksandr Kogan per raccogliere i dati per Ca). Del resto, Cambridge Analytica, era stata ingaggiata nel 2015 sia da Ted Cruz che da Ben Carson, due candidati repubblicani alla nomination per le elezioni presidenziali. Ebbene, il contributo di CA è risultato nullo, e le campagne hanno avuto esiti disastrosi. Le persone che dirigevano quella di Cruz hanno ben presto deciso di lasciar perdere il contributo di CA, perché irrilevante. Nel comunicare la decisione si lamentarono del fatto che stessero pagando un servizio che non esisteva neppure. C’è poi il fatto che dietro CA ci fosse, come investitore, Robert Mercer e la sua famiglia, fra i principali sostenitori e finanziatori dei repubblicani. Per Cruz era importante avere i soldi di Mercer, a costo di ingaggiare la creatura CA che Mercer finanziava.
Mercer, come noto, passò poi a Trump, convinto anche da Bannon e da Breitbart. La cosa interessante è che, d’altra parte, la stessa campagna di Trump, dopo aver abbracciato CA, l’ha successivamente abbandonata. A sostegno della tesi di Cambridge Analytica come un bluff che ha venduto più che altro fumo, ci sarebbe anche il video registrato dai reporter di Channel 4, presentati sotto la falsa identità di politici dello Sri Lanka interessati a comprare i servizi dell'azienda. Ebbene, se questi servizi fossero così efficaci come i manager di CA sostengono, che bisogno ci sarebbe stato, per venderli ai politici interessati, di proporre anche manovre per intrappolare gli avversari di questi ultimi, screditandoli con possibili scandali sessuali, sospetti di corruzione e cose del genere? Più in generale, gli osservatori citati da Graham sono da tempo assai dubbiosi dell’efficacia di queste tecniche “psicometriche”, fino a qualche anno fa chiamate di “microtargeting”.
La democrazia liberale deve comunicare meglio i pregi della società aperta. Detto questo, i democratici negli Stati Uniti, chi voleva che il Regno Unito restasse nell'Unione Europea, i partiti sconfitti dall'onda populista in Italia, chi teme l'autoritarismo sovranista e illiberale di Ungheria e Polonia, dunque, tutti coloro ai quali sta a cuore la democrazia liberale e la società aperta dovrebbero concentrarsi più sugli argomenti politici, i linguaggi, le proposte, la comunicazione per convincere gli elettori. In questo modo sarebbe più facile e probabile rendere innocuo chi cerca di manipolare le opinioni pubbliche in questi paesi, siano manovratori nell'ombra, gli hacker di Putin o di chi altro (che, vale la pena ricordarlo, sono comunque preoccupanti per la democrazia).
Facebook, ecco come Obama violò la privacy degli americani, scrive il 22 marzo 2018 Giampaolo Rossi su "Gli Occhi della Guerra" su "Il Giornale". Carol Davidsen è stata il capo Dipartimento “Media Targeting” dello staff di Obama nelle elezioni del 2012 ed è considerata un’esperta di campagne elettorali online in America. In una conferenza pubblica, tre anni dopo l’elezione di Obama, rivelò qualcosa che allora passò sotto silenzio ma che oggi è dirompente alla luce dello scandalo Cambridge Analityca: “Noi siamo stati capaci di ingerire l’intero social network degli Stati Uniti su Facebook”. Nello stesso intervento affermò che i democratici acquisirono arbitrariamente i dati dei cittadini americani a cui i Repubblicani non avevano accesso; e questo avvenne con la complicità dell’azienda americana che lo consentì tanto che la Davidsen è costretta ad ammettere che “ci fu uno squilibrio di acquisizione informazioni ingiusto” (nel video dal minuto 19:48). Nei giorni scorsi su Twitter, la Davidsen è tornata sulla questione confermando che a Facebook furono sorpresi quando si accorsero che lo staff di Obama aveva “succhiato l’intero social graph” (vale a dire il sistema di connessioni tra gli utenti) “ma non ce lo impedirono una volta capito cosa stavamo facendo”. In altre parole Facebook consentì ad Obama di rubare i dati dei cittadini americani e di utilizzarli per la sua campagna presidenziale, in quanto azienda schierata dalla parte dei democratici. D’altro canto già nel 2012, sul Time, un lungo articolo di Michael Scherer spiegava come Obama si era impossessato dei dati degli americani su Facebook con lo scopo d’intercettare l’elettorato giovanile. Esattamente nello stesso modo in cui lo ha fatto Cambrdige Analytica per la campagna di Trump: attraverso un app che carpì i dati non solo di chi aveva autorizzato, ma anche della rete di amicizie su Facebook ignare di avere la propria privacy violata. Solo che allora la cosa fu salutata come uno dei nuovi orizzonti delle politica online e descritta da Teddy Goff, il capo digital della campagna di Obama, “il più innovativo strumento tecnologico” della nuove campagne elettorali.
Zuckerberg e democratici. La stretta connessione tra Facebook e il Partito Democratico Usa è continuata anche nelle ultime elezioni come rivelano in maniera implacabile le mail di John Podesta, il potente capo della campagna elettorale di Hillary Clinton, pubblicate da Wikileaks. È il 2 gennaio del 2016, quando Sheryl Sandberg, Direttore esecutivo di Facebook e di fatto numero due dell’Azienda, scrive a Podesta una mail di augurio di Buon Anno, affermando: “Sono elettrizzata dai progressi che sta facendo Hillary”. È il periodo in cui si stanno completando i preparativi per la designazione alla primarie del Partito democratico che partiranno a febbraio; e la risposta del Capo Staff di Hillary non lascia adito a dubbi: “Non vedo l’ora di lavorare con te per eleggere la prima donna presidente degli Stati Uniti”.
Sheryl Sandberg (oggi una delle dirigenti Facebook al centro dello scandalo) è la donna che Zuckerberg volle fortemente nella sua azienda strappandola nel 2008 al diretto concorrente Google. La manager, da sempre democratica, aveva lavorato nell’amministrazione di Bill Clinton come capo staff di Larry Summers il Segretario del Tesoro, voluto proprio dal marito di Hillary. Il rapporto tra Podesta e la Sandberg è di vecchia data. Nell’agosto del 2015 lei scrive a lui per chiedergli se fosse disposto ad incontrare direttamente Mark Zuckerberg. Il grande capo di Facebook è interessato ad incontrare persone che “lo aiutino a capire come fare la differenza sulle questioni di politica a cui lui tiene maggiormente” e “comprendere le operazioni politiche efficaci per far avanzare gli obiettivi” tematici a cui lui tiene, come “immigrazione, istruzione e ricerca scientifica”. E chi avrebbe potuto farlo meglio del guru della campagna elettorale di colei che erano tutti convinti, sarebbe diventata il successivo presidente degli Stati Uniti?
Conclusione. Lo scandalo Cambridge Analytica che doveva essere l’ennesimo attacco contro Trump e la sua elezione si sta trasformando in un boomerang per Democratici e sopratutto per Facebook; l’azienda è oggi al centro del mirino delle polemiche per un modello di business che si fonda proprio sull’accaparramento e la cessione dei nostri dati di privacy che possiede nel momento in cui noi inseriamo la nostra vita, le nostre immagini, le amicizie e la nostra identità all’interno del social media. Ma la questione è sopratutto politica: quello che oggi è scandalo perché fatto per la campagna elettorale di Trump, fu ritenuta una grande innovazione quando lo fece Obama. Con in più un particolare di non poco conto: che nel caso di Obama, Facebook ne era a conoscenza e consentì la depredazione dei dati degli americani. Forse, all’interno del suo “mea culpa”, è di questo che Zuckerberg e i vertici di Facebook dovrebbero rispondere all’opinione pubblica.
Cambridge Analytica gate: il dito e la luna, scrive Guido Scorza il 21 marzo 2018 su "L'Espresso". Se esisteva ancora qualcuno al mondo che non conosceva Facebook ora lo conosce certamente. Lo scandalo che ha travolto il più popolare social network della storia dell’umanità è, da giorni, sulle prime pagine dei media di tutto il mondo. Il “diavolo” è nudo. Se non è già avvenuto, presto qualcuno titolerà così uno dei tanti feroci j’accuse all’indirizzo di Zuckerberg. Ma si commetterebbe uno dei tanti errori dei quali la narrazione mediatica globale – in alcuni Paesi tra i quali il nostro più che in altri – è piena zeppa. Vale la pena, quindi, di mettere nero su bianco qualche punto fermo in questa vicenda e provare anche a trarne qualche insegnamento senza rischiare di perder tempo a fissare il dito, lasciando correre via la luna. La prima necessaria considerazione è che nessuno ha rubato né a Facebook, né a nessun altro i dati personali dei famosi 50 milioni di utenti. Non in questa vicenda. Quei dati – stando a quanto sin qui noto – sono stati acquisiti direttamente da 270 mila utenti che hanno deliberatamente – per quanto, naturalmente, si possa discutere del livello di reale consapevolezza – scelto di renderli disponibile al produttore di una delle centinaia di migliaia di app che ciclicamente ci offrono la possibilità di velocizzare il processo di attivazione e autenticazione a fronte del nostro “ok” a che utilizzino a tal fine i dati da noi caricati su Facebook e a che – già che ci sono – si “aspirino” una quantità più o meno importante di altri dati dalla nostra vita su Facebook. Basta andare su Facebook, cliccare su “impostazioni” – in alto a destra – e, quindi, su “app” per rendersi conto di quanto ampio, variegato e affollato sia il club dei gestori di app ai quali, dalle origini del nostro ingresso sul social network a oggi abbiamo dato un permesso, probabilmente, in tutto e per tutto analogo se non identico a quello che i 270 mila ignari protagonisti della vicenda hanno, a suo tempo, dato al gestore dell’app “This is Your Digital Life”. E basta cliccare sull’icona di una qualsiasi delle app in questione per avere un elenco, più o meno lungo, delle categorie di dati che, a suo tempo, abbiamo accettato di condividere con il suo fornitore. E’ tutto li, a portata di click, anche se per aver voglia di arrivare a sfogliare le pagine in questione, forse, è stato necessario che scoppiasse uno scandalo planetario perché, altrimenti, nel quotidiano la nostra navigazione su Facebook sarebbe proseguita si altri lidi, come accaduto sino a ieri e, probabilmente, come succederà nelle prossime settimane. La seconda considerazione – direttamente correlata alla prima – è che Facebook non è stata vittima di nessun breach, nessuna violazione dell’apparato di sicurezza che protegge i propri sistemi, nessun attacco informatico di nessun genere. Non in questa vicenda, almeno. Sin qui, quindi, tanto per correggere il tiro rispetto a quello che si legge sulle prime di centinaia di giornali, nessun furto, nessuno scasso, nessun furto con scasso.
E allora? Come ci è finito Facebook sul banco degli imputati del maxi processo più imponente e severo della sua storia?
La risposta è di disarmante semplicità anche se difficile da conciliare con quanto letto e sentito sin qui decine di volte. Facebook viene portato alla sbarra proprio perché non ha subito nessun furto scasso e questa vicenda ha semplicemente confermato – non certo per la prima volta – che la sua attività – che è la stessa di milioni di altre imprese di minor successo in tutto il mondo – è pericolosa ed espone ad un naturale e ineliminabile rischio alcuni tra i diritti più fondamentali degli uomini e dei cittadini. Attenzione, però: espone a un rischio tali diritti ma non li viola. Al massimo, come accaduto nel Cambridge Analytica gate, facilita l’azione di chi tali diritti voglia consapevolmente violare. Ed è esattamente questo che accaduto nella vicenda in questione: una banda di sicari delle libertà – perché ogni definizione diversa non renderebbe giustizia al profilo dei veri protagonisti negativi della vicenda – assoldati da mandanti nemici dell’A,B,C della democrazia ha furbescamente approfittato della debolezza del sistema Facebook a proprio profitto e in danno della privacy e, forse, della libertà di coscienza di milioni di persone.
E’ la debolezza del suo ecosistema la principale colpa di Facebook. L’aver reso possibile una tragedia democratica che – ammesso che le ipotesi possano trovare una conferma scientifica – ha condizionato l’esito delle elezioni negli Stati Uniti d’America e il referendum che ha portata l’Inghilterra fuori dall’Unione Europea. E guai a dimenticare che sono queste ipotetiche conseguenze ad aver reso una vicenda che in realtà non fa altro che confermare che un uovo sodo ammaccato a una delle due estremità può stare in piedi da solo. Il famoso uovo di Colombo. Perché se la stessa tecnica – egualmente fraudolenta ed egualmente figlia dell’intrinseca debolezza dell’ecosistema Facebook – fosse stata utilizzata, come sarà stata utilizzata milioni di volte, per vendere qualche milione di aspirapolveri, oggi, evidentemente, non saremmo qui a parlarne e non sarebbe accaduto che le Autorità di mezzo mondo si siano messe in fila davanti alla porta di Menlo Park, bussando per chiedere audizioni e ispezioni, rappresentando possibili sanzioni e conseguenze salate. Guai a dire tanto rumore per nulla. E guai anche a suggerire l’assoluzione di Facebook che, tra le sue colpe, ha – ed è forse la più grave – quella di esser stato a conoscenza da anni dei rischi che 50 milioni di propri utenti stavano correndo ma di aver scelto di non informarli. Ma, ad un tempo, se si vuole evitare di lasciarsi trascinare e travolgere dall’onda lunga della sassaiola mediatica val la pena di trovare il coraggio di fissare in mente questa manciata di considerazioni di buon senso prima che di diritto. Anche perché, a condizione di trovare la necessaria serenità di giudizio e una buona dose di obiettività, da questa vicenda c’è, comunque, molto da imparare. Bisogna, però, esser pronti a non far sconti a nessuno, a mettersi in discussione in prima persona e resistere alla tentazione di dare addosso a Facebook con l’approssimazione emotiva che connota la più parte degli attacchi che si leggono in queste ore. In questa prospettiva sul banco degli imputati, accanto a Facebook, dovrebbe salirci un sistema di regole che, evidentemente, ha fallito, ha mancato l’obiettivo e si è rivelato inefficace: è quello a tutela dei consumatori, degli interessati, degli utenti basato sugli obblighi di informazione e sulle dozzine di flag, checkbox e tasti negoziali. Le lenzuolate di informazioni che Facebook – e naturalmente non solo Facebook – da, per legge, ai suoi miliardi di utenti non servono a nulla o, almeno, non sono abbastanza perché questa vicenda dimostra plasticamente che gli utenti cliccano “ok” e tappano flag senza acquisire alcuna consapevolezza sulla portata e sulle conseguenze delle loro scelte. Anzi, a volercela dire tutta, questo arcaico e primitivo sistema regolamentare produce un risultato diametralmente opposto a quello che vorrebbe produrre: anziché tutelare la parte debole del rapporto finisce con il garantire alla parte forte una prova forte e inoppugnabile di aver agito dopo aver informato a norma di legge la parte debole ed aver raccolto il suo consenso.
Così non funziona. E’ urgente cambiare rotta. Basta obblighi di informativa chilometrici e doppi, tripli e quadrupli flag su improbabili check box apposti quasi alla cieca, su schermi sempre più piccoli e mossi, esclusivamente, dalla ferma di volontà di iniziare a usare il prima possibile il servizio di turno. Servono soluzioni più di sostanza. Servono meno parole e più disegni. Servono meno codici e più codice ovvero informazioni capaci di esser lette direttamente dai nostri smartphone e magari tradotte visivamente in indici di rischiosità, attenzione e cautela.
La vicenda in questione è una storia di hackeraggio negoziale. Se si vuole per davvero evitare il rischio che si ripeta è in questa prospettiva che occorre leggerla. E sul banco degli imputati assieme a Facebook dovrebbe, egualmente, salire chi, sin qui, ha sistematicamente e scientificamente ridimensionato il diritto alla privacy fino a bollarlo come un inutile adempimento formale, un ostacolo al business o un freno al progresso. Perché non ci si può ricordare che la privacy è pietra angolare delle nostre democrazie solo quando, violandola, qualcuno – a prescindere dal fatto che riesca o fallisca nell’impresa – si mette in testa di condizionare delle consultazioni elettorali o referendarie. In caso contrario le conseguenze sono quelle che oggi sono sotto gli occhi di tutti: utenti che considerano la loro privacy tanto poco da fare il permesso a chicchessia di fare carne da macello dei propri dati personali, disponendone con una leggerezza con la quale non disporrebbero delle chiavi del loro motorino, della loro auto o del loro portafogli e Autorità di protezione dei dati personali con le armi spuntate e costrette a registrare episodi di questo genere leggendo i giornali quando non i buoi ma i dati personali di decine di milioni di utenti sono ormai lontani dai recinti.
Anche qui bisogna cambiare strada e cambiarla in fretta. E’ urgente tracciare una linea di confine netta, profonda invalicabile tra una porzione del diritto alla protezione dei dati personali che è giusto e indispensabile che resti appannaggio del mercato e una porzione che, invece, meriterebbe di entrare a far parte dei diritti indisponibili dell’uomo come lo sono le parti del corpo umano, sottratta, per legge, al commercio, agli scambi e al mercato a prescindere dalla volontà dei singoli utenti. Ed è urgente investire sulle nostre Autorità di protezione dei dati personali perché non si può, al tempo stesso, scandalizzarsi di episodi come quello della Cambridge Analytica e pretendere che un’Autorità di poche decine di professionisti e finanziata con una percentuale infinitesimale del bilancio dei nostri Stati garantisca protezione, regolamentazione e vigilanza su quello che è ormai diventato il più grande, proficuo e per questo attaccabile mercato globale. Facciamo tesoro di quello che è accaduto. Leggiamo i fatti con obiettività e, soprattutto, facciamo quanto possibile per cambiare rotta perché il problema non è Facebook e, in assenza di correttivi importanti, se anche domani la borsa condannasse Facebook all’estinzione, non avremmo affatto risolto il problema.
Dal Lago: «La disinformazione è diventata un’arma per vincere in politica», scrive Giulia Merlo il 22 Marzo 2018 su "Il Dubbio". «I social ci condizionano come facevano i manifesti della Dc nel 1948 e per questo sono diventati uno strumento decisivo sul piano della propaganda politica». «I social ci condizionano come facevano i manifesti della Dc nel 1948 e per questo sono diventati uno strumento decisivo sul piano della propaganda politica». Per Alessandro Dal Lago, sociologo e studioso dei fenomeni del web, lo scandalo che ha investito Facebook ha fatto venire alla luce lo sfruttamento illegale di informazioni che, però, già da tempo sono diventate uno strumento politico.
L’inchiesta contro Cambridge Analytica ha aperto il vaso di Pandora del lato oscuro dei social?
«Ha rivelato che i nostri dati, sia pubblici che privati come le reti di amicizia su Facebook, possono essere usate per campagne di profilazione e per la creazione di modelli di utenza. In seguito, questa mole di informazioni può essere usata per campagne di marketing e di propaganda politica. Così, il cittadino della lower class americana esasperato dalla mancanza di lavoro e che odia i vicini di casa neri diventa personaggio medio, utilizzabile come modello per studiare una propaganda mirata. Considerando che i dati analizzati hanno permesso alla Cambridge Analytica di profilare 50 milioni di utenti, si capisce la portata del fenomeno».
E questo quali problemi solleva?
«Da una parte c’è il tema della tutela della privacy e le ipotesi sono due: o Facebook sapeva dell’indebita profilazione e dunque è connivente, oppure non sapeva e questo significa che il sistema è penetrabile. Tutto sommato, questa seconda prospettiva mi sembra la più grave».
I dati sono stati usati per fare campagne politiche.
«Il rilievo politico della vicenda porta in primo piano l’esistenza di società di big data, che puntano a controllare l’opinione pubblica e che fanno parte di un mondo pressochè sconosciuto alla collettività. Basti pensare che, prima di qualche giorno fa, nessuno conosceva Cambridge Analytica, e come questa esistono altre centinaia di società analoghe. Senza complottismi, è evidente come esistano ambienti che, attraverso la consulenza strategica, sono interessati a orientale la politica globale. Altro dato, la presenza nell’inchiesta di Steve Bannon – noto suprematista bianco e stratega di Trump – mostra come la capacità di influenzare l’opinione pubblica attraverso la manipolazione dei dati sul web è più forte nella destra globale che non nella sinistra».
Davvero un post pubblicitario su Facebook è in grado di condizionare l’elettorato fino a questo punto?
«E’ più che normale che sia in grado di farlo. La comunicazione si è evoluta: partiamo dal manifesto elettorale, e penso alla geniale trovata di propaganda anticomunista della Dc del 1948, con il manifesto dei cosacchi che si abbeverano a una fontana davanti a una chiesa. Poi sono arrivati i media generalisti come la televisione e la stampa, in cui la propaganda si faceva attraverso i modelli culturali. Penso alla Rai, in cui si propagandava un modello familiare che indirettamente finiva per legittimare la Dc. Oggi la propaganda è molto cambiata: il web e i social creano un pubblico universale, che accede alla stessa sfera comunicativa. Questo permette ai manipolatori intelligenti di arrivare istantaneamente a un pubblico enorme, influenzandoli a un livello impensabile solo fino a qualche anno fa».
In Italia esistono fenomeni simili di sfruttamento del web?
«La Casaleggio Associati è un esempio di questo. La società gestisce un’enorme rete di pagine Facebook e siti collegati al blog delle Stelle e indirettamente a quello di Beppe Grillo».
E come funziona, praticamente, il meccanismo?
«Le faccio un esempio. Esiste una pagina appartenente a questa galassia che si chiama “Alessandro Di Battista presidente del consiglio”, che contiene messaggi di propaganda in stile mussoliniano del tenore di: «Ringraziamo il guerriero Di Battista, eroe nazionale». Ora, si puo dire che queste parole suonino ridicole, ma bisogna leggerle in chiave social e in base al target degli elettori che si vogliono calamitare: giovani elettori del sud Italia, con una scolarità medio bassa. A questi soggetti si propone una propaganda che da una parte martella sull’odio per la casta e dall’altra propone un eroe nazionale. Considerando che pagine come queste hanno centinaia di migliaia di follower, è facile immaginare gli effetti».
Nulla di tutto questo, però, è illegale.
«Certo che no, però esiste un problema di profonda manipolazione della realtà contro la quale non esistono strumenti di difesa adeguati. Le fake news, infatti, non sono solo le notizie inventate ma per la maggior parte si tratta di manipolazioni di notizie verosimili, che vengono caricate di retorica per diventare virali e, nello stesso tempo, nessuno verifica che si tratta di falsi».
Si può parlare di un modello politico?
«E’ certamente un modello. Politicamente, io credo sia inquietante che i parlamentari del Movimento 5 Stelle abbiano sottoscritto un contratto ridicolo nel quale tuttavia si impegnano a versare 300 euro al mese alla Casaleggio Associati, che non è un partito ma un’azienda privata di comunicazione».
Si può dire che, oggi, vince le elezioni chi sa usare meglio questi strumenti del web?
«Diciamo che i social non sono lo strumento esclusivo, ma sono diventati quello decisivo. Difficile dire quanti milioni di voti abbia spostato la campagna di Cambridge Analytica però, se si pensa alle elezioni americane, anche un milione di voti in più o in meno può garantire l’elezione alla Casa Bianca. Insomma, la propaganda sul web è in grado di spostare le decisioni».
Il web, quindi, condiziona la realtà?
«Il web ne condiziona la percezione, e questo è decisivo. La realtà e i conflitti continuano ad esistere, ma il modo in cui vengono percepiti e il luogo in cui si propongono le soluzioni è deciso dalla propaganda sul web. In questo modo la sfera di comunicazione virtuale decide l’orientamento dei settori critici dell’elettorato. Tornando ai 5 Stelle: il loro sistema di comunicazione prevede di generare un cortocircuito tra l’abile uso delle news sul web e la sistematica disinformazione».
L'errore di lasciare il web a Casaleggio, scrive Renato Mannheimer, Lunedì 26/03/2018, su "Il Giornale". L'articolo di Davide Casaleggio sul Washington Post (e poi su Il Dubbio) riporta con chiarezza il pensiero e, forse, la stessa ideologia dello stratega del Movimento Cinque Stelle. Ma contiene, al tempo stesso, tematiche di grande importanza. Occorre dire con franchezza che Casaleggio pone una questione sulla quale è cruciale riflettere con attenzione. È vero, infatti, come lui sostiene, che il Web ha cambiato radicalmente la nostra vita per moltissimi aspetti. È mutato il modo di interagire con gli altri, il modo di lavorare, si sono modificate perfino certe abitudini nei rapporti sentimentali. Tenuto conto di tutto ciò, non si capisce perché la rete non dovrebbe cambiare anche i connotati della politica e, in particolare, dei modi con cui ci relazioniamo con essa. Non solo per quanto riguarda le modalità di comunicazione o di propaganda, ma anche, specialmente, le logiche con cui il cittadino si raffronta con il potere costituito e con i suoi esponenti. Le modalità e i processi con cui si formano le credenze, i dubbi, le stesse opzioni elettorali. In altre parole, con l'avvento del Web muta non solo il modo di comunicare, ma anche quello di pensare e di rispondere agli stimoli che ci vengono dagli attori politici. Più in generale, come diversi analisti hanno osservato, siamo di fronte a un profondo cambiamento delle logiche della stessa democrazia. Questo vero e proprio sovvertimento portato dal Web mi era stato prospettato più di trent'anni fa da Casaleggio senior. Io ero a suo tempo incredulo, ma devo riconoscere che aveva in gran parte ragione nel preconizzarmi già allora gli effetti della rete sulle relazioni sociali e sugli atteggiamenti e sui comportamenti dei cittadini. Certo, Davide Casaleggio ha torto quando afferma che il Movimento Cinque Stelle è il vero alfiere di questo mutamento. Che attraverso di esso «i cittadini hanno avuto accesso al potere». In realtà il «pubblico» del M5s è limitato alla porzione di italiani peraltro fortemente caratterizzata nei suoi connotati demografici e sociali - che accede alla piattaforma Rousseau. Per di più con modalità non trasparenti e controllate dalla stessa Casaleggio e Associati. Anche le cosiddette «parlamentarie», che Casaleggio descrive come l'esercizio genuino della volontà popolare nello scegliere i candidati alle elezioni, sono state caratterizzate, come si sa, da scarsi livelli di partecipazione e da notevoli e sistematiche interferenze e condizionamenti da parte dei vertici della Casaleggio e Associati. Insomma, la pratica condotta sin qui dal M5s è assai lontana dall'avere realizzato quegli stessi ideali di partecipazione e di «vera» democrazia che Casaleggio evoca nel suo articolo. Ma questa considerazione non ci deve portare a sottovalutare il punto centrale delle sue argomentazioni. Vale a dire che, come si è detto, la Rete e in particolare i «social media» hanno radicalmente cambiato i modi di agire, di pensare e gli stessi meccanismi di formazione delle opinioni e delle scelte da parte dei cittadini. Con tutti i pericoli (il caso della Cambridge Analyitica lo dimostra) e i problemi che questi fenomeni comportano. Larga parte delle formazioni politiche operanti nel nostro paese ha affrontato solo in parte e talvolta solo in modo approssimativo questa tematica. È un limite che va superato: trascurare questa rivoluzione in atto costituisce un formidabile errore e dà spazio proprio al Movimento di Grillo.
Che ipocrisia indignarsi se le nostre vite sono in vendita, scrive Francesco Maria Del Vigo, Giovedì 22/03/2018, su "Il Giornale". Ma siamo sicuri che quello di Cambridge Analytica sia uno scandalo con la esse maiuscola? È davvero una notizia sconvolgente o è una notizia di dieci anni fa? Ricapitoliamo: molti di noi, dal 2007, quotidianamente passano ore a caricare foto, scrivere post, fare giochi, installare app e seminare like su Facebook. Cosa stiamo facendo in quel determinato momento? Stiamo perdendo tempo, dice qualcuno. Ci stiamo divertendo e stiamo socializzando, dice qualcun altro. Stiamo cedendo una mole incredibile di dati sulla nostra vita, dice Mark Zuckerberg. E lo dice chiaramente. Perché vendere, ovviamente in modo anonimo, le nostre informazioni - che poi sono i nostri gusti, i nostri hobby, i luoghi che amiamo o la marca del nostro dentifricio preferito - è la ragione sociale di Facebook. È il suo business, il suo mestiere. Cadere dalle nuvole è surreale, è come stupirsi che un calzolaio lustri le scarpe. Vi siete mai chiesti come ha fatto una matricola di Harvard a racimolare un patrimonio da 70 miliardi di euro? Coi vostri status, le foto dei vostri gatti e i vostri «mi piace». E noi tutti, iscrivendoci al social network, abbiamo accettato, più o meno consapevolmente, questo mercimonio. Ti diamo un po' di noi in cambio di quindici like di notorietà, abbiamo barattato la nostra privacy con una vetrina dalla quale poterci esporre al mondo virtuale. Dunque qual è il problema? Il problema è che in questo caso un'azienda terza ha utilizzato le «nostre» informazioni all'insaputa di Facebook. Grave, certo. Ma nulla di particolarmente sconvolgente. Un traffico che, abbiamo ragione di immaginare, accade molto spesso per scopi commerciali. Il problema è che l'opinione pubblica è disposta ad accettare di vedere comparire sulla propria bacheca la pubblicità della propria maionese preferita, ma se entra in ballo la politica la questione cambia. Se poi, come in questo caso, entrano in ballo la Brexit e gli impresentabili Trump e Bannon allora la faccenda precipita. Possibile che le anime belle della Silicon valley, quelli che per mesi ci hanno detto che Trump era un pazzo scatenato, lo abbiano lasciato giocherellare coi nostri dati? Sì, perché pecunia non olet. Nemmeno per i nerd di San Francisco. E, per loro, la nostra opinione politica è un dato come un altro, masticato e sputato dagli algoritmi per poi essere rivenduto. È l'era dei big data e della data economy. Che prima piacevano tanto agli intelligentoni à la page, ma che ora, sembra andargli di traverso. Ma è anche l'era della data politics. E, al netto delle ripercussioni giudiziarie che ci saranno su questo caso, le campagne elettorali si sposteranno sempre di più sulla profilazione degli utenti del web e sulla psicometria. Così sui nostri social, accanto alla pubblicità delle nostre cravatte preferite, compariranno anche informazioni e annunci politici. È manipolazione? No, è solo un'altra forma di marketing. Elettore avvisato...
Come si manipola l’informazione: il libro che ti farà capire tutto, scrive Marcello Foa il 17 marzo 2018 su "Il Giornale". Ci siamo: il mio saggio “Gli stregoni della notizia. Atto secondo”, pubblicato da Guerini e Associati, è in libreria da quattro giorni e i riscontri sono davvero incoraggianti, sia sui media (ne hanno parlato con ampio risalto il Corriere del Ticino, La Verità, il Giornale, Libero, Dagospia), sia da parte dei lettori. Alcuni mi hanno scritto: ma cosa c’è di nuovo rispetto alla prima edizione del 2006? C’è molto: le tecniche usate dai governi per orientare e manipolare i media, che descrissi 12 anni fa, sono valide ancora oggi e vengono applicate ancor più intensamente, per questo le ripropongo anche in questo secondo atto ma attualizzate, ampliate e, nella seconda parte del libro, arricchite da capitoli completamente nuovi, che permetteranno al lettore di entrare in una nuova dimensione: quella, sofisticatissima ma indispensabile per capire le dinamiche odierne, dell’informazione quale strumento essenziale delle cosiddette guerre asimmetriche, che vengono combattute senza il ricorso agli eserciti ma i cui effetti sono altrettanto poderosi e che raramente vengono spiegate dai media. Attenzione: non riguardano solo il Vicino Oriente o l’Ucraina, ma anche le nostre democrazie, molto più esposte di quanto si immagini. Non mi dilungo, ovviamente. Sappiate che in questo saggio approfondisco l’uso (e l’abuso) del concetto di frame dimostrando come sia stato impiegato per “vendere” al popolo l’euro e impedire per anni un dibattito oggettivo sugli effetti della moneta unica o per costruire il mito del salvataggio della Grecia e quello dell’autorazzismo nei confronti della Germania. Ne “Gli stregoni della notizia. Atto secondo” riprendo alcuni documenti governativi, noti solo agli specialisti, sull’impressionante influenza del Pentagono su film e produzioni di Hollywood, spiego il ruolo opaco degli spin doctor e delle società di PR negli allarmi sanitari (dalla Mucca Pazza all’influenza suina, da Ebola a Zika) e quale ruolo hanno avuto le Ong e le loro sorelle maggiori (le quango ovvero le Ong quasi autonome, sconosciute ai più) nelle rivoluzioni colorate e nelle operazioni di destabilizzazione di Paesi, che un tempo erano opera esclusiva dei servizi segreti. Accendo un faro sugli aspetti poco noti dell’ascesa di Macron, sull’altro volto di Obama, dedico molte pagine all’Italia, in particolare spiegando le tecniche di spin che sono state decisive nell’ascesa e nella caduta di Matteo Renzi e denuncio le ipocrisie sulle fake news, dimostrando come servano a rendere l’informazione non più trasparente ma più docile e, possibilmente, sottoposte a censura. E’ un libro che ho scritto a cuore aperto, documentatissimo, rivolto a lettori che hanno voglia di capire e di scavare oltre le apparenze, come Giorgio Gandola, che lo ha recensito su La verità, ha capito perfettamente. Spero, di cuore, che vi piaccia. Ne parlo anche nella bella intervista che mi ha fatto Claudio Messora per Byoblu e che trovate qui sotto. Vi lascio ricordandovi la presentazione che si svolgerà lunedì 19 a Milano, alla libreria Hoepli, ore 17.30 con Nicola Porro e lo stesso Gandola. Altre seguiranno in diverse città italiane. Grazie a tutti voi e, naturalmente, buona lettura!
Ecco come lavorano i persuasori (non) occulti al servizio dei governi. Gli spin doctor sfruttano le convinzioni diffuse fra il pubblico. E agitano lo spettro complottista, scrive Marcello Foa, Giovedì 15/03/2018, su "Il Giornale". Le insidie che avevo individuato nel 2006, preconizzandone le derive si sono, purtroppo, puntualmente verificate. Allora scrivevo che il fatto che i giornalisti non conoscessero le tecniche per orientare e all'occorrenza manipolare i media, avrebbe non solo reso molto più fragili le nostre democrazie, generando un sentimento di crescente sfiducia verso la classe politica, ma anche danneggiato la credibilità dell'informazione. È il mondo in cui viviamo oggi. Quelle tecniche, come allora, restano ampiamente sconosciute ai media e, naturalmente, al grande pubblico. Eppure comprenderle è indispensabile se si vuole cercare di decodificare l'attualità senza limitarsi all'apparenza, come dovrebbe fare ogni giornalista e come dovrebbe esigere ogni lettore. Certo, il mondo mediatico nel frattempo è cambiato. Un tempo la cosiddetta grande stampa aveva il monopolio dell'informazione, oggi non più e subisce la concorrenza, a mio giudizio salutare, dei siti e dei blog di informazione alternativi. Oggi il mass media è sostituito dal personal media che ognuno si costruisce attraverso la propria rete sui social. Oggi si guarda meno la tv e si passa molto più tempo a «chattare» su Whatsapp, a pubblicare foto e a tessere relazioni su Instagram. Oggi, naturalmente, la diffusione di notizie false è ancora più facile benché, come vedremo, non sia affatto una prerogativa della nostra epoca. Ma gli spin doctor sono ancora tra noi, più influenti, più informati, più pervasivi che mai. E non hanno modificato il loro obiettivo, che resta quello di condizionare noi giornalisti e, in fondo, te, caro lettore; con la decisiva complicità del mondo politico. Lo spin doctor non ha bisogno di contare sul controllo dei media, perché sa che per orientare i giornalisti è sufficiente conoscere le loro logiche. E da buon persuasore è convinto che la propaganda sia davvero efficace solo quando non è facilmente riconoscibile. Infatti opera avvalendosi di:
- una comprensione perfetta dei meccanismi che regolano il ciclo delle informazioni;
- il ricorso a sofisticate tecniche psicologiche, che gli consentono di condizionare le masse.
Tra queste ultime il concetto più importante in assoluto è quello del frame, che è stato elaborato dal linguista americano George Lakoff, il quale sostiene che ognuno di noi ragiona per cornici di riferimento costituite da una serie di immagini o di giudizi o di conoscenze di altro tipo (culturali, identitarie). Ogni giorno noi elaboriamo continuamente, senza esserne consapevoli, dei frame valoriali, che possono essere effimeri o profondi se associati, su temi importanti, a una forte emozione e ai nostri valori più radicati. La nostra visione della realtà e il nostro modo di pensare ne risultano condizionati, perché una volta impressa una larga, solida cornice, il nostro cervello tenderà a giudicare la realtà attraverso questi parametri. Tutte le notizie coerenti con il frame saranno recepite ed enfatizzate facilmente dalla nostra mente, rinforzando la nostra convinzione. Al contrario, tutte quelle distoniche tenderanno a essere relativizzate o scartate come assurde e, nei casi più estremi, irrazionali, folli o stupide. Alla nostra mente non piacciono le contraddizioni e questo spiega perché per un militante di destra gli scandali che colpiscono politici di sinistra sono percepiti come gravissimi e veritieri, mentre quelli che colpiscono la propria parte derubricati come delegittimati, irrisori o faziosi. E naturalmente viceversa. Un abile spin doctor riesce, calibrando le parole, a indirizzare l'opinione pubblica nella direzione voluta. La tecnica del frame viene usata non solo per forgiare un giudizio su notizie contingenti, ma anche per stabilire nell'opinione pubblica dei valori di fondo e dunque il confine tra politicamente corretto e politicamente scorretto; tra ciò che è conveniente o non conveniente dire su un argomento; tra ciò che l'opinione pubblica «moderata» deve considerare ragionevole o deve respingere come scandaloso, ponendo di fatto le premesse per screditare le opinioni che travalicano quel confine invisibile e che possono pertanto, all'occorrenza, essere etichettate come estremiste, complottiste o fasciste.
A proposito di cospirazionismo, sapevate che il termine fu inventato dalla Cia ai tempi dell'omicidio Kennedy per screditare le tesi di coloro che contestavano la versione ufficiale stabilita dalla Commissione Warren? Lo spiega il professor Lance Dehaven-Smith, osservando come gli effetti di quell'operazione, circostanziati nel dispaccio 1035-960, sorpresero persino i vertici di Langley. Da allora è diventato un metodo: quando vuoi screditare qualcuno lo accusi di essere complottista. Facendo così ottieni due scopi: screditi le sue tesi agli occhi della massa e lo costringi ad assumere un atteggiamento difensivo, ovvero a dimostrare di non essere cospirazionista e dunque, sovente, a moderare i toni delle sue denunce, pena l'autoghettizzazione. Che poi le sue accuse siano plausibili o fondate diventa inevitabilmente secondario; anzi, colpendo l'autorevolezza di chi critica, delegittimi in toto le sue idee. E se costui persiste lo fai apparire sacrilego. Impedisci che anche sulle critiche fondate si apra una vera riflessione pubblica. Una volta stabilito, il frame resiste nel tempo e può essere scacciato solo da un altro equivalente che abbia pari o superiore legittimità. Un esempio? La fine politica di Antonio Di Pietro. Come ricorderete a screditarlo fu un'inchiesta di «Report» sul suo (presunto) impero immobiliare, accumulato approfittando anche dei fondi del partito. Quelle accuse non erano nuove, poiché erano già state formulate da alcuni giornali come il Giornale e Libero, ma non avevano scalfito l'immagine dell'ex pm rispetto al suo elettorato, perché ritenute faziose e dunque almeno parzialmente false. Quando però sono state avanzate da Milena Gabanelli, dunque da una fonte autorevole e super partes, il leader dell'Italia dei Valori è stato travolto. Ovvero il frame Gabanelli ha scacciato il frame Di Pietro sul terreno su cui entrambi si erano costruiti la reputazione, quello dell'onestà.
GLI INFLUENCER.
“Influencer”: chi sono e cosa fanno, scrive Stefano Gallon il 15 Settembre 2014 su social-media-expert.net. Figure talmente importanti da poter ormai parlare di “Influencer Marketing”, ma esattamente chi sono? E cosa fanno? Un influencer è un utente con migliaia (se non milioni) di seguaci sparsi sui vari social network; può essere uno YouTuber, un Instagramer, un blogger o avere semplicemente una pagina su Facebook dove condivide foto, video e contenuti vari. Fin qui è come un qualsiasi utente nella rete, ma a differenza degli altri, l’Influencer è in grado letteralmente di influenzare i suoi followers.
Il ritratto di un influencer. Su “chi è” l’influencer e “cosa fa” c’è al momento molta confusione, sia da parte delle azienda che li cercano, che da parte di chi vede tutto questo come un lavoro (è noto infatti che gli influencer guadagnano molto). Riassumendo:
L’influencer può essere YouTuber, un Instagramer, un blogger (o simili);
Deve avere moltissimi followers;
Crea contenuti in grado di generare moltissime interazioni;
Viene considerato “Credibile” e “Affidabile”;
L’elemento più importante e quasi consequenziale di tutto questo è che l’Influencer è letteralmente in grado di influenzare chi solo segue, grazie non solo alla sua notorietà, ma anche alla sua “Neutralità” e “affidabilità”. In poche parole, se un grande YouTuber che seguite vi consiglia di vedere un film e voi lo fate, vi ha influenzato, ma se lo stesso YouTuber lo ha fatto perché pagato dalla casa di produzione, allora non è più un influencer, diventando di fatto un Ambassador.
Esperti, giornalisti, VIP e non… Gli Influencer non sono solamente personaggi nati sul web, spesso possono essere anche giornalisti o esperti di settore che, con i loro post, sono in grado di offrire enorme visibilità a notizie, video, prodotti o servizi, determinandone anche il successo o un fallimento. Ma c’è un’altra categoria che pur non avendo alcuna competenza specifica, può rivelarsi incredibilmente utile per promuovere qualsiasi business: i VIP. Alcuni personaggi dello spettacolo infatti, come cantanti, attori, attrici, speaker e presentatori, hanno un enorme numero di persone che legge qualsiasi cosa scrivano sui social network, come per esempio accade per lo Zoo di 105 (che seguo da sempre). Se vai a visitare la loro pagina Facebook, Instagram o Twitter vedrai come ricevano commenti, like e condivisioni per qualsiasi cosa. Adesso prova a pensare se gli speaker dello Zoo di 105 parlassero di te sui loro social network, quanta pubblicità avresti? Naturalmente questo è solamente un esempio ma spero che il senso sia chiaro.
Perché investire nell’Influencer Marketing. Coinvolgere gli influencers significa avere una pubblicità enorme ad un costo bassissimo, soprattutto se restiamo in un target specifico. Gli influencers hanno un rapporto reale con i propri seguaci che seguono i consigli dei propri beniamini e sono molto interessati a quello che condividono sui proprio social.
Dal Passa-Parola al “Click to Click”. Il buon vecchio metodo del passa-parola non è mai finito, si è solo evoluto nel “Click to Click”. Adesso infatti quando un argomento va di moda, ne parlano su Facebook, Twitter, Instagram, realizzano parodie su YouTube, scrivono articoli su blog e creano ovviamente hashtag tematiche.
Un Influencer è come un amico. Facciamo un esempio. Quando devi fare un viaggio in un altro paese, chiami i tuoi amici per avere consigli sul posto che visiterai, li chiami perché ti fidi. L’influencer per l’utente medio diventa proprio questo, una persona di fiducia, perché col tempo ha saputo guadagnarsi il rispetto dei suoi followers. Adesso hai capito perché è importante il loro parere? Allora adesso quando progetterai la tua nuova campagna pubblicitaria, non tralasciare l’influencer marketing.
Come Star Nel Web. Lunedì 9 ottobre 2017 sono stato ospite in diretta della trasmissione FUORI Tg su Rai 3, per la puntata intitolata “Come star nel web”. Durante la trasmissione ho avuto modo di trattare il delicato argomento degli influencer, affrontato anche dal Sociologo dei Media – Università Carlo Bo di Urbino – Professor Boccia Artieri. Durante la trasmissione (che dura poco più di 20 minuti) troverete importanti spunti di riflessione sul tema.
Quando gli influencer danno i numeri: statistiche e guadagni, scrive Stefano Gallon l'11 Ottobre 2017 su social-media-expert.net. Sapere quanto guadagnano gli influencer e quanto sia veramente efficace la loro comunicazione non è semplice. Youtubers, Blogger e Instagramers infatti sono (giustamente) molto riservati sul proprio lavoro e sui loro guadagni, anche anche perché il loro mestiere è complesso e molto competitivo.
Il lavoro di influencer: facciamo chiarezza. Scrivo questo paragrafo perché mi hanno spesso richiesto consulenze per “Diventare influencer” o per “Guadagnare come influencer”. Quello che rispondo a tali richieste è che a mio parere, sono sbagliate in partenza. Gli influencer sono Youtubers, Bloggers e Instagramers con un enorme numero di followers, con i quali sono realmente in grado di interagire e di influenzarne le opinioni o gli acquisti. L’influenza di questi personaggi è dovuta a diversi fattori, tra cui c’è sicuramente la loro affidabilità e credibilità. Per fare un esempio pratico, se un famoso YouTuber consiglia di vedere un film, saranno in molti i suoi seguaci che lo andranno sicuramente a vedere. Se si venisse a sapere che lo YouTuber in questione è stato pagato dalla casa di produzione per consigliare il film, ecco che la sua “imparzialità” potrebbe venir meno.
Le aziende non devono pagare gli Influencer. Riassumendo in poche righe il paragrafo precedente si può semplicemente dire che un vero influencer non deve essere pagato dalle aziende, altrimenti perderebbe la sua ragion d’essere. Quando uno YouTuber o un blogger, in grado di “influenzare”, vengono pagati e coinvolti in una campagna web marketing, devono essere definiti “Ambassador” e non “influencer”.
Quanto guadagnano le “Web Star”. Abbiamo parlato di influencer, ambassador, youtuber e quant’altro, ma in generale, queste figure in grado di vantare un enorme numero di Followers (e non solo), vengono definite anche “Web Star”, e un loro post può valere diverse migliaia di euro. Non è facile avere dati precisi sui loro guadagni, ma personalmente ritengo questa ricerca dell’Economist abbastanza attendibile.
Questa è una stima di quanto prendono per singolo post i base alla loro popolarità:
Youtube: guadagno medio per video in base al numero dei followers
100k-500k: 12,500 dollari
500k-1m: 25.000 dollari
1m-3m: 125.000 dollari
3m-7m: 187.000 dollari
Oltre 7m: 300.000 dollari
Facebook: guadagno medio per post in base al numero dei followers
100k-500k: 6.250 dollari
500k-1m: 12.500 dollari
1m-3m: 62.500 dollari
3m-7m: 93.750 dollari
Oltre 7m: 187.500 dollari
Instagram: guadagno medio per post in base al numero dei followers
100k-500k: 5.000 dollari
500k-1m: 10.000 dollari
1m-3m: 50.000 dollari
3m-7m: 75.000 dollari
Oltre 7m: 150.000 dollari
Twitter: guadagno medio per singolo post in base al numero dei followers
100k-500k: 2000 dollari
500k-1m: 4000 dollari
1m-3m: 20.000 dollari
3m-7m: 30.000 dollari
Oltre 7m: 60.000 dollari
Gli Influencer più seguiti sui social media in Italia
fonte audisocial.it
Di seguito riporto le classifiche riguardanti gli influencer più seguiti in Italia.
Classifica generale: Gianluca Vacchi, Chiara Ferragni, Mariano di Vaio.
Youtube:Favij, Ipantellas, Ghali, St3pny.
Facebook: Mariano di Vaio, Frank Matano, Fatto in casa da Benedetta, ludovia Comello, Veronica Ferraro.
Twitter: Ludovica Comello, Selvaggia Lucarelli, Sofia Viscardi, Greta Menchi, Leonardo Decarli.
Instagram: Gianluca Vacchi, Chiara Ferragni, Mariano di Vaio, Giorgia Gabriele, Favij,
Fashion: Chiara Ferragni, Mariano di Vaio, Veronica Ferraro, Martina Corradetti, Valentina Vignali.
Come indicato sul sito di Audisocial, le classifiche generate dal loro sistema non tengono conto dei personaggi che, per così dire, non sono “nati” su internet (ma provengono da altri settori come il mondo dello spettacolo), o che non utilizzano la lingua italiana come principale.
Quanto guadagno i Top influencer italiani. Dopo aver raccolto diverse informazioni a riguardo ho deciso di non trascriverle, neanche citando le fonti, per i seguenti motivi:
Non esistono mezzi per sapere con precisione quanto guadagna un influencer;
Diffondere dati a riguardo potrebbe lasciare il tempo che trova;
Basta fare una ricerca su Google per trovare centinaia di pagine sull’argomento.
Le cifre che girano sull’argomento sono diverse, come i 10 milioni di utili dichiarati nel 2015 da Chiara Ferragni o come i classici “20mila” euro al mese usati come punto di riferimento per le web star “Più ricche”. Un top influencer può guadagnare molto, su questo non c’è dubbio e non lo negano neanche loro, ma è anche vero che tutta la loro fama, e le loro entrate possono svanire molto rapidamente. Bloggers, Youtubers (etc) più intelligenti e lungimiranti infatti, non appena raggiunta una certa stabilità, iniziano a diversificare la propria attività, proponendo contenuti diversi ma anche lavorando in ambienti diversi. Non per niente oggi si vedono personaggi nati sul web fare tv, radio, cinema o musical.
Come Guadagno i Top Influencer. Anche su questo punto, per ovvi motivi, non c’è molta trasparenza, ma sicuramente possiamo dire che i Top Influencer, quando non lavorano come Ambassador, guadagnano soprattutto da sistemi come Google Adsense. Alcuni di loro (anche se qui la situazione non è chiara) possono essere pagati anche per presenziare a determinati eventi a tema.
Diventare Influencer. Ovviamente leggendo cifre come 20mila euro al mese, sono sempre di più le aspiranti web star che sognano di diventare ricche e famose. La realtà dei fatti però è che lavorare su internet e guadagnare creando contenuti (foto, video, etc) è veramente complesso. Se il vostro obiettivo è questo, per prima cosa dovete aver ben chiaro che essere (per esempio) uno Youtuber è un vero e proprio lavoro, e che pertanto non bastano 2 ore al giorno. Una volta compreso l’impegno che necessita questo lavoro, dovete iniziare a studiare argomenti come la comunicazione digitale, il web design, SEO, programmazione, fotografia, montaggio video e qualsiasi altra materia che pensate possa esservi utile per iniziare questa nuova professione.
Un Consiglio… puntate una nicchia. Come scritto in precedenza, per diventare influencer bisogna impegnarsi e studiare molto, come se si volesse avere successo in qualsiasi altro settore. Un consiglio però che mi sento di dare a tutti (e che riguarda anche le aziende) è di non iniziare puntando troppo in alto. Portando un esempio pratico, se volete diventare un travel blogger di successo, di quelli che parlano di tutto il mondo, dovete faticare moltissimo e sarà molto difficile raggiungere il vostro obiettivo. Se invece abbassate il tiro, cercando di diventare (per esempio) un travel blogger specializzato sulla Tanzania, puntando ad una nicchia specifica, avrete più possibilità di successo.
Perché le aziende amano gli influencer. Le aziende sono sempre più alla ricerca di influencer in grado di aumentare la visibilità e le vendite. Gli influencer (o almeno alcuni di loro) hanno possono raggiungere anche milioni di persone sul web, proprio nel settore dove oggi si concentrano gli utenti. Inoltre…Secondo i dati Audiweb aggiornati a luglio 2017:
In Italia in 32 milioni (dai 2 anni in su) hanno navigato su internet (desktop + mobile) quasi 56 ore;
Più del 65% degli italiani ha navigato da mobile.
Inoltre Audiweb certifica che i contenuti web, in Italia, vengono sempre più visionati da smartphone o tablet. Ogni giorno le persone si collegano mediamente circa 2 ore e mezza. In un mese la digital audience conta circa 32 milioni di utenti. Con questi numeri è semplice capire perché le aziende sono sempre più alla ricerca di figure influenti.
Perché le aziende odiano gli influencer. “Odio” è sicuramente una parola forte, che uso per evidenziare una sorta di antipatia che spesso viene manifestata nei confronti di bloggers, youtubers, etc. Non si parla molto di questo argomento ma nel “Sottobosco” della rete, si sente spesso parlare di come le aziende non abbiano fatto i salti giogia quando hanno capito che il successo di un capo di abbigliamento o di un brand poteva essere deciso un un personaggio “Nato all’improvviso sul web”. Sinceramente credo che il problema sia che in molti si rifiutano di riconoscere la grande professionalità dell web star, e l’enorme fatica che ci vuole per essere seguiti da milioni di persone.
L’importanza di YouTube. YouTube è sicuramente la piattaforma social più efficace e potente per il web marketing, molto più di Instagram e anche più di Facebook. YouTube al momento conta 24 milioni di utenti attivi mensilmente contro I 30 milioni di Facebook, in Italia, mentre nel mondo ne conta un miliardo contro I 2 del social di Zuckerberg, ma sono altri I numeri di YouTube che fanno venire le vertigini. Nel 2016, la piattaforma di video più frequentata del mondo, ha potuto vantare circa un miliardo di ore al giorno di visualizzazioni video, ma sono oltre 400 le ore di video che vengono caricate ogni giorno, e gli YouTuber più seguiti hanno dai 20 ai 60 milioni di iscritti ai propri canali. Non a caso uno degli influencer più pagati al mondo, PewDiePie, ha fatto la sua fortuna proprio su YouTube.
Conclusioni. Dopo aver letto questo articolo ne saprete sicuramente di più sui numeri degli influencer, dei social network e di internet in generali. Un ultimo consiglio che vi voglio però dare riguarda proprio questo: i numeri, un aspetto al quale non dovete dare troppa importanza. Ricordate che su internet ci sono persone reali, e se volete diventare dei veri influencer, dovete instaurare delle vere interazioni con loro. Quindi non pensate solo ad aumentare il numero dei vostri followers, pensate anche ai like, ai commenti e alle interazioni in generale che ricevete.
Gli influencer? Studio rivela: sono «virali» come le epidemie. Una ricerca spiega come si propagano i messaggi diffusi da figure-chiave della rete e aiuta a prevedere chi potrebbe essere il prossimo «untore». Ma una volta avviata la comunicazione «virale», l’influencer non ha più il controllo della sua propagazione, scrive Antonella De Gregorio il 30 gennaio 2018 su "Il Corriere della Sera". Blogger, youtuber, instagrammer: sono loro gli idoli della rete. Incisivi, comprensibili dalle masse, capaci di veicolare messaggi che diventano universali attraverso una foto, un pensiero (spesso minimo), un brano musicale. In comune non hanno solo la capacità di entrare in contatto con milioni di utenti: sono anche una particolare, efficacissima categoria di «untori». Così (all’incirca) li classificano alcuni ricercatori dell’Università delle Isole Baleari, che sullo European Physical Journal hanno pubblicato uno studio che dimostra come i messaggi diffusi da alcuni influencer si propaghino esattamente come un’epidemia. Come nelle epidemie - sostengono i ricercatori del gruppo guidato da Byungjoon Min - anche le informazioni iniziano a diffondersi partendo da singoli individui. Ecco perché, per individuare una Chiara Ferragni, stella di Instagram, un Fvij, star di Youtube, un Mariano Vaio (modello e fashion blogger) - influencer di successo sulla rete e i social network - si possono usare i modelli matematici con cui si analizza la diffusione dei virus in un’epidemia.
Il modello. Gli studi fatti per classificare l’impatto di ogni «influencer», non hanno avuto sinora grande successo perché - spiegano i ricercatori - non hanno preso in considerazione le dinamiche di diffusione. Ora invece si è scoperto che è possibile trovare gli influencer o «diffusori» di virus più importanti in modo analogo a quanto si riscontra in una rete dalla struttura ramificata, in cui è possibile calcolare la dimensione probabile di un’epidemia partendo da un singolo diffusore. È bastato - spiegano gli studiosi - esaminare il problema dalla prospettiva della trasmissione del messaggio e affidarsi al modello «Sir» (che sta per Suscettibili, infetti e rimossi), usato per spiegare la crescita e decrescita del numero di persone colpite dal virus durante un’epidemia. Seguendo questa proceduta, i ricercatori hanno ottenuto una mappa precisa di come viene trasmesso il singolo messaggio tra i membri della rete, scoprendo che la probabilità che scoppi un’epidemia è strettamente legata al punto di partenza in cui si trova il «diffusore», o influencer. Una volta che la comunicazione «virale» è iniziata, l’influencer non invece ha più alcun impatto nel controllare le dimensioni che l’epidemia potrà assumere.
Gli influencer più efficaci. Le applicazioni di questa teoria, che può essere usata anche su reti più ramificate, vanno dal marketing virale a strategie efficienti di immunizzazione, oltre all’identificazione degli influencer più efficaci. Quelli più utili, per esempio, per instaurare un forte legame tra il personaggio e un brand che viene «raccontato» attraverso le immagini e i pensieri postati.
Signori (& signore) della critica in Rete. Ecco chi sono, come lavorano e quanto fanno vendere i nuovi recensori digitali, scrive Stefania Vitulli, Domenica 18/02/2018, su "Il Giornale". «All'evento in diretta su Facebook per l'uscita di Bacio feroce di Saviano ci hanno chiamati in 25. Quattro o cinque che si occupano solo di libri, gli altri erano webstar, gente da uno o due milioni di follower, come Sofia Viscardi o Michele Bravi. Era pieno di questi sedicenni superattrezzati con le telecamerine: mi sono sentita vecchia». Giulia Ciarapica, book blogger, ma anche «giornalista analogica», ha 28 anni e di social se ne intende, ma la rete va così rapida che supera persino quelle come lei. Per fermare alcuni concetti chiave ha deciso allora di scrivere un saggio, manuale e mappa aggiornata per orientarsi nel mondo della critica letteraria 2.0: Book blogger. Scrivere di libri in Rete: come, dove, perché (Franco Cesati, pagg. 144, euro 12). Dentro ci sono prima di tutto i nomi. Dei pionieri del blog letterario, come Carmilla, Lipperatura, Vibrisse, Minima&Moralia. Delle nuove leve, come Doppiozero, Libreriamo, Piego di Libri, Flanerì. Dei grandi spazi social di promozione come Anobii, Bookcrossing o Goodreads, degli account twitter come Twletteratura, Lucia Libri, Modusvivendi, delle pagine Instagram come Petunia Ollister o Vicolostretto o dei profili Facebook come Letteratitudine, Pausa Caffè, Nuvole d'inchiostro. «In rete c'è concorrenza, anche se ci aiutiamo e ci promuoviamo tra noi. Però prima di tutto vorrei dire che cosa non siamo: non siamo influencer - spiega la Ciarapica - Non scriviamo Che bello questo libro per avere un milione di like. I like ci servono, ma per promuovere la lettura, non per fare tendenza. Scriviamo recensioni non prezzolate per promuovere titoli in modo indipendente». I recensori digitali sono cani sciolti che sanno fare tutto da soli: scrivere, tagliare, titolare, calibrarsi il tono di voce a seconda di tema e target, valutare editori e autori e saperci tenere rapporti equilibrati, fare video e foto professionali, condividere all'ora giusta della giornata (a pranzo e dopo le 18.30) e scegliere chi taggare, «per non sembrare un poveraccio che cerca la visibilità a tutti i costi». I più bravi sanno fare i numeri e i numeri sono una delle grandi novità: per la prima volta gli editori sanno chi e perché smuove copie in libreria o porta gente alle presentazioni. «Il mio blog, Chez Giulia, non è supportato da pubblicità e ha una media di 40mila lettori - commenta la Ciarapica - Ma ci sono blog quotati che fanno anche duemila visualizzazioni all'ora ogni giorno per articolo e scrivono quattro articoli a settimana, con una piccola redazione interna». Alcuni fanno vendere davvero: Modus Legendi, ad esempio, nato dall'unione di lettori forti, chiede ai follower di comprare entro un certo tempo il libro preferito in una cinquina proposta sul sito e due anni fa portò in classifica Neve, cane, piede (Exorma) di Claudio Morandini. Mentre i big come Rizzoli e Mondadori fanno ancora fatica a entrare nella logica, gli editori indipendenti e medi danno ai blogger la stessa credibilità dei media tradizionali. «Creano un contenuto che noi usiamo nei lanci, nelle presentazioni, sui nostri siti. Sembra paradossale, ma i contenuti digitali restano, non svaniscono come la carta stampata, e innescano un circolo virtuoso - ci conferma Alice di Stefano di Fazi - I lettori si affezionano alle blogger la maggior parte sono donne e si affidano ai loro giudizi: Anna Giurickovic Dato è stata adottata dalle blogger e ha fatto il botto. Ora vanno molto i blog tour: al lancio di un libro, i blog si mettono insieme e si dividono gli argomenti da trattare, uno parla solo dei personaggi, un altro della trama. Su Twitter si riportano frasi dai libri e si fanno andare in tendenza: La manutenzione dei sensi di Franco Faggiani è stato in lettura condivisa per una settimana. L'autore? Noi suggeriamo che interagisca, ma non possiamo forzarlo. L'età? Non conta: Faggiani ha 69 anni e in rete è bravissimo». Gli autori più bravi on line sono social perché a loro piace, non perché sono scrittori: «Uso la rete come gruppo di lettura condiviso: chi vive nei paesini reconditi d'Italia si collega, posta le frasi di un libro amato e si sente meno solo, meno fuori moda, meno marginale» chiarisce Nadia Terranova, autrice Einaudi e Mondadori, blogger, quasi 9mila follower su Twitter.
Attenti però: la nuova critica letteraria ci tiene alla propria indipendenza e non va costretta né condizionata. La relazione che le blogger o le youtuber creano coi propri seguaci si basa su libertà e spontaneità nella condivisione: «I miei video funzionano perché uso Youtube come motore conversazionale - ci spiega Ilenia Zodiaco, 25 anni, quasi 42mila iscritti al suo canale e oltre 5 milioni di visualizzazioni totalizzate dal 2011 - Le persone hanno l'impressione di parlare con un conoscente, instaurare un rapporto diretto e cancellare il mezzo grazie a un'informalità di fondo. La libreria è un luogo deputato che - specie a chi non legge e ha già un complesso di inferiorità - fa paura. Nei social invece è come se la lettura venisse normalizzata. Valuto il mio successo anche attraverso l'affiliazione con Ibs e Amazon, in base ai libri che vendo dal link diretto alle mie recensioni. Il massimo l'ho raggiunto con 4321 di Paul Auster: trecento copie. Ai critici tradizionali consiglio umilmente di provare a risultare più comprensibili e meno autoreferenziali». Ma chi sono i critici tradizionali? Massimo Onofri, saggista e professore ordinario di Letteratura italiana, collaboratore dell'Indice, Avvenire, La Stampa, consulente editoriale, sembra corrispondere al profilo. Eppure anche lui riserva sorprese digitali: «Ho scritto i miei ultimi due libri per La nave di Teseo Benedetti Toscani e Isolitudini, di prossima uscita interamente su Facebook. Mi affascina la conferma del lettore e il suo contributo alla documentazione, come in un seminario. Ferma restando la compiutezza formale: sul web scrivo al massimo delle mie possibilità stilistiche. In rete ho scoperto autori, come Carmen Pellegrino, che ho stanato quando scriveva di paesi abbandonati. La rete è implicitamente democratica: intavolare discussioni letterarie sul web è un atto inclusivo che potenzia l'intelligenza. Ciò non toglie che le gerarchie del mondo reale si ristabiliscono presto: se uno ha autorevolezza lo commentano, se un coglione fa la sua defecazione non se lo fila nessuno». Ma fare il critico on line è o non è un vero lavoro? «Eccome. Può portarti via anche otto ore al giorno, se lo fai seriamente - chiude la Ciarapica - Ai commenti devi rispondere subito, per cui spesso non puoi seguire altro. Devi essere competente sulle logiche del confronto, perché lo spessore di una persona si vede anche da un cinguettìo. E devi avere una formazione critica di base, se no alla lunga fatichi a distinguerti. Però ne vale la pena: sul Messaggero non posso mettermi a fare la critica all'Arbasino, invece sul mio blog certe libertà me le posso concedere».
Il Paese che non ama, scrive Mauro Munafò il 14 febbraio 2018 su "L'Espresso". Questo post di Di Maio dimostra il dominio del Movimento 5 Stelle su Facebook (gli altri partiti prendano nota). La foto che c'è all'inizio di questo post vi è familiare? Dovrebbe perché, da quanto mi risulta, è il contenuto politico più visto almeno dell'ultimo anno sul Facebook italiano. Un record i cui numeri ancora sono in crescita e che, al momento di scrittura di questo post, significa 115mila condivisioni e più di 137mila azioni tra like e faccine e circa 20mila commenti. Si tratta del post con cui Luigi Di Maio, capo politico e candidato premier del Movimento 5 Stelle, spiega a Filippo Roma come il movimento che guida intende affrontare il caso dei rimborsi che gli eletti pentastellati hanno bonificato e poi annullato. Un caso scoperchiato dal programma di Italia 1 Le Iene che sta occupando prime pagine e Tg e rappresenta un importante banco di prova per Di Maio stesso per dimostrare la sua capacità di direzione. Quante persone hanno visto questa foto? Non posso dirlo con certezza (solo l'amministratore della pagina di Luigi Di Maio lo sa). Ma incrociando i dati su post simili condivisi da altre pagine politiche, possiamo stimare una cifra di persone raggiunte non inferiore a 4-5 milioni. (Edit: l'ufficio stampa di Di Maio mi comunica che hanno superato le 10 milioni di persone raggiunte). Sì, circa 10 milioni di persone sono state raggiunte direttamente e senza intermediazione alcuna dal messaggio di Luigi Di Maio. Ora, non è questo il luogo per discutere sulla questione in sè: non importa cosa ne pensiate del caso rimborsi del M5S. Quello su cui voglio concentrarmi in questo articolo è la potenza mostrata dai 5 Stelle nell'uso dei social network: una potenza che nessun'altra forza politica italiana è in grado di schierare. La forza dei 5 Stelle infatti si fonda sulla presenza di decine di pagine legate ai diversi eletti con decine di migliaia di fan ciascuna, a cui si aggiunge un nutrito sottobosco di pagine e gruppi più o meno ufficiali. Dal mio personale monitoraggio che tengo per l'Espresso, risulta che sulle 20 pagine politiche con più fan, 8 risultano legate a esponenti del Movimento. Sulle prime 5, ben 4 sono dell'universo pentastellato. Perché questo è importante? Semplice. La pagina con più fan e maggiore portata politica in Italia è quella di Matteo Salvini, che ha da poco superato Beppe Grillo oltre la quota dei due milioni di like. Ma il vantaggio di Di Maio e soci è legato all'effetto rete: il post con la Iena di cui parliamo, infatti, mi risulta essere stato condiviso da almeno 40 importanti pagine della galassia 5 Stelle: da Grillo ad Alessandro Di Battista fino a quelle degli esponenti meno noti ma con un loro seguito comunque importante. L'algoritmo di Facebook che determina cosa vedete sulla vostra pagina tende a privilegiare i contenuti che sono stati condivisi da più pagine e contatti che seguite. Quindi se Di Maio scrive una cosa e Beppe Grillo la condivide, e se voi avete i like a entrambe le pagine (cosa piuttosto probabile se siete fan del Movimento), la probabilità che voi vediate quel contenuto si moltiplica. Quando Di Maio parla di "effetto boomerang" per i partiti che stanno cercando di cavalcare il caso dei rimborsi dei 5 Stelle per screditarli si riferisce quindi anche a questo: non conta quanti tg, siti o giornali tratteranno la notizia. Lui oggi è in grado di raggiungere direttamente milioni di potenziali elettori a cui fornirà la sua versione dei fatti senza filtri e senza dubbi. Un potere, legittimo sia chiaro, che in questa campagna elettorale è diventato quanto mai rilevante. E che forse anche dalle parti del Pd dovrebbero iniziare a prendere in seria considerazione.
LE SOLITE FAKE NEWS DEI MEDIA DI REGIME.
Si può fare giornalismo sbeffeggiando la verità? Sempre più spesso i giornali offrono ai lettori non delle notizie, ma dei commenti fondati sul ribaltamento delle notizie, scrive Piero Sansonetti il 31 Marzo 2018 su "Il Dubbio". È giusto chiedere che tra il giornalismo e i fatti realmente accaduti ci sia un qualche collegamento? O è una fisima da vecchi, legata a un’idea novecentesca e sorpassata di informazione? Ieri ho dato un’occhiata ai giornali – diciamo così – populisti, quelli più vicini, cioè, alla probabile nuova maggioranza di governo, e ho avuto l’impressione di una scelta fredda e consapevole: separiamo i fatti dalle opinioni – come dicevano gli inglesi – ma separiamoli in modo definitivo: cancellando i fatti, e permettendo alle opinioni di vivere in una propria piena e assoluta autonomia dalla realtà.
Trascrivo alcuni di questi titoli, pubblicati in prima pagina a caratteri cubitali.
Libero: «Scoprono solo ora che siamo pieni di terroristi bastardi». (Sopratitolo, piccolino: “Retata di musulmani violenti”). La Verità, titolo simile: «Così importiamo terroristi». Sopratitolo: “Presi i complici di Anis Amri». Fermiamoci un momento qui. Qual è il fatto al quale ci si riferisce? La cattura, da parte delle autorità italiane, di una serie di persone di origine nordafricana sospettate di essere legate al terrorismo. Noi non sappiamo se effettivamente queste persone siano colpevoli. Ogni tanto – sapete bene vengono arrestati, o inquisiti, anche degli innocenti. E’ successo appena una settimana fa a un tunisino, che è stato linciato (dai mass media) lui e la famiglia prima che si scoprisse che non c’entrava niente. Ma ora non è questo il punto. Proviamo a capire quali sono le cose certe in questa vicenda. Che i servizi segreti italiani, o la polizia, hanno trovato dei sospetti terroristi. Che è in corso una operazione volta a sventare attentati. Che finora l’Italia è l’unico grande paese europeo che non è stato colpito da attentati. Che l’Italia è l’unico paese che ha catturato diversi sospetti terroristi. Che, tra l’altro, l’Italia è il paese che ha preso quel famoso Anis Amri (del quale parla La Verità) e cioè l’uomo accusato di una strage in Germania. E’ sfuggito alla polizia e agli 007 tedeschi ma non ai nostri. Punto.
Traduzione in lingua giornalistica dell’arresto di Amri e di alcuni suoi probabili complici? “Importiamo terroristi”. Voi penserete: li importiamo dal mondo arabo. No, dalla Germania. In Germania loro sono liberi, qui vengono fermati.
Traduzione Invece dell’azione del governo, degli 007 e della polizia per fermare il terrorismo arabo (che ci fa invidiare da tutti gli altri europei): «Scoprono solo ora che siamo pieni di bastardi islamici». C’è una barzelletta famosa, che qualche anno fa fu polemicamente raccontata ai giornalisti da Mitterrand, il presidente francese, e qualche anno dopo da Clinton (cambiando il protagonista). In mare c’è un ragazzo che sta affogando. Mitterrand lo vede e inizia a camminare sul pelo dell’acqua, arriva fino a lui ormai allo stremo, con un braccio lo tira su, se lo carica sulle spalle e lo riporta a riva. Salvandogli la vita. Tutto ciò, come avete capito, lo fa camminando sull’acqua, e non nuotando. Il giorno dopo i giornali francesi titolano: «Mitterrand non sa nuotare».
Mi pare che la barzelletta calzi bene e possa essere riferita ai titoli di Libero e della Verità Il Fatto invece non si occupa dei terroristi ma del Pd (il grado di ossessione di Libero e Verità per i terroristi, che, come è noto, negli ultimi vent’anni hanno messo a ferro e fuoco l’Italia, è simile al grado di ossessione del Fatto per il Pd). Titola: «Rivolta anti- Renzi: “Basta Aventino vogliamo giocare”». La parola giocare è usata in senso positivo: partecipare, essere attivi. La rivolta in corso sarebbe stata avviata da Franceschini e Orlando. In cosa consisterebbe? Nel chiedere un atteggiamento amichevole del Pd verso i 5 Stelle, in contrasto con Renzi che invece vuole che il Pd resti all’opposizione. Dopodiché uno legge l’articolo del direttore, cioè di Travaglio, e scopre che Orlando e Franceschini se ne stanno in realtà zitti zitti e rintanati. E per questo Travaglio li rimprovera. Cioè li rimprovera proprio per non aver dato il via ad alcuna rivolta, che invece servirebbe. E servirebbe allo scopo di bloccare l’Aventino e di spingere il Pd ad una scelta simile a quella dei socialdemocratici tedeschi, i quali hanno chiamato i loro elettori ad un referendum interno per avere il permesso di collaborare con la Merkel. Travaglio dice che il Pd deve fare la stessa cosa. Però ci sono due imprecisioni, nel ragionamento. La prima è che il Pd non ha scelto l’Aventino, ma l’opposizione. Sono due cose molto, molto diverse. L’Aventino (cioè il ritiro dei propri deputati dal Parlamento) fu scelto dai socialisti e dai liberali, dopo l’assassinio di Matteotti (segretario del Psi). Socialisti e liberali, guidati da Giovanni Amendola, decisero di disertare il parlamento per delegittimarlo e dunque delegittimare il fascismo. I comunisti (guidati da Gramsci) fecero una scelta diversa. Dissero: restiamo dentro a combattere. Cioè rifiutarono l’Aventino e scelsero l’opposizione. In realtà andò male a tutti e due: il fascismo non fu delegittimato da Amendola e Turati né fermato da Gramsci, e finì per fare arrestare sia i socialisti sia i comunisti. Ma che c’entra tutto questo con l’attuale situazione? Niente. Qualcuno forse pensa – o ha detto che il Parlamento non è legittimo, e che le elezioni non valgono, e che i vincitori non sono legittimati a governare? Hanno detto tutti l’esatto contrario.
Quanto all’alleanza tra Merkel e Spd è una alleanza che è impossibile paragonare a una possibile alleanza tra 5 Stelle e Pd. La Spd ha accettato di sostenere la Merkel esattamente con l’idea opposta a quella di Travaglio: e cioè per sbarrare la strada ai populisti. La Merkel e i socialdemocratici hanno già governato insieme e dunque non solo affatto incompatibili. Ma lasciamo stare la polemica politica, nella quale, effettivamente, è ovvio che le opinioni prevalgano su tutto. Restiamo nel campo del giornalismo. La domanda che mi tormenta è sempre la stessa: il giornalismo moderno ha bisogno dei fatti, delle notizie vere, delle verifiche, della somiglianza con la realtà, o invece si è trasformato in una specie di nuovo genere letterario, basato sulla fantasia, e volto esclusivamente a costruire polemiche politiche o culturali e ad influenzare, indirizzare, spostare l’opinione pubblica?
Naturalmente nel giornalismo c’è stata sempre questa componente e questa aspirazione: di influenzare lo spirito pubblico. In tutte le attività culturali c’è questa aspirazione. Anche nella pittura, anche nel cinema. Però, fino a qualche anno fa, il giornalismo aveva – come la fotografia – la caratteristica di essere una attività intellettuale legata strettamente alla realtà, e il cui grado di autorevolezza si misurava esclusivamente valutando la sua vicinanza alla verità. Sempre meno è così. I giornali populisti vengono confezionati con un metodo che si fonda sul disprezzo per la realtà. La loro forza è direttamente proporzionale alla lontananza dalla realtà. Gli altri giornali oscillano, tentati dai vecchi valori e dai vecchi schemi del giornalismo europeo e americano, ma alla fine rassegnati a inseguire Vittorio Feltri. In dieci anni – cifra approssimativa – il giornalismo italiano ha completamente cambiato faccia. E le possibilità per i cittadini di essere informati si è enormemente ridotta. Dobbiamo prenderne atto e basta? Cioè considerare il divorzio tra giornalismo e verità e la sua trasformazione in genere letterario fantasioso, come un’inevitabile conseguenza della modernità? Se è così però bisognerà trovare qualche altro modo per informare e informarsi. La ricerca di questo nuovo modo dovrebbe essere la preoccupazione principale dei politici e degli intellettuali. E anche dei tantissimi giornalisti che sono stati tagliati fuori da questa nuova tendenza. La preoccupazione principale: perché nessuna democrazia può sopravvivere, senza una informazione decente.
«Ha vinto il M5S, dateci il reddito di cittadinanza». L'assalto ai Caf del barese. Succede nel piccolo comune di Giovinazzo. Cittadini in fila per ottenere i moduli, centralini tempestati dalle telefonate al servizio di Comune e Regione, scrive l'8 marzo 2018 “L’Espresso. "Ha vinto il M5S, ora dateci i moduli per Reddito di Cittadinanza": accade in alcuni Comuni della Puglia, anche a Bari, dove numerose persone fra ieri e oggi si sono presentate ai Caf locali e, nel capoluogo, anche a Porta Futuro, il centro servizi per l'occupazione. Gli episodi, già resi noti dal sindaco di Giovinazzo (Bari), Tommaso Depalma, che ha parlato di file davanti ai Caf della città, si stanno verificando anche in queste ore. A Porta futuro a Bari, racconta il responsabile, Franco Lacarra, "sono una cinquantina le persone che tra ieri e oggi hanno chiesto i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza, si tratta soprattutto di giovani". "A noi sindaci - afferma Depalma - piacerebbe poter comunicare ai cittadini che il problema della disoccupazione è risolto e che per tutti quelli che non hanno lavoro c'è un Reddito di Cittadinanza, ma credo che i cittadini siano stati ammaliati da spot elettorali". «Ovviamente - aggiunge Franco Lacarra - non si tratta di folle oceaniche, ma comunque è certo che molta gente è alla ricerca dei moduli per ottenere il reddito di cittadinanza e ci chiede informazioni». «Sono soprattutto i giovani - aggiunge - che ci chiedono informazioni, naturalmente anche i Caf potranno dare una descrizione su quello che sta accadendo».
"Ha vinto M5S, dateci i moduli per il reddito di cittadinanza". Numerose richieste ai Caf da Bari e Palermo. A Giovinazzo e nel capoluogo pugliese decine di richieste. A Palermo un Caf costretto a mettere un avviso all'esterno. Ma i Cinque Stelle della Puglia attaccano: "Una mistificazione", scrive l'8 marzo 2018 "La Repubblica". "Ha vinto il M5S, ora dateci i moduli per il reddito di cittadinanza": accade in alcuni Comuni della Puglia, anche a Bari, dove numerose persone dopo l'esito del voto si sono presentate ai Caf locali. A Bari e a Giovinazzo - ma anche a Palermo dove gira anche un falso formulario - decine di cittadini hanno chiesto informazioni sulla modulistica per accedere al reddito di cittadinanza promesso in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle. Nel job center di Porta Futuro a Bari, per esempio, in tre giorni sono pervenute da persone di età compresa tra i 30 e i 45 anni una cinquantina di richieste di accesso alla modulistica. "A chi si è affacciato chiedendo se fossero già disponibili i moduli per richiedere il reddito di cittadinanza, abbiamo dato una risposta tecnica, dicendo che non c'è al momento nessun provvedimento che codifica questo strumento", ha chiarito Giovanni Mezzina, responsabile dei servizi di orientamento di Porta Futuro Bari. Anche a Palermo le richieste iniziano ad arrivare. Una decina di persone si sono presentate al Caf Asia di Piazza Marina. E al patronato dell'Ente nazionale di assistenza sociale ai cittadini (Enasc), per frenare il via vai di chi chiedeva informazione hanno affisso un foglio con la scritta in italiano e in arabo: "In questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di cittadinanza". In Puglia, dal Comune di Giovinazzo, l'assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito, racconta che le domande su questo specifico provvedimento si aggiungono, ma in termini di curiosità, a quelle che da tempo i cittadini pongono per accedere al Reddito di dignità (Red) della Regione Puglia e al Reddito di Inclusione (Rei) del Governo. "Non c'è nessuna nuova frenesia per il reddito di cittadinanza proposto dai 5Stelle, ma curiosità sì. Ma nessun pugno sul tavolo o nessuna rivendicazione animata. Perché Giovinazzo non è una città di indolenti parassiti". Dal canto suo il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma (lista civica), ritiene "che i cittadini siano stati ammaliati da spot elettorali. La vittoria del M5S c'è stata, netta e inconfutabile, ma per il reddito di cittadinanza la vedo dura". Ma in Cinque Stella della Puglia parlano di mistificazione della realtà. E raccontano che anche il direttore di Porta Futuro, Franco Lacarra, "che per dovere di cronaca è il fratello del neoeletto deputato renziano Marco Lacarra del Pd ha confermato in maniera molto schietta che non vi era stato alcun assalto". Il comunicato di Porta Futuro, però, non smentisce: "Alcuni cittadini sono passati dal nostro sportello per chiederci informazioni e approfondimenti su questo tema. Vogliamo chiarire che tutto ciò è normale nel nostro Paese: succede ogni volta che vengono divulgate notizie rilevanti per le politiche del lavoro e per la vita dei cittadini, come è avvenuto per altre proposte legislative promosse negli ultimi mesi".
La Fake news contro il Movimento Cinque Stelle delle richieste di massa di reddito di cittadinanza, scrive il 9 marzo 2018 "Positano News". Da questa mattina in Puglia politici e giornali hanno lanciato una nuova bufala: FIUMI di persone avrebbero preso d’assalto alcuni CAF e centri per l’impiego per richiedere il reddito di cittadinanza. A lanciare l’allarme per primo il sindaco di Giovinazzo (BA) (che ha appoggiato il PD in campagna elettorale) che, commentando un articolo di una testata locale, ha parlato di “file davanti ai Caf della città”. La notizia è stata poi ripresa da “La Repubblica” che ha raccontato di “RAFFICHE DI RICHIESTE” anche per “Porta Futuro” il centro per l’impiego di Bari. UNA FOLLIA GENERALE CHE CI E’ APPARSA QUANTOMENO “SOSPETTA” ad appena 4 giorni dal voto, con un Governo nemmeno insediatosi in attesa che si sblocchi la situazione tra le varie forze politiche e dunque nessuna possibilità di legiferare. ABBIAMO DUNQUE DECISO DI ANDARE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN PRIMA PERSONA. Dopo aver girato alcuni CAF senza scorgere neanche lontani tentativi di “assalti”, abbiamo deciso di recarci direttamente a “Porta futuro”. Ingresso vuoto. Corridoi vuoti. (Dell’assalto e delle file interminabili mattutine, neanche un superstite). All’ingresso alcuni addetti ci hanno subito spiegato che “in realtà noi non abbiamo visto quasi nessuno, questa notizia ha lasciato di stucco anche noi”. Ci hanno dunque fatto parlare con il direttore Franco Lacarra (per dovere di cronaca sottolineiamo essere il fratello del neoeletto deputato renziano MARCO LACARRA (PD)) che in maniera molto schietta e onesta ci ha confermato che rispetto agli articoli letti non vi era stato alcun “assalto” ma che è solo capitato, come gli capita sempre per qualsiasi provvedimento compresi quelli regionali, che alcune persone NEGLI ULTIMI 3 GIORNI si siano recate a chiedere informazioni generiche sul reddito di cittadinanza. Abbiamo dunque chiesto al direttore di riportare la realtà dei fatti specificando di come si sia trattato di un fenomeno assolutamente normale e quotidiano per loro. Il direttore, d’accordo con noi, ha dunque richiesto al suo ufficio comunicazione di scrivere una smentita sul canale Facebook di Porta Futuro. Non sappiamo bene come sia potuto accadere ma solo pochi minuti dopo lo stesso direttore è stato contattato telefonicamente, davanti a noi, dallo staff del sindaco renziano ANTONIO DECARO (PD). Abbiamo ascoltato dunque il direttore costretto a “giustificarsi” spiegando che con questa smentita avrebbe voluto solo raccontare la verità dei fatti (a suo parere, testualmente, “una cazzata”). Nel frattempo, mentre eravamo ancora in loco, sono arrivati altri giornalisti del TG RAI, di Repubblica e pare che il direttore sia stato contattato anche dalla CNN. Tutto quanto vi abbiamo raccontato sopra è cronaca, ora traete voi le vostre conclusioni. Dal canto nostro, vorremmo solo dirvi una cosa: è evidente che la lezione di queste elezioni politiche a qualcuno non sia bastata. A questo punto vi preghiamo: se davvero avete così poca considerazione per l’intelligenza dei cittadini italiani continuate pure a diffondere falsi “scandali” e fake news, vorrà dire che alle prossime consultazioni elettorali il Movimento 5 Stelle volerà, da solo, oltre il 41%. A riveder le stelle…
Putin è davvero colpevole? Qualcosa proprio non torna nel caso Skripal, scrive il 27 marzo 2018 Marcello Foa su "Il Giornale". Siamo proprio sicuri che ad avvelenare l’ex spia Skripal e sua figlia siano stati i russi? Permettetemi di avanzare più di un dubbio esaminando con attenzione le notizie uscite finora. I punti che non tornano sono questi:
Primo. Qual è il movente? Quale l’interesse per Putin? Mi spiego: tutti riconoscono al presidente russo grande sagacia nel calibrare le sue mosse. Eccelle sia nella strategia che nella tattica. Da tempo sappiamo che gli Stati Uniti (i quali trainano l’Europa) sono impegnati in un’operazione di logoramento del Cremlino volto a ottenerne un rialliniamento su posizioni filoamericane, che potrà essere ottenuto con certezza solo attraverso un cambio di regime ovvero con l’uscita di scena di Putin. Siccome una rivolta colorata è inattuabile, lo scenario è quello di rendere insostenibile il peso delle sanzioni e dell’isolamento internazionale, inducendo le élite russe a ribellarsi al presidente appena rieletto. In questo contesto, ogni pretesto viene sfruttato per innervosire o indebolire Putin. Conoscendo l’obiettivo finale, bisogna chiedersi: ma che interesse aveva il presidente russo a tentare di eliminare un’ex spia, peraltro fuori dai giochi, ricorrendo al più spettacolare dei tentativi di omicidio, l’unico che – dopo la vicenda del pollonio – tutto il mondo avrebbe attribuito al Cremlino? Ne converrete: non ha senso. Diplomaticamente sarebbe stato un suicidio, perché avrebbe offerto all’Occidente lo spunto per un’ulteriore campagna antirussa, che infatti si è puntualmente verificata, fino all’ultimo atto, l’espulsione coordinata dei diplomatici, a cui l’Italia dell’uscente Gentiloni si è accodata, benchè avrebbe potuto – e proceduralmente dovuto – astenersi. No, Putin non è leader da commettere questi errori.
E veniamo al secondo punto, che riguarda il rumore mediatico e il furore delle accuse. Non dimentichiamolo, la comunicazione è uno strumento fondamentale nell’ambito delle guerre asimmetriche (tra l’altro è il tema che tratto nel mio ultimo saggio “Gli stregoni della notizia. Atto secondo”). Quando il rumore mediatico è assordante, univoco, esasperato, le possibilità sono due: le prove sono incontrovertibili (ad esempio l’invasione irachena del Kuwait) o non lo sono ma chi accusa ha interesse a sfruttarle politicamente, il che può avvenire solo se le fonti supreme – ovvero i governi – affermano la stessa cosa e con toni talmente urlati e assoluti da inibire qualunque riflessione critica, pena il rischio di esporsi all’accusa di essere “amici del dittatore Putin”.
Se analizziamo attentamente le dichiarazioni del governo britannico, notiamo come la stessa premier May continui a dire che “è altamente probabile” che l’attentato sia stato sponsorizzato dal Cremlino. Altamente probabile non significa sicuro, perché per esserne certi bisognerebbe provare l’origine del gas, cosa che è impossibile in tempi brevi. E nel comunicato congiunto diffuso ieri da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania si ribadisce che si tratta di «agente nervino di tipo militare sviluppato dalla Russia», che farebbe parte di un gruppo di gas noto come Novichok concepito dai sovietici negli anni Settanta. Ma sviluppato non significa prodotto in Russia. Se non è stato usato questo verbo – o un sinonimo, come fabbricato – significa che gli stessi esperti britannici non hanno prove concrete a sostegno della tesi della responsabilità russa, che pertanto andrebbe considerata come un’ipotesi investigativa. Non come un verdetto. Anche la semantica, in frammenti ad alta emotività come questi, è indicatrice e dovrebbe allertare la stampa, che invece non mostra esitazioni. Eppure di ragioni per mostrarsi più cauti ce ne sono molte. Vogliamo ricordare le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein? Ma esempi in tempi recenti non mancano. L’isteria accusatoria di queste ore ricorda quella delle “prove incontrovertibili” del 2013, secondo cui Assad aveva sterminato col gas 1300 civili, fa cui molti bambini. Scoprimmo in seguito che a usare il gas furono i ribelli per provocare un intervento nella Nato. O, sempre in Siria, nel 2107 quando Amnesty e il Dipartimento di Stato denunciarono l’esistenza di un formo crematorio in cui venivano bruciati i ribelli, rivelazione che indignò giustamente il mondo ma che venne smentita dopo un paio di settimane dallo stesso governo americano. Sia chiaro: nessuno sa chi abbia attentato alla vita di Skipal e di sua figlia e nessuna ipotesi può essere esclusa. Ma la propaganda è davvero assordante e i precedenti, nonché l’esperienza, suggeriscono maggior cautela. E un sano scetticismo: perché Putin sarà, per la grande stampa, “cattivo” ma di certo stupido non è.
Israele-Gaza: tutti i falsi miti da sfatare. Dall'onnipotenza del Mossad alla lobby ebraica e all'idea di "Due popoli due Stati". La complessità del conflitto israelo-palestinese negli anni ha generato una serie di convinzioni che non si basano sui fatti. Il dizionario del conflitto dalla A alla Z, scrivono Anna Mazzone e Paolo Papi su "Panorama". Israele ha avvertito i palestinesi della Striscia di Gaza di abbandonare le loro abitazioni. La pseudo-tregua è durata un batter di ciglia. I razzi di Hamas continuano a piovere in Israele e lo Stato ebraico ha ripreso i bombardamenti su Gaza e si prepara (forse) a un'operazione terrestre. Compresso tra i suoi falchi, Netanyahu sembra non avere chiara la rotta da seguire e intanto il numero dei morti aumenta di ora in ora. Si parla di più di 200 persone, tutti palestinesi e 1 israeliano. Il conflitto israelo-palestinese affonda la sua storia nella notte dei tempi. Difficile districarsi nelle fitte trame degli eventi, dei passi fatti in avanti e di quelli (tanti) fatti indietro. E, soprattutto, difficile non ascoltare le sirene dei "falsi miti". Idee preconcette, spesso frutto di propaganda da una parte e dall'altra, che a forza di essere ripetute sono diventate realtà. Abbiamo provato a smontarli uno per uno.
Il mito dei Paesi arabi "fratelli". Non è vero, contrariamente a quanto sostiene la vulgata corrente, che i palestinesi siano vittime esclusivamente delle rappresaglie israeliane. I Paesi arabi che confinano con Israele, Gaza e Cisgiordania sono stati, nonostante la retorica antisionista dei governi arabi strumentalmente usata in chiave interna, tra i più feroci nemici degli oltre 5 milioni di profughi palestinesi della diaspora, considerati - ovunque siano stati ospitati - come dei paria senza diritti, degli inguaribili attaccabrighe da confinare in campi sovraffollati, senza servizi né diritti e controllati a vista dalle onnipotenti polizie locali. Dalla Giordania - dove durante il settembre nero del 1970 la polizia giordana lanciò una sanguinosa operazione contro i gruppi palestinesi nei campi - al Libano - dove i 500 mila profughi che vivono nei campi sono considerati tuttora senza diritti politici e sociali - fino al Kuwait - dove i lavoratori palestinesi furono espulsi durante la prima guerra del Golfo per il sostegno che l’Olp ricevette dal regime di Saddam - non c’è Paese arabo che - al di là delle magniloquenti dichiarazioni di solidarietà ai fratelli palestinesi - abbia mai offerto un concreto aiuto ai palestinesi fuggiti dalle loro case. Sempre in Giordania (e anche in Libano) un palestinese non può studiare Legge o Medicina e non può essere proprietario di un immobile. Se questi sono "fratelli", allora forse è il caso di parlare di "parenti serpenti".
Il mito dei negoziati. Non è vero, o meglio: è estremamente improbabile, visto anche il disimpegno americano - che una soluzione al conflitto israelo-palestinese possa essere frutto di un negoziato tra i leader dei due campi, come dimostrano i fallimenti di tutti gli accordi di pace degli anni '90 e 2000. È assai più probabile che le tendenze demografiche di lungo periodo dei due gruppi etnici possano mutare, irrimediabilmente, nei prossimi decenni, la natura politica dello Stato di Israele. E questo per una ragione molto semplice: se guardiamo alle proiezioni statistiche scopriamo che al momento in Terra Santa vivono 6.1 milioni di ebrei e 5.8 milioni di arabi. La demografia dice che gli arabi fanno molti più figli degli ebrei. E' inevitabile pensare che nel giro dei prossimi dieci anni, qualora non si riuscisse a raggiungere una soluzione "Due popoli due Stati", Israele potrebbe perdere progressivamente il suo carattere di Stato ebraico. Insomma, quello che non si riesce a raggiungere da più di mezzo secolo al tavolo dei negoziati, potrebbe realizzarlo la Natura.
Il mito degli insediamenti congelati. Nonostante il governo israeliano abbia più volte dichiarato l'intenzione di congelare i nuovi piani di insediamento nella West Bank, questo non è accaduto. L'ultimo esempio è molto recente. Ai primi di giugno di quest'anno l'esecutivo israeliano ha annunciato uno stop nella costruzione di nuove abitazioni in Cisgiordania. In realtà, però, su un piano che prevedeva 1.800 nuovi insediamenti ne sono state costruite 381. Forte la pressione da parte di cinque Paesi dell'Unione europea affinché Israele congelasse i suoi piani sui nuovi insediamenti. Ma il governo Netanyahu ha fatto sapere che lo stop è arrivato per motivi "tecnici" e non in seguito alle pressioni europee.
Il mito della lobby ebraica. E' sicuramente il mito più gettonato. Quello dell'esistenza di una lobby ebraica in grado di influenzare qualsiasi avvenimento socio-economico-politico nel mondo è il cavallo di battaglia dell'esercito dei complottisti. Il mito della lobby "giudaica" affonda le sue radici nell'antisemitismo e, come tutti i miti, si fonda su idee fantasiose ripetute a oltranza, nei secoli dei secoli, fino a diventare - almeno per alcuni - delle verità inviolabili. E' il mito che ha gettato le fondamenta dello sterminio nazista e che ha motivato nei secoli l'odio nei confronti degli ebrei, accusati - dopo la Seconda guerra mondiale - di fare "marketing dell'Olocausto" per poter mantenere una situazione di potere nel mondo. In realtà, basterebbe una sola domanda per smontare il mito della lobby ebraica: perché - se la lobby esiste sul serio - Israele non riesce a modificare l'immagine che passa sulla maggior parte dei media nel mondo e che assegna allo Stato ebraico la maglia nera del carnefice a fronte di una Palestina presentata largamente come vittima indiscussa? Il vecchio adagio che la verità sta nel mezzo in realtà vale sia per Israele che per la Palestina, ed è troppo semplice e superficiale credere che esista una struttura monolitica e unica come la potente lobby ebraica, in grado di modificare i destini del mondo.
Il mito di "Due popoli, due Stati". La soluzione "Due popoli due Stati" è l'idea di creare uno Stato palestinese indipendente, che possa esistere "assieme" a Israele. Negli anni è diventata una sorta di "mito", perché sarebbe sicuramente la soluzione migliore per risolvere un conflitto così complesso, ma è pur vero che al momento le parti in causa sono troppo distanti. La creazione di creare uno Stato binazionale non ottiene ugualmente supporto e i sondaggi dimostrano che sia gli israeliani che i palestinesi preferirebbero la "mitica" soluzione "Due popoli due Stati". E allora perché questa soluzione non viene raggiunta? La risposta affonda le sue radici in anni e anni di conflitto israelo-palestinese per la terra, la legittimazione, il potere. Un tema molto sentito dai palestinesi è il controllo delle frontiere e la libertà di movimento. Movimento che Israele restringe e controlla ai check-point e all'ingresso della città di Gerusalemme. E' molto difficile negoziare una soluzione "Due popoli due Stati" se non ci si riesce a mettere d'accordo sui confini come punto di partenza. Un ulteriore motivo di conflitto è la disputa sul controllo di Gerusalemme, casa di molti siti sacri per gli ebrei, ma anche per i palestinesi (e i cristiani). C'è poi la questione degli insediamenti israeliani nella West Bank, che fa parte dei territori palestinesi. L'espansione degli insediamenti israeliani nella West Bank è vista da molti come il principale ostacolo alla costruzione di una pace stabile e duratura. Infine c'è Hamas, l'organizzazione terroristica che controlla Gaza, che non vuole l'esistenza di Israele e si batte per cancellare lo Stato ebraico dalla mappa mediorientale. Di fronte a queste considerazioni, è evidente come la soluzione "Due popoli due Stati", pur essendo la migliore da praticare, è anche un falso mito da sfatare. Almeno finché le parti non muoveranno passi in una direzione diversa da quella presa finora.
Il mito dell'estremismo "solo" arabo. Per chi crede che nel conflitto israelo-palestinese il "terrorismo" si esprima solo sul fronte islamico, questo è un altro mito da sfatare. In Terra Santa gli estremisti sono anche ebrei e rappresentano un serio problema per il governo israeliano. Ultra ortodossi, gli estremisti ebraici si sono spesso distinti per attacchi di gruppo a donne. Come nel caso della ragazza presa a sassate a Beit Shemesh (nei pressi di Gerusalemme) perché stava attaccando dei poster della lotteria nazionale per le strade del villaggio. In occasione della recente visita di Papa Francesco in Terra Santa, le autorità israeliane hanno vietato a cinque noti estremisti di mettere piede nella città di Gerusalemme. Considerano lo Stato israeliano "un nemico" e attaccano con bombe e attentati, esattamente come gli omologhi della controparte palestinese. Un nome su tutti è quello di Yigal Amir, il terrorista ultranazionalista che nel 1995 ha ucciso Yitzhak Rabin, perché non accettava l'iniziativa di pace sposata dal premier israeliano e la sua firma sugli accordi di Oslo.
Il mito dell'onnipotenza del Mossad. I servizi segreti israeliani vengono spesso portati a esempio di infallibilità, ma non è così. Anche perché è umanamente impossibile. Tuttavia, il mito dell'onnipotenza del Mossad è uno delle fondamenta su cui si articola il mito della lobby ebraica, e pertanto resiste tenacemente nel tempo. Eppure, i flop del Mossad (e dello Shin Bet, l'intelligence israeliana per gli affari interni) sono sotto gli occhi di tutti. Cominciano nell'ottobre del 1973, quando Aman, i servizi militari israeliani, giudica "Poco probabile" lo scoppio di una guerra con i Paesi arabi, Qualche giorno dopo l'esercito sirio-egiziano attacca Israele, cogliendo il Paese del tutto impreparato. Il capo di Aman fu costretto a dimettersi. Poco prima, a luglio dello stesso anno, gli agenti del Mossad danno la caccia ai leader di Settembre Nero, l'organizzazione terroristica islamica responsabile dell'uccisione di 11 atleti israeliani ai Giochi olimpici di Monaco del '72. Gli 007 israeliani credono di avere individuato Hassan Salamé (uno dei leader) in Norvegia. Lo colpiscono, ma poi scoprono di avere ucciso per sbaglio un cameriere di origine marocchina. In tempi più recenti, a gennaio del 2010 in un hotel di Dubai viene ucciso Mahmoud al Mabhouh, uno dei comandanti di Hamas. Le foto dei killer (agenti del Mossad) fanno il giro del mondo con i loro passaporti, su operazione della polizia locale. Infine, a giugno 2011 i siti dell'IDF, di Shin Bet e del Mossad vengono violati da un gruppo di hackers di Anonymous, che minaccia un attacco cibernetico contro Israele. Per due ore i siti non sono accessibili.
Violenti scontri a Gaza: 16 palestinesi uccisi dall'esercito israeliano. Oltre mille feriti. L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto l'intervento della comunità internazionale dopo la violentissima battaglia al confine con la Striscia dove ha preso il via la 'Grande marcia del ritorno' che commemora gli scontri del marzo 1976. La mobilitazione durerà fino al 15 maggio, giorno della Nakba. Fonti diplomatiche: all'Onu riunione d'urgenza a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza, scrive il 30 marzo 2018 "La Repubblica". Sedici morti e più di mille feriti nella Striscia, secondo il ministero della Sanità. Tra le vittime, la più giovane ha 16 anni. È il bilancio, ancora provvisorio secondo fonti mediche di Gaza, degli scontri tra palestinesi e forze della sicurezza israeliane scoppiati al confine tra il sud della Striscia e Israele, dove ha preso il via la “Grande marcia del ritorno” convocata da Hamas nell'anniversario dell'esproprio delle terre arabe per creare lo Stato di Israele nel 1948. Da fonti diplomatiche si apprende che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu, su richiesta del Kuwait, terrà una riunione d'urgenza sui tragici eventi di Gaza. La stessa fonte, coperta da anonimato, ha precisato che la riunione avverrà a porte chiuse a partire dalle 18.30 ora locale (le 00.30 in Italia). La Grande Marcia si è aperta nella Giornata della Terra che ricorda l'esproprio da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea, il 30 marzo 1976. Le proteste dureranno fino al 15 maggio, anniversario della fondazione di Israele, per i palestinesi "Nakba", la "catastrofe", come la chiamano, perché molti furono costretti ad abbandonare per sempre case e villaggi.
L'esercito ha aperto il fuoco in più occasioni con colpi di artiglieria, munizioni vere e proiettili di gomma vicino alla barriera di sicurezza davanti a cui hanno manifestato 17 mila palestinesi. Dalla folla sono stati lanciati sassi e bottiglie molotov verso i militari. Di primo mattino il colpo di artiglieria di un carro armato aveva ucciso Omar Samour, un agricoltore palestinese di 27 anni che era entrato nella fascia di sicurezza istituita dalle forze armate israeliane. Testimoni hanno raccontato che si trovava su terreni vicini alla frontiera e un portavoce dell'esercito ha spiegato l'episodio parlando di "due sospetti che si sono avvicinati alla barriera di sicurezza nel sud della Striscia di Gaza e hanno cominciato a comportarsi in maniera strana", e i carri armati hanno sparato contro di loro". Successivamente è stato ucciso con un colpo allo stomaco un 25enne a est di Jabaliya, nel nord del territorio costiero e altri due (fra cui un 38enne) in punti diversi della frontiera. La maggior parte dei feriti sono stati colpiti da proiettili di gomma e gas lacrimogeni.
L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto l'intervento della comunità internazionale. Yusef al Mahmoud, portavoce dell'Anp a Ramallah, ha chiesto "un intervento internazionale immediato e urgente per fermare lo spargimento del sangue del nostro popolo palestinese da parte delle forze di occupazione israeliane". L'esercito israeliano ha precisato di aver preso di mira "i principali istigatori" delle proteste violente e ha ribadito che non verrà permesso a nessuno di violare la sovranità di Israele superando la barriera di sicurezza e per questo ha anche schierato un centinaio di tiratori scelti. Secondo il generale israeliano Eyal Zamir, l'esercito è intervenuto perché ha "identificato alcuni terroristi che cercano di condurre attacchi, camuffandosi da manifestanti". Zamir ha chiesto ai residenti palestinesi di stare lontano dal confine e ha accusato Hamas di essere responsabile degli scontri in corso. Le manifestazioni sono partite da sei punti dell'arido confine tra Gaza e Israele, lungo una cinquantina di chilometri: in particolare Rafah e Khan Younis nel sud, el-Bureij e Gaza City al centro, Jabalya nel nord. Il leader di Hamas,Ismail Haniyeh, ha arringato la folla assicurando che "è l'inizio del ritorno di tutti i palestinesi". Fonti dell'esercito di Tel Aviv hanno descritto gli scontri: "Fanno rotolare pneumatici incendiati e lanciano pietre verso la barriera di sicurezza, i soldati israeliani ricorrono a mezzi antisommossa e sparano in direzione dei principali responsabili e hanno imposto una zona militare chiusa attorno alla Striscia di Gaza, una zona dove ogni attività necessita di autorizzazione".
L'esercito israeliano ha detto che una ragazzina palestinese di 7 anni è stata "mandata verso Israele per superare la barriera difensiva". "Quando i soldati hanno realizzato che era una ragazzina - ha continuato l'esercito - l'hanno presa e si sono assicurati che tornasse in sicurezza dai genitori". Secondo l'esercito - citato dai media - la ragazzina è stata inviata da Hamas che "cinicamente usa le donne e i bambini, li manda verso la frontiera e mette in pericolo le loro vite". La protesta, che secondo gli organizzatori sarebbe dovuta essere pacifica, ha l'obiettivo di realizzare il "diritto al ritorno", la richiesta palestinese che i discendenti dei rifugiati privati delle case nel 1948 possano ritornare alle proprietà della loro famiglia nei territori che attualmente appartengono a Israele. Sono giorni che Israele fa intendere che avrebbe usato le maniere forti. Il ministro della Difesa, Avigdor Liberman, aveva avvertito che qualsiasi palestinese si fosse avvicinato a una barriera di sicurezza avrebbe messo a repentaglio la propria vita. Secondo i media israeliani, Liberman da stamane si trova presso il quartier generale dell'esercito per monitorare la situazione. L'esercito ha dichiarato la zona "area militare interdetta". Scontri sono in corso anche in Cisgiordania, nelle zone di Ramallah e di Hebron. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz la mobilitazione chiamata da Hamas è anche un modo per sviare l'attenzione dal pantano politico all'interno della Striscia: dove dopo la guerra del 2014 le infrastrutture sono in rovina e la gestione delle necessità quotidiane è sempre più complicato. "Condanniamo in modo forte l'uso sproporzionato della forza da parte di Israele contro i palestinesi durante le proteste pacifiche di oggi a Gaza", ha detto il ministro degli Esteri della Turchia. "È necessario che Israele ponga fine rapidamente all'uso della forza, che innalzerebbe ulteriormente le tensioni nella regione", afferma Ankara, lanciando un invito "alla comunità internazionale a rispettare la sua responsabilità di convincere Israele ad abbandonare il suo atteggiamento ostile".
Israele spara sulla marcia palestinese: 15 morti a Gaza. Striscia di Gaza. Uomini, donne e bambini per il ritorno e il Giorno della terra: i cecchini israeliani aprono il fuoco su 20mila persone al confine. Oltre mille i feriti, scrive Michele Giorgio il 30.3.2018 su "Il Manifesto". Manifesto Il video che gira su twitter mostra un ragazzo mentre corre ad aiutare un amico con in mano un vecchio pneumatico da dare alle fiamme. Ad certo punto il ragazzo, avrà forse 14 anni, cade, colpito da un tiro di precisione partito dalle postazioni israeliane. Poi ci diranno che è stato “solo” ferito. Una sorte ben peggiore è toccata ad altri 15 palestinesi di Gaza rimasti uccisi ieri in quello che non si può che definire il tiro al piccione praticato per ore dai cecchini dell’esercito israeliano. Una strage. I feriti sono stati un migliaio (1.500 anche 1.800 secondo altre fonti): centinaia intossicati dai gas lacrimogeni, gli altri sono stati colpiti da proiettili veri o ricoperti di gomma. È stato il bilancio di vittime a Gaza più alto in una sola giornata dall’offensiva israeliana “Margine Protettivo” del 2014. Gli ospedali già in ginocchio da mesi hanno dovuto affrontare questa nuova emergenza con pochi mezzi a disposizione. Hanno dovuto lanciare un appello a donare il sangue perché quello disponibile non bastava ad aiutare i tanti colpiti alle gambe, all’addome, al torace. «I nostri ospedali da mesi non hanno più alcuni farmaci importanti, lavorano in condizioni molto precarie e oggi (ieri) stanno lavorando in una doppia emergenza, quella ordinaria e quella causata dal fuoco israeliano sul confine», ci diceva Aziz Kahlout, un giornalista.
Gli ordini dei comandi militari israeliani e del ministro della difesa Avigdor Lieberman erano tassativi: aprire il fuoco con munizioni vere su chiunque si fosse spinto fino a pochi metri dalle barriere di confine. E così è andata. Per giorni le autorità di governo e i vertici delle forze armate hanno descritto la Grande Marcia del Ritorno come un piano del movimento islamico Hamas per invadere le comunità ebraiche e i kibbutz a ridosso della Striscia di Gaza e per occupare porzioni del sud di Israele. Per questo erano stati fatti affluire intorno a Gaza rinforzi di truppe, carri armati, blindati, pezzi di artiglieria e un centinaio di tiratori scelti.
Pur considerando il ruolo da protagonista svolto da Hamas, che sicuramente ieri ha dimostrato la sua capacità di mobilitare la popolazione, la Grande Marcia del Ritorno non è stata solo una idea del movimento islamista. Tutte le formazioni politiche palestinesi vi hanno preso parte, laiche, di sinistra e religiose. Anche Fatah, il partito del presidente dell’Anp Abu Mazen che ieri ha proclamato il lutto nazionale. E in ogni caso lungo il confine sono andati 20mila di civili disarmati, famiglie intere, giovani, anziani, bambini e non dei guerriglieri ben addestrati. Senza dubbio alcune centinaia si sono spinti fin sotto i reticolati, vicino alle torrette militari, ma erano dei civili, spesso solo dei ragazzi. Israele ha denunciato lanci di pietre e di molotov, ha parlato di «manifestazioni di massa volte a coprire attacchi terroristici» ma l’unico attacco armato vero e proprio è stato quello – ripreso anche in un video diffuso dall’esercito – di due militanti del Jihad giunti sulle barriere di confine dove hanno sparato contro le postazioni israeliane prima di essere uccisi da una cannonata.
La Grande Marcia del Ritorno sulla fascia orientale di Gaza e in Cisgiordania è coincisa con il “Yom al-Ard”, il “Giorno della Terra”. Ogni 30 marzo i palestinesi ricordano le sei vittime del fuoco della polizia contro i manifestanti che in Galilea si opponevano all’esproprio di altre terre arabe per costruire comunità ebraiche nel nord di Israele. I suoi promotori, che hanno preparato cinque campi di tende lungo il confine tra Gaza e Israele – simili a quelle in cui vivono i profughi di guerra -, intendono portarla avanti nelle prossime settimane, fino al 15 maggio quando Israele celebrerà i suoi 70 anni e i palestinesi commemoreranno la Nakba, la catastrofe della perdita della terra e dell’esilio per centinaia di migliaia di profughi. Naturalmente l’obiettivo è anche quello di dire con forza che la gente di Gaza non sopporta più il blocco attuato da Israele ed Egitto e vuole vivere libera. Asmaa al Katari, una studentessa universitaria, ha spiegato ieri di aver partecipato alla marcia e che si unirà alle prossime proteste «perché la vita è difficile a Gaza e non abbiamo nulla da perdere». Ghanem Abdelal, 50 anni, spera che la protesta «porterà a una svolta, a un miglioramento della nostra vita a Gaza».
Per Israele invece la Marcia è solo un piano di Hamas per compiere atti di terrorismo. La risposta perciò è stata durissima. Il primo a morire è stato, ieri all’alba, un contadino che, andando nel suo campo, si era avvicinato troppo al confine. Poi la mattanza: due-tre, poi sei-sette, 10-12 morti. A fine giornata 15. E il bilancio purtroppo potrebbe salire. Alcuni dei feriti sono gravissimi.
Si rischia la Pasqua di rappresaglia. In Israele si rischia una Pasqua di rappresaglia, scrive Fiamma Nirenstein, Sabato 31/03/2018 su "Il Giornale". C'è confusione sui numeri ma non sul significato della «Marcia del ritorno», come l'ha chiamata Hamas. 15 morti, 1.400 feriti e 20mila dimostranti sul confine di Israele con Gaza, in una manifestazione organizzata per essere solo la prima in direzione di una mobilitazione di massa che dovrebbe avere il suo apice il 15 di maggio, giorno della Nakba palestinese, il «disastro», festa dell'indipendenza di Israele, che coinciderà anche con il passaggio dell'ambasciata americana a Gerusalemme. Un'escalation continua di eccitazione mentre cresceva l'incitamento ha visto per ben quattro volte unità di giovani armati di molotov, bombe a mano e coltelli, infiltrati dentro il confine. Un esempio limitato di quello che Hamas vorrebbe riprodurre su scala di massa, ovvero l'invasione di Israele, come nei loro discorsi ieri hanno ripetuto i leader massimi Ismail Hanyie e Yehyia Sinwar. Non a caso nei giorni della preparazione si sono svolte esercitazioni militari con lanci di razzi e incendi di finti carri armati, pretesi rapimenti e uccisioni che hanno persino fatto scattare i sistemi antimissile spedendo gli israeliani nei rifugi. Il messaggio di Hamas era chiaro: marciate, noi vi copriamo con le armi. Ma le intenzioni terroriste sono state incartate dentro lo scudo delle manifestazioni di massa e l'uso della popolazione civile, inclusi donne e bambini, è stato esaltato al massimo. Molti commentatori sottolineano che se Hamas decide di marciare, non ci sia molta scelta. E una marcia di civili risulta indiscutibile presso l'opinione pubblica occidentale, ma il messaggio sottinteso è stato spezzare il confine sovrano di Israele con la pressione della folla civile, utilizzare le strette regole di combattimento dell'esercito israeliano che mentre lo stato maggiore si arrovellava, si è trovato nel consueto dilemma delle guerre asimmetriche: tu usi soldati in divisa e il nemico soldati in abiti civili, donne, bambini, talora palesemente utilizzati come provocazione. L'esercito ha confermato che una piccola di sette anni per fortuna è stata individuata in tempo prima di venire travolta negli scontri. E in serata Israele ha bombardato con cannonate e raid aerei tre siti di Hamas a Gaza in risposta a un tentativo di attacco armato contro soldati. La protesta di Hamas - che arriva alla vigilia della festa di Pesach, la Pasqua ebraica - ha vari scopi: il primo è legato alla situazione interna di Gaza. L'uso militarista dei fondi internazionali e il blocco conseguente del progresso produttivo ha reso la vita della gente miserabile e i confini restano chiusi. È colpa della minaccia che l'ingresso da Gaza di uomini comandati da un'entità terrorista, comporta per chiunque, israeliani o egiziani. Hamas con la marcia incrementa la sua concorrenza mortale con l'Anp di Abu Mazen, cui ha cercato di uccidere pochi giorni fa il primo ministro Rami Hamdallah; minacciata di taglio di fondi urla più forte che può contro Israele, cosa su cui la folla araba, anche quella dei Paesi oggi vicini a Israele come l'Arabia Saudita e l'Egitto, la sostiene. Il titolo «Marcia del ritorno» significa che non può esserci nessun accordo sul fondamento di qualsiasi accordo di pace, ovvero sulla rinuncia all'ingresso distruttivo nello Stato ebraico dei milioni di nipoti dei profughi del '48, quando una parte dei palestinesi fu cacciata e una parte se ne andò volontariamente certa di tornare sulla punta della baionetta araba. Israele ha cercato invano di evitare che alle manifestazioni si facessero dei morti. Ma nessuno Stato sovrano accetterebbe da parte di migliaia di dimostranti guidati da un'organizzazione che si dedica solo alla sua morte una effrazione di confini. Hamas userà i nuovi shahid (povera gente) per propagandare la sua sete di morte in nome di Allah e contro Israele. Certo questo non crea in Israele maggiore fiducia verso una pace futura.
Il silenzio assordante sul massacro dei curdi, scrive Marco Rovelli il 29 marzo 2018 su Left. Fin dove arriva l’estensione dell’impunità? Fin dove ci si può spingere nel massacro e nel disprezzo del diritto? Fin dove si può farlo nella più totale indifferenza della comunità internazionale e dei media? Erdogan ci sta mostrando sul campo che questi confini sono assai estensibili. Quella porzione di Medio Oriente che dopo la dissoluzione dell’Impero ottomano prese il nome di Siria, e che adesso si è dissolta a sua volta, è il luogo ideale per riplasmare i confini di ciò che è lecito. Ed è lecito tutto ciò che si può fare, come nello stato di natura di Hobbes e Spinoza. In quello stato di natura non esiste alcuno Stato civile: l’assoluta libertà di massacro di Erdogan, allora, ci mostra che non è collassata solo la sovranità statale siriana, ma pure qualsiasi simulacro di comunità internazionale. Erdogan ha di fatto invaso la Siria, e tutto accade come nulla fosse: perché, dal punto di vista di una comunità internazionale, che non esiste in quanto comunità normata da un diritto, nulla è, in effetti. Erdogan massacra i curdi, tanto combattenti quanto civili, e, ancora, nulla è. I curdi del resto sono da cent’anni l’assoluto rimosso del Medio Oriente, vittima silenziosa delle strategie delle sovranità statali. Negli ultimi quindici anni i curdi hanno provato a mettere in discussione il principio della sovranità dello Stato-nazione, attraverso la teoria del confederalismo democratico: e così adesso, quel Leviatano si abbatte su di loro, in forma di vendetta, lacerando ancora le carni di quel popolo ribelle. Mentre il sacrificio si compie, il mondo resta ammutolito. Ma non perché sgomento dalla terribile entità di quel massacro. Piuttosto, perché nulla sa, e, se sa qualcosa, preferisce non farne parola. Così appaiono del tutto naturali le immagini di Erdogan in visita in Italia senza che nessuno dei nostri governanti abbia osato far cenno dei suoi crimini. Un’infamia inemendabile. E allora, sia gratitudine a chi è penetrato nei cancelli della fabbrica Agusta, il luogo primo della nostra complicità nel massacro in corso. È con i nostri elicotteri Agusta Westland che il massacro viene compiuto. Le pale degli elicotteri fanno un rumore tale, e le bombe sganciate, che il silenzio dei media e dei governanti si fa sempre più assordante. Fanno bene al cuore le immagini della partecipazione alle manifestazioni per Afrin, certo: ma è sempre troppo poco quel che possiamo fare, perché il silenzio del discorso pubblico ci sopravanza. Ciò, ovviamente, non ci esime dal continuare a fare. Bisogna ricordare, senza posa, a fronte dell’obsolescenza programmata del discorso pubblico, dove i morti scompaiono dalla scena più velocemente di una qualsiasi canzone pop, di qualsiasi tormentone estivo, come si getta un bene di consumo qualsiasi nell’immondizia. Ricordiamo, invece. Ricordiamoci di Alan Kurdi, quel bambino curdo finito morto riverso sulla spiaggia, che il mondo ha guardato in faccia per un istante, commuovendosi come sempre per interposta persona, per poi assistere il giorno dopo a un nuovo spettacolo che cancella quello del giorno precedente. Ricordiamolo, che migliaia di piccoli Alan Kurdi sono uccisi, o costretti a un esodo immane, dalle nostre bombe. E ricordiamo che Erdogan sta provando a uccidere la speranza più luminosa di un Medio Oriente da troppo tempo disperato, la speranza costruita giorno dopo giorno da un movimento curdo che tenta di ridare forma e contenuti e pratiche nuovi a una parola da noi usurata e consunta e abusata: democrazia. Ricordiamolo, che è perché i curdi del Rojava sperimentano una democrazia radicale, che sono massacrati.
Siria: l’attacco chimico, tragico pretesto, scrive il 9 aprile 2018 Piccole note su “Il Giornale". Un altro attacco chimico in Siria scatena la reazione internazionale. “Ora l’America di Trump dovrà colpire. Dovrà rispondere alle immagini spaventose che giungono dalla Siria”, scrive Franco Venturini sul Corriere della Sera di oggi. Si potrebbe concordare. Ma difficilmente Washington bombarderà Ryad, che sostiene i jihadisti di Jaysh al-Islam, l’organizzazione jihadista che ha lanciato l’attacco. Perché, con ritornello ripetitivo quanto stantio, i politici e i media dell’Occidente accusano Damasco e Putin. E si preparano a colpire la Siria.
Un attacco chimico annunciato. Solo che stavolta Mosca non starà a guardare. Ha allertato le difese schierate in Siria, e sono tante. Sarà la terza guerra mondiale? Washington dovrebbe riflettere prima di compiere passi fatali. L’escalation è una possibilità, anche se ad oggi remota. Sull’attacco chimico è inutile spiegare che Assad non ha alcun interesse a usare i gas contro i suoi nemici, anzi, sui quali sta avendo la meglio usando armi convenzionali. Per un beffardo incrocio di destini, proprio oggi sembra si sia chiuso l’accordo con gli assassini di Jaish al islam che controllano Douma, il quartiere nel quale sono stati sganciati i gas. Dovrebbero andarsene altrove, liberando l’area dalla loro nefasta occupazione. Ma al di là, degli sviluppi, resta che non interessa a nessuno accertare i fatti. La responsabilità di Assad è dogma inderogabile. Come furono le armi di distruzione di massa di Saddam. E anche se gli interventisti palesano qualche dubbio, restano fermi nell’asserire che Assad va colpito. Come fa Venturini con quel cenno col quale abbiamo iniziato questa nota. Nel proseguo dell’articolo, infatti, ammette che la responsabilità del governo siriano è dubbia…A fine marzo avevamo riportato che “i ribelli siriani che combattono nel Ghouta avrebbero simulato un attacco chimico contro i civili come pretesto per un attacco americano”. Una constatazione non nostra, ma del sito Debkafile, collegato ai più che informati servizi segreti israeliani, che pure non hanno in grande simpatia Assad, anzi. E da giorni media russi e iraniani avevano allertato su un attacco chimico imminente ad opera dei cosiddetti ribelli per incolpare i siriani. Sempre Debkafile, oggi riporta: “Alcune fonti a Washington sospettano che alcuni gruppi dell’opposizione siriana stiano innescando l’escalation nella speranza di provocare un’azione militare USA in Siria, ribaltando l’intenzione annunciata dal presidente Trump di riportare a casa le truppe statunitensi”.
Trump e il ritiro dalla Siria. Trump, obnubilato dai fumi dell’incendio che ieri è divampato alla Trump Tower, (funesto presagio), si è scagliato lancia in resta per un’azione militare. La sua idea di ritirare le truppe dalla Siria sembra dunque appartenere al passato. Oggi le difese siriane danno notizia di aver abbattuto alcuni missili Tomahawk lanciati contro una loro base aerea, un attacco che Mosca attribuisce a Israele. Gli autori della strage di Douma sembrano dunque aver conseguito i risultati sperati. Resta la perplessità per un complesso mediatico unidirezionale, come riscontrato durante la guerra in Iraq e quella in Libia. L’Unione sovietica aveva la Pravda, parola russa che significa verità. Ai media occidentali è consentita certa libertà su temi secondari, ma, quando il sistema si compatta su una decisione che riguarda il suo stesso destino, hanno anche loro una Pravda alla quale attenersi, pena l’esclusione dal sistema stesso. Una Pravda più sofisticata, certo, ma non meno perniciosa. Pericolosa deriva. Totalitaria.
Attacco chimico a Douma: se gli jihadisti scagionano Assad, scrive il 9 aprile 2018 Piccole note su “Il Giornale". Strano strano: l’Osservatorio siriano per i diritti umani, totalmente consegnato alla causa del regime-change in Siria, quindi non certo uno strumento in mano ad Assad, non dà alcuna notizie dell’asserito attacco chimico che sarebbe avvenuto a Douma, presso Ghouta orientale. Attacco che l’Occidente attribuisce ad Assad. L’Osservatorio è dedito alla propaganda contro il governo siriano. I suoi oppositori lo accusano di Inventarsi o distorcere notizie alla bisogna; un po’ come quando si narrava che i comunisti mangiavano i bambini. Allo scopo si avvale di fonti sul campo, fonti jihadiste, ovvio, e terroriste. Ha quindi un rapporto diretto con gli attori presenti nel teatro di guerra. Nel caso specifico, la banda Jaysh al-Islam, finanziata e armata dall’Arabia Saudita, che controllava Douma.
Il resoconto dell’Osservatorio siriano dei diritti umani. Bene, l’Osservatorio dedica alle interna corporis di Douma tantissimi articoli, di cui cinque solo oggi (almeno fino al momento in cui abbiamo realizzato questa piccola nota), dettagliando cosa è successo nel quartiere assediato di Damasco. Note in cui si narra che ci sono stati pesanti bombardamenti da parte delle forze russo-siriane, e che in seguito a queste la popolazione civile si è ribellata agli jihadisti e gli ha chiesto di accettare l’accordo proposto dai loro nemici e di abbandonare il quartiere. Hanno persino manifestato sotto la casa del capo della milizia, per fargli capire che doveva sloggiare. Magnanimamente, i jihadisti alla fine hanno accettato, spiegando in un comunicato che lo facevano per il bene della popolazione civile. E ora pare che stiano andando via, sotto la “pressione popolare”, imbarcati su 26 autobus messi a disposizione da Damasco. Saranno destinati ad un’altra zona della Siria controllata da altri jihadisti. Bene, in nessuno di questi articoli si parla di gas tossico, attacco chimico o quanto altro. Solo in un articolo del 7 aprile si accenna a “11 persone, tra cui almeno 5 bambini, soffocate, dopo il bombardamento di un aereo da guerra”. Al di là della veridicità o meno della notizia (l’Osservatorio non è molto attendibile, per usare un eufemismo), resta che non parla di gas, ma di generici sintomi di soffocamento di 11 persone. Va da sé che se si lancia un attacco chimico i sintomi sono ben più gravi e le persone colpite risulterebbero in numero ben maggiore. Inoltre, di solito, le notizie riguardanti gli asseriti attacchi chimici del passato erano corredate con foto raccapriccianti. In questo caso di foto ne sono circolate pochine e tutte molto più che generiche: potrebbero essere state scattate ovunque. Quella che circola di più l’abbiamo messa in esergo al nostro articolo e inquadra un bambino con un respiratore, mentre la sua compagnetta non ha nulla, se non legittima paura. Foto che non provano nulla insomma, se non l’innocenza violata dei bambini in questa sporca guerra. Una sporca guerra che si alimenta di menzogne. I siti russi rilanciano le dichiarazioni della Croce rossa siriana, che dice di non aver trovato tracce di gas a Douma. E in realtà, non si capisce perché i jihadisti incistati nel quartiere non hanno denunciato quell’attacco nel comunicato rivolto ai cittadini di Douma che l’Osservatorio siriano per i diritti umani riporta tutto nel dettaglio: non una riga sull’asserito attacco chimico. Perché tacere? Si poteva ben denunciare che a seguito dell’attacco chimico avevano deciso di andar via… Si noti che questo articolo, e soprattutto il comunicato degli jihadisti, è successivo all’attacco in cui L’Osservatorio denuncia i presunti sintomi di soffocamento. Non una riga su gas e attacchi chimici. Nemmeno una… Vuoi vedere che si sono inventati tutto?
Ps. Ovvio che da oggi tutto può cambiare e magari anche sul sito dell’Osservatorio scorreranno fiumi di inchiostro su gas e quanto altro. Ma il dato rilevato resta. E conferma quanto scritto stamane: la storia dell’attacco chimico è una messinscena costruita ad arte per attaccare Assad.
Armi chimiche ad orologeria, scrive Sebastiano Caputo il 9 aprile 2018 su “Il Giornale”. Presunte armi chimiche, ancora. Il governo siriano è sotto inchiesta dal potere mediatico internazionale per aver colpito la città di Duma, dove è in corso una battaglia contro Jaish al Islam, con gas tossici. In poche ore i video dal campo diffusi sono diventati virali e senza alcuna verifica tutti i mezzi d’informazione occidentale gli hanno rilanciati sui loro siti web e ritrattati in forma cartacea sulle prime pagine. E’ evidente però che siamo di fronte ad un’evidente operazione di “spin” giornalistico, vale a dire di una notizia che è stata fabbricata, confezionata o per lo meno riadattata, per poi essere gettata in mondovisione in un contesto geopolitico, militare e diplomatico molto preciso. In Siria c’è la guerra da oltre sette anni e quando vengono organizzate queste campagne mediatiche così corali non è mai per caso per cui occorre inserirle in un quadro molto più ampio altrimenti diventa solo becera e lacrimevole propaganda. Per capire quanto siano davvero autorevoli tali accuse è necessario analizzare le fonti della notizia, poi la campagna mediatica che ne è seguita, e infine tracciare le conseguenze dirette. Il presunto uso di armi chimiche è stato diffuso da due organi. Prima dai canali informativi legati a Jaish al Islam, poi dai White Helmets, un’organizzazione che è stata più volte denunciata per connivenza con i gruppi terroristici in Siria e di fornire un racconto parziale e mai obiettivo del conflitto. Eppure nonostante questa mancanza di obiettività i media occidentali hanno riportato ciecamente la notizia facendosi portavoce di una fazione creata coi soldi sauditi nel settembre 2013 per intercessione della famiglia Allouche – che oggi vive comodamente a Londra facendo fare il lavoro sporco allo sceicco Isaam Buwaydani, detto “Abu Hamam”, succeduto a Zahrane Allouche ucciso da un raid siriano – e che per anni ha comandato Duma con metodi mafiosi, imponendo la propria legge ai commercianti della Ghouta e giustiziando pubblicamente, senza esitare, chi ne ha contestato il potere (per credere è sufficiente ascoltare le testimonianze dei civili fuggiti dai corridoi umanitari aperti dalla Mezzaluna Rossa in collaborazione con l’Esercito Arabo Siriano). La campagna mediatica che ha seguito questi fatti è stata perfettamente sincronizzata in un lasso di tempo cortissimo. Tutti i giornali e i telegiornali hanno aperto con le stesse fotografie, gli stessi titoli, gli stessi slogan, e così anche gli intellettuali, uno fra tutti Roberto Saviano, che sulla scia di quel monologo fazioso di qualche settimana fa su Rai 1 che avevo commentato con un video, si è accodato a questa narrativa a senso unico inventandosi persino un gesto virale – la mano che tappa bocca e naso – per denunciare, senza prove, il governo siriano. Questa traiettoria informativa con l’intento di trascinare emotivamente l’opinione pubblica, si iscrive come detto sopra in un contesto geopolitico molto preciso. Siamo di fronte ad una vittoria militare di Bashar Al Assad e dei suoi alleati russi, iraniani, e libanesi, allora a rigor di logica è quanto mai legittimo domandarsi che interessi avrebbe il presidente siriano, sapendo di avere gli occhi puntati della comunità internazionale e dei media, per lo più in una posizione di forza, di utilizzare le armi chimiche nella battaglia di Duma? Sarebbe un errore da principiante e Assad un principiante non lo è affatto per come ha condotto la guerra mediatica e militare. La verità è che questa campagna arriva una settimana dopo le dichiarazioni di Donald Trump sul ritiro delle truppe dal nord della Siria (circa 2mila soldati), mentre all’interno della sua amministrazione c’è una componente legata al complesso militare-industriale che vuole continuare a seguire un’agenda alternativa a quella della Casa Bianca, con degli obiettivi molto chiari: difendere i pozzi petroliferi, coordinare i curdi sempre più propensi ad un riavvicinamento con il governo di Damasco e controllare zone altamente strategiche nella parte settentrionale del Paese. Per ultimo e non meno importante, è da ricordare che pochi giorni fa Erdogan, Rohani e Putin si sono riuniti per dare seguito ai colloqui di pace, perseguendo il processo di Astana, dove gli americani non sono invitati a prendere parte, ed è evidente che tutto questo servirà a spostare l’attenzione diplomatica sulle Nazioni Unite dove gli Stati Uniti, insieme a Francia e Inghilterra, la fanno da padroni.
ALL’1% GLI UTILI IDIOTI DELL’UCCIDENTE. La Siria di Ghouta e la Ghouta di Amnesty, Palmira e Babilonia, i nazifascisti in agguato, il gender e i migranti: quando i “sinistri” condividono distruzioni e distrazioni di massa, scrive Fulvio Grimaldi sul suo blogspot, riportato da Davide il 10 marzo 2018 su ComeDonChisciotte.
Quelli “del popolo”. Quelli che risultano più nauseabondi sono sempre gli ipocriti. A partire dal “manifesto” e da tutta la combriccola pseudosinistra dell’imperialismo di complemento, che volteggia nel vuoto dell’interesse e del consenso di un elettorato italiano che, per quanto disinformato o male informato sulle cose del mondo, ha dimostrato di badare più alla sostanza che alle formulette di palingenesi sociale incise sulle lapidi della sinistra che fu. E la sostanza ci dice che mettere tutti sullo stesso piano, 5Stelle e ologrammi nazifascisti, Putin e Trump, opposti imperialismi, migranti in fuga da bombe Nato e migranti attivati dalle Ong di Soros, jihadisti a Ghouta Est e truppe governative, a dispetto dell’immane e unanimistica potenza di fuoco mediatica, poi produce al massimo l’1 virgola qualcosina per cento. Brave persone, certo (esclusi i paraculi fessi dei GuE), ma fuori dal mondo, da chi è il nemico e da come si muove l’1% finanzcapitalista e tecno-bio-fascista nell’era del mondialismo e dell’high-tech. E, permettetemi una risatina, neanche bravi, ma di un narcisismo solipsista che rivela tratti patologici per quanto è dissociato dal reale, quelli della Lista del Popolo (Chiesa, Ingroia, bislacchi e farlocconi vari), trionfalmente giunti allo 0,02%. Ma si può!
Di Maio tra omaggi a San Gennaro e Mattarella e rifiuto degli F35. Sebbene questo unanimismo di fondo in fatto di geopolitica tra gli ambiguoni o catafratti della sinistra ausiliaria del sistema e del sistema i militanti in divisa, possa aver confuso le idee a molti sulla partita che si gioca in Medioriente, o nei trasferimenti via Ong di popolazioni, o a proposito dello “Zar Putin” e dei suoi maneggi per non far vincere Hillary, basta a volte una piccola crepa e la luce passa e illumina quanto si voleva restasse al buio. Possiamo dire tutto e il contrario di tutto su Di Maio, ma credo che siano davvero pochini gli italiani che condividono l’idea che spendere 80 milioni al giorno per muovere guerre a chi non si sogna di disturbarci e che quindi non abbiano apprezzato il voto 5 Stelle contro ogni missione militare e contro l’acquisto degli F35. Questo al netto delle promesse di “normalizzazione” profferite ora a tutto spiano dal leader 5Stelle e che lo fanno apparire come il pifferaio di Hamelin le cui liete marcette si trascinano dietro tutti i ratti della prima e seconda repubblica. Pensano di salire sul carro del vincitore, ma nella storia il pifferaio i ratti li porta a precipitare nell’abisso. Di Maio se lo ricorda? Non vorremmo che si finisse come la fiaba: che poi quelli trascinati via sono i bambini.
La Siria si riprende anche Ghouta: pacifisti e diritto umanisti a stracciarsi le vesti. Prendiamo la Siria, insieme a tutte le altre guerre, una dopo l’altra, che con ripetitività parossistica ci vendono come difesa dei diritti umani di un popolo massacrato dal proprio governante. Ci hanno seppellito in un bunker di menzogne: i tondini li forniscono le Ong tipo Amnesty International, HRW, MSF, la malta che li tiene insieme sono i media. Date un’occhiata a questo osceno appello di Amnesty perché si costringa Damasco a levare l’assedio alla Ghouta. Ancora una volta questo sempre più lurido arnese del bellicismo imperiale si fa riconoscere. Non una parola sul golem terrorista che da 7 anni sbrana la Siria e tiene ostaggi, ogni tanto massacrandoli, gli abitanti delle zone occupate. Mille parole perfide e lacrimose su Aleppo in corso di liberazione, non una parola su Raqqa polverizzata dai bombardamenti Usa, con tutti i suoi abitanti, mentre elicotteri prelevavano quelli dell’Isis per reimpiegarli, insieme agli ascari curdi, in altri crimini contro il popolo siriano.
Bimbi a Damasco. Ma poi nel calcestruzzo si apre una crepa. Ed è la pigrizia degli stereotipi. C’è sempre un dittatore che bombarda il proprio popolo, una massa sterminata di bambini uccisi, come se, per esempio, Ghouta, fosse tutta una scuola materna, ci sono sempre gli Elmetti Bianchi e i Medici senza Frontiere, grazie ai soldi di Soros, che stanno inevitabilmente dalla parte dei “ribelli” e che poi vengono esaltati e premiati dagli strumenti di comunicazione di coloro che le guerre le promuovono. Non mancano mai le “armi chimiche di Assad”, linea rossa che poi regolarmente sfuma, cancellata da prove e testimonianze (grazie russi!), come sono insostituibili i sanguinari jihadisti di Al Qaida e Isis contro cui gli imperiali dicono di combattere, ma dopo averli addestrati, armati e poi salvati dalle offensive dell’esercito siriano e suoi alleati. Qualcuno rovistando nel web si accorge, a dispetto della furia anti-fake news della Boldrini, che l’attacco siriano alla provincia di Ghouta avviene dopo sei anni che da lì i terroristi hanno ininterrottamente bombardato con razzi e mortai i 7 milioni di civili della capitale Damasco; che le centinaia di vittime dell’offensiva governativa su Ghouta, “soprattutto bambini”, sono il dato inventato dall’Osservatorio che i servizi britannici e i jihadisti gestiscono a Londra; che, se il governo spedisce colonne di autobus a evacuare la gente di Ghouta, o la Croce Rossa siriana prova a creare corridoi umanitari per rifornire di cibo e medicinali, a bombardare queste colonne e questi corridoi, voluti dal governo, saranno difficilmente gli stessi governativi. Nel documentario “Armageddon sulla via di Damasco” ho illustrato alcuni effetti del martellamento su Damasco, fino a 90 missili in una settimana. Dal mercato Al Hamidiyya, il più antico e bello del Medioriente, colpito nel momento di maggiore affollamento, alla stazione di autobus disintegrata nell’ora di punta, con schizzi di sangue e parti di corpo spiaccicati fin sul cavalcavia alto 20 metri. Immagini mie e di canali siriani che nessuno in Occidente ha mai ripreso. E’ successo mille volte, come centinaia sono state le incursioni aeree dei pirati israeliani. Avete sentito qualche sussurro di disapprovazione da Amnesty e compari?
Il “manifesto”: tutti uguali ma uno più uguale. Così, un po’ per volta, si aprono crepe, delle quali la più grossa è il dubbio che il “manifesto” e affini, quelli che si precipitano a fornire palchi e ghirlande ad Amnesty, non te la raccontino giusta quando mettono sullo stesso piano chi spara da Ghouta e chi avanza da Damasco e, anzi, trovano che i più cattivi siano coloro che “assediano” il sobborgo della capitale per eliminare uno degli ultimi bubboni tumorali incistati nel proprio territorio dai gangster imperialsionisti e mica quelli, sicari e mandanti, che vogliono mantenere, ai costi più inenarrabili, un presidio che tenga sotto tiro Damasco e impedisca la pacificazione e la vittoria dei giusti. Che sono poi anche le forze popolari siriane precipitatesi in soccorso ai curdi sotto attacco turco ad Afrin, a dispetto delle pugnalate alle spalle che questo mercenariato di Usa, Israele e sauditi, ha inflitto a chi ne aveva accolto, con tanto di cittadinanza, le centinaia di migliaia di fuggitivi dalle persecuzioni di Ankara.
Quando parla il popolo, non gli gnomi da giardino, il re buonista resta nudo. Le ambiguità e distorsioni dei media, a qualsiasi obbedienza politica pretendano di rifarsi, hanno iniziato a frantumarsi contro il muro della realtà. Elezioni politiche che mozzano gli arti alla principale forza di dominio e relegano nell’irrilevanza chi gli opponeva formule di rito anni ‘50, del tutto avulse da quanto una chiara percezione dello stato di cose reale richiederebbe, dimostrano che il re è nudo e nudi sono anche principi, duchi, baroni, paggi, nani e ballerine. La menzogna ha esaurito la sua capacità mistificatrice. Da fuffa e nebbia, demagogia presidenziale e pontificale, sono scaturiti irresistibili gli abusi inflitti dai dominanti ai dominati sul piano sociale, economico, ambientale, di lavoro, scuola, salute. Ma forse anche i crimini dei quali ci hanno voluto partecipi, anche a spese nostre, compiuti contro altri popoli. Non sarà un caso che gli unici vincitori di questa contesa elettorale siano coloro che a spese e avventure guerresche, come alle sanzioni che a queste si accompagnano, si sono sempre opposti. E se questa barra la manterranno dritta, sarà già molto.
Al potere via decostruzione e migrazione. Che sono poi anche quelli che, in un modo o nell’altro, quale corretto ed equo, quale rozzo e falsamente motivato, hanno messo in dubbio la sacralità dei facilitatori delle migrazioni “per fame, guerra, persecuzioni”. Il che ci porta a un’altra considerazione. Invasori e terrorismo jihadista ha posto particolare accanimento nella distruzione delle vestigia storiche delle nazioni che sono stati mandati ad assaltare. Ong, umanitaristi, sinistre, Don Ciotti e missionari nelle colonie, Soros, briciole sinistre, sostengono l’accoglienza dei rifugiati senza se e senza ma. Ci sono punti di contatto, affinità di obiettivi, tra queste forze e le campagne che condividono? Non penso al semplicistico discorso che individua causa ed effetto nelle bombe e nelle conseguenti fughe. Lo stereotipo del “fuggono da guerre, fame e persecuzioni”. Penso a una manovra a tenaglia che cancella corpi e spirito di comunità formatesi nel sangue, nei progetti, nelle sconfitte e nelle rinascite, nella lingua e nei costumi, su una comune terra, in rapporto con lo stesso ambiente ed è così che ha acquisito conoscenza e coscienza di sé, identità, autostima, volontà di perpetuarsi e crescere. Un fiore nell’infinita ricchezza della varietà dei fiori. Prima di manipolazioni e ibridazioni. Se, io élite di infima minoranza, perseguo un progetto di dominio mondiale assoluto che solo a me e ai miei subalterni obbedienti convenga, delle forze così formatesi e così composte, altrettante negazioni al mio disegno, devo liberarmi. E’ conditio sine qua non per l’affermazione del progetto mondialista. La mia operazione a tenaglia consiste, primo, nel cancellarne i segni della storia, delle opere compiute, le fondamenta dell’edificio che una comunità, un popolo, una nazione, devono avere sempre in corso d’opera se intendono avere un futuro. Del resto, senza queste tessere del mosaico, l’umanità si estingue. L’élite regnerà sul deserto o su un altro pianeta. E, secondo, nello sradicarli, spostare quelli che non ho decimato con guerre militari o economiche, tagliare radici, staccare il fogliame dal tronco, disperderlo, alienarlo da se stesso, confondendolo in quello che chiamano “meticciato”. Erano le mie ultime ore nella Baghdad che ho illustrato in “IRAQ: un deserto chiamato pace”, aprile 2003. I carri Usa, penetrati in città avevano sparato i primi colpi contro l’Hotel Palestine, dove stavamo noi giornalisti che non avevamo seguito l’ordine di Bush di far parlare solo gli embedded al seguito degli invasori. Morirono un mio amico di Al Jazeera e un reporter spagnolo. Uscendo dalla città in taxi passai accanto al Museo Nazionale: Protetta da reparti angloamericani, manovalanza importata dal Kuweit stava già saccheggiando la più ricca testimonianza della storia araba e irachena, dai sumeri agli Abbassidi, anche a beneficio dei predatori dei caveau occidentali. Subito dopo avrebbero disperso e bruciato i testi, resi sacri dal tempo e dall’amore dei loro lettori, della Biblioteca Nazionale, dalle tavolette cuneiformi della prima scrittura, alla magnificenza letteraria delle Mille e una notte e ai traduttori arabi di Aristotele. Intanto i carri americani si preparavano a travolgere sotto i propri cingoli Babilonia, Ur, Niniveh, Samarra, Nimrud, Ctesifonte, Hatra. Quattromila anni di creatività umana, di civiltà, di culla della civiltà. Meticolosamente, sistematicamente polverizzati o predati. E poi stessa procedura in Siria, Aleppo, Palmira, Libia, Gaza, ovunque la pianta umana fosse più antica, robusta, rigogliosa, degli stenti arbusti, delle misere gramigne di chi a una cultura annegata nel sangue ha sostituito centri commerciali, tecnologie decerebranti e arsenali atomici.
Mosul. In parallelo i migranti, pezzi interi di popoli, 6 milioni di siriani spodestati, un milione a disposizione dei minijob di Angela Merkel. E, logicamente, afghani, iracheni, libici, pachistani e, soprattutto africani: basta seccare con una megadiga Impregilo un fiume come l’Omo in Etiopia e 60mila perdono l’acqua, i coltivi, la sussistenza, diventano foglie secche al vento che qualche Ong seduce a farsi schiavi “meticciati” in un bengodi di sfruttati europei. Come si vede in ogni sequenza che ci induce a impietosirci e a condividere “l’accoglienza”, sono in stragrande maggioranza giovani con i tempi e le forze capaci di futuro. Un futuro abbandonato alle multinazionali a casa propria, ma per il quale fornire braccia e saperi In Occidente. Sono giovani, in grado di affrontare i pericoli della filiera del traffico di carne umana, ma non procreeranno più per la continuità di una comunità arrivata fin ad oggi a dispetto di prove di ogni genere, procreeranno per il “meticciato”. A compensare ciò che da noi, nell’esaltazione dei generi e transgeneri della sterilità, non nasce più. E se crediamo che da tutto ciò noi siamo esenti, proviamo a gettare uno sguardo fuori dalla finestra, tra un asilo nido che non c’è e una famiglia che il precariato di sistema rinserra in sogni frustrati. Diamo un’occhiata ai territori terremotati, banco di prova e cartina di tornasole di un altro fronte della stessa guerra. Credete che, a quasi due anni dal sisma con migliaia ancora nei campeggi al mare, in alloggi di fortuna lontani, con attività produttive sparite per sempre, con la ricostruzione neanche di una stalla, si tratti solo di inefficienza, ritardi, risse per appalti? Ho girato per quelle terre palmo a palmo (“O la Troika o la vita – Non si uccidono così anche le nazioni”). Paesi con le radici nell’impero romano e le chiese del Medioevo, dove hanno lasciato segni Arnolfo da Cambio, Mantegna, Leopardi, Piero della Francesca: tesori inenarrabili. I terremotati li vogliono scoraggiati, esportati, migranti anche loro, i territori privati di una economia nativa, sorta dal genius loci, anacronisticamente non sovranazionale, ma legata ai bisogni locali, ai biotopi naturali e umani. Spopolare per nuove destinazioni d’uso. Sovranazionali. Come quando sradicano con gli ulivi l’anima della Puglia, per far posto a gasdotti e resort di Briatore. Rifugiati nostrani di cui nessuno tiene conto e né Soros, né alcuna Ong dei diritti umani reclamano un’accoglienza senza se e senza ma. Tutto questo Pippo non lo sa. Tutto questo quelli dell’1% “rosso”, PaP (Potere al Popolo), i PC (le scissioni dell’atomo), o LuE (i neoliberisti, NATOisti, Bruxellisti, insofferenti di Renzi), non lo sanno. Sepolti nell’altroieri, del progetto capitalista e della relativa strategia non studiano e non vedono neanche la più abbagliante evidenza. Nanetti da giardino occupati a strappare erbacce, mentre fuori cresce una giungla di piante carnivore. E non si accorgono che, ignorando quella strategia, ogni lotta contro il precariato di vite e lavoro è già persa, mentre sono del tutto compatibili quelle contro le molestie, per i matrimoni e le adozioni gay, per ogni più fantasiosa invenzione di genere come fieramente esibite in quelle manifestazioni d buongusto e di cultura popolare che sono i Gay Pride, contro la minaccia dell’Onda Nera nazifascista. Minaccia eroicamente combattuta, da Macerata a Milano a Roma a Palermo, con l’illusione di ricavarne dividendi boldriniani e poi spassosamente risultata pulviscolo littorio allo 0,9%, Casa Pound, e allo 0,37% Forza Nuova. Tocca scioglierli per salvarci dall’orrore di nuovi Farinacci e Himmler, era l’invocazione tonitruante della Boldrini, grande specialista di armi di distrazione di massa. Intanto, però, il mondo reale scioglieva lei e i suoi scioglitori. E senza neanche un sorso di olio di ricino. Ma più compatibile, anzi, più gradita di tutte, è la campagna per l’accoglienza dei migranti. Roba di sinistra, ca va sans dire.
I non detti di Ghouta, scrive Sebastiano Caputo il 22 febbraio 2018 su "Il Giornale". Tutto ciò che accade in queste ore nella periferia di Damasco, di preciso a Ghouta, è filtrato da una sconcertante quanto irresponsabile narrativa. In Siria c’è la guerra da oltre sette anni eppure i grandi e autorevoli mezzi d’informazione sembrano accorgersene solo ora perché gli ingredienti per la mistificazione della realtà non mancano affatto. La meccanica comunicativa è più o meno sempre la stessa: una produzione di notizie scollegate fra loro e confezionate dentro un frame, cioè la cornice giornalistica da cui è impossibile sfuggire, in questo caso “la mattanza di Ghouta perpetuata dall’aviazione del governo siriano”. Seguono immagini scioccanti – in larga parte riportate dai “White Helmets”, il braccio umanitario e mediatico dei gruppi terroristici- che mostrano le tragiche conseguenze “dell’offensiva”, intere abitazioni rase al suolo, cadaveri sulla strada, donne in lacrime, ambulanze, soccorritori in cerca di cadaveri tra le macerie. Le riprese sono di qualità, il logo con l’elmetto bianco appare di continuo, le fotografie vengono scattate con cura. Nell’album emerge un’istantanea che diventa il simbolo di un assedio: una bambina col pigiama rosa – la scelta del pigiama non è casuale e richiama di riflesso i campi di concentramento nazista – che viene tratta in salva da casa sua. Esattamente come ad Aleppo, quando il piccolo Omran Daqneesh fu immortalato coperto di sangue e polvere nell’ambulanza, peccato che poco tempo dopo il padre svelò la tecnica dei White Helmets i quali presero il bambino ancora sporco e scosso dai bombardamenti e lo gettarono in mondovisione sul loro profilo Twitter certi che le agenzie occidentali lo avrebbero alzato come trofeo. Alla sequenza di immagini trasmesse a ripetizione – peraltro sempre le stesse – seguono i dati. A contare i morti ci pensa il generatore di notizie diretto da un solo uomo che vive in Inghilterra: l’Osservatorio Siriano dei Diritti Umani. Ad accodarsi a questo macabro spettacolo del dolore sono le organizzazioni non governative occidentali – Unicef, Save The Children, Médecins Sans Frontières – che mentre mettono in primo piano i cadaveri putrefatti di donne e bambini raccolgono donazioni – tramite squallidi banner pubblicitari – dai lettori distratti e travolti da un flusso ininterrotto di lacrime. Nessuno vuole negare le conseguenze immonde della guerra, il problema, ancora una volta, sono i non detti dell’offensiva di Ghouta. Chi vive nel sobborgo di Damasco? Chi sono questi ribelli (che se ci fate caso non vengono più nemmeno definiti “moderati”)? Come agiscono? E come fa un’enclave, senza sbocchi autostradali, a fornirsi di armi e munizioni? Questo spazio geografico si è ritagliato nella contorta mappa militare nel lontano 2012 e si colloca sul lato nord-orientale, alle porte della capitale. Quasi 400mila civili sono tenuti praticamente in ostaggio da tre fazioni jihadiste legate a doppio filo con Al Qaeda - Faylaq al Rahman, Tahrir al Sham e Jaysh al Islam – che da anni attaccano i quartieri centrali di Damasco – non lontani dal Suk – a colpi di mortai. L’offensiva dell’esercito siriano è stata rafforzata per rispondere agli attacchi contro i damasceni che si sono intensificati proprio in questi giorni. Molti di loro hanno perso la vita ma se ne parla poco perché la narrativa occidentale è monodirezionale e classifica i civili siriani in due categorie: alcuni sono più vittime di altri. Ghouta è anche quel luogo in cui vengono fabbricate e utilizzate armi chimiche come dimostrò l’attacco del 21 giugno del 2013 in cui inizialmente furono lanciate accuse contro il governo di Bashar al Assad, poi smentite dal premio Pulitzer Seymour Hersh e rispedite al mittente fornendo le prove che invece incolparono proprio quei ribelli “angelizzati” dalla stampa occidentale, i quali le utilizzarono per trascinare l’amministrazione Obama in guerra. Ecco, fin quando i grandi esperti con i loro look confortevoli o i commentatori isterici non vi risponderanno a queste domande precise vorrà dire che sono alimentatori inconsapevoli di questa grande macchina della disinformazione, o furbetti che coprono per chissà quali interessi veri e propri gruppi terroristici complici dei peggior crimini che loro stessi denunciano.
Erdogan tuona sui civili di Ghouta, ma quelli di Afrin sono “terroristi”, scrive il 27 febbraio 2018 Lorenzo Vita su "Gli Occhi della Guerra" su "Il Giornale". In questa guerra di Siria tutto assume connotati incredibili, anche Erdogan che si erge a paladino del diritto internazionale e umanitario. Parlando della tragedia umanitaria della Ghouta orientale, il portavoce del presidente turco ha scritto che “il regime sta commettendo massacri” e che “il mondo dovrebbe dire stop a questo massacro insieme”. Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, venerdì scorso ha invitato la Russia e l’Iran, alleati della Siria di Assad, a “fermare” le bombe su Ghouta Est, parlando del bombardamento del sobborgo damasceno come qualcosa che passerà alla storia come la “Srebrenica siriana”. Il presidente turco ha deciso di sposare, in questi giorni, una linea fortemente negativa nei confronti dell’avanzata di Damasco nel sobborgo della Ghouta orientale. Rompendo quasi definitivamente il patto di Astana con Putin e Rohani, Erdogan ha deciso di intraprendere una campagna assolutamente contraria al governo facendo tornare indietro le lancette dell’orologio ai tempi delle prime rivolte contro Assad, quando Ankara sosteneva il rovesciamento del leader siriano e le milizie che si ergevano in tutta la Siria. E ovviamente sfrutta la questione della Ghouta orientale per colpire il governo siriano e imporre la propria linea nello scacchiere settentrionale siriano. Erdogan è così: chi lo tutela ha la sua collaborazione e chi non lo tutela diventa nemico. E sono sempre i curdi dell’Ypg l’ago della bilancia. Quando gli Stati Uniti hanno deciso di sostenere le milizie del Rojava e del nord dell Siria, il presidente turco ha abbandonato nella sostanza l’alleanza con Washington schierandosi con Mosca e sostenendo il piano delle de-escalation zones con l’Iran e la Russia. Adesso che ha intrapreso l’operazione “Ramoscello d’ulivo” e ha scatenato le forze armate contro i curdi di Siria, ottenendo il confronto diretto con la Siria, eccolo di nuovo andare contro il governo di Damasco e provare a riallacciare i rapporti con gli Usa. Nel frattempo, ha intrapreso contro i curdi una campagna militare cruenta, che sta tenendo sotto scacco intere città e dove ci sono già le prime accuse di uso di gas contro i villaggi. Soltanto che, secondo Ankara, c’è una differenza. Mentre per Erdogan la risoluzione Onu sulla tregua è giusta per fermare il massacro della Ghouta orientale, la stessa cosa non vale per Afrin, Manbij. La Turchia ha accolto positivamente l’approvazione della tregua umanitaria in Siria, ma ha subito messo le mani avanti, dicendo che questo non avrà alcuna conseguenza su Afrin e l’offensiva di terra nel nord della Siria perché “resterà risoluta nella battaglia contro le organizzazioni terroristiche che minacciano l’integrità territoriale e l’unità politica della Siria”. Non c’è discussione sul fatto che questa decisione” del Consiglio di Sicurezza dell’Onu “non abbia alcun effetto sulla operazione che la Turchia sta portando avanti”, ha confermato il vice premier turco, Bekir Bozdag, mentre Erdogan ha sottolineato che l’offensiva “continuerà fino a che l’ultimo terrorista sarà distrutto”. “Sembra che sarà una estate dura e calda per i terroristi e per i loro sostenitori. Prima ripuliremo Manbij, poi tutta l’area a ovest dell’Eufrate”, così si è espresso Erdogan. Parole non troppo dissimili da quelle rivolte dal blocco a sostegno di Assad nei riguardi dell’offensiva contro Ghouta Est e altre sacche. Eppure, se per Erdogan questi sono massacri sui civili, quella che ha intrapreso la Turchia è solo un’offensiva contro il terrorismo. Un interessante punto di vista che fa riflettere su quanto sia importante l’uso del linguaggio in un conflitto che si svolge anche con le definizioni.
Ghouta Est: quando i ribelli mettevano i civili in gabbie, scrive "Piccole note" il 27 febbraio 2018 su "Il Giornale". La Russia ha stabilito che da oggi, ogni giorno, ci sarà una tregua umanitaria per Ghouta Est, dalle 9 alle 14 e chiesto l’apertura di vie di fuga per i civili che vi abitano. La pressione internazionale per fermare l’attacco dell’esercito siriano diretto all’enclave di Damasco controllata dai cosiddetti ribelli ha sortito un primo effetto. Vedremo gli sviluppi: anche la campagna per la riconquista di Aleppo Est fu uno stillicidio di stop and go, a causa da una pressione internazionale diretta a contrastare le operazioni dell’esercito siriano.
La Caritas siriana denuncia lo squilibrio dell’informazione. Esattamente quanto accade adesso, grazie una fortissima campagna mediatica che dipinge l’operazione contro Ghouta Est come brutale e i ribelli come eroi in lotta contro il sanguinario regime di Assad. La guerra è brutta, anche quelle giuste (quella di liberazione dal nazifascismo, ad esempio, conobbe ombre terribili: Dresda, Cassino, Hiroshima e Nagasaki…). Ma questa sembra più brutta di altre. E i ribelli che la combattono più umanitari di altri: ecco che foto e video li immortalano mentre, premurosi, soccorrono i feriti e altro e più stucchevole. Nessuna notizia di quanto da essi perpetrato a Damasco in questi giorni. Tanto che anche la Charitas siriana, in un raro comunicato, ha sbottato: «La maggior parte dei reportage giornalistici si concentra sui bombardamenti effettuati dalla Siria e dalla Russia su Ghouta Est». Nulla si dice invece di quanto avviene a Damasco, martellata ogni giorno «dall’inizio del 2018» da «colpi di mortaio» sparati da quel quartiere (vedi anche Piccolenote). Come anche nessuna notizia sul raid degli Stati Uniti a Deir Ezzor compiuto in questi stessi giorni: 25 i civili uccisi (Xinhua). D’altronde tale silenzio è in linea con quanto accaduto a Raqqa, città coventrizzata dagli Stati Uniti per scacciarne l’Isis (questa la narrazione ufficiale).
Le gabbie umanitarie degli eroi di Ghouta Est. Resta che se il quartiere di Ghouta Est non viene liberato, gli altri quartieri di Damasco resteranno preda dei bombardamenti dei ribelli cari ai circoli che stanno perpetrando il regime-change siriano. A meno che i loro sponsor internazionali non li fermino, cosa che non hanno alcuna intenzione di fare. Gli servono perché sono fonte di destabilizzazione permanente della capitale siriana. Così anche le campagne umanitarie servono a uno scopo prettamente bellico: a evitare che Ghouta Est cada ed essi perdano un tassello prezioso nella prospettiva di portare al collasso il governo di Damasco, logorandone la resistenza.
Ma chi sono gli eroi di Ghouta Est? Si tratta di alcune milizie jihadiste, subordinate ad al Nusra (al Qaeda), la più forte e organizzata. Istruttivo un report di Human Rights Watch, organizzazione non certo filo-Assad, del 2015: «I gruppi armati siriani mettono in pericolo i civili, incluse le donne» che espongono «in gabbie di metallo in tutta Ghouta orientale». Un crimine di guerra, spiega HRW, che i miliziani hanno usato per evitare gli attacchi del governo siriano. Importante quel cenno a «tutta Ghouta orientale» contenuto nel testo: indica che le gabbie dell’orrore sono state usate da tutte le milizie presenti a Ghouta, non dalla sola al Nusra. Nel report di HRW un cenno a un altro video che immortala «camion che trasportano gabbie, ciascuna contenente da quattro a otto uomini o donne». I «ribelli di Ghouta hanno distribuito 100 gabbie, ogni gabbia contiene circa sette persone e il piano è quello di produrre 1.000 gabbie da distribuire nella Ghouta orientale». Il bello è che lo sanno anche loro: anche la Cnn, infatti, aveva ripreso quel video (cliccare qui). Allora, quelle terribili immagini servivano per denunciare la brutalità dell’estremismo islamico. E così giustificare un intervento americano in loco. Oggi non servono più, anzi. Così sono semplicemente obliate. La guerra siriana, come anche altre (Yemen ad esempio), è «disumana», come ha detto papa Francesco all’Angelus di domenica. Quelle immagini lo documentano nella maniera più agghiacciante. Come disumana è la cortina fumogena che intossica le informazioni su quanto realmente sta avvenendo in quel martoriato Paese.
LE FAKE NEWS DEL CONTRO-REGIME.
Fake news, il veleno che piegò Mia Martini, scrive Domenica 14 maggio 2017 Aldo Grasso su "Il Corriere della Sera". Ventidue anni fa, di questi giorni, moriva la cantante Mia Martini. Una morte misteriosa, al culmine di una vita privata e di un percorso artistico segnati dalla maldicenza: dicevano portasse iella, non volevano mai pronunciare il suo nome. Proviamo a leggere questa vergognosa storia con gli occhi di adesso. Mia Martini è stata prima vittima di due fake news (dicevano portasse male per un tragico incidente in cui persero la vita due musicisti della sua band e per il crollo di un telone che copriva il palco su cui doveva esibirsi) e poi di bullismo. Un bullismo feroce, consapevole e adulto: quello di certi suoi colleghi, di certi impresari, di certi giornalisti. Mia è vissuta per anni nella post verità, nel regno delle bufale e delle cattiverie. E non c’erano nemmeno gli algoritmi dei social media a rilanciarle. Di fake news e bullismo si può morire, è bene saperlo. Ieri come oggi. Sono veleni iniettati per privare la vittima di ogni difesa. In ebraico c’è un’espressione forte per indicare la maldicenza, lashon hara (malalingua). È considerata una colpa gravissima, che Dio non tollera: «Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopererai alla morte del tuo prossimo» (Levitico 19:16). Nelle nostre società laiche e illuminate, il reato ha sostituito il peccato. Ma il rito tribale e persecutorio della maldicenza è sempre lo stesso, amplificato oggi dal «popolo del web».
Fake news, bufale e dintorni, scrive Paolo Campanelli il 17 maggio 2017. Con la scusa dell’“informazione libera e super partes perché fatta dall’uomo qualunque” che molti hanno visto in internet, la bufala ha invece raggiunto il livello opposto, diventando propaganda, il metodo più diretto di attacco costituzionale. L’amore per le bufale è un curioso concetto. Certo, c’è chi spaccia notizie con titoli dubbi o incompleti per far andare persone sui propri siti e guadagnare soldi, c’è lo Schierato Politico Estremo che s’inventa storielle inverosimili per favorire la propria posizione, ma molte, troppe false notizie vengono semplicemente buttate nella rete e lasciate a loro stesse. Prima di andare oltre, c’è da fare una chiara differenza: la bufala è differente dal giornale di satira; dove la prima è disinformazione, i secondi fanno ironia con situazioni chiaramente grottesche e impossibili, il Vernacoliere è lo storico giornale cartaceo, mentre Lercio è uno dei più famosi siti internet al riguardo. Il problema sorge quando le fonti delle bufale si fingono giornali di satira. Ma una cosa è dire che il politico “presunto corrotto” di turno ha un indice di gradimento del 215% nelle carceri, cosa impossibile già matematicamente oltre che improbabile dal punto di vista della necessità di fare rilevazioni, o prendere qualche istantanea da una fiction o un cartone animato e aggiungerci sotto una didascalia che la faccia sembrare presa da un momento critico nei libri di storia e aggiunto il colore, un’altra è incolpare il gruppo di immigrati di turno di aver fatto danni ad un palazzo storico aggiungendo la foto di qualche resto archeologico cittadino o dei veri e propri ruderi tanto comuni nel territorio italiano. Quella delle bufale recentemente soprannominate Fake News (seguendo la denominazione americana diventata famosa per via del costante usa da parte del loro Presidente, è una situazione che si autoalimenta, una persona che crede a varie bufale diventa più suscettibile ad altre, creando un loop di cecità dalla quale il credulone non si riesce a liberare, al grido di “metti tutto in discussione”. Tralasciando però la seconda parte “e analizza i risultati metodicamente per non farti ingannare nuovamente”. Il caso più eclatante degli ultimi tempi è stata quello di “Luciana” Boldrini: sorella di Laura, presidente della Camera dei Deputati, accusata di aver speso, solo nell’ultimo anno, ingenti somme pubbliche nell’accoglienza di immigrati oltre a ciò già fatto dal governo. In realtà Lucia Boldrini, pittrice, è morta da più di trent’anni. E il punto di origine della bufala non lascia alcun dubbio, si trattava di un attacco a base di “fango politico” in piena regola. Ricostruendo il percorso di alcune delle bufale dalla diffusione più rapida infatti, si giunge ad una cerchia di persone che le creano “professionalmente”, fin troppo spesso collegati con medie e piccole industrie e con gruppi politici; dove l’obbiettivo dei secondi è chiaramente quello di ottenere il voto di persone facilmente influenzabili anche al di fuori dei sostenitori del proprio partito, per le aziende si tratta di manovre più subdole: incrementare la vendita di prodotti “alternativi” mettendo in circolo l’informazione di come i prodotti più diffusi creino problemi all’organismo o all’ambiente, talvolta persino con informazioni parzialmente corrette. La storia degli acidi a base di limone che circolava a inizio 2013 è emblematica, in quanto prendeva in considerazione che il succo di limone è effettivamente una sostanza acida utilizzata come sgrassatore e come anticoagulante in ambito medico (acido citrico), ma nelle percentuali di purezza e quantità in cui si trova negli alimenti è comunque inferiore all’acidità dei succhi gastrici. Gli effetti più estremi di una bufala possono essere sottovalutati, vedendo come molte possano essere risolte con una semplice e rapida ricerca su un qualsiasi browser internet, ma tre sono i giganteschi esempi di una bufala fuori controllo: l’omeopatia, i vaccini e l’olio di palma. Omeopatia e vaccini richiedono conoscenze chimiche di un livello al di sopra di quello del cittadino medio, e comunque prenderebbero troppo tempo, l’olio di palma, invece, pur se segue gli stessi schemi, è un “concetto” estremamente più comprensibile. Fino a un paio di anni fa, nessuno si interessava all’olio di palma, eccetto le industrie alimentari; l’olio di frutti e semi di palma è sempre stato utilizzato in Africa e medio oriente per una moltitudine di usi, fra cui la preparazione di cibo, anche sostituendo oli e altri tipi di grassi, come ad esempio il burro, sapone, ed infine, nel caso del Napalm e del biodiesel, come componente di armi e di carburanti rispettivamente; una delle peculiarità dell’olio di palma è che ha una grande percentuale di grassi saturi, e quindi può essere confezionato in un panetto simile al burro a temperatura ambiente, che ne semplifica la lavorazione quando si ha a che fare con gli enormi quantitativi industriali. Tuttavia, con l’aumento della richiesta nel XX secolo, la coltivazione della palma ha portato a un incremento delle colture a discapito di altre produzioni, e di deforestazione. A questo si aggiunge che il consumo smodato di quest’olio ha effetti deleteri sull’organismo, identici all’eccesso di burro e di grassi. A partire dalla metà del 2014, però, cominciò a girare la notizia che “l’olio di palma fa male”; In breve tempo, espandendosi a macchia…d’olio, la notizia lasciò tutta l’Europa terrorizzata. I reparti di marketing delle grandi aziende, però, presero la palla al balzo, e scrissero chiaramente sui loro prodotti che non contenevano olio di palma, anche su quelli che non lo avevano mai utilizzato. Eccetto la Ferrero, che forte della sua posizione, e della sua cremosità, affermò fermamente che la Nutella, e tutti i suoi fratelli dolciari, avrebbero continuato a usare l’olio di palma nelle loro ricette, poiché parte essenziale nella creazione del gusto e non come araldo dei mali dovuti all’eccesivo consumo di dolci (arrivando persino a fare test di laboratorio). Questo ha indubbiamente posto il potenziale bersaglio della “bufala” di fronte ad un inatteso dilemma tra l’ansia indotta dalla pressione mediatica ed il consolidato piacere della adoratissima crema di nocciole. Con la scusa dell’“informazione libera e super partes perché fatta dall’uomo qualunque” che molti hanno visto in internet, la bufala ha invece raggiunto il livello opposto, diventando propaganda, il metodo più diretto di attacco costituzionale. La costituzione, infatti, delinea la libertà di informazione, che è legata a doppio filo con la libertà di opinione degli utenti, e con l’obbligo per chi fornisce le informazioni di, attendibilità, cioè di dimostrare che si tratta di fatti avvenuti. Due concetti che non possono e non devono sovrapporsi l’uno all’altro, ma che non hanno alcuna limitazione se semplicemente messi in rete e spacciati per “Fatto”. Dei passi contro la disinformazione e le bufale sono stati fatti sia dai governi di vari paesi, fra cui dei timidi passi anche in Italia, che dai privati, prevalentemente dai social network, ma a questo deve corrispondere un minimo di attività da parte dell’utente, il cosiddetto “Fact Checking” (o in italiano, controllo delle fonti), particolarmente da parte di chi si è “laureato all’università della vita” e da chi si è ritirato dagli studi, conscio di una minore abilità in ambito di studio e comprensione.
Rai, Alfano denuncia autori e conduttori Gazebo: "Mi diffamano da tre anni". Lo annuncia una nota di Alternativa Popolare: "Non si è trattato di un singolo atto ma di una intera campagna durata anni a spese del contribuente", scrive il 20 maggio 2017 "La Repubblica". Angelino Alfano denuncia autori e conduttori del programma Rai Gazebo (condotto da Diego 'Zoro' Bianchi su Rai3) per diffamazione, in sede civile e penale: lo annuncia una nota di Alternativa Popolare, il partito del ministro degli Esteri. "Ieri, con i soldi degli italiani, due milioni e mezzo di euro per il 2017!!!, si è consumata la consueta diffamazione. Quel che è più grave è che essa è stata perpetrata da parte del servizio pubblico". La nota spiega che: "Ieri, con i soldi degli italiani - due milioni e mezzo di euro per il 2017 - si è consumata la consueta diffamazione. Quel che è più grave è che essa è stata perpetrata da parte del servizio pubblico. Il presidente di Alternativa Popolare, Angelino Alfano, annuncia, dunque, di avere dato mandato ai propri legali per denunciare autori e conduttori di Gazebo in sede civile e in sede penale". È quanto si legge in una nota. "Alla denuncia, Alfano allegherà i riferimenti diffamatori a lui rivolti durante gli ultimi tre anni di puntate televisive di Gazebo, per dimostrare ciò che sarà facile dimostrare: non si è trattato di un singolo atto diffamatorio - che sarebbe stato comunque grave - ma di una intera campagna diffamatoria durata anni a spese del contribuente e con una pervicacia diffamatoria che rende plateale il dolo, l’intenzionalità, la tenace volontà di creare un danno alla persona e all’area politica che rappresenta. Il punto è reso ancor più grave dall’enorme sproporzione che vi è, all’interno del servizio pubblico, tra lo spazio dedicato alla diffamazione da questa trasmissione e lo spazio dedicato alla informazione, in altre trasmissioni Rai, sulla medesima area politica e sulla stessa persona che la rappresenta. Infine, è stata la stessa Rai 3, pochi giorni fa, a sottolineare che tale trasmissione è un mix tra informazione e satira, con questa frase contenuta nella nota che era stata diffusa e che riportiamo qui fedelmente: ’... programma caratterizzato dal mix di satira e informazione che ne definiscono l’identità...’. Quindi, se è già stato ampiamente superato il confine della satira traducendosi in diffamazione, a maggior ragione tutto ciò nulla ha avuto a che fare con l’informazione. Ultima considerazione amara: questa diffamazione non può che essersi svolta con la azione o la dolosa e persistente omissione di una intera catena di comando che, dalla rete sino ai vertici massimi, ha consentito questi abusi. Anche costoro, nei limiti del legalmente consentito, saranno, da Alfano, chiamati a rispondere sia nel giudizio civile che nel giudizio penale. Alfano fa presente, infine, di essere giunto a questa amara determinazione dopo tre anni di paziente sopportazione di questo scempio che ha fatto il servizio pubblico, nella speranza che vi fosse un operoso ravvedimento nella diffamazione". L'annuncio della denuncia arriva a pochi giorni dall'ultima polemica: Alternativa Popolare aveva negato l'accredito a Gazebo per partecipare alla conferenza stampa sulla legge elettorale convocata nella sede del partito di Alfano.
“Casa Renzi”, la soap opera infinita del Fatto Quotidiano, scrive Lanfranco Caminiti il 17 Maggio 2017 su "Il Dubbio". Il caso Consip e la miseria del giornalismo: quando l’informazione diventa pettegolezzo e spettacolo di bassa lega. Quel che conta è la cornice narrativa e non più i fatti.
‘Ofiglie: Tu ha da riciri ‘ a verità, ggiura. Ggiura ca nun ricuordi.
‘ O pate: T’o ggiuro, nun m’arricuord nniente.
‘ O figlie: Ggiurale ‘ ncoppa a Maronna ‘ e Pumpei.
‘ O pate: ‘ O ggiuro, ncoppa a Marunnina nuost’. Nun m’arricuordo nniente.
‘ O figlie: E nun mmiettiri ‘ a mmiezzu ‘ a mamma. ‘ Nce fa’ passa’ nu guaie.
‘ O pate: No, t’o ggiuro, ‘ a mamma, no.
‘ O figlie: Statte bbuono. E accuorto.
Non è un dialogo spoilerato dell’ennesima puntata dell’ennesima stagione della saga dei Savastano, insomma della fiction Gomorra. Piuttosto una verace traslazione, dal toscano del “giglio magico” al napoletano più proprio della notitia criminis (tutto ruota intorno il napoletano imprenditore Alfredo Romeo), dell’ennesima puntata dell’ennesima stagione di intercettazioni intorno “casa Renzi” – secondo la sceneggiatura di Marco Lillo, casa di produzione Il Fatto Quotidiano. La quale casa di produzione pubblica (cioè spoilera, fregando il segreto delle procure) un fitto e drammatico dialogo tra figlio e padre Renzi riguardo l’incontro con uno degli imputati del caso Consip. Come se fosse, appunto, la conferma di quanto ha sempre sostenuto – un appalto “mafiosizzato”, in cui imprenditori, facilitatori, politici e commissari si tengono insieme da un patto scellerato di corruzione – e non, piuttosto, quanto è lampante, evidente. Che cioè, l’allora presidente del Consiglio e segretario del Partito democratico non ne sapesse proprio una beneamata mazza, e che, pure, tutto quest’ambaradam è stato costruito “ad arte” per colpirlo. Come è possibile questo, cioè che l’una cosa venga spacciata per l’altra? È possibile per lo stesso meccanismo per il quale se un personaggio muore in una stagione di una fiction può capitare che risorga due stagioni dopo: quello che conta cioè è la “cornice narrativa”, per un verso, e la disponibilità dello spettatore, per l’altro. E anche la cosa più inverosimile, cioè che un morto resusciti, viene passata per buona. Vedete, è la stessa risposta di Marco Travaglio quando gli si fa notare che tutto è un po’ illegittimo. E lui che dice? Non è questo che conta, è la “sostanza” che conta. La “sostanza” è solo il racconto. La tensione drammatica del dialogo tra figlio e padre Renzi c’è tutta. Un figlio deve chiedere conto al padre di un certo comportamento. Di un episodio, di una cosa. È un uomo fatto, ormai, e l’altro è sulla strada del declino. È un destino, questo, che prima o poi tocca tutti. Ma non a tutti tocca prendere di petto il proprio padre, incalzarlo di domande, metterlo all’angolo perché sia limpido, almeno per una volta, per questa volta. Accenna a qualcosa d’altro – e toccando proprio un tasto che sa l’altro ha proprio a cuore, la fede – per fargli capire che non è proprio aria, che non sorvolerà come magari altre volte è accaduto. Sa che il padre indulge alla bugia, magari piccola piccola, di quelle che si dicono per il bene – è un insegnamento che i cattolici conoscono a perfezione. O forse solo all’omissione. Lo ha fatto con lui, chissà quante volte quand’era piccino, e adesso ancora, adesso che è l’uomo più potente d’Italia, lo ha fatto con un suo braccio destro, Luca Lotti. «E non farmi dire altro», questo dice Matteo Renzi a suo padre. L’altro sa di cosa stia parlando il figlio, capisce, tace. Non farmi dire altro: è una frase forte, potente. Terribile. Matteo Renzi è un maschio alfa, un capo branco. Ha fatto presto, forse anche troppo presto, a misurare la sua forza, i suoi denti, la sua zampata con i vecchi capi del suo branco – non erano di già sdentati. Li ha rottamati a cornate, a unghiate, a morsi. Per quello che era la storia del suo partito era poco più di un cucciolo – la gerontocrazia vigeva sovrana nei partiti comunisti d’occidente. Eppure, quel cucciolo – all’inizio guardato con sufficienza nella sicurezza di domarlo al primo impatto – ha mostrato che era impastato di smisurata ambizione e forza. S’era addestrato in casa, prima. Forse presto, troppo presto, aveva già preso a cornate il proprio padre. Il primo, probabilmente, a essere rottamato. Vedete, in letteratura, c’è il complesso di Edipo, l’amore del figlio verso la madre e l’ostilità verso il padre, e il complesso di Elettra, per spiegarlo dalla parte delle bambine, e il complesso di Giocasta, l’amore morboso di una madre per il figlio. Ma non c’è letteratura, e nominazione, per un complesso del padre verso il figlio. Quell’uomo è tornato adesso come un incubo. E anche gli altri – quelli che ha rottamato politicamente – sono tornati come un incubo. Tutto troppo presto: nei racconti tutto questo accade quando il personaggio è ormai in agonia, negli ultimi giorni di vita, in cui rivede a ritroso la propria storia e tutti quelli che ha “fatto fuori” per il potere, quel dannato potere, tornano come fantasmi malmostosi. Chi sta accelerando il corso degli eventi narrativi? Qual è la manina che scrive? Che di soap opera si tratti è ormai evidente. Gli ingredienti ci sono tutti. Il malloppo, anzitutto, ovvero: l’avidità. E poi, il militare infedele, le carte false, il giudice che non decide su fatti e reati ma se gli atteggiamenti di uomini e donne siano o meno integerrimi, le gazzette ciarliere, gli azzeccagarbugli, la famiglia, quella naturale e quella allargata della Massoneria, e soprattutto: isso, issa e ‘ o malamente. Dove isso e issa è abbastanza facile identificarli, in Renzi e in Maria Teresa Boschi. Non c’è niente che unisca il caso Consip e il caso Banca Etruria, certo, a parte l’appartenere entrambi i personaggi principali, le dramatis personae, allo stesso “pacchetto di mischia”. Non c’è niente che unisca il caso Consip e il caso Banca Etruria, tranne il fatto che siano due giornalisti – de Bortoli e Lillo – le “gole profonde”. Scrivono e trascrivono, orecchiano e intercettano, alludono e illudono. A un certo punto, combaciano pure. Nella tempistica, intendo. Escono allo scoperto.
Sono loro, i due scrivani, ‘ o malamente? Due persone, in carne, ossa e testata, per un solo personaggio? Qualcosa si va sfaldando nella storia. Il militare infedele – che avrebbe dovuto “sacrificarsi” – va in giro a raccontare come sono andate davvero le cose. A chi rispondeva. Gli era stato ordinato di fare così, non è farina del suo sacco. Quasi, dice, ho solo obbedito agli ordini. E addita il responsabile. È stato il magistrato che indagava a voler lasciare intendere che i servizi segreti si stessero interessando della cosa – non c’è proprio traccia di questa storia, ma un faldone che racconta di come probabilmente i servizi segreti si sarebbero potuti interessare di questa storia. E le trascrizioni un po’ abborracciate, in cui l’uno veniva scambiato con l’altro, e quello che aveva detto l’uno veniva messo in bocca all’altro, beh, sì, quelle forse sono state un mio errore – dice l’infedele – però, dovete capirmi, ero sotto stress, quello – il giudice – voleva dei risultati e io non avevo in mano niente. Lo chiamava di notte, mentre compulsava ancora le sudate carte, il giudice Woodcock al capitano Scarfato per chiedergli conto di cosa fosse riuscito a concludere quel giorno? O lo chiamava all’alba, mentre iniziava a compulsare le sudate carte, per incitarlo a concludere finalmente qualcosa quel giorno? Che qua, di risultati, se ne vedevano pochini. Ah, che stress per il povero capitano. A un certo punto deve aver capito che sarà solo lui a pagare, a finire a dirigere il traffico a Forlimpopoli, e non ci sta. Tutto l’impianto narrativo rischia di impazzire come la maionese. E qua ‘ o malamente iesce ‘ a fora.
Banca Etruria, Renzi contro De Bortoli: "È ossessionato da me". Renzi in campo per blindare la Boschi: "Che Unicredit studiasse il dossier Etruria è il segreto di Pulcinella". E attacca De Bortoli: "Ha un'ossessione per me", scrive Sergio Rame, Sabato 13/05/2017, su "Il Giornale". "Ferruccio de Bortoli ha fatto il direttore dei principali quotidiani italiani per quasi vent'anni e ora spiega che i poteri forti in Italia risiedono a Laterina? Chi ci crede è bravo". In una intervista a tutto campo al Foglio, Matteo Renzi va all'attacco dopo le indiscrezioni sul salvataggio di Banca Etruria pubblicate dall'ex direttore del Corriere della Sera sul nuovo libro Poteri forti (o quasi). "De Bortoli ha una ossessione personale per me che stupisce anche i suoi amici". "Quando vado a Milano, mi chiedono: ma che gli hai fatto a Ferruccio? Boh. Non lo so". Nell'intervista al Foglio l'ex premier non fa sconti a De Bortoli: "Forse perché non mi conosce. Forse perché dà a me la colpa perché non ha avuto i voti per entrare nel Cda della Rai e lo capisco: essere bocciato da una commissione parlamentare non è piacevole. Ma può succedere, non mi pare la fine del mondo". Per Renzi "che Unicredit studiasse il dossier Etruria è il segreto di Pulcinella". "Praticamente tutte le banche d'Italia hanno visto il dossier Etruria in quella fase. Come pure il dossier Ferrara, il dossier Chieti, il dossier Banca Marche. Lo hanno visto tutti e nessuno ha fatto niente", continua Renzi. Che, poi, aggiunge: "Ferruccio de Bortoli ha detto falsità su Marco Carrai. Ha detto falsità sulla vicenda dell'albergo in cui ero con la mia famiglia. Ha detto falsità sui miei rapporti con la massoneria. Non so chi sia la sua fonte e non mi interessa. So che è ossessionato da me. Ma io non lo sono da lui. È stato un giornalista di lungo corso, gli faccio i miei auguri per il futuro e spero che il suo libro venda tanto". Renzi è convinto che, quanto prima, "si chiariranno le responsabilità a vari livelli". "E - avverte - se c'è un motivo per cui sono contento che la legislatura vada avanti fino ad aprile 2018 è che avremo molto tempo per studiare i comportamenti di tutte le istituzioni competenti. Cioè, competenti per modo di dire. Non vedo l'ora che la commissione d'Inchiesta inizi a lavorare. Come spiega sempre il professor Fortis, vostro collaboratore, Banca Etruria rappresenta meno del 2 per cento delle perdite delle banche nel periodo 2011-2016. Boschi senior è stato vicepresidente non esecutivo per otto mesi e poi noi lo abbiamo commissariato: mi pare che non sia stato neanche rinviato a giudizio. Se vogliamo parlare delle banche, parliamone. Ma sul serio".
Sulla propria pagina Facebook, De Bortoli replica ricordando all'ex premier che "avendo detto due volte no alla proposta di fare il presidente, non era tra le mie ambizioni essere eletto nel cda della Rai". E incalza: "Visto quello che sta accadendo, ringrazio di cuore per non avermi votato. Non avrei potuto comunque accettare avendo firmato un patto di non concorrenza". Poi continua: "Io non ho mai scritto che è un massone, mi sono solo limitato a porre l'interrogativo sul ruolo della massoneria in alcune vicende politiche e bancarie. Ruolo emerso, per esempio, nel caso di Banca Etruria. Ho commesso degli errori, certo". Nel libro ne ammette diversi in oltre quarant'anni. Come quello, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera sul caso JpMorgan-Mps, della data di un sms solidale inviato da Marco Carrai a Fabrizio Viola, "licenziato" poi dal governo. "Non so quali falsità siano state scritte sul soggiorno a Forte dei Marmi nell'estate del 2014 - continua - mi aspetterei invece da Renzi che chieda scusa al collega del Corriere che, in quella occasione, stava facendo il suo lavoro e alloggiava nell'hotel. L'inviato venne minacciato dalla scorta che gli intimò di andarsene. E gli faccio i miei migliori auguri per il suo libro che uscirà a breve".
Giornalismo del controregime, scrive Piero Sansonetti il 13 Maggio 2017 su "Il Dubbio". Le fake news sono diffuse dai social network o comunque dalla rete? No. Le fake news sono diffuse principalmente dai giornali e dalle televisioni. I social vengono a rimorchio, le rilanciano. Ma non sono loro a costruirle. Almeno, non sono loro a costruire le fake importanti. La responsabilità della creazione delle bugie e del loro uso come arma politica e di disinformazione ricade soprattutto sui grandi quotidiani e sui grandi giornalisti. Giornalismo di contro- regime Cioè, giornalismo di regime. Proviamo un inventario di avvenimenti recenti. Caso Guidi, con annesse dimissioni della ministra. Caso Consip, con annessa richiesta di dimissioni del ministro Luca Lotti. Caso Ong, con annessa richiesta di limitazione dell’azione dei soccorsi ai migranti sul Mediterraneo. Caso De Bortoli, con annessa – ed ennesima – richiesta di dimissioni della ministra Maria Elena Boschi. Su questi quattro casi i giornali italiani e i principali talk show televisivi hanno vissuto per mesi e mesi. Con titoli grandi in prima pagina e – alcuni – con vere e proprie campagne di stampa, molto moraleggianti e molto benpensanti. Certo, soprattutto del “Fatto Quotidiano” – che quando offre ai suoi lettori una notizia vera succede come successe a Nils Liedholm quando per la prima volta in vita sua sbagliò un passaggio: lo Stadio di San Siro lo salutò con una ovazione… – ma anche di parecchi altri giornali che godono di alta fama. Ora vediamo un po’ come sono finiti questi quattro casi.
Guidi: mai incriminata. L’inchiesta giudiziaria che la sfiorò, Tempa Rossa, conclusa con il proscioglimento di tutti. Era una Fake. Federica Guidi è scomparsa dai radar della politica.
Consip, l’inchiesta è stata trasferita a Roma, le accuse al padre di Renzi erano fondate su una intercettazione manipolata da un carabiniere, anche le notizie sull’ingerenza dei servizi segreti (evidentemente mandati da Renzi per ostacolare le indagini) erano inventate da un carabiniere e l’informativa al Pm che riguardava queste ingerenze era stata scritta su suggerimento dello stesso Pm che avrebbe dovuto esserne informato. Fake e doppia fake.
Ong, l’ipotesi del Procuratore di Catania che fossero finanziate dagli scafisti è stata esclusa dalla Procura di Trapani da quella di Palermo e da svariati altri magistrati. Fake. Intanto l’azione di soccorso ha rallentato.
De Bortoli. Sono passati ormai quattro giorni da quando, per lanciare il suo libro sui poteri forti, l’ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore ha diffuso la notizia della richiesta di Maria Elena Boschi all’amministratore delegato di Unicredit di comprare la banca nella quale lavorava il padre. Boschi ha smentito nettamente. Anche la banca ha dichiarato che non risulta niente. De Bortoli ha fatto mezza marcia indietro, poi ha accusato Boschi e Renzi, o almeno i loro ambienti, di essere massoni, ed è andato in Tv, senza portare neppure uno straccio di prova delle sue accuse ed evitando il confronto diretto con gli avvocati della Boschi. Tranne improvvisi colpi di scena, appare evidente un po’ a tutti che l’accusa di De Bortoli è infondata, altrimenti, ormai, avrebbe fornito degli elementi a sostegno della sua tesi. Anche qui possiamo dire: fake.
La questione invece del complotto massonico a favore di Renzi, denunciato da de Bortoli, non è definibile esattamente una fake, è solo qualcosa di già visto tante volte nella politica italiana. In frangenti non bellissimi. Il più famoso complotto massonico – per la precisione giudaico-massonico, anzi: demo-pluto-giudaicomassonico – fu denunciato da Mussolini, nel 1935, per favorire la persecuzione dei massoni e poi lo sterminio degli ebrei. Non ci fa una gran figura De Bortoli a tornare sul quel concetto, peraltro senza avere proprio nessun indizio sulla appartenenza di Boschi o di Renzi alla massoneria. E in ogni caso andrà segnalato il fatto che la massoneria non è una associazione a delinquere. Furono massoni, in passato, un gran numero di Presidenti americani, tra i quali Washington e Lincoln, furono massoni poeti come Quasimodo e Carducci, furono massoni Cesare Beccaria, Mozart, Brahms, e svariate altre centinaia di geni, tra i quali moltissimi giornalisti di alto livello, parecchi dei quali del Corriere della Serra. Possibile che un giornalista colto e autorevole come De Bortoli scambi la massoneria per Avanguardia Nazionale? Eppure De Bortoli ha trovato grande sostegno nella stampa italiana. In diversi giornali e in diverse trasmissioni Tv la sua “ipotesi di accusa” alla Boschi è stata ed ancora in queste ore è presentata come dato di fatto: «Lei che ha svelato la richiesta della ministra…». Una volta esisteva la stampa di regime. Ossequiosa verso i politici, soprattutto, e in genere verso l’autorità costituita. Ora esiste la stampa di anti- regime. O di contro- regime, che però funziona esattamente come la stampa di regime. Anche perché ha dietro di se poteri molto forti. Non solo un pezzo importante di magistratura ma uno schieramento vasto di editori, cioè di imprenditoria, diciamo pure un pezzo robustissimo della borghesia italiana. De Bortoli oggi è sostenuto da quasi tutti i mezzi di informazione, e si può pensare tutto il bene possibile di lui, tranne una cosa: che sia un nemico dei poteri forti. De Bortoli, per definizione, è i poteri forti. Lo è sempre stato, non lo ha mai negato, nessuno mai ne ha dubitato.
La stampa di contro-regime funziona esattamente così. Non è una stampa di denuncia ma una stampa che costruisce notizie e le difende contro ogni evidenza e logica anche queste crollano. Nei regimi totalitari questa si chiamava “disinformazia” ed aveva un compito decisivo nel mantenimento al potere delle classi dirigenti. Ora si chiama fake press e ha un ruolo decisivo nella lotta senza quartiere che è aperta nell’establishment italiano per la conquista del potere, di fronte alla possibilità di un rovesciamento dei rapporti di forza nel ceto politico. L’avanzata dei 5 Stelle ha provocato un terremoto. Pezzi molto grandi, autorevoli e potenti proprio dei poteri forti si predispongono a dialogare coi 5 Stelle, prevedendone, o temendone, l’ascesa al governo. Questo movimento tellurico squassa la democrazia e devasta i meccanismi dell’informazione. Esistono le possibilità di resistere, di fermare il terremoto, di reintrodurre il principio di realtà – se non addirittura di verità – nella macchina dei mass media che lo ha perso? Non è una impresa facile. Molto dipende dai giornalisti. Che però, nella loro grande maggioranza, oggi come oggi non sembrano dei cuor di leone…
Ferruccio, per favore, se hai le prove mostrale, scrive Piero Sansonetti il 12 Maggio 2017 su "Il Dubbio". Il caso Boschi-Banca Etruria si sta sgonfiando. Finirà nel dimenticatoio come il caso-Guidi, il caso-Lupi, il caso Madia? Il caso-Boschi si ridimensiona. Molti giornali di destra hanno mollato la presa dopo la parziale marcia indietro di Ferruccio De Bortoli, che ha spiegato di non aver mai sostenuto che la Boschi fece pressioni indebite su Unicredit per salvare Banca Etruria. Eppure nel suo libro c’è scritto che «Boschi chiese a Ghizzoni (amministratore delegato di Unicredit) di valutare l’acquisto di Banca Etruria». Resta in campo, al momento, solo Il Fatto Quotidiano che ieri si è lanciato in soccorso di De Bortoli sostenendo di avere le prove della colpevolezza della Boschi. Lo ha scritto enorme, in prima pagina, con l’inchiostro rosso: «Boschi mente: ecco le prove». E ha pubblicato un servizio d Giorgio Meletti nel quale si parla di una riunione a casa del papà della Boschi, dirigente di Banca Etruria, con gli amministratori della stessa Banca Etruria e di alcune banche del Nord. A questa riunione – dice Meletti – che si tenne nel marzo del 2014, partecipò anche la Boschi. Il servizio di Meletti è fatto molto bene e sembra assai informato, anche se naturalmente occorreranno dei riscontri. E tuttavia resta una domanda: ma Meletti non accenna nemmeno all’ipotesi che a questa riunione, o ad altre riunioni, partecipò Ghizzoni. E allora perché mai questo fatto dovrebbe provare che De Bortoli ha ragione? Ieri de Bortoli ha partecipato alla trasmissione televisiva “Otto e Mezzo” di Lilli Gruber. Ha detto che la vicenda di Banca Etruria è tutta una vicenda di massoneria. Un paio d’anni fa aveva detto la stessa cosa del governo Renzi. Né allora né adesso, però, ha citato elementi di prova, o almeno di indizio. Più che altro è sembrata una sua sensazione. Se anche le accuse alla Boschi di aver tentato di spingere Ghizzoni a comprare la Banca dove lavorava il papà dovessero basarsi solo su una sua impressione, non sarebbe una buona cosa. Questa vicenda può concludersi in tre modi. O De Bortoli si decide a portare le prove della sua affermazione, e allora il governo Gentiloni va a gambe all’aria. O De Bortoli queste prove non le ha, e davvero ha scritto il libro solo basandosi su voci raccolte in ambienti vicini a Unicredit, e allora ci troveremmo di fronte a un capitolo nerissimo per il giornalismo italiano. Oppure può succedere che i due contendenti capiscono che è meglio non esagerare nel duello, anche perché l’uno e l’altra hanno dietro le spalle forze abbastanza potenti e capaci di far male, e in questo caso anche “Il Fatto” abbasserà i toni e tutta la storia passerà in cavalleria. Come è successo col caso-Guidi, col caso-Lupi, col caso Madia. E’ sicuramente la terza l’ipotesi più probabile. E non è una bella cosa, né per il giornalismo né per la politica.
Quelle cene con Ligresti per tornare in via Solferino. La vacanza dell'ex direttore nel resort in Sardegna, scrive Domenica 14/05/2017, "Il Giornale". Le cronache raccontano di aragoste a quintali per gli ospiti illustri di Salvatore Ligresti al Tanka Village di Villasimius, in Sardegna. Vecchie storie, un'altra epoca, uno splendore e una leggerezza che ormai non ci sono più. Alla corte dell'ingegnere, quando i tempi del crack Fonsai erano ancora molto lontani, accorrevano in tanti, per lo più personalità del mondo politico e istituzionale, ministri, generali, prefetti, sottosegretari, direttori. Andare al Tanka era un po' lavorare, perché lì si tessevano le relazioni pubbliche che contavano e che portavano spesso alle poltrone importanti. Relazioni rigorosamente trasversali, bipartisan si direbbe oggi. Il Tanka, insomma, veniva considerato un po' una prosecuzione dell'ufficio. Anche se molti scroccavano pure la vacanza, visto che pochi alla fine pagavano il conto. Qualcuno, quando poi se n'è parlato sui giornali, ha persino negato di esserci stato. Non si sa mai. Tra i tanti che negli anni sono passati per il bellissimo villaggio sardo un tempo regno della famiglia Ligresti c'era anche l'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli. Correva l'estate del 2008. All'epoca non guidava più il quotidiano di via Solferino, che aveva già diretto per sei anni, dal 1997 al 2003, ma era già in trattativa per tornarci e si muoveva in quella direzione. C'è chi lo ricorda, infatti, ospite di Ligresti, proprio lì, nel resort di Villasimius, dove l'ingegnere amava organizzare cene speciali per i suoi ospiti di riguardo. Quell'estate il giornalista trascorse qualche giorno al Tanka e tutte le sere sedeva al tavolo di Ligresti, in quel periodo ancora saldamente al vertice di Fonsai, azionista di peso del patto di sindacato dell'editore del Corriere della Sera. Per poter tornare al timone di via Solferino, insomma, era quello il posto giusto dove mangiare aragoste in compagnia e dove valeva la pena trascorrere qualche giorno di vacanza. Di lì a qualche mese, infatti, de Bortoli tornò al comando del giornale milanese, dove è poi rimasto fino al 2015. E pensare che in quei giorni d'estate furono in molti a stupirsi di vederlo al Tanka, tra i clientes di Ligresti. C'è anche chi lo ricorda bersaglio di amichevoli sfottò sull'argomento da parte di chi sedeva con lui al tavolo dell'ingegnere e che sapeva bene perché fosse lì. Pare che lui non gradisse le prese in giro sull'evidente motivo della sua presenza in quel luogo. Era tanti anni fa. Un'altra epoca, appunto.
Il libro di de Bortoli e la memoria corta sul "Corriere" indipendente, scrive Alessandro Sallusti, Venerdì 12/05/2017, su "Il Giornale". Ho letto Poteri forti (o quasi), il libro di Ferruccio de Bortoli già direttore del Corriere della Sera e del Sole24Ore - edito da «La nave di Teseo», di cui si parla in questi giorni per il clamore suscitato dal capitolo che svela l'interessamento della ministra Boschi presso Unicredit per agevolare il salvataggio della banca di papà, la Etruria. «Memorie di oltre quarant'anni di giornalismo», recita il sottotitolo di copertina. E questo basta per mettere l'autore al riparo da critiche su eventuali errori ed omissioni nel racconto che corre fluido come si addice alla penna di un grande giornalista e direttore. Perché di «memoria» ognuno ha la sua e ha il diritto di centellinarla a suo piacimento, che sia per amnesia o per calcolo. Non so perché Ferruccio de Bortoli abbia deciso di raccontarsi a soli 64 anni. Di solito l'autobiografia salvo casi di conclamato narcisismo o ragioni economiche arriva a chiudere una carriera, non a rilanciarla. Svelare retroscena, dare giudizi su uomini viventi e potenti si presta a ritorsioni pericolose. Conoscendo la cautela dell'uomo, grande e cauto navigatore, mi vien quindi da pensare che de Bortoli consideri conclusa la sua brillante carriera, almeno nel giornalismo attivo e di vertice. Fatti suoi, ovviamente. Ma torniamo al libro. De Bortoli vuole farci credere di essere stato per dodici anni (in due tranche, 1997-2003, 2009-2015) a capo di un giornale tempio della libertà e sentinella di democrazia, arbitro imparziale delle partite alcune violente e drammatiche - che si giocavano nel Paese. È la vecchia tesi, retorica e falsa, della sacralità del Corriere della Sera, giornale in cui ho lavorato per diversi anni e che quindi ho ben conosciuto dall'interno. Il Corriere è stato il primo, e per lungo tempo unico, grande e ricco giornale nazionale e per questo ha allevato e ospitato le migliori firme del giornalismo e della cultura per oltre un secolo. Fin dalla nascita, il vestito è stato a libera scelta da qui la sua apparente indipendenza - del direttore e dei giornalisti, ma il cappello è sempre stato attaccato dove padrone voleva: monarchico durante la monarchia, fascista sotto il fascismo, antifascista alla caduta del regime, piduista all'epoca della P2, filo-Fiat sotto il regime di Agnelli, benevolo, negli anni più recenti governati da Bazoli, con il sistema finanziario e bancario vincente. Quest'ultimo è un club di miliardari i cui membri, come tutti i padroni, sono conservatori, ma hanno la necessità di apparire progressisti per non avere rogne nel loro espandersi nell'ombra (in Francia la chiamano «sinistra al caviale»). Tutto ciò non significa che de Bortoli non sia stato un direttore libero. Lui, nato in altro mondo (la sua era una solida e umile famiglia), sognava e studiava fin da giovane racconta chi l'ha frequentato in quegli anni di entrare in quell'ambiente dorato ed esclusivo. Sulla plancia del giornale degli Agnelli prima e dei banchieri poi è stato quindi perfettamente a suo agio. Più che di indipendenza parlerei quindi di coerenza.
Non è poca cosa, la coerenza, cioè la fedeltà alle proprie idee. Ma perché non dirlo? Perché evitare, in una biografia di oltre duecento pagine, di scrivere due righe sul suo essere stato un giovane e convinto comunista, sia pur di quelli che, essendo intelligenti, avevano capito che più che le piazze era meglio frequentare i salotti, che le parole potevano essere più utili e potenti delle spranghe alle quali, infatti, l'uomo, a differenza di tanti compagni, non si è mai neppure avvicinato. Nel libro la fede politica di de Bortoli la si deduce solo dal fatto che le offerte di lavoro che narra di aver ricevuto (presidente Rai, sindaco di Milano, direttore del Corriere) gli arrivavano sempre da politici o banchieri di sinistra (una, in verità, da Letizia Moratti, ma era appunto per dirigere il Tg3). Essere di sinistra è infatti la non misteriosa precondizione per dirigere il Corriere della Sera, altrimenti non si spiega come a giornalisti altrettanto bravi (penso a Montanelli prima di lui e a Vittorio Feltri suo quasi coetaneo) sia stata negata tale possibilità. Anche l'attuale direttore, Luciano Fontana, non a caso professionalmente e culturalmente nasce e cresce all'Unità. De Bortoli (con Paolo Mieli, con il quale si è avvicendato più volte al comando) è stato la faccia presentabile dell'antiberlusconismo militante, la lunga mano della sinistra politica e affaristica (che nel libro, giustamente, si vanta di aver frequentato con reciproca stima e soddisfazione) per manipolare l'opinione pubblica in punta di regole («la notizia è notizia», ama ripetere il direttore, quasi a scusarsi). Noi tutti sappiamo che cosa de Bortoli che oggi ci rinfresca la memoria anche con aneddoti curiosi - è stato libero di scrivere e far scrivere, non cosa non ha pubblicato (potere questo più importante del primo). E, forse, non lo sa neppure lui, perché in un giornale l'acqua inevitabilmente scorre dove il direttore (e il padrone) traccia il solco. Escludo in modo categorico che de Bortoli sia mai stato servo di qualcuno, ma socio ho il sospetto di sì. Forse pure dei magistrati che davano la caccia a Silvio Berlusconi. Nel libro c'è un lungo paragrafo di elogi a Ilda Boccassini («ne ammiro il coraggio, per fortuna il Paese ha toghe come lei, coraggiosa e preparata»). Dice di averla incontrata tante volte, la chiama per nome, «Ilda», incurante di poter così suscitare anche solo un sospetto sull'origine di tanta abbondanza di informazione che il Corriere ha sfornato durante il caso Ruby («una inchiesta per la quale è stata ingiustamente attaccata», scrive senza aggiungere che l'imputato, Berlusconi, è stato assolto per non aver commesso il fatto e che, quindi, non fu una grande inchiesta). Di Berlusconi scrive con distacco: «Il Cavaliere non si arrese mai all'idea che un giornale liberale non stesse per definizione dalla sua parte». Per la verità il Corriere della Sera è stato «per definizione» contro Berlusconi, il cui dubbio è lo stesso che negli ultimi cinquant'anni hanno avuto in tanti: come ha fatto un giornale che si dice liberale a farsi soggiogare dal Pci, dal sindacato interno (un vero Soviet con diritto di censura), fino a strizzare l'occhio alla non pacifica rivoluzione sessantottina? Cosa c'era, nel 1994, di liberale nello sperare che Occhetto prendesse il potere a scapito di un partito davvero liberale come Forza Italia (io c'ero, dietro le quinte, e l'apparente equidistanza era tifo vero)? Cosa c'è stato di liberale nel fare un endorsement, alla vigilia del voto del 2006, a firma del direttore (Paolo Mieli, prima volta nella storia di quel giornale) a favore di un governo Prodi-Bertinotti? Cosa c'è stato di liberale nell'avere un pregiudizio profondo nei confronti non solo di un liberale come Silvio Berlusconi, ma di chiunque emergesse in qualsiasi campo (arte, letteratura, musica, perfino lo sport) e non fosse dichiaratamente di sinistra? La risposta è semplice: Il Corriere, da un secolo a questa parte, non è un foglio liberale. È un camaleonte che ha ingannato, e inganna tuttora, i suoi non pochi lettori liberali (e tutti i politici liberali che bramano di apparire sulle sue colonne). Il Corriere di de Bortoli è stato, lo ripeto, «per definizione» e con un abile gioco di doppi pesi e doppie misure, contro tutto ciò che non era omologato al clan. Tra i suoi editori nel consiglio di amministrazione Rcs - De Bortoli ne ha avuto uno mal visto dai salotti della sinistra e simpatico alla destra: Salvatore Ligresti. E, guarda caso, è l'unico che nelle sue memorie stronca anche con un certo cattivo gusto: «Mi sono trovato a disagio a sedermi a tavola con la sua famiglia». Ora, è vero che Ligresti era un personaggio atipico, che è fallito malamente. Ma sono certo che la sua coscienza non è meno linda di quella di diversi suoi soci apparentemente «per bene» tanto cari al direttore. Certo, è facile vantarsi, con un eccesso di civetteria, dell'amicizia di Mario Draghi: «Una sera camminavo per Parigi, mi suona il telefonino: ciao Ferruccio, sono Mario...». Facile liquidare l'appoggio entusiasta dato dal Corriere al disastroso governo Monti dando un paio di buffetti al Professore oggi in disuso. Facile svelare solo oggi l'aggressione subita da un cronista del Corriere da parte di Matteo Renzi, taciuta quando l'aggressore era potente primo ministro. Insomma, è facile continuare la narrazione della favola di un Corriere della Sera vergine e nelle mani di coraggiosi paladini senza macchia con fonti disinteressate. Facile e pure legittimo. Ma, almeno io, non ci casco.
MAGISTRATI: FACCIAMO QUEL CHE VOGLIAMO!
Le Brigate nere del voyeurismo giudiziario. La Corte d’appello di Milano ha smontato il processo Ruby-Berlusconi, una fiction contrabbandata per processo penale, mentre un manipolo di giornalisti guardoni insiste nel tentativo di lapidazione pubblicando intercettazioni irrilevanti, scrive Giorgio Mulè su “Panorama”. Lo dico con assoluta certezza: sono stati anni di piombo. Anni putridi, in cui nel nome della superiore necessità di distruggere quel nemico personale e politico chiamato Silvio Berlusconi, s’è sparato ad alzo zero come negli anni più bui della Repubblica. Non abbiamo sentito il rimbombo dei colpi di P38 ma abbiamo sulla nostra pelle le cicatrici di micidiali pallottole di carta mentre le molotov sono state sostituite da vergognose serpentine televisive. E d’altronde l’humus quello era. Quello, cioè, di un gruppo di reduci del ’68 che occhieggiavano alla lotta armata senza impugnare una pistola perché tanto a fare il lavoro sporco ci pensavano i poveracci della classe proletaria. È il loro «stile», che inizia col lurido manifesto contro il commissario Calabresi dopo la morte di Giuseppe Pinelli. Venne pubblicato per tre settimane di fila dal settimanale L’Espresso nel giugno del 1971, meno di un anno dopo Luigi Calabresi veniva ucciso dalla manovalanza di Lotta continua su incarico dell’ideologo del gruppo Adriano Sofri. Quel manifesto agghiacciante che «ricusava» la legge e bollava come «torturatore» il commissario lo firmarono in 757 (andatevi a leggere chi lo sottoscrisse e vi sembrerà di partecipare a una riunione di redazione del gruppo L’Espresso). Non è stato perciò sorprendente, per me, leggere la scorsa settimana su L’Espresso un articolo che dava conto di una intercettazione telefonica del luglio 2013 tra me e Marina Berlusconi della quale ignoravo l’esistenza non essendomi mai stata consegnata dai signori magistrati. Ma all’Espresso, ribadisco, lo stile impunito della casa è questo. Che permette, nonostante una diffida legale, la pubblicazione di un atto penalmente irrilevante qual è questa conversazione tra il direttore e il suo editore, non indagato, in un procedimento comunque archiviato ben quattro mesi fa. Una barbarie assoluta. La cui presunta rilevanza pubblica viene giustificata meschinamente ai propri lettori con il bla bla politico che vuole Marina Berlusconi prossimo leader del centrodestra. Quell’intercettazione, tra l’altro, rappresenta uno dei punti più bassi nella storia giudiziaria italiana. Per settimane, infatti, sull’onda di un’ipotesi di reato offensiva e palesemente farlocca (si presumeva che io avessi corrotto qualcuno per avere uno scoop) vennero ascoltate migliaia di telefonate su 24 utenze in uso al sottoscritto, al vicedirettore esecutivo, al capo della redazione romana, a un giornalista e a un collaboratore. Una gigantesca operazione degna della peggiore Stasi. Un anno fa, appena seppi di questa enorme infamia mascherata da investigazione, misi in guardia dal fatto che «conversazioni personalissime» sarebbero potute finire «nelle mani di giornalisti guardoni» e invocai l’intervento del presidente della Repubblica in qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura, di garante della Costituzione laddove è contemplata la libertà di stampa. Il presidente Napolitano, che ha dimostrato anche recentemente di saper far sentire (eccome!) la sua voce al Csm, non ha mosso un dito. Non l’hanno fatto, se è per questo, neppure i miei colleghi conigli che rappresentano la categoria. Il risultato è che, certamente dall’interno di un ufficio giudiziario, è stata consegnata all’Espresso la telefonata numero 831 (vi rendete conto quante migliaia ne hanno ascoltate!) tra me e Marina Berlusconi. Invocare non un intervento, ma anche una sola parola di condanna da parte di Matteo Renzi sarebbe inutile: il ragazzino deve essere così atterrito dai signori in toga che – pensate in che mani siamo – ha smesso di mandare sms o rispondere ai miei da quando il 30 maggio scorso ho scritto che i nostri scambi sarebbero stati letti anche da «qualche pubblico ministero che controlla le mie comunicazioni». Il silente ministro della Giustizia, che un giorno sì e l’altro pure corre a confessarsi con Repubblica, potrebbe trovare la favella visto che è alle prese con la riforma anche delle intercettazioni telefoniche. Faccia il seguente esercizio per sentire scorrere un brivido: provi a pensare se una sua conversazione intercettata in cui magari si sfoga e, che so io, dà dello stronzo a Renzi potrebbe finire sui giornali. Brutta roba, eh? Però, vedete, questa è ahimè l’Italia che negli anni di piombo ha lapidato Berlusconi e chiunque gli stesse vicino. È l’Italia che ha additato come «guardie armate» di Berlusconi facenti parte di un’orrida Struttura Delta alcuni direttori del gruppo Mondadori, Mediaset e del Giornale colpevoli, Repubblica dixit, di «propiziare “atti sediziosi” e inquinare fatti incontrovertibili» come l’indagine su Ruby. È l’Italia che ha calpestato la dignità di ragazze che frequentavano Arcore dandogli lo stigma di puttane a vita. È l’Italia dei maître-à-penser che nel 2011 sputavano sul proprio Paese scrivendo sul New York Times articolesse per spiegare «Why have italians, especially the women, tolerated Mr. Berlusconi for so long?». È l’Italia che ha criminalizzato chi si riconosceva in una parte politica e che si è bevuta, nel 2011, un colpo di Stato morbidissimo consumato sull’onda del voyeurismo giudiziario e sull’imbroglio dello spread. Adesso che la Corte d’appello di Milano ha smontato questa fiction agghiacciante contrabbandata per processo penale è il caso di ricordare ciò che Marina Berlusconi disse a Panorama, non intercettata ma in un’intervista, nel maggio del 2013 a proposito della vicenda Ruby: «Finirà tutto in una bolla di sapone, ma all’associazione della gogna non importa nulla di come andrà a finire, interessa solo la condanna mediatica. E, quando il teorema dell’accusa crollerà, quale interdizione dovrebbe essere chiesta per coloro che hanno costruito questa montatura infernale?». Vedremo adesso che cosa succederà nell’Italia del 2014 che si dice coraggiosa e che, finora a parole, vuol cambiare verso.
Filippo Facci su “Libero Quotidiano”: Ruby e Puttanopoli sono la più grande sconfitta di Ilda Boccassini. E di qualche giornalista. Forse sì, forse è la più grande sconfitta patita della procura di Milano in vent’anni di processi ad personam contro Silvio Berlusconi. Questa non è l’America, dove un procuratore sconfitto ha delle immediate ripercussioni sulla carriera: qui un procuratore sconfitto fa subito ricorso contro il malcapitato, s’infila in cento altri processi contro di lui, se necessario prosegue la sua campagna per quindici o vent’anni, certo, sì. Ma stavolta la sconfitta non ha rimedio perché è inequivoca, netta, il reato non esiste e stop, non ci sono margini (manca soltanto il sigillo della Cassazione) e stiamo parlando del processo più rumoroso, mondialmente sputtanante e al tempo stesso più semplice da capire, l’unico che era stato ampiamente pre-giudicato dall’opinione pubblica e l’unico, soprattutto, che a suo modo pareva perduto dalla procura anche dopo la vittoria in primo grado. Ora gli esterofili si divertirebbero nel chiedersi «in quale Paese al mondo» una procura possa processare un capo del governo per concussione e prostituzione minorile e poi, dopo la sconfitta, uscirsene come se nulla fosse, come se la sua azione in nome del popolo italiano non si fosse tradotta in un sostanziale danno al popolo italiano. In quale altro Paese - Di che parliamo? Di una campagna mediatica spaventosa, senza paragoni con qualsiasi altra, migliaia di intercettazioni che hanno sputtanato uomini e donne costrette in qualche caso a rifugiarsi all’estero, una task-force di magistrati che ha strapazzato le regole pur di aggiudicarsi un processo che spettava ad altri e che ha contribuito a sfaldare la procura davanti al Csm, e tutto per una domanda che da ieri è alla portata di tutti, cittadini e giornalisti e politici e giudici di ogni orientamento, ossia questa: ci voleva tanto? Ci voleva tanto a capire che era tutta un’immensa e pruriginosa cazzata? Era così difficile - anche senza scomodare procedure e giurisprudenze - capire che quella telefonata non era una concussione? Che una concussione senza concussi resta improbabile? Che la signorina Ruby si era facilmente spacciata per maggiorenne senza esserlo? Che una furbastra e una mitomane è da considerare sempre furbastra e sempre mitomane? Che un rapporto sessuale negato, in un’aula di giustizia, non si può dimostrare per teorema? Che per anni e anni e anni ci siamo occupati solo degli stracazzi personali di Silvio Berlusconi? C’erano quelli, nelle 500 pagine di allegati che giunsero alla Camera il 17 gennaio 2011 assieme alla richiesta di perquisizione per l’ufficio di Giuseppe Spinelli, ragioniere dal quale partivano bonifici per alcune «olgettine» già ospiti delle serate a villa San Martino: c’era il «sistema Arcore», quello in cui giovani donne facevano semplicemente quello che volevano e non facevano quello che non volevano. Un giorno s’infilò una minorenne che Ilda Boccassini definì di «furbizia orientale» (anche se era marocchina e il Marocco è a Occidente) ed ecco che la mitica procura di Milano si scaraventò a perseguire il reato notoriamente più grave e urgente: un caso di sospetta prostituzione minorile. E quattro anni dopo non è una sconfitta, è un’ecatombe. Egregio vicepresidente del Csm Michele Vietti, sono queste le mazzate che distruggono la credibilità di una procura davanti all’opinione pubblica: mica gli esposti di Alfredo Robledo contro il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati. Ecco, Bruti Liberati: mesi o anni passati a dividere l’ufficio, a favorire i suoi pubblici ministeri preferiti a scapito di altri, acrobazie procedurali per spiegare che Berlusconi era un concussore ma che i presunti concussi, i funzionari della Questura, avevano commesso solo delle scorrettezze amministrative. Paf, tutto disciolto in una sbrigativa camera di consiglio. Con la complicazione che alcuni funzionari poco collaborativi sono stati addirittura indagati per depistaggio, senza contare la complicazione ancora più complicata di un Ruby bis - il processo parallelo per corruzione di testimoni - che ora resta appeso al nulla. Il fatto non sussiste. Il fatto non costituisce reato. Senza contare che questa sentenza d’appello potrebbe ripercuotersi sulle residue puttanopoli sparse per il Paese. E poi c’è lei, Ilda Boccassini, una delle più grandi investigatrici del Paese - nessuna ironia - ma che ora rischia di gettare una luminosa carriera nell’ombra di questo processo ridicolo. Quando Berlusconi fu inquisito per la prima volta, nel 1994, lui aveva 58 anni ed era presidente del Consiglio; la Boccassini quell’anno ne aveva 45 ed era reduce da esperienze importanti in Sicilia sulle orme degli assassini di Falcone e Borsellino, e stava appunto per coinvolgere Berlusconi in inchieste pesantissime su corruzioni giudiziarie, roba tosta ma che l’hanno lasciato illeso. Poi c’è un terzo soggetto, Karima el Mahroug, detta Ruby, che in quel 1994 si limitava a ciucciare il biberon perché aveva un anno. Ora, cioè una ventina d’anni dopo, rieccoci con un Berlusconi che ha 78 anni, è ancora politicamente in sella e però è stato appena assolto da un processo imbastito ancora da lei, Ilda Boccassini, che ora ha 63 anni e l’anno scorso aveva finalmente ottenuto una pesante condanna: e per che cosa? Per una concussione e una prostituzione minorile alle quali non ha mai creduto nessuno. Imbarazzi - Non pochi, nel giorno della condanna di Berlusconi in primo grado, lessero nell’assenza di Ilda Boccassini un doppio imbarazzo: la possibile amarezza per una sconfitta o la possibile amarezza per una vittoria. Finì con la più improbabile delle vittorie, 7 anni e interdizione a vita, un collegio giudicante simbolicamente retto da tre donne. Bella figura anche la loro. Poi ci sarebbe tutto un discorso sui giornalisti, ma tanto è inutile. Ieri Marco Travaglio ha già tirato in ballo un possibile «errore giudiziario» e ha chiarito che «secondo me, a naso, hanno sbagliato i giudici d’appello». A naso: chissà con che cosa ha scritto il suo articolo, poi. «Sono curioso di vedere», ha aggiunto, «come il giudice motiva questa cosa e se è tutto regolare». All’erta, signor giudice. Infine è andato a rincarare la dose a Bersaglio Mobile, da Enrico Mentana, su La7: la parola all’esperto. «Il nostro giornale», ha concluso, «non ha una linea preconcetta per la quale Berlusconi è sempre colpevole». È simpatico, dài.
Ruby, rissa in procura a Milano: Armando Spataro contro Ilda Boccassini, scrive “Libero Quotidiano”. L'assoluzione di Silvio Berlusconi nel secondo grado del processo Ruby ha gettato nello sconforto la procura di Milano. O almeno parte della procura, che sulla vittoria del Cav ufficialmente non commenta, anche se tra i corridoi di palazzo di Giustizia si parla soltanto di quello. E se ne parla anche nella mailing list di categoria, con toni molto, molto accesi. Infatti il fronte uscito con le ossa rotte dalla sentenza, ossia quello che fa riferimento alla grande accusatrice Ilda Boccassini e al suo "capo", Edmondo Bruti Liberati, è partito un missile diretto contro il Consiglio superiore della magistratura. L'accusa rivolta all'organo di autocontrollo delle toghe è quella di aver indebolito il pool di Milano alla vigilia della sentenza, avviando il procedimento disciplinare contro Boccassini e Bruti in seguito agli esposti presentati da Alfredo Robledo. Botta e risposta - Un'accusa che viene accolta con sdegno dal fronte opposto. Portavoce dei malumori è Armando Spataro, nuovo procuratore di Torino, da sempre in aspra antitesi con Ilda la rossa. Ad innescare la sua rabbia non solo la mailing list, ma anche un articolo comparso su Repubblica in cui, citando fonti anonime, si scriveva della tesi complottista: "Chi sta con Bruti e Boccassini - scriveva il quotidiano diretto da Ezio Mauro - è convinto che a Roma non sarebbe andata come è andata (la sanzione disciplinare, ndr) se non ci fosse stata la voglia di colpire Milano proprio alla vigilia della sentenza Ruby". Durissimo il commento di Spataro: "Penso che quell'affermazione sia semplicemente ridicola, forse più della teoria che vuole le Twin Towers abbattute dalla Cia. La mia solidarietà dunque per queste anonime offese sia a tutti i componenti del Csm sia ai componenti della Corte di Milano che hanno emesso la sentenza". Orecchie che soffiano - Una dura replica, quella di Spataro, palesemente rivolta all'entourage-Boccassini, se non a Ilda la rossa stessa. La giornalista di Repubblica - che, come detto, citava fonti anonime - chiamata in causa da Spataro non ha però voluto rivelare da chi arrivasse la soffiata complottista. Una circostanza che ha fatto ulteriormente inalberare Spataro, che ha messo nuovamente nel mirino la parte della Procura che getta fango sul Csm: "Quando certi politici parlavano di giustizia a orologeria noi potevamo denunciarne la strumentale aggressione. Ma sempre noi, diversi da loro, possiamo definire ad orologeria le decisioni del Csm. Da non crederci!", chiosa Spataro. E alla Boccassini, che vive probabilmente il momento più difficile della sua carriera, soffiano le orecchie...
Effetto Ruby: in Procura volano gli stracci tra pm. Violento scambio di mail al vetriolo, Spataro contro la Boccassini e Repubblica, scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. Inevitabilmente, la «botta» della sentenza Ruby fa sentire i suoi effetti anche all'interno della magistratura. Nessuna dichiarazione ufficiale: ma nei corridoi degli uffici giudiziari (a Milano, e non solo) le toghe non parlano che della clamorosa assoluzione in appello di Berlusconi. E se ne parla con franchezza quasi brutale anche all'interno delle mailing list interne alla categoria. Dal fronte uscito sconfitto dal processo (l'asse tra Ilda Boccassini e il capo della Procura, Edmondo Bruti Liberati) parte un siluro contro il Consiglio superiore della magistratura, che viene accusato di avere indebolito - avviando il procedimento disciplinare contro la Boccassini e Bruti poco prima della sentenza Ruby -la procura milanese, per rendere possibile l'assoluzione del Cavaliere. Accusa pesante. Dal fronte opposto si risponde con altrettanta asprezza. Insomma: volano gli stracci. A lanciare l'attacco è il nuovo procuratore di Torino, Armando Spataro, che da sempre mal sopporta la Boccassini. Il giorno dopo della sentenza, legge su Repubblica un articolo che citando fonti anonime ma immaginabili della Procura di Milano lancia la tesi del complotto: «Chi sta con Bruti e Boccassini - scrive il quotidiano - è convinto che a Roma non sarebbe andata come è andata - gli atti per entrambi ai titolari dell'azione disciplinare - se non ci fosse stata la voglia di colpire Milano proprio alla vigilia della sentenza Ruby». Spataro si infuria, scrive all'autrice che «già la tecnica dell'anonimo è fortemente criticabile specie in relazione a fatti così importanti», e poi attacca: «Autorizzo a girare questo mio commento all'anonimo o agli anonimi: penso che quell'affermazione (che tra l'altro allude alla permeabilità dei componenti il collegio che ha assolto B.) sia semplicemente ridicola, forse più della teoria che vuole le Twin Towers abbattute dalla Cia. La mia solidarietà dunque per queste anonime offese sia a tutti i componenti del Csm (comunque abbiano votato) sia ai componenti della Corte d'appello di Milano che ha emesso la sentenza».Chiamata in causa da Spataro, la giornalista di Repubblica rifiuta di indicare le sue fonti: «Rivendico il diritto, soprattutto in tempi di azioni disciplinari facili, di riprodurre un virgolettato anonimo in un articolo». Spataro si arrabbia ancora di più: ed è chiaro che nel mirino più di Repubblica sono i suoi contatti all'interno della Procura di Milano. «Quando certi politici parlavano di giustizia a orologeria noi potevamo denunciarne la strumentale aggressione. Ma sempre noi - diversi da loro - possiamo definire ad orologeria le decisioni del Csm. Da non crederci!». Accanto a Spataro scende in campo uno dei membri del Csm che ha deciso l'esito del «caso Milano», Paolo Carfì: che pure fu giudice del processo intentato dalla Boccassini a Cesare Previti, e accolse in pieno le sue tesi. Ma stavolta prende di petto la faccenda: spiega di sperare che la ricostruzione di Repubblica sia frutto di «una qualche incomprensione tra l'articolista e gli anonimi magistrati della Procura di Milano», ma poi aggiunge che in caso contrario «bisognerebbe concludere che c'è negli uffici giudiziari di Milano chi ritiene che la sentenza di assoluzione di Berlusconi non sia stata assunta in piena libertà dal collegio giudicante e che tra il Csm e la Corte d'appello di Milano sarebbe intercorso un filo rosso avente per fine ultimo la normalizzazione degli uffici giudiziari milanesi, in primis la Procura della Repubblica. Il che prima che offensivo è incredibilmente ridicolo». Dopodiché Carfì si spinge ancora più in là, e se la prende anche con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che nel pieno della discussione al Csm del «caso Milano» era intervenuto con una lettera in aperta difesa di Bruti Liberati: «Certo non ha aiutato il tutto sommato inutile (rispetto alla materia del contendere) messaggio del presidente della Repubblica e la gestione che del medesimo se n'è fatta». A togliersi un sassolino contro la Boccassini è anche Ferdinando Pomarici, grande vecchio della procura milanese: che affronta direttamente il tema per cui la Boccassini è finita sotto procedimento disciplinare, ovvero il pervicace rifiuto di fare circolare le notizie all'interno del pool antimafia e di comunicare le indagini alla Dna, la Procura nazionale antimafia. Il magistrato della Dna che aveva accusato la Boccassini, Filippo Spiezia, ha dovuto lasciare il posto dopo la furibonda reazione della dottoressa. E al suo posto a tenere i rapporti con Milano è arrivata Anna Canepa, leader di Magistratura Democratica e buona amica di Ilda. Al Csm, la Canepa, la Boccassini e Bruti Liberati hanno cercato di spiegare che a Milano va tutto bene, e che comunque una certa riservatezza fa parte delle tradizioni del pool antimafia meneghino. Ma Pomarici, che era capo dell'antimafia appena prima della Boccassini, insorge con una mail: «Per debito di verità, essendomi già doluto con Anna Canepa della rappresentazione non corretta della situazione, contesto assolutamente che sotto la mia gestione ci fossero delle criticità nell'inserimento dei dati per quanto concerne la Dda di Milano. Ignoro, e non mi interessa sapere, quale sia la situazione attuale, ma le mie disposizioni puntualmente attuate erano univoche: tutte le informative della polizia giudiziaria con i relativi seguiti, tutte le richieste di misure cautelari, tutte le relative ordinanze, tutte le sentenze di primo grado sono state inserite in banca dati e in tempo reale e trasmesse alla Dna. Chi riferisce di cose diverse afferma il falso, e viene da chiedersi il motivo. Ed eguale circolazione di informazioni è stata ovviamente assicurata all'interno della dea i cui magistrati ricevevano semestralmente relazione completa su tutte le indagini assegnate agli altri colleghi sul loro sviluppo e su tutti i nomi delle persone sottoposte a indagini». Esattamente ciò che la Boccassini è accusata ora di non avere fatto, e perciò rischia il procedimento disciplinare.
Il Cav? Critico condanna e assoluzione”, scrive Antonio Di Pietro (Già magistrato ed ora contadino) su “Il Garantista”. Le sentenze si rispettano sempre, sia quando piacciono che quando non piacciono, e a me francamente non piace né la sentenza di Appello che ha assolto Berlusconi per la vicenda Ruby, né la sentenza di primo grado che invece per gli stessi fatti lo aveva condannato a 7 anni di carcere. Ripeto, le sentenze vanno sempre rispettate e anche io stavolta mi atterrò a questo sacro principio. Le sentenze però possono essere serenamente commentate (pur rispettando i giudici, gli accusati e gli accusatori). Ciò premesso, a me pare che ci siano state due forzature di troppo: in primo grado aver condannato Berlusconi anche per “concussione per costrizione” ed in Appello averlo assolto anche per il reato di “prostituzione minorile”. Ma andiamo con ordine ed innanzitutto riassumiamo la vicenda. La procura della Repubblica di Milano, in relazione alla vicenda Ruby, aveva accusato Berlusconi di due specifici reati: quello di aver avuto rapporti sessuali con la minorenne Karima-Ruby El Marhouh (Ruby Rubacuori, appunto) punito dall’art. 600 bis del codice penale con la pena da uno a sei anni di reclusione e quello di concussione per costrizione punito dall’art. 317 del codice penale con la pena da sei a dodici anni di reclusione, per avere egli – nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di presidente del Consiglio in carica – abusato di tale sua qualità per “costringere” il capo di Gabinetto della Questura di Milano, Pietro Ostuni, a far rilasciare la predetta Ruby (che, nel frattempo, era stata portata in questura dagli agenti di polizia ed ivi trattenuta per accertamenti) sostenendo che, altrimenti, sarebbe successa una diatriba internazionale in quanto la predetta era imparentata con l’allora presidente egiziano Hosni Mubarak (mentre invece, nella realtà era ed è una cittadina marocchina che nulla aveva a che vedere con l’Egitto). Ebbene, i giudici di primo grado hanno riconosciuto Berlusconi colpevole di entrambi i reati, ritenendo provato sia che Berlusconi fosse perfettamente al corrente che la signorina Ruby fosse minorenne (e quindi aveva il dovere di non avere rapporti sessuali con lei perché appunto la legge vieta ai maggiorenni di avere rapporti sessuali con minorenni) sia che il funzionario della questura, Ostuni, fosse stato costretto ad assecondare le richieste del presidente del Consiglio di far uscire dalla questura la signorina Ruby. I giudici di Appello, invece, hanno assolto Berlusconi da entrambi i reati, sebbene con motivazioni diverse. Egli infatti è stato assolto dall’accusa di concussione “perché il fatto non sussiste” e dall’accusa di prostituzione minorile “perché il fatto non costituisce reato”. Assoluzione che ho così tradotto “in dipietrese” a mia sorella Concetta che – qui a Montenero dove mi trovo – me ne ha appena chiesto spiegazione: i giudici di Appello hanno assolto Berlusconi dall’accusa di concussione perché Ostuni non era e non può essere considerato alla stregua di un “povero Cristo” che – siccome gli telefona il presidente del Consiglio – si impaurisce a tal punto da non potergli “resistere” e quindi da non potergli dire che Ruby non era e non poteva essere affatto parente di Mubarak e soprattutto che non poteva essere rilasciata nell’immediatezza in quanto anche nei suoi confronti dovevano essere effettuati gli accertamenti di rito che ogni ufficio stranieri di ogni questura d’Italia ha l’obbligo di svolgere in casi del genere. Insomma, ai giudici di Appello potrebbe essere sembrato più plausibile che il dottor Ostuni si sia volontariamente adeguato alle richieste di Berlusconi, pur essendo le stesse improprie e fuori luogo. Attenzione però: per capire meglio le ragioni per cui i giudici di Appello si sono determinati ad assolvere Berlusconi dobbiamo attendere la pubblicazione delle motivazioni perché non dobbiamo dimenticarci che nel frattempo è intervenuta le legge n. 190 del 6 novembre 2012 con cui è stato di fatto abolito il reato di “concussione per induzione”, reato tipico di chi vuole convincere spintaneamente – si ho scritto “spintaneamente” e non spontaneamente – un pubblico ufficiale a favorirlo, abolizione che è comunque intervenuta a fagiolo per risolvere anche questo caso (come anche il “caso Penati”, in verità). Quindi, e in conclusione, per la Corte di Appello di Milano – mancando un elemento essenziale per la commissione del reato (ovvero la “costrizione”) – il fatto-reato “non sussiste”, vale a dire che è come se non si fosse mai verificato. Berlusconi, però, è stato assolto dall’accusa di prostituzione minorile ma in questo caso non perché “il fatto non sussiste” bensì perché “il fatto non costituisce reato”, vale a dire che – sempre secondo i giudici di Appello – il “fatto” c’è o ci potrebbe essere stato ma non è reato in quanto Berlusconi non aveva avuto la percezione di avere a che fare con una minorenne (anche in questo caso, comunque è bene attendere la pubblicazione della sentenza per capire meglio su quali elementi di fatto i giudici sono arrivati a tale conclusione). Così stando le cose, e tornando all’inizio del mio discorso, ribadisco che a me – pur dovendo rispettare, come rispetto, entrambe le sentenze – nessuna delle due mi convince. Già non mi aveva convinto la sentenza di primo grado e cioè quella che aveva condannato Berlusconi per “concussione per costrizione” ai danni di Ostuni e ciò in quanto a me è sembrato sin dal primo momento più plausibile che tale funzionario della questura di Milano possa aver deciso di sua sponte di assecondare Berlusconi o quanto meno possa esservi stato “indotto” dal fatto che stava parlando con il presidente del Consiglio in persona ma in tal caso – come abbiamo sopra precisato – tale tipo di reato era stato nel frattempo abolito dalle legge n. 190 del 2012 (che fortunata coincidenza, eh!!!). Comunque per me – per come sono fatto io e per come mi sono sempre comportato – avrei preferito che il funzionario della questura avesse reagito come dovrebbe reagire sempre un pubblico ufficiale “con le palle” (scusate il termine), resistendo a qualsiasi pressione esterna, fosse pure del presidente del Consiglio!!! Bene quindi hanno fatto i giudici di Appello a rivedere questo passaggio della sentenza di primo grado, anche se, forse poteva essere meglio esplorata la figura processuale del nuovo reato pure introdotto dalla legge n. 190/12 (istigazione alla corruzione) e comunque attendiamo di leggere come si esprimeranno in relazione all’abolito reato di “concussione per induzione”. Parimenti non mi convince neanche l’assoluzione che in Appello i giudici hanno riconosciuto a Berlusconi per il reato di prostituzione minorile e ciò perché non vedo la ragione per cui costui si sia dato tanto da fare quella notte per far uscire dalla Questura la ragazzina Ruby Rubacuori e farla affidare addirittura alle cure della nota Nicole Minetti se non perché poteva sapere che la ragazza era minorenne e quindi poteva metterlo nei guai. Ma comunque, ripeto, le sentenze si rispettano ed io ho voluto esprimere le mie riserve, solo per far sapere come la penso e non già per pretendere di giudicare gli altri. Per il resto chi vivrà vedrà!!!
L’arresto di Galan è la fulminea rivincita del partito dei magistrati, scrive Piero Sansonetti su “Il Garantista” E così ne hanno spedito in prigione un altro. Bravi. Violando la legge, lo spirito della Costituzione, il codice di procedura penale. Prima i magistrati e poi la Camera dei deputati hanno commesso un atto illegale violando i principi della democrazia politica, le leggi della Repubblica e lo Stato di diritto. Non esiste nessuna autorità democratica in grado di mettere un argine a questo sopruso. Ed è esattamente questo che fa impazzire di rabbia. Anche un po’ di paura. La consapevolezza che le istituzioni non si possono opporre a una violenza illegale, perché le istituzione, tutte o in parte, sono le autrici di questa violenza. La magistratura ha deciso consapevolmente di chiedere l’arresto di una persona, in spregio dell’articolo 275 del codice di procedura. I magistrati sono pienamente consci dell’illegalità che compiono, ma sanno che nessuna autorità potrà contestargliela, o perché non ha le competenze o semplicemente per viltà. La Camera dei deputati ha mostrato senza neppure cercare di mascherarsi la sua viltà. Il Csm non interverrà. Né interverrà il ministro della Giustizia, che anzi ha votato a favore del sopruso. Diceva Manzoni che se uno il coraggio non ce l’ha non può darselo. Galan, seppure in gravi condizioni di salute, andrà in carcere, in barella, e questo atto sarà simbolicamente il grido d’accusa contro la vigliaccheria e l’ignoranza del nostro sistema politico. E il nostro sistema politico resterà schiacciato dall’atto di sottomissione, dall’umiliazione accettata con spirito lieve, ieri, nei confronti e da parte della magistratura, anzi – per essere più precisi – della corporazione dei Pm. E adesso? Ricomincia la partita che ha per posta la riforma della giustizia. Ma ricomincia in condizioni del tutto rovesciate rispetto a due giorni fa. L’assoluzione piena di Silvio Berlusconi, nel processo Ruby, e la conseguente delegittimazione del partito dei Pm appoggiato dalla grande stampa legalitaria (Repubblica, Il Fatto e tanti altri) poteva aprire uno spiraglio e rendere più sereno il clima nel quale ci si apprestava ad affrontare lo scoglio della riforma della giustizia. Ma il partito dei Pm, bisogna riconoscerlo, ha dimostrato di avere forza morale, coraggio e intelligenza infinitamente superiori rispetto al mondo politico. In due giorni è riuscito ad annullare gli effetti politici della sentenza Ruby e a ristabilire una posizione nettissimamente di forza. Prima con l’attacco feroce alla politica e alla democrazia del Pm di Palermo Di Matteo, che ha chiamato i giudici ad una azione compatta e sovversiva – la famosa sovversione delle classi dirigenti: vi ricordate Gramsci? Però ora non sono più classi, come immaginava lui, sono corporazioni, o caste, o gruppi di potere – una azione di sbarramento che impedisca la riforma e che avvii anzi una controriforma, per permettere una ulteriore riduzione dello Stato di diritto. Il partito dei Pm questo vuole, e lo dichiara: niente separazione delle carriere, niente responsabilità e punibilità dei giudici, niente revisione dell’obbligatorietà dell’azione penale, niente riduzione del carcere preventivo e delle intercettazioni, ma invece due drastiche misure: abolizione dell’appello e allungamento sine die della prescrizione. Di conseguenza aumento smisurato del potere dei magistrati, e soprattutto dell’accusa, riduzione degli spazi della difesa e quasi annullamento dei diritti del sospettato e poi dell’imputato. Ci spiace dirlo, senza lasciare neppure una lucetta accesa: i giudici ieri hanno vinto la partita.
Divisioni e sconfitte. L'anno terribile della Procura di Milano. La guerra intestina tra Robledo e Bruti, i difficili rapporti tra Ilda Boccassini e la Dna. Così si è rotto un equilibrio che sembrava perfetto, scrive Giuseppe Vespo su “L’Unità”. Un anno fa oggi la procura di Milano incassava la seconda sentenza di condanna sul caso Ruby, quella a carico del trio Fede, Mora, Minetti. Un anno fa oggi nessuno avrebbe immaginato che il 2014 sarebbe stato così travagliato per i pm guidati da Edmondo Bruti Liberati. Invece l’equilibrio si è rotto, e alcuni dei commenti all’assoluzione Berlusconi lo ricordano senza appello. «La disfatta della procura», come si è affrettato a titolare l’ex fedelissimo Fabrizio Cicchitto, è solo l’ultimo di una serie di risultati negativi per i pm milanesi. Non certo dal punto di vista della produttività investigativa - basti ricordare i colpi inflitti alla corruzione, alla criminalità organizzata e le inchieste su Expo - quanto da quello dell’immagine. E non è poco in un Paese che da oltre venti anni si trova spesso diviso in due fazioni, pro e contro i magistrati. In questi mesi agli attacchi esterni si sono aggiunti i veleni interni all’ufficio. Alle notizie sulle indagini si sono affiancate quelle su chi le indagini le conduceva: esposti, lettere, audizioni al Csm e comportamenti affidati al vaglio dei cosiddetti titolari delle azioni disciplinari nei confronti dei togati. La «guerra» intestina è scoppiata a marzo con il primo esposto del procuratore aggiunto Alfredo Robledo nei confronti del procuratore Capo Bruti Liberati. Il titolare del pool che indaga sui reati contro la pubblica amministrazione attacca il suo capo per i metodi usati nell’assegnazione dei fascicoli d’indagine. Bruti Liberati, in sostanza, avrebbe preferito affidare ad altri pm inchieste che per competenza spetterebbero a Robledo. La notizia svela le frizioni interne all’ufficio e scatena una serie di reazioni a catena che hanno quasi messo a rischio alcune inchieste. L’ultima è arrivata con la bocciatura da parte del Consiglio Giudiziario milanese della «area omogenea Expo», l’unità organizzativa con la quale il procuratore capo si assegna l’esclusivo e diretto coordinamento di tutte le indagini che riguardano l’evento. Mentre gli atti sulla «scarsa collaborazione» tra Ilda Boccasini, capo della Dda, e la Direzione nazionale antimafia, finiscono al pg di Cassazione e al ministro della Giustizia, titolari dell’azione disciplinare. La sentenza di assoluzione di Berlusconi dal caso Ruby arriva dunque in un momento poco felice per la procura, che aspetta di sapere se sarà ancora guidata dallo stesso capo o se ne arriverà uno nuovo. Il procuratore è in scadenza e si è candidato per un nuovo mandato. A questo proposito, dieci giorni fa Bruti Liberati ha scritto una lettera ai suoi pm: «A dispetto di qualche piccola, circoscritta polemica degli ultimissimi mesi - si legge - l’apprezzamento per l’opera della procura di Milano nel quadriennio corso è stato ampio e condiviso e il prestigio indiscusso». «Ma ciò che rileva - continua - sono i riscontri ottenuti a livello di giudizio, in termini di accoglimento delle richieste e dei tempi di definizione». Spetterà al Csm decidere sulla riconferma. una vittoria ai mondiali Ma intanto chi paga i danni subiti da Berlusconi per quella che adesso viene definita «un’autentica operazione non solo giudiziaria ma anche politica e mediatica»? Dietro questa domanda si ricompatta non solo Forza Italia, ma tutto il centro destra. L’attacco ai magistrati ritorna con «la disfatta della Procura di Milano e in primo luogo - aggiunge Cicchitto - sia di Bruti Liberati che della Boccassini, che hanno gestito questo processo in una chiave addirittura unilaterale ed esclusiva». Brunetta, capo gruppo di Fi alla Camera, vuole una commissione parlamentare d’inchiesta sulla caduta dell’ultimo governo Berlusconi, causata «anche grazie a questo fango». Mentre Micaela Biancofiore chiede che «i pm e i giudici di primo grado che hanno diffamato Berlusconi, a quel tempo presidente del Consiglio e dunque gettato fango internazionalmente sull’Italia intera, dovrebbero dimettersi spontaneamente lasciando spazio alla maggioranza della magistratura italiana, quella maggioritaria, indipendente, autonoma e terza». E così via, nelle parole degli altri parlamentari di centro destra è tutto un susseguirsi di bordate contro il quarto piano del palazzo di Giustizia di Milano: «Verità e giustizia», fine di «un accanimento senza precedenti», «milioni di euro spesi per il processo». Sollecitato sulla «sconfitta della procura di Milano», uno dei legali di Silvio Berlusconi, il professor Franco Coppi - che insieme all’avvocato Filippo Dinacci ha difeso l’ex premier nel processo d’Appello - dice: «Non ho mai considerato il processo penale come una specie di gara sportiva tra chi vince e chi perde». In molti invece lo considerano proprio così. C’è addirittura chi esulta, come il senatore siciliano e forzista Vincenzo Gibiino, «come se l’Italia avesse vinto i mondiali».
La toga rossa ammette: i giudici fanno quello che vogliono, scrive di Cristiana Lodi su “Libero Quotidiano”. La sintesi è che i giudici fanno quello che vogliono. Perché hanno margini di discrezionalità sconfinati nella ricostruzione e nella valutazione dei fatti. Perché anche le possibilità d’interpretazione delle norme non conoscono limiti. Perché in Tribunale il clima è cambiato (o forse è tornato ancora più uguale a quello di un tempo), nel senso che il principio dell’uguaglianza di tutti (deboli e forti) davanti alla legge, di fatto, non esiste. O, di fatto, non è proprio mai esistito. La sintesi che noi riportiamo, non l’ha esposta un individuo qualunque, ma una toga. Un magistrato che di nome fa Livio Pepino, membro del Consiglio superiore della magistratura (l’organo di autogoverno dei giudici) dal 2006 al 2010, ex sostituto procuratore generale a Torino. E presidente di Magistratura democratica. Dunque una toga rossa, anche. In un articolo pubblicato ieri sul giornale comunista il Manifesto, Livio Pepino spiega come la sentenza Ruby che assolve Silvio Berlusconi dai reati di concussione per costrizione e prostituzione minorile, sia la prova provata che i giudici - anche i più irreprensibili e convinti di agire in piena indipendenza - alla fine fanno quello che vogliono. Questo con buona pace dei giornalisti vari o dei sostenitori della giurisdizione, i quali si sono sprecati nel giudicare, considerare e spiegare l’assoluzione dell’ex capo del governo come «una conseguenza (quasi) obbligata della modifica del delitto di concussione operata con la cosiddetta legge Severino (in realtà, precedente alla sentenza di primo grado)». Ma vi pare? Tempo buttato cimentarsi in simili esercizi interpretativi. Perché, scrive il magistrato, «come sempre le ragioni di una decisione sono molte, ma certo le principali stanno non nelle modifiche legislative bensì nelle scelte dei giudici». Che fanno quel che gli gira in quel momento. «E l’esercizio di tale discrezionalità risente del clima in cui essi stessi operano». Con una disinvoltura che ricorda, dice ancora il giudice Pepino, il caso dell’ex ministro Scajola: «Accusato di avere ottenuto un illecito finanziamento mediante il pagamento di parte cospicua del prezzo di acquisto di un prestigioso alloggio romano e assolto in primo grado per essere tale pagamento avvenuto “a sua insaputa”». Come contraddirlo? Difficile. Così com’è complicato sostenere che il magistrato ha torto quando afferma che «mai» si è visto un pubblico ufficiale macchiarsi del reato di concussione per costrizione perché ha usato la minaccia di una pistola puntata alla tempia del concusso. Anche se, aggiungiamo noi, non lo ha certo inventato il prete che l’elemento costitutivo del delitto di concussione, dal quale Berlusconi viene assolto dalla Corte d’Appello, è proprio la minaccia grave ed esplicita (come ad esempio quella con armi). Le interpretazioni giuridiche, in tal caso possono sì essere infinite e lasciare gran margine di decisione ai giudici, ma se la minaccia grave non esiste, diventa improbabile inventarla. Perfino quando l’imputato si chiama Berlusconi Silvio, giudicato a Milano. Il quadro nei tribunali «è mutato», insiste Livio Pepino, «una fase si sta chiudendo. Accade quotidianamente. In forza del nuovo/antico ruolo attribuito alla giurisdizione si divaricano le regole di giudizio adottate nei processi contro i “briganti” (poveri o ribelli che siano) e in quelli contro i “galantuomini”: qui il canone probatorio del “non poteva non sapere” di Scajola è sacrilegio; là è regola». Dunque nessuno è uguale davanti alla legge. E i giudici decidono quel che loro garba. Ergo: fanno quello che vogliono. E se a dirlo è una toga. Per di più rossa...
GUERRA DI TOGHE. ANCHE I MAGISTRATI PIANGONO.
Non solo Milano. Tribunale di Taranto. Guerra di toghe.
Cosa è che l’Italia dovrebbe sapere e che la stampa tarantina tace?
«Se corrispondesse al vero la metà di quanto si dice, qui parliamo di fatti gravissimi impunemente taciuti», commenta Antonio Giangrande, autore del libro “Tutto su Taranto, quello che non si osa dire”, pubblicato su Amazon.
Mio malgrado ho trattato il caso dell’ex Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Matteo Di Giorgio, così come altri casi della città di Taranto. Questioni che la stampa locale ha badato bene di non affrontare. Prima che iniziassero le sue traversie giudiziarie consideravo il dr. Matteo Di Giorgio uno dei tanti magistrati a me ostile. Ne è prova alcune richieste di archiviazione su mie denunce penali. Dopo il suo arresto ho voluto approfondire la questione ed ho seguito in video la sua conferenza stampa, in cui esplicava la sua posizione nella vicenda giudiziaria, che fino a quel momento non aveva avuto considerazione sui media. Il contenuto del video è stato da me tradotto fedelmente in testo. Sia il video, sia il testo, sono stati pubblicati sui miei canali informativi. Il seguito è fatto noto: per Matteo Di Giorgio quindici anni di reclusione per concussione e corruzione semplice. Tre in più rispetto ai dodici chiesti dal pubblico ministero. Il Tribunale di Potenza (presidente Gubitosi), competente a trattare procedimenti in cui sono coinvolti magistrati in servizio presso la Corte d’appello di Lecce, ha inoltre inflitto la pena di tre anni di reclusione all’ex sindaco di Castellaneta (Taranto) Italo D’Alessandro e all’ex collaboratore di quest’ultimo, Agostino Pepe; 3 anni e 6 mesi a Giovanni Coccioli, 2 anni a Francesco Perrone, comandante dei vigili urbani a Castellaneta, 2 anni ad Antonio Vitale e 8 mesi ad un imputato accusato di diffamazione.
L'ex pm Di Giorgio, sospeso cautelativamente dal Csm, fu arrestato e posto ai domiciliari nel novembre del 2010. Le contestazioni riguardano presunte minacce in ambito politico e ai danni di un imprenditore, altre per proteggere un parente, e azioni dirette a garantire l’attività di un bar ritenuto dall’accusa completamente abusivo. Il Tribunale di Potenza ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla procura per valutare la posizione di diversi testimoni in ordine al reato di falsa testimonianza. Tra questi vi sono l’ex procuratore di Taranto Aldo Petrucci e l’attuale procuratore aggiunto di Taranto Pietro Argentino. Complessivamente il Tribunale di Potenza ha trasmesso alla procura gli atti relativi alle testimonianze di 21 persone, quasi tutti carabinieri e poliziotti. Tra questi l’ex vicequestore della polizia di Stato Michelangelo Giusti.
Eppure Pietro Argentino è il numero due della procura di Taranto. È il procuratore aggiunto che ha firmato, insieme ad altri colleghi, la richiesta di rinvio a giudizio per i vertici dell’Ilva ed altri 50 imputati.
Pietro Argentino è il pubblico Ministero che con Mariano Buccoliero ha tenuto il collegio accusatorio nei confronti degli imputati del delitto di Sarah Scazzi ad Avetrana.
Possibile che sia un bugiardo? I dubbi mi han portato a fare delle ricerche e scoprire cosa ci fosse sotto. Ed è sconcertante quello che ho trovato. La questione è delicata. Per dovere-diritto di cronaca, però, non posso esimermi dal riportare un fatto pubblico, di interesse pubblico, vero (salvo smentite) e continente. Un fatto pubblicato da altre fonti e non posto sotto sequestro giudiziario preventivo, in seguito a querela. Un fatto a cui è doveroso, contro censura ed omertà, dare rilevanza nazionale, tramite i miei 1500 contati redazionali.
«Come volevasi dimostrare nessuno dei giornali italiani nazionali o locali ha più parlato dopo il primo maggio 2014 dei quindici anni di galera inflitti al Magistrato di Taranto Matteo Di Giorgio e dell’incriminazione per falsa testimonianza inflitta al Procuratore Aggiunto di Taranto Pietro Argentino - scrive Michele Imperio -. Ma “La Notte” no. “La Notte” non ci sta a questa non informazione o a questa disinformazione. Quando assunsi la direzione di questo glorioso giornale, che ora sta per riuscire nella sua versione cartacea, dissi che avremmo sempre raccontato ai nostri lettori tutta la verità, solo la verità, null’altro che la verità e avremmo quindi sfidato tutte le distorsioni giornalistiche altrui, tutti i silenzi stampa, tutti i veti incrociati dei segmenti peggiori del potere politico. Strano cambiamento. Sarà stata l’aspirazione di candidarsi Presidente della Provincia di Taranto per il centro-destra, maturata nel 2008. Ancora alcuni anni fa infatti il giudice Matteo Di Giorgio era ritenuto il più affidabile sostituto procuratore della Repubblica della Procura della Repubblica di Taranto, tanto da essere insignito della prestigiosa carica di delegato su Taranto della Procura Distrettuale Antimafia di Lecce. Subì perfino un attentato alla persona per il suo alacre impegno contro il crimine organizzato. Sette capi di imputazione! Però sin poco dopo il mandato di cattura tutti hanno capito subito che qualcosa non andava in quel processo, perché in sede di giudizio sul riesame di quei capi di imputazione la Corte di Cassazione ne aveva annullati ben tre (censure che la Cassazione, in sede di riesame, non muove praticamente mai!) e il resto della motivazione della Cassazione sembrava un’invocazione rivolta ai giudici di marito: Non posso entrare nel merito – diceva la Cassazione – ma siete sicuri che state facendo bene? Tutti i commenti della Rete su questo caso sono stati estremamente critici, quanto meno allarmati. Invece i vari giornali locali, dopo aver dato la notizia il giorno dopo, non ne hanno parlato più. Scrive invece sulla Rete – per esempio – il prof. Mario Guadagnolo, già sindaco di Taranto dal 1985 al 1990: “Premetto che io – scrive (Guadagnolo) – non conosco il dott. Di Giorgio nè ho alcuna simpatia per certi magistrati che anzichè amministrare la giustizia la usano per obbiettivi politici. Ma 15 anni sono troppi se paragonati ai 15 anni di Erika e Omar che hanno massacrato con sessanta pugnalate la madre e il fratellino di sette anni o con i 15 anni comminati alla Franzoni che ha massacrato il figlioletto Samuele. Qui c’è qualcosa che non funziona. Non so cosa ma è certo che c’è qualcosa che non funziona”. Trovo molto singolare che il Procuratore Aggiunto di Taranto Pietro Argentino sarà incriminato di falsa testimonianza a seguito del processo intentato contro il dott. Matteo Di Giorgio - scrive ancora l’avv. Michele Imperio su “Tarastv” e su “La Notte on line” - A parte la stima che tutti riservano per la persona, il dott. Pietro Argentino aveva presentato al CSM domanda per essere nominato Procuratore Capo proprio della Procura di Potenza e il CSM tiene congelata questa delicata nomina da diversi anni. L'attuale Procuratore Capo di Potenza Laura Triassi è solo un facente funzioni e sicuramente anche lei aspirerà alla carica. Certamente questa denuncia terrà bloccata per molti anni una eventuale nomina del dott. Pietro Argentino a Procuratore Capo di una qualsiasi Procura. La sua carriera è stata quindi stroncata. Laura Triassi è inoltre sorella di Maria Triassi, professoressa dell'università di Napoli la quale fu incaricata della perizia epidemiologica nel processo Ilva dal noto Magistrato Patrizia Todisco, la quale è lo stesso Magistrato che già aveva denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza il collega Giuseppe Tommasino, poi assolto e che aveva invece lei stessa assolto dal reato di concorso esterno in associazione a delinquere il noto pregiudicato A. F., mandante - fra l'altro - di un grave attentato dinamitardo a sfondo politico, che poteva provocare una strage. Il conflitto Di Giorgio-Loreto lo conosciamo già. Ma di un altro conflitto che sta dietro questo processo non ha parlato mai nessuno. Alludiamo al conflitto Di Giorgio-Fitto. Se infatti il dott. Matteo Di Giorgio fosse stato nominato presidente della provincia di Taranto sarebbero saltati per aria tanti strani equilibri che stanno molto cari all'on.le Fitto e non solo a lui. Inoltre trovo molto strano che l'on.le Raffaele Fitto, il quale fa parte di un partito molto critico nei confronti di certe iniziative giudiziarie, quanto meno esagerate, non abbia mai detto una sola parola su questa vicenda, che vedeva peraltro coinvolto un Magistrato dell'area di centro-destra. Come pure non una sola parola, a parte quelle dopo l'arresto, è stata mai detta sulla vicenda dall'attuale Procuratore Capo della Repubblica di Taranto dott. Franco Sebastio. E nel processo sulla malasanità di Bari compaiono intercettazioni telefoniche fra il dott. Sebastio e il consigliere regionale dell'area del P.D. ostile al sindaco di Bari Michele Emiliano, Michele Mazzarano, nel corso delle quali il dott. Sebastio esprimeva sfavore per la nomina a Procuratore Aggiunto del dott. Pietro Argentino. Nel corso di una dichiarazione pubblica il dott. Sebastio espresse invece, in modo del tutto sorprendente, soddisfazione per l'arresto del dott. Matteo Di Giorgio e disse che auspicava che anche un secondo Magistrato fosse stato allontanato dalla Procura della Repubblica di Taranto (Argentino?). Ora, guarda un pò, anche il dott. Argentino potrebbe essere sospeso dalle funzioni o trasferito di sede....Ciò che è accaduto al Tribunale di Potenza è, quindi, come ben comprenderete, un fatto di una gravità inaudita e sottintende un conflitto fra Magistrati per gestioni politiche di casi giudiziari, promozioni e incarichi apicali, mai arrivato a questi livelli. Voglio fare alcune premesse utili perchè il lettore capisca che cosa c’è sotto. Sia a Taranto che a Potenza, patria di Angelo Sanza, sottosegretario ai servizi segreti quando un parte del Sisde voleva assassinare Giovanni Falcone e un’altra parte del Sisde non era d’accordo (e lui da che parte stava?), come forse anche in altre città d’Italia, opera da decenni una centrale dei servizi segreti cosiddetti deviati in realtà atlantisti, che condiziona anche gli apparati giudiziari e finanche quelli politici della città. Di sinistra. Così pure altra sede dei servizi segreti atlantisti questa volta di destra, opera a Brindisi. La sezione di Taranto in particolare appartiene sicuramente a quell’area politica che Nino Galloni avrebbe chiamato della Sinistra politica democristiana cioè una delle tre correnti democristiane, in cui si ripartiva la vecchia Sinistra Democristiana che erano – lo ricordo a me stesso – la Sinistra sociale capeggiata dall’on.le Carlo Donat Cattin, il cui figlio è stato suicidato-assassinato; la Sinistra morotea capeggiata dall’on.le Aldo Moro, assassinato, e poi inutilmente e per brevissimo tempo riesumata dal Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, anche lui assassinato; la Sinistra politica capeggiata dai vari De Mita, Mancino, Rognoni, Scalfaro e Prodi, i quali non sono stati mai nemmeno scalfiti da un petardo. Ma torniamo a noi e ai giudici tarantini Pietro Argentino e Matteo Di Giorgio. La cui delegittimazione – per completezza di informazione – è stata preceduta da un’altra clamorosa delegittimazione di un altro Giudice dell’area di centro destra, il capo dei g.i.p. del Tribunale di Taranto Giuseppe Tommasino, fortunatamente conclusasi con un’assoluzione e quindi con un nulla di fatto. Quindi Tommasino, Di Giorgio, Argentino, a Taranto dovremmo cominciare a parlare di un vero e proprio stillicidio di incriminazioni e di delegittimazioni a carico di Magistrati della Procura o del Tribunale non appartenenti all’area della Sinistra Politica Democristiana o altra area alleata, ovvero all’area della Destra neofascista finiana. L’indagine a carico del Dott. Matteo Di Giorgio è durata circa due anni ed è stata condotta da un Maresciallo dei Carabinieri espulso dall’arma e caratterizzata dall’uso di cimici disseminate in tutti gli uffici del Tribunale di Taranto e della Procura. E’ capitato personalmente a me di essere invitato dal giudice Giuseppe Di Sabato, (g.i.p.), un Magistrato che non c’entrava niente con l’inchiesta, di essere invitato a interloquire con lui al bar del Tribunale anziché nel suo ufficio, perchè anche nel suo ufficio c’erano le cimici di Potenza. Ma c’è di più! La Sinistra Politica democristiana vuole diventare a Taranto assolutamente dominante sia in Tribunale che in tutta la città, perché corre voce che due Magistrati, uno della Procura l’altro del G.I.P., resi politicamente forti dalla grande pubblicità e visibilità del processo Ilva, starebbero per passare alla politica, uno come candidato sindaco l’altro come parlamentare, quando sarà.»
Sembra che il cerchio si chiuda con la scelta del Partito democratico caduta su Franco Sebastio, procuratore capo al centro dell’attenzione politica e mediatica per la vicenda Ilva, intervistato da Francesco Casula su “La Gazzetta del Mezzogiorno”.
Procuratore Sebastio, si può giocare a carte scoperte: il senatore Alberto Maritati alla Gazzetta ha ammesso di averle manifestato l’idea del Partito democratico di averla in lista per il Senato...
«Io conosco il senatore Maritati da tempo, da quando era pretore a Otranto. Siamo amici e c’è un rapporto di affettuosa stima reciproca. Ci siamo trovati a parlare del più e del meno... É stato un discorso scherzoso, non ricordo nemmeno bene i termini della questione».
Quello che può ricordare, però, è che lei ha detto no perché aveva altro da fare...
«Mi sarà capitato di dire, sempre scherzosamente, all’amico e all’ ex collega che forse ora, dopo tanti anni, sto cominciando a fare decentemente il mio lavoro. Come faccio a mettermi a fare un’attività le cui caratteristiche non conosco e che per essere svolta richiede qualità elevate ed altrettanto elevate capacità? É stato solo un discorso molto cordiale, erano quasi battute. Sa una cosa? La vita è così triste che se non cerchiamo, per quanto possibile, di sdrammatizzare un poco le questioni, diventa davvero difficile».
«Candidare il procuratore Franco Sebastio? Sì, è stata un'idea del Partito democratico. Ne ho parlato con lui, ma ha detto che non è il tempo della politica». Il senatore leccese Alberto Maritati, intervistato da Francesco Casula su “La Gazzetta del Mezzogiorno”, conferma così la notizia anticipata dalla Gazzetta qualche settimana fa sull’offerta al magistrato tarantino di un posto in lista per il Senato.
Senatore Maritati, perchè il Pd avrebbe dovuto puntare su Sebastio?
«Beh, guardi, il procuratore è un uomo dello Stato che ha dimostrato sul campo la fedeltà alle istituzioni e non solo ora con l'Ilva. Possiede quei valori che il Pd vuole portare alla massima istituzione che è il Parlamento. Anche il suo no alla nostra idea è un esempio di professionalità e attaccamento al lavoro che non sfocia mai in esibizionismo».
ANCHE BORSELLINO ERA INTERCETTATO.
Riina: "Borsellino era intercettato". Il Capo dei capi parla in carcere: "Sapevamo doveva andare perché le ha detto 'domani mamma vengo'", scrive “La Repubblica”. Riina e il boss Lorusso ripresi in carcere Cosa nostra teneva sotto controllo il telefono del giudice Paolo Borsellino o dei suoi familiari. E' lo stesso Totò Riina, in una conversazione intercettata, a rivelarlo a un compagno di carcere. "Sapevamo che doveva andare là perché lui gli ha detto: 'domani mamma vengo'", racconta il boss, riferendo le parole dette dal magistrato alla madre. "Questa del campanello però è un fenomeno...Questa una volta il Signore l'ha fatta e poi basta. Arriva, suona e scoppia tutto". E' un pezzo della conversazione intercettata in cui il boss Totò Riina, racconta all'uomo con cui trascorre l'ora d'aria in carcere, Alberto Lorusso, che a innescare l'esplosione che uccise Paolo Borsellino fu lo stesso magistrato, suonando al citofono in cui era stato piazzato un telecomando. La conversazione - il cui contenuto era noto, ma non il testo - è stata depositata al processo sulla "trattativa". "Il fatto che è collegato là è un colpo geniale proprio. Perché siccome là era difficile stare sul posto per attivarla... Ma lui l'attiva lo stesso", commenta Lorusso il 29 agosto del 2013. Il boss detenuto racconta di avere cercato di uccidere Borsellino per anni. "Una vita ci ho combattuto - dice - una vita... Là a Marsala (il magistrato lavorava a Marsala ndr)". "Ma chi glielo dice a lui di andare a suonare?" si chiede Riina. "Ma lui perché non si fa dare le chiavi da sua madre e apre", aggiunge confermando che a innescare l'esplosione sarebbe stato il telecomando piazzato nel citofono dello stabile della madre del magistrato in via D'Amelio. "Minchia - racconta - lui va a suonare a sua madre dove gli abbiamo messo la bomba. Lui va a suonare e si spara la bomba lui stesso. E' troppo forte questa". Secondo gli inquirenti Cosa nostra avrebbe predisposto una sorta di triangolazione: un primo telecomando avrebbe attivato la trasmittente, poi suonando al citofono il magistrato stesso avrebbe inviato alla ricevente, piazzata nell'autobomba, l'impulso che avrebbe innescato l'esplosione. La tecnica, per i magistrati, sarebbe analoga a quella usata per l'attentato al rapido 904 per cui Riina è stato recentemente rinviato a giudizio come mandante. Questo genere di innesco si renderebbe necessario quando è pericoloso o impossibile per chi deve agire restare nei pressi del luogo dell'esplosione.
TANGENTI: CORRUZIONE E COLLUSIONI. LA STORIA SCRITTA DAI VINCITORI.
Saccenti e cattivi. Ecco a voi i sinistroidi.
Virus su Rai 2 condotto da Nicola Porro. 22:33 va in onda un servizio dedicato al caso del magistrato Antonio Lollo di Latina. Gomez: "C'è un problema in Italia riguardo i tribunali fallimentari. Non è la prima volta che un magistrato divide i soldi con il consulente. Nelle fallimentari, è noto che c'è la cosiddetta mano nera. Sulle aste, succedono cose strane. E se lo dice Peter Gomez, direttore de "Il Fatto Quotidiano", notoriamente giustizialista e manettaro oltre che asservito alla magistratura, è tutto dire.
Con lo Stato dilaga il moralismo. La corruzione è figlia di statalismo e burocrazia, scrive Piero Ostellino su “Il Giornale”. Alcuni lettori si sono indignati perché nell'ultimo Dubbio ho scritto che - vivendo in mezzo agli altri, in una società di relazioni - la segnalazione e la raccomandazione non sono immorali in sé perché rientrano nell'ordine delle cose, nella zona grigia delle relazioni interpersonali. Sono un fatto logicamente connaturato al nostro modo di vivere. Prendersela con i fatti non produce conoscenza e, tanto meno, moralità, ma solo confusione. È una forma di arretratezza culturale che non approda a nulla. Pensavo che inclini al moralismo fossero soprattutto certi lettori del Corriere, fra i quali quelli orientati a sinistra sono probabilmente la maggioranza, che se la prendevano volentieri per quello che scrivevo. Invece, constato che ancora prevalgono forme di moralismo che rifiuta il realismo e c'è chi se la prende con la realtà, rifiutandola e rifugiandosi nelle buone intenzioni, convinto che la realtà dovrebbe essere morale. L'Uomo, ha scritto Kant, «è il legno storto» dal quale non si può pretendere esca qualcosa di dritto. La cultura liberale, a differenza di quella socialista, non pretende di cambiare l'Uomo, di renderlo migliore, ma si limita a governarlo come è. Prendersela con la realtà - che non è immorale in sé - è sciocco, equivale a prendersela con i temporali, perché ci si bagna. Non è un segno di intelligenza - da intelligere: capire - e fa dell'Italia un Paese incapace di agire politicamente, cioè un Paese intimamente arretrato! Se piove, piuttosto che imprecare contro la pioggia, è meglio fornirsi di un ombrello...Invece di indignarsi, i lettori del Giornale e noi stessi, dovremmo chiederci, ad esempio, perché, da noi, come accadeva nei Paesi di socialismo reale, corruzione e clientelismo - che sono (anche) una forma di rimedio contro le rigidità del sistema - siano tanto diffusi. La risposta è semplice. Perché siamo un Paese dove prevalgono statalismo e burocratismo, non prevale il merito, ma prosperano permessi e divieti di ogni genere. Corruzione e clientelismo sono un modo di ovviare agli eccessi burocratici. In una economia libera, di mercato, corruzione e clientelismo hanno poca presa perché non sono convenienti; chi si scontra con l'eccesso di legislazione, di permessi e divieti, si comporta guardando, nel proprio interesse, al merito e difficilmente inclinerebbe verso la corruzione e il clientelismo e/o assumerebbe qualcuno che non abbia la qualifica richiesta dalla domanda del mercato. Ho visto, giorno dopo giorno, crollare l'Unione Sovietica per questa ragione e constato con raccapriccio che l'Italia è avviata sulla stessa strada. Se anche lettori aperti al mercato, come si presume dovrebbero essere quelli del Giornale , invece di pensare realisticamente e politicamente, reagiscono moralisticamente di fronte alla realtà, stiamo freschi! Ho la tendenza, da liberale, ad attribuire allo statalismo e al burocratismo, l'arretratezza di cui soffrono i Paesi socialisti. Mi rendo, però, anche conto che, da noi, non sono solo i socialisti a ragionare in tal modo, ma, in generale, tutti gli italiani in quanto culturalmente eredi del fascismo, che era una forma di dirigismo di destra, e influenzati dal collettivismo, indipendentemente dalla loro collocazione politica. Lo dico, allora, con franchezza. Diamoci tutti una regolata, se non vogliamo fare una brutta fine...
Roma, due milioni l’anno per portare i rom a scuola. Stanziamenti d’oro per gli appetiti delle coop. Ma poi frequenta solo un minore su 20, scrive Mario Valenza su “Il Giornale”. Due milioni di euro per mandare i Roma a scuola. Riparte il business delle cooperative nei campi rom per mandare i bambini a scuola. Con una spesa complessiva di quasi 1 milione di euro, infatti, il Comune di Roma ha affidato a 4 cooperative il compito di attivare nei 6 mesi che verranno (dal 1 marzo al 31 agosto) un percorso di scolarizzazione per 1827 minori residenti in 10 strutture fra campi attrezzati, tollerati e residence. Parliamo, tuttavia, di un progetto che riguarda soltanto l’assistenza all’insegnamento, e non tiene conto dei costi collaterali, come quelli ad esempio legati al trasporto, che fanno parte di un capitolo a parte. Basti pensare che nel 2013 sono stati spesi ben 3.115.509 euro di fondi soltanto per tutto quello che riguarda la scuola. L’appalto per quasi 200mila euro al campo di Castel Romano (364 bambini) è stato preso in carico dalla Arci Solidarietà. Nella struttura divenuta famosa negli ultimi mesi per essere stata creata e gestita per anni dalle cooperative di Salvatore Buzzi, arrestato nell’ambito di Mafia Capitale, nel 2013 la cooperativa. come racconta ilTempo, Arci Solidarietà nel 2013 ha speso ben 654.962 euro per i progetti di scolarizzazione, che rappresentano il 12,2% dei fondi assegnati al campo. La scolarizzazione dovrebbe essere il viatico, in prospettiva, per l’inclusione sociale di queste persone. Ma i progetti finora sono stati fallimentari. Sempre secondo 21 Luglio, il tasso di inclusione è dello 0% in 10 delle 11 strutture esistenti: solo il campo di Candoni, nell’ex XV Municipio, può "vantare" un risultato lievemente superiore, lo 0,8%. Un fallimento inevitabile, guardando il tasso delle frequenze: ad oggi sono iscritti alla scuola dell’obbligo quasi 2.000 minori, ma solo il 5% va alle superiori.
Giuseppe Pagliani: "Ho fatto un convegno contro le coop rosse e mi hanno arrestato", scrive Francesco Specchia su “Libero Quotidiano”. Sembra Detenuto in attesa di giudizio, quel film di Nanni Loy, con Alberto Sordi immerso in un’allucinazione giudiziaria. Ma Giuseppe Pagliani, anni 41, consigliere comunale Pdl di Reggio Emilia, avvocato con quattro studi avviati, politicamente e penalmente intonso da un quarto di secolo, non è Sordi. Quei ventidue -giorni- ventidue di ingiusta detenzione non li ha vissuti sul set. Pagliani è stato strappato, lo scorso fine gennaio, dalla famiglia all’alba, nell’ora degli assassini; l’hanno rinchiuso come un topo nelle galere della civilissima Emilia senza essere mai ascoltato dai magistrati che in quell’inferno l’avevano precipitato; e «senza aver mai capito -lo giuro- il motivo per cui ero stato arrestato». Pagliani, oggi, è stato scarcerato per un errore giudiziario ciclopico, ma senza troppe scuse dalla Procura. Anzi, a dire la verità è stato scarcerato il 19 febbraio scorso; ma oggi sono arrivate le sferzanti motivazioni della sentenza del Tribunale della Libertà di Bologna che doveva giudicare la sua accusa di concorso esterno in associazione mafiosa «semplicemente perchè tre anni fa, in un incontro pubblico, a un ristorante, con i fornitori-creditori delle Coop rosse, tra 60 imprenditori c’erano mescolati degli esponenti della N’drangheta del clan Aracri di cui nulla sapevo e mai più avrei rivisto...» ci racconta Pagliani con la voce mozzata. Da lì, il solito copione. Qualcuno sussurra che quella «consorteria» era il legame con le ’ndrine; e il politico-avvocato entra nel mirino dei piemme, e ci esce in gabbia, con la chiave buttata chissà dove. «Un incubo, sono figlio unico: genitori e fidanzata sono rimasti choccati. Le famiglie dei miei 14 dipendenti erano in stato di trance. In galera senza un perchè, ho cominciato perfino a fare consulenza agli altri detenuti». Per capirci: nella retata a strascico del suo arresto -117 persone, per l’inchiesta Aemilia- finiscono anche incensurati assoluti, con violazione palese del principio della misura della pena. Ci finisce addirittura un signore, tal Oppido, che passava di lì per caso, in cella per una settimana prima di sapere di esser vittima d’una devastante omonimia. «Se non ci fosse stato il riesame, se non facessi l’avvocato, se non avessi vergato sette pagine di memorie per spiegare l’assurdo; be’, ora sarei ancora lì a marcire. Per fortuna c’era il riesame, la cui sentenza pare scritta da me». E la sentenza spiega che, in effetti: «Non possono giudicarsi acquisiti gravi indizi di colpevolezza», stilando con aguzza precisione un documento che è una demolizione completa e definitiva dell’accusa. Sostiene Pagliani: «Nel mio ruolo politico mi sono sempre occupato degli strani affari delle cooperative. Ho attaccato per anni i conflitti d’interesse dell’ex presidente della Provincia Sonia Marini e gli interessi locali della sinistra. Forse ho alzato troppo la cresta...». Forse. Di certo le 1286 lettere e email di solidarità («risponderò a tutte») ricevute, compresa quella ufficiale Pdl a firma Maurizio Gasparri, attestano una patologia. Scene d’ordinaria ingiustizia, giusto alla vigilia di una vaporosa riforma giudiziaria. Secondo l’aggiornatissimo sito Errorigiudiziari.com nel solo 2014 sono state accolte 995 domande di risarcimento per 35,2 milioni di euro, incremento del 41,3 per cento rispetto al 2013. Dal 1991 al 2012 lo Stato per questo motivo ha speso 580 milioni di euro per 23.226 cittadini ingiustamente dietro le sbarre negli ultimi 15 anni. Non è finita qui, per Pagliani. Qualche piemme orgoglioso potrebbe riprende il filo dell’assurdo: «Mi auguro che ci provino. Così saranno sberle anche dalla Cassazione». Dov’eravamo rimasti su quella cosa della responsabilità civile dei magistrati macbethiani, ministro Orlando...?
Tangentopoli: la storia scritta dai vincitori, scrive Tiziana Maiolo su “Il Garantista”. Il 1992 mi evoca subito il numero 41, i quarantuno morti suicidi di Tangentopoli, che non hanno potuto scrivere la Storia per ovvie ragioni, ma anche perché la Storia la scrivono i vincitori, e loro erano i vinti. La storia dei Vinti è rimossa con fastidio, dopo che uno dei Pubblici Ministeri di Milano, Gerardo D’Ambrosio, aveva sentenziato, non senza un certo cinismo: «Evidentemente c’è ancora qualcuno che ha il senso dell’onore». Non un dubbio sul fatto che il circo mediatico-giudiziario del disonore che era stato cucito addosso a colpevoli e innocenti sia stato il vero assassino, che ha colpito con violenza la reputazione e la vita di persone che non avevano nessuna possibilità di difendersi, incarcerati, disorientati e sbeffeggiati. Ma dalla parte dei trionfatori, che in occasione della fiction di Sky invadono ogni angolo del pianeta della comunicazione, la storia è stata raccontata come il puro trionfo del Bene sul Male, un gruppo di magistrati-guerrieri senza macchia in lotta contro una classe politica corrotta che ammorbava l’intera società. Sulla scialuppa degli onesti erano saliti ben presto imprenditori in lacrime, giornalisti-coccodè, uomini politici con le tasche traboccanti di rubli, avvocati-accompagnatori alleati del Pubblici Ministeri. Ma la storia di Tangentopoli potrebbe anche essere raccontata come vera Storia Politica, come vicenda che segnò il trionfo massimo di una giustizia di parte, che ebbe come protagonisti magistrati politicizzati e un eroe tutt’altro che “senza macchia”. Che vide complici con le toghe innanzi tutto quegli imprenditori che avevano ben lucrato sul finanziamento illegale ai partiti, a tutti i partiti, e che mai se ne erano lamentati, finché l’arresto di otto di loro fece rendere conveniente agli altri immaginare di esser stati sfruttati. Sono gli stessi che, proprietari di giornali, decisero la campagna del Grande Sputtanamento degli uomini politici, quelli sconvenienti, i non allineati. Quelli che si salvarono dal carcere ripudiando se stessi e la propria storia e accoltellando quelli che erano stati i loro benefattori. La vacca non dava più latte. Non c’era più pane e loro scelsero le brioches. Il girotondo intorno ai protagonisti principali, magistrati e imprenditori, era fatto di avvocati di grandi e piccoli studi, che salivano festosi, ma in ginocchio, le scale fino al quarto piano del Palazzo di giustizia tenendo per mano i proprio assistiti pronti all’autodafè, mentre il Di Pietro di turno li riceveva in ciabatte, rideva e agitava manette. Quelli bravi, quelli amici, riuscivano a salvare l’assistito dal carcere e ne venivano ricompensati. In vario modo e da diverse parti. Avevano dimenticato il codice a casa, molti di questi avvocati, badavano al sodo e basta. C’erano poi i giornalisti-coccodè, i cronisti giudiziari che ogni mattina fiutavano la preda, giovani entusiasti che indossavano con orgoglio la maglietta che inneggiava all’eroe di Mani Pulite, lavoravano in pool e non tornavano mai in redazione a mani vuote, con il carniere pieno di verbali d’interrogatorio ( non erano ancora di moda le intercettazioni ), sicuri che avrebbe apprezzato il direttore, ma soprattutto l’editore, lo stesso che tremava se il campanello di casa suonava troppo presto il mattino. I fiaccolanti forse erano i più innocenti, cittadini che facevano il girotondo intorno al Palazzo, nella speranza-illusione che qualcosa cambiasse. Ma non c’erano solo loro, c’era un po’ di tutto, in quelle manifestazioni, compresi i cinici di nuovi movimenti politici che volevano solo sostituirsi agli altri, e anche quelli che erano sulla scialuppa di salvataggio, comunisti e democristiani di sinistra che si erano finanziati come gli altri, ma che si erano opportunamente alleati ai magistrati. Una folla di indifferenti, mentre ogni giorno saltavano le regole dello Stato di diritto, mentre veniva calpestata la Costituzione, mentre si violavano le competenze territoriali, la libertà personale e i diritti della difesa. Mentre si usava il carcere come tortura per far parlare la gente. Mentre si uccideva. Tanto la Storia la scrivono i vincitori, anche alle spalle dei quarantuno che non ci sono più.
Virus su rai 2 condotto da Nicola Porro. 22:33 va in onda un servizio dedicato al caso del magistrato Antonio Lollo di Latina. Gomez: "C'è un problema in Italia riguardo i tribunali fallimentari. Non è la prima volta che un magistrato divide i soldi con il consulente. Nelle fallimentari, è noto che c'è la cosiddetta mano nera. Sulle aste, succedono cose strane. E se lo dice Peter Gomez, direttore de "Il Fatto Quotidiano", notoriamente giustizialista e manettaro oltre che asservito alla magistratura, è tutto dire.
"Tangenti e cricche si possono sconfiggere ma ci sono anche giudici riluttanti". "La magistratura in qualche caso ha dato l’impressione d’essere dura e pura davanti a questioni banali e di non saper affrontare con fermezza i problemi più gravi. E qualche collega non ha voglia di impegnarsi in inchieste difficili". Intervista a Raffaele Cantone, presidente dell'Anticorruzione, tratta dal nuovo libro scritto con Gianluca Di Feo.
«Non voglio creare illusioni, ma neppure lasciare alibi. La guerra alla corruzione si può fare. L’Autorità che guido non può arrestare né intercettare: non può bloccare le tangenti. Ma ha altri poteri, che cominciano a dare qualche risultato».
Raffaele Cantone è il presidente della prima struttura creata in Italia per cercare di prevenire la corruzione. Un modo nuovo di affrontare il problema, insistendo sulla trasparenza, sul merito, sulla fiducia nella capacità di riscatto del Paese. In un solo anno ha dovuto misurarsi con gli scandali dell’Expo, del Mose e di Mafia Capitale. E adesso affida a un libro intervista scritto con Gianluca Di Feo de “l’Espresso” l’analisi de “Il male italiano” più grave: un morbo più profondo delle tangenti, che ha contaminato l’intera società. Cantone discute delle colpe della politica, degli imprenditori e della burocrazia. Senza risparmiare critiche alla magistratura, a cui è orgoglioso di appartenere. Come in queste pagine che anticipiamo.
Raffaele Cantone, lei sostiene che per domare la corruzione è necessario puntare su tre pilastri: repressione, prevenzione e una battaglia culturale per cambiare l’atteggiamento degli italiani. Partiamo dalla repressione: cosa bisogna fare?
«Prima di tutto, bisogna porre l’attenzione su una questione organizzativa, ossia la capacità della magistratura di mettere in campo il meglio. Ancora oggi esistono realtà in cui non si aprono indagini per tangenti, nonostante nel Paese non esistano zone franche. Questo male si manifesta ovunque, seppure con diversi livelli di intensità. Se la corruzione non viene scoperta, significa che c’è un problema, nelle procure o negli inquirenti, e questo è anche specchio dell’inefficienza della magistratura nell’affrontare questioni complesse. Credo che sia necessaria un’autocritica sull’organizzazione giudiziaria e sull’importanza che viene riconosciuta alla lotta alla corruzione. Per esempio, non tutti gli uffici investigativi hanno pool specializzati per i reati di questo tipo. Che richiedono grande impegno e professionalità: quando le inchieste vengono fatte bene, i risultati arrivano sempre».
Ma se la giustizia non funziona, come si può fermare la corruzione? Oggi l’impunità per i colletti bianchi è praticamente certa: la maggioranza dei procedimenti per corruzione si chiude con la prescrizione o con pene irrisorie. Quasi sempre i protagonisti degli scandali riescono a tornare al loro posto.
«La repressione giudiziaria è il momento chiave della lotta, senza il quale la prevenzione non ha alcun senso. Inutile mettere in campo strumenti per impedire la corruzione, se i reati non vengono puniti. Anche negli anni di Mani Pulite le inchieste sono state a macchia di leopardo. In quel periodo c’è stato il più alto livello di incriminazioni, ma studiando le statistiche giudiziarie ci si rende conto che esistono vuoti assoluti in alcune zone d’Italia: perché quelle procure non hanno indagato? Di sicuro non perché in quei territori non ci fossero tangenti o finanziamenti illeciti. La legge Cirielli del 2005 è stata devastante, perché ha reso la prescrizione di questi reati più rapida, ma anche prima di allora tanti processi venivano buttati via perché si perdeva troppo tempo. Ricordo la prima indagine sulle ecomafie in Italia, che ha fatto finire alla sbarra l’alleanza tra boss casalesi, politici e funzionari campani: una vicenda fondamentale, l’origine dell’avvelenamento di un’intera regione. L’assessore della Provincia – che aveva intascato tangenti per autorizzare il trasporto di rifiuti illeciti – venne condannato, in primo grado, poi in appello ci sono stati talmente tanti rinvii che si è arrivati alla prescrizione. E di casi come questi ce ne sono moltissimi. Oggi ci sono istruttorie che vengono cancellate dal tempo prima ancora che sia pronunciato qualunque giudizio: l’inchiesta finisce nel cestino senza neppure l’incriminazione. Questo ha un effetto disastroso: oltre a non dare un colpo al malaffare, trasmetti la certezza dell’impunità. Una parte della magistratura compie il proprio dovere e difende i processi. Ma bisogna riconoscere che un’altra parte, sicuramente minoritaria, non sempre ha fatto tutto quello che poteva».
Nel 1992 i risultati delle indagini milanesi e il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno cementato il consenso degli italiani verso i giudici. Piercamillo Davigo ha detto che la magistratura non ha fatto una rivoluzione, ma ha salvato la credibilità delle istituzioni, impedendo che la crisi economica e politica di quegli anni degenerasse nel caos. Adesso la fiducia nella categoria è ai minimi e la paralisi della giustizia insostenibile. Ma non sembra che la magistratura tenti di trovare soluzioni.
«Nella magistratura convivono varie anime. Lei ha citato il 1992, ma anche allora era divisa. Mentre Falcone, Borsellino, Livatino venivano uccisi, c’era un pezzo di magistratura che faceva in modo molto più burocratico la sua parte. Nel 1980, l’assassinio del procuratore di Palermo Gaetano Costa, una figura la cui probità dovrebbe essere d’esempio a tanti, venne collegato al fatto che alcuni colleghi avevano preso le distanze dalle sue decisioni, rifiutandosi di firmare l’ordine d’arresto per i capi di Cosa nostra. Oggi come allora, tra le toghe c’è chi fa il suo dovere con abnegazione, correndo rischi altissimi, e chi non lo fa: numericamente questi ultimi sono molti di meno, una percentuale inferiore alla media riscontrata negli altri settori della pubblica amministrazione. E non è un caso che nel 1988 si sia preferito insediare Antonino Meli e non Falcone alla guida degli inquirenti di Palermo. Perché? Falcone era antipatico a molti, veniva considerato un «supergiudice» e tra i colleghi c’era invidia nei suoi confronti. Ma anche perché con il suo lavoro metteva in discussione la figura del magistrato che si limita a fare il minimo indispensabile. Negli ultimi anni questa fascia della magistratura si è ridotta, ma esiste ancora».
Ci sono importanti magistrati che hanno fatto l’apologia del «giudice senza qualità», che si limita ad applicare la legge senza protagonismi. Ma così si rischia di avallare la débâcle della giustizia. Perché le regole processuali favoriscono chi ha le risorse economiche per sfruttare in pieno la prassi dei ricorsi fino al traguardo della prescrizione.
«La magistratura è per certi versi schizofrenica. In qualche caso abbiamo dato l’impressione d’essere duri e puri davanti a questioni banali e di non saper affrontare con fermezza i problemi più gravi. Somigliamo per certi versi alla tela del ragno: più grossa è la vittima che cade nella nostra rete, più è facile che le sue maglie cedano e la lascino scappare indenne. Per il ragno, è una dimostrazione di intelligenza: a che serve affannarsi a imprigionare un animale troppo grande per le sue forze? Meglio concentrarsi sugli insettini inermi che si impigliano nella sua trappola. Per la magistratura, invece, questa diventa una dichiarazione di impotenza».
I pezzi grossi, infatti, beneficiano della situazione. E non solo grazie al colpo di spugna della prescrizione. Ci sono tribunali di provincia dove raramente si dà fastidio ai potenti, senza contare che la procura di Roma, per decenni, è stata «il porto delle nebbie» in cui tutte le indagini scomparivano nel nulla. Se si tratta di punire emarginati e piccoli delinquenti, però, gli stessi giudici sanno essere inflessibili.
«L’impressione è che spesso sia così. E questo consolida il potere dei forti. Basta vedere quanto spesso i processi ai colletti bianchi finiscono nel nulla rispetto ai giudizi contro cittadini comuni. Certo, sono processi più complessi, ma questo giustifica solo in parte le disparità negli esiti. La verità è che molti non hanno voglia di impegnarsi in inchieste difficili, e il fatto che i meccanismi di valutazione della produttività siano spesso oggetto di valutazioni meramente burocratiche peggiora le cose: se tu condanni uno scippatore che ha rubato venti euro, o un concussore che ha intascato milioni con metodi sofisticati, non fa differenza. Nelle statistiche possono valere entrambi uno, anche se l’impegno richiesto per assicurarli alla giustizia è molto diverso».
CORRUZIONE A NORMA DI LEGGE.
"Corruzione a norma di legge", piaga italiana. Nel libro di Giorgio Barbieri e Francesco Giavazzi la ricostruzione dell'intreccio che tra controllati e controllori, il quadro di un fenomeno che è oggi più grave di quanto non fosse all'epoca di Tangentopoli: allora le norme venivano violate, oggi sono state "aggiustate" per permettere gli abusi, scrive “La Repubblica”. La lobby delle Grandi opere affonda l'Italia, recita il sottotitolo del libro di Giorgio Barbieri e Francesco Giavazzi, Corruzione a norma di legge (Rizzoli) dedicato alla palude e al malaffare che per due decenni, con gli scandali del MoSE di Venezia, dell'Expo di Milano o dell'Alta velocità hanno inquinato il Paese durante la Prima e la Seconda Repubblica, allungando i tempi e gonfiando a dismisura i costi di realizzazione. Ed è assai chiaro il messaggio che fa da filo conduttore alla ricostruzione del fitto intreccio che ha legato controllori e controllati lungo il percorso delle Grandi opere. Oggi la corruzione è perfino più grave che in passato e questo avviene perché, se con Tangentopoli gli imprenditori che avevano violato le leggi potevano essere perseguiti, ai nostri giorni punire i responsabili è diventato assai più arduo. Poiché sono le stesse leggi a essere state "aggiustate" a monte per permettere il vantaggio dei privati a discapito dello Stato, chi corrompe non viola norme, ma le usa e sfrutta per il proprio tornaconto. Una desolante realtà di fronte alla quale la giustizia ha le armi spuntate e che potrebbe essere combattuta soltanto dai cittadini e dalla politica. Ma come fare per promuovere e dar corso alle Grandi Opere necessarie al Paese, evitando il sistema corruttivo che ha imperversato negli ultimi vent'anni e cambiato la percezione che i cittadini hanno della politica, mai stata come ora al minimo del gradimento? Innanzi tutto, rispondono Giorgio Barbieri, giornalista, e Francesco Giavazzi, economista, la politica dovrebbe radicalmente cambiare il modo d'intendere il suo ruolo e dunque impedire (e non promuovere) quelle leggi ad hoc che finora hanno permesso i tornaconti privati, a tutto svantaggio dell'interesse pubblico. E qui entrano in gioco i cittadini che, con il loro voto, possono pretendere di sostenere solo chi s'impegna contro la "corruzione delle leggi". Inoltre, suggeriscono gli autori, le imprese dovrebbero potersi assicurare presso una compagnia privata così come le "gole profonde", che denunciano la corruzione, dovrebbero poter contare su una rete di protezione efficiente e reale. Infine, è dovere di chi controlla qualità e costi delle Grandi opere essere finalmente del tutto indipendente dalla politica.
Perché la vicenda del MoSe è emblematica della corruzione diffusa?
«Perché meglio di ogni altra dimostra che la corruzione più grave, cioè quella che più costa ai cittadini, non è quella che avviene tramite violazione delle leggi, di cui per lo più si occupa la stampa, bensì quella che avviene per "corruzione delle leggi". Leggi ad hoc, come la legge del 1984 che creò il concessionario unico, ovvero assegnò buona parte dei lavori di salvaguardia della laguna di Venezia (18 miliardi di euro di oggi) ad un monopolista. Costui, il Consorzio Venezia Nuova, in questi 30 anni ha realizzato lavori per il MoSE per oltre 6 miliardi (in euro di oggi), con un sovrapprezzo per lo Stato, e quindi per i cittadini, che supera i 2,4 miliardi di euro. La "corruzione" della legge è più ambigua della "violazione", perché nel primo caso nessuna legge viene violata: sono le leggi stesse a essere state "corrotte", cioè scritte e approvate per il tornaconto dei privati contro l'interesse dello Stato, o per alcuni privati a svantaggio di altri. Di fronte a questo tipo di corruzione la giustizia non ha armi e che può essere combattuta solo dalla politica e dai cittadini».
Tutti gli scandali da Tangentopoli in poi...
«Gli imprenditori sono usciti dall'esperienza di Tangentopoli con danni giudiziari limitati e una lezione: per non cedere tutta la rendita della corruzione ai politici occorre trattare da una posizione di forza, costruendo un'unica impresa monopolista per eliminare la possibilità che il politico tratti con altri. Di qui nasce l'idea del consorzio di imprese che tratta con politici e amministrazioni come fosse un'unica impresa, rappresentando tutti i soci, e quindi evitando anche l'imbarazzo di incontri diretti fra politica e imprenditori. Non a caso nel Consorzio Venezia Nuova si ritrovano gli stessi imprenditori attivi al tempo di Tangentopoli. Trattando da una posizione di forza si può anche fare in modo che i benefici ottenuti non siano sanzionati dalla legge, e così evitare il rischio della prigione. I politici sono quindi pagati per ottenere non solo una parte della rendita, ma anche leggi che la rendano "legale". Durante Tangentopoli politici e imprenditori violavano le leggi, e infatti in molti sono finiti in prigione. Con il MoSE tutto diventa legittimo perché le leggi sono scritte in modo tale che appropriarsi di una parte della rendita destinata alla realizzazione della grande opera diventi legale».
Come uscire dall'ennesima palude che ha coinvolto la Prima e la Seconda repubblica?
«Il libro si chiude con tre proposte concrete. 1: richiedere che, per partecipare a un appalto, le imprese si assicurino con una compagnia privata, come avviene negli Stati Uniti. In Italia una legge in questo senso esiste, ma i decreti attuativi non sono mai stati scritti. 2: la creazione di un'efficiente rete di protezione per le "gole profonde", ossia chi denuncia sospetti episodi di corruzione, ma anche di ogni altra forma di comportamento illegale. 3:. l'indipendenza dalla politica di chi deve controllare qualità e costi. Ma queste misure non risolvono il problema più grave, che è la corruzione delle leggi. Questo è compito esclusivamente della politica. L'amara vicenda che ha travolto il Mose di Venezia può però trasformarsi in un'occasione affinché politica e cittadini, con il proprio voto, trovino l'antidoto affinché simili casi di corruzione delle leggi non si ripetano».
Leggi sbagliate, non solo gli uomini. Nel libro di Barbieri e Giavazzi, l’analisi di due tipi di corruzione: le tangenti e quelle norme scritte e approvate per il tornaconto dei privati contro l’interesse dello Stato, scrive Gian Antonio Stella su “Il Corriere della Sera”. I veneziani dei tempi d’oro non ci avrebbero pensato due volte: ogni colpevole sarebbe stato portato dopo la condanna a San Marco, legato mani e piedi a quattro cavalli che con un colpo di frusta sarebbero schizzati via in direzioni opposte. Era implacabile, la Serenissima, sul furto e lo spreco di soldi pubblici. Più ancora era rigida nella difesa del delicato equilibrio della laguna. Figuratevi dunque la collera che sarebbe esplosa alla scoperta che il Mose, senza avere ancora dato prova se funzionerà o meno, è già costato, a prezzi aggiornati grazie a preziose ricostruzioni storiche, trenta volte più della grandiosa e costosissima deviazione del Piave compiuta mezzo millennio fa dai nostri bisnonni con mezzi tecnici immensamente inferiori a quelli di oggi. Per l’esattezza sono stati sottratti alle tasche dei cittadini 6,2 miliardi di euro: più del triplo di quanto dichiarato inizialmente. Quasi il doppio di quanto costò, in moneta attuale, l’Autostrada del Sole. È un cazzotto allo stomaco, il saggio Corruzione a norma di legge. La lobby delle grandi opere che affonda l’Italia, scritto da Giorgio Barbieri e Francesco Giavazzi, in libreria da domani per Rizzoli. Ma se volete capire «come mai» annaspiamo nella corruzione, nell’inefficienza e nella paralisi delle opere pubbliche (e come sia obbligatorio cambiare tutto), dovete assolutamente leggerlo. Perché la storia scellerata del Mose, intorno alla quale ruota il libro, è un impasto di tutto ciò che ci affligge: la cattiva politica, la cattiva imprenditoria, le cattive regole. Ci sono infatti, per gli autori, due tipi di corruzione. Il primo, che vede scattare piuttosto spesso le manette, è quello classico: la tangente. Ma è il secondo tipo a essere più pericoloso e ambiguo «perché nessuna legge viene violata: sono le leggi stesse a essere state corrotte, cioè scritte e approvate per il tornaconto dei privati contro l’interesse dello Stato, o per alcuni privati a svantaggio di altri. Di fronte a questo tipo di corruzione la giustizia non possiede armi. Nel momento in cui la regola corrotta viene applicata nessuno commette alcun reato; i reati semmai sono stati compiuti quando il Parlamento ha approvato le leggi, ma sono più difficili da dimostrare e sanzionare». «Chi ha pagato chi ed esattamente per cosa?» Mica facile rispondere. Certo è che tutta la vicenda delle paratie mobili trabocca di deroghe decise per scassinare le regole. La scelta iniziale di un concessionario unico per prendere in contropiede Bruxelles, che avrebbe imposto gare d’appalto europee. La nascita di un cartello che si accaparra il monopolio dei lavori e dà soldi a tutti e «tratta con politici e amministrazioni come fosse un’unica impresa, rappresentando tutti i soci, e quindi evitando anche l’imbarazzo di incontri diretti fra politica e imprenditori». Le disinvolte scorciatoie per scansare ogni intralcio normativo in nome dell’urgenza («Le opere per salvare Venezia verranno ultimate entro il 1995», giurava Craxi nel 1986), col risultato che chi oggi chiede se «una scelta tecnologica fatta quarant’anni fa sia tuttora idonea, soprattutto alla luce dell’analisi costi-benefici», si sente rispondere che «è troppo tardi, ma è una domanda che, in quarant’anni, mai è stato consentito porre, sempre con la scusa che “ormai i lavori sono quasi finiti”». Erano anni e anni, accusano Barbieri e Giavazzi, che l’andazzo era sotto gli occhi di tutti. Lo dicono le parole dei magistrati Felice Casson e Ivano Nelson Salvarani, che nella stagione di Mani pulite fecero arrestare l’allora presidente del Veneto Gianfranco Cremonese e la spalla di Gianni De Michelis, Giorgio Casadei, scrivendo nella richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro Carlo Bernini di «un accordo spartitorio tra i partiti che investe il Consorzio Venezia Nuova». Lo ripete un micidiale rapporto degli ispettori ministeriali contro l’allora Magistrato alle acque Patrizio Cuccioletta, rimosso nel 2001 per «un uso improprio dei poteri d’urgenza» e un mucchio di irregolarità, comprese «234 giornate lavorative di assenza su 381», e ciò nonostante rimesso al suo posto anni dopo dal berlusconiano Altero Matteoli. Lo conferma un dossier giudiziario secondo cui «l’80% dell’attività del Magistrato era in realtà istruito, redatto e preparato da personale del Consorzio Venezia Nuova». Lo ribadisce una relazione della Corte dei conti sui collaudi delle opere: «Gli emolumenti ai collaudatori sono integralmente posti a carico del concessionario». Una schifezza, denunciano Barbieri e Giavazzi: il collaudatore opera per conto e nell’interesse dello Stato e «dovrebbe essere la naturale controparte del concessionario, cioè del Consorzio, ed è un evidente conflitto d’interessi se le parcelle sono saldate da chi deve essere controllato». Parcelle enormi, tra l’altro: 23.868.640 euro nel solo quinquennio 2004-2008. Con tariffe, come rivelò Sergio Rizzo, «maggiorate del 60% per rimborso forfettario delle spese». E distribuite persino a potenti dirigenti ministeriali, che poi avevano voce in capitolo sui finanziamenti al Consorzio. L’impasto di interessi appiccicosi era tale, ricorda il libro, che a un certo punto Carlo Azeglio Ciampi decise con un decreto di dire basta al concessionario unico. Ma ancora quell’impasto di interessi fece sì che l’anno dopo il decreto fosse svuotato da Lamberto Dini, con due righe che blindavano gli affari del Consorzio: «Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti». Per non dire come fu presa per i fondelli Bruxelles, che, furente per le violazioni alla concorrenza sulle gare d’appalto comunitarie, abboccò all’impegno del governo di destra di un cambio di rotta e dell’assegnazione con gare europee del 53% dei lavori «per circa 3.160 milioni di euro». Una bufala: «Il Consorzio ha infatti messo a gara forniture per una cifra inferiore ai 200 milioni di euro, il 5% circa». Ma quanto è costata agli italiani questa miliardaria poltiglia di interessi, dove le mazzette sono solo la parte più visibile? Il libro risponde che, sommando i ribassi mancati (1,6 miliardi circa) all’aggio di 744 milioni trattenuto da Venezia Nuova, si arriva a quasi 2,4 miliardi di euro. «E questa cifra non include il maggiore costo dei lavori eseguiti dal Consorzio per altre opere di salvaguardia, che ammonta a 3 miliardi di euro circa». Un bottino spropositato. Che ci ricorda l’urgenza di cambiare finalmente, prima ancora che gli uomini, le regole. Ne va del destino di Venezia. Dell’Expo. Delle grandi opere. Del Paese stesso: «Il rischio è che l’opinione pubblica, sconcertata dai casi di eclatanti violazioni della legge, scordi che il problema principale è la corruzione delle leggi».
In tutta questa ipocrisia stona la retorica del sud assistito.
IL SUD TARTASSATO.
Sud tartassato: il Meridione paga più di tutti, scrive Lanfranco Caminiti su “Il Garantista”. Dice la Svimez che se muori e vuoi un funerale come i cristiani, è meglio che schiatti a Milano, che a Napoli ti trattano maluccio. E non ti dico a Bari o a Palermo, una schifezza. A Milano si spende 1.444,23 euro per defunto, a Napoli 988 euro, a Bari 892 euro e 19 centesimi, a Palermo 334 euro. A Palermo, cinque volte meno che a Milano. Il principe Antonio De Curtis, in arte Totò, si rivolterà nella tomba, che a quanto pare non c’è nessuna livella, dopo morti. E checcazzo, e neppure lì terroni e polentoni siamo uguali. E basterebbe solo questo – il culto dei morti dovrebbe antropologicamente “appartenere” alle società meridionali, era il Sud la terra delle prefiche, era il Sud la terra delle donne in nero, era il Sud la terra dei medaglioni con la fotina dell’estinto che pendono sul petto delle vedove – per dire come questa Italia sia cambiata e rovesciata sottosopra. Si paga al Sud di più per tutto, per l’acqua, la monnezza, l’asilo, gli anziani, la luce nelle strade, i trasporti, insomma per i Lep, come dicono quelli che studiano queste cose: livelli essenziali delle prestazioni. Essenziali lo sono, al Sud, ma quanto a prestazioni, zero carbonella. Eppure, Pantalone paga. Paga soprattutto la classe media meridionale che si era convinta che la civilizzazione passasse per gli standard nazionali. Paghiamo il mito della modernizzazione. Paghiamo l’epica della statalizzazione. Paghiamo la retorica della “cosa pubblica”. Paghiamo l’idea che dobbiamo fare bella figura, ora che i parenti ricchi, quelli del Nord, vengono in visita e ci dobbiamo comportare come loro: non facciamoci sempre riconoscere. Paghiamo le tasse, che per questo loro sono avanti e noi restiamo indietro. Lo Stato siamo noi. Parla per te, dico io. Dove vivo io, un piccolo paese del Sud, pago più tasse d’acqua di quante ne pagassi prima in una grande città, e più tasse di spazzatura, e non vi dico com’è ridotto il cimitero che mi viene pena solo a pensarci. Sono stati i commissari prefettizi – che avevano sciolto il Comune – a “perequare” i prelievi fiscali. Poi sono andati via, ma le tasse sono rimaste. Altissime, cose mai viste. In compenso però, la spazzatura si accumula in piccole montagne. A volte le smantellano, poi si ricomincia. Non sai mai quando, magari qualcuno dei laureati che stanno a girarsi i pollici al baretto della piazza potrebbe studiarla, la sinusoide della raccolta rifiuti. Invece, i bollettini arrivano in linea retta. Con la scadenza scritta bella grossa. L’unica cosa che è diminuita in questi anni al Sud è il senso di appartenenza a una qualche comunità più grande del nostro orto privato. La pervasività dello Stato – e quale maggiore pervasività della sua capacità di prelievo fiscale – è cresciuta esponenzialmente quanto l’assoluta privatizzazione di ogni spirito meridionale. Tanto più Stato ha prodotto solo tanta più cosa privata. E non dico solo verso la comunità nazionale, la Patria o come diavolo vogliate chiamarla. No, proprio verso la comunità territoriale. Chi può manda i figli lontano, perché restino lontano. Chi può compra una casa lontano sperando di andarci il prima possibile a passare gli anni della vecchiaia. Chi può fa le vacanze lontano, a Pasqua e a Natale, il più esotiche possibile. Chi non può, emigra. Di nuovo, come sempre. Il Sud è diventato terra di transito per i suoi stessi abitanti. Come migranti clandestini, non vediamo l’ora di andarcene. il Sud dismette se stesso, avendo perso ogni identità storica non si riconosce in quello che ha adesso intorno, che pure ha accettato, voluto, votato.
C’era una volta l’assistenzialismo. Rovesciati come un calzino ci siamo ritrovati contro un federalismo secessionista della Lega Nord che per più di vent’anni ci ha sbomballato le palle rubandoci l’unica cosa in cui eravamo maestri, il vittimismo. Siamo stati vittimisti per più di un secolo, dall’unità d’Italia in poi, e a un certo punto ci siamo fatti rubare la scena da quelli del Nord – e i trasferimenti di risorse, e le pensioni, e l’assistenzialismo e la pressione fiscale e le camorre degli appalti pubblici – e l’unica difesa che abbiamo frapposto è stata lo Stato. Siamo paradossalmente diventati i grandi difensori dell’unità nazionale contro il leghismo. Noi, i meridionali, quelli che il federalismo e il secessionismo l’avevano inventato e provato. Noi, che dello Stato ce ne siamo sempre bellamente strafottuti. Li abbiamo votati. Partiti nazionali, destra e sinistra, sindaci cacicchi e governatori, li abbiamo votati. Ci garantivano le “risorse pubbliche”. Dicevano. Ci promettevano il rinascimento, il risorgimento, la resistenza. Intanto però pagate. Come quelli del Nord. Facciamogli vedere. Anzi, di più. La crisi economica del 2007 ha solo aggravato una situazione già deteriorata. E ormai alla deriva. È stata la classe media meridionale “democratica” l’artefice di questo disastro, con la sua ideologia statalista. Spesso, loro che possono, ora che le tasse sono diventate insopportabili, ora che il Sud è sfregiato, senza più coscienza di sé, ora se ne vanno. O mandano i loro figli lontano. Chi non può, emigra. Di nuovo, come sempre.
Non solo i cittadini italiano sono tartassati, ma sono anche soggetti a dei disservizi estenuanti.
DISSERVIZI A PAGAMENTO.
COSE STRANE AGLI SPORTELLI ASL DI TARANTO? O COSI’ FAN TUTTI?
Ritardi, disservizi e cose varie…….negli uffici pubblici.
Esercizio di un privilegio o abuso del diritto a danno dei più deboli?
Per esempio, 10 minuti di pausa ogni ora per l’unico terminalista e, al fine dell’esenzione per reddito, essere considerati disoccupati solo se si è cessato un lavoro dipendente. Per chi non ha mai trovato lavoro e per chi da anni ha chiuso bottega: niente!!!
Mi capita spesso di vedere cose strane in giro per l’Italia, che regolarmente riporto nei miei libri, giacchè il mio lavoro di sociologo storico lo impone.
Mi viene il dubbio, però, che io sia più un alienato che un alieno, tenuto conto che quello che vedo io, gli altri non lo vedono.
Per esempio parliamo dell’ufficio anagrafe dell’ASL TA presso l’ospedale di Manduria. In quell’ufficio le esenzioni per reddito vengono rilasciate dopo circa un mese dalla loro richiesta. Non so quanti addetti ci lavorino dentro, ma, spesso, c’è un solo sportello front office operativo. Ergo, vi è sempre una fila bestiale e non raramente cessano la distribuzione dei numerini del turno giornaliero di fila. Nell’attesa del proprio turno, però, non si può fare a meno di leggere tutti gli avvisi appesi al muro. Nell’imbarazzo non ti rapporti con il vicino per evitare di tediarlo ed allora gli occhi cadono su quei pezzi di carta indistinti affissi alle pareti ed inizi a leggere, giusto per darti l’aria di essere affaccendato in altro ed evitare, quindi, di attaccar bottone.
L’occhio, anzi, tutt’e due, questa volta mi son caduti su un avviso che diceva: “AVVISO. Il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e che sia iscritto al centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione. Non è considerato disoccupato né chi ha mai lavorato, né chi ha cessato un lavoro autonomo”. La sottolineatura era apposta per evidenziare il concetto.

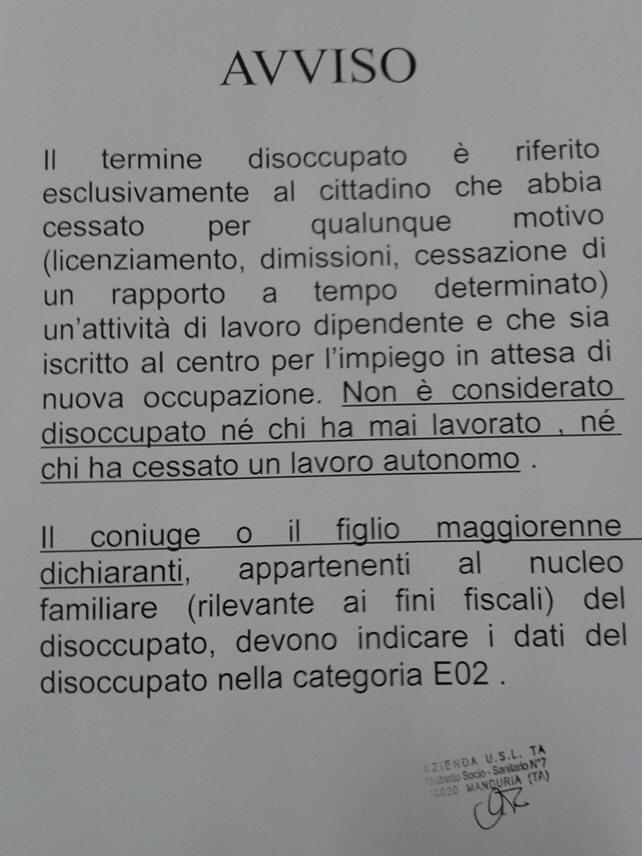
Da lasciare sgomenti, specie nella terra del governatore Niki Vendola, leader di SEL, il porta bandiera della sinistra. Sono rimasto indignato dal fatto su come si possa pensare che uno che sta a casa senza lavoro da sempre, sia diverso da un altro che sta a casa dopo essere stato licenziato. Va be’! I meandri della burocrazia sono infiniti, dirà qualcuno … che sicuramente non conosce l’art. 3 della Costituzione. Ma come disse Dante, ….non ragioniam di loro, ma guarda e passa.
Ed io nella lunga attesa di ore son passato oltre….ad un altro cartello, in cui era scritto in maiuscolo: “L’ADDETTO AL VIDEOTERMINALE E’ AUTORIZZATO AD UNA PAUSA DI 10 MINUTI OGNI ORA DAL MEDICO COMPETENTE”. Il termine “pausa di 10” ed “ogni ora” è evidenziato oltre che essere sottolineato. Tutto in rosso, come per far capire chi è che comanda negli uffici pubblici.


Quando qualcosa non mi torna, cerco di approfondire la tematica. E così ho fatto.
Le Pause sul lavoro: Noemi Ricci su PMI scrive che il loro effetto benefico sulla salute è comprovato, visto che servirebbe fisiologicamente una pausa ogni 90 minuti o massimo 120, pena la decadenza della soglia di attenzione e quindi anche della produttività lavorativa. Ma la gestione delle pause (sigaretta, caffè, aria fresca,..) non è cosa facile per il datore di lavoro, che tende a prendere provvedimenti anche se in realtà esiste una norma in materia, seppur lacunosa. Se da un lato si arriva a obbligare i dipendenti a timbrare il cartellino quando vanno a fumare ecc. (vedi il caso del Comune di Firenze), dall’altro ci si appella al Decreto n. 66 del 2003 secondo cui, a meno di diversi accordi contrattuali, ogni lavoratore ha diritto ad almeno dieci minuti di pausa per ogni turno di lavoro che superi le sei ore giornaliere (e undici ore di riposo consecutive tra un turno e l’altro). Le modalità e la durata della pausa dovrebbero essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, in difetto della quale «al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo».
Certo, è difficile quantificare il tempo perso sul lavoro per “staccare un pò la spina”: chiacchiere tra colleghi, telefonate e email personali, sigarette, caffè, persino l’uso del bagno!
L’argomento rimane controverso e di difficile regolamentazione, come in molte cose quello che dovrebbe prevalere, sia da parte dei datori di lavoro che dei dipendenti, è la misura e il buon senso.
Cosa a parte è il lavoro al Pc. Datori di lavoro obbligati a concedere pause ai dipendenti in caso di lavoro continuato al videoterminale: ecco cosa prevede la legge, scrive invece Alessandro Vinciarelli sempre su PMI. Il computer è diventato parte integrante della vita professionale e la presenza dei computer sul posto di lavoro è diventata la normalità. Una pervasività alla quale non fa seguito un’adeguata attenzione agli obblighi stabiliti per legge dalla contrattazione collettiva - anche aziendale - volta a garantire la salute sul lavoro nel caso in cui i dipendenti aziendali utilizzino il Pc (videoterminale) per il proprio lavoro. Inizialmente a regolamentare questo tipo di attività era l’art. 54 del d.lgs. 626/94 della contrattazione collettiva (con obbligo di concedere al lavoratore una interruzione nel caso di lavoro continuato davanti al Pc e in assenza di una disposizione contrattuale). Dal 15 maggio 2008 è poi in vigore il decreto legislativo n.81 (del 9 aprile 2008) in attuazione all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123: anche in questo caso l’obiettivo è scongiurare i rischi per la salute (vista, postura e affaticamento) connessi all’attività lavorativa tramite videoterminali, confermando l’obbligo per il datore di lavoro di tutelare i dipendenti con misure ad hoc e con interruzioni di un quarto d’ora ogni due ore (sempre mediante pause o cambiamento di attività di lavoro). In generale, qualora i propri impiegati svolgono la propria attività per almeno quattro ore consecutive, a questi spetta di diritto ad una interruzione che può essere esplicata tramite pause o mediante cambiamento di attività. Per ogni centoventi minuti (2 ore) passati in maniera continuativa davanti al computer il lavoratore debba avere quindici minuti interruzione, se si raggiunge un accordo aziendale, magari per una pausa caffè – o comunque un intervallo di tempo per “staccare” e rilassare la vista. In caso di diverse necessità personali, il lavoratore può, presentando apposito certificato medico, richiedere al proprio datore di lavoro di stabilire temporaneamente a livello individuale diverse modalità e durata delle interruzioni.
Da precisare che tale obbligo deve essere osservato dal datore di lavoro per preservare la salute sul lavoro dei propri dipendenti, i quali possono quindi usufruire di tale diritto solo a questo scopo. La legge non consente pertanto di cumulare le pause per entrare dopo o uscire prima dal lavoro. Allo stesso modo la pausa deve essere considerata parte integrante dell’orario di lavoro e quindi non può essere riassorbita all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro. Infine il datore di lavoro non deve considerare pause i tempi di attesa davanti al Pc: aspettare una risposta dal sistema elettronico è considerato a tutti gli effetti tempo di lavoro, non potendo il lavoratore abbandonare il posto di lavoro.
A Taranto, dove da una parte muore per inquinamento e dall’altra i reparti ospedalieri chiudono, alla ASL di Taranto preme proprio tutelare la salute dei suoi dipendenti. Non so se la ASL tuteli la salute di tutti i suoi dipendenti od il benessere di quelli più furbi, con l’aiutino del medico compiacente. Certo è che agli utenti proprio non ci pensa. Per limitare l’isteria dei cittadini, però, potrebbe applicare agli sportelli front office gli addetti meno cagionevoli di salute. Od aprire più di uno sportello, affinchè di due o più addetti con salute malferma se ne sostanzi uno per evitare inutili esasperazioni degli utenti in fila da ore. E’ superfluo, altresì, consigliare che, al di là degli impiegati allo sportello, di impegnarsi a smaltire in fretta l’arretrato, affinchè qualche indigente, nell’attesa di veder concessa l’esenzione per effettuare gli esami necessari, nel mese canonico di attesa non tiri le cuoia.
Da rimarcare il fatto che i privilegi della funzione pubblica, con il sostegno dei sindacati, si scontra da sempre con i diritti dei cittadini. C’è l’uniformità nazionale del fenomeno. E’ da mentecatti, quindi, pensare che questo succeda solo a Taranto. Spesso gli avvisi analoghi non sono affissi, ma di fatto sono operativi negli uffici pubblici di tutta Italia . E come se lo sono!!!
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
Economia Sommersa: Il Nord onesto e diligente evade più del Sud, scrive Emanuela Mastrocinque su “Vesuviolive”. Sono queste le notizie che non dovrebbero mai sfuggire all’attenzione di un buon cittadino del Sud. Per anni ci hanno raccontato una storia che, a furia di leggerla e studiarla, è finita con il diventare la nostra storia, l’unica che abbiamo conosciuto. Storia di miseria e povertà superata dai meridionali grazie all’illegalità o all’emigrazione, le due uniche alternative rimaste a “quel popolo di straccioni” (come ci definì quella “simpatica” giornalista in un articolo pubblicato su “Il Tempo” qualche anno fa) . Eppure negli ultimi anni il revisionismo del risorgimento ci sta aiutando a comprendere quanto lo stereotipo e il pregiudizio sia stato utile e funzionale ai vincitori di quella sanguinosa guerra da cui è nata l‘Italia. Serviva (e serve tutt‘ora) spaccare l’Italia. Da che mondo e mondo le società hanno avuto bisogno di creare l’antagonista da assurgere a cattivo esempio, così noi siamo diventati fratellastri, figli di un sentimento settentrionale razzista e intollerante. Basta però avere l’occhio un po’ più attento per scoprire che spesso la verità, non è come ce la raccontano. Se vi chiedessimo adesso, ad esempio, in quale zona d’Italia si concentra il tasso più alto di evasione fiscale, voi che rispondereste? Il Sud ovviamente. E invece non è così. Dopo aver letto un post pubblicato sulla pagina Briganti in cui veniva riassunta perfettamente l’entità del “sommerso economico in Italia derivante sia da attività legali che presentano profili di irregolarità, come ad esempio l’evasione fiscale, che dal riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività illecite e mafiose” abbiamo scoperto che in Italia la maggior parte degli evasori non è al Sud. Secondo i numeri pubblicati (visibili nell‘immagine sotto), al Nord il grado di evasione si attesta al 14, 5%, al centro al 17,4% mentre al Sud solo al 7,9%. I dati emersi dal Rapporto Finale del Gruppo sulla Riforma Fiscale, sono stati diffusi anche dalla Banca d’Italia. Nel lavoro di Ardizzi, Petraglia, Piacenza e Turati “L’economia sommersa fra evasione e crimine: una rivisitazione del Currency Demand Approach con una applicazione al contesto italiano” si legge “dalle stime a livello territoriale si nota una netta differenza tra il centro-nord e il sud, sia per quanto attiene al sommerso di natura fiscale che quello di natura criminale. Per quanto riguarda infine l’evidenza disaggregata per aree territoriali, è emerso che le province del Centro-Nord, in media, esibiscono un’incidenza maggiore sia del sommerso da evasione sia di quello associato ad attività illegali rispetto alle province del Sud, un risultato che pare contraddire l’opinione diffusa secondo cui il Mezzogiorno sarebbe il principale responsabile della formazione della nostra shadow economy. Viene meno, di conseguenza, la rappresentazione del Sud Italia come territorio dove si concentrerebbe il maggiore tasso di economia sommersa". E ora, come la mettiamo?
Si evade il fisco più al Nord che al Sud. E’ uno dei dati che emerge dal rapporto sulla lotta all’evasione redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo Padoan, la somma totale delle principali imposte evase (Iva, Ires, Irpef e Irap) ammonta a 91 miliardi. Il 52% di questa cifra si attesta dunque nel Settentrione, contro i 24 miliardi del centro (26% del totale) e i 19,8 miliardi del Meridione (22%). Il dato è influenzato dal maggior reddito nazionale del Nord. Soprattutto, scrivono i tecnici del Tesoro, la rabbrividire la percentuale di verifiche sulle imprese che trova irregolarità fiscali: è 98,1% tra le grandi, al 98,5% sulle medie e al 96,9% sulle Pmi. Il record tocca agli enti non commerciali, il 99,2% non è in regola. 100% di `positività´ i controlli sugli atti soggetti a registrazione. Ad ogni modo, l’evasione effettiva ‘pizzicata’ dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, ha rilevato il Mef, ammonta a 24,5 miliardi. La maggiore imposta accertata è così salita dell’87% in sette anni, rispetto ai 13,1 miliardi del 2006. Un numero in calo rispetto agli anni 2009-2012 e soprattutto rispetto al picco di 30,4 miliardi del 2011.
Ma quale Sud, è il Nord che ha la palma dell’evasione, scrive Vittorio Daniele su “Il Garantista”. Al Sud si evade di più che al Nord. Questo è quanto comunemente si pensa. Non è così, invece, secondo i dati della Guardia di Finanza, analizzati da Paolo di Caro e Giuseppe Nicotra, dell’Università di Catania, in uno studio di cui si è occupata anche la stampa (Corriere Economia, del 13 ottobre). I risultati degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza mostrano come, nelle regioni meridionali, la quota di reddito evaso, rispetto a quello dichiarato, sia inferiore che al Nord. E ciò nonostante il numero di contribuenti meridionali controllati sia stato, in proporzione, maggiore. Alcuni esempi. In Lombardia, su oltre 7 milioni di contribuenti sono state effettuate 14.313 verifiche che hanno consentito di accertare un reddito evaso pari al 10% di quello dichiarato. In Calabria, 4.480 controlli, su circa 1.245.000 contribuenti, hanno consentito di scoprire un reddito evaso pari al 3,5% di quello dichiarato. Si badi bene, in percentuale, le verifiche in Calabria sono state quasi il doppio di quelle della Lombardia. E ancora, in Veneto il reddito evaso è stato del 5,3%, in Campania del 4,4% in Puglia, del 3,7% in Sicilia del 2,9%. Tassi di evasione più alti di quelle delle regioni meridionali si riscontrano anche in Emilia e Toscana. Alcune considerazioni. La prima riguarda il fatto che nelle regioni del Nord, dove più alta è la quota di evasione, e dove maggiore è il numero di contribuenti e imprese, si siano fatti, in proporzione, assai meno accertamenti che nel meridione. Poiché, in Italia, le tasse le paga chi è controllato, mentre chi non lo è, se può, tende a schivarle, sarebbe necessario intensificare i controlli là dove la probabilità di evadere è maggiore. E questa probabilità, secondo i dati della Guardia di Finanza, è maggiore nelle regioni più ricche. La seconda considerazione è che il luogo comune di un’Italia divisa in due, con un Nord virtuoso e un Sud di evasori, non corrisponde al vero. L’Italia è un paese unito dall’evasione fiscale. Il fatto che in alcune regioni del Nord si sia evaso di più che al Sud non ha nulla a che vedere né con l’etica, né con l’antropologia. Dipende, più realisticamente, da ragioni economiche. L’evasione difficilmente può riguardare i salari, più facilmente i profitti e i redditi d’impresa. E dove è più sviluppata l’attività d’impresa? Come scrivevano gli economisti Franca Moro e Federico Pica, in un saggio pubblicato qualche anno fa della Svimez: «Al Sud ci sono tanti evasori per piccoli importi. Al Nord c’è un’evasione più organizzata e per somme gigantesche». Quando si parla del Sud, pregiudizi e stereotipi abbondano. Si pensa, così, che la propensione a evadere, a violare le norme, se non a delinquere, sia, per così dire, un tratto antropologico caratteristico dei meridionali. Ma quando si guardano i dati, e si osserva la realtà senza la lente deformante del pregiudizio, luoghi comuni e stereotipi quasi mai reggono. Di fronte agli stereotipi e alle accuse – e quella di essere evasori non è certo la più infamante – che da decenni, ogni giorno e da più parti, si rovesciano contro i meridionali, non sarebbe certo troppo se si cominciasse a pretendere una rappresentazione veritiera della realtà. Insieme a pretendere, naturalmente, e in maniera assai più forte di quanto non si sia fatto finora, che chi, al Sud, ha responsabilità e compiti di governo, faccia davvero, e fino in fondo, il proprio dovere.
Quante bugie ci hanno raccontato sul Mezzogiorno! Scrive Pino Aprile su “Il Garantista”. L’Italia è il paese più ingiusto e disuguale dell’Occidente, insieme a Stati Uniti e Gran Bretagna: ha una delle maggiori e più durature differenze del pianeta (per strade, treni, scuole, investimenti, reddito…) fra due aree dello stesso paese: il Nord e il Sud; tutela chi ha già un lavoro o una pensione, non i disoccupati e i giovani; offre un reddito a chi ha già un lavoro e lo perde, non anche a chi non riesce a trovarlo; è fra i primi al mondo, per la maggiore distanza fra lo stipendio più alto e il più basso (alla Fiat si arriva a più di 400 volte); ha i manager di stato più pagati della Terra, i vecchi più garantiti e i giovani più precari; e se giovani e donne, pagate ancora meno. È in corso un colossale rastrellamento di risorse da parte di chi ha più, ai danni di chi ha meno: «una redistribuzione dal basso verso l’alto». È uscito in questi giorni nelle librerie il nuovo libro di Pino Aprile («Terroni ’ndernescional», edizioni PIEMME, pagine 251, euro 16,50). Pubblichiamo un brano, per gentile concessione dell’autore. Quante volte avete letto che la prova dell’ estremo ritardo dell’Italia meridionale rispetto al Nord era l’alta percentuale di analfabeti? L’idea che questo possa dare ad altri un diritto di conquista e annessione può suonare irritante. Ma una qualche giustificazione, nella storia, si può trovare, perché i popoli con l’alfabeto hanno sottomesso quelli senza; e í popoli che oltre all’alfabeto avevano anche ”il libro” (la Bibbia, il Vangelo, il Corano, Il Capitale, il Ko Gi Ki…) hanno quasi sempre dominato quelli con alfabeto ma senza libro. Se questo va preso alla… lettera, la regione italiana che chiunque avrebbe potuto legittimamente invadere era la Sardegna, dove l’analfabetismo era il più alto nell’Italia di allora: 89,7 per cento (91,2 secondo altre fonti); quasi inalterato dal giorno della Grande Fusione con gli stati sabaudi: 93,7. Ma la Sardegna era governata da Torino, non da Napoli. Le cose migliorarono un po’, 40 anni dopo l’Unità, a prezzi pesanti, perché si voleva alfabetizzare, ma a spese dei Comuni. Come dire: noi vi diamo l’istruzione obbligatoria, però ve la pagate da soli (più o meno come adesso…). Ci furono Comuni che dovettero rinunciare a tutto, strade, assistenza, per investire solo nella nascita della scuola elementare: sino all’87 per cento del bilancio, come a Ossi (un secolo dopo l’Unità, il Diario di una maestrina, citato in Sardegna , dell’Einaudi, riferisce di «un evento inimmaginabile »: la prima doccia delle scolare, grazie al dono di dieci saponette da parte della Croce Rossa svizzera). Mentre dal Mezzogiorno non emigrava nessuno, prima dell’Unità; ed era tanto primitivo il Sud, che partoriva ed esportava in tutto il mondo facoltà universitarie tuttora studiatissime: dalla moderna storiografia all’economia politica, e vulcanologia, sismologia, archeologia… Produzione sorprendente per una popolazione quasi totalmente analfabeta, no? Che strano. Solo alcune osservazioni su quel discutibile censimento del 1861 che avrebbe certificato al Sud indici così alti di analfabetismo: «Nessuno ha mai analizzato la parzialità (i dati sono quelli relativi solo ad alcune regioni) e la reale attendibilità di quel censimento realizzato in pieno caos amministrativo, nel passaggio da un regno all’altro e in piena guerra civile appena scoppiata in tutto il Sud: poco credibile, nel complesso, l’idea che qualche impiegato potesse andare in giro per tutto il Sud bussando alle porte per chiedere se gli abitanti sapevano leggere e scrivere» rileva il professor Gennaro De Crescenzo in Il Sud: dalla Borbonia Felix al carcere di Penestrelle. Come facevano a spuntare oltre 10.000 studenti universitari contro i poco più di 5.000 del resto d’Italia, da un tale oceano di ignoranza? Né si può dire che fossero tutti benestanti, dal momento che nel Regno delle Due Sicílie i meritevoli non abbienti potevano studiare grazie a sussidi che furono immediatamente aboliti dai piemontesi, al loro arrivo. Sull’argomento potrebbero gettare più veritiera luce nuove ricerche: «Documenti al centro di studi ancora in corso presso gli archivi locali del Sud dimostrano che nelle Due Sicilie c’erano almeno una scuola pubblica maschile e una scuola pubblica femminile per ogni Comune oltre a una quantità enorme di scuole private» si legge ancora nel libro di De Crescenzo, che ha studiato storia risorgimentale con Alfonso Scirocco ed è specializzato in archivistica. «Oltre 5.000, infatti, le ”scuole” su un totale di 1.845 Comuni e con picchi spesso elevati e significativi: 51 i Comuni in Terra di Bari, 351 le scuole nel complesso; 174 i Comuni di Terra di lavoro, 664 le scuole; 113 i Comuni di Principato Ultra, 325 le scuole; 102 i Comuni di Calabria Citra, 250 le scuole…». Si vuol discutere della qualità di queste scuole? Certo, di queste e di quella di tutte le altre; ma «come si conciliano questi dati con quei dati così alti dell’analfabetismo? ». E mentiva il conte e ufficiale piemontese Alessandro Bianco di Saint-Jorioz, che scese a Sud pieno di pregiudizi, e non li nascondeva, e poi scrisse quel che vi aveva trovato davvero e lo scempio che ne fu fatto (guadagnandosi l’ostracismo sabaudo): per esempio, che «la pubblica istruzione era sino al 1859 gratuita; cattedre letterarie e scientifiche in tutte le città principali di ogni provincia»? Di sicuro, appena giunti a Napoli, i Savoia chiusero decine di istituti superiori, riferisce Carlo Alianello in La conquista del Sud. E le leggi del nuovo stato unitario, dal 1876, per combattere l’analfabetismo e finanziare scuole, furono concepite in modo da favorire il Nord ed escludere o quasi il Sud. I soliti trucchetti: per esempio, si privilegiavano i Comuni con meno di mille abitanti. Un aiuto ai più poveri, no? No. A quest’imbroglio si è ricorsi anche ai nostri tempi, per le norme sul federalismo fiscale regionale. Basti un dato: i Comuni con meno di 500 abitanti sono 600 in Piemonte e 6 in Puglia. Capito mi hai? «Mi ero sempre chiesto come mai il mio trisavolo fosse laureato,» racconta Raffaele Vescera, fertile scrittore di Foggia «il mio bisnonno diplomato e mio nonno, nato dopo l’Unità, analfabeta». Nessun Sud, invece, nel 1860, era più Sud dell’isola governata da Torino; e rimase tale molto a lungo. Nel Regno delle Due Sicilie la ”liberazione” (così la racconta, da un secolo e mezzo, una storia ufficiale sempre più in difficoltà) portò all’impoverimento dello stato preunitario che, secondo studi recenti dell’Università di Bruxelles (in linea con quelli di Banca d’Italia, Consiglio nazionale delle ricerche e Banca mondiale), era ”la Germania” del tempo, dal punto di vista economico. La conquista del Sud salvò il Piemonte dalla bancarotta: lo scrisse il braccio destro di Cavour. Ma la cosa è stata ed è presentata (con crescente imbarazzo, ormai) come una modernizzazione necessaria, fraterna, pur se a mano armata. Insomma, ho dovuto farti un po’ di male, ma per il tuo bene, non sei contento? Per questo serve un continuo confronto fra i dati ”belli” del Nord e quelli ”brutti” del Sud. Senza farsi scrupolo di ricorrere a dei mezzucci per abbellire gli uni e imbruttire gli altri. E la Sardegna, a questo punto, diventa un problema: rovina la media. Così, quando si fa il paragone fra le percentuali di analfabeti del Regno di Sardegna e quelle del Regno delle Due Sicilie, si prende solo il dato del Piemonte e lo si oppone a quello del Sud: 54,2 a 87,1. In tabella, poi, leggi, ma a parte: Sardegna, 89,7 per cento. E perché quell’89,7 non viene sommato al 54,2 del Piemonte, il che porterebbe la percentuale del Regno sardo al 59,3? (Dati dell’Istituto di Statistica, Istat, citati in 150 anni di statistiche italiane: Nord e Sud 1861-2011, della SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno). E si badi che mentre il dato sulla Sardegna è sicuramente vero (non avendo interesse il Piemonte a peggiorarlo), non altrettanto si può dire di quello dell’ex Regno delle Due Sicilie, non solo per le difficoltà che una guerra in corso poneva, ma perché tutto quel che ci è stato detto di quell’invasione è falsificato: i Mille? Sì, con l’aggiunta di decine di migliaia di soldati piemontesi ufficialmente ”disertori”, rientrati nei propri schieramenti a missione compiuta. I plebisciti per l’annessione? Una pagliacciata che già gli osservatori stranieri del tempo denunciarono come tale. La partecipazione armata dell’entusiasta popolo meridionale? E allora che ci faceva con garibaldini e piemontesi la legione straniera 11 domenica 4 gennaio 2015 ungherese? E chi la pagava? Devo a un valente archivista, Lorenzo Terzi, la cortesia di poter anticipare una sua recentissima scoperta sul censimento del 1861, circa gli analfabeti: i documenti originali sono spariti. Ne ha avuto conferma ufficiale. Che fine hanno fatto? E quindi, di cosa parliamo? Di citazioni parziali, replicate. Se è stato fatto con la stessa onestà dei plebisciti e della storia risorgimentale così come ce l’hanno spacciata, be’…Nei dibattiti sul tema, chi usa tali dati come prova dell’arretratezza del Sud, dinanzi alla contestazione sull’attendibilità di quelle percentuali, cita gli altri, meno discutibili, del censimento del 1871, quando non c’era più la guerra, eccetera. Già e manco gli originali del censimento del ’71 ci sono più. Spariti pure quelli! Incredibile come riesca a essere selettiva la distrazione! E a questo punto è legittimo chiedersi: perché il meglio e il peggio del Regno dí Sardegna vengono separati e non si offre una media unica, come per gli altri stati preunitari? Con i numeri, tutto sembra così obiettivo: sono numeri, non opinioni. Eppure, a guardarli meglio, svelano non solo opinioni, ma pregiudizi e persino razzismo. Di fatto, accadono due cose, nel modo di presentarli: 1) i dati ”belli” del Nord restano del Nord; quelli ”brutti”, se del Nord, diventano del Sud. Il Regno sardo era Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e Sardegna. Ma la Sardegna nelle statistiche viene staccata, messa a parte. Giorgio Bocca, «razzista e antimeridionale », parole sue, a riprova dell’arretratezza del Sud, citava il 90 per cento di analfabeti dell’isola, paragonandolo al 54 del Piemonte. Ma nemmeno essere di Cuneo e antimerìdionale autorizza a spostare pezzi di storia e di geografia: la Sardegna era Regno sabaudo, i responsabili del suo disastro culturale stavano a Torino, non a Napoli;
2) l’esclusione mostra, ce ne fosse ancora bisogno, che i Savoia non considerarono mai l’isola alla pari con il resto del loro paese, ma una colonia da cui attingere e a cui non dare; una terra altra («Gli stati» riassume il professor Pasquale Amato, in Il Risorgimento oltre i miti e i revisionismi «erano proprietà delle famiglie regnanti e potevano essere venduti, scambiati, regalati secondo valutazioni autonome di proprietari». Come fecero i Savoia con la Sicilia, la stessa Savoia, Nizza… Il principio fu riconfermato con la Restaurazione dell’Ancièn Regime, nel 1815, in Europa, per volontà del cancelliere austriaco Klemens von Metternich). E appena fu possibile, con l’Unità, la Sardegna venne allontanata quale corpo estraneo, come non avesse mai fatto parte del Regno sabaudo. Lo dico in altro modo: quando un’azienda è da chiudere, ma si vuol cercare di salvare il salvabile (con Alitalia, per dire, l’han fatto due volte), la si divide in due società; in una, la ”Bad Company”, si mettono tutti i debiti, il personale in esubero, le macchine rotte… Nell’altra, tutto il buono, che può ancora fruttare o rendere appetibile l’impresa a nuovi investitori: la si chiama ”New Company”.
L’Italia è stata fatta così: al Sud invaso e saccheggiato hanno sottratto fabbriche, oro, banche, poi gli hanno aggiunto la Sardegna, già ”meridionalizzata”. Nelle statistiche ufficiali, sin dal 1861, i dati della Sardegna li trovate disgiunti da quelli del Piemonte e accorpati a quelli della Sicilia, alla voce ”isole”, o sommati a quelli delle regioni del Sud, alla voce ”Mezzogiorno” (la Bad Company; mentre la New Company la trovate alla voce ”Centro-Nord”). Poi si chiama qualcuno a spiegare che la Bad Company è ”rimasta indietro”, per colpa sua (e di chi se no?). Ripeto: la psicologia spiega che la colpa non può essere distrutta, solo spostata. Quindi, il percorso segue leggi di potenza: dal più forte al più debole; dall’oppressore alla vittima. Chi ha generato il male lo allontana da sé e lo identifica con chi lo ha subito; rimproverandogli di esistere. È quel che si è fatto pure con la Germania Est e si vuol fare con il Mediterraneo.
LA PATRIA DELLA CORRUZIONE.
E' possibile avere un po' meno corruzione? Si Chiede Bruno Manfellotto su "L'Espresso". Non bastano leggi più severe o l’Autorità di Cantone. Questo rimane il paese dell’impunità. Tocca alla politica fare pulizia al suo interno. È luogo comune o verità che l'Italia sia il paese più corrotto d'Europa? Insomma, ciò che continuiamo a vedere, da Roma mafiosa a Ischia mazzettara, passando per il Mose, l'Expo, e un Pd percorso da bande, è ordinario tasso di corruttela - che ci vuoi fa', è la politica - o straordinaria quotidianità criminale? E qualora record fosse, perché? Prima di tutto, però, un paio di osservazioni. A dispetto delle statistiche, in Italia c'è ancora tanta stampa libera che pubblica ogni notizia che trova senza guardare in faccia a nessuno. Voi che leggete "l'Espresso" lo sapete bene. E così, se si smazzetta a Procida o a Venezia, si scrive, magari talvolta rinunciando a quella prudenza necessaria quando si fa informazione: ma davanti a certe notizie forse è meglio rischiare che tacere, no? Anche i magistrati fanno il loro mestiere e dispongono di uno strumento formidabile, le intercettazioni, capaci di svelare mondi inimmaginabili. Pure qui ci sono abusi, si sa, e grande è la responsabilità di pm e giornalisti nel distinguere il grano dal loglio senza calpestare i diritti di nessuno. E certo si può sbagliare, ma non è un caso che a ogni governo - e quello di Matteo Renzi non fa eccezione - corrisponda una riforma della giustizia che, immancabilmente, mette in discussione poteri dei magistrati e intercettazioni. Il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, le vorrebbe addirittura abolire. Come se nascondere i reati significasse cancellarli, un po' come fanno i bambini quando si tappano gli occhi convinti che così nessuno li veda. Già, ma perché la corruzione è così diffusa? Perché la politica ha perso le motivazioni che la muovono, ha risposto Marcello Veneziani in una lettera al "Corriere della Sera", quelle motivazioni politiche, civili e religiose che formano il sostrato di ogni civiltà. E con queste, ha aggiunto, si sono esaurite anche le spinte più personali, cioè l’ambizione di distinguersi e la voglia di veder riconosciuti i propri meriti. Infatti la corruzione dilaga lì dove non c'è meritocrazia. Osservazione condivisibile, ma allora bisogna chiedersi come si è arrivati a questa generale demotivazione politica e personale. Intendiamoci, che la corruzione possa essere sconfitta è impensabile, essa è insita nella natura umana e da che mondo è mondo appartiene alla politica, perfino come strumento necessario a conseguire i propri obiettivi. Ma da noi non è più questo. Già trent'anni fa Rino Formica, socialista, lamentava che «il convento è povero, ma i frati sono ricchi»; oggi, addirittura, si comincia a fare politica solo per affermare il proprio personale potere e, appunto, arricchirsi. Tra le tante cause del decadimento c'è, prima fra tutte, la mancata selezione della classe politica, viziata da liste elettorali bloccate - che riservano il potere di scelta a pochi ras - e da partiti squagliati, più che liquidi. E l'idea che la politica appartenga dunque a ristrette oligarchie autoreferenziali demotiva e allontana gli uomini di buona volontà. Devastante è stato poi il cattivo esempio di leader e dirigenti, anche di antica militanza, soliti camminare sul filo del rasoio, bravi a muoversi con arroganza in un'area grigia dove favoritismi e trattamenti di riguardo si mescolano a finanziamenti occulti, appalti pilotati, tangenti in natura. L'idea generalizzata che così fan tutti e che non ci sia altro modo per emergere, trovare un lavoro, avere successo ha prodotto incredibili fenomeni imitativi a tutti i livelli e cancellato quelle forme di controllo sociale con le quali ogni comunità pone un argine al degrado morale e civile. E non basta. Se qualche passo avanti è stato fatto con l'approvazione della legge Severino, con l'istituzione di un'autorità anticorruzione (Raffaele Cantone) e il ripristino del falso in bilancio, questo ahimè è ancora il paese non della certezza della pena, ma dell'impunità: come riassume Piercamillo Davigo, una volta si minacciava «ti faccio causa», oggi la sfida è «fammi causa». Non c'è un giudice a Berlino. Facile che, con tali premesse, prevalgano cinismo e rassegnazione. E però non c'è altro modo per ridare credibilità alla politica e alle istituzioni che impegnarsi a fondo per arginare il fenomeno. Prima che siano i corrotti a rottamare gli innovatori.
Ecco la mappa della corruzione disegnata dagli studenti. Il progetto coinvolge mille ragazzi: per mesi hanno raccolto dati e testimonianze sulla corruzione in Lazio, Campania e Lombardia. Produrranno un "Atlante" che la fotografa nei loro quartieri, scrive Manuel Massimo su “La Repubblica”. Da discenti a docenti: gli studenti del progetto per la legalità "Piccolo Atlante della corruzione", dopo aver indagato il fenomeno sul campo e raccolto in forma anonima le testimonianze dei soggetti a rischio, si stanno preparando alla lezione conclusiva di fine maggio che li vedrà protagonisti. Saranno proprio loro a salire in cattedra per "insegnare" quello che hanno imparato dai tutor e agli esperti che li hanno seguiti nel corso del laboratorio - ideato e promosso da Beatrice Ravaglioli del circolo "Libertà e Giustizia" di Roma, finanziato dal Miur, sostenuto attivamente dall'Autorità nazionale anticorruzione, dall'Associazione nazionale magistrati e in collaborazione con l'Università di Pisa e con Repubblica.it. I materiali prodotti dalle 15 scuole aderenti al progetto confluiranno nel "Piccolo Atlante della corruzione": una pubblicazione scaricabile gratuitamente online che potrà essere utilizzata anche dagli addetti ai lavori che ogni giorno combattono per la legalità. Questa seconda edizione del progetto (2015) - partito lo scorso anno in via sperimentale solo a Roma e nel Lazio e allargato quest'anno anche alla Campania e alla Lombardia - ha visto la partecipazione di oltre mille ragazzi, studenti delle scuole superiori, che hanno mappato la percezione del fenomeno "corruzione" nei territori accanto ai loro istituti grazie a questionari (somministrati anonimamente a una varietà di soggetti potenzialmente interessati dal problema, ndr) messi a punto seguendo le indicazioni del professor Alberto Vannucci, politologo e direttore del Master anticorruzione presso l'Università di Pisa. Non si è trattato di un modello di didattica calata dall'alto, ma piuttosto di un processo attivo di raccolta ed elaborazione dei dati, come spiega Vannucci: "Nelle fasi iniziali noi docenti ed esperti abbiamo fornito ai ragazzi gli strumenti d'indagine: poi sono stati loro a elaborare da soli il questionario mappando i settori più a rischio e diventando protagonisti". Dopo aver ascoltato dal vivo le testimonianze di giornalisti sotto scorta come Federica Angeli, cronista di nera e giudiziaria per Repubblica, gli studenti hanno intrapreso un percorso di studio sul campo, indagando nei meandri del sommerso e diventando giovani "sentinelle della legalità" anche in contesti difficili dove la presenza della criminalità organizzata è forte e si fa sentire. Ogni scuola ha elaborato autonomamente un questionario specifico, partendo da una base comune ma modellandolo sulle peculiarità del proprio territorio. Un'operazione che fornirà una mappa diversificata e territoriale della corruzione, partendo anche da casi concreti. L'elemento della comparazione è fondamentale in questo tipo di studi, ne è convinto il professor Vannucci che auspica un ulteriore allargamento del progetto: "Dopo l'esperienza-pilota dello scorso anno e questa seconda edizione che ha coinvolto anche altre due Regioni, da studioso del fenomeno spero che il progetto possa crescere ancora. I ragazzi coinvolti hanno sviluppato gli anticorpi per la legalità e maturato una fiducia critica nelle Istituzioni, perché troppo spesso la sfiducia radicale nasce dall'ignoranza ed è lì che bisogna andare a stimolare la presa di coscienza su determinati temi". Il "Piccolo Atlante della corruzione" sarà composto da 15 parti - una per ciascuna delle scuole coinvolte nel progetto itinerante per la legalità - e scatterà un'istantanea del fenomeno che potrà essere utilizzata come base di ulteriori indagini e approfondimenti della magistratura. Uno strumento utile, soprattutto oggi che la corruzione si è "smolecolarizzata" e troppo spesso riesce a passare inosservata, come sottolinea Vannucci con tre aggettivi: "Sotterranea, invisibile, impercettibile". Portare a galla il sommerso rappresenta dunque il primo passo per guardare dritto negli occhi il problema, prenderne coscienza e impegnarsi in prima persona per cercare di risolverlo. I tre incontri finali - uno in Lombardia, uno nel Lazio e uno in Campania - si stanno avvicinando e gli studenti sono pronti a salire in cattedra: l'appuntamento di Napoli è fissato per mercoledì 20 maggio a partire dalle ore 10 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Sannino-Petriccione"; già calendarizzato anche l'incontro di Roma, che si terrà la mattina di venerdì 29 maggio nell'aula magna dell'Università Sapienza, alla presenza tra gli altri del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone e con la partecipazione dell'attore Elio Germano. I ragazzi, sentinelle di legalità, hanno studiato la corruzione nelle strade che percorrono tutti i giorni per andare a scuola e ora sono pronti a salire in cattedra per parlarne in pubblico: un piccolo passo individuale per ciascuno, ma un grande esempio collettivo per tutti nella lotta alla corruzione.
Corruzione? Tutto il mondo è paese, scrive Alessandro Bertirotti su “Il Giornale”. È tutta questione di… disonestà. Abbiamo letto in molte classifiche che la nostra meravigliosa nazione è fra gli ultimi posti rispetto alla capacità di combattere la corruzione, e dunque ai primi per il numero di casi in cui tale reato è presente. E questo, ovviamente, assieme a molte altre cose non positive rappresenta per noi tutti un disonore, specialmente quando i rappresentanti di questo reato sono persone che vengono definite “onorevoli”. Scritto questo, è interessante sapere che anche nel mondo islamico esiste un divieto a procurare corruzione, come ad accettare di essere corrotti, e lo si legge nella seconda Sura. I corrotti sono coloro che non rispettano le leggi che Allah ha fornito agli uomini per vivere in pace fra loro; sono coloro che al posto di conciliare spargono divisioni e male per il prossimo; coloro che rubano, non sono leali e sfruttano la fiducia degli altri per il proprio personale tornaconto. Insomma, anche per il Corano questo comportamento viene profondamente sanzionato ed è considerato un vero e proprio oltraggio ad Allah, il quale giungerà a vendicarsi con questi suoi figli fedifraghi. Ebbene, qualche giorno fa, ho incontrato una persona che mi raccontava di essersi recato a Roma in una ambasciata di un Paese arabo, imbattendosi in un funzionario che per un documento ha rilasciato una ricevuta di Euro 25,00, chiedendone però 50,00. La motivazione è stata che, avendo la richiesta le caratteristiche dell’urgenza, vi era il costo aggiuntivo di 25,00 euro, fuori ricevuta, ovviamente. Bere oppure affogare, proprio come accade da noi quando andiamo da un professionista che non ci rilascia la ricevuta con il giusto prezzo pagato. Ho l’impressione che le classifiche che vengono stilate su questo tipo di comportamento umano, non tengano conto di quanto il concetto di corruzione sia diventato pervasivo, anche all’interno di quei paesi che ci sembrano tanto diversi da noi. E sono anche convinto che tale situazione sia rinvenibile in altri paesi, ad esempio in quelli del Nord Europa, perché la questione non è legata solo alla morale religiosa, ma anche a quello che ogni individuo pensa di se stesso. In sostanza, non lamentiamoci dei nostri ladri perché i ladri abitano l’intero mondo e non dipende dalla religione professata se una persona si comporta male con il mondo intero, quanto dall’asservimento che la mente umana, di qualsiasi cultura essa appartenga, accorda al dio denaro. È il dio denaro che governa come un Principe questo mondo, e servirlo significa dedicare molti atti della propria vita a comportamenti come questi, dimenticando che il libero arbitrio lo possiamo esercitare in tutte le cose della vita quotidiana, anche nelle più piccole.
LE BUGIE DEI POLITICANTI CHE SCHIAVIZZANO I NOSTRI GIOVANI.
Ecco come i politici manipolano i numeri. Da Berlusconi a Renzi, 20 anni di bugie. Dal milione di posti di lavoro al bonus di 80 euro, passando per tesoretti che appaiono e scompaiono e stime (come quelle Istat) su contratti e disoccupazione: sondaggi, tabelle e statistiche hanno invaso media e tv, e sono usate dai politici come strumento di propaganda. Così anche la matematica è diventata un'opinione, scrive Emiliano Fittipaldi su “L’Espresso”. Quando dà i numeri, Matteo Renzi sembra ispirarsi alla leggendaria lezione di economia di “The Wolf of Wall Street”. «Regola numero uno: nessuno (ok, se sei Warren Buffett allora forse sì), nessuno sa se la Borsa va su, va giù, di lato o in circolo», ragiona il broker Matthew McConaughey mentre spiega strafatto di coca a Leonardo DiCaprio come fare soldi e fregare i clienti. I dati e le cifre? «Sono tutto un “fughesi”, un “fugasi”, cioè falso, volante... polvere di stelle, non esiste, non tocca terra, non ha importanza, non è sulla tavola degli elementi, non è reale cazzo!». Ecco. A vedere le statistiche snocciolate dal premier e dai suoi ministri nelle ultime settimane, sembra che in Italia, come nel film di Martin Scorsese, la matematica sia diventata un’opinione, un luogo dove 2 più 2 può fare anche 5, 7 o 39, a secondo delle esigenze e degli esegeti del numero. Così, se un tesoretto da «1,6 miliardi» può apparire improvvisamente in un bel giorno di primavera e scomparire 48 ore dopo, per rinascere ancora (accresciuto o sgonfiato, a seconda dell’economista che ne scrive) in qualche dichiarazione al tg, e se le previsioni di crescita del Pil piazzate nel Documento di programmazione economica sembrano scientifiche quanto una partita a dadi, i dati sugli effetti del nuovo Jobs Act sono metafora perfetta dell’affidabilità delle tabelle che dominano il dibattito pubblico. Già: sia a fine marzo che a fine aprile il ministro Giuliano Poletti ha annunciato il miracolo, spiegando che la nuova legge aveva creato 79 e 92 mila contratti in più. Dopo una settimana l’Istat ha però certificato che il tasso di disoccupazione, proprio a marzo, ha raggiunto il suo massimo storico, toccando il 13 per cento. «I numeri non sono confrontabili», hanno spiegato fuori di sé da Palazzo Chigi. Oggi l'Istituto ha rilasciato un'altra sfilza di dati, stavolta trimestrali, che evidenzierebbero un boom (grazie al taglio delle tasse per chi assume) di contratti a tempo indeterminato. Insomma, ce più o meno lavoro di prima? Nemmeno i chiromanti e gli economisti più quotati finora ci hanno ancora capito nulla. Dal milione di posti di lavoro promessi da Silvio Berlusconi nel 1994 fino agli 80 euro del bonus Renzi, passando per l’ossessione europea del 3 per cento nel rapporto tra deficit e Pil, sono più di vent’anni che la dittatura dei numeri condiziona le elezioni, il confronto politico e, conseguentemente, l’evoluzione della società. La passione per le tabelle è diventata una moda e poi una malattia, un diluvio di cifre ci piove in testa tutti i santi giorni. «È vero. Il boom delle cifre è un fenomeno evidente, tangibile, ed è contestuale alla fine delle ideologie», spiega Ilvo Diamanti, ordinario all’università di Urbino che con dati e sondaggi ci lavora da sempre. «Durante la Prima Repubblica politica e partiti erano fondati su certezze granitiche, ma la fine della contrapposizione tra democristiani e comunisti, sommata al declino della fede religiosa, ha cambiato tutto. Le statistiche rappresentano una risposta alla crisi dei valori tradizionali, hanno riempito un vuoto, e sono diventate un totem». Scomparsi i fondamenti culturali e le visioni etico-morali su cui si disegnavano gran parte delle misure politiche e delle strategie sociali, dunque, la matematica e la statistica sono diventate il filtro più usato per rappresentare e analizzare la realtà. I politici, ovviamente, ci sguazzano dappertutto, ma sotto le Alpi lo fanno con accanimento e modalità che altrove non hanno attecchito: non è un caso che nel “Grande dizionario della lingua italiana” la locuzione «dare i numeri» vuol dire anche «apparire insincero, suscitare il sospetto di tramare un inganno, di agire con doppiezza, con fini reconditi». Di sicuro i numeri sono diventati un corredo indispensabile a ogni strategia comunicativa. Ma, oltre a dare sostegno alle chiacchiere e una parvenza di concretezza alle parole, in Italia vengono usati soprattutto per impressionare, suggestionare, muovere passioni, speranze e paure. Se nel contratto con gli italiani Berlusconi prometteva «l’innalzamento delle pensioni minime ad almeno un milione di lire al mese» e «la riduzione delle imposte al 23 per cento per i redditi fino a 200 milioni di lire annui», nel 2013 Bersani spiegò di voler restituire alle imprese «50 miliardi in 5 anni» in modo da diminuire i debiti della pubblica amministrazione. Il cavallo di battaglia di Beppe Grillo è, da sempre, il reddito minimo di cittadinanza «da mille euro al mese», mentre Matteo Salvini afferma, da giorni, che «un milione di immigrati è pronto a salpare dalla Libia per le nostre coste». Secondo il linguista Michele Porcaro, dell’università di Zurigo, c’è anche una strategia precisa nel dare i numeri, a seconda di cosa si vuole comunicare: la cifra tonda (un milione, un miliardo) «è in funzione di aggressione verbale», scrive l’esperto, «serve non a essere credibili, ma a suggestionare. Se si vuole suonare affidabili, invece, si usa la cifra esatta». In quest’ultimo caso, però, l’eccesso di pignoleria può causare effetti comici, come quando Berlusconi annunciò che durante il suo mandato a Palazzo Chigi «gli sbarchi di clandestini si sono ridotti del 247 per cento». Fosse stato vero, sarebbe addirittura un saldo negativo, sotto zero. Già nel 1954 Darrell Huff nel best seller “Mentire con le statistiche” spiegava che i politici hanno una tendenza innata alla manipolazione della matematica. Che in sé è oggettiva e non opinabile, ma la sua interpretazione è assai discutibile. Prendiamo il tasso di disoccupazione: un dato che dovrebbe essere obiettivo e invece dipende da decine di parametri: hai risultati diversi se consideri o meno gli scolarizzati, l’ampiezza della popolazione che misuri, puoi decidere se dare il tasso annuale, mensile, tendenziale. «Alla fine il politico sceglie quello che gli conviene maggiormente. L’ambizione primaria dei partiti non è quella di riformare il Paese, ma costruire consenso», spiega ancora Diamanti. «E i numeri sono invece facili da strumentalizzare. Io per primo, quando faccio sondaggi elettorali, so che il mio lavoro può essere usato come mezzo di condizionamento delle masse. Bisogna, proprio per questo, che gli studi siano autorevoli, e che i media sappiano discernere tra fatti e fattoidi». La propaganda non è l’unico modo in cui i politici e gli opinionisti stuprano le cifre. Altra caratteristica nazionale è quella di commentare fenomeni che non si conoscono a fondo, e imbastire analisi con numeri orecchiati al volo. «Nessuno studia, nessuno sa nulla, e così gli errori non si contano più. Anche perché ministri e deputati hanno mutuato dalla Borsa, sempre affamata di previsioni, una tendenza a pubblicare dati provvisori, che dopo poco tempo possono subire enormi revisioni», ragiona Giacomo Vaciago, economista all’Università Cattolica di Milano. «Questo avviene soprattutto in Italia, dove i politici hanno ormai una veduta non corta, come diceva Tommaso Padoa-Schioppa, ma cortissima: se esce un dato sull’occupazione o sul Pil, un sondaggio o uno studio dell’ultima associazione dei consumatori, il politico vuole subito commentarlo, in modo da comparire sui telegiornali delle 20, sui siti, sulla stampa e nei talk show. Pazienza se il dato è solo una stima che può cambiare dopo qualche giorno: mal che vada si fa sempre in tempo a tornare in tv e ricommentarlo, dicendo il contrario di quanto affermato prima. È tutta fuffa, una bolla, numerologia irrazionale. La cosa incredibile è che tutti noi ci viviamo in mezzo, a questa panna montata, come fossero sabbie mobili». Così non deve stupire che esperti vari, economisti, e persino i cervelloni di Bankitalia abbiano prodotto decine di interventi per spiegare come spendere al meglio il tesoretto da 1,6 miliardi di euro che dopo un po’ si è ridotto della metà, e che oggi rischia di scomparire mangiato da un nuovo buco miliardario causato dalla sentenza della Consulta che ha bocciato come incostituzionale quella parte della riforma Fornero sul blocco delle pensioni (anche qui si è passati da 5 a 13 miliardi di euro in due giorni appena). Un provvedimento che angosciò anche i cosiddetti esodati, lavoratori finiti in un limbo tra lavoro e pensione. Per mesi non si capì quanti fossero davvero: se il governo Monti li quantificò in 65 mila persone, l’Inps parlò inizialmente di 130 mila casi, lievitati in una seconda relazione tecnica a 390 mila, mentre il sindacato ne contò 300 mila. Nemmeno fossimo alla tombola di Natale. Se fin dalle scuole elementari i numeri danno ai futuri contribuenti un’illusoria garanzia di precisione, oggi gli italiani non riescono a sapere con certezza nemmeno quante tasse pagano: se il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha annunciato che il 2014 s’è chiuso con una riduzione della pressione fiscale, l’Istat - classificando il bonus da 80 euro come spesa sociale e non come riduzione del peso fiscale - ha fotografato invece un nuovo picco, arrivato al 43,5 per cento del Pil. Anche i numeri ballerini sulla spending review hanno intasato per mesi tv e giornali: se l’ex commissario Carlo Cottarelli parlò di tagli «per 8-14 miliardi», il governo Renzi ha recentemente ipotizzato «tagli per 10 miliardi». Alla fine, visto che gran parte degli impegni è rimasta solo su carta, la spesa pubblica ha continuato a crescere. Almeno così sostiene la Ragioneria dello Stato. Se le cifre hanno sostituito le ideologie, coloro che le maneggiano sono diventati i nuovi guru, i sacerdoti della modernità. «E i numeri», aggiunge Diamanti, «sono il nuovo dio: peccato che, per definizione, siano molto meno obiettivi e infallibili di quanto si creda». La voglia incontenibile di tabelle e grafici ha fatto esplodere la domanda di cifre e sondaggi già da qualche lustro, ma oggi, nell’era dei Big Data, la tendenza è ancora più evidente. La società chiede ai numeri le risposte alle domande che pone: decisioni aziendali, personali, politiche vengono prese innanzitutto su dati statistici. I numeri fanno ascolto, piacciono alla gente, e non è un caso che economisti ed esperti, veri o presunti, siano diventati star assolute della tv e del web: sondaggisti come Renato Mannheimer, Nicola Piepoli e Nando Pagnoncelli sono ospiti fissi nei talk, ascoltati e riveriti da politici e giornalisti come fossero la Sibilla Cumana (e pazienza se a ogni elezione le loro previsioni si dimostrano distanti dalla realtà); economisti come Tito Boeri hanno fondato siti di successo come lavoce.info e hanno fatto carriere importanti (Renzi l’ha nominato presidente dell’Inps, mentre cinque suoi redattori sono in aspettativa dopo aver ottenuto incarichi politici); piccole associazioni di artigiani, come la Cgia di Mestre, hanno pure creato un inedito business delle tabelle, grazie a un ufficio studi che macina centinaia di analisi e classifiche l’anno, riprese quotidianamente da agenzie di stampa e giornali. «Per fortuna non ho beccato neppure una smentita», disse il segretario Giuseppe Bortolussi in un’intervista a “Panorama”, dimenticando però le critiche arrivate da Asl, assessori comunali, Regioni ed economisti assortiti. «Questa associazione ha una buona notorietà, ma a volte dà i numeri», notò pure Marco Ponti, ordinario di Economia a Milano. «Non che i numeri che dà siano tecnicamente sbagliati, ma confonde tra di loro dati che non c’entrano affatto». Bortolussi, per la cronaca, ha ottenuto un ritorno d’immagine straordinario, e nel 2010 è stato anche candidato del Pd in Veneto alle regionali contro Luca Zaia. Il doping informativo ha travolto tutto, e non c’è fenomeno che non venga misurato e quantificato. Dal presunto boom dei suicidi degli imprenditori (bufala di cui i media si sono occupati per mesi) all’«inflazione percepita» in voga dopo il passaggio dalla lira all’euro, non c’è organismo o consorteria che non abbia un suo centro studi che macina dati e fornisce tabelle facendo concorrenza a Istat, Ocse e Eurostat: dai sindacati alla Confcommercio, da Confindustria al Codacons di Carlo Rienzi, dalle banche al Censis, il delirio di cifre su Pil, fatturati industriali, tasse, stime per la ripresa e crisi dei consumi non lascia tregua a nessuno, ventiquattro ore su ventiquattro. Vittima predestinata dell’overdose è ovviamente l’opinione pubblica, intontita da dati che alla lunga perdono di senso e di valore, in uno tsunami di matematica che, se da un lato allontana dalla verità, dall’altro distanzia le masse dalla politica, dalla televisione e dai giornali. Perché in tanti, ormai, cominciano a comprendere l’aforisma dell’ex primo ministro inglese Benjamin Disraeli: «Esistono tre tipi di bugie: le bugie, le bugie sfacciate e le statistiche».
Così sono aumentate le tasse sul lavoro. Ecco chi paga di più. E dove conviene emigrare. La pressione fiscale nel nostro Paese non vuole saperne di ridursi e ha raggiunto ormai una cifra record. Ma non tutte le categorie dei lavoratori sono vessate allo stesso modo. E il confronto con alcuni paesi europei è impietoso, scrive Davide Mancino su “L’Espresso”. La teoria è semplice - quasi banale: lo stato esiste per servire i propri cittadini. A volte invece succede il contrario, soprattutto nei momenti di difficoltà. Dall'inizio della crisi economica il conto è diventato sempre più salato, e a pagarlo sono state le tasse dei cittadini: anche quelle sul lavoro. I dati Ocse mostrano che rispetto al 2007, ultimo anno prima della crisi economica, tasse sul lavoro e contributi sono aumentate per quasi tutti i tipi di famiglie - per alcune molto più di altre. Prendiamo una famiglia con un solo coniuge che lavora e guadagna uno stipendio nella media - intorno ai 30mila euro lordi l'anno. Per loro, due figli e spina dorsale della classe media italiana, in sette anni il cuneo fiscale è passato dal 35,7 percento al 39 percento. Non ci vuole molto neppure per essere considerati ricchi: il secondo incremento più consistente è per i single senza figli con un reddito lordo sui 50mila euro - per un guadagno di circa 2.500 euro netti al mese -, che fra tasse e contributi passano al 53,8 percento contro il 51,4 percento del 2007. Aumentano le pretese dello stato anche verso i lavoratori single senza figli, nonché per le coppie in cui un coniuge ha reddito medio e l'altro invece molto basso, sui 10mila euro. Unica eccezione, i single con un reddito medio-basso, per i quali invece il cuneo fiscale è diminuito - anche se di poco. Eppure tassare il lavoro ha due effetti collaterali. Il primo - più evidente - è che sottrae reddito alle persone, così che ogni mese hanno meno da spendere o risparmiare. Il secondo è più sottile ma non meno importante: tanto più un datore di lavoro si trova costretto a pagare contributi elevati, tanto più sarà difficile mantenere i dipendenti che ci sono già - per non parlare di assumerne nuovi. È una cosa che può succedere a chiunque. Poniamo di aver bisogno di una persona che si occupi delle pulizie, qualcuno che badi a un anziano in famiglia. Se aumentano le tasse sul lavoro non ci sono molte alternative: o troviamo qualcuno che si accontenta di guadagnare poco - magari meno bravo -, oppure è necessario dargli uno stipendio più alto per compensare. E se salgono i contributi il risultato non cambia. Ma noi non siamo ricchi, né possiamo spendere troppo, soprattutto in tempi incerti come questi. Forse abbiamo soltanto qualcuno che dia una mano ogni tanto, senza troppe pretese. Così, invece di prendere qualcuno, lasciamo perdere e facciamo noi uno sforzo in più. Risultato: meno lavoro. L'esatto contrario di quanto sarebbe necessario mentre la disoccupazione cresce. Se invece confrontiamo l'Italia con altre nazioni europee la troviamo nel gruppo di quelle che il lavoro lo tassano di più. Allora forse non è un caso che tanti italiani decidano di trasferirsi a Londra, visto proprio in Gran Bretagna per un single senza figli e con un reddito medio-basso - una situazione comune per tanti giovani espatriati - tasse e contributi incidono per il 26 percento. Nella stessa identica situazione, per una persona nel nostro paese ammontano invece al 42 percento: un differenza che vale diverse migliaia di euro - ogni anno. Non sono l'unico gruppo: in generale nel Regno Unito il cuneo fiscale è più ridotto per tutti i tipi di famiglie e risulta generoso soprattutto verso i single con due figli a basso reddito, per i quali non arriva neppure al 6 percento. Anche in Spagna le famiglie sono meno pressate dalle tasse. Qui però la differenza maggiore con il nostro paese riguarda le coppie con figli e reddito medio basso, che sono più tutelate. Ma poiché in Europa il paese iberico è il più simile all'Italia - sotto tutti i punti di vista - sorprende trovare un sistema fiscale tanto diverso dal nostro. Francia e Germania, d'altra parte, hanno livelli di tassazione sul lavoro pressappoco equivalenti all'Italia. Non identici, però: se Londra sembra essere un rifugio per i giovani lavoratori, Parigi va in senso opposto - lì il cuneo fiscale per quel tipo di persone è persino più elevato che in Italia. La Germania è un caso a parte, e riesce ad avere allo stesso tempo tasse elevate e un livello di disoccupazione molto basso, anche per i giovani. Certo tasse e contributi sul lavoro sono una parte importante dei balzelli che cittadini e datori di lavoro devono versare allo stato, ma certo non gli unici. In realtà il loro aumento, negli ultimi anni, è andato di pari passo con una crescita generalizzata della pressione fiscale. Mentre la crisi imperversava già da tempo, Berlusconi rassicurava il paese. “I ristoranti sono pieni”, diceva ancora nel 2011, evitando di prendere misure - anche minime - per attenuare la gravità degli eventi. Così la situazione è diventata ancora più grave. Dopo di lui il governo tecnico di Monti, la cui manovra economica ha pesato di più proprio dal lato delle imposte: in questo modo l'Italia arriva ad avere una pressione fiscale pari al 43,5 percento del prodotto interno lordo. Ogni dieci euro prodotti dai 60 milioni di abitanti della penisola, quattro e 35 centesimi si trasformano in tasse dovute allo stato. È un livello mai raggiunto prima durante la Seconda Repubblica. Il governo guidato da Enrico Letta, più avanti, non modifica questo rapporto in maniera sostanziale. Né le cose cambiano con Renzi e il suo bonus di 80 euro, che secondo le convenzioni statistiche internazionali vale come ulteriore spesa pubblica - anch'essa a livelli record. Così si torna al punto di partenza mentre l'economia resta ferma, e con lei il reddito degli italiani - soprattutto di chi ha meno.
Cervelli in fuga, un problema non solo italiano. Ecco chi sono e dove vanno i nostri emigranti. Il nostro paese continua a "esportare" laureati, ma ha difficoltà ad attrarne. Scopri con le nostre infografiche interattive quali sono le mete principali e dove preferiscono andare quelli con la tua età e titolo di studio, scrive Davide Mancino su “L’Espresso”. Di italiani in giro per il mondo ce ne sono sempre di più, e su questo non c'è dubbio. Ma chi sono, e dove vanno esattamente? Secondo le stime prodotte dall'Ocse e aggiornate al 2010, con 450mila migranti gli Stati Uniti sono risultati come prima meta degli espatriati italiani. Seguono Francia (350mila), Germania (340mila), Canada (260mila), Svizzera e Australia (entrambe 185mila). Il flusso verso il Regno Unito si ferma a 140mila persone, mentre quello diretto in Spagna a 80mila. Altri gruppi più piccoli sono andati a cercare fortuna in Polonia, Irlanda o persino in Grecia, meno ancora nell'esotico Giappone. Anche i dati Istat, aggiornati fino al 2013, mostrano che negli ultimi anni i flussi di italiani che vanno via sono in aumento. Dal 2010 le cose non sembrano essere cambiate troppo e le destinazioni preferite restano, nell'ordine, Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia e Stati Uniti. Se però andiamo a guardare più in dettaglio, emergono preferenze molto specifiche a seconda dell'età, del sesso e del proprio titolo di studio. Per esempio paesi come Stati Uniti o Gran Bretagna sono le mete preferiti dei giovani laureati, soprattutto maschi. Chi ha un'istruzione inferiore tende invece a dirigersi spesso verso Germania, Spagna e Svizzera. Discorso diverso per la Francia, più in alto fra le destinazioni delle giovani donne laureate. Anche Australia e (soprattutto) Canada risaltano per ospitare un nutrito gruppo di italiani. Di questi buona parte è composta da anziani a bassa scolarizzazione: due mete molto diffuse per le migrazioni del dopoguerra, e che però ora sembrano attrarre meno chi decide di andare via. Quando si parla di emigrazione proprio i laureati sono una delle categorie cui prestare più attenzione. Una maggiore cultura è in sé un valore aggiunto, impossibile negarlo, e poi c'è un elemento in più. Tracciarne le migrazioni è un utile indizio per capire quali sono i paesi più dinamici, aperti al cambiamento e alle nuove idee: da dovunque esse vengano. Il discorso vale anche al contrario, per stabilire i luoghi più ambiti da parte di chi lascia il proprio paese natale. Qual è allora la situazione in Italia? Sono pochi, pochissimi gli arrivi di laureati. E in effetti proprio l'Ocse, in uno studio preliminare , conferma che in quanto a capacità di attirare talenti l'Italia fa peggio di tutti gli altri paesi con cui, in teoria, vorrebbe confrontarsi. Senza neppure voler citare Regno Unito e Stati Uniti, dove rispettivamente il 46 e il 30 per cento dei migranti sono laureati, anche il 24 per cento della Spagna sembra un miraggio e all'Italia tocca invece fermarsi appena sopra il 10 per cento. Da notare anche Francia (24 per cento) e Germania (20 per cento), che in questo gioco riescono meno bene di quanto ci si potrebbe aspettare. Un altro modo di guardarla è contare quanti sono i laureati che arrivano rispetto a quelli che vanno via – il loro “ricambio”, se così lo vogliamo chiamare. Qui gli Stati Uniti restano la calamita globale: nessuno vuole andare via, mentre molti altri arrivano. Anche l'Australia, seconda in classifica e che pure non se la cava male, resta comunque molto più indietro, mentre altre mete attraenti per i laureati sono Israele, il Canada e la Spagna. E l'Italia? Il bilancio è appena positivo, e comunque molto inferiore a Francia, Germania e Regno Unito. Altrove però va peggio e si verifica una perdita complessiva di laureati: in Irlanda e Giappone, per esempio, oppure in Finlandia o Islanda dove per ogni due titolati che hanno lasciato il paese ne è arrivato solo uno a sostituirli. Attirare cervelli è come cercare di riempire una piscina: conta l'acqua nuova che arriva dall'esterno, attraverso i rubinetti, ma anche quella che scappa via dalle crepe. Per l'Italia il problema non sembra essere tanto il liquido che sfugge: le analisi Ocse mostrano che il tasso di emigrazione dei laureati nel 2010 era dell'8,4 per cento, più elevato di quello spagnolo (2,5 per cento) o francese (5,7 per cento), ma molto inferiore a quello inglese (10,5 per cento) e in linea con la Germania (8,8 per cento). Pare piuttosto che qualcuno ci abbia tagliato le forniture perché venire a nuotare, alla fine, non interessava a nessuno.
Nota: i dati sono stime che fanno riferimento all'immigrazione nei paesi Ocse fino al 2010. In alcuni casi le statistiche escludono coloro di cui non è stato possibile rilevare età, paese di provenienza o titolo di studio. È del tutto probabile, dunque, che i valori reali siano leggermente più elevati.
"Schiavi" italiani in Australia? Sì, ma legali. E invece di indignarci dovremmo imitarli. Un'inchiesta tv ha denunciato casi di schiavismo nelle campagne dell'isola oceanica. Gli sfruttati sono però solo una piccola parte del totale e il sistema di Canberra offre ai migranti molte più garanzie del nostro, scrive Stefano Vergine su “L’Espresso”. «L'odissea dei giovani schiavi italiani. Undici ore a notte, a raccogliere cipolle». L'articolo pubblicato dal “Corriere della Sera” racconta il risultato di un'inchiesta giornalistica condotta dalla popolare trasmissione televisiva australiana “Four Corners”. Un programma che ha squarciato il velo, nella terra dei canguri, sulle migliaia di giovani europei che finiscono a lavorare gratis nelle fattorie. Tutto vero. Per gli australiani meno informati è stato sicuramente uno shock scoprire che nel loro Paese ci sono persone praticamente schiavizzate, raccoglitori di quei prodotti che finiscono poi nei supermercati di Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin e delle altre cittadine sparse per l'immensa isola dell'Oceania. Ma le cose sono un po' più complicate di come appaiono. Ovvero: per tanti che hanno denunciato condizioni di sfruttamento, ce ne sono almeno altrettanti contenti dei loro tre mesi di vita agreste. Perché, a differenza di quanto succede in Italia con gli extracomunitari, di fatto costretti all'illegalità oltre che talvolta schiavizzati, in Australia i tre mesi di lavoro in campagna danno diritto a un regolare permesso di soggiorno. L'inchiesta in questione si è concentrata sul visto vacanza-lavoro, il “working holiday visa” . Rilasciato solo a cittadini di alcune nazioni industrializzate, con età compresa tra i 18 e i 31 anni, costa poche centinaia di euro e permette di stare in Australia per un anno lavorando a tempo pieno, estendendo la permanenza di un altro anno se il migrante è disposto a svolgere per tre mesi alcune mansioni come l'agricoltore o l'allevatore. Si può decidere di farlo percependo uno stipendio (le paghe variano dai 10 ai 25 dollari australiani all'ora), oppure prestare la propria opera gratuitamente, in cambio di vitto e alloggio. Nel 2014, scrive il “Corriere” della Sera citando i dati del dipartimento per l'Immigrazione australiana, nel Paese c'erano più di 145 mila giovani con questo tipo di visto, oltre 11 mila dei quali italiani. I casi di sfruttamento sono stati ben documentati dalla tv australiana. E pure il "Corriere" ha dato conto di alcuni esempi, come quello di due ragazze che, impiegate in un'azienda agricola, raccoglievano cipolle rosse «dalle sette di sera alle sei di mattina, anche quando pioveva o faceva freddo». Il fatto è che quelli evidenziati da “Four Corners” sono solo i casi sfortunati. Chi scrive ha potuto sperimentare in prima persona il working holiday visa australiano. E può assicurare che molti europei, fra cui parecchi italiani, non hanno subìto alcun tipo di sfruttamento. Certo, con questo sistema le aziende locali beneficiano della manodopera straniera a basso costo, ma c'è un altro lato della medaglia da considerare. Grazie a questa politica migratoria, gli italiani e i tanti altri cittadini stranieri che vogliono emigrare in Australia possono farlo legalmente. Fanno la richiesta di visto online, vanno a lavorare per tre mesi in campagna, pagati oppure solo compensati con il vitto e l'alloggio, e in questo modo si guadagnano la possibilità di restare nel Paese per un secondo anno (in realtà, come ricorda il “Corriere”, il governo di Canberra ha recentemente deciso di concedere l'estensione del visto solo a chi viene pagato per lavorare). La sostanza però non cambia. Invece di costringerli ad entrare illegalmente, come avviene oggi per i tanti extracomunitari che continuano ad arrivare sulle nostre coste, adottando una politica migratoria simile a quella del "working holiday visa" si permetterebbe ai migranti di avere due anni di visto per stare nel Paese, tempo utile per imparare la lingua e trovarsi un lavoro. Al contempo, le aziende italiane beneficerebbero di manodopera a basso costo, come peraltro già avviene. Ma tutto questo avverrebbe in modo legale, mentre oggi da noi le campagne sono ancora teatro di uno sfruttamento ben più pesante rispetto a quello visto nei casi raccontati dalla tv australiana.
Australia, ecco i giovani «schiavi» italiani: undici ore a notte, a raccogliere cipolle nei campi. 15 mila giovani italiani si trovano nel Paese con un visto di «Vacanza Lavoro» rinnovabile dopo un anno. Molti subiscono ricatti, abusi e perfino violenze sessuali, scrive di Roberta Giaconi su “Il Corriere della Sera”. Oltre 15.000 giovani italiani si trovano attualmente in Australia con un visto temporaneo di «Vacanza Lavoro». Hanno meno di 31 anni e, spesso, una laurea in tasca. Alla partenza, molti di loro neppure immaginano di rischiare condizioni di aperto sfruttamento, con orari di lavoro estenuanti, paghe misere, ricatti, vere e proprie truffe. Perlopiù finiscono nelle «farm», le aziende agricole dell’entroterra, a raccogliere per tre lunghi mesi patate, manghi, pomodori, uva. L’ultima denuncia arriva da un programma televisivo australiano, «Four Corners», durante il quale diversi ragazzi inglesi e asiatici hanno raccontato storie degradanti di molestie, abusi verbali e persino violenze sessuali. Gli italiani non sono esclusi da questa moderna «tratta». Ne sa qualcosa Mariangela Stagnitti, presidente del Comitato italiani all’estero di Brisbane. «In un solo anno ho raccolto 250 segnalazioni fatte da giovani italiani sulle condizioni che avevano trovato nelle “farm” australiane. Alcune erano terribili», spiega. Due ragazze le hanno raccontato la loro odissea in un’azienda agricola che produceva cipolle rosse. Lavoravano dalle sette di sera alle sei di mattina, anche quando pioveva o faceva freddo. «Non potevano neanche andare in bagno, dovevano arrangiarsi sul posto», dice Stagnitti. Un ragazzo, invece, era stato mandato sul tetto a pulire una grondaia piena di foglie. «È scivolato ed è caduto giù, ferendosi gravemente. L’ospedale mi ha chiamata perché il datore di lavoro sosteneva che aveva fatto tutto di sua iniziativa». Secondo i dati del dipartimento per l’Immigrazione, nel giugno dell’anno scorso in Australia c’erano più di 145.000 ragazzi con il visto «Vacanza Lavoro», oltre 11.000 dei quali italiani. E il nostro è uno dei Paesi da cui arriva anche il maggior numero di richieste per il rinnovo del visto per un secondo anno. Per ottenerlo, questi «immigrati temporanei» hanno bisogno di un documento che attesti che hanno lavorato per tre mesi nelle zone rurali dell’Australia. E questo li rende vulnerabili ai ricatti. «Ho sentito di tutto», dice Stagnitti. «Alcuni datori di lavoro pagano meno di quanto era stato pattuito e, se qualcuno protesta, minacciano di non firmare il documento per il rinnovo del visto. Altri invece fanno bonifici regolari per sembrare in regola, ma poi obbligano i ragazzi a restituire i soldi in contanti. E poi ci sono i giovani che accettano, semplicemente, di pagare in cambio di una firma sul documento». Non sono in molti a denunciare la situazione. «Quando mi chiedono cosa fare, io consiglio loro di non accettare quelle condizioni e di chiamare subito il dipartimento per l’Immigrazione, ma i ragazzi non lo fanno perché hanno paura di rimetterci. Tanti mi dicono che ormai sono abituati: anche in Italia, quando riuscivano a lavorare, lo facevano spesso in nero e sottopagati». Stagnitti alza le spalle. «La verità è che spesso questi giovani in Italia sono disoccupati, senza molte opzioni, per questo vengono a fare lavori che gli australiani non vogliono più fare». Sulla scia della denuncia di «Four Corners», il governo dello stato di Victoria ha annunciato che darà il via a un’inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle «farm», con l’obiettivo di stroncare gli abusi e trovare nuove forme di regolamentazione che mettano fine allo sfruttamento. Intanto, proprio nei giorni scorsi, il Dipartimento per l’Immigrazione ha deciso che il cosiddetto «WWOOFing», una forma di volontariato nelle azienda agricole in cambio di vitto e alloggio, non darà più la possibilità di fare domanda per il secondo anno di visto «Vacanza Lavoro». «Nonostante la maggior parte degli operatori si sia comportata correttamente - si legge in un comunicato stampa - è inaccettabile che alcuni abbiano sfruttato lavoratori stranieri giovani e vulnerabili».
MINISTRI. UNA IMPUNITA' TUTTA PER LORO.
Indagare i ministri è diventato impossibile. Così una legge vergogna difende la Casta. Tremonti e Matteoli sono sotto accusa per corruzione, ma una norma soccorre i politici di governo. E le uniche condanne risalgono a Tangentopoli, scrive Paolo Biondani su "L'Espresso". Altero Matteoli e Giulio Tremonti Vietato indagare sulla casta di governo. Nell’Italia saccheggiata da una corruzione enorme, c'è uno scudo legale che protegge proprio i politici con più poteri: i ministri che controllano le casse centrali della spesa pubblica. In questi mesi di crisi e lotta agli sprechi, i magistrati di Venezia e di Milano hanno rimesso in moto la speciale procedura per i reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Giulio Tremonti e Altero Matteoli, esponenti di spicco dei governi di Silvio Berlusconi, sono accusati di corruzione. Come tutti gli indagati, fino a prova contraria vanno considerati innocenti. Anche perché la legge in vigore non impone più rigore e più controlli per chi conta di più, ma il contrario: come parlamentari, non possono essere intercettati, perquisiti e tantomeno arrestati; e come ministri, godono di privilegi speciali, tutti per loro. Che nella storia italiana hanno quasi sempre salvato i governanti. I condannati per reati ministeriali sono pochissimi. E gli ultimi casi risalgono ai tempi di Mani Pulite. Prima e dopo quel periodo eccezionale, decine di accuse sono state azzerate da un veto politico: stop alle indagini, con tanti saluti alla giustizia. Le inchieste sui ministri sono regolate da una disciplina che alcuni giuristi paragonano a un «fossile legale» dei tempi del vecchio codice: la legge costituzionale numero 1 del 16 gennaio 1989. «È una normativa tecnicamente incredibile: sembra fatta apposta per garantire l'impunità», sintetizza uno dei magistrati che hanno condotto le nuove inchieste. Il privilegio più vistoso è l'autorizzazione a procedere: il ministro può essere processato solo con il permesso della Camera, se è un onorevole, o del Senato. Dietro questo muro legale, trovano riparo anche i coimputati di ogni sorta: imprenditori, burocrati, faccendieri, eventuali complici mafiosi. Se il Parlamento nega l'autorizzazione, si salvano tutti. «Una vera assurdità tecnica», secondo diversi magistrati, è il comma di legge che regola l'avvio dell'inchiesta. Quando una Procura scopre un ipotetico reato ministeriale, non può fare niente: «omessa ogni indagine», come prescrive l'articolo 6, i pm devono liberarsi del fascicolo «dandone immediata comunicazione» a tutti i sospettati. Per i normali cittadini le Procure possono, anzi devono tenere segreta l'inchiesta almeno nei primi sei mesi, per evitare che l'indagato possa far sparire i soldi o inquinare le prove. Per i ministri e i loro complici, la regola è rovesciata: preavviso immediato a tutti gli indagabili, fosse anche un caso di omicidio, mafia o droga. Messi così in allarme i sospettati, l'inchiesta va affidata a tre giudici estratti a sorte tra tutti i magistrati del distretto, anche se non hanno mai fatto indagini, riuniti nel cosiddetto tribunale dei ministri: un collegio che ricorda i vecchi giudici istruttori, aboliti da un quarto di secolo. Il collegio ha solo 90 giorni per concludere tutta l'inchiesta, prorogabili di altri 60 al massimo. In tempi così brevi è praticamente impossibile fare rogatorie, ad esempio, per trovare l'eventuale bottino nascosto all'estero. Alla fine, se il tribunale archivia, il verdetto è «inoppugnabile». Se invece chiede l'autorizzazione al processo, il Parlamento può negarla anche se il reato è provato, «qualora reputi che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato»: un alibi politico «insindacabile», per cui regge anche se è falso. Con regole del genere, non meraviglia che i ministri condannati si riducano a pochi sfortunati. Il primo e per anni unico fu Mario Tanassi, socialdemocratico, condannato a due anni e quattro mesi, il primo marzo 1979, dalla Corte Costituzionale con il vecchio rito: una sola sentenza autorevolissima e inappellabile. Era il fronte italiano dello scandalo Lockheed, innescato da un'inchiesta degli Stati Uniti che il nostro Paese non poteva ignorare: come ministro della Difesa, Tanassi fu corrotto con 560 milioni di lire per sbloccare l'acquisto di 14 aerei militari costosissimi. La legge del 1989 è nata proprio per garantire a ministri come lui i soliti tre gradi di giudizio. E così è toccato al tribunale dei ministri, appena creato, indagare sulle "carceri d'oro": le tangenti confessate a Milano, dopo l'arresto, dall'imprenditore Bruno De Mico. Il suo processo si è chiuso nel 1994 con la condanna definitiva a cinque anni, per concussione, dell'ex ministro Franco Nicolazzi, anche lui del Psdi, che aveva intascato 2,5 miliardi di lire. In quel periodo era diventato normale concedere l'autorizzazione a procedere, che nel 1993, al culmine di Tangentopoli, è stata abolita per i semplici parlamentari. Tra i ministri, il condannato più illustre è Francesco De Lorenzo, liberale, titolare della sanità dal 1989 al 1992, condannato a cinque anni e quattro mesi per decine di tangenti, per un totale accertato di 4,5 milioni di euro, sborsate dalle industrie farmaceutiche da lui favorite. Dopo Mani Pulite, invece, le indagini sui governi sembrano fermarsi. Per tutto il ventennio dominato da Berlusconi, la procedura per i reati ministeriali diventa un muro di gomma. Alcune procure archiviano sul nascere decine di fascicoli. E quando il tribunale dei ministri conferma qualche accusa, interviene il Parlamento. Tra i casi più clamorosi spicca il salvataggio politico di Pietro Lunardi, l'ex ministro delle grandi opere, accusato di corruzione con il cardinale Crescenzio Sepe. Nel 2010 il tribunale dei ministri conclude che Lunardi ha acquistato a prezzo bassissimo un palazzo di lusso dall’ente religioso Propaganda Fide, che intanto otteneva cinque milioni di euro dal governo«in assoluta carenza dei presupposti». I magistrati invocano per quattro volte l'autorizzazione a procedere, ma il parlamento le blocca una dopo l'altra chiedendo sempre «approfondimenti». Nello stesso periodo beneficia dello stop politico al processo anche il ministro Matteoli, accusato di favoreggiamento per aver rivelato a un amico prefetto che era sotto intercettazione per tangenti su speculazioni edilizie all'Isola d'Elba. Dopo la bocciatura del lodo Alfano, (che avrebbe sospeso i processi al premier) l'immunità ministeriale è stata invocata pure nel caso Ruby: Berlusconi, secondo la sua maggioranza, telefonò in questura per far rilasciare la minorenne marocchina agendo da premier, perché credeva veramente che fosse la nipote di Mubarak. Quindi la Camera ha votato un conflitto di attribuzioni, ma la Corte Costituzionale, il 12 aprile 2012, ha dato ragione alla Procura di Milano, scrivendo che «era obbligata a indagare». Pochi ricordano che anche Giulio Andreotti, dopo una carriera costellata di mancate autorizzazioni a procedere, tentò di sottrarsi allo storico processo di Palermo per complicità con la mafia (poi chiuso con la prescrizione fino al 1980 e l'assoluzione per gli anni successivi) accampando la competenza del tribunale dei ministri di Roma. Ma i giudici hanno replicato che Andreotti era sotto accusa solo come capo-corrente della Dc. Ora si ricomincia da due. La nuova Camera ha già autorizzato il processo a Matteoli: i padroni del Mose di Venezia hanno confessato di avergli versato 550 mila euro, oltre a dover inserire una sua società, intestata secondo l'accusa a un prestanome, nei maxi-finanziamenti per disinquinare Porto Marghera. E al Senato pende la richiesta di procedere contro Tremonti per una presunta corruzione targata Finmeccanica: 2,6 milioni di euro mascherati da parcella per il suo studio professionale. Il tribunale dei ministri ha firmato un atto d’accusa che sembra quasi una sentenza di condanna. Ma l’affare è del 2008/2009, per cui Tremonti potrà comunque approfittare della vecchia, cara legge sulla prescrizione.
PER GLI ONOREVOLI...NON C'E' FRETTA.
Onorevole inquisito? Non c'è fretta. La melina delle Camere che rallenta i giudici. Due anni di attesa per le intercettazioni di Verdini. Quasi uno per quelle dell'Ncd Azzollini. Sei mesi (finora) per l'autorizzazione nei confronti dell'ex ministro Matteoli e tempi ancora vaghi per le offese di Calderoli alla Kyenge. Quando è indagato un suo componente, il Parlamento se la prende comoda, scrive Paolo Fantauzzi su "L'Espresso". Paragonare un ministro di origini congolesi a un orango è un'opinione insindacabile espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari? Comunque la pensiate, sappiate ci vuole molto tempo prima di stabilirlo. Pure se, dopo un'istruttoria durata settimane e settimane, per decidere ci vorrebbe assai poco. E per autorizzare la magistratura a procedere nei confronti di un ex ministro accusato di aver intascato mezzo milione di euro? Possono volerci anche sei mesi. Troppo? Sciocchezze, perché come niente si può arrivare anche a un anno o due di attesa. Parafrasando Bogart, sono i tempi dell'immunità parlamentare, bellezza. Un istituto pensato per proteggere deputati e senatori dal rischio di intenti persecutori della magistratura, trasformatosi col tempo in un tribunale preventivo preoccupato più che altro di salvarli dai processi. Ma a regalare anzitempo generose assoluzioni non c'è solo questo scudo giudiziario, che ha trasformato l'immunità in impunità e portato a respingere nella Seconda repubblica il 90 per cento delle richieste di arresto avanzate dai giudici . Prima ancora di arrivare a un verdetto, qualunque sia, si assiste infatti puntualmente a una sorta di "melina" calcistica che dilata a dismisura i tempi. Il caso di Denis Verdini è emblematico: il Parlamento ci ha messo due anni prima di concedere l'uso delle sue intercettazioni nell'inchiesta sulla P4, in cui è accusato di corruzione. Era maggio 2012 quando il gup Cinzia Parasporo ha trasmesso alla Camera la richiesta di usare una trentina di telefonate captate indirettamente tra l'allora deputato, che in quanto tale non poteva essere intercettato, e la "cricca" delle Grandi opere (Angelo Balducci, Fabio De Santis e Riccardo Fusi). La Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio aveva anche espresso parere positivo e nel giro di un mese era tutto pronto. Bastava solo trovare uno spazio nel calendario dei lavori d'Aula. Invece, nonostante ci fossero mesi e mesi a disposizione, niente da fare. Risultato: la legislatura è finita, Verdini è stato eletto senatore e ad aprile 2013 il gup ha dovuto di nuovo trasmettere gli atti, stavolta a Palazzo Madama. Dove, come al gioco dell'oca, si è ripartiti da zero. E prima del via libera è trascorso un altro anno. Grosso modo lo stesso lasso di tempo necessario a rispondere "no" al gip di Trani che chiedeva di usare una decina di intercettazioni indirette del senatore Ncd Antonio Azzollini, inquisito per la presunta truffa dell'ampliamento del porto di Molfetta . Una vicenda che mostra la mera ragion politica che si cela a volte dietro alcune scelte: per salvare il potente parlamentare alfaniano e in questo modo la stabilità del governo, con una decisione senza precedenti il Pd - come ha rivelato l'Espresso - ha addirittura convocato una riunione d'emergenza. E dire che in Giunta si era già visto di tutto: 11 sedute in 7 mesi, due richieste di integrazioni istruttorie chieste al giudice e altrettante audizioni del senatore, perfino una disputa sulle date in cui erano iniziati gli ascolti. Alla fine, dopo dieci mesi di passione, il Senato ha negato l’autorizzazione: era chiaro che mettendo sotto controllo i telefoni degli altri indagati i pm avrebbero intercettato anche il parlamentare, ha motivato nella sua relazione il senatore Pd Claudio Moscardelli. Ma se quelli di Verdini e Azzollini sono i più eclatanti, i casi sono numerosissimi. Sono passati sei mesi, ad esempio, da quando è arrivata in Senato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Ambiente Altero Matteoli, che secondo i pm dell’inchiesta sul Mose avrebbe ricevuto tangenti per 550 mila euro fra il 2001 e il 2012. Sarebbe bastata qualche ora per votare, visto che la relazione istruttoria sulla vicenda è pronta dal 10 febbraio. Solo che per settimane nessuno si è preoccupato di farla mettere all'ordine del giorno dell’Aula. Che si è occupata di tutt’altro, fra decreti in scadenza da convertire, emergenze, mozioni varie e perfino la richiesta di dimissioni di fuoriusciti del Movimento cinque stelle. Adesso, dopo qualche pressing informale, il presidente Piero Grasso ha finalmente fissato la data: il 2 aprile. Intanto, nel corso di un'audizione sugli appalti, si è assistito al paradosso di un presidente di commissione accusato di corruzione (Matteoli) seduto accanto al presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone. Ancora tempi lunghi si prevedono invece per gli epiteti di Roberto Calderoli rivolti nel luglio 2013 all’allora ministro dell’Integrazione: «Ogni tanto, smanettando con internet, apro il sito del governo e quando vedo venire fuori la Kyenge io resto secco. Io sono anche un amante degli animali per l’amore del cielo. Ho avuto le tigri, gli orsi, le scimmie e tutto il resto. Però quando vedo uscire delle sembianze di un orango, io resto ancora sconvolto». Diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale, secondo i pm bergamaschi Maria Cristina Rota e Gianluigi Dettori. Ma non per la Giunta di Palazzo Madama, che col voto determinante di alcuni senatori Pd si è espressa per lo stop al processo. Adesso resta da vedere se, dopo le polemiche, l'Aula ( e soprattutto il Pd ) confermerà o ribalterà il parere espresso. Intanto le cose vanno per le lunghe: la relazione, affidata al forzista Lucio Malan, è pronta dal 25 febbraio ma la questione non ha ancora trovato posto nel calendario dei lavori.. «Calderoli - vi si legge - ha utilizzato, all'interno di un articolato intervento sull'immigrazione fortemente critico, un'espressione forte, ma fatta esclusivamente come battuta ad effetto, visto che il contesto, oltre che politico, era anche ludico e cioè quello di una festa estiva organizzata». Insomma, uno scherzo. Quindi niente processo. Non sono state poste all'ordine del giorno nemmeno le 13 telefonate e 68 sms dell’ex senatore Pd Antonio Papania che secondo la Procura di Trapani proverebbero la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio: tra il 2010 e il 2012 l’allora parlamentare avrebbe ricevuto “in più occasioni utilità consistite nell’assunzione di numerose persone a lui gradite e da lui segnalate”. Ma la vicenda è oggetto di un ping pong che si trascina da mesi. Le carte sono arrivate a Palazzo Madama a giugno ma se ne è iniziato a discutere solo a ottobre. A dicembre il caso è approdato in Aula ma per una questione formale il fascicolo è stato rimandato in Giunta. Sono trascorsi altri tre mesi e da qualche settimana è tutto pronto per il voto dell’Assemblea. Ma tutto è ancora fermo. Va riconosciuto che quando si tratta di arrestare un parlamentare le Camere riescono a essere più celeri: per acconsentire a mandare dietro le sbarre i deputati Giancarlo Galan (Forza Italia) e Francantonio Genovese (Pd), come chiesto dai giudici, ci sono voluti “solo” due mesi. In ogni caso moltissimo se si considerano le motivazioni che richiedono la carcerazione: pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. Insomma, se i rischi sono tali, a ben vedere neppure otto settimane sono così poche. Tanto più che, a giudicare dalle date, nemmeno in queste circostanza di estrema urgenza il Parlamento pare essere stato particolarmente solerte nella rispondere alla magistratura. La relazione che concedeva l'arresto di Galan per corruzione, ad esempio, è rimasta ferma una dozzina di giorni prima di arrivare in Aula: dal 10 al 22 luglio 2014. Nel caso di Genovese - accusato di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, emissione di fatture false e associazione a delinquere - le carte sono arrivate da Messina il 18 marzo 2014 ma la Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio ha iniziato l’esame solo il 26 e la seconda seduta si è tenuta il 10 aprile, dopo altre due settimane. Poi, siccome c'è stata Pasqua di mezzo, altre due settimane di stop. Casi eccezionali? Non proprio. Nella scorsa legislatura, quando fu raggiunto il record di 11 richieste di arresto nei confronti di parlamentari, i tempi sono stati grosso modo gli stessi. Nel 2008 ci vollero tre mesi e mezzo prima di votare (contro) la richiesta di domiciliari per il pidiellino Nicola Di Girolamo. E oltre due mesi prima di respingere l'arresto dell'imprenditore Antonio Angelucci, di Vincenzo Nespoli, del consigliere del ministro Tremonti, Marco Milanese, e consentire quello di Alfonso Papa (tutti del Pdl). Due mesi per arrestare Alberto Tedesco (Pd) e un mese e mezzo per mandare ai domiciliari Sergio De Gregorio (Pdl) e in carcere Luigi Lusi (Pd). Unica eccezione, quella del deputato Pd Salvatore Margiotta: nel 2008 la Camera impiegò appena due giorni per respingere la richiesta di arresti domiciliari, avanzata dal pm Henry John Woodcock nell'ambito dell'inchiesta per la realizzazione del Centro oli della Total in Basilicata. Per quelle accuse (turbativa d’asta e corruzione) lo scorso dicembre il parlamentare dem, adesso senatore, è stato condannato in Appello a un anno e sei mesi.
Casta, così l'immunità parlamentare è diventata lo scudo contro arresti e processi. Dal 1994 Montecitorio e Palazzo Madama hanno respinto il 90 per cento delle richieste di carcerazione o di domiciliari avanzate dai giudici. E negato spesso l’uso di intercettazioni e tabulati, sempre per un presunto fumus persecutionis nelle indagini. Una “protezione” che con il nuovo Senato sarà estesa a sindaci e consiglieri regionali, scrive Paolo Fantauzzi su "L'Espresso". Immunità anche per i “nuovi” senatori. Dopo critiche, proteste, smentite e pressioni varie, alla fine lo scudo giudiziario sarà esteso anche ai sindaci e ai consiglieri regionali che approderanno a Palazzo Madama. E come avviene per i deputati, servirà un’autorizzazione per arrestarli, intercettarli ed effettuare perquisizioni nei loro riguardi. Eppure, se vorrà evitare che finisca col lancio di monetine come durante Tangentopoli, il governo farebbe bene ad approfittare della riforma costituzionale per congegnare un sistema che eviti gli abusi degli ultimi due decenni. Senza contare il caso Galan , in merito al quale Montecitorio non si è ancora espresso, su 31 richieste di arresto avanzate dai giudici nell’arco di questo ventennio - ha ricostruito l’Espresso - 28 sono state respinte. Nove volte su dieci, in pratica, Camera e Senato hanno ritenuto viziate da fumus persecutionis le istanze della magistratura di mandare in carcere o ai domiciliari un parlamentare. Un dato che mostra come la riforma dell’articolo 68 della Costituzione varata nel 1993 sull’onda di Mani pulite non sia servita a granché. Così se nella Prima Repubblica, senza il via libera della Camera di appartenenza, un onorevole non poteva essere inquisito e nemmeno arrestato dopo una condanna definitiva, dal ’94 in poi l’immunità ha continuato a rappresentare un formidabile scudo dalle vicende giudiziarie. Peraltro con una significativa recrudescenza negli ultimi anni, visto che oltre un terzo delle richieste di arresto sono state inoltrate nella scorsa legislatura (2008-2013). Il berlusconiano Alfonso Papa e i democratici Luigi Lusi e Francantonio Genovese , arrestati negli ultimi tre anni, sono gli unici a essere finiti dietro le sbarre. Ma fino al 2011 ogni richiesta è stata puntualmente respinta. Spesso grazie anche al voto segreto. Come nel caso del deputato Pdl Nicola Cosentino, accusato di concorso esterno in associazione camorristica: secondo l’istruttoria svolta dai deputati della Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio, l’onorevole andava spedito in carcere come chiedeva il gip di Napoli. Ma nel segreto dell’urna, nel 2009 l’Aula lo ha graziato , impedendo anche l’utilizzo di alcune sue intercettazioni telefoniche. Idem nel 2011 per Alberto Tedesco (Pd) e nel 2012 per il senatore Sergio De Gregorio (Pdl), accusato di truffa e false fatturazioni nell’inchiesta sui fondi pubblici all’editoria e per il quale erano stati chiesti i domiciliari. In altri casi, invece, il Parlamento si è trasformato in una sorta di Corte di Cassazione. E anziché limitarsi ad appurare un eventuale intento persecutorio dei pm (come previsto dalla legge), si è spinto a dare giudizi di merito sulle inchieste. Nel 1997, ad esempio, il deputato Carmelo Carrara (Ccd-Cdu), relatore della richiesta d’arresto di Cesare Previti - salvato dal carcere nell’inchiesta Imi-Sir, in cui l’avvocato fu poi condannato per corruzione in atti giudiziari - ravvisava «un’esasperazione accusatoria del gip di Milano». Due anni dopo anche il relatore Filippo Berselli (An) motivò il suo “no” alla richiesta di carcerazione nei confronti di Marcello Dell’Utri per la «evidente sproporzione tra la misura cautelare adottata e i reati contestati», ovvero tentata estorsione e calunnia. Quando il gip di Bari nel 2006 chiese i domiciliari per Raffaele Fitto nell’ambito di un’inchiesta sulla sanità, la Giunta della Camera stabilì all’unanimità che il pericolo di reiterazione del reato “non appare motivato”. E quindi l’ex governatore pugliese - poi condannato a 4 anni in primo grado - doveva restare libero. La richiesta di carcerazione nei confronti del deputato Udc Remo Di Giandomenico, anche lui accusato di corruzione nel 2006, era invece “connotata da fumus persecutionis, specie in rapporto all’attualità delle esigenze cautelari”. E siccome l’onorevole in una sua memoria difensiva alla Giunta aveva “offerto concreti elementi di contestazione nei confronti delle accuse”, “si affievolisce la esigenza custodiale”. Tradotto: niente arresto. Il fumo della persecuzione Montecitorio l’aveva ravvisato anche nel 1998, nelle due diverse richieste di carcerazione dell’ex sindaco di Taranto Giancarlo Cito (poi condannato sia per l’una che l’ altra vicenda): entrambe furono infatti respinte. Si dirà: se l’inchiesta è debole, è comprensibile una levata di scudi. Eppure nemmeno un’indagine riconosciuta come fondata dagli stessi onorevoli ha portato a un esito diverso. Quando nel 2006 il gip di Roma chiese il carcere per il deputato Giorgio Simeoni (Forza Italia) per il pericolo d'inquinamento delle prove in un’inchiesta sulla sanità, la maggioranza dei suoi colleghi in Giunta osservarono che “il pericolo mancherebbe perché il quadro indiziario è tutto sommato abbastanza solido”. Risultato: l’autorizzazione a procedere non fu concessa nemmeno in questo caso. Il diniego agli arresti non è l’unico aspetto significativo. Grosso modo una volta su due (in totale 26 su 58), il Parlamento ha negato anche l’uso di uno strumento fondamentale d’indagine come le intercettazioni. Ma le Camere non hanno solo impedito l’utilizzo delle conversazioni captate indirettamente. In qualche caso hanno negato perfino la semplice acquisizione dei tabulati, che consentono di ricostruire le chiamate ricevute ed effettuate, per “tutelare la sfera di riservatezza del parlamentare”. Pure l’insindacabilità, vero cuore dell’immunità, si è prestata a qualche interpretazione di manica assai larga. Si tratta dello “scudo” nei confronti delle opinioni espresse dagli eletti, una prerogativa fondamentale per assicurare la loro indipendenza e autonomia senza il timore di essere trascinati in tribunale. Su oltre 700 casi, il 92 per cento delle volte Montecitorio e Palazzo Madama hanno ritenuto che i giudizi di deputati e senatori sfociati in una causa per diffamazione erano stati espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, come prevede la legge. Pertanto gli onorevoli non erano processabili. Un “ombrello” sotto il quale - solo per citare alcuni degli episodi più celebri - sono finite le critiche di Francesco Storace a Giorgio Napolitano (dalla «disdicevole storia personale», la «evidente faziosità istituzionale» e «indegno di una carica usurpata a maggioranza»), le accuse di Maurizio Gasparri a John Woodcock («un bizzarro pm, che spara a vanvera accuse ridicole») oppure le intemerate di Vittorio Sgarbi contro i pm del pool di Milano («vanno processati ed arrestati: sono un’associazione a delinquere con libertà di uccidere che mira al sovvertimento dell'ordine democratico»). Proprio Sgarbi, peraltro, in questi anni si è dimostrato una sorta di record-man: oltre 150 delibere di insindacabilità (un quinto del totale) hanno riguardato proprio lui. Un dilagare generalizzato contestato dalla Corte costituzionale, che in questi 20 anni - a seguito di conflitti di attribuzione sollevati dai giudici - ha annullato 84 concessioni di immunità: per la Consulta si trattava di affermazioni che nulla avevano a vedere con l’attività parlamentare. E quindi deputati e senatori andavano processati come normali cittadini.
LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA.
Mafia: pm Teresi, nell'antimafia ci sono persone senza scrupoli. L'antimafia è rappresentata anche "da persone senza scrupoli che vogliono sfruttare questo palcoscenico per potere ricevere vantaggi che sono tipici di persona senza scrupoli". Lo denuncia il 30/04/2015 all'Adnkronos il Procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi. "Probabilmente esiste davvero la mafia dell'antimafia - dice il magistrato a margine della commemorazione di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo - Ormai esistono non solo rischi ma anche concreti esempi di infiltrazioni nella cultura e nella pratica giornaliera dell'antimafia che è fatto da persone che vogliono sfruttare questo palcoscenico per potere emergere e potere ricevere dei vantaggi che sono tipici di persone senza scrupoli". "Non parlerei di mafia dell'antimafia, ma di mancanza di scrupoli di una certa antimafia che esiste certa", aggiunge. Poi, parlando dell'ex segretario del Pci La Torre ucciso il 30 aprile di 33 anni fa, l'aggiunto dice: "Pio La Torre è stato un pioniere non solo della lotta alla mafia, ma anche della lotta alla miseria e alla vera lotta di classe in Sicilia - dice - La questione meridionale scissa dalla questione mafiosa era un esercizio culturale inutile. Lui ha intuito che erano la stessa cosa e l'ha pagata con la vita, perché ha individuato la mafia come la vera responsabile del distacco della Sicilia dal resto della crescita della nazione. Quindi, un esempio di capacità di vedere avanti veramente straordinario". "Ora si parla più di lotta alla mafia come esercizio di abitudine che andrebbe rivisto e si parla meno di questione meridionale, cioè abbiamo di nuovo scisso le due cose - aggiunge Teresi - Continuiamo a fare finta che la storia non esista e che le due vicende siano separate. Dobbiamo capire che la questione economica siciliana è questione di mafia".
Giustizia: il pm di Palermo Vittorio Teresi "nell'antimafia ci sono persone senza scrupoli", scrive Vincenzo Vitale su "Il Garantista". In occasione della commemorazione di Pio La Torre, l'affondo di Vittorio Teresi, Procuratore Aggiunto di Palermo. Dopo tanti anni, si da ragione a Sciascia. Nella mitologia greca, Cronos - il Tempo - divora i figli che esso stesso ha fatto nascere: e ne rimane un celebre e perfino impressionante olio di Goya, dove appunto si mostra un essere mostruoso che letteralmente prende a morsi poveri omiciattoli in sua totale balia. Ne facciamo esperienza ogni giorno: tutto ciò che ci affatichiamo a fare e a disfare, non appena entra nell'ambito della vita, delle cose, è già candidato a scomparire, a dissolversi. Appena nato, il piccolo già principia ad invecchiare. Tuttavia, in un'altra prospettiva - che è quella che qui davvero interessa - il Tempo si fa cogliere come un potente coefficiente di chiarificazione delle realtà più complesse: esso serve a far capire ciò che prima non si capiva, a semplificare ciò che sembrava complicato, perfino a dissolvere la nebbia dell'ideologia. Si pensi per esempio a come Emile Zola abbia affidato al tempo la marcia inesorabile di quella verità che condusse poi, dopo anni, alla definitiva riabilitazione del capitano Dreyfus, ingiustamente accusato di spionaggio a favore dei tedeschi. È questo il caso che oggi si registra in virtù delle dichiarazioni di Vittorio Teresi, Procuratore Aggiunto di Palermo, il quale ha affermato all'Adnkronos che l'antimafia è rappresentata anche "da persone senza scrupoli che vogliono sfruttare questo palcoscenico per poter ricevere vantaggi che sono tipici di persone senza scrupoli", e che aggiunto: "...non parlerei di mafia dell'antimafia, ma di mancanza di scrupoli di una certa antimafia che esiste". Ebbene, ricordate un celebre articolo pubblicato a firma di Leonardo Sciascia, nel gennaio del 1987, sul Corriere della Sera, dal titolo (che, peraltro, non era a lui dovuto) "I professionisti dell'antimafia", e che tante polemiche suscitò? Ricordate che il coordinamento antimafia di Palermo, in quel tempo, inveì contro lo scrittore siciliano, affermando che egli si era posto "ai margini della società civile"? Ricordate che gli intellettuali di casa nostra s'indignarono profondamente alla pubblicazione di quel pezzo e che nel nome della lotta alla mafia criticarono aspramente Sciascia, ergendosi a difesa di Orlando e Borsellino? Basti pensare a Eugenio Scalari. Ne nacquero poi polemiche annose ed astiose che travagliarono dalle pagine dei giornali e di riviste di politica e di costume l'intera società italiana, insomma una vera tempesta mediatica e ideale. E perché? Semplicemente perché lo scrittore siciliano aveva individuato come esistesse il concreto pericolo che, per come veniva organizzata l'antimafia, per le strategie che usava, per il tipo di consenso a volte cieco e privo di capacità critica che essa riusciva a capitalizzare, dietro di essa si muovesse un interesse di altro tipo, assai meno nobile e socialmente utile, un interesse inconfessabile destinato a costruire un vantaggio proprio o dei propri sodali, fosse esso politico, sociale, morale, perfino economico e che perciò si trattava di demistificarlo, portandolo a conoscenza di tutti. E ciò non certo per indebolire la lotta alla mafia, effetto che, tradotto quale accusa mossa allo scrittore, suonava già semplicemente insulso, ma, al contrario, per depurarla da indebite contaminazioni che sarebbero state in grado di degradarla, di renderla dominio di pochi invece che patrimonio di tutti. Già. Ma ciò Sciascia scriveva e denunciava - "spirito critico mancando e retorica aiutando" - ventotto anni e quattro mesi or sono. Ci son voluti tutti, per capire che le cose stavano proprio così, che davvero nell'antimafia son presenti anche persone che, prive di scrupoli, ne sfruttano il palcoscenico per lucrare vantaggi personali, come ha efficacemente dichiarato il dott. Teresi. E, a pensarci bene, perché dovrebbe o come potrebbe essere diversamente? Perché mai l'antimafia dovrebbe far eccezione a tutte le altre organizzazioni umane - dal circolo degli Ufficiali alla bocciofila - nessuna delle quali è -né pretende di esserlo - perfetta, senza macchia, tutta ed interamente composta da persone probe, incontaminate, incorruttibili. Del resto, come è noto, "l'incorruttibile" finì col perdere la testa sotto la medesima lama alla quale egli stesso aveva destinato migliaia di teste. L'antimafia, perciò, non fa al riguardo eccezione. Solo che - ed è qui la vera differenza che, come un crinale, distingue il profetismo letterario dello scrittore dalla pigrizia coscienziale - Sciascia ebbe la preveggenza di vederlo ed il coraggio civile di denunciarlo quasi trent'anni or sono: e ne ebbe rampogne e contumelie. Oggi, anche altri non solo lo comprendono, ma lo dichiarano pubblicamente e si spera si tratti ormai di un dato definitivamente acquisito dalla coscienza sociale. E dunque, meglio tardi che mai: il Tempo in questo caso è stato galantuomo.
Pietrangelo Buttafuoco su “QTSicilia Magazine”: "Una cosa è la mafia, un'altra la mafia dell'antimafia e un'altra cosa ancora è la lotta alla mafia". Ma Buona Pasqua a Tutti. Come solitamente facciamo nelle prossimità delle festività, cogliamo l'occasione nell'augurare Buona Pasqua ai lettori, per sottolineare e risaltare un tema attuale che assedia la Sicilia.Stavolta non scriviamo noi ma vogliamo riportare un interessante pezzo scritto, con maestria solita, da Pietrangelo Buttafuoco su "Il Foglio" di stamane. Il tema è a noi caro visto che lo abbiamo più volte affrontato con determinazione, affermando il nostro pensiero che non è soltanto intellettuale e lontano dalla realtà, bensì è la testimonianza di chi vive, osserva, analizza la società siciliana che deve necessariamente scrollarsi di dosso la teoria bizzarra delle patenti dell'antimafia, metodo usato per la lotta politica e non per la lotta alla mafia. Detto ciò leggiamo l'imperdibile Pietrangelo Buttafuoco. "Due sono i tipi di mafia: la mafia e la mafia dell’antimafia. Non avendo obblighi di diplomazia, ecco, la dico chiara. L’esito della lotta alla mafia, al netto del teatrino cui s’è ridotta, è quello di una tenaglia stretta intorno alla Sicilia.Due sono i tipi di mafia e l’unica fabbrica operosa di Sicilia è quella dell’antimafia fatta mafia. E’ la madre di tutte le imposture. E’, appunto, un teatrino la cui regia è la malafede e il cui pezzo forte – orgoglio del cartellone – è la pantomima degli inganni. Uno spettacolo grottesco, questo della tenaglia che avvita e svita, consumato in queste giornate di convulsione del potere regionale e, in rimbalzo romano, nella preparazione delle liste per le Europee dove sia gli assessori chiamati nella giunta di governo, sia i candidati del Pd, tutti duri e tutti puri, hanno contrabbandato ideali e calunnie, ricatti e anatemi, lasciando inerme e sconfitta la verità. E’ stata tutta una gara di tutti contro tutti, quella di questi giorni. Tutti a sfregiarsi reciprocamente secondo il tasso di antimafietà riducendo la rivoluzione del governatore Rosario Crocetta – una rivoluzione di fatui annunci – a una macchietta. Una favola, dunque. La cui morale, purtroppo, è lercia. Il pegno di sangue di tanti innocenti è diventato pretesto di un mercato per le carriere dei vivi e il destino tutto ribaltato di una bugia apparecchiata nelle buone intenzioni – quella di essersi assicurato il credito dovuto ai rivoluzionari, ai giusti, ai difensori della legalità perpetuando la fogna del potere – s’è svelata in un contrappasso: Crocetta che se ne partì per combattere la mafia risultò che sfasciò l’antimafia. L'ex Pm Nicolò Marino, assessore dell’attuale governatore fino a qualche settimana fa, è stato tolto di mezzo, causa incomprensioni in tema di energia. Incomprensioni senza riparo, vista la delicatezza della questione, quella della gestione dei rifiuti. E tanto delicata deve essere stata la questione da far dimenticare a Crocetta quando Marino indagò a suo proposito. Indagò e archiviò. Per comprovata innocenza, manco a dirlo.L’ex Pm, pluristellato in materia di antimafia, intervistato da Livesicilia ha letteralmente scorticato il governatore. Lo ha spogliato di tutti i paramenti, quelli del rito trito e accettato dell’antimafia naturalmente. Un’intemerata che lasciato attoniti quanti, ancora qualche settimana prima, vedevano nell’uno e nell’altro, la sacra unione dei rivoluzionari, dei giusti e dei difensori della legalità. Tra le tante parole dette da Marino ad Accursio Sabella che lo intervistava, una frase, una, ha turbato più di tutte: “Dopo la vergognosa vicenda Humanitas ho dovuto formalizzare la richiesta del rispetto delle regole”. Laddove per vicenda vergognosa s’intenda il caso di una delibera per l’ampliamento dei posti letto di una clinica privata, l’Humanitas. Una delibera fatta firmare nottetempo, nelle ferie d’estate, a Lucia Borsellino, assessore nel delicato assessorato della Sanità e che di cognome, appunto, fa “Borsellino”. Una delibera che solo grazie alle rivelazioni della stampa venne ridimensionata ad errore, forse un lapsus, certamente gettata nella fogna di quel potere di Sicilia, tanto micragnoso quanto inesorabile.Oltre il sipario, la tenaglia. Questo è il fatto. A disposizione di furbissimi prestidigitatori della legalità per cui se oggi va bene Caterina Chinnici candidata alle europee per il Pd – la stessa, figlia di Rocco, il magistrato trucidato dalla mafia – appena ieri stava andando a male. Stava nella giunta di governo di Raffaele Lombardo, condannato in concorso esterno. Per mafia ovviamente. E Lombardo però – oltre alla Chinnici – è anche quello che ha trasmesso a Crocetta, il suo successore, massimo campione di antimafietà per come è notorio, il regista politico che ha assicurato la continuità: Beppe Lumia, un altro campione di antimafietà. Anzi, di più. Il già presidente della Commisione parlamentare antimafia è il maestro concertatore, compositore, arrangiatore e direttore di orchestra di ben due governi siciliani. Quello del condannato, innanzitutto. Di Lombardo, infatti, Lumia si fece garante. E gli affidò – a mo’ di coroncina d’aglio sul vampiro – tutta un agghirlandar di magistrati in giunta. Garante e ancora qualcosa di più, Lumia, lo è dell’attuale governatore. Con perizia riuscì a mettere al posto di Massimo Russo, un altro magistrato, assessore della delicatissima Sanità con Lombardo, la suddetta Lucia Borsellino, con pazienza ha poi seguito – passo dopo passo – il periglioso percorso del governo di Crocetta, prima e dopo il rimpasto, non riuscendo però a farsi candidare alle Europee avendo avuto contro “non un colluso e contiguo comunista da mascariare”, per dirla con Francesco Foresta, ma appunto la Chinnici, degno deus ex machina del più inatteso colpo di scena in cotanto teatro. Nella tenaglia, lo spettacolo. Anzi, il baraccone. E siccome la rivoluzione è pur sempre redditizia, siccome val bene un tradimento, un disconoscimento o un ripudio, tutto quel mettersi in casa un Antonio Fiumefreddo oggi, per poi scaricarlo domani (uno su cui Il Fatto prima e poi Repubblica hanno però svelato essere l'avvocato difensore della “famiglia Ercolano”), non è tanto una prova di pragmatismo di Crocetta, piuttosto un reiterare il pasticcio. Fiumefreddo, infatti, ha perfino la patente d’antimafia, da soprintendente del Massimo Bellini, a Catania, issò sulla facciata del teatro i ritratti di Matteo Messina Denaro per additarlo a eterno monito di wanted e Crocetta che adora le eccentricità, improvvisa, impapocchia, fa giochi di prestigio, allude e illude perché – appunto, appunto – la fase estrema dell’antimafia non è più il professionismo, bensì l’illusionismo. Improvvisa, impapocchia e illude, l’illusionista. Vista la malaparata, nel fare il suo rimpasto, il governatore ha ripiegato su altre personalità. Perfino d’importazione, come il dr. Salvatore Calleri, da Firenze. “Un allievo”, si legge nel curriculum, “di Antonino Caponnetto”. Dopo di che, certo, il cambiamento, evocato da Totò Cardinale, “è stato bloccato...” L’ex ministro nisseno è il leader del Drs, una sigla non ben definita, è una sorta di pustola del Pd, una delle tante casette a uso dei transfughi. E’ il partito del Fiumefreddo di cui sopra, costretto alle dimissioni, frastornato al punto di scrivere sul proprio sito web una lettera intrisa di allusioni al Golgota, ai ferri della Passione, al Crucifige di un agnello – qual è lui – il cui martirio comprova il cambiamento di Sicilia definitivamente bloccato. E così sia. Improvvisa, impapocchia e illude, l’illusionista. Nel frattempo s’è tentato di mettere Antonio Ingroia al posto del reprobo Marino. L’uomo simbolo di tutti i simboli è, si sa, momentaneamente sott’utilizzato. Al momento, infatti, è commissario della disciolta provincia di Trapani. Non è propriamente commissario di Pubblica Sicurezza ma ha comunque il preciso compito di catturare Matteo Messina Denaro, il latitante dei latitanti e Crocetta che lo vorrebbe con sé, in qualunque ruolo, pure in quello di un Mastro Lindo risanatore delle partecipate regionali, compatisce quell’amico così sfortunato che retrocede sempre di più nella parodia e magari teme di vederlo finire a cantare tra i tavoli di “Pizza & pizzini”, il nuovo ristorante di Massimuccio Ciancimino, figlio di don Vito, star di Servizio pubblico, la trasmissione di Michele Santoro dove a suo tempo, l’ex Pm, portandoselo a braccetto per farlo applaudire dal pubblico politicamente sensibile, lo battezzò “icona dell’antimafia”. Ecco, certo. Sono cose al cui confronto, lo slogan di Totò Cuffaro, “La mafia fa schifo”, per ingenuità e pacchianeria, fa ormai sorridere. Ma c’è solo da piangere. Crocetta che se ne partì per combattere la mafia risultò che la sfasciò tutta l’antimafia. E non solo perché due persone serie come Claudio Fava e Leoluca Orlando se ne guardano bene dall’assecondarlo ma perché la terapia, infine, col pullulare di pittoreschi personaggi dalla carriera proprio sgargiante – su tutti, Pietro Grasso, quasi un vescovo del rito trito e politicamente accettato – ha fatto propri i sintomi della malattia. Come la mafia, in letteratura, al cinema, nelle fiction, ha trovato la propria caricatura, così l’antimafia, nella sua variante di mafia, è diventata prateria di carriere, territorio senza Re e senza Regno a uso di spregiudicati elargitori di credibilità e autorità, di fatto sostituitisi allo Stato e alle Istituzioni se della giustizia, e dei valori sacrissimi della vita, ne fanno solo un uso politico. Peggio che una caricatura, un’impostura, di cui non si può neppure fare show business. Viene difficile immaginare un copione speculare ai perfetti modelli della commedia, non un Johnny Stecchino di Roberto Benigni, non il Mafioso di Alberto Sordi, non La Matassa dei sublimi Ficarra e Picone ma solo e soltanto la parodia di Ingroia fatta da Crozza. Poca cosa. E potremo sperare un giorno di liberarci dall'uggia del rito, trito e ritrito, quando come con la mafia anche la mafia dell'antimafia potrà essere raccontata e denudata dalla satira. Prima di allora, ci resta addosso solo l'impostura. E sono cose di Sicilia, tutte dentro il sipario, strette nella tenaglia della legittimazione reciproca o, al contrario, del disconoscimento di ritorno. Ponendo il caso, tra i casi, che un Salvatore Borsellino (che di cognome, appunto, fa “Borsellino”), non convochi un’assemblea di Agende rosse e non stili un nuovo elenco di buoni e di cattivi (sì, la famosa agenda da cui Paolo Borsellino non si staccava mai, quella andata sicuramente distrutta dalla carica di tritolo, ritenuta trafugata sulla scena dell’orrenda strage, quella considerata alla stregua del Graal per smascherare la trattativa Stato-Mafia e poi rivelatasi “un parasole”). Buoni e cattivi che pencolano, trasversalmente, tra mafia, antimafia e mafia dell’antimafia per relegare i mafiosi, già servi di scena, in cotanto teatro, alla consolle degli effetti speciali – quasi a far da tecnici e attrezzisti, dietro le quinte – giusto per luci & ombre. E proiettili, ovviamente, da imbustare. Proiettili che intelligentissimi mafiosi fanno recapitare nei momenti di massima difficoltà agli illusionisti e per restituirli così alla scena, anzi, al baraccone. La tenaglia, dunque. Una morsa fatta di ferri opposti ma ugualissimi pronta a svitare o avvitare, a proprio piacimento, la testa vuota, vuotissima di un pupo senza più speranze se in via Libertà, a Palermo, i negozi chiudono e muoiono come i fiori di agave nelle sciare di pietra: di colpo, prosciugandosi di vita. Tutti – in quella strada, un tempo ricca di commerci – aspettano l’apertura di un lussuoso locale e già aleggia la nera leggenda (“ci sono i soldi di Matteo Messina Denaro...”). Non c'è più niente di niente nell’Isola: non un’industria, non più la Fiat a Termini Imerese, né Pasquale Pistorio e la sua Stm a Catania, un tempo fiore all’occhiello dell’elettronica. Perfino i turisti scarseggiano se a distanza di un anno, a Lipari, si sente l’eco di un colpo di pistola. E’ quello con cui spense la propria vita – flagellata dai debiti, dalla crisi, dalla mancanza di lavoro – Edoardo Bongiorno, titolare dell’Hotel Oriente, un albergo tra i più antichi, un luogo della bellezza destinato all’altra tenaglia, quella dove una ganascia è il niente e l’altra è il nulla. Nessuno più vuole investire in Sicilia. Antonello Montante, presidente di Confindustria, che si schiera contro le banche impegnate a strozzare quel poco che resta delle aziende, denuncia con durezza il maledetto clima che abbuia ogni speranza: “Tutti hanno paura di tutti, della mafia, della burocrazia e anche dei giornalisti”. Tutti hanno paura di tutti. E tutti – in questa terra, ormai alla prova generale del default che toccherà in sorte a tutta l’Italia – aspettano di partirsene via. Ed è una fortuna che Campari abbia acquistato Averna. L’amaro di Caltanissetta è stato preso in custodia dal bitter di Milano. Per qualche anno ancora, Deo gratias, si potrà fare il brindisi. E il Deo gratias definitivo, quello necessario, potrà aversi se qualcuno, qui, a Roma, capisca che cosa sta succedendo davvero. Se proprio non un Cesare Mori, un prefetto che arrivi e metta fine ai mercanti asserragliati nel tempio della lotta alla mafia, almeno un commissario, in Sicilia, ci vuole e serve. Se non subito, subitissimo. E come quello, come Mori, si faccia forte di un principio: far tornare lo Stato in Sicilia. Avere carta bianca e – come quello, che ebbe mandato pieno dal presidente del consiglio dei ministri – avere il potere di cambiare le leggi se queste, sporche per come è infettata di mafia la legislazione derivata dallo Statuto autonomo, non permettano il raggiungimento dell’unico necessario proposito: fare tornare lo Stato in Sicilia. PS. Ho preso a prestito la categoria del dopoguerra, quella sulla distinzione di Leo Longanesi dei due fascismi ( "il fascismo e il fascismo dell'antifascismo", elevato a pretesto di una guerra civile ancora viva) perché è il binario obbligato dell’identità di una nazione, il cui tracciato, forgiato dalla natura arcitaliana, è quello inesorabile del conformismo. Dopo di che, la Sicilia. Certo, tutti hanno paura di tutti. Una cosa è la mafia, un'altra la mafia dell'antimafia e un'altra cosa ancora è la lotta alla mafia. E io, qui, lo so che mi ritrovo a prendere a mani nude le braci degli altri. Ma – come si dice? – così come finisce, un giorno si racconterà".
Indagato il pm antimafia Mollace. “Favoreggiamento alla ‘ndrangheta”, scrive Guido Ruotolo su “La Stampa”. Lo storico magistrato di Reggio Calabria sotto inchiesta per corruzione. Un colpo di scena, un altro. Per Reggio Calabria e l’antimafia è una mazzata. E anche un nuovo capitolo dei veleni che hanno intossicato il Palazzo di Giustizia. È indagato dalla procura antimafia di Catanzaro Francesco Mollace, uno dei pilastri storici della procura antimafia, sostituto procuratore generale di Reggio Calabria da meno di due mesi è in servizio alla procura generale presso la Corte d’appello di Roma (e qualcuno ipotizza la precipitosa decisione di trasferirsi dettata per evitare il carcere). L’ipotesi di reato che viene ipotizzata nei confronti dell’alto magistrato è corruzione in atti giudiziari, con l’aggravante di aver favorito la ’ndrangheta. L’inchiesta dei pm Giuseppe Borrelli, Gerardo Dominjanni e Domenico Guarascio è una costola di quella sugli autori della strategia stragista contro lo Stato del 2010, la cosca Lo Giudice, che fece esplodere ordigni sotto il portone della procura generale (3 gennaio) e nell’atrio del palazzo del procuratore generale Salvatore Di Landro (25 agosto). Infine, il 5 ottobre, fu ritrovato un bazooka sotto la procura di Giuseppe Pignatone. Per questi attentati si sta celebrando il processo a Catanzaro, avendo individuati gli autori. Sono diverse le letture sul possibile movente. Quella più accreditata: il procuratore generale Di Landro si era da poco insediato, facendo saltare immediatamente quegli accordi non scritti tra avvocati e sostituti procuratori generali, che praticavano il patteggiamento occulto in Appello. E, dunque, le bombe come richiesta a Di Landro di ripristinare quegli accordi. Francesco Mollace è stato lo storico titolare delle inchieste che hanno riguardato i fratelli Lo Giudice, e nessuna di queste indagini è mai arrivata a processo. Ma c’é, ci sarebbe anche dell’altro. Viene ipotizzato dagli inquirenti uno scambio corruttivo tra il magistrato e la cosca di Nino Lo Giudice. Sì, il «nano», il mandante delle bombe del 2010. Il dottor Mollace - che non ha voluto commentare le indiscrezioni sulle indagini che lo riguardano - avrebbe tenuto la sua barca nel cantiere navale di Nino Spanò, il prestanome della cosca Lo Giudice. A processo Spanò ha dichiarato che la rata mensile per la barca del magistrato Mollace veniva pagata in contanti e che lui non la contabilizzava. «Don Ciccio, cercate don Ciccio che mi deve difendere». Quello che è importante è ricordare che questa intercettazione è agli atti della inchiesta, genuina. Il boss comunica al suo avvocato di contattare Mollace, e sembra dire che è il suo garante. Per l’accusa, questa intercettazione è una prova decisiva, che mette in secondo piano la interpretazione e l’attendibilità del pentito Nino Lo Giudice che prima chiama in causa il procuratore aggiunto nazionale antimafia, Alberto Cisterna, poi evade dal rifugio protetto lasciando un memoriale nel quale ritratta tutto (infine è stato catturato).
E il giudice finì nei guai per colpa dei Lo Giudice, scrive Felice Manti su “Il Giornale”. Ma la cosca dei Logiudice esiste ancora? A questa domanda sembra dare una risposta la decisione della Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex sostituto pg di Reggio Calabria Francesco Mollace, adesso in servizio alla Procura generale presso la Corte d’appello di Roma. Mollace è indagato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per corruzione in atti giudiziari. Alla sbarra con lui finiranno Luciano Lo Giudice, fratello del boss Nino – pentito a fasi alterne – e Antonino Spanò, titolare di un cantiere nautico a Reggio Calabria, in cui Mollace avrebbe avuto la sua imbarcazione a rimessaggio. La richiesta di Gerardo Dominijanni e Domenico Guarascio, a capo dell’inchiesta coordinata dal procuratore della Repubblica Vincenzo Antonio Lombardo, nasce dal memoriale del boss reggino Nino Lo Giudice, a capo di una cosca che Mollace avrebbe favorito. La vicenda è intricata e complessa: l’ex pentito Nino, come ho già scritto qualche tempo fa, ha detto tutto e il contrario di tutto ai magistrati reggini, anche attraverso memoriali messi più volte in discussione. Il dubbio che dietro il suo pentimento «ballerino» ci sia una macchinazione per colpire alcuni magistrati. Non ha convinto molti l’essersi autoaccusato di essere l’ideatore delle bombe fatte esplodere nel 2010 contro la Procura generale di Reggio Calabria e contro l’abitazione del procuratore generale Salvatore Di Landro e dell’intimidazione all’allora procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone, con il ritrovamento di un bazooka ad alcune centinaia di metri dal palazzo della Dda. Nino ha anche chiamato in causa il fratello Luciano, considerata la mente della cosca, salvo rimangiarsi tutto, con un video fatto immediatamente prima di abbandonare il rifugio protetto dove era stato nascosto: «Ho confessato perché ero manipolato dalla Dda di Reggio Calabria», cioè a suo dire dall’allora procuratore capo Giuseppe Pignatone, adesso a Roma, dell’aggiunto Michele Prestipino, del pm Beatrice Ronchi e dell’ex capo della mobile Renato Cortese, che oggi dirige la squadra mobile di Roma. Nel fango era finito anche l’ex procuratore aggiunto della Dna Alberto Cisterna, che non ha mai negato la frequentazione con il presunto boss. Ma la cosca Lo Giudice, ripete sempre Cisterna, è stata lui a smantellarla nel 1993 arrestando il capofamiglia. E Cisterna è uscito pulito dai guai. Ma la cosca Lo Giudice esiste, almeno così pensano i pm di Catanzaro. E qual è la colpa di Mollace? Aver sottovalutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Maurizio Lo Giudice (fratello di Nino e Luciano) e Paolo Iannò (ex braccio destro e armato del superboss Pasquale Condello detto «il Supremo» arrestato dal Ros il 18 febbraio 2008 dopo una latitanza infinita) senza svolgere – secondo i pm di Catanzaro – le necessarie indagini per capire se i Lo Giudice a Reggio avessero ancora un peso oppure no. Per i due pentiti il peso lo avevano eccome. I magistrati catanzaresi scrivono che Mollace, per chiudere un occhio, avrebbe ricevuto in cambio «la dazione gratuita dei servizi di manutenzione e rimessaggio dei natanti ormeggiati nel cantiere di Calamizzi, gestito e diretto da Spanò e Luciano Lo Giudice, il primo quale prestanome del secondo». A pesare su Mollace c’è soprattutto il giallo dell’omicidio di Angela Costantino, moglie del boss Pietro Lo Giudice, che secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa per salvare l’onore del capoclan. Il presunto mandante sarebbe Bruno Stilo, l’esecutore materiale Fortunato Pennestrì (considerato il reggente della cosca dopo l’arresto del boss) entrambi condannati a fine 2013 a 30 anni con una sentenza che ha rispecchiato in pieno l’impianto accusatorio portato avanti dal pm Sara Ombra. I due sospettavano che mentre il marito era detenuto la donna fosse incinta di un altro uomo di cui si era innamorata- o Pietro Calabrese, poi trasferitosi a Roma o Domenico Megalizzi, scomparso nello stesso periodo, che riceveva telefonate a casa da parte di una ragazza di nome Angela – l’avrebbero strangolata il 16 marzo 1994 nell’appartamento che abitava da circa un mese a Reggio Calabria in via XXV luglio, in un immobile al piano terra che, per decenni, è stato il feudo storico della cosca Lo Giudice e poi ne avrebbero occultato il cadavere pur di salvare l’onore del capoclan. Per il Gup Indellicati che ha deciso la condanna dei due ’ndranghetisti, come emerso dai documenti di natura medica agli atti dell’indagine, la situazione della donna «poteva essere compatibile sia con una disfunzione ginecologica, sia con un aborto precoce, a seguito di una gravidanza molto recente». Durante il processo sull’omicidio Mollace aveva difeso le sue scelte investigative con qualche «non so, non ricordo» di troppo, tanto che in una lettera al Collegio presieduto da Silvia Capone lo stesso magistrato ammise di non aver ricordato bene, tanto che il pm Beatrice Ronchi spingerà, con le sue indagini, a indurre il presidente del Collegio a verbalizzare «la falsità delle affermazioni di Mollace». Ad aprire squarci di luce sulla vicenda, finita anche su Chi l’ha visto, fu soprattutto Maurizio Lo Giudice, che nel ’99 indicò in Pennestrì l’esponente più di spicco della cosca Lo Giudice, insieme a Bruno Stilo («Era lui che prendeva in mano tutta la famiglia… dopo che sono stati arrestati… andava pure a chiedergli i soldi), e nell’ipotizzare che la donna, madre di quattro figli, fosse invaghita di un altro («Aviva perdutu a testa, dottori!») . La conferma a Maurizio Lo Giudice l’avrebbe data lo stesso Pennestrì, che poi avrebbe contribuito a depistare le indagini. Le dichiarazioni di Maurizio Lo Giudice di fine anni Novanta («In quei giorni Natino Pennestrì prese la palla al balzo, disse che Angela si lamentava con tutti noi che si buttava dal porto, dai ponti, così creò un po’ di pubblicità che era pazza, dei falsi ricercamenti, che portarono per… la credibilità che Angela era veramente malata») non furono considerate credibili fin quando il pm Beatrice Ronchi deciderà di riaprire le indagini e incrociarle con le affermazioni di almeno altri due collaboratori di giustizia considerati attendibilissimi, appunto Paolo Iannò e Domenico Cera. Insomma, la cosca decapitata da Cisterna all’inizio degli anni Novanta era ancora pienamente operativa, tanto da orchestrare un omicidio. Nino, Maurizio e Luciano avevano rapporti privilegiati con magistrati e forze dell’ordine, come raccontano le ultime vicende giudiziarie. Adesso per Mollace si apre un processo difficile. Le cui conseguenze, anche sui delicatissimi equilibri tra la Procura reggina e quella catanzarese, potrebbero essere inimmaginabili…
Il giudice e Lo giudice, continua Felice Manti. Chi difende lo Stato in Calabria? Le forze dell’ordine, quando non si dimostrano a busta paga dei boss. I politici, quando non vanno in udienza a casa dei capifamiglia a elemosinare voti. E poi ci sono i magistrati… E qui il discorso – per chi ha voglia di farsi qualche domanda – si complicano. Cominciamo da Giancarlo Giusti, l’ex gip di Palmi arrestato dalla Procura di Catanzaro per un presunto«patto scellerato» con la cosca Bellocco di Gioia Tauro. Su Giusti i primi sospetto erano sorti quando nel 2009 furono scarcerati tre esponenti della potente famiglia della Piana: Rocco Bellocco, Rocco Gaetano Gallo e Domenico Bellocco detto «Micu ’u Lungo», gettando alle ortiche mesi di lavoro investigativo. Scattarono le intercettazioni e «venne scoperta – così dice il procuratore della Repubblica di Catanzaro Vincenzo Antonio Lombardo – una corruzione accertata dopo una prima richiesta di archiviazione, in una vicenda che evidenzia un tradimento degli obblighi professionali, fermo restando il principio di presunta innocenza». Secondo un magistrato, un suo collega si sarebbe venduto (per circa 120mila euro) facendo scarcerare personaggi di spessore della ndrangheta calabrese. Se è vero saranno i processi a dirlo. Ma le accuse sono pesantissime: corruzione in atti giudiziari, con l’aggravante di avere favorito un’associazione mafiosa, ed il famigerato concorso esterno. Che cosa possa essere successo quando Giusti ha lavorato al Riesame a Reggio Calabria è ancora tutto da scoprire. Giusti era (ed è ancora) agli arresti domiciliari per un’altra faccenda poco chiara. Il 27 settembre del 2012 l’ex gip era stato infatti condannato a quattro anni per i suoi rapporti con la cosca Lampada, aveva tentato il suicidio il giorno successivo al carcere di Opera. Circa un mese dopo, il 29 ottobre, un perito del tribunale di Milano aveva stabilito che nel carcere di Opera non poteva ricevere le cure psichiatriche di cui aveva bisogno dopo il tentato suicidio. Qual era la natura dei suoi rapporti con la presunta cosca dei Lampada? Favori in cambio di sesso, a causa di una personalità fragile: «La sua è una vera e propria ossessione per il sesso, per lo più a pagamento; ha esigenze economiche legate a un tenore di vita sicuramente elevato; ricerca spasmodicamente occasioni di guadagno parallele in operazioni immobiliari e di varia natura», scrivono i giudici milanesi che lo hanno incastrato qualche anno prima, quando in una telefonata intercettata, Giusti non si faceva scrupolo a dire: «Non hai capito chi sono io.. sono una tomba .. ma io dovevo fare il mafioso, non il giudice». Un finto bullo, sembrerebbe, che alla sorella (la telefonata è agli atti) , dopo avere avuto la notifica dell’avvio di un procedimento disciplinare del Csm sulla base anche dell’inchiesta della Dda di Catanzaro, dice: «È finita per me, guarda che vengono di notte e mi prendono… è finita».
La domanda è: com’è possibile – se è vero – che nessuno si sia accorto che un importante magistrato fosse alla fine un uomo fragile, assetato di soldi e di sesso e ben disposto a fare affari con le cosche in cambio di soldi? A quanto pare non sarebbe il solo. C’è un altro nome che merita qualche riga. Si chiama Vincenzo Giglio, è un giudice ed è finito nello stesso vortice di Giusti: gli affari con il clan Lampada-Valle, su cui la letteratura giudiziaria (soprattutto sul fronte della famiglia Lampada) è abbastanza scarna. Ma tant’è. Giglio e l’ex finanziere Luigi Mongelli (condannato a 5 anni e tre mesi, contro i 4 anni e 7 mesi di Giglio) , furono arrestati nel novembre 2011 nell’ambito dell’inchiesta milanese sul clan Valle-Lampada e oggi sono agli arresti domiciliari, in attesa della sentenza d’appello, anche grazie a una sentenza che stabilì l’incostituzionalità di quella parte dell’articolo 275 del codice di procedura penale che prevede l’obbligo della custodia in carcere per chi è accusato di reati aggravati dal cosiddetto articolo 7, ovvero reati commessi con l’aggravante del metodo mafioso. (Piccola parentesi. Quando uscì in agenzia la notizia del tentato suicidio di Giusti le agenzie scrissero che la vittima era Giglio, e che era morto. Amen). Cosa avrebbe combinato Giglio? Corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento aggravato dall’aver agevolato la cosca mafiosa. La sorte di Giglio era legata a doppio filo con quella dell’ex consigliere regionale Pdl Franco Morelli, condannato in primo grado a 8 anni e 4 mesi e interdizione perpetua dai pubblici uffici per concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio e il presunto boss Giulio Lampada(«Non è mai esistito quel clan, non ce n’è traccia negli atti», dissero allora i suoi legali Ivano Chiesa e Manlio Morcella), re dei videopoker a Milano condannato a 16 anni. Il giochino, secondo i pm, era facile. L’ex maresciallo Gdf Mongelli intascava mazzette assieme ad altri colleghi per non fare i controlli sulle macchinette mangiasoldi. Il giudice Giglio, amico di Morelli, avrebbe fatto pressioni per piazzare la moglie a commissario della Asl di Vibo Valentia e in cambio avrebbe offerto al politico qualche «dritta» sulle indagini che lo riguardavano. Entrambi erano in rapporti con Lampada, cui avrebbe fatto comodo una copertura politica dopo il «mascariamento» del suo precedente cavallo politico di battaglia, quell’Alberto Sarra di cui si parla nel libro Madun’drina, che nel 2007 al telefono (intercettato) con Lampada parla, anzi straparla: «Quando mi muovo a Milano ho una chiavetta nera. Ho praticamente un centinaio di sportelli Bancomat perché quella è la chiave del cambiamoneta (cioè dei videopoker, ndr). Ti faccio un esempio: stasera sono con te e mi serve da prendere mille euro, vado in uno dei bar, apro e me li prendo». Al telefono Lampada e Giglio progettano anche la costituzione di una finanziaria. Dice in un’intercettazione l’ex macellaio di Reggio: Dobbiamo trovare, Alberto, una bella banca, qua su Milano, che ci faccia fare quello che vogliamo… Quello che vogliamo… io intendo dire… attenzione! Non che ci fottiamo i soldi alla banca, mi sa che non rientra nelle nostre…. E la cosa si complica… Sarra viene coinvolto in un’altra inchiesta su mafia e politica, quella che ipotizza un ruolo dell’ex senatore Idv Sergio De Gregorio beccato dai Ros a una cena con Sarra assieme ad alcuni esponenti della cosca Ficara. De Gregorio fu archiviato perché riuscì a dimostrare di non sapere chi fossero, a differenza di Sarra, i suoi interlocutori. Scrivevo a fine 2010: «Quell’avviso di garanzia a Sarra, dicono i Ros, aveva fatto crollare il sogno dei Lampada e avrebbe portato Sarra a “interrompere ogni collegamento con esponenti vicini alla criminalità organizzata” per non aggravare la sua posizione giudiziaria». Morto un papa se ne fa un altro. al posto di Sarra arriva appunto Morelli, consigliere regionale calabrese. Il 13 febbraio 2008 viene intercettata una telefonata fra Giulio Lampada, nato a Reggio Calabria il 16 ottobre 1971, e Morelli. Dice il primo: «La chiamavo per salutarla siccome sapevo che doveva salire a Milano in questa settimana, non l’ho sentita per nulla, ho detto io lo chiamo vediamo se verifi… se sale per caso a Milano… così». Ma bisogna anche rileggersi un informativa del Ros dei carabinieri in cui si parla di rapporti “oscuri” tra i Lampada e i fratelli Vincenzo e Mario Giglio, cugini del giudice. Scrivevo ormai quattro anni fa: «Vincenzo, medico di professione, secondo i carabinieri “voleva scalare i vertici della politica locale di Reggio Calabria”. Alle politiche del 2008 tentò invano di farsi eleggere nel movimento La Rosa bianca. Con Giulio Lampada avrebbe creato un intenso rapporto cominciato con un affare: l’acquisizione di un immobile nel pieno centro di Milano. Il problema è che, secondo i pubblici ministeri, i Lampada rappresentano “quelle tipiche figure criminali che si innestano pienamente nel substrato mafioso” con “compiti e ruoli connessi alla gestione del patrimonio economico del cartello mafioso” legato alla cosca Condello, guidata da Pasquale Il Supremo, arrestato nel febbraio 2008 dopo diciotto anni di latitanza. E qui il malaffare s’intreccia con un omicidio che ha riscritto la storia politica recente. Il fratello di Vincenzo Giglio, Mario, ha lavorato nelle segreterie politiche di due consiglieri regionali coinvolti in vicende inquietanti. Era il capo della segreteria di Franco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria eletto nelle fila della Margherita e assassinato a Locri il 16 ottobre del 2005. Poi diventerà capo della segreteria di Crea, che all’inizio del 2008 finisce in carcere nell’inchiesta Onorata sanità su un giro di corruzione e pressioni mafiose. Basta così? Non proprio. C’è ancora l’affaire Lo Giudice, l’ex pentito Antonino che ha detto tutto e il contrario di tutto ai magistrati reggini, anche attraverso discutibili memoriali. Macchinazioni per colpire altri magistrati, ovviamente. Prima si è autoaccusato di essere l’ideatore delle bombe fatte esplodere nel 2010 contro la Procura generale di Reggio Calabria e contro l’abitazione del procuratore generale Salvatore Di Landro oltre all’intimidazione all’allora procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone, con il ritrovamento di un bazooka ad alcune centinaia di metri dal palazzo della Dda, chiamando in causa anche il fratello Luciano ed altre due persone. Poi si è rimangiato tutto, con un video fatto immediatamente prima di abbandonare il rifugio protetto dove era stato nascosto: «Ho confessato perché ero manipolato dalla Dda di Reggio Calabria», cioè a suo dire dall’allora procuratore capo Giuseppe Pignatone, adesso a Roma, dell’aggiunto Michele Prestipino, del pm Beatrice Ronchi e dell’ex capo della mobile Renato Cortese, che oggi dirige la squadra mobile di Roma. Ma c’è un giudice a cui Lo Giudice chiede scusa: è l’ex procuratore aggiunto della Dna Alberto Cisterna, che non nega la frequentazione con il presunto boss ma sostiene che la cosca Lo Giudice l’avrebbe smantellata nel 1993 arrestando il padre. C’è un rapporto stilato dall’attuale capo della Mobile di Torino Luigi Silipo che confermerebbe la pericolosità della loro frequentazione, ma Cisterna si è imbufalito e ha querelato il funzionario, incassando una denuncia di calunnia da parte di Silipo e una conseguente assoluzione, anche se il pm della procura di Reggio Matteo Centini aveva chiesto per Cisterna una condanna a due anni. Il problema è che c’è di mezzo anche un pm che indaga(va) sulla presunta trattativa Stato-mafia, legato a doppio filo con Cisterna e Lo Giudice: si chiama Gianfranco Donadio e secondo Lo Giudice gli avrebbe chiesto di accusare falsamente Berlusconi e Dell’Utri, oltre ad altre persone a lui sconosciute. Ma cosa c’entra Cisterna con la mafia? Bisogna ricordarsi che l’ex braccio destro di Pietro Grasso era stato sentito dai magistrati della Procura di Palermo, come persona informata sui fatti perché, come viceprocuratore della Dna, sarebbe venuto a conoscenza di episodi inediti che avrebbero preceduto la cattura di Bernardo Provenzano. Grasso aveva delegato proprio Cisterna ai rapporti con la Procura di Palermo, compito poi interrotto a seguito del procedimento disciplinare scaturito dall’inchiesta per corruzione in atti giudiziari istruita dalla Procura di Reggio, all’epoca guidata da Pignatone. Cisterna è innocente, l’inchiesta è stata archiviata e molti punti restano tutti da chiarire, anche perché sull’inchiesta Stato-mafia (e sul ruolo della ‘ndrangheta in quegli anni, soprattutto) è tutto in divenire. Ma se ci fossero altri magistrati in riva allo Stretto collusi con le cosche?
Accusato di corruzione, Mollace: “Solo spazzatura e servile disprezzo mediatico”. Su "Strill". Riceviamo e pubblichiamo dal magistrato Francesco Mollace – «Apprendo dai soliti ben accreditati nelle stanze giudiziarie che la Procura di Catanzaro avrebbe depositato una richiesta di rinvio a giudizio nei miei confronti. Resto in attesa di riceverne conferma ufficiale e nei modi previsti dalla legge, ammesso che il rispetto dei diritti dei cittadini abbia ancora un qualche valore in certi palazzi. Con la serenità di chi non ha niente da farsi perdonare e niente da nascondere, sono certo che un giudice terzo e imparziale saprà fare giustizia della spazzatura raccolta in alcuni anni di indagini e di servile dileggio mediatico. Per mio conto sono sicuro di aver dimostrato con documenti inoppugnabili di avere circa venti anni fa arrestato, fatto condannare e determinato alla collaborazione componenti dell’allora cosca Lo Giudice. Mai ricevuto niente da chicchessia. L accusa è fondata su illazioni e le regole del processo mi rendono sereno. Francesco Mollace».
Il fratello del pm antimafia al ricevimento del boss. A essere immortalato mentre partecipa al ricevimento della nipote paterna del boss Antonio Pelle, alias Gambazza, e del nipote del boss Antonio Nirta, è Vincenzo Mollace, scrive Luca Rocca su “Il Tempo”. Nozze, clan e parenti stretti dei pm antimafia. Ad essere immortalato mentre partecipa al ricevimento della nipote paterna del boss Antonio Pelle, alias Gambazza, e del nipote del boss Antonio Nirta, detto «il terribile», è Vincenzo Mollace, fratello «scomodo» del magistrato antimafia Francesco Mollace, di recente trasferito dalla procura di Reggio Calabria a Roma. Lo scenario è un ristorante di Gerace, nella locride. Il dvd che ritrae il fratello del pm mentre s’intrattiene, fra un pasto e l’altro, coi più potenti boss calabresi, è contenuto in un’informativa dei carabinieri di Locri, nelle cui mani è finito praticamente per caso. Siamo nel gennaio 2010 e il reparto speciale «Cacciatori» dell’Arma è sulle tracce di un pericoloso latitante: Stefano Mammoliti. Irrompono nella casa di un secondo latitante di San Luca convinti di scovare la loro preda, ma non trovano nessuno. Si imbattono, però, nel dvd e nel visionarlo restano basiti: a tavola coi mammasantissima c’è infatti Vincenzo Mollace, docente universitario, fratello del pm antimafia e all’epoca dei fatti direttore generale dell’Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Calabria. Nell’informativa gli uomini dell’Arma scrivono: «Si nota di spalle con cappotto e cappello di colore scuro Mollace Vincenzo nella zona antistante il buffet, vicino a un soggetto anziano con la coppola, successivamente di fianco vicino a due soggetti di spalle e a Nirta Antonio, alias “terribile”, padre dello sposo, mentre parlano». Intorno a loro, che bevono vino, chiacchierano e mangiano, anche Rocco Morabito, «successore» del boss Giuseppe Morabito «u tiradrittu», e Bruno Gioffrè, che nella «cupola calabrese» occupa il secondo posto più importante. Fra i commensali, come riportato nell’informativa, anche due politici locali: Tommaso Mittiga, sindaco di Bovalino di area Pd, e Domenico Savica, suo «oppositore» in consiglio comunale. Il filmato rinvenuto dai carabinieri fa da riscontro a molti elementi contenuti nelle carte dell’operazione «Inganno» che un mese fa ha portato agli arresti dell’ex sindaco di San Luca, Sebastiano Giorgi, e della «paladina antimafia» Rosy Canale, coordinatrice del «Movimento delle donne di San Luca». Ed è nel corso di questa operazione che gli investigatori hanno intercettato l’ex sindaco Giorgi mentre affermava che gli incontri tra Vincenzo Mollace e i boss si sarebbero intensificati a ridosso delle ultime elezioni regionali. Gli inquirenti si soffermano anche sui rapporti tra Savica e Vincenzo Mollace e dello stesso Savica con Antonio Stefano Caridi, oggi senatore del Nuovo Centrodestra.
CITTADINI. MANIFESTARE E DEVASTARE. IMPUNITA’ CERTA.
Manifestare e Devastare in città? Un Reato ampiamente impunito!
Negozi, banche, auto in fiamme, vetrine infrante, gente e turisti in fuga terrorizzati, scontri con la polizia, alcuni agenti feriti. E' sfociata in terrore e devastazione nel cuore della città la giornata inaugurale di Expo, l'evento universale inaugurato l'1 maggio 2015, a Milano. Al corteo del No Expo Mayday Parade organizzato nel pomeriggio. Come temuto ed ampiamente previsto, hanno preso il sopravvento i pochi black bloc e le fasce più violente e la manifestazione è presto degenerata.
La polizia nei giorni precedenti ha sfoggiato mediaticamente il suo impegno, mostrando alle telecamere qualche arnese atto ad offendere rinvenuto in una casa occupata dai "No Tav", tacitando così le preoccupazioni dei milanesi. Una delle tante case di proprietà occupate abusivamente da tante sigle vicine alla sinistra.
Circa la violenza unilaterale dei manifestanti scoppiata a Milano ognuno dice la sua. A destra sono pronti a solidarizzare con le forze dell'ordine, a prescindere dal loro operato; a sinistra sono dediti a rimarcare e difendere il diritto a poter manifestare il proprio punto di vista, scambiando la locuzione con “ogni mezzo”, appunto, anche con l’uso della violenza, usata spesso contro i beni di quei lavoratori, che a parole dicono di rappresentare. Quella sinistra che si riempie la bocca del termine “Legalità”, fino ad ingozzarsi, fino a soffocarsi.
Chiediamo cosa ne pensa lo scrittore Antonio Giangrande, che, autore della collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo", con decine di saggi pubblicati su Amazon, Google libri, Lulu e Create Space, dice la sua, invece, rispetto al diritto ed agli interessi dei cittadini danneggiati e trascurati.
«La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto riconosciuto negli ordinamenti democratici. Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni.
Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: Art. 19: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
La libertà di espressione è sancita anche dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848: “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.”
La Costituzione italiana del 1948 supera l'esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all'art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Durante il periodo fascista queste leggi dello Stato diventeranno delle censure, tipiche dei regimi totalitari. L'art. 21 della Costituzione stabilisce che:
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”
Ebbene, in Italia, se scrivi in stato di disomologazione al sistema mediatico o in dissenso al sistema di potere, a cui la stampa è genuflessa, i giudici te la fanno pagare.
Ma con il paraculo del diritto di manifestare in piazza si genera la più grande sorta di illegalità impunita che il paese ricordi. E dire che queste manifestazioni si palesano proprio come protesta contro le illegalità. Ognuno di noi che volesse commettere reati a iosa, sicuri di farla franca, basterebbe partecipare ad una manifestazione organizzata, spesso, dalla sinistra e l’impunità è compiuta.
"Abbiamo spaccato un po' di roba", è giusto così. A parlare è un ragazzo intervistato dalla troupe di TgCom24. Nessuna paura di ammetterlo e nessuna giustificazione, anzi, per lui è solo “bordello”. "Siamo arrivati, c'era un bordello, abbiamo spaccato un po' di roba", ha ammesso. Il giornalista chiede il perché e la sua risposta è secca: "Perché è la protesta, e alle proteste si fa bordello. È giusto così, noi dobbiamo far sentire la nostra voce. Se non lo capiscono con le buone, lo capiranno in altro modo. È stata una bella esperienza. Ero solo in mezzo a una guerriglia e mi sono preso bene, ma non ho distrutto un cazzo di nulla".
Eppure nelle manifestazioni di piazza ci sono talmente tante violazioni del codice penale che ne basterebbe una a far scattare l’arresto.
Dispositivo dell'art. 419 Codice Penale: "Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito". E poi quante violazioni penali cerchi, tante ne trovi. E comunque basta il sol travisamento a far scattare le manette.
Genova, sette studenti condannati per travisamento ad una manifestazione contro la Gelmini, scrive Genova Today. Una sciarpa che copre il volto per sfuggire all'occhio "invadente" delle telecamere Digos. Una mano sulla bocca per non respirare l'odore acre dei lacrimogeni. O un cappello "tenuto basso" per non essere del tutto riconoscibili: scene classiche da manifestazioni. Scene che da oggi potrebbero essere punite con il carcere. E' questo, in soldoni, quello che prevede una condanna del tribunale della Procura di Genova che ha disposto pene variabili fra i nove e i quattordici mesi per sette persone accusate di resistenza e "travisamento". Gli accusati, sette studenti liguri che parteciparono ad una manifestazione del 30 novembre 2010 contro l'allora ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini, sono stati condannati per avere nascosto il proprio volto nelle fasi calde del corteo. Tradotto: la Procura non ha accertato che i sette ragazzi in questione abbiano partecipato a scontri o disordini, dato che nella sentenza non vi si fa riferimento, ma li ha condannati "semplicemente" perché si sono resi non riconoscibili. Nello specifico, le condanne fanno riferimento ai momenti successivi ad una carica della polizia. Azione che gli agenti non annunciarono, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del Tulps, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede la "intimazione formale al discioglimento di un corteo". Agli avvocati dei giovani, che avevano puntato su questa "mancanza" da parte delle forze dell'ordine, il pubblico ministero Biagio Mazzeo ha spiegato che "si tratta di un provvedimento desueto e comunque, con tutti i tagli che devono subire le forze dell'ordine probabilmente non avevano neppure la possibilità di portarsi dietro un megafono". Insomma, condanna sia. Condanna, giunta pochi giorni fa, che rischia di inaugurare una giurisprudenza alquanto pericolosa. Appare troppo sottile, infatti, il confine fra la giusta necessità di punire i manifestanti facinorosi e l'eccesso di condannare chiunque si renda irriconoscibile durante una manifestazione. Ma non è tutto. Sotto la Lanterna, infatti, sono in corso almeno un'altra decina di indagini su cortei e proteste simili, riguardanti in particolare lo sciopero del 6 maggio 2011 e il corteo del 28 gennaio che vide in piazza studenti e operai al grido di "noi la crisi non la paghiamo". Le indagini, a questo punto sembra scontato, si chiuderanno con un processo e con altre condanne. Ma anche qui, la procura ligure potrebbe stupire. Oltre alle "storiche" pene per travisamento, infatti, molti dei ragazzi indagati, fra "anarchici noti" e semplici studenti, rischiano una somma di condanne e quindi il carcere per la "reiterata partecipazione a cortei". Insomma, i giovani che abbiano partecipato a più di una delle proteste finite nel mirino della procura rischiano le manette, perché colpevoli in più di un'occasione di "travisamento", anche se i cortei nella realtà non si siano trasformati in guerriglia. Le condanne di questi giorni, comunque, non stanno stupendo più di tanto Genova, una città che, da due anni a questa parte, ha subito una "gestione giudiziaria della piazza". Per l'esattezza da quando, un paio di anni fa, il procuratore aggiunto Vincenzo Scolastico elaborò una "griglia" nella quale incrociare date dei cortei, nomi dei partecipanti, denunce e qualsiasi manifestazione dove la Digos avesse ripreso delle immagini. A quanto pare, la "griglia" sta cominciando a dare i suoi effetti.
Invece a Milano la polizia che fa: niente!!!
E non è certo l’alibi della nuova legge sulla tortura che li sprona a rimanere inermi di fronte alla commissione di reati, né può essere colpa degli agenti che, oltretutto, sono i primi a prender botte da manifestanti, spesso, figli di papà o figli proprio di quelle istituzioni che dovrebbero reprimere e condannare i reati.
E non sono certo gli agenti a mancare. Questo passerà alla storia come il primo maggio più lungo di sempre. Complice l'inaugurazione di Expo 2015, 6.000 uomini delle forze dell'ordine italiane sono stati mobilitati per evitare che chi vuole rovinare la festa dei lavoratori sia fermato senza conseguenze. Avendo gli occhi del mondo puntati sull'area in cui si svolgerà l'esposizione universale, una falla nella sicurezza dell'evento non può essere permessa. Per questo il Viminale ha inviato 3796 uomini di rinforzo ai reparti già mobilitati su Milano, per l'intera durata della manifestazione. Queste forze aggiuntive andranno a sommarsi ai 2.000 addetti già disposti in città per i prossimi giorni, che si preannunciano da bollino rosso.
Eppure qualche centinaio di black bloc ha sopraffatto la forza dello Stato. Alla fine il bilancio dei numeri è di 11 feriti tra le forze dell'ordine e zero tra i violenti criminali manifestanti, oltre che 10 antagonisti accompagnati in questura. Cinque gli arresti in flagranza eseguiti dalle forze dell'ordine. Durante i disordini avvenuti a Milano al corteo No Expo sono stati lanciati 400 lacrimogeni. Il dato è stato fornito dalla Questura. Un risultato risicato a favore della polizia. Un po’ troppo poco per il costo subito dei danni subiti e il costo per mantenere tutta la struttura per proteggere la città.
E non credo che la colpa sia degli agenti, ma, forse, visti i risultati è colpa di chi li comanda? Non mancano le voci critiche, come quella di Matteo Salvini che si chiede "Renzi e Alfano, i danni ai cittadini li pagate voi?". E così pensa la gente.
C'è la rabbia della gente, tra le reazioni allo scempio che i No Expo hanno fatto questo pomeriggio a Milano scrive Libero Quotidiano il primo maggio 2015. Auto incendiate, cassonetti rovesciati, negozi dati alle fiamme, vetrine sfondate. Danni per milioni di euro. E la polizia che resta a guardare gli antagonisti che sfasciano tutto, limitandosi a contenere l'avanzata dei vandali e impedendogli di accedere alla zona rossa del centro. Una strategia assai diversa da quella adottata quattordici anni fa a Genova in occasione del G8. E la rabbia della gente esplode, pensando alle tante sentenze dei giudici contro la polizia (l'ultima quella sulla scuola Diaz) e l'introduzione del reato di tortura. "Attendere! Potrebbe scattare il reato di tortura!!!" scrive Vittorio. "Sono manifestanti pacifici. Perché fermarli? Sarebbe tortura" aggiunge Vittorio. Karl: "Fa bene a non intervenire...dopo certe sentenze!!!". La polizia ormai è stata disarmata da certe sentenze, dai buonisti, dagli ipergarantisti sinistronzi, da certa stampa e non sentendosi tutelata, resta a guardare in attesa di ordini da parte di organismi superiori anch'essi congelati da certe sentenze". Angelo: "Perché tanta meraviglia? dopo la condanna come torturatori e un capo che invece di difenderli li sospende...dopo giudici che mandano sempre liberi i delinquenti che vengono catturati perché mai i poliziotti dovrebbero rischiare di essere condannati.. un piffero disse "non siamo a Beirut" beh siamo peggio....". Maurizio: Quanti dei danneggiati di oggi hanno urlato contro la polizia cilena di Genova? Quanti hanno trattato il povero carabiniere Placanica come uno sfigato (loro, i ricconi radical-chic)? Quanti hanno votato per Heidi Giuliani, madre dell'eroe dei tempi moderni (emblema perfetto del gramo destino d'Italia)? Bene, spero che i danni riguardino solo loro. La polizia non faccia nulla, non meritano nulla". Giovanni: "non possono intervenire se no i giudici li condannano". Rul5646: Naturalmente grande scandalo se la polizia si permettesse di intervenire. Allora certa magistratura, certe esponentesse ed i buonisti in coro si indignerebbero infinitamente". E ancora: "E cosa potrebbero fare di più quei poveracci? Quei bastardi delinquenti sono sacri ed intoccabili per taluni magistrati e per tanti esponenti della politica italiana. Questa è l'Italia comunista!". Cheope: "La polizia aspetta......tanto sa che se anche li prendono , domani per ordine di qualche magistrato li mettono fuori. E intanto ci sono persone che hanno le auto incendiate, negozi sfasciati e tanta paura. E tutto questo con l'Expo non c'entra, è solo terrorismo". Poi c'è chi se la prende con Alfano: A O Anna 17 scrive: "Ma quel cretino di Alfano dove sta? Ah si è dimesso? Che fortuna. No no non si è dimesso, ma che schifo e non si vergogna?".
Appunto i No Expo sfasciano e incendiano, la polizia sta a guardare. Scene già viste tante volte, purtroppo: auto e negozi in fiamme, vetrine spaccate a martellate. Qualche anno fa era toccato a Buenos Aires, questa volta a via Carducci, una delle strade più eleganti e centrali di Milano. Dove i manifestanti No Global hanno bruciato due auto, sfasciato tutto lo sfasciabile e bruciato un paio di negozi con colonne di fumo nero alte decine di metri. Per mezz'ora la strada, lunga circa 500 metri tra corso Magenta e piazzale Cadorna, è rimasta in preda totale ai No Global. le forze dell'ordine sono state a guardare senza fare nulla, senza intervenire, senza impedire la devastazione. Solo dopo mezz'ora un mezzo antincendio è arrivato a spegnere le fiamme delle due auto. E solo a quel punto polizia e carabinieri hanno iniziato a intervenire con cariche e manganelli.
Una gestione "tattica" dell'ordine pubblico, non con l'obiettivo di impedire una quantità inevitabile di devastazione, ma di bloccare l'accesso al centro di Milano al blocco dei violenti senza coinvolgere negli scontri le migliaia di partecipanti pacifici alla May Day Parade contro l'Expo. Questa è stata la strategia messa in campo dalla questura di Milano - in accordo con le disposizioni del ministero degli Interni - per affrontare una giornata che fin dalla vigilia si annunciava assai critica. E che critica alla fine è stata, come vede ripercorrendo le strade del centro di Milano devastate dal passaggio dei Black bloc. Ma che ha portato al risultato che fin dall'inizio i vertici della polizia si erano dati: evitare che il giorno dell'inaugurazione di Expo si trasformasse in una specie di G8, con feriti da una parte e dall'altra. Lo scontro fisico è stato evitato. e poi...dalle 18 del primo maggio piazza della Scala è completamente blindata dalle forze dell’ordine da ogni accesso. Dopo la manifestazione con oltre 20 mila No Expo e trecento black bloc che hanno devastato Milano, la tensione è alta per l’inizio della Turandot, l’opera scelta dal teatro milanese per festeggiare l’inizio di Expo 2015.
Vuoi metter gli "Scalisti" con i cittadini danneggiati dai black bloc? Tutta un'altra musica!
E poi ci siamo noi cittadini, perché lì, a manifestare in piazza, ci vanno anche i nostri figli. Ma le mamme italiane dove sono? Perché non scendono pure loro in strada a prendere a sberle i figli che spaccano le vetrine e devastano le città? Questo si chiede Mario Giordano su “Libero Quotidiano”. Nei giorni scorsi siamo rimasti tutti colpiti da quella signora di Baltimora, di giallo vestita e di sganassoni munita: appena si è accorta che il suo adorato pargolo si era vestito da black bloc per fare a botte con la polizia, non ci ha pensato neppure un attimo. È scesa in strada, l’ha preso per la collottola, l’ha riempito di sberle e l’ha ricondotto sulla via della ragione. Un mito, certo. Ma che cosa impedisce alle mamme italiane di fare altrettanto? Si badi bene: quel che vale per la politica, vale anche per le violenze nello sport e nel calcio in particolare.»
LA SCUOLA DELL'INDOTTRINAMENTO IDEOLOGICO.
La sinistra si batte per eliminare ogni simbolo che inneggia all'italica tradizione ed appartenenza in nome di una sudditanza ideologica e strumentale.
Storia del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane di Rosci Valentina su “Diritto”. L’esposizione dei crocifissi nelle scuole pubbliche viene disposta mediante circolare con riferimento alla Legge Lanza del 1857 per la quale l’insegnamento della religione cattolica era fondamento e coronamento dell’istruzione cattolica, posto che quella era la religione di Stato. L’esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere, è data con ordinanza ministeriale 11 novembre 1923 n. 250, nelle aule giudiziarie con Circolare del Ministro Rocco, Ministro Grazia e Giustizia, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 recante “Collocazione del crocifisso nelle aule di udienza”, che recita: “Prescrivo che nelle aule d’udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocifisso, secondo la nostra tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e giustizia. I capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi con le Amministrazioni Comunali affinché quanto esposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte quale si conviene all’altissima funzione della giustizia”. In materia scolastica si ricordano, le norme regolamentari art. 118 Regio Decreto n. 965 del 1924 (relativamente agli istituti di istruzione media) e allegato C del Regio Decreto n. 1297 del 1928 (relativamente agli istituti di istruzione elementare), che dispongono che ogni aula abbia il crocifisso. Con circolare n. 367 del 1967, il Ministero dell’Istruzione ha inserito nell’elenco dell’arredamento della scuola dell’obbligo anche i crocifissi. Nei Patti Lateranensi e successivamente nelle modifiche apportate al Concordato con l’Accordo ratificato e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985 n.121, nulla viene stabilito relativamente all’esposizione del crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule del tribunale e negli altri luoghi nei quali il crocefisso trova ad essere esposto. Con parere n. 63 del 1988, infatti, il Consiglio di Stato ha stabilito che le norme dell’art 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e l’allegato C del R.D. del 26 aprile 1928 n. 1297, che prevedono l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica. Ha argomentato il Consiglio di Stato: premesso che “il Crocifisso, o più esattamente la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa, le norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Occorre, poi, anche considerare – continua il Consiglio di Stato – che la Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come il Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico”. Le norme citate dovrebbero, però, ritenersi implicitamente abrogate dal d.lgs. 297/94 in cui all’art. 107, nell’elencazione puntuale delle suppellettili che compongono l’arredo si fa riferimento esplicito solamente all’attrezzatura, l’arredamento e il materiale da gioco per la materna. In modo più chiaro ed esplicito l’art. 159 stabilisce “Spetta ai comuni prevedere al riscaldamento, all’illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari…”. L’art. 190 stabilisce che “i Comuni sono tenuti a fornire (…) l’arredamento” dei locali delle scuole medie. Nessun riferimento al crocifisso. Sicchè si potrebbe sostenere che le norme dell’art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e l’allegato C del R.D. n. 1297 del 1928, dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate ex art. 15 preleggi, perché il d.lgs. 297/ 94 regola l’intera materia scolastica. Tuttavia restano in vigore in forza dell’art. 676 dello stesso decreto intitolato “norme di abrogazione” il quale dispone che “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Orbene, alla specificazione del contenuto minimo necessario delle locuzioni generali “arredi” ovvero “arredamenti” contenute negli artt. 107, 159 e 190 concorrono le due disposizioni regolamentari citate, comprendendovi anche il “crocifisso”. Così si può affermare che le disposizioni del d.lgs. 297/94, come specificate dalle norme regolamentari citate, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici. Conclusivamente, poiché non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute, né può configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, già regolata da norme anteriori, né, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, attengono all’insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, le disposizioni di cui all’art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e quelle allegato C del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, devono ritenersi legittimamente operanti. La Corte di Cassazione (Sez. III, 13-10-1998) ha affermato in particolare, che non contrasta con il principio di libertà religiosa, formativa della Costituzione, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche: “Il principio della libertà religiosa, infatti, collegato a quello di uguaglianza, importa soltanto che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto, fermo restando che deve prevalere la tutela della libertà di coscienza soltanto quando la prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, abbia un contenuto contrastante, con l’espressione di detta libertà: condizione questa, non ravvisabile nella fattispecie”, nella quale si discuteva della lesività del principio di libertà religiosa proprio ad opera dell’esposizione del crocifisso nell’aula scolastica adibita a seggio elettorale. In una recente decisione, invece, la Cassazione ha ritenuto contraria al principio di laicità l’esposizione dei crocifissi nei seggi elettorali, prendendo ad esempio una decisione del Tribunale Costituzionale tedesco del 1995. Escluso che l’articolo 9 del nuovo Concordato con la Chiesa cattolica – in cui la Repubblica italiana prende atto che “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” – possa costruire idoneo fondamento normativo alla prassi amministrativa in materia, la Suprema Corte rigetta anche la “giustificazione culturale”, contraddicendo espressamente l’avviso del Consiglio di Stato. Non è sostenibile, infatti, “la giustificazione collegata al valore simbolico di un’intera civiltà o della coscienza etica collettiva”, per il contrasto in essa implicito con il divieto delle differenziazioni per motivi religiosi. È lecito esporre un crocifisso in un’aula scolastica, in un tribunale o in un ufficio pubblico, questa scelta può offendere la coscienza del non credente o dell’appartenente ad una confessione religiosa contraria a tale simbologia? L’esposizione contraddice la “laicità dello Stato”? E a che tipo di simbologia deve essere ascritto il crocifisso: identità religiosa o culturale? Nel corso dell’anno scolastico 2002-2003, Adel Smith, cittadino italiano di religione musulmana, domanda all’insegnante della scuola di Ofena (in provincia di L’Aquila), frequentata dai suoi figli, di rimuovere il crocifisso appeso alla parete o, in subordine, di appendervi un quadretto con la sura del Corano. L’insegnante accondiscende a questa seconda richiesta, ma viene smentita dal dirigente scolastico il quale impone di rimuovere il quadretto. Assistito da un avvocato, Adel Smith ricorre al Tribunale di L’Aquila per ottenere un pronunciamento d’urgenza. Investito della questione, il Tribunale ribadisce il carattere laico della Repubblica italiana e delle sue istituzioni e il 23 ottobre decreta la rimozione del crocifisso. Un’ordinanza successiva ha invece revocato tale rimozione poiché ha ritenuto che l’istanza presentata non integrasse una domanda “meramente risarcitoria”, ma si concretizzasse nella richiesta di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella gestione del servizio scolastico, dal che la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La rimozione del crocifisso scatena un’aggressiva polemica pubblica e una vera e propria campagna per il rilancio del crocifisso così che la maggior parte degli italiani hanno fatto questo tipo di ragionamento: “L’offesa è grande. Insopportabile. Una prevaricazione. Un esproprio. Un Tizio entra nel tuo alloggio, si accomoda in poltrona, ha libero accesso al frigorifero, usa il tuo bagno e invece di ringraziare per l’ospitalità, ti ingiunge di togliere dalla parete quel “coso” lì. Sarà anche un coso ma permetti decido io se deve restare lì o sparire”. Un ragionamento un po’ rozzo ma tale vicenda ci fa comprendere che oggi la questione dei simboli religiosi, a partire dal sostrato argomentativo connesso alla rivendicazione della libertà di coscienza e della neutralità dello Stato, può trasformarsi in un momento di “scontro tra religioni e civiltà”. Una questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal TAR del Veneto, avente ad oggetto gli artt. 159 e 190 del d. lgls. n. 297 del 1994, come specificati dall’art. 119 allegato C del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 e dall’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924 n. 965, nella parte in cui includono il crocefisso tra gli arredi scolastici, nonché l’art. 676 d.lgs. 297/94, nella parte in cui conferma la vigenza degli artt. 119 allegato C del R.D. 1297/28 e 118 del R.D. 965/24. Il Tribunale remittente sostiene che il crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso cristiano, di univoco significato confessionale, che l’imposizione della sua affissione nelle aule scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di laicità, desunto dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione, e con la conseguente posizione di equidistanza e di imparzialità fra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere; che la presenza del crocifisso, che verrebbe obbligatoriamente imposta ad alunni, genitori e insegnanti, delineerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata posizione di privilegio. La Corte Costituzionale con ordinanza 389/2004 ha ritenuto di non doversi pronunziare in quanto le norme in esame hanno natura regolamentare, norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né conseguentemente, un intervento interpretativo. In questa prospettiva, l’ordinanza della Corte, con le sue argomentazioni tecniche, pare suggerire un inasprimento di toni senza rinunciare a continuare ad interrogarsi. Tuttavia il dibattito in corso sull’esposizione del crocifisso pare sempre meno legato alla religione, alla religiosità e alla fede e invece strumentalizzato dai politici di destra e di sinistra.
Crocifisso a scuola, assolta l'Italia. Ribaltata la condanna del 2009. Chi ha ragione? si chiede G. Galeazzi su su “La Stampa”. Il crocefisso può restare appeso nelle aule delle scuole pubbliche italiane. Questo è quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, che con una sentenza definitiva della Grande Camera, votata da 15 giudici su 17, ha dichiarato che la presenza in classe di questo simbolo non lede nè il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni, nè il diritto degli alunni alla libertà di pensiero, di coscienza o di religione. Per il governo italiano e il fronte pro-crocefisso è una vittoria a tutto campo. Nel motivare la sua decisione la Corte afferma come il margine di manovra dello Stato in questioni che attengono alla religione e al mantenimento delle tradizioni sia molto ampio. Ma i quindici giudici che hanno votato a favore della piena assoluzione delle autorità italiane sono andati oltre. Nella sentenza si legge infatti come la Corte non abbia trovato prove che la presenza di un simbolo religioso in una classe scolastica possa influenzare gli alunni. E come nonostante la presenza del crocefisso (definito simbolo passivo) conferisca alla religione maggioritaria una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico, questo non sia sufficiente a indicare che sia in atto un processo di indottrinamento. Si sottolinea infatti che nel giudicare gli effetti della maggiore visibilità data al cristianesimo nelle scuole si deve tener conto che nel curriculum didattico non esiste un corso obbligatorio di religione cristiana e che l’ambiente scolastico italiano è aperto ad altre religioni. Nessun commento dall’avvocato Nicolò Paoletti, difensore di Soile Lautsi, la cittadina italiana di origini finlandesi che aveva presentato ricorso alla Corte. Dichiarazioni euforiche, invece, di coloro che hanno strenuamente difeso l’importanza della presenza del crocifisso nelle scuole italiane. «È una pagina di speranza per tutta l’Europa», ha commentato monsignor Aldo Giordano appena il presidente della Corte di Strasburgo, Jean Paul Costa, è uscito dall’aula dopo la lettura della sentenza. Il rappresentante della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa ha quindi sottolineato come la Corte abbia preso una posizione coraggiosa e abbia tenuto conto delle preoccupazioni che in questo momento gli europei esprimono nei riguardi delle loro tradizioni, dei loro valori e della loro identità. Gli ha fatto eco il vice ministro della giustizia russo, Georgy Matyushkin, che è intervenuto davanti alla Grande Camera in favore dell’Italia ed è volato appositamente da Mosca per assistere alla lettura della sentenza. Il minisro russo si è detto «molto soddisfatto per l’approccio della Corte». Ma anche il direttore dello European Centre for Law and Justice, Gregor Puppinck, ha definito la sentenza «un colpo che mette un freno alle tendenze laiciste della Corte di Strasburgo e che costituisce un cambiamento di paradigma». Lo European Centre for Law and Justice era una delle organizzazioni no profit che si erano costituite parte terza a favore dell’Italia nel procedimento. Alla lettura della sentenza, che è avvenuta in un’aula piena di studenti e funzionari del Consiglio d’Europa, erano presenti anche l’ambasciatore italiano Sergio Busetto, oltre agli ambasciatori cipriota e greco e ai rappresentanti della diplomazia armena, lituana, e di San Marino. Tutti Paesi che assieme a Bulgaria, Romania, Malta e Principato di Monaco erano intervenuti a favore dell’Italia. La sentenza emessa oggi mette la parola fine al ricorso «Lautsi contro Italia». Un fascicolo che fu aperto dalla Corte nel 2006 e che nel 2009, con una sentenza in primo grado a favore delle tesi della ricorrente, suscitò una vera alzata di scudi contro la Corte. L’indignazione fu tale che il governo italiano ricorse immediatamente, chiedendo e ottenendo la revisione del caso da parte della Grande Camera. In questo suo appello, andato a buon fine, l’Italia ha potuto contare non solo sui dieci Paesi che «ufficialmente» si sono presentati come parti terze davanti alla Corte, ma anche sul contributo di diverse ong, di parlamentari italiani ed europei e del lavoro diplomatico condotto dal rappresentante della Santa Sede. «Esprimo profonda soddisfazione per la sentenza della Corte di Strasburgo, un pronunciamento nel quale si riconosce la gran parte del popolo italiano. Si tratta di una grande vittoria per la difesa di un simbolo irrinunciabile della storia e dell’identità culturale del nostro Paese», ha dichiara il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini. «Il Crocifisso sintetizza i valori del Cristianesimo, i principi sui cui poggia la cultura europea e la stessa civiltà occidentale: il rispetto della dignità della persona umana e della sua libertà. È un simbolo dunque che non divide ma unisce e la sua presenza, anche nelle aule scolastiche, non rappresenta una minaccia nè alla laicità dello Stato, nè alla libertà religiosa. Oggi è un giorno importante per l’Europa e le sue istituzioni che finalmente, grazie a questa sentenza, si riavvicinano alle idee e alla sensibilità più profonda dei cittadini», ha concluso il ministro.
Toglie il crocifisso dall’aula. «Non me ne faccio nulla». Il simbolo religioso scompare pochi giorni dopo l’inizio della scuola. Gragagnani (Pdl): «Va rimesso, è una questione di libertà», scrive Francesco Alberti su “Il Corriere sella Sera”. Il caso di un’insegnante in una prima elementare. Il simbolo religioso scompare pochi giorni dopo l’inizio della scuola. Gragagnani (Pdl): «Va rimesso, è una questione di libertà». Via un altro. L’ennesimo. Tolto dalla parete a cui era appeso da anni. E scoppia la polemica. C’è chi parla di «strage dei crocifissi». E chi, più laicamente, si rifugia nel concetto di tolleranza e invita al reciproco rispetto. Siamo a Bologna, nella scuola elementare «Bombicci», classe prima B. Il simbolo religioso scompare pochi giorni prima dell’inizio delle lezioni. Qualcuno, probabilmente dall’interno della scuola, avverte l’ex parlamentare pdl Fabio Garagnani, personaggio piuttosto combattivo in materia, che parte in quarta, informando della rimozione il ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, e il vicedirettore regionale dell’ufficio scolastico, Stefano Versari. Per nulla scandalizzato invece il preside del comprensivo di cui fa parte la scuola, Stefano Mari: «Non esiste alcuna legge dello Stato che impone l’obbligo di ostensione del crocifisso, ma solo un regolamento del 1928 sugli arredi scolastici, poi superato nel 1999 da norme che conferiscono autonomia ai singoli istituti: dipende dalla sensibilità dei docenti». A riprova di ciò, prosegue il dirigente, «negli istituti che fanno parte del mio comprensivo, che riunisce 1.400 studenti tra elementari e medie, in moltissime aule il crocifisso non c’è mai stato o è stato tolto, mentre in altre è presente». Un processo graduale, aggiunge, «avvenuto negli ultimi anni e quasi passato inosservato in un clima di reciproca tolleranza tra chi lo avrebbe voluto e chi no». Fino ad oggi. Ora la polemica rischia di montare. Il giornale dei vescovi, Avvenire , censura l’episodio, ricorda l’ordinanza del 2011 della Corte di Strasburgo che impose a una scuola media di Abano Terme (Padova) di riappendere il crocifisso, ma soprattutto riporta le parole di un calibro da novanta come il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli, il cui parere giuridico è agli antipodi di quello del preside Mari: «Non è rimesso alla scelta di qualcuno se togliere o meno il crocifisso - afferma il giurista -, non ci possono essere interpretazioni da scuola a scuola. Se è vero che la regolamentazione vigente sui simboli religiosi, che li vuole affissi nelle aule, può sembrare datata, è altrettanto vero che, chiamato a esprimersi, il Consiglio di Stato ne ha riaffermato la validità». Ma il preside insiste: «Credo che la questione vada risolta a livello amministrativo, è finito il tempo in cui tutto veniva deciso centralmente dal ministero». L’insegnante che ha tolto il crocifisso preferisce non esporsi. Raccontano che a chi le chiedeva spiegazioni sulla rimozione del simbolo avrebbe sbrigativamente risposto «di non farsene nulla». Il preside fa da scudo: «È inevitabile che sia turbata dalle polemiche, ma continua il suo lavoro e per ora non si registrano proteste dalle famiglie degli alunni». Ma Garagnani incalza: «È un problema di libertà, i genitori non si facciano intimidire».
Ma non solo oil crocifisso si vuol togliere. Anche il Presepe.
Il sottosegretario all'Istruzione: "Sì al presepe a scuola; vietarlo non aiuta l'integrazione". Gabriele Toccafondi, coordinatore regionale Ncd Toscana, sottosegretario di Stato all’Istruzione, e l'intervento su La Nazione: "Non interrompiamo le nostre tradizioni". Caro direttore, ho seguito con attenzione le inchieste dedicate da La Nazione ai “presepi vietati” nella nostra città. Questo tema ci permette di affrontare un dibattito sul rapporto tra identità e cultura nei Paesi occidentali secolarizzati e multiculturali, sui concetti di accoglienza e di dialogo. L’idea che per rispettare le altre culture e religioni sia necessario rinunciare alle proprie tradizioni, o rinnegarle, è un’idea decisamente bizzarra, che mai ha fatto parte della storia delle civiltà, e che si è affacciata nel mondo occidentale solo da pochissimi anni. Vietare il presepe non aiuta né il dialogo né l’integrazione, ma anzi sottolinea le differenze, allontana mondi che invece dovrebbero conoscersi e avvicinarsi. Come facciamo a dialogare con gli immigrati di altre culture e tradizioni, che vengono a vivere da noi, se non siamo in grado di trasmettere loro la nostra civiltà, le nostre usanze e le nostre credenze, ciò che abbiamo di bello? Il Natale è la memoria di un fatto storico e non solo un avvenimento di fede per molti credenti. E’ talmente un fatto riconosciuto e universale che ai bambini non puoi nascondere che si festeggia qualcosa durante Dicembre e così pur di nascondere la nascita di Gesù dentro una grotta in alcune scuole ci si inventa qualcosa da festeggiare: dall’albero di natale, alla neve fino a bizzarre creazioni come il topolino che porta i doni ai poveri o al pesciolino rosso dentro l’acquario. Non sarebbe più semplice dire le cose come stanno? E poi, sono davvero così sicuri, questi presidi e insegnanti che vietano il presepe, che gli alunni stranieri e le loro famiglie siano contrarie alla realizzazione della capannuccia negli istituti educativi? Io ricordo che proprio qui, a Firenze, esponenti di rilievo della comunità islamica locale dissero, qualche anno fa, che era opportuno e formativo che i loro figli potessero conoscere usanze e tradizioni del Paese in cui erano venuti a vivere. Impedire la realizzazione di un presepe in una scuola è un atto che reputo privo di ragioni, di un malinteso senso di laicità, che si nasconde dietro la presenza di alunni stranieri o di altre religioni, ma che nulla ha a che vedere con una sana laicità positiva, in grado di accogliere e valorizzare, non di censurare. Come stabilito anche dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 2011, neppure il crocifisso esposto nelle aule scolastiche viola il principio della laicità degli istituti educativi. Che male può fare un simbolo come il presepe? Mi auguro che i docenti e dirigenti scolastici che hanno impedito a tanti bambini di avere una capannuccia nelle loro scuole, riconsiderino la loro decisione, in questi ultimi giorni prima del Natale: perché un vero dialogo con chi appartiene a tradizioni culturali diverse si può impostare solo valorizzando e facendo conoscere le radici più profonde della nostra identità.
Il presepe, bersaglio sbagliato, scrive Edoardo Crisafulli su “Avanti On line”. Un Preside ha vietato il Presepe, “un focus cerimoniale e rituale che può risultare soverchiante”: gli alunni di origine straniera, cospicua minoranza nella sua scuola, subirebbero l’imposizione di “ciò che non appartiene” loro. Concordo sul fatto che “la scuola pubblica è di tutti e non va creata alcuna occasione di discriminazione.” Ma questa decisione mi pare assurda. Il Presepe fa parte della cultura italiana come l’arte sacra, la musica barocca e la Divina Commedia. Non è un mero simbolo di fede. Sarebbe folle pretendere che l’alunno islamico (o buddista o quel che è) si converta al cristianesimo. Ma chi vuole integrarsi in Italia deve assimilare la nostra cultura. Altrimenti sarà un cittadino privo di un’identità. Non c’è bisogno di credere nella resurrezione di Cristo per ammirare la pittura di Giotto e la poesia di Dante, così come non occorre compiere sacrifici a Giove per apprezzare la mitologia classica. Il cristianesimo, inteso come fenomeno culturale, non deve apparire estraneo, o alienante, a chi ha scelto di vivere a casa nostra. I cristiani d’Oriente non studiano forse il Corano, un vero e proprio capolavoro linguistico, nonché testo di base della civiltà arabo-islamica, cui anche loro appartengono? Nessun cristiano colto nega che l’arabo classico — la koiné di tutti gli arabi – è, essenzialmente, una lingua coranica. Se c’è un simbolo più religioso che culturale, quello è il crocefisso. Ma il Preside, che ha “cose più importanti” di cui occuparsi, ha deciso di lasciarlo “appeso ai muri”. Se lo togliesse, i credenti ne farebbero “una questione di Stato”. Più facile bandire l’innocuo Presepe, che spunta a ridosso del Natale, per poi svanire subito dopo l’Epifania. Una volta affermato il principio demenziale che il Presepe offende la sensibilità islamica, dove arriveremo? Proibiremo la lettura a scuola del Canto XXVIII dell’Inferno dantesco, perché il Profeta Maometto vi compare nella veste sommamente offensiva di un dannato squarciato dal mento fin dove si “trulla”; punizione vergognosa, riservata agli scismatici, ai seminatori di discordia, come erano reputati i musulmani nel Medioevo? E metteremo alla berlina il Manzoni cristiano in quanto credente in una divinità falsa e bugiarda? No, non è questo il compito di una scuola laica, che forma i cittadini della polis secolare. Il vero laico è un liberale, un libertario. La laicità è una neutralità attiva: lo Stato laico non propaganda né una singola religione né l’ateismo; crea semplicemente le condizioni politiche che garantiscono la libertà di culto. La censura del Presepe non è un’affermazione di laicità, e non è neppure frutto della degenerazione di uno spirito laico intollerante. È piuttosto figlia del politically correct saccente e confusionario che imperversa da anni negli Stati Uniti, e che ora è approdato sulle nostre coste. Un multiculturalismo di bassa lega, con una spruzzata di giacobinismo a senso unico (l’unica tradizione da azzerare è la nostra), viene spacciato come una riedizione dell’Illuminismo progressista. I sacerdoti del politically correct, in nome della tolleranza verso lo straniero e il diverso, impongono forme subdole di censura o di auto-censura: chi non si adegua ai loro dettami subisce una gogna mediatica. Il multiculturalista serio è fatto di tutt’altra pasta: ama la diversità, perché è consapevole che il pluralismo religioso/culturale arricchisce la società civile. A una condizione, però: che venga rispettata la libertà e la dignità di tutti. Solo così il principio liberale è adattabile al mondo cosmopolita d’oggi. La cifra del laico autentico, peraltro, è la coerenza: anche quando degenera nella polemica anti-religiosa, ha il coraggio di prendersela ex aequo con preti, rabbini, imam e monaci: per lui, tutte le religioni positive sono ricettacoli di superstizione e di fanatismo. Mica rinnega la sua tradizione culturale per esaltarne una straniera, esotica, perché così va di moda nei circoli radical-chic! In certi ambienti di sinistra invece si usano due pesi e due misure: si insorge (giustamente) quando viene offeso l’islam, ma si tace o si gongola se qualcuno dissacra il cristianesimo o inveisce contro il Papa (da questo punto di vista, Oriana Fallaci non aveva tutti i torti). Agli apostoli del multiculturalismo suggerisco la lettura di Innamorato dell’Islam, credente in Cristo, di Paolo Dall’Oglio, il gesuita rapito dai jihadisti in Siria, il quale ha dedicato la sua vita al dialogo interreligioso basato sulla reciprocità. Se noi dobbiamo rispettare l’islam, i musulmani devono fare altrettanto con noi. Il dialogo interreligioso è una faccenda maledettamente seria: Dall’Oglio, forse, ci ha rimesso la pelle. Ho avuto l’onore di conoscerlo a Damasco, nel 2011. È stato lui a insegnarmi una grande verità, valida anche per chi non è credente: per confrontarmi con chi crede in un Dio diverso dal mio, non devo rinnegare la mia religione. Tutt’altro: la devo professare (o difendere) con orgoglio. Cosa fare, allora? Abolire l’insegnamento del cattolicesimo nella scuola pubblica (unico vero vulnus alla laicità), oppure garantire, per equità, la medesima importanza a tutte le religioni professate dai cittadini italiani? A mio avviso, l’educazione religiosa, fatto di coscienza individuale, spetta alle famiglie, non allo Stato. Sarebbe sbagliato inaugurare una sorta di carnevale variopinto di tutte le fedi. Lo Stato, però, ha il dovere di insegnare la storia del cristianesimo, quale disciplina curricolare. Che sia un docente di lettere o di storia a insegnarla, laicamente. La nostra civiltà ha radici cristiane, oltreché pagane (greco-romane) – e qui consiglio, a chi pencola verso le tesi dei teocon, il saggio di Luciano Pellicani, Le radici pagane d’Europa. Il vero scandalo, oggi, non è il Presepe: è l’ignoranza: i nostri figli non conoscono le parabole evangeliche e le narrazioni bibliche. Senza quei codici culturali, tanta parte della nostra letteratura e della nostra tradizione artistica risulta incomprensibile. Anche la polemica sui crocefissi la risolverei in chiave culturale: sostituiamo quelli bruttissimi di plastica con riproduzioni di Giotto o di Cimabue. Che ogni classe adotti una croce dipinta della tradizione pittorica italiana. Trasformare un fenomeno artistico, qual è il Presepe, in un simbolo religioso, è anche un grave errore politico. I fascio-leghisti non si sono fatti sfuggire l’occasione per specularci sopra: “Ecco la sinistra che plaude all’Eurabia islamizzata!’ Non lasciamo la difesa delle nostre tradizioni alla Lega e a Casa Pound: la rappresentazione della natività – l’espressione più poetica della religiosità popolare italiana – fu inventata da San Francesco d’Assisi. Per testimoniare, ogni anno, la nascita in assoluta povertà e umiltà di Cristo. Un messaggio formidabile per i creso-cristiani d’ogni tempo, che difendono a parole la cristianità mentre la tradiscono trescando con i potenti di turno. Riappropriamoci, noi socialisti, del Presepe e denunciamo l’uso politico distorto che ne fanno coloro che annacquano lo spirito rivoluzionario, sovversivo del cristianesimo. Ecco perché io, agnostico e laico-socialista, amo il Presepe e lo voglio esposto nei luoghi pubblici, così com’è: un bambino adagiato in una mangiatoia, in una grotta. E a chi sparge a piene mani il seme dell’odio e dell’intolleranza ricordo i bei versi di Trilussa “Ve ringrazio de core, brava gente/ pe’ ‘sti presepi che me preparate,/ ma che li fate a fa? Se poi v’odiate,/ si de st’amore non capite gnente…”.
La sinistra a favore dei mussulmani contro i cristiani. L'Islam astio al principio di reciprocità.
La persecuzione dei cristiani in Medio Oriente, scrive Salvatore Lazzara. Gesù nel Vangelo, ricorda ai discepoli: “Beati voi quando, vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”. La promessa di Gesù non prevede per i suoi seguaci vita facile. E’ il mistero della sequela, un cammino che costa a quanti aderiscono, un prezzo altissimo. In alcuni casi è richiesto il dono della vita, per testimoniare la fede nel Signore morto e Risorto. Già nel nuovo testamento sono registrati i primi attacchi contro i cristiani: dopo la morte in croce del maestro, i discepoli ebbero paura ad annunciare ciò che avevano visto e udito, per paura di essere uccisi. E’ necessario che il Risorto stesso indichi ai discepoli con le apparizioni nel giorno dopo il sabato, la via da seguire. Durante una riunione a porte chiuse, presente la Madre di Gesù Maria, ricevono il dono dello Spirito Santo, il quale li abilita a proclamare che Gesù è il Signore, e quanti ascoltano la loro parola, gli abitanti di Tiro, di Sidone, della Cappadocia, intendono nella loro lingua il messaggio del Dio fatto carne e crocifisso per la salvezza degli uomini. Da questo punto in poi, i discepoli vivranno incomprensioni, delusioni, tradimenti, fino a versare il sangue per la fede. Il primo martire di cui abbiamo notizia è Stefano, il quale viene ucciso brutalmente perché si rifiutava di rinnegare Gesù. Sono esemplari le ultime parole pronunciate da questo discepolo del Signore, che ricalcano quelle dette da Gesù sulla croce prima di morire. La tradizione dei primi secoli ha tramandato alcuni atti dei primi martiri della fede, molto suggestivi e pieni di spunti di riflessione. Le persecuzioni si scatenano contro i cristiani quando non vogliono cedere ai compromessi o alle false divinità. Tutto ciò produce odio, perché la parola di Dio condanna il male e ciò che di brutto il mondo possiede. Cito per tutti san’Ignazio di Antiochia, il quale catturato non volle essere liberato per diventare nelle mandibole dei leoni frumento di Cristo macinato per la salvezza del mondo. Certamente non possiamo analizzare i motivi e le lunghe persecuzioni cruente dei cristiani nell’arco dei 2000 anni, ma possiamo sintetizzare i vari periodi per comprendere il faticoso annuncio della Parola di Dio all’umanità. Fino al quarto secolo, i vari imperatori romani nel vasto territorio sotto la loro giurisdizione, tentarono in tutti i modi di eliminare il Cristianesimo che si diffondeva sempre più attraverso le vie commerciali, con la complicità di alcuni ufficiali militari, che avendo sentito ciò che Gesù aveva fatto ad alcuni colleghi, come ad esempio la guarigione del figlio del centurione, -il quale prima dell’ingresso del Signore nella sua casa esclamò-: “Guarda io non sono degno che tu entri nella mia casa, ma dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito…”-, suscitava in quanti ascoltavano sentimenti profondi di commozione e di partecipazione. La “nuova fede”, fece breccia sugli schiavi, i quali vedevano nel Cristianesimo, la liberazione dalla condizione di oppressi. Sappiamo dai racconti, che molti di essi erano a servizio dei potenti del tempo. Venendo a contatto con loro, cominciarono a convertirsi per la fedeltà che i servi mostravano verso la nuova religione. Tutto ciò turbava gli equilibri politici, sociali e religiosi del tempo. Sentendo odore di minaccia al potere costituito il cristianesimo, cominciò ad essere perseguitato in tutto l’impero con le grandi campagne messe in atto da Diocleziano, Tito, Nerone, il quale accusò i cristiani di essere responsabili del famoso rogo-incendio di Roma, che lui stesso aveva fatto appiccare. Per giustificare le efferate esecuzioni e sbarazzarsi di questa nuova forma di religiosità, Nerone non ebbe scrupoli ad addebitare ai cristiani un atto che non avevano commesso, soltanto per placare la sua coscienza ed affermare il personale potere nei confronti dei sudditi. Con la conversione di Costantino al cristianesimo, cominciò un era di pace e di libertà. Cominciarono le costruzioni delle Basiliche, e il culto era permesso alla luce del sole. Il cristianesimo a poco a poco cominciò a diventare parte strutturale della società, arrivando a permeare la vita dei fedeli in modo totalizzante. Certamente non siamo qui ad esaminare tutti gli aspetti positivi e negativi del processo storico descritto, ciò che conta e comprendere la difficoltà in cui ad esempio si trova oggi l’espansione dell’Islam, alla luce di quanto ho affermato. Ai tempi di Costantino, il potere sociale e religioso erano uniti indissolubilmente. L’imperatore era il depositario, il custode del creato, perché da Dio riceveva la potestà di governare. Dunque dalla religione partiva ogni input per regolare la vita della società. Ogni cosa era subordinata alla Bibbia, e dalla Scrittura si prendeva ispirazione per stabilire le leggi etiche e morali. Questo sistema naturalmente ha subito parecchie modifiche nel tempo, fino ad arrivare ai tempi odierni, portando dietro di se integralismi, fondamentalismi, e tante volte scelte sbagliate che hanno causato la morte di tanta gente innocente. Dobbiamo purtroppo dire che lo schema citato, ha portato a persecuzioni accanite contro i cristiani e viceversa. Questa struttura ancora oggi è usata dall’Islam nei paesi a maggioranza musulmana. E’ il Corano con le sue leggi a determinare il corretto svolgimento della vita dei cittadini. Ogni cosa prende spunto e trae ispirazione dalla parola di Allah. Tutto ciò che non coincide con il predicato religioso islamico, deve essere abbattuto con ogni mezzo. Ogni musulmano è chiamato ad osservare il Corano, e da esso prendere spunto per la vita familiare e relazionale. Le società islamiche oggi vengono classificate in moderate e radicali. E’ una divisione che a me personalmente crea diverse perplessità e problemi. Cosa significa essere moderati? Forse non usare la violenza per convertire? Oppure cosa significa radicali? Usare la violenza come via per raggiungere la conversione degli infedeli a scapito del dialogo e della civile e pacifica convivenza con chi non accetta l’Islam? Sono domande complicate, da cui nasce la confusione e la persecuzione di cui noi oggi siamo testimoni contro i cristiani in generale e le minoranze religiose. Nei paesi musulmani, generalmente ai cristiani è riconosciuta la libertà di professare la loro fede, ma con limitazioni in alcuni paesi. In Arabia Saudita è formalmente vietata ogni religione che non sia quella musulmana; la presenza di stranieri cristiani è tacitamente tollerata, ma essi non possono in alcun modo manifestare la propria fede. Persino il possesso della Bibbia è considerato un crimine. In generale nei paesi arabi i cristiani sono oggetto, da parte della popolazione musulmana, di forme di discriminazione più o meno gravi, che negli ultimi decenni hanno portato molti di loro a emigrare o a convertirsi all’Islam. La popolazione cristiana è in calo pronunciato in tutti i paesi del Medio Oriente. La conversione di musulmani al cristianesimo è poi vista come un crimine (apostasia) e, anche nei paesi in cui la legge la consente, i convertiti sono spesso oggetto di minacce e vendette da parte della popolazione. Mentre in Occidente si combatte ogni forma di religiosità di carattere cristiano in nome di una falsa laicità aggressiva, in alcuni paesi a maggioranza islamica il percorso è inverso. I musulmani al potere cercano in tutti i modi di “islamizzare” gli stati in cui sono a maggioranza con leggi che favoriscono lo sviluppo dell’Islam, ma che penalizzano di molto le altre religioni, le quali strette nella morsa della persecuzione diventano sempre più minoritarie. In Europa la confusione ideologica porta allo smantellamento culturale, causando effetti devastanti: la costruzione di moschee, il Real Madrid ha dovuto togliere la croce della scudetto perché il maggiore azionista della squadra è diventato un famoso emiro musulmano, le continue polemiche contro l’allestimento dei presepi, l’insegnamento della religione nelle scuole, il crocifisso nelle aule pubbliche, le difficoltà relazionali in alcune città europee importanti a maggioranza musulmana che avanza silenziosa, la natalità, gli investimenti economici, fanno parte di una persecuzione precisa e metodica contro i cristiani portata avanti dai cosiddetti moderati, che pur non prevedendo il sacrificio cruento con lo spargimento del sangue, condiziona la libertà del cristianesimo in nome della tolleranza e dell’accoglienza. A questo punto possiamo fare un accenno all’epoca delle Crociate, considerate a torto come persecuzioni contro i non cristiani, ma il tempo a disposizione è poco. Contrariamente a quanto è stato affermato dai libri di storia foraggiati dai nemici del cristianesimo, -come possiamo vedere dall’immagine- (foto 1), avevano uno scopo chiaro e limpido: difendere i luoghi santi dalle invasioni islamiche. Mentre le conquiste musulmane avevano ed hanno come obiettivo la conquista dei territori, per convertire all’Islam gli infedeli, contrariamente i crociati difendevano e riconquistavano con la forza i luoghi santi. Certamente non tutto è stato rose e fiori…. Ma permettetemi di dire che bisognerebbe rivedere con onestà queste pagine di storia senza i pregiudizi di quanti avversano in tutti i modi la presenza cristiana nel mondo. I cristiani a Gerusalemme e a Nazareth sono ormai il 2 per cento, mentre la nazione con il maggior numero di cristiani resta il Libano. Se ne contano approssimativamente il 35 per cento, ma in diminuzione rispetto a qualche anno fa. “Più i cristiani lasciano il Paese, più i cristiani diventano un’esigua minoranza, più alcuni principi della modernità, come ad esempio i diritti umani, vengono a cadere”, avverte il gesuita egiziano padre Samir, esperto di questioni mediorientali. “Con la diminuzione degli elementi cristiani si fa un passo indietro nell’economia ma, ancor di più nella politica, e soprattutto in tutto ciò che è legato ai diritti umani: la situazione della donna, la libertà religiosa, la libertà tout court, il progresso sociale, i diritti sociali per i più poveri e i deboli”. Anche per questo motivo sentiamo tra i musulmani – intellettuali e non solo, politici e anche gente di media cultura – dire: “Per favore, non andatevene! Rimanete! Abbiamo vissuto insieme per secoli!”. Dal 2000 ad oggi i cristiani vittime di persecuzioni sono stati 160.000 ogni anno. Ogni 5 minuti un cristiano viene ucciso a causa della propria fede.
Don Salvatore Lazzara - Sacerdote da 17 anni, è cappellano militare all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Da Cappellano Militare ha svolto i seguenti incarichi: Maricentro (MM) La Spezia, Nave San Giusto con la campagna addestrativa nel Sud Est Asiatico, X° Gruppo Navale in Sinai per la missione di Pace MFO. Successivamente trasferito alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Ha partecipato alla missione in Bosnia con i Carabinieri dell’MSU. Di ritorno dalla missione è stato trasferito alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Dopo l’esperienza nei Carabinieri è tornato a Palermo presso i Lanceri d’Aosta (Esercito). Per Da Porta Sant’Anna curava inizialmente la rubrica “Al Pozzo di Sicar”; da Luglio 2014 ha assunto il ruolo di Direttore del Portale.
E poi c'è lei. Peppa Pig. Oggetto di strali dei benpensanti.
E' attualmente il cartone animato più famoso e visto al mondo, ma anche dai genitori che, in caso di stanchezza giornaliera, piazzano i figli davanti alla tv, incantati dal maialinio super star. Ma ora Peppa Pig finisce nell'occhio del ciclone. Tutto per una presunta parolaccia pronunciata dal maialino in un nuovo episodio. E ora le mamme protestano: "Siamo scioccate". A denunciare l'episodio è Natalie, una mamma inglese di 30 anni che si è resa conto del turpiloquio di Peppa Pig dopo che la sua bambina aveva ripetuto una strana parola. L'episodio incriminato è in un DVD in cui si fa un riferimento a una band. Da "Rocking Gazzelle" diventano "Fucking Gazelle", almeno secondo quanto ha capito la mamma. "Sono scioccata", ha detto la donna al Daily Mail. "Quando ho sentito mia figlia dire certe parole l'ho rimproverata ma poi mi sono resa conto che era tutta colpa del cartone". La donna si sente responsabile e colpevole e conclude dicendo che non permetterà mai più ai suoi bambini di vedere il cartone. Anche Peppa Pig potrebbe rimanere vittima dell’elevato livello di attenzione per la prevenzione degli attentati. La simpatica maialina rosa potrebbe essere messa al bando. Le nuove linee guida della Oxford University Press, la casa editrice dell'ateneo inglese che pubblica testi scolastici e prodotti editoriali educativi. Secondo queste indicazioni c’è il divieto di pubblicazione di riferimento al maiale e alla sua carne per non offendere i musulmani e gli ebrei. L’Università è un’autorità negli ambienti culturali inglesi e, se dovessero essere accolti i suggerimenti, il cartone animato che fa impazzire i bambini di tutto il mondo potrebbe essere messo al bando. La censura dell’Università arriva subito dopo gli attentati di Parigi. Sulla questione sono intervenute perfino le comunità ebraiche e musulmane che hanno definito la vicenda un tentativo “politically correct senza senso”.
Liberateci da Peppa Pig: sta rovinando i nostri bambini, scrive di Lucia Esposito su “Libero Quotidiano”. C'era una volta Heidi che faceva "ciao" alle caprette e aiutava l'amica Clara in carrozzina, c'erano i Barbapapà animalisti ed ecologisti che ci lasciavano di stucco coi loro "barbatrucchi" e le trasformazioni più improbabili. C'era Winnie the Pooh, l'orsetto grasso che lievitava all'ombra del bosco dei cento acri bevendo ettolitri di miele ma capace di grandissimi gesti di amicizia. C'era la cagnetta Pimpa che perdeva per strada le sue macchie rosse ma che faceva la felicità del suo padrone Armando… Mai si erano visti in televisione dei maiali che ruttano senza ritegno, grugniscono in continuazione, si rotolano nel fango allegramente e che, quando ridono, si ribaltano sul pavimento sbellicandosi come idioti. Liberatemi, vi prego, dalla famiglia Pig. Qualcuno mi spieghi cosa c'è di educativo in questo cartone che sta lentamente trasformando mio figlio di tre anni in un suino. «Tu sei mamma Pig», mi dice quando si sveglia. «No, Francesco io non sono un maiale», gli rispondo piccata. Lui arriccia il naso, dice «oink» e scappa via. Quando al mattino va a scuola, si guarda attorno con la stessa attenzione con cui un bracco ungherese cerca i tartufi nel bosco e, appena intercetta una pozza d'acqua, si fionda per saltarci dentro. «Come Peppa Pig» salta e ride mentre i suoi occhi roteano come biglie per individuare un altro specchio d'acqua fangoso in cui rotolarsi come un porcellino. Inutile provare a spiegargli che i maialini sono sporchi e puzzano e che la loro casa, il porcile, è un posto lurido e nauseabondo. Lui dice che «Patata City» (la città in cui vive la maledetta famiglia Pig) è bella e pulita. Per non parlare del rutto tra una portata e l'altra, diventato la colonna sonora dei miei pasti. Davvero non so come sia capitato ma lo spirito della famiglia Pig si è impossessato di lui e viene fuori senza alcun ritegno proprio quando tutti tacciono e non si può far finta di non aver sentito. «Non si fa, i maiali lo fanno» e lui: «Ma io sono Peppa Pig». Allontanarlo dal tavolo non fa che scatenare il processo di identificazione con la famiglia di suini perché invece di piangere, invece di starsene umiliato in camera, va in bagno, prende il braccio della doccia fa cadere acqua sul pavimento e si mette a saltare nella pozza. Per chi è fuori da questo incubo perché non ha figli tra i due e gli otto anni, Peppa Pig è un cartone animato che ogni sera ipnotizza mezzo milione di bimbi. È la storia di una famiglia di maiali (mamma Pig, papà Pig, il fratellino George di due anni e la protagonista Peppa di quattro anni). I suini non vivono in un porcile ma, pur mantenendo comportamenti propri della specie, sono umanizzati. Il povero signor Pig, il padre, è un pasticcione inetto, incapace di fare qualsiasi cosa (in un episodio per piantare un chiodo, fa crollare una parete) che si fa prendere in giro dai figli senza dire un «oink» sia perché è più grasso del normale sia perché è un fallimento che cammina. Lui e sua moglie non sono in grado di dare una sola regola comportamentale ai figli e, quando ci provano, non sono credibili. Non si fanno rispettare. Peppa e George fanno quello che vogliono, inzozzano di fango la casa, rompono il pc con cui la mamma lavora. Viziati e ribelli, trasmettono ai bambini l'idea che tutti sono uguali, che la loro parola-grugnito vale quanto quella dei genitori. Vogliamo poi parlare di George? A due anni dice solo e sempre «dinosauo», attaccato come una cozza al suo peluche verde ripete ossessivamente le stesse cose da centinaia di puntate senza che nessuno (tranne Peppa Pig che lo chiama «tontolone») si faccia delle domande sull'evoluzione del linguaggio del piccolo, senza che nessuno gli spieghi che si dice «dinosauro» e gli dia qualche informazione in più sull'animale preistorico. I dialoghi sono semplici, il vocabolario basico, i personaggi ripetono sempre le stesse parole, il disegno dei cartoni è elementare, eppure i bambini sono pazzi di questi porcellini. Molti esperti dicono che Peppa Pig piace tanto perché riproduce un modello di “famiglia normale”: i genitori che vanno al lavoro, i figli affidati ai nonni, le gite della domenica, i capricci a cui non seguono punizioni... Adesso, gli psicologi avranno anche le loro ragioni ma io da un po' ho vietato al mio bimbo di vedere «Peppa Pig»: perché per me non è normale che a cena rutti con lo stesso orgoglio di chi prende dieci in pagella. Ridatemi i barbatrucchi di Barbapapà!
E poi Peppa Pig è un maiale e non è corretto parlarne in un'Italia Islamica voluta dalla sinistra contro gli italiani cattolici.
Follia islam, fatwa per fatwa. Vietati rock, calcio, cani e bici. Le scomuniche religiose possono costare la vita. Ma osservarle tutte vuol dire non vivere più, scrive Massimo M. Veronese su “Il Giornale”. Ha una fama sinistra ma la fatwa, o fatawi al plurale, in fondo, è solo un codice di comportamento quotidiano e non è obbligatorio rispettarlo. Per avere valore deve uscire dalla bocca di un'autorità religiosa, ma in troppi, hanno denunciato alcuni analisti algerini, si attribuiscono un ruolo nell'Islam e si sentono autorizzati a dettare legge a caso. Le fatawi vietano gadget, oroscopi, la riproduzione di cd e dvd. Per non dire del nuovo profumo «Victoria's Secret: Strawberries and Champagne» ritirato dal governo dagli scaffali di Doha senza bisogno di una fatwa perchè «va contro le abitudini, le tradizioni e i valori religiosi del Qatar». Ma in questi anni abbiamo visto anche di peggio.
Le palle di neve. É l'ultima in ordine di apparizione: vietato costruire pupazzi di neve in Arabia Saudita, fatwa dell'imam Mohammad Saleh Al Minjed. Dice che realizzare uomini o animali di neve è contrario all'Islam. Unica eccezione, riporta Gulf News , i pupazzi di neve raffiguranti soggetti inanimati cioè navi, frutta o case. La reazione però è stata piuttosto gelida.
I pokemon. Pikachu, Meowih, Bulbasaur, sono stati accusati di complotto giudaico-massonico, e messi al bando dallo sceicco saudita Yusuf al-Qaradawi, ideologo dei Fratelli musulmani. Vietata la loro vendita in tutta l'Arabia Saudita. I Pokemon, sentenzia la fatwa, si sono coalizzati per far diventare ebrei i musulmani. Bastasse un cartoon.
I tatuaggi. Fresca anche questa. La Direzione Affari Religiosi di Turchia guidata dal Gran Mufti Mehmet Gormez, principale autorità religiosa islamica del paese, ha emesso una fatwa contro i tatuaggi: «Allah ha maledetto coloro che cambiano il loro aspetto creato da Dio». Spacciati Materazzi e Belen.
Il calcio. La fatwa dello sceicco Abdallah Al Najdi si basa sul principio che vieta ai musulmani di imitare cristiani ed ebrei. Si può giocare ma con regole diverse: niente linee bianche in campo, niente squadre di 11 giocatori, porte senza traverse, chi grida gol va espulso e niente arbitro perchè superfluo. Come del resto nel nostro campionato...
I croissant. Ad Aleppo una commissione sulla sharia ha emanato un editto religioso contro il consumo di croissant, considerati il simbolo della colonizzazione dell'Occidente. Il babà invece va bene ma solo se si chiama alì...
La chat. Chi chatta online attraverso i social network con persone dell'altro sesso commette peccato. Lo stabilisce la fatwa dello sceicco Abdullah al-Mutlaq, membro della Commissione saudita degli studiosi islamici. Poi hanno fatto retromarcia: si riferiva a un caso isolato da non generalizzare. Non mi piace.
Il rock. L'ha decisa in Malaysia la Commissione del consiglio per gli affari islamici secondo la quale la musica rock va spenta perché fa male allo spirito. E c'è una variante, il black metal, che essendo dominata dall'immaginario occulto, ha il potere di traviare e stravolgere le anime dei giovani musulmani. Il liscio non si sa.
Il sesso. Fare l'amore si può. Ma non nudi. «Esserlo durante l'atto sessuale invalida il matrimonio» la fatwa imposta dallo sceicco Rashar Hassan Khalil. Non tutti sono d'accordo. Il presidente del comitato delle fatwa di alAzhar, Abdullah Megawer, ha corretto, come si suol dire, il tiro: nudità ammesse, ma a patto che i partner non si guardino.
La bicicletta. A lanciarla è stata la guida suprema della Repubblica islamica, l'ayatollah Ali Khamenei in persona: proibisce nel modo più assoluto la bici alle donne iraniane.
Il cane. Nonostante sia per l'Islam un animale impuro, il cane è molto diffuso come animale domestico in Iran. Così il grande ayatollah Nasser Makarem-Shirazi ha emesso la sua fatwa: «Non c'è dubbio che il cane sia un animale immondo». Pur ammettendo che il Corano non dice nulla in proposito. E allora?
Lo yoga. Oltre 10 milioni di persone hanno partecipano in India a una lezione di massa di yoga per il Guinness dei Primati. La cosa però non è piaciuta ai vertici religiosi musulmani di Bhopal che hanno lanciato una fatwa per condannare l'esercizio come «antislamico» e «pagano» per il riferimento al dio Surya.
La festa di compleanno. Celebrare compleanni e anniversari di nozze non può avere spazio nell'Islam. Lo dice il Gran Muftì dell'Arabia Saudita, Sheikh Abdul Aziz Al-Alsheikh. «Un musulmano dovrebbe solo ringraziare Allah se i suoi figli stanno bene e se la sua vita matrimoniale è buona». Le classiche nozze con i fichi secchi.
L'eclisse. Una fatwa lanciata dal gran mufti d'Egitto proibisce ai musulmani di osservare l'eclissi. «Mette in pericolo la vista dell'essere umano e poiché l'islam proibisce all'uomo di mettere in pericolo la sua vita è peccato guardare l'eclisse». E con questa siamo al buio pesto.
La sinistra tace sulla mercificazione dei bambini.
Nuovo video shock Isis, bambino spara ai prigionieri. Ragazzino di 10 anni giustizia due uomini, scrive Benedetta Guerrera su “L’Ansa”. Non c'è limite all'orrore jihadista: dopo le bambine kamikaze in Nigeria, costrette dai terroristi di Boko Haram a farsi saltare in aria imbottite di esplosivo, un nuovo terribile video dell'Isis mostra un ragazzino che impugna una pistola e fredda due ostaggi come un boia consumato. Immagini scioccanti, che dimostrano come la follia del terrore non si fermi più davanti a nulla. Nei nuovi otto minuti di orrore, pubblicati sui siti jihadisti e rilanciati dal Site (il sito Usa di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web), la scena è simile a tante altre diffuse in questi mesi di atroce propaganda da parte degli assassini dell'Isis. Solo che in questo caso, il boia ha il volto pulito di un bambino che non avrà neanche 10 anni. "L'Isis ha raggiunto un nuovo livello di depravazione morale: usano un bambino per giustiziare i loro prigionieri", ha commentato postando un fermo immagine del video sul suo account Twitter Rita Katz, la direttrice del Site. Le vittime vengono presentate come due kazaki, di 38 e 30 anni, accusati di essere "spie russe". Prima della loro esecuzione i due confessano di essere "agenti del Fsb", i servizi russi, inviati in Siria per raccogliere informazioni sui jihadisti e soprattutto sui 'foreign fighter' russi. Dalle parole delle due spie si evince che sono stati in Turchia sulle tracce di qualche 'pezzo grosso' dell'Isis, il cui nome è però omesso. Il più giovane dei due 'rivela' anche di essere stato reclutato per uccidere "un leader dello Stato islamico". Il filmato, intitolato "Uncovering the enemy within" (Scoprire il nemico interno) e targato al Hayat media center - la 'casa di produzione' dello Stato Islamico - è di ottima qualità e ha un montaggio quasi cinematografico. Al momento dell'esecuzione ad opera del bambino, i due uomini appaiono inginocchiati a terra e hanno le mani legate dietro la schiena. Non indossano la tradizionale tuta arancione dei prigionieri di Guantanamo, che di solito i jihadisti fanno mettere agli ostaggi occidentali, ma una divisa azzurra. Alle spalle dei due condannati ci sono il ragazzino armato di pistola e un terrorista con la barba lunga e il kalashnikov che parla in russo. E' lui che spinge il bambino verso le sue vittime. Proprio a questo punto, quasi a voler enfatizzare il momento, le immagini vengono trasmesse al rallentatore e con un gioco di dissolvenze, mentre il terrorista ripete le ennesime minacce ai "nemici di Allah": il ragazzino, che ha un vistoso orologio al polso e indossa una felpa nera e pantaloni mimetici come il suo 'superiore', solleva la pistola e spara un colpo alla testa di ciascuno dei due prigionieri. Un colpo secco, sulla nuca, con incredibile freddezza. I due cadono a terra, il ragazzino si avvicina e ne finisce uno con altri due spari. Poi solleva il braccio con la pistola in segno di vittoria e sorride. Un video agghiacciante, che potrebbe essere una squallida messa in scena, costruita ad arte dai jihadisti dell'Isis, abili comunicatori del terrore. Nonostante le due vittime vengano colpite alla testa infatti, non si vede il proiettile uscire, né il sangue sgorgare dalla nuca o dal collo. Ma sono immagini che comunque lasciano sgomenti. Anche perché subito dopo la sequenza dell'uccisione parte il frammento di un altro video che era già stato pubblicato dall'Isis a novembre in cui lo stesso ragazzino appare in un gruppo di bambini kazaki che si addestrano a usare i kalashnikov. "Sarò uno di quelli che vi sgozzerà, kafiri", diceva il ragazzino. Anche in quel caso il filmato era scioccante, quasi irreale. Una ventina di bambini che smontavano e riassemblavano kalashnikov e poi miravano inginocchiati ai loro bersagli. "Sono la nuova generazione, saranno loro che scuoteranno la Terra", recitava una voce fuori campo.
Quanti sono i bambini soldato nel mondo. Il report redatto dall'Ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite prende in esame i paesi dove è stata confermato l'utilizzo di minori arruolati sia dalle forze governative che da altri gruppi armati, e riporta i dati, ove ci sono, dei nuovi reclutamenti confermati nel 2013, scrive Cristina Da Rold su “L’Espresso” Il fenomeno dei bambini soldato pesa sempre di più, ma non si può contare. Le stime riportate da Amnesty International parlano di 300 mila bambini coinvolti in conflitti armati nel mondo, il 40% dei quali sarebbero bambine. L'Onu ne stima 250 mila. Se si cerca di definire con maggior dettaglio i contorni del fenomeno, il profilo diventa infatti subito sfumato. UNICEF, Human Right Watch, Child Soldier International, Amnesty International, le Nazioni Unite e molte altre realtà che si occupano di salvaguardare le condizioni dei minori nelle aree colpite dalla guerra, riportano la presenza ancora oggi come cinquant'anni fa, di bambini soldato, maschi e femmine, in molti paesi del mondo, dall'Africa al Sud America, al Medio Oriente. Secondo le stime UNICEF per esempio sarebbero 9000 i bambini soldato coinvolti in Sud Sudan, 2500 in India e addirittura 10000 quelli che avrebbero abbracciato le armi nella Repubblica Centrafricana. Tuttavia non ci sono dati certi e le stime spesso divergono di molto fra di loro, soprattutto in ragione della fluidità del fenomeno. Ogni anno infatti vengono effettuati numerosi raid fra la popolazione civile, più o meno noti alle milizie internazionali, dove vengono reclutati nuovi bambini da inserire nelle file degli eserciti, governativi e non. Al tempo stesso però altri vengono sottratti alle forze armate grazie all'azione di realtà come le Nazioni Unite. Il bilancio è dunque difficile. Il punto di riferimento più recente e più dettagliato in questo senso è un Report redatto dall'Ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite Children and armed conflict, che prende in esame i paesi dove è stata confermato l'utilizzo di bambini soldato sia dalle forze governative che da altri gruppi armati, e riporta i dati, ove ci sono, dei nuovi reclutamenti confermati nel 2013. Come emerge dalla mappa però, solo per una parte di questi paesi, quelli evidenziati in rosso, le Nazioni Unite sono in grado di fornire dei numeri. Per gli altri, quelli colorati in nero, la presenza di bambini soldato per quanto accertata, non è quantificata con esattezza.
Armi giocattolo e fiabe sui martiri, niente tv. Ecco come si educa un bambino al jihad. Nel manuale per la donna jihadista, i consigli pratici per diventare la mamma perfetta. E insegnare ai figli ad essere «combattenti e ad avere paura solo di Allah: la chiave è iniziare a istillare questi valori quando sono ancora piccoli», scrive Daniele Castellani Perelli “L’Espresso”. Niente tv. Sì a pistole giocattolo e freccette. E prima di andare a nanna una bella favola sul jihad. Queste sono solo alcune delle regole che deve seguire una mamma perfetta per educare un piccolo jihadista. Il testo è uno di quelli per cui un mese fa Runa Khan, una donna di Luton, mamma di 6 bambini, è stata condannata in Inghilterra a cinque anni per aver incitato su Facebook al terrorismo. Fa parte di un vero manuale per la donna jihadista, chiamato “Il ruolo della Sorella nel Jihad”. Ma la sezione più interessante è sicuramente quella dedicata all'educazione dei bambini, una specie di “Emilio” rousseauiano pensato per il jihad. Lo è alla luce del ruolo centrale che i bambini sembrano avere nella strategia e nella propaganda dei terroristi islamici, quasi fossero impegnati nella costruzione di un uomo nuovo, fin dai primi anni. Lo confermano ora due notizie macabre degli ultimi giorni: il video del bambino kazako che, puntando una pistola, ucciderebbe per lo Stato Islamico due presunte spie russe e poi festeggia il suo gesto (in realtà dal video non è dmostrato che sia stato lui a ucciderli), e l'uso di almeno una bambina ricoperta di esplosivo per degli attentati compiuti da parte dell'organizzazione nigeriana Boko Haram. Ma già in precedenza erano note le tante foto di bambini vestiti con i simboli dell'Isis che circolano da tempo su Twitter e gli altri social media, tra cui quelle del britannico Siddhartha Dhar in posa con neonato e fucile, ma anche quella di Ismail, di Longarone, in Veneto, che il padre Ismar Mesinovic ha portato con sé in guerra strappandolo alla madre cubana. Alla stessa Runa Khan, 35 anni, sono state trovate foto dei figli con pistole e spade, ma aveva anche indicato dettagli del modo in cui raggiungere la guerra in Siria dall'Inghilterra e su un sito per estremisti si era augurata che un giorno suo figlio diventasse un jihadista. Il manuale era già noto da qualche anno agli specialisti, ma secondo l'istituto americano Memri (Middle East Media Research Institute) ora è tornato particolarmente in auge proprio per l'Isis. Lo dimostra lo stesso caso di Runa Khan, che quel testo l'ha pubblicato su Facebook nel settembre del 2013. Ma cosa dice esattamente il manuale? Nel capitolo “Come educare bambini mujahid (combattente nel jihad, ndr)” si descrive questo compito come «forse il più importante per le donne». Si deve insegnare ai bambini, che siano maschi o femmine, «ad avere paura solo di Allah»: «La chiave è iniziare a istillare questi valori quando sono ancora piccoli. Non aspettate che raggiungano i sette anni, potrebbe essere troppo tardi!». Poi ecco i consigli: «Racconta loro storie della buonanotte che parlino dei martiri e dei mujahideen. Sottolinea che non devono colpire i musulmani, anzi perdonarli, e che devono esprimere la loro rabbia sui nemici di Allah che combattono contro i musulmani. Magari crea un surrogato di nemico, ad esempio un sacco da colpire, e incoraggia i bambini, specialmente i maschi, a usarlo, a costruire la propria forza così come a imparare a controllarsi e a saper dirigere la propria rabbia». E per quanto riguarda lo svago? «Elimina se puoi completamente la tv, che perlopiù insegna cose senza vergogna, anarchia e violenza casuale. Inoltre la tv instilla pigrizia e passività, e contribuisce a un abbandono mentale e fisico. Se non puoi proprio eliminarla, usala per video che trasmettano l'amore per Allah e per il jihad. Ce ne sono alcuni anche sull'addestramento militare». Per i videogiochi il discorso è simile. Meglio di no, ma se proprio non può farne a meno allora sì a quelli militari. Il manuale invita poi a comparare «queste caratteristiche con gli aspetti salutari del gioco e dello sport, da cui può trarre beneficio in termini di disciplina e forza fisica». Qualche esempio? Il tiro al bersaglio con armi giocattolo, il tiro con l'arco e le freccette, «che permettono di sviluppare un buon coordinamento mano-occhio», e giochi militari che siano divertenti. Quanto agli sport, sì a arti marziali, nuoto, equitazione, ginnastica, sci, e poi altre attività come la guida di veicoli, l'orientamento nei boschi, il campeggio e l'addestramento per la sopravvivenza. Ci sono anche consigli di lettura, ovvero libri militari («meglio se con le figure») e siti web, il tutto già a partire da quando il bambino ha «due anni o anche meno»: «Non sottovalutate l'effetto duraturo di ciò che quelle piccole orecchie e quei piccoli occhi possono assimilare nei primi anni di vita!». Il manuale ricorda che «i bambini imitano quello che fanno gli adulti», e invita a iniziare sin dai primi anni perché così «non affronteranno poi battaglie interne quando diventeranno più grandi e saranno più coinvolti nel mondo». Ma a giudicare dalle notizie degli ultimi giorni bisogna dire che questo è un testo a suo modo moderato, laddove ad esempio raccomanda di non tenere le armi vere alla portata dei bambini, e di non usarle davanti a loro, oppure di non uccidere altri musulmani. Vuol dire che Isis e Boko Haram hanno alzato ancora più in là l'asticella. È la conferma che il jihadista di oggi è ancora più spietato di quello di ieri. È una nuova generazione.
Non solo apologia dell'Islam, ma anche tentativo di resuscitare una ideologia morta in nome di una falsa tolleranza.
I partigiani e la lezione di comunismo alle elementari. In Romagna l'Anpi celebra il Pci in un libro per le elementari. E le famiglie romene insorgono, scrive Paolo Bracalini su “Il Giornale”. «Papà cosa vuol dire "utero in affitto"?». Domande che ti vengono, all'età di dieci anni, solo se ti capita di leggere di femminismo, comunismo, guerra partigiana e D'Alema, in un libretto gentilmente donato dall'Anpi locale alle scuole elementari di Cervia, nella rossa Romagna, nel corso di una serie di lezioni. L'autore del librettino è Giampietro Lippi, presidente dell'Associazione nazionale partigiani a Cervia, «esponente del Pd» secondo un genitore di una delle scuole coinvolte, Raffaele Molinari, che sul suo blog denuncia l'«indottrinamento di partito» a spese dei bambini. Nel libretto distribuito nelle classi di quinta elementare, nel corso di vari incontri a scuola, non si rievocherebbe solo la storia dei partigiani e delle staffette, perché «tutte le storie sono raccontate per rendere idilliaco il ricordo del Pci, con innumerevoli note dove si citano personaggi del grande Partito comunista, le immagini col pugno alzato... Insomma comunismo ovunque», lamenta Molinari. Il quale riporta alcuni passi del libretto per rendere meglio l'idea: «Ho incontrato allora tanta brava gente. Tra i tanti, uno che ricordo con stima e simpatia, era il padre del nostro D'Alema, che aveva come nome di battaglia "Braccio"». O anche quest'altro: «Le portava l'Unità , perché la leggesse e incominciasse ad interessarsi alle cose vere della vita, ed Anna poco alla volta capì che era importante scegliere il fronte politico con il quale accasarsi e scelse il Pci». I genitori hanno chiesto spiegazioni alla scuola: «Dalle informazioni raccolte in un colloquio con la maestra - spiega Molinari - è risultato che Lippi è stato autorizzato ufficiosamente dalla direzione didattica di Cervia. Non una visita occasionale, ma un vero e proprio programma di lezioni, per tre settimane. Una sorta di arruolamento in vista del settantesimo anno della liberazione di Cervia». Il presidente dell'Anpi di Cervia, invece, è sconcertato dalle accuse: «Assurde, fuori luogo, senza senso - ci spiega al telefono - Io non faccio politica, racconto la storia, se le staffette partigiane erano comuniste o socialiste cosa devo farci, nasconderlo? Io sono un ex democristiano, si figuri, anche se adesso sì, sono iscritto al Pd. Questa iniziativa nelle scuole è nata insieme all'amministrazione comunale (guidata dal Pd, ndr ) e alla direzione didattica, per coinvolgere le scuole nel settantesimo anniversario della Liberazione a Cervia. C'è una bella differenza tra fare propaganda di partito e parlare delle staffette partigiane! Sono sconcertato dal livello culturale di certa gente, non meravigliamoci se l'Italia va male». I più arrabbiati per la sua iniziativa sono i genitori immigrati dall'Europa dell'Est, che del comunismo hanno un ricordo più vivo. Sui cancelli della scuola hanno appeso dei cartelli: «No al comunismo nelle scuole», «Il comunismo rovina i nostri figli», in romeno e altre lingue slave. E, mentre si parla di denunce partite all'indirizzo del presidente Anpi, oggi i genitori inscenano un corteo silenzioso nel centro della città: «In piedi, senza schiamazzi, senza rumore, reggendo in mano un libro di storia come segno della nostra protesta».
"Sì agli immigrati, convinci un leghista". Così la scuola indottrina i nostri figli. Bufera per il tema assegnato da un insegnante agli allievi di una scuola vicentina. Il Carroccio: "È inaccettabile", scrive Giovanni Masini su “Il Giornale”. Un clamoroso caso di indottrinamento politico: è questa l'accusa con cui la Lega Nord del Veneto si scaglia contro un insegnante dell'istituto "Ceccato" di Thiene, in provincia di Vicenza, reo di aver assegnato agli studenti un tema dal titolo "Persuadi un tuo compagno leghista che l'immigrazione non è un problema bensì una risorsa". In difesa del Carroccio si è levata l'europarlamentare Mara Bizzotto, che della Lega è anche vicepresidente regionale: "Quanto successo all'istituto Ceccato è molto grave e conferma come esistano purtroppo insegnanti che mischiano, in modo scorretto e inaccettabile, i propri convincimenti politici con l'insegnamento - continua l'onorevole Bizzotto - La scuola dovrebbe essere un luogo di libertà e una palestra di educazione e di vita, non un luogo di indottrinamento politico secondo i convincimenti politici del professore di turno". "Bene hanno fatto i genitori e gli studenti che hanno segnalato questo grave comportamento da parte dell'insegnante che, mi auguro, sarà severamente ripreso dagli organi competenti - conclude la Bizzotto - I nostri ragazzi hanno bisogno di una scuola che insegni, che funzioni e che svolga il proprio ruolo: i professori che vogliono far comizi o proselitismi politici li devono fare rigorosamente fuori dalle classi e fuori dalle scuole!". L'episodio risale a qualche giorno prima delle ferie natalizie. "Un professore si permette - ha rincarato la dose il consigliere regionale leghista Nicola Finco - di dare giudizi politici in classe su un partito come se il problema in questi giorni non fosse l'islam; nel frattempo i benpensanti radical chic di sinistra si scandalizzano perchè l'assessore regionale all'Istruzione scrive alle scuole affinchè in classe si tratti del problema del terrorismo islamico che è solo e unicamente cronaca".
Tema: «Immigrati sono una risorsa convinci un tuo compagno leghista». La bufera sulla traccia assegnata agli studenti dell'istituto Ceccato di Thiene. Salvini: «Pazzesco». L’europarlamentare Fontana: Pd regali tessera al prof, scrive Elfrida Ragazzo su “Il Corriere della Sera”. La parola «leghista» nel testo di un’esercitazione di italiano scatena la polemica. A sollevarla è il Carroccio attraverso Michele Pesavento, della segreteria politica del partito di Vicenza. Sotto accusa è una traccia per un esercizio di argomentazione proposto da un’insegnante di lettere agli alunni di una classe terza dell’istituto tecnico Ceccato di Thiene. «Dopo aver preso in considerazione i dati sull’immigrazione in Italia e dopo aver letto l’articolo – si legge nel documento diffuso - scrivi un testo argomentativo in cui persuadi un tuo compagno leghista che il fenomeno migratorio non è un problema, bensì una risorsa». Venuto a conoscenza dell’accaduto da alcuni genitori, Pesavento attacca: «Quella traccia è offensiva e razzista, l’insegnante di lettere ha trasformato quell’aula in un “pensatoio politico”». Ed invita il preside a «vigilare su chi ha confuso l’istituto Ceccato con una tribuna elettorale» e la docente in questione «a lasciare a casa tessera e ideologie politiche». Interviene anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini: «Pazzesco!», Scrive in un tweet. Il consigliere regionale della Lega Nord Nicola Finco ricorda il caso sollevato da lui stesso sulla presenza dell’eurodeputata Alessandra Moretti, candidata alle elezioni regionali venete per il Pd, ad una festa di un istituto comprensivo di Arzignano prima di Natale. «Basta con la politica in classe. Le aule scolastiche non sono circoli del Partito democratico o della sinistra, serve rispetto – dice – Altrimenti i veri fondamentalisti non sono i leghisti, bensì certi professori di cui si può fare volentieri a meno. Invece di preoccuparsi di leghisti da persuadere, il docente potrebbe spiegare ai ragazzi cosa accade nel mondo in queste ore». L’europarlamentare della Lega Nord Lorenzo Fontana commenta sarcastico il caso di Thiene, Fontana chiosa serio: «La scuola è luogo di istruzione e formazione, non di propaganda politica, anche se è noto come sia un vizio storico della sinistra metterci becco. E poi quel professore dà per scontato l’assunto che l’immigrazione è una risorsa. E se un alunno non la pensasse così che succede? Mi piacerebbe conoscere i metodi di questo prof». E conclude: «Quel professore se proprio ha la fregola della politica può sempre iscriversi al Pd, sempre che non lo sia già. Ma fossi del Partito democratico gli regalerei la tessera. Motivazione: alti servigi al partito e alla causa della sinistra».
«Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza» (Dante Alighieri).
"La scuola italiana in tutti i suoi gradi e i suoi insegnamenti si ispiri alle idealità del Fascismo, educhi la gioventù italiana a comprendere il Fascismo, a nobilitarsi nel e a vivere nel clima storico creato dalla Rivoluzione fascista". Benito Mussolini. Il fascismo, fin dai primi anni in cui prese il potere si preoccupò di rafforzare le proprie basi ideologiche e il consenso sociale. Uno dei mezzi utilizzati era l'indottrinamento ideologico a partire dalla scuola. Dal neo-governo fascista venne, infatti, approvata la Riforma Gentile che proponeva una nuova forma di organizzazione scolastica, con l'introduzione dell'Esame di Maturità e la Religione come materia obbligatoria. Il partito si preoccupò anche di garantire un'impostazione dei vari programmi secondo un criterio nettamente di parte, introducendo testi scolastici come il noto libro di testo unico per le Elementari. All'organizzazione scolastica si aggiungevano varie forme di indottrinamento legate soprattutto all'attività fisica e alle parate.
Poi le cose son cambiate. E’ nato l’indottrinamento comunista e di sinistra in generale.
Scrive Giorgio Israel. Un ragazzino di 13 anni mi dice di detestare la letteratura. Il suo sguardo scettico, mentre gli vanto la bellezza dei classici e gli parlo della Divina Commedia, mi spinge a una sfida temeraria: «Te ne leggo un canto». Procedo temerariamente, aspettandomi sbadigli e il rigetto finale condito del tipico insofferente sarcasmo adolescenziale. E invece funziona. Tanto funziona che il ragazzino mi chiede se non potremmo fare altri incontri e continuare, e poi chiede: «Ma perché a scuola non ci fanno leggere testi così? Guarda invece cosa mi è toccato in questi giorni». È un brano di Gino Strada sugli “effetti collaterali delle guerre”. Lo leggo tutto e non ha niente di letterariamente valido: è una predica ideologica noiosa scritta in modesto italiano. Colgo l’occasione per sfogliare l’antologia del ragazzino: c’è da restare a bocca aperta. Al brano di Strada seguono due pagine di “competenze di lettura” dove l’alunno deve mostrare di aver capito il testo apponendo crocette nelle caselle giuste. Seguono pagine di indottrinamento sotto il titolo “che cosa succede nei paesi dove c’è la guerra”; poi ancora competenze di lettura e scrittura “contro la guerra”, per finire con una pagina incredibile. Contiene una serie di immagini, per lo più banali o stucchevoli, come quella di un gruppo di bambini a cavalcioni su un cannone, e prescrive il seguente compito: «osserva i cartelli contro la guerra, poi scrivi per ognuno una frase-slogan»…
Come la dobbiamo chiamare? Competenza di manifestazione di piazza? È finita qui?
Niente affatto. Seguono le “competenze grammaticali”, in cui l’alunno è invitato a mostrare di saper far uso della locuzione “sarebbe meglio”: riempi lo spazio con i puntini nella frase «Invece di fare la guerra, sarebbe meglio…», e così via. Seguono le “competenze di cittadinanza attiva”, in cui l’alunno deve dar prova di aver assimilato i concetti di conflitto, guerra e pace, costruendo una “mappa concettuale” sul tema. E, come se non bastasse, l’acme di un tormentone di decine di pagine è una “verifica di fine unità” e… una prova Invalsi. Non capisco in base a quale diritto la scuola pretenda di indottrinare i ragazzi all’idea che tutte le guerre siano egualmente sporche. Dovrei forse accettare che i miei figli considerino la guerra di liberazione dal nazifascismo – grazie alla quale sono potuti venire al mondo – alla stregua della guerra scatenata dalle armate hitleriane? Non saprei immaginare una prepotenza più oscena. Ma andiamo avanti. Ometto di fare un elenco completo degli autori che popolano l’antologia, per non offendere nessuno, anche se credo che né Jovanotti né Luciano Violante abbiano mai compreso nelle loro aspirazioni quella di competere con Tolstoj e Pirandello. Consiglio di sfogliare alcune delle antologie che circolano nelle nostre scuole per constatare che ormai questa è la concezione della letteratura che le ispira. E pongo alcune semplici domande.
Qualcuno può davvero seriamente pensare che questo sia un modo valido per instillare l’interesse per la letteratura, per la lettura, per la scrittura? Non è giunto il momento di interrogarsi seriamente sulla deriva che sta prendendo la funzione istituzionale dell’istruzione?
L’attuale dibattito sulla vicenda della lettura del romanzo di Melania Mazzucco in un liceo romano è tutto centrato attorno al dilemma se sia giusto o no scegliere dei testi adatti a combattere le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere o se tale scelta sia mera pornografia. Pare che per molti, inclusi alcuni dirigenti scolastici e insegnanti, la funzione della scuola sia ormai meramente ideologica. Si dirà che Melania Mazzucco è una vera scrittrice a differenza di Strada ma, la vera questione è se, a fronte del panorama sterminato di letteratura di livello indiscutibilmente alto, e con cui si potrebbero riempire decine di antologie, si preferisce cancellare Leopardi a vantaggio di testi il cui unico indiscutibile merito è di avere una funzione ideologica. Le denunce legali, che finiranno puntualmente nel nulla, sono un’azione senza senso. È più appropriato denunciare (in termini non legali) la deriva di una scuola che sta rinunciando all’educazione al bello, e la guarda con sarcasmo come se fosse orpello di altri tempi; che rinuncia ad appassionare i ragazzi al piacere di leggere prose e poesie di valore universale, a discuterli in classe senza questionari di competenze e senza pagine pieni di imbecilli quesiti a crocette; lasciando che la determinazione di posizioni su temi come il sesso, la famiglia, la guerra o l’ambiente, sia conseguenza della formazione libera di una personalità strutturata sull’amore per la conoscenza, la cultura, la bellezza artistica in tutte le sue forme. La scuola non dovrebbe impicciarsi di imbastire “lotte” contro questo o quello, di educare a pensare in questo o quel modo, di insegnare a compilare cartelli da portare in piazza, selezionando la letteratura su questi criteri. Perché, così facendo, la sua funzione educativa si trasforma in ciò che vi è di più brutto: l’indottrinamento ideologico. Brutto e diseducativo, perché è caratteristico delle società totalitarie e come tale stimola le peggiori forme di intolleranza.
Non potrò mai dimenticare che, all’indomani della caduta del Muro di Berlino, Alberto Lecco, un grande romanziere dimenticato – dal cui capolavoro “Anteguerra” si potrebbero trarre brani antologici ben più validi di quelli che vengono propinati – fece questo commento: «Il comunismo finito? Comincia solo adesso…». Aveva ragione. Il comunismo dei soviet, dei comitati centrali e delle commissioni centrali di controllo è finito da un pezzo. Ma il comunismo come costruttivismo sociale, come aspirazione a una società basata sull’indottrinamento ideologico, è più vivo che mai, metastatizzato nella forma del “politicamente corretto” che, sotto la veste di una bontà ipocrita e falsa, propina incessantemente le prescrizioni soffocanti di un conformismo sociale costruito a tavolino, in cui non c’è più spazio per il libero sviluppo della personalità.
L’intellighenzia sinistra non finisce mai di stupire, scrive “Il Fazioso”. Certi professoroni dei nostri licei, dopo l’abituale giro in sezione, si impegnano al massimo per trovare occasioni per fare della sana propaganda nelle scuole. E sono veramente fantasiosi se per il loro scopo piazzano a tradimento persino delle versioni di latino contro Berlusconi. Ora la prof mattacchiona tenta di difendersi in ogni modo, spiegando l’alta importanza didattica della versione. Il preside difende la docente parlando di tentativo di incuriosire gli studenti con l’attualità, ovviamente nessuno ha pensato all’opportunità di una versione palesemente contro il premier. Ma che sarà mai? Ci spiegheranno che non c’è dietrologia politica ma piuttosto educazione d’avanguardia. Il prossimo passo è portare Berlusconi nella matematica con qualche problema sul suo patrimonio finanziario (ovviamente condito da qualche passaggio denigratorio). Quanto sono furbi questi sinistri.
Istruzione o Indottrinamento? Si chiede David Icke su “Crepa nel Muro”. La "istruzione" esiste allo scopo di programmare, indottrinare e inculcare un convincimento collettivo in una realtà che ben si addica alla struttura del potere. Si tratta di subordinazione, di mentalità del non posso, e del non puoi, perché è questo ciò che il sistema vuole che ciascuno esprima nel corso nel proprio viaggio verso la tomba o il crematorio. Ciò che noi chiamiamo istruzione non apre la mente: la soffoca. Così come disse Albert Einstein, “l’unica cosa che interferisce con il mio apprendimento, è la mia istruzione.” Egli disse anche che "la istruzione è ciò che rimane dopo che si è dimenticato tutto quanto si è imparato a scuola." Perché i genitori sono orgogliosi nel vedere che i loro figli ricevono degli attestati di profitto per aver detto al sistema esattamente quanto esso vuole sentirsi dire? Non sto dicendo che le persone non debbano perseguire la conoscenza ma – se qui stiamo parlando di libertà – noi dovremmo poterlo fare alle nostre condizioni, non a quelle del sistema. C’è anche da riflettere sul fatto che i politici, i funzionari del governo e ancora giornalisti, scienziati, dottori, avvocati, giudici, capitani di industria e altri che amministrano o servono il sistema, invariabilmente sono passati attraverso la stessa macchina creatrice di menti (per l’indottrinamento), cioè la università. Triste a dirsi. Molto spesso si crede che la intelligenza e il passare degli esami siano la stessa cosa ... Una sera mi trovavo in discoteca, e la pista da ballo era vuota perché il DJ aveva messo su della musica che le persone non volevano ascoltare. Questo insopportabile egocentrico si rifiutò di cambiarla, e io chiesi se fosse una scelta così intelligente, date le circostanze. Quello si indignò. Aveva la prova di essere intelligente, avendo un diploma! Che ridere. La intelligenza fondamentalmente consiste nel rendersi conto che le persone non ballano perché la musica fa schifo, e nel mettere al suo posto qualcosa che piaccia; un diploma consiste nel dire al sistema ciò che esso ti ha detto di dire. Cosa c’è di intelligente in questo? Il sistema relativo alla istruzione, o Programma di Distribuzione Automatico di Salsicce è parte essenziale dello ipnotismo sistemico. Il programma della istruzione è organizzato in modo sistematico con tre principali obiettivi:
1 – Impiantare nella realtà un convincimento in linea con la illusione della Matrice. Questo è abbastanza semplice. Non devi fare altro che offrire agli studenti la versione ufficiale della scienza, della storia, della religione e del mondo in generale. Questo viene fatto programmando gli insegnanti attraverso la scuola, la università e la facoltà di magistero; poi li si manda fuori a programmare la generazione successiva con le stesse fesserie che è stato detto loro di insegnare e di credere. Come disse Oscar Wilde: “Quasi tutte le persone sono altre persone. I loro pensieri sono le opinioni di qualcun altro, le loro esistenze una parodia, le loro passioni una citazione.” La maggior parte degli insegnanti, come anche dei medici, degli scienziati, della gente del mondo della informazione, e così via,è ciò che il mio amico Mark Lambert definisce ‘i ripetitori’. Essi non fanno che ripetere ciò che qualcun altro ha detto loro, invece di accedere attraverso la coscienza alla propria verità. Si tratta di una realtà di seconda mano. Il procedimento è simile a quello dello scaricamento di informazioni su disco (insegnante) seguito dalla sua riproduzione in un gran numero di copie (ragazzi e studenti). Nell’ambito di scuole e istituti superiori si ha il permesso di discutere poco o nulla che esuli da questa versione convenzionale della vita, e i punti di riferimento alternativi dai quali osservare questa realtà indottrinata da una altra prospettiva sono scarsi, sempre ammesso che ve ne siano. I ragazzi passano attraverso questo distributore automatico mentale e nel frattempo vivono con adulti (altri ripetitori) che hanno già assorbito la stessa programmazione, e in più guardano mezzi di informazione (altri ripetitori) che ripete a pappagallo la stessa storia ‘ufficiale.’ Non c’è da meravigliarsi se i ragazzi credono che la illusione sia reale quando ogni fonte di ‘informazione’ dice loro che è così.
2 – Trasformare i ragazzi in robot che seguano gli ordini dell'insegnante (sistema). Ciò richiede il Programma del Bastone e della Carota. Si rende molto più facile ai ragazzi la accettazione del volere degli insegnanti (personificazione del sistema), piuttosto che il mettere in discussione la autorità ed i concetti in cui essi dicono di credere. Ricompensa uno e punisci l’altro. "Fa come ti dico e credi a ciò che ti racconto" viene instillato fin dalla più tenera età in quello indottrinamento che chiamiamo scuola, istituto superiore e università. Gli esami rappresentano il sistema che richiede di sentirsi dire ciò che ti hanno detto che devi pensare. Sono la prova che conferma se un download sia andato o meno a buon fine. Quando fate il download di qualcosa su un computer, appare un piccolo box con la scritta: "Vuoi aprire questo file adesso?" Voi lo aprite per assicurarvi che i dati siano stati scaricati correttamente. E’ questo che sono gli esami. I bambini indipendenti, che rifiutano il download, vengono considerati una influenza distruttiva. Avete notato che – mentre possono esserci disaccordi su come si insegna ai ragazzi – raramente vi sono discussioni su cosa viene loro insegnato? Questo perché la Matrice ha una tale presa sulla realtà umana che il cosa venga insegnato è accettato pressoché universalmente. In verità, se le scuole introducessero corsi sulla spiritualità in relazione alla Unità di tutto e alla illusione della forma, i genitori controllati dal Programma Divino protesterebbero furiosamente contro questa offesa alla loro fede cristiana, islamica, ebraica, ecc. ai bambini non solo viene somministrato del veleno per bocca, ma anche attraverso la mente.
3 – Soffocare nella popolazione/bersaglio (ragazzi) qualsiasi idea di unicità e spontaneità. Le scuole sono per lo più zone proibite alla spontaneità e al libero pensiero perché sono consumate dalle regole. Questa è una perfetta preparazione al mondo degli adulti, il quale è strutturato nello stesso modo. La unica differenza è che gli insegnanti per adulti si chiamano agenti di polizia, funzionari statali, ispettori del fisco, più tutti gli altri cloni - per la maggior parte ignari – al servizio della Matrice. Stavo leggendo che in Inghilterra, in una scuola secondaria, è stato proibito agli alunni di tenere per mano o abbracciare il proprio fidanzatino / fidanzatina allo interno dello edificio. Il preside si è giustificato dicendo che un tale comportamento non sarebbe stato consentito ad adulti sul luogo di lavoro. I ragazzi vengono plasmati per diventare una mente collettiva ad alveare, piuttosto che espressioni di unicità. Comportatevi allo stesso modo, e credete allo stesso modo. Un’ultima cosa: perché agli adulti non dovrebbe essere permesso di baciarsi e abbracciarsi sul luogo di lavoro? Accidenti, solo nella matrice lo affetto poteva essere sottoposto ad un regolamento.
Come ottenere l’obbedienza. L'indottrinamento scolastico, scrive Corrado su “Scienza Marcia”. Immaginiamo una ristretta cerchia di persone, un’oligarchia, che voglia mantenere il proprio potere politico/economico sopra una nazione sfruttandone il popolo: quali sono i metodi migliori per consolidare tale potere e renderlo inattaccabile? I metodi sono diversi, anche perché ci sono due strategie di fondo per mantenersi al potere:
1) Quella di esercitare il potere in maniera ferrea e dittatoriale, mostrando palesemente che chi si oppone rischia di venire incarcerato, torturato, ucciso;
2) Quella di fingere di fare tutto il possibile per il popolo, peccato che ci siano i nemici esterni, i nemici interni, le calamità naturali, le crisi ricorrenti del sistema economico, le recessioni, fattori difficilmente controllabili che vanificano gli sforzi che il potere fa “per il bene del popolo”.
Ovviamente questi sono due schemi di massima, che in realtà non si realizzano mai in maniera “pura”. Anche le dittature esplicite nel corso della storia hanno cercato di presentarsi di volta in volta come “necessarie per il bene del popolo, della repubblica, del regno, della nazione” ed hanno cercato di fingere di fare del bene per i propri sudditi. Anche le dittature implicite (come le odierne “democrazie”) pur fingendo di agire per il bene dei sudditi utilizzando il pungo duro con gli avversari più irriducibili, quelli che hanno capito l’ipocrisia del sistema politico e la denunciano, la combattono. Anche nelle nostre finte democrazie che si oppone radicalmente al sistema di potere smascherandone le menzogne rischia di essere incarcerato, torturato, ucciso. In tutti i casi però ci sono degli strumenti che vengono utilizzati da quasi tutte le oligarchie/dittature (esplicita o implicita) per mantenersi saldamente al potere:
- la creazione di finti nemici;
- la divisione del popolo in due o più fazioni che si contrappongono su tematiche di poca importanza (come dicevano i romani “divide et impera” ossia “dividi e governa”);
- il grande risalto dato a manifestazioni di nessun valore, giochi, sport, intrattenimenti futili (ai tempi dei romani c’erano i “circenses”, ossia i giochi del circo);
- la garanzia della sopravvivenza alimentare, senza la quale si rischia una seria rivolta (per governare i romani distribuivano “panem et circenses”, “pane e giochi circensi);
- l’infiltrazione nei movimenti di opposizione di massa per manovrarli a loro insaputa;
- l’utilizzo di tecniche di controllo di massa (tramite l’applicazione delle più raffinate tecniche derivate dallo studio della psicologia di massa, della sociologia);
- il controllo dell’emissione della moneta;
- il controllo sulla formazione della cultura;
- il controllo della scuola;
- il controllo dell’informazione (il cui utilizzo distorto serve anche a nascondere agli occhi della gente la maniera in cui si utilizzano tutti gli altri strumenti di controllo).
Quando avrò più temo forse mi metterò a dimostrare che le nostre “democrazie” sono oligarchie mascherate, che i veri poteri forti che stanno dietro ai burattini che siedono in parlamento non hanno scrupolo ad usare le peggiori forme di violenza e di coercizione contro chi si oppone ad essi. Basterebbe ricordare il clima di violenza e di repressione totalitaria che si è respirato a Genova nel 2001 (governo di destra), e a Napoli pochi anni prima (governo di sinistra) in occasione di due manifestazioni dei no-global per rendersi conto che il potere che comanda le nostre “democrazie” è violento per natura (detto questo non mi confondete con un aderente ai movimenti no-global per carità, non rientro né in quella né in altre etichette). Quando avrò più tempo mi impegnerò a dimostrare come i governi utilizzino tutte le strategie sopra elencate. Per adesso mi limito ad una sola affermazione: sarebbero stupidi se non le utilizzassero. Volete che governi che utilizzano le migliori e più raffinate tecnologie scientifiche (ad esempio per spiare e controllare tutto e tutti) e non usino le più sottili e raffinate strategie di controllo sociale, pensate davvero che si astengano dall’infiltrarsi nei gruppi di opposizione per pilotarli nascostamente ed utilizzarli per i propri fini? Non vi rendete conto che il leader della cosiddetta “opposizione no-global” è un medico che porta acqua al mulino del Nuovo Ordine Mondiale diffondendo il pregiudizio che l’AIDS sia causato dall’HIV? Non vi ricordate di quando il TG della RAI disse che “i servizi segreti italiani erano a conoscenza del piano per il rapimento di Aldo Moro due settimane prima che avvenisse la strage di Via Fani?”. Non vi ricordate di come in quei giorni arrivò una soffiata sul posto in cui era nascosto Moro e di come la polizia evitò di controllare l’informazione? Lo so, l’informazione dei mass-media non aiuta certo a ricordare certi “dettagli” di fondamentale importanza. Se riuscirò un giorno parlerò di come vengono utilizzate tutte queste tecniche di manipolazione/controllo/dominio, ma oggi voglio parlarvi di una di esse in particolare, perché ci lavoro: la scuola. Cosa c’è di meglio della scuola per indottrinare le persone? Se n’era accorta subito la chiesa quando lo Stato Italiano ha deciso di istituire una scuola elementare pubblica. “Orrore! Orrore! - hanno gridato il papa e tutti i preti in coro - sacrilegio! L’istruzione l’abbiamo sempre gestita noi fino ad ora, guai a chi la sottrae al nostro controllo”. Con questo non voglio certo affermare che lo stato abbia inaugurato una scuola pubblica incentrata sulla libertà, perché se l’educazione gestita dai preti era sicuramente di parte, anche la scuola pubblica serviva ad inculcare nei futuri cittadini tutta una serie di idee preconcette: “lo stato è buono”, “il potere è buono”, “il re è buono”, “il re è bello”, “il papa è santo”, “è giusto morire per la patria”, “non ribellarti al potere”. Un tipico esempio è quello della Germania/Prussia ai tempi di Bismarck , il quale affermò senza giri di parola che voleva utilizzare la scuola per infondere uno spirito militaresco nei allievi. A giudicare dai risultati che si sono ottenuti nel giro di 50 anni (Hitler, il nazismo, la seconda guerra mondiale) bisogna dire che quell’indottrinamento militare è stato decisamente “proficuo”. Cosa pensate che sia cambiato da quei lontani termini? La forma sì, certamente la forma è cambiata, ma la sostanza? Nel 2001 ad esempio è stato decretato dal ministro dell’istruzione Moratti l’osservanza di tre minuti di silenzio per commemorare i morti delle torri gemelle a New York, squallida manovra per indurre un’approvazione della guerra USA contro l’Afghanistan e della partecipazione Italiana al conflitto (sebbene in una maniera minore e molto subdola, inviando un contingente al comando degli USA solo dopo l’occupazione militare di quella Nazione e la caduta del vecchio governo). Forse qualcuno pensa che la scuola, almeno quella pubblica, garantisca un confronto fra diversi modi di pensare, diverse opinioni politiche, idee contrapposte. In realtà questo succede limitatamente al fatto che i professori e i maestri hanno diversi orientamenti politici, votano per partiti differenti, e quindi si lasciano sfuggire discorsi e battute contro questo o quell'uomo politico. Per il resto l'omologazione all'interno della classe docente é fortissima, soprattutto quando entrano in gioco la storiografia e la scienza ufficiale, oppure il "sentimento religioso" ed il cosiddetto "amor patrio" (che raramente coincide con il vero amore per la propria terra e per i propri connazionali, mentre troppo spesso é bieco nazionalismo). In tutti questi casi non solo vi é un quasi totale allineamento dei docenti sulle stesse posizioni, ma chi tenta di esprimere il suo dissenso viene spesso trattato come un folle o come un fastidioso rompiscatole. Nei primi anni del 2000 nella scuola italiana (a partire dal già menzionato episodio relativo ai morti dell’11 settembre 2001) si é preso il brutto vizio di indire dei minuti di silenzio per commemorare la morte di alcune persone, facendo così una ben curiosa distinzione fra morti da commemorare e su cui riflettere, e morti su cui é meglio non soffermarsi col pensiero. A quanto pare qualcuno vuole inculcare nelle menti delle persone, e dei alunni in particolare, l'idea che le vite degli esseri umani non abbiano tutte uguale dignità e valore. Per due volte l'iniziativa é stata imposta direttamente dal governo, ma le altre volte sono stati i singoli dirigenti scolastici a decidere "autonomamente" (le virgolette sono dovute al fatto che lo hanno fatto praticamente tutti adeguandosi ad un andazzo nazionale). Di conseguenza l'istituzione scolastica ha cercato di imporre una particolare visione politica della realtà secondo la quale, ad esempio, i 3000 morti delle torri gemelle sono da ricordare e commemorare e sono più importanti sia del milione di iracheni uccisi dalla guerra e dall'embargo negli anni '90, sia dei 3000 bambini che muoiono di fame ogni giorno. Alla stessa maniera i militari italiani (superpagati e volontari) morti a Nassirya sono da ricordare e commemorare per il loro "sacrificio per la pace" a differenza degli operai (sottopagati e sfruttati) che muoiono quotidianamente negli incidenti sul lavoro. In quell'occasione una mia timida espressione di dissenso é stata stigmatizzata dal preside (che era persino contrario alla guerra in Iraq). Non credo che abbia capito che, per quanto mi dispiacesse per la morte di quelle persone, non ritenevo opportuno che la scuola venisse utilizzata per imporre simili commemorazioni dal fine prettamente politico. Avete mai visto una simile commemorazione quando sono morti 10 operai di una fabbrica? A quanto pare per i mass media e per le istituzioni, scuola compresa, la vita di un operaio é meno importante di quella di un militare. Per altro molti militari inviati in Iraq facevano sfoggio nei loro alloggi di simboli fascisti, ed é quindi più che legittimo dubitare del fatto che fossero lì a rischiare la vita per la pace; forse molti di loro si sono ritrovati in Iraq perché attratti dall'alta paga e dalla voglia di un'avventura esotica. Ma la scuola con le sue commemorazioni calate dall'alto impone implicitamente un punto di vista, ed invece che organizzare una riflessione sul conflitto iracheno, una discussione sull'opportunità di quella missione militare all'estero, fa semplicemente da grancassa al trambusto mediatico, e contribuisce al risorgere di quel discutibile "sentimento della patria" che nasconde il rilancio della funzione offensiva dell'esercito; un esercito che, in barba alla costituzione, è stato impiegato in 15 anni per ben 4 volte in operazioni militari al seguito delle guerre statunitensi. Anche quando c'è stata la strage dei bambini in una scuola della Cecenia si è ripetuta a scuola la commemorazione silenziosa; curiosamente questa volta non é stata imposta direttamente dal governo, ma organizzata dal solito trambusto dei mass-media. Ma il copione non è per questo cambiato di molto: siccome i terroristi Ceceni venivano presentati come islamici e siccome gli USA ed i loro alleati erano impegnati in una serie di guerre contro il “terrorismo islamico” qualcuno deve avere deciso di utilizzare anche questo triste avvenimento per orientare la coscienza delle masse, e degli alunni in particolare. E che dire del Papa commemorato col solito minuto di silenzio e ricordato come "uomo di pace"? Proprio lui che col riconoscimento precipitoso delle repubbliche secessioniste della ex-Jugoslavia aveva accelerato un processo che avrebbe portato alla guerra fratricida? Proprio lui che dei preti uccisi nella guerra civile spagnola, aveva beatificato solo quelli fedeli al fascista Franco? E non parliamo delle sue discutibili scelte in ambito religioso per evitare di scrivere un trattato sull'argomento. Intendiamoci, non mi interessa in questa sede discutere sulla bontà o sulla presunta santità del defunto Papa Giovanni Paolo II, quello che intendo rilevare é che la scuola rendendo omaggio alla memoria di alcune persone e dimenticandosi invece di altre, fa una scelta che ha dei significati politici ben precisi, e che puzza tanto di indottrinamento. "La scuola dell'indottrinamento scientifico". Quanto al resto, o meglio, per quanto riguarda tutti gli aspetti controversi della cultura ufficiale che vengono esaminati in questo sito, di confronto e di contrapposizione ce n'é ben poca, ma quello che é peggio è che il confronto o viene vietato o viene ostracizzato in ogni maniera. Se é comprensibile il fatto che i docenti siano stati ingannati da un certo sistema di gestione del potere e della cultura e che quindi non discutano quasi mai argomenti che mettano in dubbio certe presunte verità (in particolare sull'affidabilità della medicina ufficiale, sugli espianti, sull'aids, sulla psichiatria, sulla preistoria), ben diverso é il fatto che quando ci si prova a prospettare un confronto su questi tempi si scatenino i peggiori isterismi che portano perfino a vietare l'approfondimento di certe tematiche controverse. La mia pluriennale esperienza di docente nella scuola superiore mi ha permesso purtroppo di verificare che su certe questioni l'atteggiamento di rifiuto del dissenso e di condanna di chi esprime opinioni difformi é del tutto generalizzato. Ecco un primo esempio.
Espianti e trapianti. Liceo scientifico di Caravaggio, agli inizi del 2000, su proposta di una professoressa la scuola approva una visita ad un ospedale per andare ad assistere in diretta ad un'operazione di trapianto. Al di là del fatto che una simile iniziativa si potrebbe subito giudicare di cattivo gusto, la cosa peggiore è stata la maniera in cui la scuola ha reagito alle proteste contro tale iniziativa. In seguito ad un volantinaggio di protesta della "Lega nazionale contro la predazione degli organi" che cosa ha pensare di fare l'istituzione scolastica per garantire una serena discussione di approfondimento su questo tema controverso? Semplice, ha chiamato un medico favorevole ai trapianti per tenere una conferenza rivolta soprattutto agli alunni delle ultime classi, senza pensare minimamente a prevedere alcun contraddittorio. Come lo volete chiamare questo? … "orientamento guidato"? ...Il caso ha voluto che il giorno stesso in cui era prevista quelle conferenza a favore dei trapianti io fossi stato invitato nella stessa scuola a tenere una relazione sull'embargo in Iraq. Si trattava di iniziative all'interno di quella che viene (spesso impropriamente) chiamata "autogestione", uno spazio di alcuni giorni dedicato a dibattiti, discussioni, approfondimenti su tematiche sociali e politiche di attualità. Finita la mia relazione sull'Iraq sono venuto a sapere che subito dopo iniziava la conferenza sui trapianti. Allora ho chiesto ad alcuni alunni responsabili dello svolgimento di quella "autogestione" se potevo partecipare alla conferenza per esprimere pareri opposti a quelli del conferenziere e permettere un contraddittorio. Per essere corretto non sono entrato nella sala in cui si svolgeva la conferenza prima di chiedere ed ottenere un permesso. Risultato: dopo 10 minuti in cui ho contestato alcune affermazioni del relatore ufficiale arriva il vicepreside ha "espellermi". Ma come, non era un'autogestione? No, risponde il vicepreside, in realtà si trattava di una "co-gestione", ossia un'iniziativa gestita dalla direzione scolastica in collaborazione con gli studenti, ed il mio intervento non era previsto. L'idea di approfittare della presenza di un esperto che potesse ravvivare il dibattito e creare un contraddittorio é ovviamente fuori dalla portata di certe persone. Dopo qualche anno è successo il bis in una scuola in cui insegnavo, quando con una collega di Italiano abbiamo affrontato il tema dei trapianti, facendo leggere articoli pro e contro la donazione degli organi (da notare che la mia collega è moglie di un medico che ha lavorato in rianimazione e certificato alcune “morti cerebrali”), ed a fine anno abbiamo pure organizzato una presentazione ai genitori ed alla scuola il lavoro da noi svolto. In questo “happening di fine anno” sono stati anche presentati i dati:
fra gli alunni di quella classe (primo liceo) che hanno approfondito l’argomento, nonché fra i genitori che erano stati coinvolti nella discussione, l’80% era contrario alla “donazione degli organi”;
fra gli alunni di un’altra classe (sempre una prima liceo), che non aveva mai approfondito la tematica, nonché fra i loro genitori, l’80% era favorevole alla “donazione degli organi”.
In quell’occasione io ho anche espresso (cercando persino di moderarmi a causa della mia “veste istituzionale”) alcune mie perplessità sulla donazione degli organi, mentre un dottore (il marito della mia collega) ha espresso la sua convinzione sulla correttezza della dichiarazione di “morte cerebrale” pur facendo alcuni distinguo sulle modalità con cui avveniva la “donazione”. Risultato: il preside mi ha additato al pubblico disprezzo come indottrinatore durante una riunione collegiale dei docenti della scuola (lo ringrazio per avermi considerato così bravo da indottrinare e convincere non solo i miei alunni ma persino i loro genitori che hanno solo ricevuto dei materiali di opposte tendenze sul trapianto e la donazione degli organi). Come se non bastasse durante un colloquio personale mi ha precisato che i docenti che avevano fatto propaganda esplicita alla donazione degli organi hanno agito bene, mentre io che ho provato (con tutti i miei limiti) ad informare sul pro e sul contro della questione ho agito male ed ho indottrinato gli studenti !!! Ah dimenticavo, il mio preside si vantava di “essere di sinistra” (e che vuol dire)? Ah dimenticavo, due anni dopo hanno fatto in un’altra classe un lavoro di ricerca sui trapianti, avendolo saputo mi sono offerto come collaboratore per contribuire ad una informazione non settaria. Non solo mi hanno escluso, ma nei lavori dei ragazzi non ho visto traccia del dubbio, nemmeno del dubbio, che trapianti/espianti potessero essere poco utili e poco etici. Avete capito come funziona la scuola?
E poi c'è ancora un'altra storia.
"Raccogliamo soldi contro il cancro". Sempre nella stessa scuola mi sono opposto alla raccolta di fondi per un’associazione che “lotta contro la leucemia”, che sostiene i trapiantati di midollo (e che quindi propaganda, sebbene indirettamente, il trapianto di midollo). Ho provato per 4 anni a chiedere su quali basi scientifiche si potesse affermare che il trapianto di midollo fosse utile nella cura della leucemia, e devo dire che a volte ho litigato ferocemente con alcuni docenti (povero me, com’ero ingenuo a quei tempi!). Per 4 anni mi hanno detto che “le prove ci sono”, “te le porteremo prima o poi”. Poi ho chiesto per telefono all’associazione “contro la leucemia” e avessero tali dati. “Non ne abbiamo - è stata la risposta - si rivolga ai medici dell’Ospedale”. Poi finalmente mi sono rivolto a Internet (perché non ci ho pensato prima?) e ho scoperto che la mortalità per leucemia è del 67%, quella per trapianto di midollo … indovinate! Intorno al 66% (con la maggior parte dei decessi nei primi due anni dal trapianto). Un’ottima cura quella del trapianto non c’è che dire, tanto è vero che in quella scuola si usava raccogliere fondi per “la lotta alla leucemia” in memoria di una ragazza leucemica che era stata trapiantata ben due volte ed era morta. Due insuccessi non sono bastati per aprire gli occhi. E adesso cosa credete che sia successo quando ho stampato quei dati (presi dal sito del ministero della sanità e dal sito dell’Istituto nazionale dei tumori) e li ho mostrati ai miei colleghi? Niente, niente di niente, tutto come prima. E si continuano a raccogliere fondi. Avete capito come funziona la scuola?
No, no, non è finita, perchè è la volta del'AIDS!
AIDS: Vietato dissentire. Sempre la solita scuola, propongo di realizzare in alcune classi un lavoro di confronto pro e contro l'ipotesi che l'HIV causi l'AIDS, mi riesco persino a procurare due medici relatori di opposte tendenze. Inizio ad approntare il materiale di studio, pro e contro, presento il progetto in presidenza (anche per i finanziamenti, per quanto piccoli, del caso), e per correttezza lascio (con grande anticipo) una copia del progetto ai colleghi di scienze per stimolare il dibattito e per verificare se da parte loro ci fossero eventuali perplessità. Risultato: i colleghi di scienze non dicono niente fino alla riunione del collegio docenti in cui si discutono i vari progetti ... poi d'improvviso in quell'occasione esplodono tuonando contro di me e dicendo che il mio progetto è pericoloso. E d'altronde come dargli torto? Sì, è pericoloso, i ragazzi potrebbe iniziare a pensare con la loro testa. Ma di cosa avevano paura? Se l'AIDS fosse sicuramente una malattia virale ci vorrebbe poco a smontare le tesi di chi pensa che siano altri i fattori che scatenano tale mortale sindrome. Se fosse tutto così vero, così sicuro, un approfondimento tematico da parte degli studenti, persino un confronto coi fautori di teorie differenti li rassicurerebbe sul fatto che l'AIDS è una malattia infettiva e che bisogna difendersi con ogni mezzo dal contagio dell'HIV. Eppure ... vietato, sissignori, vietato! I dogmi sull'AIDS non si possono discutere. Ovviamente tutti i colleghi intimoriti dalla levata di scudi del team di scienze cosa pensate che abbiano votato? Vietato, vietato, proposta da bocciare! Però questa volta c'è il lieto fine. Uno dei colleghi di scienze ha avuto il coraggio di approfondire la questione, leggere i libri dei "dissidenti" e degli "eretici", confrontare le loro tesi con quelle ufficiali, e poi alla fine dell'anno dichiarare di fronte ai docenti tutti che si era convinto che l'AIDS non fosse una malattia infettiva. Un'altra collega a fine anno mi ha confessato che aveva più dubbi che certezze sull'argomento. Due docenti di scienze su 5 non è poco, specie se sono gli unici che si mettono in discussione, perchè in tal caso la percentuale sale al 100%. Poi ho scopeto che una docente di scienze era particolarmente contraria al mio progetto: aveva lavorato come volontaria in Africa per "curare i malati di AIDS"! Penso proprio che non avrebbe mai accettato di mettere discussione il proprio operato.
Ooops, non è finita! Che ne dite di Telethon?
Soldi per la ricerca genetica. A me non piace per niente (a dire poco) perchè finanzia la vivisezione, perchè la ricerca genetica credo abbia finalità ben diverse da quelle dichiarate, perchè i geni sono solo una parte del problema ma è fondamentale l'interazione con l'ambiente: ci sono diversi casi di malattie "genetiche" che non si manifestano se si segue una certa alimentazione. Ma la lista sarebbe è lunga. Per farla breve, in un'altra scuola (tanto il problema è sempre lo stesso) l'anno scorso si sono raccolti fondi per Telethon, io ero contrario, ho comunicato la mia contrarietà ai docenti che hanno sostenuto l'iniziativa (tali iniziative ovviamente non vengono discusse in nessuna sede, vengono approvate tout court!) e al preside. Dietro mia richiesta e insistenza l'unica motivazione che sono riusciti a produrre per una tale raccolta di fondi è che "si spera che queste ricerche alla fine producano qualche risultato positivo". Qualcuno mi ha detto che però "i ragazzi sono stati informati", non hanno donato soldi a scatola chiusa. "Informati come?" chiedo io. "Con gli opuscoli Telethon!" è l'ingenua risposta. A quanto pare quando si parla di medicina la par condicio non esiste, la scienza ufficiale non si tocca. Avete capito come funziona la scuola?
“Si cambia partendo dai bambini”: prove tecniche di indottrinamento? Scrive il Comitato Articolo 26. Prima di questo, si consiglia di leggere l’articolo precedente (200 milioni per l'educazione di genere) per comprendere i presupposti a partire dai quali vengono sviluppati i ragionamenti qui riportati.
Istruzione: 200 milioni per l’educazione di genere! Introduzione dell’educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università è il nome di una nuova proposta di legge che si pone, tra gli altri, l’obiettivo di prevenire il femminicidio e di combattere le discriminazioni. Cosa ci potrai mai essere di male in una iniziativa simile e chi potrebbe non condividere finalità così nobili? Per esempio chi, informandosi e approfondendo, ha visto cadere il velo dell’apparenza e ha ormai chiaro che per “genere” non si intende (solo) il sesso femminile contrapposto al maschile, ma tutta una concezione della sessualità e della persona. Al contrario, chi si limiterà a restare in superficie accontentandosi di qualche slogan senza volersi affacciare ai contenuti più profondi della “rivoluzione gender”, forse continuerà a ritenere le voci critiche come posizioni incomprensibili e reazionarie, ma con il rischio concreto di venire manipolato da un’ideologia che cerca di far credere che neppure esista. L’attuale classe politica avrà una responsabilità enorme nel caso in cui voglia volgere lo sguardo altrove per non vedere che dietro ai concetti di “educazione alla parità” o di “decostruzione degli stereotipi sessisti”, in realtà si cela una visione radicale ed inaccettabile della persona, dell’identità sessuale e della famiglia. Lo ripetiamo: se l’unica finalità di questi programmi fosse educare al rispetto tra maschi e femmine, valorizzare il ruolo delle donne nella storia o criticare l’oggettivazione dei corpi femminili nelle pubblicità, ne saremmo tutti ben lieti. Ma come è ormai manifesto nelle gender theories, come viene recepito da svariati documenti internazionali e poi messo in pratica anche in molte scuole di casa nostra, educare “alle differenze di genere” troppo spesso sottintende condurre i giovani all’indifferentismo sessuale e al non concepirsi come donne o uomini, ma come individui per i quali la caratterizzazione sessuale, l’identità di genere e l’orientamento sessuale sono fluidi, continuamente modificabili e in fin dei conti irrilevanti. E’ emblematico il fatto che quando si parla di stereotipi di genere, si finisca sempre a parlare di stereotipi in base all’orientamento sessuale (come del resto fa anche la risoluzione n.2011/2116 per l’eliminazione degli stereotipi di genere in Europa, che la suddetta proposta di legge richiama). Il percorso classico è partire sottolineando le differenze individuali (una donna camionista o un ragazzo amante del cucito) per arrivare ad affermare che le differenze non esistono affatto, vale a dire che non esiste un quid che sostanzia naturalmente l’umanità come divisa in maschi e femmine. Cosa ne deriva? Che non solo sarebbe indifferente come nasciamo, ma anche il nostro orientamento sessuale, pena il diventare discriminanti. E a partire da questo presupposto, la mamma che fa la torta o la bambina che culla la bambola diventano immagini che indurrebbero ad una disparità tra maschi e femmine e alimenterebbero una cultura misogina: ecco quindi che vanno eliminate dalle teste (e dai testi) degli studenti. Un esempio di educare alle differenze sarebbe il libro “Mi piace Spider Man”, che viene consigliato alla scuola materna dai 4 anni (?!?). La piccola protagonista deve combattere non pochi “stereotipi” per conquistare la sua cartella “da maschio” che le piace tanto. E va bene; ma perché qualche pagina dopo, le fanno dire – a lei che di anni ne avrebbe sei – che ha capito che “da grande potrà avere un fidanzato o una fidanzata”? A sei anni? Come ha scritto pochi giorni fa Karen Rubin su “Il Giornale” a tal proposito, non si considera che “di un universo femminile che contempla più volti, i bambini piccoli conoscono solo la parte che li riguarda… Poco importa che faccia l’astronauta o la dottoressa: la mamma il piccolo la vorrebbe sempre con sé. E’ degradante tutto ciò?… Si sogna una società dove padri e madri siano interscambiabili e le torte non siano più menzionate, neanche fossero droghe pesanti… C’è un errore in tutto questo. La mamma che cucina e la bambina che culla la bambola non sono stereotipi, sono ruoli di genere che si legano strettamente all’identità di ogni essere umano. Se la mamma prepara il cibo per il suo piccolo non trasmette debolezza ma amore. Se il padre è virile perché protegge i figli e la moglie manda un messaggio di forza e coraggio. Se invece picchia la sua compagna non è una questione da ridurre a stereotipi”. E come conclude la Rubin “duecento milioni di euro – questo l’esborso per questa riforma scolastica a carico nostro, che siamo abituati ad autotassarci per dotare di carta igienica le scuole dei nostri figli - sono davvero sprecati per censurare le immagini. Usiamoli per educare gli uomini e lasciamo in pace i bambini“.
In un paese democratico sui banchi di scuola ci si dovrebbe sedere per imparare l’arte lunga e difficile della vera libertà, e non per subire un indottrinamento, che appoggia per altro su discutibili basi filosofico-teoretiche spacciate per scientifiche. Da quanto si evince da una recente intervista apparsa su La Repubblica, non la pensa così Valeria Fedeli, PD, vicepresidente del Senato, che parla proprio di un insegnamento che si vuole rendere normativo e vincolante e il cui contenuto ormai dichiarato è l’ideologia gender. In questa intervista con poche parole viene liquidata un’intera civiltà, basata sulla legge di natura e sulla forma corrispondente di razionalità: “i luoghi comuni che inchiodano maschi e femmine a stereotipi, che ignorano quanto l’altra metà del cielo ha fatto in tutti campi”. Come se la porzione più consistente di questi importanti conseguimenti femminili non fosse stata realizzata all’interno della suddetta civiltà. Ci viene da chiederci se la Fedeli si renda conto che la società che programma di decostruire partendo dalla scuola è proprio quella che l’ha condotta a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Senato (mentre una donna presiede la Camera e si riscontra una parità tra ministri di sesso maschile e femminile); citando delle frasi della sua intervista ci viene da tranquillizzarla, perché i fatti già dicono altro: oggi parlare come fa lei di passività delle donne può giusto essere un vecchio ricordo stereotipato, mentre il tempo di crisi che le famiglie concrete stanno affrontando ha già messo in fuga tutti i principi azzurri su piazza, per cui i sogni delle femminucce si sono adeguati diventando molto più a buon mercato. L’educazione di genere – che dando credito a qualcuno neppure esisterebbe, quasi fosse una teoria del complotto di pochi reazionari – verrebbe così introdotta tramite un apposito disegno di legge nelle scuole e nelle università nell’intento di spazzare via, in nome di una libertà banalizzata, l’inaccettabile adeguarsi alla verità dei programmi educativi tradizionali, elaborati dalla razionalità del buon senso naturale e presupponenti la differenza sessuale come dato di fatto autoevidente ed inamovibile. E’ incredibile il prezzo che si è disposti a pagare pur di distorcere la realtà. E’ impressionante il modo semplicistico con il quale il sistema scolastico venga etichettato come anticaglia da cestinare: le elementari vengono banalizzate come fucina di storielle discriminatorie e non come primo stadio della scolarizzazione, più che mai rispettoso della differenza sessuale, non in nome di un’ideologia conservatrice, ma perché indirizzato ad esseri umani, molto vulnerabili e manipolabili, che trovano in tale differenza il loro primo solido orientamento identitario. Nell’intervista della Fedeli si parla di parità, di uguaglianza, di rispetto, di libertà. Parole altisonanti, politicamente corrette, che incantano lettori ed ascoltatori, che mettono d’accordo tutti, ma lasciate come sono del tutto prive di contenuto, diventano oggetto di una manipolazione semantica gravissima, venendo in modo subdolo riempite di contenuti razionalmente inaccettabili. Ma la cosa più paradossale è che questo peana per la libertà si conclude, nel massimo dispregio del principio di non contraddizione, con un’affermazione programmatica dal sinistro tenore totalitario e liberticida: “si cambia partendo dai bambini, gli uomini di domani“. L’avrebbe condivisa Pol Pot. Si parte dai bambini, arrivando a sottrarne l’educazione sessuale ai violenti e retrogradi genitori, perché solo in esseri indifesi e non ancora formati dal punto di vista razionale può sperare di attecchire in profondità una visione dell’uomo tanto priva di base scientifica e per questo lontana dalla realtà come quella propugnata dall’ideologia ipersessualizzata del gender. E vorremmo chiudere permettendoci una riflessione, un appello che speriamo che la prima firmataria della legge voglia ascoltare: è stato preso in considerazione il fatto che il fenomeno della violenza contro le donne è fortemente connesso al fenomeno dell’ipersessualizzazione della società e del mondo maschile? Domanda: siamo certi che l’investimento dei 200 milioni di euro per tirare la volata al gender e agli standard OMS con la loro sovra-esposizione al sesso fin dalla più tenera età non si riveli un doloroso boomerang proprio per il mondo femminile che si vorrebbe proteggere?
L’ideologia oggi è la mancanza di serietà. Una prof racconta, scrive Marina Valensise su “Il Foglio”. Anna Maria Ansaloni è una prof un po’ speciale, è vero. Insegna al Leonardo da Vinci-Duca degli Abruzzi, il liceo tecnico di via Palestro, quartiere centrale. E’ convinta che la scuola non debba fare quello che “vogliono le famiglie”, ma “formare il cittadino”, e pensa anzi che le famiglie oggi siano spesso ignare dei veri problemi della scuola. Ma su un punto conviene con l’allarme lanciato dal presidente del Consiglio, quando difende l’insegnamento libero contro l’indottrinamento ideologico. “I genitori sanno che i loro figli escono dalla scuola sprovvisti delle competenze che invece loro avevano alla stessa età. Per questo, insistono perché la scuola sia più seria, più attenta alle conoscenze di base, più centrata sulla disciplina e sul rigore”. Anna Maria Ansaloni è un’entusiasta, è un’insegnante che adora insegnare. E’ convinta che l’egemonia di sinistra non sia altro che un ricordo sbiadito: “E’ semplicemente morta. La sinistra non esiste più, nel mondo della scuola è irrilevante, mi pare. Tieni conto che la maggioranza degli insegnanti oggi quarantenni ha vissuto gli ultimi vent’anni con Berlusconi. L’ideologia semmai sopravvive come abitudine di costume, nell’occupazione, che non è un fatto politico, ma un rituale di passaggio”. La prof Ansaloni insegna Italiano e storia in una seconda e terza classe, ha le idee chiare e i mezzi per realizzarle: “Il vero dramma è la scuola media, dove i ragazzi disimparano ciò che apprendono alle elementari. Vedo ragazzi che scrivono a matita perché poi così possono cancellare, ma scrivono compiti di otto pensierini che non sono da scuola superiore. Io perciò lavoro molto sul costruire le regole. I ragazzi purtroppo sono molto lenti e disordinati. Vanno educati a un certo ordine nell’esporre gli argomenti, a una notevole quantità di compiti sistematicamente valutati e compresi, alla chiarezza dal punto di vista linguistico. Fraintendimento e intendimento per loro sono la stessa cosa. Per lavorare sul senso delle parole e sulla forma scritta, devi tornare ai testi appresi a memoria, perché senza chiarezza non c’è conoscenza. Devi fargli capire che la fatica è inevitabile, mettere sanzioni chiare e rispettarle”. La professoressa Ansaloni, dunque, ha rafforzato i programmi di lettura. Una volta al mese riunisce gli studenti di 14 e 15 anni nella biblioteca della scuola per discutere con signore di 60 o 70 anni dello stesso libro, e a volte incontrare l’autore. “Mi piace tantissimo parlare con queste signore, mi ha detto un ragazzino, non sono mica come mia madre. Non è l’alunno a parlare, ma il lettore e il lettore è trasversale”. In questo modo si accrescono le competenze linguistiche, si supera un problema didattico. “Noi adottiamo libri di testo inadeguati ai ragazzi” dice infatti la prof Ansaloni. “Per capirli devi decodificarli, e per questo cerco di costruire una sintesi, di fare scrivere i miei allievi su quel testo, di fargli poi valutare cosa realmente ne hanno capito. Dobbiamo ampliare il lessico. Una volta i nostri figli parlavano con 300 parole, ora ne usano 50. Perciò io punto a rafforzare il programma scolastico col lavoro di lettura e di scrittura e la verifica attraverso i questionari. E’ vero che molti miei colleghi non mi seguono, "lasciami stare, mi dicono, con 1.600 euro al mese, per mantenere moglie e due figli devo fare tre lavori". Ma risultati ci sono. Se dico ai miei ragazzi, guarda, quel tizio non ha né artigli né zanne, loro continuano, sì però non voleva essere sbranato. Vuol dire che qualcosa dei ‘Promessi Sposi’ è rimasto: il lessico e la lettura gli si è sedimentata dentro e in modo naturale”. C’è anche un altro handicap dei giovani d’oggi: nessuno scrive più in corsivo. “Il corsivo è scomparso. Abituati col computer e l’sms scrivono tutti in stampatello, alcuni non sanno più come si scrivono certe maiuscole in corsivo. Non è solo una questione di grafia o calligrafia. In stampatello, usano frasi sintetiche di comunicazione, non di espressione: vado, vengo, anziché – penso di venire, avrei intenzione di andare, con una struttura della frase paratattica, senza principali e secondarie, ma con una sfilza di principali spesso con la stessa forma verbale. Il corsivo invece prevede un certo tempo in cui pensi, elabori, unisci le lettere, ti dà una capacità riflessiva, permette un’elaborazione concettuale che implica l’uso di articoli, aggettivi, la punteggiatura, la varietà di forme verbali e l’espressione di sé. Oggi i ragazzi è proprio questo che vogliono evitare: non sanno né vogliono scrivere di sé, esprimere emozioni, anche se ce le hanno dentro. Allora devi aiutarli. Io per esempio quando leggiamo un sonetto di Dante, ‘Tanto gentile e tanto onesta pare’, chiedo ai ragazzi di cercare dei raffronti con l’immensità, con Dio, con la spiritualità. Loro li trovano nelle canzoni di Vasco Rossi o Jovanotti, e per me è un successo”. La maggiore soddisfazione, però, Ansaloni dice di averla “tutti i giorni quando entro in classe, perché insegnare mi diverte da morire, quando i ragazzi trascorrono un’ora senza rendersene conto, quando vedo all’intervallo quello con la cresta che ti cita una frase di Manzoni. Adesso sta leggendo il ‘Postino di Neruda’ di Skármeta, e una sua allieva rumena, brava e determinata, che dopo la scuola lavora come babysitter, quasi non ci crede: ‘Professoressa, le metafore le possiamo fare anche noi…’”.
Scuola: arriva il divieto per gli insegnanti di fare propaganda politica e ideologica. Chi sgarra sarà sospeso. Un deputato del Pdl ha proposto un'aggiunta al testo unico sulla scuola per impedire agli insegnanti di fare propaganda politica. Secondo lui questo avverrebbe soprattutto in Emilia Romagna. A vigilare dovranno essere i dirigenti scolastici, scrive Marta Ferrucci su “Studenti”. Fabio Garagnani, deputato del Pdl, ha proposto una aggiunta al testo unico sulla scuola: il divieto per gli insegnanti di fare propaganda politica e ideologica. Dovranno essere i dirigenti scolastici a vigilare e per chi sgarra è prevista la sospensione da 1 a 3 mesi. "L'importante era inserire nel Testo unico sulla scuola il divieto di fare propaganda politica o ideologica per i professori". Per quanto riguarda le sanzioni queste dovranno essere contenute poi in dettaglio in un provvedimento attuativo della legge. La propaganda politica" -secondo garagnani- "non può trovare tutela nel principio della libertà dell'insegnamento enunciato dall'Articolo 33 della Costituzione. Un conto infatti è tutelare la libertà di espressione del docente, un'altra è quella di consentire che nella scuola si continui a fare impunemente propaganda politica". E sarebbero molti i casi in cui i professori oltrepassano questo limite; per Garagnani accade soprattutto in Emilia Romagna, tra i professori iscritti alla Cgil". Per Mimmo Pantaleo, segretario generale della Flc-Cgil si tratta di una proposta "delirante" ed ha aggiunto che "gli insegnanti educano, non inculcano". Ha ragione Garagnani o si tratta di una proposta "delirante"?
"Troppi libri comunisti a scuola", Pdl: Ci vuole una commissione d'inchiesta, scrive Agenzia Dire su “Orizzonti Scuola” - Iniziativa di 19 deputati guidati da Gabriella Carlucci, all'indice i testi di storia: "Gettano fango su Berlusconi". Dopo i giudici, anche i libri di testo contro Silvio Berlusconi. Secondo 19 deputati del Pdl, capitanati da Gabriella Carlucci, i testi scolastici di storia, su cui studiano migliaia di ragazzi, nasconderebbero "tentativi subdoli di indottrinamento" per "plagiare" le giovani generazioni "a fini elettorali" dando "una visione ufficiale della storia e dell'attualità asservita a una parte politica", il centrosinistra, "contro la parte politica che ne è antagonista", ossia il centrodestra. Di fronte a questa situazione definita "vergognosa", secondo i parlamentari del Pdl, il parlamento "non può far finta di non vedere" e per questo chiedono, attraverso una proposta di legge, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta "sull'imparzialità dei libri di testo scolastici". Il progetto di legge è stato depositato alla Camera da Carlucci il 18 febbraio 2011 e assegnato alla commissione Cultura il 14 marzo. In attesa dell'avvio dell'esame, in questi giorni la proposta è stata sottoscritta da altri colleghi di partito (ieri si sono aggiunte nuove firme e altre ancora ne stanno arrivando), tra cui il capogruppo Pdl in commissione Cultura, Emerenzio Barbieri. Nella premessa, gli esponenti di maggioranza si chiedono: "Può la scuola di Stato, quella che paghiamo con i nostri soldi, trasformarsi in una fabbrica di pensiero partigiano?" E la "battaglia partigiana", secondo il firmatari, viene messa in atto "osannando l'attuale schieramento di sinistra" e "gettando fango sui loro avversari". Per "capire la gravità del problema", sostengono i 19 deputati, "basta sfogliare la maggior parte dei libri che oggi troviamo nelle scuole, sui banchi dei nostri figli". Scopo della Commissione d'inchiesta? "Verificare quali sono i libri faziosi - spiega Barbieri interpellato dalla Dire - e dargli il tempo di adeguarsi prima di farli ritirare dal mercato, mica mandarli al macero...". Gli altri firmatari della proposta di legge Carlucci, che mette all'indice i libri di testo definiti "partigiani", sono: Barani, Botta, Lisi, Scandroglio, Bergamini, Biasotti, Castiello, Di Cagno Abbrescia, Di Virgilio, Dima, Girlanda, Holzmann, Giulio Marini, Nastri, Sbai, Simeoni e Zacchera. Nella premessa, si fanno alcuni esempi dei testi incriminati, specificando che "in Italia, negli ultimi cinquant'anni, lo studio della storia è stato spesso sostituito da un puro e semplice tentativo di indottrinamento ideologico" retaggio "dell'idea gramsciana della conquista delle casematte del potere" che "si è propagato attraverso l'insegnamento della storia e della filosofia nelle scuole". Si cita La storia di Della Peruta-Chittolini-Capra, edito da Le Monnier, che descrive "tre personaggi storici: Palmiro Togliatti, un uomo politico intelligente, duttile e capace di ampie visioni generali; Enrico Berlinguer, un uomo di profonda onestà morale e intellettuale, misurato e alieno alla retorica; Alcide De Gasperi, uno statista formatosi nel clima della tradizione politica cattolica". Ma anche Elementi di storia di Camera-Fabietti, edito da Zanichelli, reo, ad avviso del Pdl, di sostenere che "l'ignominia dei gulag sovietici non è dipesa da questo sacrosanto ideale (il comunismo), ma dal tentativo utopico di tradurlo immediatamente in atto o peggio dalla conversione di Stalin al tradizionale imperialismo". E ancora, la Storia, volume III, di De Bernardi-Guarracino, edito da Bruno Mondadori, per il quale dal 1948 "l'attuazione della Costituzione sarebbe diventato uno degli obiettivi dell'azione politica delle forze di sinistra e democratiche". E si arriva ai tempi più recenti. "Con la caduta del Muro di Berlino e con la fine dell'ideologia comunista in Italia - si precisa nella premessa alla proposta - i tentativi subdoli di indottrinamento restano tali" e anzi "si rafforzano e si scagliano" contro "la parte politica che oggi è antagonista della sinistra", quella guidata da Berlusconi. Nella proposta di legge Carlucci, sottoscritta alla Camera da altri 18 deputati Pdl per istituire una Commissione d'inchiesta per verificare "l'imparzialità dei libri di testo scolastici", la messa all'indice viene supportata infine dai passaggi che descrivono gli ultimi 15/20 anni di storia politica italiana, ossia l'era berlusconiana. Uno degli esempi che, secondo i firmatari, "osanna" agli occhi degli studenti i partiti di centrosinistra lo si ritrova ne La storia di Della Peruta-Chittolini-Capra, edito da Le Monnier, a proposito del Partito democratico della sinistra: "Il Pds - è scritto - intende proporsi come il polo di aggregazione delle forze democratiche e progressiste italiane" con "un programma di riforme politico sociali miranti a rendere più governabile il Paese". Si tira poi in ballo la descrizione che L'età contemporanea di Ortoleva-Revelli, edito da Bruno Mondadori, fa di Oscar Luigi Scalfaro: "Dopo aver abbandonato l'esercizio della magistratura per passare all'attività politica nel partito democristiano" si è segnalato "per il rigore morale e la valorizzazione delle istituzioni parlamentari". Ma il testo che più si distingue "per la quantità di notizie partigiane e propagandistiche" è, secondo i 19 deputati Pdl, quello di Camera e Fabietti. In Elementi di storia, citano, viene descritta l'attuale presidente del Pd, Rosy Bindi, come la "combattiva europarlamentare" che, ai tempi della militanza nella Democrazia cristiana, sollecitava ad "allontanare dalle cariche di partito" tutti "i propri esponenti inquisiti". E come viene descritto l'antagonista Berlusconi? Nel 1994, citano ancora i parlamentari dalle pagine del libro di testo, "con Berlusconi presidente del Consiglio, la democrazia italiana arriva a un passo dal disastro". Secondo gli autori, "l'uso sistematicamente aggressivo dei media, i ripetuti attacchi alla magistratura, alla Direzione generale antimafia, alla Banca d'Italia, alla Corte costituzionale e soprattutto al presidente della Repubblica condotti da Berlusconi e dai suoi portavoce esasperarono le tensioni politiche nel Paese". L'elenco dei libri "naturalmente potrebbe continuare ancora per molto - conclude il Pdl - ma bastano questi esempi per capire la gravità della questione".
Bagnasco contro i "campi d'indottrinamento" gender. Scrive Massimo Introvigne su “La Nuova BQ”. Lunedì 24 marzo 2014, aprendo il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Angelo Bagnasco, che la presiede ha affrontato con grande determinazione la problematica della famiglia e dell’ideologia di genere. «La preparazione alla grande assise del sinodo sulla famiglia, che si celebrerà in due fasi nel 2014 e nel 2015, nonché il recente concistoro sul medesimo tema – ha detto Bagnasco – hanno provvidenzialmente riposto l’attenzione su questa realtà tanto “disprezzata e maltrattata”, come ha detto il Papa: commenterei, “disprezzata” sul piano culturale e “maltratta” sul piano politico». Il cardinale ha inquadrato la natura ideologica del problema: la famiglia è diventata il nemico da abbattere. «Colpisce che la famiglia sia non di rado rappresentata come un capro espiatorio, quasi l’origine dei mali del nostro tempo, anziché il presidio universale di un’umanità migliore e la garanzia di continuità sociale. Non sono le buone leggi che garantiscono la buona convivenza – esse sono necessarie – ma è la famiglia, vivaio naturale di buona umanità e di società giusta». Il cardinale è andato oltre: non è rimasto sul generico, ma ha citato come esempio dei maltrattamenti che la famiglia subisce un episodio specifico, su cui – lo ricordiamo per la cronaca, senza rivendicare primogeniture – per prima «La nuova Bussola quotidiana», nel silenzio generale, aveva attirato l’attenzione. «In questa logica distorta e ideologica – ha detto Bagnasco –, si innesta la recente iniziativa – variamente attribuita – di tre volumetti dal titolo “Educare alla diversità a scuola”, che sono approdati nelle scuole italiane, destinati alle scuole primarie e alle secondarie di primo e secondo grado. In teoria le tre guide hanno lo scopo di sconfiggere bullismo e discriminazione – cosa giusta –, in realtà mirano a “istillare” (è questo il termine usato) nei bambini preconcetti contro la famiglia, la genitorialità, la fede religiosa, la differenza tra padre e madre… parole dolcissime che sembrano oggi non solo fuori corso, ma persino imbarazzanti, tanto che si tende a eliminarle anche dalle carte». Durissimo il commento del presidente dei vescovi italiani «È la lettura ideologica del “genere” – una vera dittatura – che vuole appiattire le diversità, omologare tutto fino a trattare l’identità di uomo e donna come pure astrazioni. Viene da chiederci con amarezza se si vuol fare della scuola dei “campi di rieducazione”, di “indottrinamento”. Ma i genitori hanno ancora il diritto di educare i propri figli oppure sono stati esautorati? Si è chiesto a loro non solo il parere ma anche l’esplicita autorizzazione? I figli non sono materiale da esperimento in mano di nessuno, neppure di tecnici o di cosiddetti esperti. I genitori non si facciano intimidire, hanno il diritto di reagire con determinazione e chiarezza: non c’è autorità che tenga». Parole chiarissime: altri vescovi prendano esempio. La strategia enunciata esplicitamente da Papa Francesco nell’esortazione apostolica «Evangelii gaudium» – il Papa di certe questioni, comprese quelle (citate in nota nel documento come esempio delle «questioni» cui si allude) della famiglia e del gender, non parla, chiede che siano gli episcopati nazionali a intervenire – non piace a tanti nostri lettori, e dalle strategie, che non sono Magistero neppure ordinario, si può certo legittimamente dissentire. Però qualche volta le strategie funzionano: dove tace il Papa, i vescovi parlano. È successo negli Stati Uniti, in Polonia, in Croazia, in Portogallo, in Slovacchia. Ora succede anche in Italia, e non si può non ricordare che – come sempre avviene nel nostro Paese – prima di aprire con questa relazione il Consiglio Permanente della CEI venerdì scorso Bagnasco è andato in udienza dal Papa, cui questi testi sono di regola previamente sottoposti. Vediamo se questa rondine farà, come ci auguriamo, primavera.
Genitori, reagite all'imposizione dell'ideologia gender!. L'edizione di domenica di RomaSette, il settimanale della diocesi di Roma, evidenzia e valorizza l'azione del Comitato Articolo 26 contro i molteplici tentativi di introdurre nelle scuole l'ideologia gender, scrive Giuseppe Rusconi su Zenit.org. Per questa domenica iniziale d’Avvento RomaSette - l'inserto settimanale di Avvenire - ha scelto come articolo di apertura un testo sull’ormai allarmante dilagare anche nelle scuole romane – dagli asili nido in poi - dell’imposizione dell’ideologia del gender, secondo la quale la differenza tra maschile e femminile è solo una costruzione culturale e dunque va “decostruita” nel senso che ognuno non è quel che è e si vede, ma ciò che si sente e pensa di essere. Il titolo è “Gender a scuola. La protesta dei genitori”. In un box si danno indicazioni su un modulo, da inviare al dirigente scolastico dell’istituto dei propri figli, per la richiesta di consenso informato sulle iniziative ‘educative’ improntate all’ideologia del gender. Nella stessa pagina, appare su quattro colonne anche un articolo molto chiaro dal titolo: “Strategia Lgbt, i consulenti sono a senso unico”, accompagnato dall’occhiello: “Ventinove associazioni del mondo gay a fianco dell’Unar (Ndr: il noto Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) per la formazione, otto nei progetti finanziati dalla Regione Lazio. Proposta politica con una bozza di ordine del giorno per il Consiglio comunale: indottrinamento tra i banchi”. Si noterà qui subito che proprio la Regione Lazio – retta da Nicola Zingaretti - ha sborsato 120mila euro per i progetti pro-gender, mentre non si risparmia neppure la giunta Marino di Roma Capitale, grazie anche al sostegno entusiasta dell’assessore alla Scuola Alessandra Cattoi, che ha affidato all’associazione lgbt “Scosse” la formazione delle educatrici degli asili nido e delle scuole materne comunali della città. Nell’articolo di Roma Sette si ricorda il caso scoppiato presso l’asilo nido comunale “Castello Incantato”, in zona Bufalotta, laddove ai pargoli si legge ad esempio la “Piccola storia di una famiglia” (casa editrice Stampatello): tale cosiddetta “famiglia” comprende due donne che si fanno donare il “semino” necessario alla procreazione da una clinica olandese, tanto che alla fine la nascitura avrà “due mamme: solo una l’ha portata nella pancia, ma entrambe, insieme, l’hanno messa al mondo. Sono i suoi genitori”. E’ proprio dal tristo episodio del “Castello Incantato” che ha preso spunto l’idea di alcuni genitori di costituire il “Comitato Articolo 26”. Perché 26? Ci si riferisce all’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: I genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. Il Comitato è aperto a genitori, docenti, professionisti dell’educazione, di diverso credo religioso e filosofico, che “rifiutano con decisione l’indottrinamento gender nelle scuole italiane di ogni ordine e grado e che rivendicano, in maniera costruttiva, la priorità delle famiglie in tema di affettività e sessualità”. Tra gli obiettivi “diffondere un’informazione oggettiva e scientifica in merito alla cosiddetta ideologia gender”, “vigilare e segnalare gli aspetti ideologici pedagogicamente infondati e pericolosi, di progetti educativi e scolastici relativi a educazione sessuale e/o affettività, educazione alle differenze, lotta alla discriminazione tra bambini e bambine, lotta all’omofobia e/o al bullismo omofobico”, “sostenere e accompagnare il diritto dei genitori ad affermare e perseguire la priorità della propria missione educativa nei confronti dei figli”. Nell’articolo di Roma Sette sulla strategia Lgbt si ricorda inoltre che “a livello nazionale è in piena attuazione” tale strategia triennale, partorita due anni fa dall’Unar “istituito in seno al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio”. Era il tempo di Monti, poi venne Letta e la strategia andò avanti, così come con Renzi. Del resto è dei giorni 26 e 27 novembre 2014 il corso per dirigenti scolastici organizzato a Roma dal ministero dell’Istruzione e dall’Unar con la collaborazione del Servizio lgbt di Rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Il Gruppo nazionale di lavoro è composto da 29 associazioni di settore, tutte rigorosamente lgbt. Il 23 febbraio scorso, il settimanale della diocesi di Roma aveva già dedicato quasi tutta la prima pagina all’ “operazione ideologica” del “gender in classe”, con un editoriale chiaro, pacato e fermo di don Filippo Morlacchi, in cui il direttore dell’Ufficio pastorale scolastica del Vicariato scriveva: “Anche in altri Paesi europei la potente minoranza favorevole al gender ha dettato l’agenda degli impegni scolastici; ma le associazioni di genitori hanno alzato la voce e prodotto agili pubblicazioni per avvertire le famiglie del fenomeno. Forse è tempo che anche in Italia non solo i cattolici, ma tutti gli uomini convinti della bontà della famiglia naturale si esprimano pubblicamente”. Un auspicio che è stato concretizzato in questi mesi da diverse associazioni e comitati a livello cittadino, regionale, nazionale (in primis la Manif pour tous Italia e le Sentinelle in piedi), in buona parte nell’area cattolica ma aperte a tutti. A livello di diocesi, ricordiamo poi l’esemplare "Nota su alcune urgenti questioni di carattere antropologico ed educativo" dei vescovi del Triveneto per la Giornata della vita 2014, la grave preoccupazione della Conferenza Episcopale toscana e di alcuni altri vescovi. Nelle ultime settimane sono successi altri fatti gravi, oltre alle intimidazioni fisiche e verbali con cui sono state bersagliate in diverse città le Sentinelle. Ad esempio una docente di religione cattolica dell’Istituto Pininfarina di Moncalieri è stata fatto oggetto ingiustamente di una pesantissima campagna di stampa originata dalle affermazioni (pare del tutto inventate) di uno studente attivista lgbt. Esposta al pubblico ludibrio dai mass-media, nelle prime reazioni a caldo non è stata certo difesa neppure dall’estemporaneamente remissivo arcivescovo di Torino. Grazie ad Avvenire è stata poi ristabilita la verità almeno per i lettori del quotidiano della Cei, oltre che per l’ambiente locale. La diocesi di Milano dal canto suo è incappata in un paio di decisioni che hanno destato molta perplessità tra non pochi cattolici: le scuse ufficiali per un’indagine statistica non certo segreta (rivolta a oltre seimila docenti di religione cattolica) e la negata solidarietà per un docente di religione (sospeso dalla scuola, con l’Ufficio scuola della Curia che ha aperto un procedimento di verifica) colpevole di aver mostrato a nove alunni di una terza liceo un documentario molto realistico, “L’urlo silenzioso”, su quel che succede durante un aborto. E’ stata la fiera dell’ipocrisia interessata, se si pensa alle tante immagini crude sfornate da tg e trasmissioni varie per ragione di audience. Intanto, in pieno sviluppo dell’applicazione della strategia totalitaria lgbt, l’Unione degli atei e agnostici razionali (Uaar), l’Arcigay, la Rete degli studenti medi ha trovato modo il 18 novembre di inviare una lettera allarmata al Ministro dell’Istruzione, all’Unar e alla Presidenza del Consiglio per denunciare che “stiamo assistendo ad un vero e proprio attacco nei confronti degli studenti e del sistema scolastico tutto, da parte di una frangia conservatrice e omofoba del nostro Paese”. Proclamano e minacciano i firmatari: “Il Ministero, e il Governo tutto, devono avere il coraggio di superare i tabù e di non fare della battaglia alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale un mero spot propagandistico. Riteniamo che il Ministero debba adoperarsi affinché tutte le scuole prevedano programmi didattici strutturati, destinati agli studenti, sull’educazione alle differenze, in cui si parli di identità di genere, orientamento sessuale e sesso biologico, e che investa nella formazione degli insegnanti, fornendo loro gli strumenti necessari così da evitare che casi come quelli sopracitati si ripetano”. Non è finita. Tuonano infatti atei, “studenti medi” e Arcigay: “Chiediamo, infine, di coinvolgere nei tavoli ministeriali le realtà sociali, le associazioni e le organizzazioni studentesche che da anni combattono le discriminazioni e l’omofobia e di far sì che questi percorsi producano finalmente soluzioni concrete”. La lettera contiene poi già una velata minaccia per gli istituti cattolici paritari, che certamente la lobby sogna costretti ad accettare l’auspicato indottrinamento oppure a chiudere. Nel resto d’Europa tentativi di tal genere sono già in corso, come in Gran Bretagna o sono minacciati, come in Francia. Insomma: la legge “antiomofobia” a firma Scalfarotto ancora non è stata approvata e già produce i suoi effetti liberticidi, dato che – oltre alle intimidazioni continue – i propugnatori dell’ideologia del gender si fanno sempre più sfrontati. Il rischio è che, considerato quanto è successo fin qui, molti scelgano il silenzio per evitare di essere lapidati dai media della nota lobby. Quel che è capitato del resto a Guido Barilla è estremamente significativo. Sbilanciatosi l’anno scorso in favore della famiglia del ‘Mulino Bianco’, è stato coperto di insulti e minacce; ha così ritenuto molto opportuno profondersi in mille scuse e agire in modo tale che oggi la Barilla è pienamente riabilitata. Come scrive il Washington Post ha ottenuto 100/100 nella classifica delle imprese gay-friendly, avendo in un anno fatto “una marcia indietro radicale, aumentando i benefit sanitari per i dipendenti transgender e le loro famiglie, donando soldi per le cause dei diritti gay", oltre che ingaggiare consulenti come il “gay più potente d’America”, David Mixner, fiero dei risultati ottenuti. Ora per la Barilla del Guido rieducato mancano solo gli spot con protagoniste coppie omosessuali. Non temete, verranno presto. Si dovrà poi vedere se qualcuno non preferirà a quel punto assaporare un altro tipo di pasta.
L’ISLAM, LA SINISTRA E LA SOTTOMISSIONE.
L’assessore scambia l’Islam per terrorismo. Gli studenti: "Si deve dimettere". All’indomani della strage di Parigi Elena Donezzan, responsabile per l’Istruzione della giunta veneta, scrive un appello ai presidi per parlare di terrorismo, accostandolo alla religione islamica. Scoppia il caso e la rete degli studenti chiede che lasci il suo posto con pubbliche scuse e il ritiro delle frasi incriminate, scrive Michele Sasso “L’Espresso”. Una frase ha scatenato un putiferio: «Se non si può dire che tutti gli islamici sono terroristi, è evidente che tutti i terroristi sono islamici e che molta violenza viene giustificata in nome di una appartenenza religiosa e culturale ben precisa». È giovedì 8 gennaio 2015 e a vergare l’appassionata lettera è l’assessore all’Istruzione della Regione Veneto, Elena Donezzan, che pochi giorni prima aveva promosso un family day a scuola per difendere la famiglia naturale. Scossa per il massacro nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi, torna alla carica non pensandoci troppo sopra. Una circolare indirizzata a tutti i presidi della sua regione intitolata “Terrorismo islamico: parliamone soprattutto a scuola” con passaggi forzati carichi di livore: «Alla luce della presenza dei tanti alunni stranieri nelle nostre scuole e dei loro genitori nelle nostre comunità, soprattutto a loro dobbiamo rivolgere il messaggio di richiesta di una condanna di questi atti, perché se hanno deciso di venire in Europa devono sapere che sono accolti in una civiltà con principi e valori, regole e consuetudini a cui devono adeguarsi e che la civiltà che li sta accogliendo con il massimo della pienezza dei diritti ha anche dei doveri da rispettare». Se il fine è la conoscenza e il dibattito dell’attualità tra i banchi il risultato di questa mossa è disastroso. Via change.org è partita una petizione dell’associazione studenti universitari e della rete degli studenti per chiedere le sue dimissioni con pubbliche scuse allegate e il ritiro delle frasi incriminate. In più di quattromila hanno sottoscritto le motivazioni: «Nella circolare si chiede a tutti i dirigenti di far discutere di quanto accaduto, condannando non solo i fatti e chiedendo a genitori e studenti stranieri di dissociarsi, ma anche la cultura islamica, che alimenta, secondo l’assessore, la genesi di tali attacchi terroristici». A scaldare gli animi l’accostamento della Donezzan tra il massacro di Parigi (e tutto quello che è seguito per 55 ore di paura) con l’aggressione alle porte di Venezia di un quattordicenne tunisino che ha accoltellato il padre di uno studente vittima di bullismo. «Fare un paragone tra un gesto di bullismo e un massacro con armi da fuoco è simbolo di un becero razzismo che non possiamo accettare, specialmente se proveniente da una figura con una certa carica istituzionale», continua la petizione: «Viene da domandarsi se questo parallelo sia frutto di una strumentalizzazione cosciente dei fatti oppure da semplice ignoranza: i casi di bullismo sono diffusi in tutto il Paese, non importa l’origine culturale del ragazzo». Dietro gli studenti anche la Cgil regionale ha preso posizione: «La lettera lascia stupefatti per il forte fondamentalismo ideologico sotteso nelle indicazioni impartite. La scuola deve formare le intelligenze e lo spirito critico di quelli che saranno i cittadini di domani, è un luogo di discussione e riflessione anche per capire quanto accaduto in Francia».
Basta coi finti Charlie. La sinistra si appropria dei simboli di ciò che ha sempre combattuto, scrive Alessandro Sallusti su “Il Giornale”. La mia libertà vale più o meno di quella dei colleghi di Charlie? La nostra libertà, quella di ognuno di noi, compresi la Le Pen e Salvini, quanto vale? E ancora: chi decide la classifica delle libertà? Mi chiedo questo perché stiamo assistendo al più ipocrita degli spettacoli e al più surreale dei dibattiti. Giornalisti, intellettuali e politici di sinistra si sono stretti - dico io giustamente - attorno ai colleghi sterminati dalla furia islamica. Ma, contemporaneamente, dagli stessi è partita una campagna contro chi, come noi, sostiene che il pericolo viene proprio dal Corano, dall'islam e dai suoi imam. In queste ore, in tv e sui giornali, ci stanno facendo passare per dei provocatori, dei seminatori di odio, degli incendiari. Ma dico: se c'è qualcuno che, in decimo, ha sostenuto e scritto negli anni ciò che Charlie ha divulgato con la sua tecnica, siamo proprio noi. Noi siamo Charlie, la Fallaci è Charlie, Magdi Allam è Charlie, Piero Ostellino è Charlie. I liberali tutti sono Charlie. Voi di sinistra siete solo degli approfittatori, vi siete impossessati del corpo di un nemico ucciso per quella libertà di opinione che voi di sinistra negavate prima della strage (satira religiosa sì, ma solo contro il Papa e Gesù) e che ancora ora vorreste negare a noi. Se questo Giornale avesse pubblicato una sola di quelle vignette blasfeme saremmo stati linciati come razzisti, fascisti, pazzi irresponsabili e messi al gabbio dalla solerte magistratura italiana per islamofobia (ci siamo andati comunque vicini, nonostante il reato non esista nei nostri codici). E invece, da domani, sarà gara anche a sinistra per pubblicare le nuove frecciate del primo numero di Charlie Hebdo post attentato. Perché Charlie domani potrà dire sull'islam ciò che pensa e noi dovremmo invece allinearci al politicamente corretto? Non condivido molte cose che sostengono la Le Pen e Salvini, ma se uno «è Charlie» deve essere anche Le Pen e Salvini. Cioè deve essere uomo libero e garantire la libertà di chiunque. Cara sinistra, è facile sostenere i diritti dei morti. Anche perché, se fossero vivi, quelli di Charlie vi farebbero un mazzo tanto, quantomeno una pernacchia lunga da Parigi a Roma.
Se la sinistra odia il popolo, scrive Alessandro Catto su “Il Giornale”. La marcia di Parigi, come da programma, ha scatenato apprezzamento e condanna, sentimenti di simpatia e lontananza. Un’ondata di contraddizioni provenente in primis da quelli che, da questa marcia, avrebbero dovuto sentirsi rappresentati, ovvero i cittadini europei. Un evento che più che storico per meriti fisiologici, si è voluto rendere storico nella sua formulazione, nella sua presentazione ai media, nel dipingerlo come unica risposta possibile ad un attacco verso l’Occidente e i suoi valori. Premetto che per me non è stata una marcia trionfale, tantomeno un successo, soprattutto per quanto riguarda la testa di quel corteo. Coi suoi leaders in giacca e cravatta, i capi di stato, sembrava una pratica di circostanza tremendamente ipocrita e fasulla, qualcosa di fatto perché così c’è scritto che bisogna fare. Un qualcosa incapace di rappresentarmi e di rappresentare moltissime persone come me che dovrebbero, in teoria, essere e sentirsi cittadini europei. Alla testa di quel corteo è andata in scena l’ipocrisia di numerosissimi politici europei che hanno grosse responsabilità riguardo la situazione mediterranea e mediorientale. Vi erano personaggi che fino a ieri ci mostravano i benefici della primavera araba di turno, il suo carattere evangelico ed evangelizzante. Vi erano gli alfieri della democrazia per esportazione, gli alfieri di una Europa che non unisce. C’era un trionfo di bandiere in Piazza della Repubblica, ma bandiere europee ce n’erano pochissime. Quella manifestazione ha avuto più il carattere di un secondo funerale ai morti di Charlie Hebdo che non quello di una rivendicazione di orgoglio, di identità e di appartenenza. Ce l’ha avuto a partire dalla sua formulazione, dall’aver fatto fin dal principio figli e figliastri. Quella manifestazione stessa è figlia pure di una porzione politica che, fin da quando il terribile agguato alla sede parigina di Charlie è avvenuto, si è preoccupata più di fare tribuna politica contro il Salvini o la Le Pen di turno che di offrire tutto il proprio supporto alle vittime. Pare esserci stata più veemenza nell’attaccare i capipartito di destra che sensibilità nel puntare il dito contro i responsabili del fatto di sangue. Ieri non è andata in scena la marcia di una Europa unita ma semmai quella di molte nazioni divise, divise pure al loro interno. Nel sud della Francia, mentre le anime belle europee marciavano a colpi di foto e riprese, è andata in scena la marcia sponsorizzata da Marine Le Pen e dal Front National. La marcia dei dannati, degli ultimi, degli esclusi da tutto. Di quelli che non vanno di moda, che fa sempre prurito ospitare in qualche salotto, di quelli che non parlano di Europa, di Diritti e Democrazia, di concetti maiuscolati. Un partito ed una leader scomodi, che è meglio cancellare ed evitare se si vuole andare in piazza imbellettati e col sorriso. Strano però, perché a suon di parlare di democrazia ci siamo forse dimenticati di farla a casa nostra, e ci siamo dimenticati che quel partito così odiato, temuto, becero per bocca dei professori dei nostri tempi, è il primo partito di Francia per consenso elettorale. Marciamo per la libertà dei popoli dimenticandoci di cos’è il popolo, del suo diritto ad essere rappresentato. Si è preferito usare un fatto tragico per trasformare il tutto nella solita, trita e oramai inascoltabile retorica sul rifiuto dei fascismi, dei razzismi, sull’accoglienza, sulla condanna di una ipotetica strumentalizzazione. Qui l’unica strumentalizzazione che ho visto, personalmente, è stata quella di chi, a cadaveri ancora caldi, ha subito messo in piedi un gioco orribile per colpire l’avversario politico, di chi ha approfittato dell’occasione per provare, tristemente, a ritornare rappresentante del popolo dopo l’usurpazione. La sinistra non dimentica, è vendicativa, non tollera usurpazioni. E quella del Front in Francia e pure della Lega in Italia è una usurpazione in piena regola. In termini elettorali, politici e in termini di consenso. La rabbia monta in partiti di sinistra che non riescono più a farsi intercettori delle istanze popolari più umili, che non sanno dar loro rappresentazione, che si ritrovano smarriti. In questi casi allora si tenta sempre di barrare la strada a chi può divenire l’intercettore della protesta al proprio posto. Può esservi la risposta più scaltra, quella di un centrosinistra in salsa renziana che tenta di attirare gli apparati più moderati della nazione. Ma c’è anche la risposta più rabbiosa, più puerile, e sta alla sua sinistra: quella di chi ha perso tutto, ha perso la propria dimensione elettorale, ha perso il passo nei confronti delle istanze del popolo, di chi come unica arma conserva una sola cosa: l’assalto indiscriminato all’avversario e al suo successo, con tutti i mezzi possibili. La sinistra di oggi pare odiare ferocemente il popolo perché l’ha smarrito, perché sa benissimo che moltissimi operai, cassaintegrati, esodati, sia in Francia che in Italia non vogliono salotti, sofismi, filosofie, teosofie, psicodrammi e buonismi. Vogliono soluzioni immediate, presenze tangibili, capacità di dialogo e rappresentazione, vogliono poter confessare le proprie paure e le proprie necessità, anche quelle politicamente scorrette. E questo ormai, in Europa, non lo si fa nella piazza di Parigi, lo si fa nella piazza di Beaucaire con la Le Pen, lo si fa a Musile di Piave con Salvini. Il popolo è lì, consegnato in toto al nemico a son di cianciare di populismo e demagogia. Parlando proprio di rapporto tra Islam e Occidente sentivo ieri, in una nota trasmissione serale di La7, un giovane dire che “non si può far parlare chi non arriva agli ottocento euro al mese”. Un giovane in giacca, occhiali da hipster, erre arrotata, espressione massima del ben pensare de sinistra in salsa europea. Non me la sento di attaccarlo perché esprime chiaramente quello che è la sinistra oggi. Rifiuto del più povero e del più debole, al quale si può pure tappare la bocca. Negazione del disagio, elogio del buonismo. Rifiuto per le classi più povere e disprezzo delle stesse. Non c’è cosa più trendy, al giorno d’oggi, di usare il termine populismo come offesa. E’ un qualcosa che potrebbe tranquillamente essere adottato come criterio di iniziazione per un percorso che parte dalle giovanili del PD, dalle università, dagli apericena meticci, dai lupanari dell’accoglienza. La sinistra oggi è questa, e sfila in giacca e cravatta dopo aver tentato di esportare la sua democrazia in giro per il mondo. Permetteteci di dissentire, e di preferire la piazza di Beaucaire. Che forse ha ancora il diritto di venir chiamata piazza, e non palcoscenico.
Alessandro Catto, laureato in Storia, collabora anche con l’Intellettuale Dissidente. Si occupa di politica e società. Nemico del pensiero unico, tradizionalista per reazione, popolare per collocazione, identitario per protesta, controcorrente per natura, nemico dichiarato della dittatura culturale da sinistra salottiera. Nato a Camposampiero (Padova) il 22/11/1991.
Maometto. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Maometto (La Mecca, 570 circa – Medina, 8 giugno 632) è stato il fondatore e, per i musulmani, l'ultimo profeta dell'Islam. Considerato dai musulmani di ogni declinazione - ad eccezione degli Ahmadi - l'ultimo esponente di una lunga tradizione profetica all'interno della quale occupa una posizione di assoluto rilievo, Messaggero di Dio (Allah) e Sigillo dei profeti, per citare solo due degli epiteti onorifici che gli sono tradizionalmente riferiti, sarebbe stato incaricato da Dio stesso - attraverso l'arcangelo Gabriele - di divulgare il suo verbo tra gli Arabi.
Prima della Rivelazione. Maometto (che nella sua forma originale araba significa "il grandemente lodato") nacque in un giorno imprecisato (che secondo alcune fonti tradizionali sarebbe il 20 o il 26 aprile di un anno parimenti imprecisabile, convenzionalmente fissato però al 570) a Mecca, nella regione peninsulare araba del Hijaz, e morì il lunedì 13 rabīʿ I dell'anno 11 dell'Egira (equivalente all'8 giugno del 632) a Medina e ivi fu sepolto, all'interno della casa in cui viveva. Sia per la data di nascita, sia per quella di morte, non c'è tuttavia alcuna certezza e quanto riportato costituisce semplicemente il parere di una maggioranza relativa, anche se sostanziosa, di tradizionisti. La sua nascita sarebbe stata segnata, secondo alcune tradizioni, da eventi straordinari e miracolosi. Appartenente a un importante clan di mercanti, quello dei Banu Hashim, componente della più vasta tribù dei Banu Quraysh di Mecca, Maometto era l'unico figlio di ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Muttalib ibn Hāshim e di Āmina bint Wahb, figlia del sayyid del clan dei Banu Zuhra, anch'esso appartenente ai B. Quraysh. Orfano fin dalla nascita del padre (morto a Yathrib al termine d'un viaggio di commercio che l'aveva portato nella palestinese Gaza), Maometto rimase precocemente orfano anche di sua madre che, nei suoi primissimi anni, l'aveva dato a balia a alīma bt. Abī Dhuʿayb, della tribù dei Banū Saʿd b. Bakr, che effettuava piccolo nomadismo intorno a Yathrib. Nell'Arabia preislamica già esistevano comunità monoteistiche, comprese alcune di cristiani ed ebrei. A Mecca - dove, alla morte della madre, fu portato dal suo primo tutore, il nonno paterno ʿAbd al-Muttalib ibn Hāshim, e dove poi rimase anche col secondo suo tutore, lo zio paterno Abu Tàlib - Maometto potrebbe forse aver avuto l'occasione di entrare in contatto presto con quei hanīf, che il Corano vuole fossero monoteisti che non si riferivano ad alcuna religione rivelata, come si può leggere nelle sure III:67 e II:135. Secondo una tradizione islamica, egli stesso era un hanīf e un discendente di Ismaele, figlio di Abramo. La storicità di questo gruppo è comunque discussa fra gli studiosi. Nei suoi viaggi fatti in Siria e Yemen con suo zio, Maometto potrebbe aver preso conoscenza dell'esistenza di comunità ebraiche e cristiane e dell'incontro, che sarebbe avvenuto quando Maometto aveva 9 o 12 anni, col monaco cristiano siriano Bahīra - che avrebbe riconosciuto in un neo fra le sue scapole il segno del futuro carisma profetico - si parla già nella prima biografia (Sīra) di Maometto, che fu curata, vario tempo dopo la morte, da Ibn Isāq per essere poi ripresa in forma più "pia" da Ibn Hishām. Oltre alla madre e alla nutrice, due altre donne si presero cura di lui da bambino: Umm Ayman Baraka e Fātima bint Asad, moglie dello zio Abū Tālib. La prima era la schiava etiopica della madre che lo aveva allevato dopo il periodo trascorso presso con Halīma, rimanendo con lui fino a che Maometto ne propiziò il matrimonio, dapprima con un medinese e poi col figlio adottivo Zayd. Nella tradizione islamica Umm Ayman, che generò Usama ibn Zayd, fa parte della Gente della Casa (Ahl al-Bayt) e il Profeta nutrì sempre per lei un vivo affetto, anche per essere stata una delle prime donne a credere al messaggio coranico da lui rivelato. Altrettanto importante fu l'affettuosa e presente sua zia Fātima bint Asad, che Maometto amava per il suo carattere dolce, tanto da mettere il suo nome a una delle proprie figlie e per la quale il futuro profeta pregò spesso dopo la sua morte. I numerosi viaggi intrapresi per via dell'attività mercantile familiare - dapprima con lo zio e poi come agente della ricca e colta vedova Khadīja bt. Khuwaylid - dettero a Maometto occasione di ampliare in maniera significativa le sue conoscenze in campo religioso e sociale. Sposata nel 595 Khadìja bint Khuwàylid (che restò finché visse la sua unica moglie), egli poté dedicarsi alle sue riflessioni spirituali in modo più assiduo e, anzi, pressoché esclusivo. Khadìja fu il primo essere umano a credere nella Rivelazione di cui Maometto era portatore e lo sostenne con forte convinzione fino alla sua morte avvenuta nel 619. A lui, in una vita di coppia senz'altro felice, dette quattro figlie - Zaynab, Ruqayya, Umm Khulthūm e Fāima, detta al-Zahrāʾ (tutte premorte al padre, salvo l'ultima) - oltre a due figli maschi (al-Qàsim e ʿAbd Allah) che morirono tuttavia in tenera età.
Rivelazione. Nel 610 Maometto, affermando di operare in base a una Rivelazione ricevuta, cominciò a predicare una religione monoteista basata sul culto esclusivo di Dio, unico e indivisibile. In effetti il concetto di monoteismo era diffuso in Arabia da tempi più antichi e il nome Allah (principale nome di Dio nell'Islam) significa semplicemente "Iddio". Gli abitanti dell'Arabia peninsulare e di Mecca - salvo pochi cristiani e zoroastriani e un assai più consistente numero di ebrei - erano per lo più dediti a culti politeistici e adoravano un gran numero di idoli. Questi dèi erano venerati anche in occasione di feste, per lo più abbinate a pellegrinaggi (in arabo: mawsim). Particolarmente rilevante era il pellegrinaggio panarabo, detto ajj, che si svolgeva nel mese lunare di Dhu l-Hijja ("Quello del Pellegrinaggio"). In tale occasione molti devoti arrivavano nei pressi della città, nella zona di Mina, Muzdalifa e di ʿArafa. Gli abitanti di Mecca avevano anche un loro proprio pellegrinaggio urbano (la cosiddetta ʿumra) che svolgevano nel mese di rajab in onore del dio tribale Hubal e delle altre divinità panarabe, graziosamente ospitate dai Quraysh all'interno del santuario meccano della Kaʿba. Maometto, come altri anīf, era solito ritirarsi a meditare, secondo la tradizione islamica, in una grotta sul monte Hira vicino Mecca. Secondo tale tradizione, una notte, intorno all'anno 610, durante il mese di Ramadan, all'età di circa quarant'anni, gli apparve l'arcangelo Gabriele (in arabo Jibrīl o Jabrāʾīl, ossia "potenza di Dio": da "jabr", potenza, e "Allah", Dio) che lo esortò a diventare Messaggero (rasūl) di Allah con le seguenti parole: « (1) Leggi, in nome del tuo Signore, che ha creato, (2) ha creato l'uomo da un grumo di sangue! (3) Leggi! Ché il tuo Signore è il Generosissimo, (4) Colui che ha insegnato l’uso del calamo, (5) ha insegnato all'uomo quello che non sapeva». Turbato da un'esperienza così anomala, Maometto credette di essere stato soggiogato dai jinn e quindi impazzito (majnūn, "impazzito", significa letteralmente "catturato dai jinn") tanto che, scosso da violenti tremori, cadde preda di un intenso sentimento di terrore. Secondo la tradizione islamica Maometto poté in quella sua prima esperienza teopatica sentire le rocce e gli alberi che gli parlavano. Preso dal panico fuggì a precipizio dalla caverna in direzione della propria abitazione e nel girarsi vide Gabriele sovrastare con le sue ali immense l'intero orizzonte (per quel "gigantismo" che caratterizza le "realtà angeliche", anche in contesti diversi da quello islamico) e lo sentì rivelargli di essere stato prescelto da Dio come suo messaggero. Non gli fu facile accettare tale notizia ma a convincerlo della realtà di quanto accadutogli, provvide innanzi tutti la fede della moglie e, in seconda battuta, quella del cugino di lei, Waraqa ibn Nawfal, che alcuni indicano come cristiano ma che, più verosimilmente, era uno di quei monoteisti arabi (anīf) che non si riferivano tuttavia a una specifica struttura religiosa organizzata. Dopo un lungo e angosciante periodo in cui le sue esperienze non ebbero seguito (fatra), Gabriele tornò di nuovo a parlargli per trasmettergli altri versetti e questo proseguì per 23 anni, fino alla morte nel 632 di Maometto.
È ancora oggetto di disputa la questione riguardante l'analfabetismo di Maometto. Si nota come la sua professione di commerciante abbia potuto portarlo in contatto con altre lingue e altre culture, e come sia intervenuto, secondo una tradizione riportata da Tabari, per apportare una correzione riguardante la sua firma nel Trattato di udaybiyya. Ci sarebbe poi una lettera autografa, conservata nel museo Topkapi di Istanbul. Secondo alcuni, tutto deriverebbe da un equivoco riguardante l'espressione a lui riferita di al-Nabī al-ummī che può voler dire in effetti "il profeta ignorante" ma anche, e più verosimilmente, "il profeta della comunità (araba)" o "il profeta di una cultura non basata su testi sacri scritti". Altre fonti fanno notare come le personalità in grado di leggere e scrivere, nel periodo precedente all'Egira, fossero una quindicina, tutte conosciute per nome, e in effetti il Corano sarebbe il più antico libro arabo in prosa. Studiosi occidentali fanno notare come le tribù nomadi, compresa quella di Maometto, disprezzassero la scrittura, privilegiando la trasmissione orale delle conoscenze. La maggior parte dei musulmani propende per un analfabetismo del loro Profeta, escludendo pertanto radicalmente che egli abbia potuto leggere la Bibbia o altri testi sacri, che del resto sarebbero comparsi in forma scritta solo diverso tempo dopo la sua morte. Maometto cominciò dunque a predicare la Rivelazione che gli trasmetteva Jibrīl, ma i convertiti nella sua città natale furono pochissimi per i numerosi anni che egli ancora trascorse a Mecca. Fra essi il suo amico intimo e coetaneo Abu Bakr (destinato a succedergli come califfo, guida della comunità islamica che si fondò con lenta ma sicura progressione malgrado l'assenza di precise indicazioni scritte e orali in merito) e un gruppetto assai ristretto di persone che sarebbero stati i suoi più validi collaboratori: i cosiddetti "Dieci Benedetti" (al-ʿashara al-mubashshara). La Rivelazione da lui espressa dunque - raccolta dopo la sua morte nel Corano, il libro sacro dell'Islam - dimostrò la validità del detto evangelico per cui "nessuno è profeta in patria". Maometto ripeté per ben due volte per intero il Corano nei suoi ultimi due anni di vita e molti musulmani lo memorizzarono per intero ma fu solo il terzo califfo ʿUthmān b. ʿAffān a farlo mettere per iscritto da una commissione coordinata da Zayd b. Thābit, segretario del Profeta. Così il testo accettato del Corano poté diffondersi nel mondo a seguito delle prime conquiste che portarono gli eserciti di Medina in Africa, Asia ed Europa, rimanendo inalterato fino ad oggi, malgrado lo Sciismo vi aggiunga un capitolo (Sura) e alcuni brevi versetti (ayat).
Gli ultimi anni a Mecca e l'Egira. Nel 619, l'"anno del dolore", morirono tanto suo zio Abu Talib, che gli aveva garantito affetto e protezione malgrado non si fosse convertito alla religione del nipote, quanto l'amata Khadìja. Fu solo dopo ripetute insistenze che Maometto contrasse nuove nozze, tra cui quelle con ʿĀʾisha bt. Abī Bakr, figlia del suo più intimo amico e collaboratore, Abu Bakr. L'ostilità dei suoi concittadini tentò di esprimersi con un prolungato boicottaggio nei confronti di Maometto e del suo clan, con il divieto di intrattenere con costoro rapporti di tipo economico commerciale, i troppi vincoli parentali creatisi però fra i clan della stessa tribù fecero fallire il progetto di ridurre a più miti consigli Maometto. Nel 622 il crescente malumore dei Quraysh nel veder danneggiati i propri interessi - a causa dell'inevitabile conflitto ideologico e spirituale che si sarebbe radicato con gli altri arabi politeisti (che con loro proficuamente commerciavano e che annualmente partecipavano ai riti della ʿumra del mese di rajab) - lo indusse a rifugiarsi con la sua settantina di correligionari, a Yathrib, trecentoquaranta chilometri più a nord di Mecca, che mutò presto il proprio nome in Madīnat al-Nabī, "la Città del Profeta" (Medina). Il 622, l'anno dell'Egira (emigrazione), divenne poi sotto il califfo 'Omar ibn al-Khattàb il primo anno del calendario islamico, utile alla tenuta dei registri fiscali e dell'amministrazione in genere.
La Umma e l'inizio dei conflitti armati. Inizialmente Maometto si ritenne un profeta inserito nel solco profetico antico-testamentario, ma la comunità ebraica di Medina non lo accettò come tale. Nonostante ciò, Maometto predicò a Medina per otto anni e qui, fin dal suo primo anno di permanenza, formulò la Costituzione di Medina (Rescritto o Statuto o Carta, in arabo aīfa) che fu accettata da tutte le componenti della città-oasi e che vide il sorgere della Umma, la prima Comunità politica di credenti. Nello stesso tempo, con i suoi seguaci, condusse attacchi contro le carovane dei Meccani e respinse i loro contrattacchi. L'ostilità di Maometto nei confronti dei suoi concittadini si concretizzò nel primo vittorioso scontro armato ai pozzi di Badr, alla successiva disfatta di Uud e alla finale vittoria strategica di Medina (Battaglia del Fossato) contro i politeisti Quraysh che lo avevano inutilmente assediato.
L'atteggiamento verso gli ebrei. In tutte queste circostanze Maometto colpì in diversa misura anche gli ebrei di Medina, che si erano resi colpevoli agli occhi della Umma della violazione del Rescritto di Medina e di tradimento nei confronti della componente islamica. In occasione dei due primi fatti d'armi furono esiliate le tribù ebraiche dei Banū Qaynuqāʿ e dei Banū Naīr, mentre dopo la vittoria nella cosiddetta "battaglia" del Fossato (Yawm al-Khandaq), i musulmani decapitarono tra i 700 e i 900 uomini ebrei della tribù dei Banū Qurayza, arresasi ai seguaci del Profeta in conseguenza del fallimento dell'assedio dei Quraysh e dei loro alleati arabi, protrattosi per 25 giorni. Le loro donne e i loro bambini furono invece venduti come schiavi sui mercati d'uomini di Siria e del Najd, dove vennero quasi tutti riscattati dai loro correligionari di Khaybar, Fadak e di altre oasi arabe higiazene. La cruenta decisione fu probabilmente la conseguenza dell’accusa di intelligenza col nemico durante l’assedio ma la sentenza non fu decisa da Maometto che invece affidò il responso sulla punizione da adottare a Saʿd b. Muʿādh, sayyid dei Banū ʿAbd al-Ashhal, clan della tribù medinese dei Banu Aws e un tempo principale alleato dei B. Quraya. Questi, ferito gravemente da una freccia (tanto da morirne pochissimi giorni più tardi) e ovviamente pieno di rabbia e rancore, decise per quella soluzione estrema, non frequente ma neppure del tutto inconsueta per l'epoca. Che non si trattasse comunque di una decisione da leggere in chiave esclusivamente anti-ebraica potrebbe dimostrarcelo il fatto che gli altri B. Quraya che vivevano intorno a Medina, e nel resto del ijāz (circa 25.000 persone), non furono infastiditi dai musulmani, né allora, né in seguito. In proposito si è anche espresso uno dei più apprezzati storici del primo Islam, Fred McGrew Donner, che, nel suo Muhammad and the believers (Cambridge, MA, The Belknap Press of Harvard University Press, 2010, p. 74), afferma « dobbiamo... concludere che gli scontri con altri ebrei o gruppi di ebrei furono il risultato di particolari atteggiamenti o comportamenti politici di costoro, come, per esempio, il rifiuto di accettare la leadership o il rango di profeta di Muhammad. Questi episodi non possono pertanto essere considerati prove di un'ostilità generalizzata nei confronti degli ebrei da parte del movimento dei Credenti, così come non si può concludere che Muhammad nutrisse un'ostilità generalizzata nei confronti dei Quraysh perché fece mettere a morte e punì alcuni suoi persecutori appartenenti a questa tribù. (Fred M. Donner, Maometto e le origini dell'islam, ediz. e trad. di R. Tottoli, Torino, Einaudi, 2011, p. 76-77). » Una minoranza di studiosi musulmani rifiutano di riconoscere l'incidente ritenendo che Ibn Ishaq, il primo biografo di Maometto, abbia presumibilmente raccolto molti dettagli dello scontro dai discendenti degli stessi ebrei Qurayza. Questi discendenti avrebbero arricchito o inventato dettagli dell'incidente prendendo ispirazione dalla storia delle persecuzioni ebraiche in epoca romana.
La conquista dell'Arabia e la morte. Nel 630 Maometto era ormai abbastanza forte per marciare su Mecca e conquistarla. Tornò peraltro a vivere a Medina e da qui ampliò la sua azione politica e religiosa a tutto il resto del Hijaz e, dopo la sua vittoria nel 630 a unayn contro l'alleanza che s'imperniava sulla tribù dei Banū Hawāzin, con una serie di operazioni militari nel cosiddetto Wadi al-qura, a 150 chilometri a settentrione di Medina, conquistò o semplicemente assoggettò vari centri abitati (spesso oasi), come Khaybar, Tabūk e Fadak, il cui controllo aveva indubbie valenze economiche e strategiche.
Due anni dopo Maometto morì a Medina, dopo aver compiuto il Pellegrinaggio detto anche il "Pellegrinaggio dell'Addio", senza indicare esplicitamente chi dovesse succedergli alla guida politica della Umma. Lasciava nove vedove - tra cui ʿĀʾisha bt. Abī Bakr - e una sola figlia vivente, Fāima, andata sposa al cugino del profeta, ʿAlī b. Abī ālib, madre dei suoi nipoti al-asan b. ʿAlī e al-usayn b. ʿAlī. Fatima, piegata dal dolore della perdita del padre e logorata da una vita di sofferenze e fatiche, morì sei mesi più tardi, diventando in breve una delle figure più rappresentative e venerate della religione islamica.
Origine del nome. "Maometto" è la volgarizzazione italiana fatta in età medievale del nome "Muhammad", utile semplificazione della pronuncia. La parola araba "muhammad", che significa "grandemente lodato", è infatti un participio passivo di II forma (intensiva) della radice [h-m-d] (lodare). Secondo lo studioso francese Michel Masson], invece, nelle lingue romanze, e tra queste l'italiano, si osserva una storpiatura del nome del profeta in senso spregiativo (e da ciò deriverebbero, a suo dire, il francese Mahomet e l'italiano Macometto). Allo stesso modo si esprimono alcuni scrittori italiani che ritengono che il nome "Maometto" non sarebbe di diretta origine araba, ma "un'italianizzazione" adottata all'epoca per costituire una sintesi dell'espressione spregiativa di "Mal Commetto", volta a conferire una connotazione negativa al Profeta dell'Islam.
Maometto secondo i non musulmani. Dopo un protratto periodo di indifferenza nei confronti dell'Islam, superficialmente equivocato dalla Cristianità occidentale e orientale, come una delle tante eresie del Cristianesimo nelle dispute con cristiani, questi ultimi sottolinearono sovente il carattere sincretistico della religione di Maometto, basata allo stesso tempo su tradizioni arabe preislamiche (come il culto della Pietra Nera della Mecca) e su tradizioni cristiane siriache ed ebraiche, e mossero critiche alla personalità di Maometto, alla formazione e trasmissione del testo coranico e alla diffusione dell'islam attraverso la spada. Nell'Occidente medievale Maometto fu considerato per oltre cinque secoli un cristiano eretico. Dante Alighieri - non consapevole del profondo grado di diversità teologica della fede predicata da Maometto, per l'influenza su di lui esercitata dal suo Maestro Brunetto Latini, che riteneva Maometto un chierico cristiano di nome Pelagio, appartenente al casato romano dei Colonna - lo cita nel canto XXVIII dell'Inferno tra i seminatori di scandalo e di scisma nella Divina Commedia assieme ad Ali ibn Abi Tàlib, suo cugino-genero, coerentemente con quanto da lui già scritto ai versetti 70-73 del canto VIII dell'Inferno:« ...«Maestro, già le sue meschite / là entro certe ne la valle cerno, / vermiglie come se di foco uscite / fossero... » in cui le "meschite" (evidente deformazione della parola del volgare castigliano mezquita, derivante dall'arabo masjid, che significa moschea) della città di Dite sono le "vermiglie" abitazioni della città dannata ove dimorano gli eresiarchi cristiani. È questo (e non altro) il motivo per cui nella basilica di San Petronio a Bologna, in un celebre affresco, Maometto fu raffigurato all'inferno, secondo la descrizione di Dante, con il ventre squarciato, come spaccata era la comunità cristiana a causa dei suoi vari scismi. Il motivo per cui Dante lo colloca tra i seminatori di discordie e non tra gli eresiarchi è probabilmente dovuto a una leggenda medievale che parla di Maometto come vescovo e cardinale cristiano, che poi avrebbe rinnegato la propria fede, deluso per non aver raggiunto il papato o per altra ragione e avrebbe creato una nuova religione «mescolando quella di Moisè con quella di Cristo». Secondo una tradizione diffusa tra i musulmani, il Negus di Abissinia - che ospitò gli esiliati musulmani quando Maometto era in vita - avrebbe attestato la sua fede in lui come profeta di Dio.
Si può ridere di Dio? Mentre il divino evoca risate, il demoniaco spande paura, scrive Paolo Pegoraro su “Aleteia”. Ricordiamo tutti il monaco cieco che, ne Il nome della rosa, avvelena quanti si avvicinano al prezioso scritto nel quale Aristotele difende la commedia e il riso. È vero che la tristezza intossica, meno che il Medioevo sia stato un’epoca di cupa e triste penitenza. Eric Auerbach, nel suo immortale studio Mimesis, ha documentato che la struttura portante della narrativa cristiana, a partire dai Vangeli, è proprio la commedia… non la tragedia. E Dante, con la sua Comedìa, ne è la pietra miliare. Lo affianca il prologo che Francois Rabelais – frate francescano (a suo modo), monaco benedettino (a suo modo), parroco diocesano (a suo modo) – antepone al Gargantua et Pantagruel: «Altra cosa non può il mio cuore esprimere / vedendo il lutto che da voi promana: / meglio è di risa che di pianti scrivere, / ché rider soprattutto è cosa umana». Altrettanto si potrebbe dire per il suo predecessore padano, il monaco, poi ex monaco, infine di nuovo monaco Teofilo Folengo. La tradizione del grottesco e del caricaturale crebbe febbrilmente in Occidente: dalle deformi statue gotiche alle pagine grottesche di Flannery O’Connor fino al caricaturale Vangelo secondo Biff di Christopher Moore. Per contrapporsi e disgregare le istituzioni, si dirà. Fosse pure, il fatto è che la tradizione comico-grottesca crebbe qui come non altrove. Prolificò qui un umorismo religioso, dissacrante, talora perfino blasfemo. Nessuna sorpresa: le barzellette più sconce vengono bisbigliate in sacrestia. Come si rapporta, allora, Dio con il ridere? Il grande poeta irlandese Patrick Kavanagh espose il suo pensiero in maniera convincente nella composizione A View of God and the Devil (Una visione di Dio e del Diavolo – traduzione dell’autore).
* * *
Ho incontrato Dio Padre sulla strada e gli aggettivi con cui vorrei descriverlo sono questi: divertente, sperimentale, irresponsabile sulle frivolezze. Non era un uomo che vorrebbe essere eletto al Consiglio né impressionerebbe un vescovo o un circolo di artisti. Non era splendido, spaventoso o tremendo e neppure insignificante. Questo era il mio Dio che fece l’erba e il sole e i ciottoli nei ruscelli in aprile; questo era il Dio che ho incontrato in una vecchia cava colma di denti-di-leone. Questo era il Dio che ho incontrato a Dublino mentre vagavo per strade inconsapevoli. Questo era il Dio che covò sui campi erpicati di Rooney accanto alla statale Carrick il giorno che i miei primi versi furono stampati io lo conobbi e mai ebbi paura di morte o dannazione e seppi che la paura di Dio era il principio della follia.
Il Diavolo anche il Diavolo ho incontrato, e gli aggettivi con cui vorrei descriverlo sono questi: solenne, noioso, conservatore. Era l’uomo che il mondo eleggerebbe al Consiglio, sarebbe nella lista degli invitati al ricevimento di un vescovo, assomigliava a un artista. Era il tizio che scrive di musica sui quotidiani andava in collera quando qualcuno rideva; era grave su cose senza peso; dovevi fare attenzione al suo complesso d’inferiorità perché era consapevole di non essere creativo.
* * *
Colpisce che il primo aggettivo scelto da Kavanagh per descrivere il “suo” Dio sia proprio amusing (“divertente”) in opposizione a quel povero diavolo che «andava in collera quando qualcuno rideva». Perché rideva proprio di lui, probabilmente, abituato a prendersi “dannatamente” sul serio. Mentre il divino sa essere irresponsabile «sulle frivolezze», il demoniaco è grave «su cose senza peso». Mentre il divino evoca risate, il demoniaco spande paura. Mentre il divino umorismo ha mille sfumature, la “dannata” serietà è monolitica e monotona. Il Dio di Kavanagh è un Dio autoironico. Non è possibile deriderlo semplicemente perché è Lui il primo a ridere di se stesso. Non si può ridere “di” Dio semplicemente perché si può ridere soltanto “con” Lui. Proprio perché così prolificamente creativo (egli “cova” i campi come una chioccia) e fantasioso, non sorprenderebbe se fosse Lui in persona l’autore delle migliori storielle su se stesso. Se il demoniaco rivela il proprio «complesso d’inferiorità» irrigidendosi di continuo, nel vano tentativo di nascondere la propria sterilità, per contro il sigillo della creatività senza limiti è l’umiltà (umile, yet not insignificant!). E, fra tutte, l’autoironia è la forma di umiltà più bella. Perché l’autoironia è una forma di umiltà così autentica che proprio non ci riesce, a prendersi sul serio.
Chiunque sa ridere degli altri, basta avere un granello d'intelligenza; ma per ridere con loro di se stessi, occorre un'oncia di santità.
Divina Commedia. Dante aveva già capito tutto: ecco dove e come aveva messo Maometto. C'è una satira anti-Maometto più feroce di quella di Charlie Hebdo. Circola liberamente in Europa e non solo da secoli. A scriverla fu uno dei più grandi scrittori della storia dell'Occidente. E la si studia anche in tutte le scuole. Mette il profeta musulmano e Alì, suo cugino, genero e successore come Califfo, nientemeno che all'inferno, nel canto XXVIII dedicato ai seminatori di discordia. Lui, l'anti-Maometto, è nientemeno che Dante e l'opera è la Divina Commedia. In cui Maometto viene messo nella bolgia più "sozza" che si possa immaginare, piena di corpi mutilati e orrendamente sfigurati. C'è che secondo le convinzioni dell'epoca, condivise evidentemente da Dante, l'islam era il risultato di uno scisma nell'ambito della cristianità: come riporta il Corriere della Sera, il cardinale o monaco Maometto, amareggiato per non aver conseguito il papato, avrebbe fondato una nuova dottrina. Per questo Dante lo immagina nella nona bolgia, squarciato dal mento all'ano, "infin dove si trulla" (ovvero dove si scorreggia). Alì con la faccia spaccata dal mento alla fronte. Questo perchè, secondo Dante, i seminatori di discordia nell'aldilà erano condannati a subire il contrappasso adeguato, soffrendo nel loro corpo le stesse mutilazioni di cui sono stati artefici in vita.
Dante, Maometto e Charlie Hebdo, scrive “Biuso”.
«Già veggia, per mezzul perdere o lulla,
com’io vidi un, così non si pertugia,
rotto dal mento infin dove si trulla.
Tra le gambe pendevan le minugia;
la corata pareva e ‘l tristo sacco
che merda fa di quel che si trangugia.
Mentre che tutto in lui veder m’attacco,
guardommi e con le man s’aperse il petto,
dicendo: ‘Or vedi com’ io mi dilacco!”
vedi come storpiato è Mäometto!’»
(Inferno, XXVIII, 22-31).
Così Dante Alighieri descrive la figura ripugnante dello ‘scismatico’ Maometto, tagliato/squartato come lui volle tagliare/squartare l’unità cristiana del Mediterraneo. Ancora una volta i monoteismi confermano tutta la loro carica di violenza, gli uni contro gli altri. Nel presente i più pericolosi e armati di tali monoteismi sono quello di Israele e quello degli islamisti. Massacrare i redattori del giornale parigino Charlie Hebdo perché hanno «offeso il Profeta» è semplicemente ripugnante. E conferma ancora una volta tutta la violenza insita nell’Identità senza Differenza, nell’Uno.
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione servile. Non avere altri dèi di fronte a me. […] Perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per quanti mi odiano, ma usa misericordia fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti» (Deuteronomio, cap. 5, versetti 6-10).
«Allah testimonia, e con Lui gli Angeli e i sapienti, che non c’è dio all’infuori di Lui, Colui Che realizza la giustizia. Non c’è dio all’infuori di Lui, l’Eccelso, il Saggio». (Corano, sura III, versetto 18).
«Egli Allah è Unico, Allah è l’Assoluto. Non ha generato, non è stato generato e nessuno è eguale a Lui» (Corano, sura CXII, versetti 1-4).
«E i miscredenti che muoiono nella miscredenza, saranno maledetti da Allah, dagli angeli e da tutti gli uomini. Rimarranno in questo stato in eterno e il castigo non sarà loro alleviato, né avranno attenuanti. Il vostro Dio è il Dio Unico, non c’è altro dio che Lui, il Compassionevole, il Misericordioso» (Corano, sura II, versetti 161-163).
Dante e l’Islam. È ormai assodata l’influenza di molte fonti musulmane sull’autore della Divina Commedia. Ma oggi, turbati dalla violenza fondamentalista, tendiamo a dimenticare i rapporti profondi tra la cultura araba e quella occidentale, scrive Umberto Eco su “L’Espresso”. Nel 1919 Miguel Asín Palacios pubblicava un libro (“La escatologia musulmana en la Divina Comedia”) che aveva fatto subito molto rumore. In centinaia di pagine identificava analogie impressionanti tra il testo dantesco e vari testi della tradizione islamica, in particolare le varie versioni del viaggio notturno di Maometto all’inferno e al paradiso. Specie in Italia ne era nata una polemica tra sostenitori di quella ricerca e difensori dell’originalità di Dante. Si stava per celebrare il sesto centenario della morte del più “italiano” dei poeti, e inoltre il mondo islamico era guardato piuttosto dall’alto al basso in un clima di ambizioni coloniali e “civilizzatrici”: come si poteva pensare che il genio italico fosse debitore delle tradizioni di “extracomunitari” straccioni? Ricordo che alla fine degli anni Ottanta avevamo organizzato a Bologna una serie di seminari sugli interpreti “deliranti” di Dante, e quando ne era uscito un libro (“L’idea deforme”, a cura di Maria Pia Pozzato) i vari saggi si occupavano di Gabriele Rossetti, Aroux, Valli, Guénon e persino del buon Pascoli, tutti accomunati come interpreti eccessivi, o paranoici, o stravaganti del divino poeta. E si era discusso se porre nella schiera di questi eccentrici anche Asín Palacios. Ma si era deciso di non farlo perché ormai tante ricerche successive avevano stabilito che Asín Palacios forse era stato talora eccessivo ma non delirante. Ormai è assodato che Dante abbia subito l’influenza di molte fonti musulmane. Il problema non è se lui le avesse avvicinate direttamente ma come sarebbero potute pervenirgli. Si potrebbe cominciare dalle molte visioni medievali, dove si raccontava di visite ai regni dell’oltretomba. Sono la “Vita di san Maccario romano”, il “Viaggio di tre santi monaci al paradiso terrestre”, la “Visione di Tugdalo”, sino alla leggenda del pozzo di san Patrizio. Fonti occidentali, certo, ma ecco che Asín Palacios le paragonava a tradizioni islamiche, mostrando che anche in quei casi i visionari occidentali avevano appreso qualcosa dai visionari dell’altra sponda del Mediterraneo. E dire che Asín Palacios non conosceva ancora quel “Libro della Scala”, ritrovato negli anni Quaranta del secolo scorso, tradotto dall’arabo in castigliano e poi in latino e antico francese. Poteva conoscere Dante questa storia del viaggio nell’oltretomba del Profeta? Poteva averne avuto notizia attraverso Brunetto Latini, suo maestro, e la versione latina del testo era contenuta in una “Collectio toledana”, dove Pietro il Venerabile, abate di Cluny, aveva fatto raccogliere testi arabi filosofici e scientifici - tutto questo prima della nascita di Dante. E Maria Corti si era molto battuta per riconoscer la presenza di queste fonti musulmane nell’opera dantesca. Chi oggi voglia leggere qualcosa su almeno un resoconto della avventura oltremondana del Profeta trova da Einaudi “Il viaggio notturno e l’ascensione del profeta”, con una prefazione di Cesare Segre. Il riconoscere queste influenze non toglie nulla alla grandezza di Dante, con buona pace degli antichi oppositori di Asín Palacios. Tanti autori grandissimi hanno porto orecchio a tradizioni letterarie precedenti (si pensi, tanto per fare un esempio all’Ariosto) e tuttavia hanno poi concepito un’opera assolutamente originale. Ho rievocato queste polemiche e queste scoperte perché ora l’editrice Luini ripubblica il libro di Asín Palacios, con il titolo più accattivante di “Dante e l’Islam”, e riprende la bella introduzione che Carlo Ossola ne aveva scritto per la traduzione del 1993. Ha ancora senso leggere questo libro, dopo che tante ricerche successive gli hanno in gran parte dato ragione? Lo ha, perché è scritto piacevolmente e presenta una mole immensa di raffronti tra Dante e i suoi “precursori” arabi. E lo ha ai giorni nostri quando, turbati dalle barbare follie del fondamentalismi musulmani, si tende a dimenticare i rapporti che ci sono sempre stati tra la cultura occidentale e la ricchissima e progredita cultura islamica dei secoli passati.
Maometto prima di Dante all'inferno. Un viaggio miracoloso che precede e forse ispira la «Commedia». Ma è solo apologetico, scrive Segre Cesare su “Il Corriere della Sera”. Nei suoi ultimi dieci anni Maria Corti era tutta presa dal problema dei contatti arabo-cristiani nella letteratura medievale. Punti di riferimento, sostanzialmente due: il tema del viaggio di Ulisse oltre le colonne d'Ercole, forse derivato da tradizioni arabe, e gli eventuali contatti fra la Commedia e un testo musulmano, il Libro della Scala, che narrava il miracoloso viaggio notturno di Maometto dalla Mecca a Gerusalemme e la sua successiva visita nei regni oltramondani. Per i due protagonisti, Ulisse e Dante, l'obiettivo è il mondo dei morti: sfiorato da Ulisse, attraversato da Dante. Le ricerche della Corti diedero spunto ad articoli e conversazioni, dibattiti, interviste. Ci si potrebbe stupire di tanto interesse per problemi che non trovarono del tutto le soluzioni desiderate, ma davvero stimolante per il lettore era già la possibilità di immergersi in problematiche di ricerca sempre più raffinate, che, indipendentemente dalle auspicate conclusioni, attraversavano punti nodali della cultura del Medioevo.Si sa che fra cultura musulmana e cultura occidentale esisteva una notevole interrelazione, che l'intensa attività traduttoria rese ancora più stretta. Si traduceva, naturalmente, dall'arabo al latino e alle lingue romanze, e non viceversa. Tra le opere tradotte, c'è il cosiddetto Libro della Scala: l'originale arabo è perduto, così come la sua prima versione spagnola, opera di un medico ebreo legato al re di Castiglia Alfonso el Sabio, ma rimangono due traduzioni, una latina e una francese, derivate dalla versione spagnola e da ascrivere (sicuramente la prima, forse la seconda) a un notaio toscano, Bonaventura da Siena, esule, dopo il 1260, presso Alfonso.Il Libro della Scala è forse la traduzione dall'arabo che ha suscitato più interesse, ma non tanto nel mondo medievale, quanto semmai presso i lettori moderni, e per una ragione molto semplice: le sue vere o apparenti rassomiglianze con la Commedia. Che Dante abbia conosciuto e imitato il popolare libro arabo?La prima curiosità per l'opera si era manifestata dopo l'edizione del testo latino pubblicata da Enrico Cerulli (1949): nella postfazione, Cerulli insisteva sul problema dei rapporti tra Libro e Commedia, riferendosi ai concetti di plagio e di imitazione (due concetti, sia detto per inciso, che ora noi trattiamo diversamente, parlando piuttosto di intertestualità e interdiscorsività). Poi tutto si calmò, almeno fino agli studi della Corti. Ora, una nuova edizione del Libro ci consente di riprendere il discorso, alla luce anche di nuove scoperte e prospettive. Il problema non è più analizzare le affinità, ma distinguere tra ciò che accomuna le due opere perché elemento diffuso nella cultura del tempo, e ciò che è stato trasposto di proposito dall'una all'altra narrazione. Si tenga conto che nel Medioevo lo scambio d'invenzioni e d'immagini era frequentissimo, anche tra gli apologeti delle tre fedi monoteistiche.La nuova edizione che ci propone Anna Longoni, allieva della Corti (Il libro della Scala di Maometto, Bur, pp. 368, ? 13), ha come pregio maggiore quello di offrirci un'edizione filologica della versione (o riscrittura) latina, testimoniata da due manoscritti, uno vaticano, dell'inizio del XIV secolo, e l'altro conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi, affiancata da una precisa traduzione in italiano moderno. Ma non vanno trascurati né l'Introduzione, molto informata, né, in appendice, la ristampa del principale articolo della Corti su Dante e la cultura islamica.In partenza, direi che gli elementi congiuntivi tra Libro e Commedia sono soprattutto la strutturazione dei regni ultraterreni e la descrizione delle pene dei dannati, mentre quello disgiuntivo è lo spirito completamente diverso che anima le due opere. La Commedia ha finalità didattiche, filosofiche e narrative, in fondo anche autocelebrative; il Libro della Scala è l'esaltazione di Allah e della sua potenza, e la consacrazione di Maometto come profeta. In più, la Commedia è primariamente un'opera d'arte, mentre il Libro della Scala è opera eminentemente apologetica. Ma ciò che allontana la Scala dalla Commedia è la diversissima tradizione che caratterizza le due opere. Perché i temi del «viaggio notturno» e dell'«ascensione al cielo» di Maometto, di cui il Libro della Scala presenta una redazione particolare, sono maturati attraverso il tempo: concepiti già all'epoca di Maometto (VII secolo), sono stati rielaborati precocemente (dice la tradizione) da Ibn'Abbas, cugino del Profeta, riscritti nel IX secolo. E continuano tuttora a circolare, anche a livello popolare (in proposito, si può leggere l'edizione del Viaggio di Ibn'Abbas a cura di Ida Zilio-Grandi, Einaudi 2010). Della Commedia viceversa sappiamo tutto, o quasi, dato che ci è noto chi l'ha scritta e quando. Nel tessuto dello stesso Libro è evidente la bipartizione tra il «viaggio notturno» di Maometto per andare dalla Mecca a Gerusalemme su una specie di ippogrifo, e il «Libro della scala», in senso stretto, che prevede l'ascensione di Maometto, attraverso la scala di Giacobbe, dall'inferno al paradiso, sino all'incontro con Allah. A un certo punto le due parti sono state cucite assieme: si tenga conto che si tratta di un'opera a tradizione orale, dunque aperta a qualunque contaminazione, anche se va riconosciuto che il contenuto rimane in fondo unitario. Ma Dante come avrebbe potuto conoscere il Libro della Scala? S'era inventata una favola ingegnosa, senza prove: Brunetto Latini, ambasciatore dei guelfi fiorentini alla corte di Alfonso el Sabio, una volta tornato a Firenze, avrebbe potuto riassumere al suo discepolo Dante il Libro, o qualche sua parte. Ma oggi gli studi sull'islamismo medievale sono molto più approfonditi, e sappiamo persino di vere scuole di arabo, in Inghilterra, a Hereford, o nel Convento di Miramar a Maiorca, oltre naturalmente alla scuola di Toledo. Il prodotto più consistente di questi circoli di studiosi è la Collectio Toletana, un'antologia di testi arabi, tra cui il Corano, tradotti in latino, e ampiamente diffusi nell'Europa medievale. Anche la convinzione che in Italia il Libro fosse sconosciuto, già smentita dai versi di Fazio degli Uberti, che nel Dittamondo (1336) cita un «Libro che Scala ha nome» e riassume in qualche verso i costumi musulmani, è ora solennemente confutata (2011) da Luciano Gargan, che ha trovato il Libro citato in un catalogo bolognese del 1312, che elenca i libri di un frate domenicano, Ugolino.Ma insomma Dante ha conosciuto o no il Libro della Scala? Tutti i critici, anche la Corti e la Longoni, hanno cercato, con equilibrio, le prove più consistenti. Certo, Dante, come tutti i grandi, è capace di trovare spunti e suggerimenti ovunque, e può aver raccattato qualcosa anche da lì. Però bisogna rendersi conto delle sue prospettive e delle sue presupposizioni culturali. Cosa poteva trovare in un libro nettamente popolare, dove il gusto dell'iperbole («misura in lunghezza quanto potrebbe percorrere un uomo in cinquecento anni»; «ognuno di questi serpenti ha in bocca diciottomila denti, ciascuno dei quali è grande tanto quanto una di quelle piante chiamate palme») si mescola con quello dei colori, sicché Maometto avanza tra quinte di veli colorati? C'è qualche scena grandiosa, ma l'unico sentimento che suscita è lo stupore. Noi siamo vittime del gusto moderno per il primitivo, e abbiamo tutto il diritto di accostare il Libro della Scala alla Commedia. Ma quanto a metterli sullo stesso piano, a qualcuno è lecito essere riluttante.
«Dante antisemita e islamofobo. La Divina Commedia va tolta dai programmi scolastici». L'accusa di Gherush92 organizzazione di ricercatori consulente dell'Onu, scrive “Il Corriere della Sera”. in alternativa alcune parti del capolavoro andrebbero espunte dal testo. La Divina Commedia deve essere tolta dai programmi scolastici: troppi contenuti antisemiti, islamofobici, razzisti ed omofobici. La sorprendente richiesta arriva da «Gherush92», organizzazione di ricercatori e professionisti che gode dello status di consulente speciale con il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite e che svolge progetti di educazione allo sviluppo, diritti umani, risoluzione dei conflitti.
ANTISEMITISMO - «La Divina Commedia - spiega all'Adnkronos Valentina Sereni, presidente di Gherush92 - pilastro della letteratura italiana e pietra miliare della formazione degli studenti italiani presenta contenuti offensivi e discriminatori sia nel lessico che nella sostanza e viene proposta senza che via sia alcun filtro o che vengano fornite considerazioni critiche rispetto all'antisemitismo e al razzismo». Sotto la lente di ingrandimento in particolare i canti XXXIV, XXIII, XXVIII, XIV. Il canto XXXIV, spiega l'organizzazione, è una tappa obbligata di studio. Il personaggio e il termine Giuda e giudeo sono parte integrante della cultura cristiana: «Giuda per antonomasia è persona falsa, traditore (da Giuda, nome dell'apostolo che tradì Gesù)»; «giudeo è termine comune dispregiativo secondo un antico pregiudizio antisemita che indica chi è avido di denaro, usuraio, persona infida, traditore» (così scrive De Mauro, Il dizionario della lingua italiana). Il significato negativo di giudeo è poi esteso a tutto il popolo ebraico. Il Giuda dantesco è la rappresentazione del Giuda dei Vangeli, fonte dell'antisemitismo. «Studiando la Divina Commedia - sostiene Gherush92 - i giovani sono costretti, senza filtri e spiegazioni, ad apprezzare un'opera che calunnia il popolo ebraico, imparano a convalidarne il messaggio di condanna antisemita, reiterato ancora oggi nelle messe, nelle omelie, nei sermoni e nelle prediche e costato al popolo ebraico dolori e lutti». E ancora, prosegue l'organizzazione, «nel canto XXIII Dante punisce il Sinedrio che, secondo i cristiani, complottò contro Gesù; i cospiratori, Caifas sommo sacerdote, Anna e i Farisei, subiscono tutti la stessa pena, diversa però da quella del resto degli ipocriti: per contrappasso Caifas è nudo e crocefisso a terra, in modo che ogni altro dannato fra gli ipocriti lo calpesti».
MAOMETTO - Ma attenzione. Il capolavoro di Dante conterrebbe anche accenti islamofobici. «Nel canto XXVIII dell'Inferno - spiega ancora Sereni - Dante descrive le orrende pene che soffrono i seminatori di discordie, cioè coloro che in vita hanno operato lacerazioni politiche, religiose e familiari. Maometto è rappresentato come uno scismatico e l'Islam come una eresia. Al Profeta è riservata una pena atroce: il suo corpo è spaccato dal mento al deretano in modo che le budella gli pendono dalle gambe, immagine che insulta la cultura islamica. Alì, successore di Maometto, invece, ha la testa spaccata dal mento ai capelli. L'offesa - aggiunge - è resa più evidente perchè il corpo "rotto" e "storpiato" di Maometto è paragonato ad una botte rotta, oggetto che contiene il vino, interdetto dalla tradizione islamica. Nella descrizione di Maometto vengono impiegati termini volgari e immagini raccapriccianti tanto che nella traduzione in arabo della Commedia del filologo Hassan Osman sono stati omessi i versi considerati un'offesa».
OMOSESSUALI - Anche gli omosessuali, nel linguaggio dantesco i sodomiti, sarebbero messi all'indice nel poema dell'Alighieri. Coloro che ebbero rapporti «contro natura», sono infatti puniti nell'Inferno: i sodomiti, i peccatori più numerosi del girone, sono descritti mentre corrono sotto una pioggia di fuoco, condannati a non fermarsi. Nel Purgatorio i sodomiti riappaiono, nel canto XXVI, insieme ai lussuriosi eterosessuali. «Non invochiamo nè censure nè roghi - precisa Sereni - ma vorremmo che si riconoscesse, in maniera chiara e senza ambiguità che nella Commedia vi sono contenuti razzisti, islamofobici e antisemiti. L'arte non può essere al di sopra di qualsiasi giudizio critico. L'arte è fatta di forma e di contenuto e anche ammettendo che nella Commedia esistano diversi livelli di interpretazione, simbolico, metaforico, iconografico, estetico, ciò non autorizza a rimuovere il significato testuale dell'opera, il cui contenuto denigratorio è evidente e contribuisce, oggi come ieri, a diffondere false accuse costate nei secoli milioni e milioni di morti. Persecuzioni, discriminazioni, espulsioni, roghi hanno subito da parte dei cristiani ebrei, omosessuali, mori, popoli infedeli, eretici e pagani, gli stessi che Dante colloca nei gironi dell'inferno e del purgatorio. Questo è razzismo che letture simboliche, metaforiche ed estetiche dell'opera, evidentemente, non rimuovono».
CRIMINI - «Oggi - conclude Sereni - il razzismo è considerato un crimine ed esistono leggi e convenzioni internazionali che tutelano la diversità culturale e preservano dalla discriminazione, dall'odio o dalla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e a queste bisogna riferirsi; quindi questi contenuti, se insegnati nelle scuole o declamati in pubblico, contravvengono a queste leggi, soprattutto se in presenza di una delle categorie discriminate. È nostro dovere segnalare alle autoritá competenti, anche giudiziarie, che la Commedia presenta contenuti offensivi e razzisti che vanno approfonditi e conosciuti. Chiediamo, quindi, di espungere la Divina Commedia dai programmi scolastici ministeriali o, almeno, di inserire i necessari commenti e chiarimenti». Certo c'è da chiederci cosa succederebbe se il criterio proposto da «Gherush92» venisse applicato ai grandi autori della letteratura. In Gran Bretagna vedremmo censurato «Il mercante di Venezia» di Shakespeare? O alcuni dei racconti di Chaucer? Certo è che il tema del politicamente corretto finisce sempre più per invadere sfere distanti dalla politica vera e propria. Così il Corriere in un articolo del 1996 racconta come, al momento di scegliere personaggi celebri per adornare le future banconote dell'euro, Shakespeare fu scartato perchè potenzialmente antisemita Mozart perché massone, Leonardo Da Vinci perché omosessuale. Alla fine si decise per mettere sulle banconote immagini di ponti almeno loro non accusabili di nulla.
Dante "razzista", follia Onu: bandire Divina Commedia. L'associazione Gherush92, consulente delle Nazioni Unite: "Offende ebrei, musulmani, gay. Non va studiata a scuola", scrive di Caterina Maniaci su “Libero Quotidiano”. L’hanno recitata a migliaia, ovunque nel mondo; l’hanno citata, letta, studiata, commentata in milioni di volumi e per intere generazioni. È persino diventata una sorta di fenomeno sociale, dopo che Vittorio Sermonti prima e Roberto Benigni poi l’hanno declamata a un pubblico sempre più numeroso, fino ad approdare in tv. Ma nessuno, fino a oggi, si era mai immaginato di poter parlare della Divina Commedia in questi termini: ossia come un’opera piena di luoghi comuni, frasi offensive, razziste, islamofobiche e antisemite che difficilmente possono essere comprese e che raramente vengono evidenziate e spiegate nel modo corretto. Definisce così il contenuto di numerose terzine dantesche “Gherush92”, organizzazione di ricercatori e professionisti che gode dello status di consulente speciale per il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite e che svolge progetti di educazione allo sviluppo, diritti umani, risoluzione dei conflitti, razzismo, antisemitismo, islamofobia. E proprio secondo questa organizzazione il poema di Dante andrebbe eliminato dai programmi scolastici o, quanto meno, letto con le dovute accortezze. Sotto la lente censoria sono finiti, in particolare, i canti dell’Inferno XIV, XXIII, XXVIII e XXXIV. Il canto XXXIV, spiega l’organizzazione, è una tappa obbligata di studio. Il personaggio e il termine Giuda e giudeo sono parte integrante della cultura cristiana: «Giuda per antonomasia è persona falsa, traditore (da Giuda, nome dell’apostolo che tradì Gesù)»; «giudeo è termine comune dispregiativo secondo un antico pregiudizio antisemita che indica chi è avido di denaro, usuraio, persona infida, traditore». Il significato negativo di giudeo è esteso a tutto il popolo ebraico. Il Giuda dantesco è la rappresentazione del Giuda dei Vangeli, fonte dell’antisemitismo. E ancora, prosegue l’organizzazione, «nel canto XXIII Dante punisce il Sinedrio che, secondo i cristiani, complottò contro Gesù; i cospiratori, Caifas sommo sacerdote, Anna e i Farisei, subiscono tutti la stessa pena, diversa però da quella del resto degli ipocriti: per contrappasso Caifas è nudo e crocefisso a terra, in modo che ogni altro dannato fra gli ipocriti lo calpesti». Il poema, spiega Valentina Sereni, presidente di Gherush92, «pilastro della letteratura italiana e pietra miliare della formazione degli studenti italiani, presenta contenuti offensivi e discriminatori sia nel lessico che nella sostanza e viene proposto senza che via sia alcun filtro o che vengano fornite considerazioni critiche rispetto all’antisemitismo e al razzismo». Spiega ancora Sereni: «Nel canto XXVIII dell’Inferno Dante descrive le orrende pene che soffrono i seminatori di discordie, cioè coloro che in vita hanno operato lacerazioni politiche, religiose e familiari. Maometto è rappresentato come uno scismatico e l’Islam come un’eresia. Al Profeta è riservata una pena atroce: il suo corpo è spaccato dal mento al deretano, in modo che le budella gli pendono dalle gambe, immagine che insulta la cultura islamica. Alì, successore di Maometto, invece, ha la testa spaccata dal mento ai capelli». «L’offesa», aggiunge, «è resa più evidente perché il corpo “rotto” e “storpiato” di Maometto è paragonato ad una botte rotta, oggetto che contiene il vino, interdetto dalla tradizione islamica. Nella descrizione di Maometto vengono impiegati termini volgari e immagini raccapriccianti tanto che nella traduzione in arabo della Commedia del filologo Hassan Osman sono stati omessi i versi considerati un’offesa». La stessa Sereni, da noi ricontattata, ci spiega che lo studio sulla Divina Commedia è stato eseguito dai ricercatori di Gherush92 «dopo alcuni mesi di riflessione». Il gruppo «si finanzia con le quote dei soci iscritti». Alla domanda se esistono nuovi studi su altre opere letterarie, risponde: «Ci stiamo lavorando e più avanti saranno diffusi». Nessun timore che, utilizzando simili criteri di analisi, tutta la letteratura italiana delle origini possa essere considerata razzista, omofoba e antisemita? «Non è colpa nostra se ci sono opere d’arte italiane eventualmente razziste», ribadisce la Sereni, perché «è l’insegnamento della Divina Commedia che deve essere contestualizzato e siccome viene insegnata e proclamata oggi, il contesto è oggi. Oggi possiamo e dobbiamo fare queste osservazioni sul razzismo nella Divina Commedia e in altre opere d’arte. D’altra parte il razzismo contro le stesse entità esisteva tanto allora quanto oggi». Tutto chiaro e preciso. Ma pur essendo Gherush92 consulente dell’Onu, status di tutto rispetto e cosa che non è concessa proprio a tutte le organizzazioni, la sede a Roma, segnalata nel sito dell’United Nations Department of Economic and Social Affairs, è inesistente: a quell’indirizzo non risulta nessuna organizzazione. Lo abbiamo scoperto personalmente. Una zona di quasi campagna, nella periferia nord della Capitale, tra villette e piccoli capannoni aziendali. Il numero civico non corrisponde, anzi non esiste. Chiediamo in giro. «Associazione Gherush92? Mai sentita, qui non c’è», risponde una ragazza che esce da un cancello. In effetti, ci viene confermato dalla stessa associazione che quell’indirizzo non è valido e non ce n’è un altro cui fare riferimento...
Il nemico che trattiamo da amico. (Questo articolo fu pubblicato sul Corriere della Sera il 16 luglio 2005). All’indomani dell’attentato terroristico di matrice islamica che ha insanguinato la redazione parigina del settimanale satirico Charlie Hebdo, si inseriscono nel dibattito pubblico di queste ore, le riflessioni di Oriana Fallaci sul rapporto tra Islam e Occidente. L’articolo fu scritto dopo la strage alla metropolitana di Londra del 7 luglio 2005 da Oriana Fallaci.
Ora mi chiedono: «Che cosa dice, che cosa ha da dire, su quello che è successo a Londra?». Me lo chiedono a voce, per fax, per email, spesso rimproverandomi perché finoggi sono rimasta zitta. Quasi che il mio silenzio fosse stato un tradimento. E ogni volta scuoto la testa, mormoro a me stessa: cos' altro devo dire?!? Sono quattr'anni che dico. Che mi scaglio contro il Mostro deciso ad eliminarci fisicamente e insieme ai nostri corpi distruggere i nostri principii e i nostri valori. La nostra civiltà. Sono quattr' anni che parlo di nazismo islamico, di guerra all' Occidente, di culto della morte, di suicidio dell' Europa. Un' Europa che non è più Europa ma Eurabia e che con la sua mollezza, la sua inerzia, la sua cecità, il suo asservimento al nemico si sta scavando la propria tomba. Sono quattr' anni che come una Cassandra mi sgolo a gridare «Troia brucia, Troia brucia» e mi dispero sui Danai che come nell' Eneide di Virgilio dilagano per la città sepolta nel torpore. Che attraverso le porte spalancate accolgono le nuove truppe e si uniscono ai complici drappelli. Quattr' anni che ripeto al vento la verità sul Mostro e sui complici del Mostro cioè sui collaborazionisti che in buona o cattiva fede gli spalancano le porte. Che come nell' Apocalisse dell' evangelista Giovanni si gettano ai suoi piedi e si lasciano imprimere il marchio della vergogna.
Incominciai con «La Rabbia e l'Orgoglio». Continuai con «La Forza della Ragione». Proseguii con «Oriana Fallaci intervista sé stessa» e con «L' Apocalisse». E tra l'uno e l'altro la predica «Sveglia, Occidente, sveglia». I libri, le idee, per cui in Francia mi processarono nel 2002 con l'accusa di razzismo-religioso e xenofobia. Per cui in Svizzera chiesero al nostro ministro della Giustizia la mia estradizione in manette. Per cui in Italia verrò processata con l'accusa di vilipendio all'Islam cioè reato di opinione. (Reato che prevede tre anni di galera, quanti non ne riceve l'islamico sorpreso con l'esplosivo in cantina). Libri, idee, per cui la Sinistra al Caviale e la Destra al Fois Gras ed anche il Centro al Prosciutto mi hanno denigrata vilipesa messa alla gogna insieme a coloro che la pensano come me. Cioè insieme al popolo savio e indifeso che nei loro salotti viene definito dai radical-chic «plebaglia di destra». Sì, è vero: sui giornali che nel migliore dei casi mi opponevano farisaicamente la congiura del silenzio ora appaiono titoli composti coi miei concetti e le mie parole. Guerra all'Occidente, Culto della Morte, Suicidio dell'Europa, Sveglia Italia Sveglia. Sì, è vero: sia pur senza ammettere che non avevo torto l'ex segretario della Quercia ora concede interviste nelle quali dichiara che questi terroristi vogliono distruggere i nostri valori, che questo stragismo è di tipo fascista ed esprime odio per la nostra civiltà».
Sì, è vero: parlando di Londonistan, il quartiere dove vivono i ben settecentomila musulmani di Londra, i giornali che prima sostenevano i terroristi fino all'apologia di reato ora dicono ciò che dicevo io quando scrivevo che in ciascuna delle nostre città esiste un'altra città. Una città sotterranea, uguale alla Beirut invasa da Arafat negli anni Settanta. Una città straniera che parla la propria lingua e osserva i propri costumi, una città musulmana dove i terroristi circolano indisturbati e indisturbati organizzano la nostra morte. Del resto ora si parla apertamente anche di terrorismo-islamico, cosa che prima veniva evitata con cura onde non offendere i cosiddetti musulmani moderati. Sì, è vero: ora anche i collaborazionisti e gli imam esprimono le loro ipocrite condanne, le loro mendaci esecrazioni, la loro falsa solidarietà coi parenti delle vittime. Si, è vero: ora si fanno severe perquisizioni nelle case dei musulmani indagati, si arrestano i sospettati, magari ci si decide ad espellerli. Ma in sostanza non è cambiato nulla. Nulla. Dall'antiamericanismo all'antioccidentalismo al filoislamismo, tutto continua come prima. Persino in Inghilterra. Sabato 9 luglio cioè due giorni dopo la strage la BBC ha deciso di non usare più il termine «terroristi», termine che esaspera i toni della Crociata, ed ha scelto il vocabolo «bombers». Bombardieri, bombaroli. Lunedì 11 luglio cioé quattro giorni dopo la strage il Times ha pubblicato nella pagina dei commenti la vignetta più disonesta ed ingiusta ch'io abbia mai visto. Quella dove accanto a un kamikaze con la bomba si vede un generale anglo-americano con un' identica bomba. Identica nella forma e nella misura. Sulla bomba, la scritta: «Killer indiscriminato e diretto ai centri urbani». Sulla vignetta, il titolo: «Spot the difference, cerca la differenza».
Quasi contemporaneamente, alla televisione americana ho visto una giornalista del Guardian, il quotidiano dell' estrema sinistra inglese, che assolveva l'apologia di reato manifestata anche stavolta dai giornali musulmani di Londra. E che in pratica attribuiva la colpa di tutto a Bush. Il criminale, il più grande criminale della Storia, George W. Bush. «Bisogna capirli». Cinguettava «la politica americana li ha esasperati. Se non ci fosse stata la guerra in Iraq...». (Giovanotta, l'11 settembre la guerra in Iraq non c'era. L'11 settembre la guerra ce l'hanno dichiarata loro. Se n'è dimenticata?). E contemporaneamente ho letto su Repubblica un articolo dove si sosteneva che l'attacco alla subway di Londra non è stato un attacco all'Occidente. E' stato un attacco che i figli di Allah hanno fatto contro i propri fantasmi. Contro l'Islam «lussurioso» (suppongo che voglia dire «occidentalizzato») e il cristianesimo «secolarizzato». Contro i pacifisti indù e la magnifica varietà che Allah ha creato. Infatti, spiegava, in Inghilterra i musulmani sono due milioni e nella metropolitana di Londra non trovi un inglese nemmeno a pagarlo oro. Tutti in turbante, tutti in kefiah. Tutti con la barba lunga e il djellabah. Se ci trovi una bionda con gli occhi azzurri è una circassa». (Davvero?!? Chi l' avrebbe mai detto!!! Nelle fotografie dei feriti non scorgo né turbanti né kefiah, né barbe lunghe né djellabah. E nemmeno burka e chador. Vedo soltanto inglesi come gli inglesi che nella Seconda Guerra Mondiale morivano sotto i bombardamenti nazisti. E leggendo i nomi dei dispersi vedo tutti Phil Russell, Adrian Johnson, Miriam Hyman, più qualche tedesco o italiano o giapponese. Di nomi arabi, finoggi, ho visto soltanto quello di una giovane donna che si chiamava Shahara Akter Islam).
Continua anche la fandonia dell'Islam «moderato», la commedia della tolleranza, la bugia dell'integrazione, la farsa del pluriculturalismo. Vale a dire delle moschee che esigono e che noi gli costruiamo. Nel corso d' un dibattito sul terrorismo, al consiglio comunale di Firenze lunedì 11 luglio il capogruppo diessino ha dichiarato: «E' ora che anche a Firenze ci sia una moschea». Poi ha detto che la comunità islamica ha esternato da tempo la volontà di costruire una moschea e un centro culturale islamico simili alla moschea e al centro culturale islamico che sorgeranno nella diessina Colle val d'Elsa. Provincia della diessina Siena e del suo filo-diessino Monte dei Paschi, già la banca del Pci e ora dei Ds. Bé, quasi nessuno si è opposto. Il capogruppo della Margherita si è detto addirittura favorevole. Quasi tutti hanno applaudito la proposta di contribuire all' impresa coi soldi del municipio cioé dei cittadini, e l'assessore all'urbanistica ha aggiunto che da un punto di vista urbanistico non ci sono problemi. «Niente di più facile». Episodio dal quale deduci che la città di Dante e Michelangelo e Leonardo, la culla dell' arte e della cultura rinascimentale, sarà presto deturpata e ridicolizzata dalla sua Mecca. Peggio ancora: continua la Political Correctness dei magistrati sempre pronti a mandare in galera me e intanto ad assolvere i figli di Allah. A vietarne l' espulsione, ad annullarne le (rare) condanne pesanti, nonché a tormentare i carabinieri o i poliziotti che con loro gran dispiacere li arrestano. Milano, pomeriggio dell' 8 luglio cioé il giorno dopo la strage di Londra. Il quarantaduenne Mohammed Siliman Sabri Saadi, egiziano e clandestino, viene colto senza biglietto sull' autobus della linea 54. Per effettuare la multa i due controllori lo fanno scendere e scendono con lui. Gli chiedono un documento, lui reagisce ingaggiando una colluttazione. Ne ferisce uno che finirà all'ospedale, scappa perdendo il passaporto, ma la Volante lo ritrova e lo blocca. Nonostante le sue resistenze, dinanzi a una piccola folla lo ammanetta e nello stesso momento ecco passare una signora che tutta stizzita vuole essere ascoltata come testimone se il poverino verrà processato ed accusato di resistenza. I poliziotti le rispondono signora ci lasci lavorare, e allora lei allunga una carta di identità dalla quale risulta che è un magistrato. Sicché un po' imbarazzati ne prendono atto poi portano Mohammed in questura e qui... Bé, invece di portarlo al centro di permanenza temporanea dove (anziché in galera) si mettono i clandestini, lo lasciano andare invitandolo a presentarsi la prossima settimana al processo cui dovrà sottoporsi per resistenza all' arresto e lesioni a pubblico ufficiale. Lui se ne va, scompare (lo vedremo mai più?) e indovina chi è la signora tutta stizzita perché lo avevano ammanettato come vuole la prassi.
La magistrata che sette mesi fa ebbe il suo piccolo momento di celebrità per aver assolto con formula piena tre musulmani accusati di terrorismo internazionale e per aver aggiunto che in Iraq non c'è il terrorismo, c'è la guerriglia, che insomma i tagliateste sono Resistenti. Sì, proprio quella che il vivace leghista Borghezio definì «una vergogna per Milano e per la magistratura». E indovina chi anche oggi la loda, la difende, dichiara ha fatto benissimo. I diessini, i comunisti, e i soliti verdi. Continua anche la panzana che l'Islam è una religione di pace, che il Corano predica la misericordia e l'amore e la pietà. Come se Maometto fosse venuto al mondo con un ramoscello d'ulivo in bocca e fosse morto crocifisso insieme a Gesù. Come se non fosse stato anche lui un tagliateste e anziché orde di soldati con le scimitarre ci avesse lasciato san Matteo e san Marco e san Luca e san Giovanni intenti a scrivere gli Evangeli. Continua anche la frottola dell' Islam vittima dell'Occidente. Come se per quattordici secoli i musulmani non avessero mai torto un capello a nessuno e la Spagna e la Sicilia e il Nord Africa e la Grecia e i Balcani e l'Europa orientale su su fino all' Ucraina e alla Russia le avesse occupate la mia bisnonna valdese. Come se ad arrivare fino a Vienna e a metterla sotto assedio fossero state le suore di sant'Ambrogio e le monache Benedettine. Continua anche la frode o l'illusione dell'Islam Moderato. Con questa, il tentativo di farci credere che il nemico è costituito da un' esigua minoranza e che quella esigua minoranza vive in paesi lontani.
Bé, il nemico non è affatto un'esigua minoranza. E ce l'abbiamo in casa. Ce l'avevamo in casa l'11 settembre del 2001 cioé a New York. Ce l'avevamo in casa l'11 marzo del 2004 cioé a Madrid. Ce l' avevamo in casa l'1, il 2, il 3 settembre del medesimo anno a Beslan dove si divertirono anche a fare il tiro a segno sui bambini che dalla scuola fuggivano terrorizzati, e di bambini ne uccisero centocinquanta. Ce l'avevamo in casa il 7 luglio scorso cioé a Londra dove i kamikaze identificati erano nati e cresciuti. Dove avevano studiato finalmente qualcosa, erano vissuti finalmente in un mondo civile, e dove fino alla sera precedente s'eran divertiti con le partite di calcio o di cricket. Ce l'abbiamo in casa da oltre trent'anni, perdio. Ed è un nemico che a colpo d'occhio non sembra un nemico. Senza la barba, vestito all'occidentale, e secondo i suoi complici in buona o in malafede perfettamente inserito nel nostro sistema sociale. Cioé col permesso di soggiorno. Con l'automobile. Con la famiglia. E pazienza se la famiglia è spesso composta da due o tre mogli, pazienza se la moglie o le mogli le fracassa di botte, pazienza se non di rado uccide la figlia in blue jeans, pazienza se ogni tanto suo figlio stupra la quindicenne bolognese che col fidanzato passeggia nel parco. E' un nemico che trattiamo da amico. Che tuttavia ci odia e ci disprezza con intensità. Tale intensità che verrebbe spontaneo gridargli: se siamo così brutti, così cattivi, così peccaminosi, perché non te ne torni a casa tua? Perché stai qui? Per tagliarci la gola o farci saltare in aria? Un nemico, inoltre, che in nome dell' umanitarismo e dell' asilo politico (ma quale asilo politico, quali motivi politici?) accogliamo a migliaia per volta anche se i Centri di Accoglienza straripano, scoppiano, e non si sa più dove metterlo. Un nemico che in nome della «necessità» (ma quale necessità, la necessità di riempire le strade coi venditori ambulanti e gli spacciatori di droga?) invitiamo anche attraverso l'Olimpo Costituzionale. «Venite, cari, venite. Abbiamo tanto bisogno di voi». Un nemico che per partorire non ha bisogno della procreazione assistita, delle cellule staminali. Il suo tasso di natalità è così alto che secondo il National Intelligence Council alla fine di quest'anno la popolazione musulmana in Eurabia risulterà raddoppiata. Un nemico che le moschee le trasforma in caserme, in campi di addestramento, in centri di reclutamento per i terroristi, e che obbedisce ciecamente all' imam (però guai se arresti l'imam.
Peggio ancora, se qualche agente della Cia te lo toglie dai piedi col tacito consenso dei nostri servizi segreti). Un nemico che in virtù della libera circolazione voluta dal trattato di Schengen scorrazza a suo piacimento per l'Eurabia sicché per andare da Londra a Marsiglia, da Colonia a Milano o viceversa, non deve esibire alcun documento. Può essere un terrorista che si sposta per organizzare o materializzare un massacro, può avere addosso tutto l' esplosivo che vuole: nessuno lo ferma, nessuno lo tocca. (Ma quando in seguito alla strage di Londra la Francia denuncia il trattato di Schengen e perfino la Spagna zapatera pensa di imitarla, l'Italia e gli altri paesi europei rispondono scandalizzati no no). Un nemico che appena installato nelle nostre città o nelle nostre campagne si abbandona alle prepotenze ed esige l' alloggio gratuito o semi-gratuito nonché il voto e la cittadinanza. Tutte cose che ottiene senza difficoltà. Un nemico che protetto dalla Sinistra al Caviale e dalla Destra al Fois Gras e dal Centro al Prosciutto ciancia, appunto, di integrazione e pluriculturalismo ma intanto ci impone le proprie regole e i propri costumi. Che bandisce il maiale dalle mense delle scuole, delle fabbriche, delle prigioni. Che aggredisce la maestra o la preside perché una scolara bene educata ha gentilmente offerto al compagno di classe musulmano la frittella di riso al marsala cioé «col liquore». E attenta a non ripeter l'oltraggio. Un nemico che negli asili vuole abolire anzi abolisce il Presepe e Babbo Natale. Che il crocifisso lo toglie dalle aule scolastiche, lo getta giù dalle finestre degli ospedali, lo definisce «un cadaverino ignudo e messo lì per spaventare i bambini musulmani». (Parlo, s'intende, dell' arabo con la cittadinanza italiana che mi ha denunciato per vilipendio all'Islam. Che contro di me ha scritto un lercio e sgrammaticato libello dove elencando quattro sure del Corano chiede ai suoi correligionari di eliminarmi, che per le sue malefatte non è mai stato o non ancora processato). Un nemico che in Inghilterra s'imbottisce le scarpe di esplosivo onde far saltare in aria il jumbo del volo Parigi-Miami. (Parlo, s'intende, dell'arabo con la cittadinanza inglese che per puro miracolo beccarono sulla American Airlines).
Un nemico che ad Amsterdam uccide Theo van Gogh colpevole di girare documentari sulla schiavitù delle musulmane e che dopo averlo ucciso gli apre il ventre, ci ficca dentro una lettera con la condanna a morte della sua migliore amica. (Parlo, s'intende, dell'arabo con cittadinanza olandese che probabilmente anzi spero verrà condannato all' ergastolo e che al processo ha sibilato alla mamma di Theo: «Io non provo alcuna pietà per lei. Perché lei è un'infedele»). Il nemico, infine, per il quale trovi sempre un magistrato clemente cioé pronto a scarcerarlo. E che i governi eurobei (ndr: non si tratta d'un errore tipografico, voglio proprio dire eurobei non europei) non espellono neanche se è clandestino. Continua anche il discorso sul Dialogo delle due Civiltà. Ed apriti cielo se chiedi qual è l'altra civiltà, cosa c'è di civile in una civiltà che non conosce neanche il significato della parola libertà. Che per libertà, hurryya, intende «emancipazione dalla schiavitù». Che la parola hurryya la coniò soltanto alla fine dell' Ottocento per poter firmare un trattato commerciale. Che nella democrazia vede Satana e la combatte con gli esplosivi, le teste tagliate. Che dei Diritti dell'Uomo da noi tanto strombazzati e verso i musulmani scrupolosamente applicati non vuole neanche sentirne parlare. Infatti rifiuta di sottoscrivere la Carta dei Diritti Umani compilata dall' Onu e la sostituisce con la Carta dei Diritti Umani compilata dalla Conferenza Araba. Apriti cielo anche se chiedi che cosa c' è di civile in una civiltà che tratta le donne come le tratta.
L' Islam è il Corano, cari miei. Comunque e dovunque. E il Corano è incompatibile con la Libertà, è incompatibile con la Democrazia, è incompatibile con i Diritti Umani. E' incompatibile col concetto di civiltà. E visto che ho toccato questo argomento mi ascolti bene, signor giudice di Bergamo che ha voluto incriminarmi per vilipendio all'Islam ma che non ha mai incriminato il mio persecutore per vilipendio al Cristianesimo. Nonché per istigazione all' omicidio. (Il mio). Mi ascolti e mi condanni pure. Mi infligga pure quei tre anni di reclusione che i magistrati italiani non infliggono nemmeno ai terroristi islamici beccati con l' esplosivo in cantina. Il suo processo è inutile. Finché avrò un filo di fiato io ripeterò ciò che ho scritto nei miei libri e che riscrivo qui. Non mi sono mai fatta intimidire, non mi faccio mai intimidire dalle minacce di morte e dalle persecuzioni, dalle denigrazioni, dagli insulti contro i quali Lei si è guardato bene dal proteggermi anche come semplice cittadino. Quindi si figuri se mi faccio intimidire da Lei che mi nega il costituzionale diritto di pensare ed esprimere la mia opinione. Però, prima del processo, una curiosità me la deve togliere. Nella cella mi ci terrà tutta sola o coi carabinieri che lo Stato Italiano mi ha cortesemente imposto affinché non venga ammazzata come Biagi o come Theo van Gogh? Glielo chiedo perché il ministro degli Interni dice che nelle nostre carceri oltre il cinquanta per cento dei detenuti sono musulmani, e suppongo che di quei carabinieri avrei più bisogno in galera che a casa mia. (Quanto a voi, signori del Parlamento, congratulazioni per aver respinto la proposta del ministro della Giustizia: abolire il reato di opinione. E particolari congratulazioni all' onorevole di Alleanza Nazionale che oltre ad aver gestito quel rifiuto ha chiesto di abolire il reato d' apologia del fascismo). Continua anche l'indulgenza che la Chiesa Cattolica (del resto la maggiore sostenitrice del Dialogo) professa nei riguardi dell' Islam. Continua cioé la sua irremovibile irriducibile volontà di sottolineare il «comune patrimonio spirituale fornitoci dalle tre grandi religioni monoteistiche». Quella cristiana, quella ebraica, quella islamica. Tutte e tre basate sul concetto del Dio Unico, tutte e tre ispirate da Abramo. Il buon Abramo che per ubbidire a Dio stava per sgozzare il suo bambino come un agnello. Ma quale patrimonio in comune?!?
Allah non ha nulla in comune col Dio del Cristianesimo. Col Dio padre, il Dio buono, il Dio affettuoso che predica l' amore e il perdono. Il Dio che negli uomini vede i suoi figli. Allah è un Dio padrone, un Dio tiranno. Un Dio che negli uomini vede i suoi sudditi anzi i suoi schiavi. Un Dio che invece dell' amore insegna l' odio, che attraverso il Corano chiama cani-infedeli coloro che credono in un altro Dio e ordina di punirli. Di soggiogarli, di ammazzarli. Quindi come si fa a mettere sullo stesso piano il cristianesimo e l' islamismo, come si fa a onorare in egual modo Gesù e Maometto?!? Basta davvero la faccenda del Dio Unico per stabilire una concordia di concetti, di principii, di valori?!? E questo è il punto che nell' immutata realtà del dopo-strage di Londra mi turba forse di più. Mi turba anche perché sposa quindi rinforza quello che considero l' errore commesso da papa Wojtyla: non battersi quanto avrebbe a mio avviso dovuto contro l' essenza illiberale e antidemocratica anzi crudele dell' Islam. Io in questi quattr' anni non ho fatto che domandarmi perché un guerriero come Wojtyla, un leader che come lui aveva contribuito più di chiunque al crollo dell' impero sovietico e quindi del comunismo, si mostrasse così debole verso un malanno peggiore dell' impero sovietico e del comunismo. Un malanno che anzitutto mira alla distruzione del cristianesimo. (E dell' ebraismo). Non ho fatto che domandarmi perché egli non tuonasse in maniera aperta contro ciò che avveniva (avviene) ad esempio in Sudan dove il regime fondamentalista esercitava (esercita) la schiavitù. Dove i cristiani venivano eliminati (vengono eliminati) a milioni. Perché tacesse sull'Arabia Saudita dove la gente con una Bibbia in mano o una crocetta al collo era (è) trattata come feccia da giustiziare. Ancora oggi quel silenzio io non l'ho capito e...
Naturalmente capisco che la filosofia della Chiesa Cattolica si basa sull'ecumenismo e sul comandamento Ama il nemico tuo come te stesso. Che uno dei suoi principii fondamentali è almeno teoricamente il perdono, il sacrificio di porgere l' altra guancia. (Sacrificio che rifiuto non solo per orgoglio cioè per il mio modo di intendere la dignità, ma perché lo ritengo un incentivo al Male di chi fa del male). Però esiste anche il principio dell' autodifesa anzi della legittima difesa, e se non sbaglio la Chiesa Cattolica vi ha fatto ricorso più volte. Carlo Martello respinse gli invasori musulmani alzando il crocifisso. Isabella di Castiglia li cacciò dalla Spagna facendo lo stesso. E a Lepanto c'erano anche le truppe pontificie. A difendere Vienna, ultimo baluardo della Cristianità, a romper l' assedio di Kara Mustafa, c'era anche e soprattutto il polacco Giovanni Sobienski con l' immagine della Vergine di Chestochowa. E se quei cattolici non avessero applicato il principio dell' autodifesa, della legittima difesa, oggi anche noi porteremmo il burka o il jalabah. Anche noi chiameremmo i pochi superstiti cani-infedeli. Anche noi gli segheremmo la testa col coltello halal. E la basilica di San Pietro sarebbe una moschea come la chiesa di Santa Sofia a Istanbul. Peggio: in Vaticano ci starebbero Bin Laden e Zarkawi. Così, quando tre giorni dopo la nuova strage Papa Ratzinger ha rilanciato il tema del Dialogo, sono rimasta di sasso. Santità, Le parla una persona che La ammira molto. Che Le vuole bene, che Le dà ragione su un mucchio di cose. Che a causa di questo viene dileggiata coi nomignoli atea-devota, laica-baciapile, liberal-clericale. Una persona, inoltre, che capisce la politica e le sue necessità. Che comprende i drammi della leadership e i suoi compromessi. Che ammira l' intransigenza della fede e rispetta le rinunce o le prodigalità a cui essa costringe. Però il seguente interrogativo devo porlo lo stesso: crede davvero che i musulmani accettino un dialogo coi cristiani, anzi con le altre religioni o con gli atei come me? Crede davvero che possano cambiare, ravvedersi, smettere di seminar bombe? Lei è un uomo tanto erudito, Santità. Tanto colto. E li conosce bene. Assai meglio di me. Mi spieghi dunque: quando mai nel corso della loro storia, una storia che dura da millequattrocento anni, sono cambiati e si sono ravveduti? Oh, neanche noi siamo stati e siamo stinchi di santo: d' accordo. Inquisizioni, defenestrazioni, esecuzioni, guerre, infamie di ogni tipo. Nonché guelfi e ghibellini a non finire. E per giudicarci severamente basta pensare a quel che abbiamo combinato sessanta anni fa con l' Olocausto. Ma poi abbiamo messo un po' di giudizio, perbacco. Ci abbiamo dato una pensata e se non altro in nome della decenza siamo un po' migliorati. Loro, no.
La Chiesa Cattolica ha avuto svolte storiche, Santità. Anche questo lei lo sa meglio di me. A un certo punto si è ricordata che Cristo predicava la Ragione, quindi la scelta, quindi il Bene, quindi la Libertà, e ha smesso di tiranneggiare. D' ammazzare la gente. O costringerla a dipinger soltanto Cristi e Madonne. Ha compreso il laicismo. Grazie a uomini di prim' ordine, un lungo elenco di cui Lei fa parte, ha dato una mano alla democrazia. Ed oggi parla coi tipi come me. Li accetta e lungi dal bruciarli vivi (io non dimentico mai che fino a quattro secoli fa il Sant' Uffizio mi avrebbe mandato al rogo) ne rispetta le idee. Loro, no. Ergo con loro non si può dialogare. E ciò non significa ch'io voglia promuovere una guerra di religione, una Crociata, una caccia alle streghe, come sostengono i mentecatti e i cialtroni. (Guerre di religione, Crociate, io ?!? Non essendo religiosa, figuriamoci se voglio incitare alle guerre di religione e alle Crociate. Cacce alle streghe io?!? Essendo considerata una strega, un'eretica, dagli stessi laici e dagli stessi liberals, figuriamoci se voglio accendere una caccia alle streghe. Ciò significa, semplicemente, che illudersi su di loro è contro ragione. Contro la Vita, contro la stessa sopravvivenza, e guai a concedergli certe familiarità.
La strage toccherà davvero anche a noi, la prossima volta toccherà davvero a noi? Oh, sì. Non ne ho il minimo dubbio. Non l'ho mai avuto. Anche questo lo dico da quattro anni. E aggiungo: non ci hanno ancora attaccato in quanto avevano bisogno della landing-zone, della testa di ponte, del comodo avamposto che si chiama Italia. Comodo geograficamente perché è il più vicino al Medio Oriente e all' Africa cioè ai paesi che forniscono il grosso della truppa. Comodo strategicamente perché a quella truppa offriamo buonismo e collaborazionismo, coglioneria e viltà. Ma presto si scateneranno. Lo stesso Bin Laden ce lo ha promesso. In modo esplicito, chiaro, preciso. Più volte. I suoi luogotenenti (o rivali), idem. Lo stesso Corriere lo dimostra con l'intervista a Saad Al-Faqih, l' esiliato saudita diventato amico di Bin Laden durante il conflitto coi russi in Afghanistan, e secondo i servizi segreti americani finanziatore di Al Qaeda. «E' solo questione di tempo. Al Qaeda vi colpirà presto» ha detto Al-Faqih aggiungendo che l'attacco all'Italia è la cosa più logica del mondo. Non è l'Italia l'anello più debole della catena composta dagli alleati in Iraq? Un anello che viene subito dopo la Spagna e che è stato preceduto da Londra per pura convenienza. E poi: «Bin Laden ricorda bene le parole del Profeta. Voi costringerete i romani alla resa. E vuole costringer l'Italia ad abbandonare l'alleanza con l'America». Infine, sottolineando che operazioni simili non si fanno appena sbarcati a Lampedusa o alla Malpensa bensì dopo aver maturato dimestichezza con il paese, esser penetrati nel suo tessuto sociale: «Per reclutare gli autori materiali, c'è solo l' imbarazzo della scelta».
Molti italiani non ci credono ancora. Nonostante le dichiarazioni del ministro degli Interni, a rischio Roma e Milano, all' erta anche Torino e Napoli e Trieste e Treviso nonché le città d' arte come Firenze e Venezia, gli italiani si comportano come i bambini per cui la parola Morte non ha alcun significato. O come gli scriteriati cui la morte sembra una disgrazia che riguarda gli altri e basta. Nel caso peggiore, una disgrazia che li colpirà per ultimi. Peggio: credono che per scansarla basti fare i furbi cioè leccarle i piedi. Ha ragione Vittorio Feltri quando su Libero scrive che la decadenza degli occidentali si identifica con la loro illusione di poter trattare amichevolmente il nemico, nonché con la loro paura. Una paura che li induce ad ospitare docilmente il nemico, a tentar di conquistarne la simpatia, a sperare che si lasci assorbire mentre è lui che vuole assorbire. Questo senza contare la nostra abitudine ad essere invasi, umiliati, traditi. Come dico nell'«Apocalisse», l'abitudine genera rassegnazione. La rassegnazione genera apatia. L'apatia genera inerzia. L'inerzia genera indifferenza, ed oltre a impedire il giudizio morale l'indifferenza soffoca l'istinto di autodifesa cioè l'istinto che induce a battersi. Oh, per qualche settimana o qualche mese lo capiranno sì d' essere odiati e disprezzati dal nemico che trattano da amico e che è del tutto refrattario alle virtù chiamate Gratitudine, Lealtà, Pietà. Usciranno sì dall'apatia, dall'inerzia, dall' indifferenza. Ci crederanno sì agli annunci di Saad al-Faqih e agli espliciti, chiari, precisi avvertimenti pronunciati da Bin Laden and Company. Eviteranno di prendere i treni della sotterranea. Si sposteranno in automobile o in bicicletta. (Ma Theo van Gogh fu ammazzato mentre si spostava in bicicletta). Attenueranno il buonismo o il servilismo. Si fideranno un po' meno del clandestino che gli vende la droga o gli pulisce la casa. Saranno meno cordiali col manovale che sventolando il permesso di soggiorno afferma di voler diventare come loro ma intanto fracassa di botte la moglie, le mogli, e uccide la figlia in blue jeans. Rinunceranno anche alle litanie sui Viaggi della Speranza, e forse realizzeranno che per non perdere la Libertà a volte bisogna sacrificare un po' di libertà. Che l' autodifesa è legittima difesa e la legittima difesa non è una barbarie. Forse grideranno addirittura che la Fallaci aveva ragione, che non meritava d' essere trattata come una delinquente. Ma poi riprenderanno a trattarmi come una delinquente. A darmi di retrograda xenofoba razzista eccetera. E quando l' attacco verrà, udiremo le consuete scemenze. Colpa degli americani, colpa di Bush.
Quando verrà, come avverrà quell'attacco? Oddio, detesto fare la Cassandra. La profetessa. Non sono una Cassandra, non sono una profetessa. Sono soltanto un cittadino che ragiona e ragionando prevede cose che secondo logica accadranno. Ma che ogni volta spera di sbagliarsi e, quando accadono, si maledice per non aver sbagliato. Tuttavia riguardo all' attacco contro l' Italia temo due cose: il Natale e le elezioni. Forse supereremo il Natale. I loro attentati non sono colpacci rozzi, grossolani. Sono delitti raffinati, ben calcolati e ben preparati. Prepararsi richiede tempo e a Natale credo che non saranno pronti. Però saranno pronti per le elezioni del 2006. Le elezioni che vogliono vedere vinte dal pacifismo a senso unico. E da noi, temo, non si accontenteranno di massacrare la gente. Perché quello è un Mostro intelligente, informato, cari miei. Un Mostro che (a nostre spese) ha studiato nelle università, nei collegi rinomati, nelle scuole di lusso. (Coi soldi del genitore sceicco od onesto operaio). Un Mostro che non s' intende soltanto di dinamica, chimica, fisica, di aerei e treni e metropolitane: s' intende anche di Arte. L'arte che il loro presunto Faro di Civiltà non ha mai saputo produrre. E penso che insieme alla gente da noi vogliano massacrare anche qualche opera d' arte. Che ci vuole a far saltare in aria il Duomo di Milano o la Basilica di San Pietro? Che ci vuole a far saltare in aria il David di Michelangelo, gli Uffizi e Palazzo Vecchio a Firenze, o il Palazzo dei Dogi a Venezia? Che ci vuole a far saltare in aria la Torre di Pisa, monumento conosciuto in ogni angolo del mondo e perciò assai più famoso delle due Torri Gemelle? Ma non possiamo scappare o alzare bandiera bianca. Possiamo soltanto affrontare il mostro con onore, coraggio, e ricordare quel che Churchill disse agli inglesi quando scese in guerra contro il nazismo di Hitler. Disse: «Verseremo lacrime e sangue». Oh, sì: pure noi verseremo lacrime e sangue. Siamo in guerra: vogliamo mettercelo in testa, sì o no?!? E in guerra si piange, si muore. Punto e basta. Conclusi così anche quattro anni fa, su questo giornale.
Oriana Fallaci a una terrorista. «Un neonato per te è un nemico?». La giornalista e scrittrice nel 1970 intervistò Rascida Abhedo, palestinese, che fece esplodere due bombe in un mercato di Gerusalemme provocando una carneficina, scrive Oriana Fallaci su “Il Corriere della Sera”. Oriana Fallaci, il terrorismo, il rapporto dell’Occidente con il mondo islamico. La grande giornalista ha affrontato questi temi molte volte nei suoi articoli e nelle sue interviste. Con l’iniziativa «Le parole di Oriana» abbiamo scelto di ripubblicare alcuni di questi suoi interventi, che mantengono - a distanza di molti anni - una forza, un valore e un fascino straordinari. Ecco l’intervista del 1970 all’attentatrice palestinese Rascida Abhedo.
Sembrava una monaca. O una guardia rossa di Mao Tse-tung. Delle monache aveva la compostezza insidiosa, delle guardie rosse l’ostilità sprezzante, di entrambe il gusto di rendersi brutta sebbene fosse tutt’altro che brutta. Il visino ad esempio era grazioso: occhi verdi, zigomi alti, bocca ben tagliata. Il corpo era minuscolo e lo indovinavi fresco, privo di errori. Ma l’insieme era sciupato da quei ciuffi neri, untuosi, da quel pigiama in tela grigioverde, un’uniforme da fatica suppongo, di taglia tre volte superiore alla sua: quella sciatteria voluta, esibita, ti aggrediva come una cattiveria. Dopo il primo sguardo, ti apprestavi con malavoglia a stringerle la mano, che ti porgeva appena, restando seduta, costringendoti a scendere verso di lei nell’inchino del suddito che bacia il piede della regina. In silenzio bestemmiavi: «Maleducata!». La mano toccò molle la mia. Gli occhi verdi mi punsero con strafottenza, anzi con provocazione, una vocetta litigiosa scandì: «Rascida Abhedo, piacere». Poi, rotta dallo sforzo che tal sacrificio le era costato, si accomodò meglio contro la spalliera del grande divano in fondo al salotto dove occupava il posto d’onore. Dico così perché v’erano molte persone, e queste le sedevan dinanzi a platea: lei in palcoscenico e loro in platea. Una signora che avrebbe fatto da interprete, suo marito, un uomo che mi fissava muto e con sospettosa attenzione, un giovanotto dal volto dolcissimo e pieno di baffi, infine Najat: la padrona di casa che aveva organizzato l’incontro con lei. Come lei, essi appartenevano tutti al Fronte Popolare, cioè il movimento maoista che da Al Fatah si distingue per la preferenza a esercitare la lotta coi sabotaggi e il terrore. Però, al contrario di lei, eran tutti ben vestiti, cordiali e borghesi: invece che ad Amman avresti detto di trovarti a Roma, tra ricchi comunisti à la page, sai tipi che fingono di voler morire per il proletariato ma poi vanno a letto con le principesse. La signora che avrebbe fatto da interprete amava andare in vacanza a Rapallo e calzava scarpe italiane. Najat, una splendida bruna sposata a un facoltoso ingegnere, era la ragazza più sofisticata della città: in una settimana non l’avevo mai sorpresa con lo stesso vestito, con un accessorio sbagliato. Sempre ben pettinata, ben profumata, ben valorizzata da un completo giacca-pantaloni o da una minigonna. Non credevi ai tuoi orecchi quando diceva: «Sono stanca perché ho partecipato alle manovre e mi duole una spalla perché il Kalashnikov rincula in modo violento». Stasera indossava un modello francese e il suo chic era così squisito che, paragonata a lei, la monaca in uniforme risultava ancor più inquietante. Forse perché sapevi chi era. Era colei che il 21 febbraio 1969 aveva fatto esplodere due bombe al supermercato di Gerusalemme, causando una carneficina. Era colei che dieci giorni dopo aveva costruito un terzo ordigno per la cafeteria della Università Ebraica. Era colei che per tre mesi aveva mobilizzato l’intera polizia israeliana e provocato Dio sa quanti arresti, repressioni, tragedie. Era colei che il Fronte custodiva per gli incarichi più sanguinolenti. Ventitré anni, ex maestra di scuola. La fotografia appesa in ogni posto di blocco: «Catturare o sparare». La patente di eroe. Al suo tono strafottente, provocatorio, ora s’era aggiunta un’espressione di gran sufficienza: la stessa che certe dive esibiscono quando devono affrontare i giornalisti curiosi. Mi accomodai accanto a lei sul divano. Lasciai perdere ogni convenevole, misi in moto il registratore: «Voglio la tua storia, Rascida. Dove sei nata, chi sono i tuoi genitori, come sei giunta a fare quello che fai». Alzò un sopracciglio ironico, tolse di tasca un fazzoletto. Si pulì il naso, lenta, rimise in tasca il fazzoletto. Si raschiò la gola. Sospirò. Rispose.
«Sono nata a Gerusalemme, da due genitori piuttosto ricchi, piuttosto conformisti, e assai rassegnati. Non fecero mai nulla per difendere la Palestina e non fecero mai nulla per indurmi a combattere. Fuorché influenzarmi, senza saperlo, coi loro racconti del passato. Mia madre, sempre a ripetere di quando andava a Giaffa col treno e dal finestrino del treno si vedeva il Mediterraneo che è così azzurro e bello. Mio padre, sempre a lagnarsi della notte in cui era fuggito con la mia sorellina su un braccio e me nell’altro braccio. E poi a dirmi dei partiti politici che c’erano prima del 1948, tutti colpevoli d’aver ceduto, d’aver deposto le armi, ma il suo era meno colpevole degli altri eccetera. E poi a mostrarmi la nostra vecchia casa al di là della linea di demarcazione, in territorio israeliano. Si poteva vederla dalle nostre finestre e penso che questo, sì, m’abbia servito. Prima di andare a letto la guardavo sempre, con ira, e a Natale guardavo gli arabi che si affollavano al posto di blocco per venire dai parenti profughi. Piangevano, perdevano i bambini, i fagotti. Erano brutti, senza orgoglio, e ti coglieva il bisogno di fare qualcosa. Questo qualcosa io lo scoprii nel 1962 quando entrai a far parte del Movimento nazionale arabo, il Fronte Popolare di oggi. Avevo quindici anni, non dissi nulla ai miei genitori. Si sarebbero spaventati, non avrebbero compreso. Del resto si faceva poco: riunioni di cellula, corsi politici, manifestazioni represse dai soldati giordani» .
Come eri entrata in contatto con quel movimento?
«A scuola. Cercavano adepti fra gli studenti. Poi venne il 1967: l’occupazione di Gerusalemme, di Gerico, del territorio a est del Giordano. Io in quei giorni non c’ero, ero nel Kuwait: insegnavo in una scuola media di una cittadina sul Golfo. C’ero stata costretta perché nelle scuole della Giordania c’era poca simpatia pei maestri palestinesi. L’occupazione di Gerusalemme mi gettò in uno stato di sonnolenza totale. Ero così mortificata che per qualche tempo non vi reagii e ci volle tempo perché capissi che agli altri paesi arabi non importava nulla della Palestina, non si sarebbero mai scomodati a liberarla: bisognava far questo da soli. Ma allora perché restavo in quella scuola a insegnare ai ragazzi? Il mio lavoro lo amavo, intendiamoci, lo consideravo alla stregua di un divertimento, ma era necessario che lo abbandonassi. Mi dimisi e venni ad Amman dove mi iscrissi subito al primo gruppo di donne addestrate dall’FPLP. Ragazze tra i diciotto e i venticinque anni, studentesse o maestre come me. Era il gruppo di Amina Dahbour, quella che hanno messo in prigione in Svizzera per il dirottamento di un aereo El Al, di Laila Khaled, che dirottò l’aereo della TWA, di Sheila Abu Mazal, la prima vittima della barbarie sionista» .
La interruppi: anche questo nome m’era familiare perché ovunque lo vedevi stampato con l’appellativo di eroina e sui giornali occidentali avevo letto che era morta in circostanze eccezionali. Chi diceva in combattimento, chi diceva sotto le torture.
Rascida, come morì Sheila Abu Mazal?
«Una disgrazia. Preparava una bomba per un’azione a Tel Aviv e la bomba scoppiò tra le sue mani» .
Perché?
«Così» .
Raccontami degli addestramenti, Rascida.
«Uffa. Eran duri. Ci voleva una gran forza di volontà per compierli. Marce, manovre, pesi. Sheila ripeteva: bisogna dimostrare che non siamo da meno degli uomini! E per questo in fondo scelsi il corso speciale sugli esplosivi. Era il corso che bisognava seguire per diventare agenti segreti e, oltre alla pratica degli esplosivi, prevedeva lo studio della topografia, della fotografia, della raccolta di informazioni. I nostri istruttori contavano molto sulle donne come elemento di sorpresa: da una ragazza araba non ci si aspettano certe attività. Divenni brava a scattar fotografie di nascosto ma specialmente a costruire ordigni a orologeria. Più di ogni altra cosa volevo maneggiare le bombe, io sono sempre stata un tipo senza paura. Anche da piccola. Non m’impressionava mai il buio. I corsi duravano a volte quindici giorni, a volte due mesi o quattro. Il mio corso fu lungo, assai lungo, perché dovetti anche imparare a recarmi nel territorio occupato. Passai il fiume molte volte, insieme alle mie compagne. A quel tempo non era difficilissimo perché gli sbarramenti fotoelettrici non esistevano, ma la prima volta non fu uno scherzo. Ero tesa, mi aspettavo di morire. Ma presto fui in grado di raggiungere Gerusalemme e stabilirmici come agente segreto» .
Dimmi delle due bombe al supermarket, Rascida.
«Uffa. Quella fu la prima operazione di cui posso rivendicare la paternità. Voglio dire che la concepii da sola, la preparai da sola, e da sola la portai fino in fondo. Avevo ormai partecipato a tanti sabotaggi del genere e potevo muovermi con disinvoltura. E poi avevo una carta di cittadinanza israeliana con cui potevo introdurmi in qualsiasi posto senza destare sospetto. Poiché abitavo di nuovo coi miei genitori, scomparivo ogni tanto senza dare nell’occhio. L’idea di attaccare il supermarket l’ebbi quattro giorni dopo la cattura di Amina a Zurigo, e la morte di Abdel. Nella sparatoria con l’israeliano, ricordi, Abdel rimase ucciso. Bisognava vendicare la morte di Abdel e bisognava dimostrare a Moshe Dayan la falsità di ciò che aveva detto: secondo Moshe Dayan, il Fronte Popolare agiva all’estero perché non era capace di agire entro Israele. E poi bisognava rispondere ai loro bombardamenti su Irbid, su Salt. Avevano ucciso civili? Noi avremmo ucciso civili. Del resto nessun israeliano noi lo consideriamo un civile ma un militare e un membro della banda sionista» .
Anche se è un bambino, Rascida? Anche se è un neonato? (Gli occhi verdi si accesero d’odio, la sua voce adirata disse qualcosa che l’interprete non mi tradusse, e subito scoppiò una gran discussione cui intervennero tutti: anche Najat, anche il giovanotto col volto dolcissimo. Parlavano in arabo, e le frasi si sovrapponevan confuse come in una rissa da cui si levava spesso un’invocazione: «Rascida!». Ma Rascida non se ne curava. Come un bimbo bizzoso scuoteva le spalle e, solo quando Najat brontolò un ordine perentorio, essa si calmò. Sorrise un sorriso di ghiaccio, mi replicò).
«Questa domanda me la ponevo anch’io, quando mi addestravo con gli esplosivi. Non sono una criminale e ricordo un episodio che accadde proprio al supermarket, un giorno che vi andai in avanscoperta. C’erano due bambini. Molto piccoli, molto graziosi. Ebrei. Istintivamente mi chinai e li abbracciai. Ma stavo abbracciandoli quando mi tornarono in mente i nostri bambini uccisi nei villaggi, mitragliati per le strade, bruciati dal napalm. Quelli di cui loro dicono: bene se muore, non diventerà mai un fidayin. Così li respinsi e mi alzai. E mi ordinai: non farlo mai più, Rascida, loro ammazzano i nostri bambini e tu ammazzerai i loro. Del resto, se questi due bambini morranno, o altri come loro, mi dissi, non sarò stata io ad ammazzarli. Saranno stati i sionisti che mi forzano a gettare le bombe. Io combatto per la pace, e la pace val bene la vita di qualche bambino. Quando la nostra vera rivoluzione avverrà, perché oggi non è che il principio, numerosi bambini morranno. Ma più bambini morranno più sionisti comprenderanno che è giunto il momento di andarsene. Sei d’accordo? Ho ragione?»
No, Rascida.
La discussione riprese, più forte. Il giovanotto dal volto dolcissimo mi lanciò uno sguardo conciliativo, implorante. V’era in lui un che di straziante e ti chiedevi chi fosse. Poi, con l’aiuto di alcune tazze di tè, l’intervista andò avanti.
Perché scegliesti proprio il supermarket, Rascida?
«Perché era un buon posto, sempre affollato. Durante una decina di giorni ci andai a tutte le ore proprio per studiare quando fosse più affollato. Lo era alle undici del mattino. Osservai anche l’ora in cui apriva e in cui chiudeva, i punti dove si fermava più gente, e il tempo che ci voleva a raggiungerlo dalla base segreta dove avrei ritirato la bomba o le bombe. Per andarci mi vestivo in modo da sembrare una ragazza israeliana, non araba. Spesso vestivo in minigonna, altre volte in pantaloni, e portavo sempre grandi occhiali da sole. Era interessante, scoprivo sempre qualcosa di nuovo e di utile, ad esempio che se camminavo con un peso il tragitto tra la base e il supermarket aumentava. Infine fui pronta e comprai quei due bussolotti di marmellata. Molto grandi, da cinque chili l’uno, di latta. Esattamente ciò di cui avevo bisogno» .
Per le bombe?
«Sicuro. L’idea era di vuotarli, riempirli di esplosivo, e rimetterli dove li avevo presi. Quella notte non tornai a casa. Andai alla mia base segreta e con l’aiuto di alcuni compagni aprii i bussolotti. Li vuotai di quasi tutta la marmellata e ci sistemai dentro l’esplosivo con un ordigno a orologeria. Poi saldai di nuovo il coperchio, perché non si vedesse che erano stati aperti e...»
Che marmellata era, Rascida?
«Marmellata di albicocche, perché?»
Così... Non mangerò mai più marmellata di albicocche. . (Rascida rise a gola spiegata e a tal punto che le venne la tosse).
«Io la mangiai, invece. Era buona. E dopo averla mangiata andai a dormire» .
Dormisti bene, Rascida?
«Come un angelo. E alle cinque del mattino mi svegliai bella fresca. Mi vestii elegantemente, coi pantaloni alla charleston, sai quelli attillati alla coscia e svasati alla caviglia, mi pettinai con cura, mi truccai gli occhi e le labbra. Ero graziosa, i miei compagni si congratulavano: «Rascida!». Quando fui pronta misi i bussolotti della marmellata in una borsa a sacco: sai quelle che si portano a spalla. Le donne israeliane la usano per fare la spesa. Uh, che borsa pesante! Un macigno! L’esplosivo pesava il doppio della marmellata. Ecco perché negli addestramenti ti abituano a portare pesi» .
Come ti sentivi, Rascida? Nervosa, tranquilla?
«Tranquilla, anzi felice. Ero stata così nervosa nei giorni precedenti che mi sentivo come scaricata. E poi era una mattina azzurra, piena di sole. Sapeva di buon auspicio. Malgrado il peso della borsa camminavo leggera, portavo quelle bombe come un mazzo di fiori. Sì, ho detto fiori. Ai posti di blocco i soldati israeliani perquisivano la gente ma io gli sorridevo con civetteria e, senza attendere il loro invito, aprivo la borsa: «Shalom, vuoi vedere la mia marmellata?». Loro guardavano la marmellata e con cordialità mi dicevano di proseguire. No, non andai dritta al supermarket: dove andai prima è affar mio e non ti riguarda. Al supermarket giunsi poco dopo le nove. Che pensi? (Pensavo a un episodio del film La battaglia di Algeri, quello dove tre donne partono una mattina per recarsi a sistemare esplosivi su obiettivi civili. Una delle tre donne è una ragazza che assomiglia straordinariamente a Rascida: piccola, snella, e porta i pantaloni. Passando ai posti di blocco strizza l’occhio ai soldati francesi, civetta. Chissà se Rascida aveva visto il film. Magari sì. Bisognava che glielo chiedessi quando avrebbe finito il racconto. Ma poi me ne dimenticai. O forse volli dimenticarmene per andarmene via prima). Pensavo... a nulla» .
Cosa accadde quando entrasti nel supermarket, Rascida?
«Entrai spedita e agguantai subito il carry-basket, sai il cestino di metallo dove si mette la roba, il cestino con le ruote. Al supermarket c’è il self-service, ti muovi con facilità. La prima cosa da fare, quindi, era togliere i due bussolotti di marmellata dalla mia borsa e metterli nel carry-basket. Ci avevo già provato ma con oggetti più piccoli, non così pesanti, coi bussolotti grandi no e per qualche secondo temetti di dare nell’occhio. Mi imposi calma, perciò. Mi imposi anche di non guardare se mi guardavano altrimenti il mio gesto avrebbe perso spontaneità. Presto i bussolotti furono nel carry-basket. Ora si trattava di rimetterli a posto ma non dove li avevo presi perché non era un buon punto. Alla base avevo caricato i due ordigni a distanza di cinque minuti, in modo che uno esplodesse cinque minuti prima dell’altro. Decisi di mettere in fondo al negozio quello che sarebbe esploso dopo. L’altro, invece, vicino alla porta dove c’era uno scaffale con le bottiglie di birra e i vasetti» .
Perché, Rascida?
«Perché la porta era di vetro come le bottiglie di birra, come i vasetti. Con l’esplosione sarebbero schizzati i frammenti e ciò avrebbe provocato un numero maggiore di feriti. O di morti. Il vetro è tremendo: lanciato a gran velocità può decapitare, e anche i piccoli pezzi sono micidiali. Non solo, la prima esplosione avrebbe bloccato l’ingresso. Allora i superstiti si sarebbero rifugiati in fondo al negozio e qui, cinque minuti dopo, li avrebbe colti la seconda esplosione. Con un po’ di fortuna, nel caso la polizia fosse giunta alla svelta, avrei fatto fuori anche un bel po’ di polizia. Rise divertita, contenta. E ciò le provocò un nuovo accesso di tosse» .
Non ridere, Rascida. Continua il tuo racconto, Rascida.
«Sempre senza guardare se mi guardavano, sistemai i due bussolotti dove avevo deciso. Se qualcuno se ne accorse non so, ero troppo concentrata in ciò che stavo facendo. Ricordo solo un uomo molto alto, con il cappello, che mi fissava. Ma pensai che mi fissasse perché gli piacevo. Te l’ho detto che ero molto graziosa quella mattina. Poi, quando anche il secondo bussolotto fu nello scaffale, comprai alcune cose: tanto per non uscire a mani vuote. Comprai un grembiule da cucina, due stecche di cioccolata, altre sciocchezze. Non volevo dare troppi soldi agli ebrei» .
Cos’altro comprasti, Rascida?
«I cetriolini sottaceto. E le cipolline sottaceto. Mi piacciono molto. Mi piacciono anche le olive farcite. Ma cos’è questo, un esame di psicologia?»
Se vuoi. E li mangiasti quei cetriolini, quelle cipolline?
«Certo. Li portai a casa e li mangiai. Non era un’ora adatta agli antipasti e mia madre disse, ricordo: «Da dove vengono, quelli?». Io risposi: «Li ho comprati al mercato». Ma che te ne importa di queste cose? Torniamo al supermarket. Avevo deciso che l’intera faccenda dovesse durare quindici minuti. E quindici minuti durò. Così, dopo aver pagato uscii e tornai a casa. Qui feci colazione e riposai. Un’ora di cui non ricordo nulla. Alle undici in punto aprii la radio per ascoltar le notizie. Le bombe erano state caricate alle sei e alle sei e cinque, affinché scoppiassero cinque ore dopo. L’esplosione sarebbe dunque avvenuta alle undici e alle undici e cinque: l’ora dell’affollamento. Aprii la radio per accertarmene e per sapere se... se erano morti bambini nell’operazione» .
Lascia perdere, Rascida. Non ci credo, Rascida. Cosa disse la radio?
«Disse che c’era stato un attentato al supermarket e che esso aveva causato due morti e undici feriti. Rimasi male, due morti soltanto, e scesi per strada a chiedere la verità. Radio Israele non dice mai la verità. La verità era che le due bombe avevan causato ventisette morti e sessanta feriti fra cui quindici gravissimi. Bè, mi sentii meglio anche se non perfettamente contenta. Gli esperti militari della mia base avevano detto che ogni bomba avrebbe ucciso chiunque entro un raggio di venticinque metri e, verso le undici del mattino, al supermarket non contavi mai meno di trecentocinquanta persone. Oltre a un centinaio di impiegati» .
Rascida, provasti anzi provi nessuna pietà per quei morti?
«No davvero. Il modo in cui ci trattano, in cui ci uccidono, spenge in noi ogni pietà. Io ho dimenticato da tempo cosa significa la parola pietà e mi disturba perfino pronunciarla. Corre voce che ci fossero arabi in quel negozio. Non me ne importa. Se c’erano, la lezione gli servì a imparare che non si va nei negozi degli ebrei, non si danno soldi agli ebrei. Noi arabi abbiamo i nostri negozi, e i veri arabi si servono lì» .
Rascida, cosa facesti dopo esserti accertata che era successo ciò che volevi?
«Dissi a mia madre: «Ciao, mamma, esco e torno fra poco». La mamma rispose: «Va bene, fai presto, stai attenta». Chiusi la porta e fu l’ultima volta che la vidi. Dovevo pensare a nascondermi, a non farmi più vedere neanche se arrestavano i miei. E li arrestarono. Non appena il Fronte Popolare assunse la paternità dell’operazione, gli israeliani corsero da quelli che appartenevano al Fronte. Hanno schedari molto precisi, molto aggiornati: un dossier per ciascuno di noi. E tra coloro che presero c’era un compagno che sapeva tutto di me. Così lo torturarono ma lui resistette tre giorni: è la regola. Tre giorni ci bastano infatti a metterci in salvo. Dopo tre giorni disse il mio nome, così la polizia venne ad arrestarmi ma non mi trovò e al mio posto si portò via la famiglia. Mio padre, mia madre, mia sorella maggiore e i bambini. Mia madre e i bambini li rilasciarono presto, mio padre invece lo tennero tre mesi e mia sorella ancora di più. Al processo non ci arrivarono mai perché in realtà né mio padre né mia sorella sapevano niente» .
E tu cosa facesti, Rascida?
«Raggiunsi una base segreta e preparai la bomba per la cafeteria dell’Università Ebraica. Questo accadde il 2 marzo e purtroppo io non potei piazzare la bomba, che non ebbe un esito soddisfacente. Solo ventotto studenti restaron feriti, e nessun morto. In compenso le cose peggiorarono molto per me: la mia fotografia apparve dappertutto e la polizia prese a cercarmi ancor più istericamente. Fu necessario abbandonare la base segreta e da quel momento dovetti cavarmela proprio da me. Mi trasferivo di casa in casa, una notte qui e una notte là, per strada mi sembrava sempre d’esser seguita. Un giorno un’automobile mi seguì a passo d’uomo per circa due ore. Esitavano a fermarmi, credo, perché ero molto cambiata e vestita come una stracciona. Riuscii a far perdere le mie tracce e, in un vicolo, bussai disperatamente a una porta. Aprì un uomo, cominciai a piangere e a dire che ero sola al mondo: mi prendesse a servizio per carità. Si commosse, mi assunse e rimasi lì dieci giorni. Al decimo, giudicai saggio scomparire. Ero appena uscita che la polizia israeliana arrivò e arrestò l’uomo. Al processo, malgrado ignorasse tutto di me, fu condannato a tre anni. È ancora in prigione» .
Te ne dispiace, Rascida?
«Che posso farci? In carcere ce l’hanno messo loro, mica io. E io ho sofferto tanto. Tre mesi di caccia continua» .
Ci credo, avevi fatto scoppiare tre bombe! E come tornasti in Giordania, Rascida?
«Con un gruppo militare del Fronte. Si passò le linee di notte. Non fu semplice, dovemmo nasconderci molte ore nel fiume e bevvi un mucchio di quell’acqua sporca. Sono ancora malata. Ma partecipo lo stesso alle operazioni da qui e l’unica cosa che mi addolora è non poter più mettere bombe nei luoghi degli israeliani» .
E non vedere più i tuoi genitori, averli mandati in carcere, ti addolora?
«La mia vita personale non conta, in essa non v’è posto per le emozioni e le nostalgie. I miei genitori li ho sempre giudicati brava gente e tra noi c’è sempre stato un buon rapporto, ma v’è qualcosa che conta più di loro ed è la mia patria. Quanto alla prigione, li ha come svegliati: non sono più rassegnati, indifferenti. Ad esempio potrebbero lasciare Gerusalemme, mettersi in salvo, ma rifiutan di farlo. Non lasceremo mai la nostra terra, dicono. E se Dio vuole...»
Credi in Dio, Rascida?
«No, non direi. La mia religione è sempre stata la mia patria. E insieme a essa il socialismo. Ho sempre avuto bisogno di spiegare le cose scientificamente, e Dio non lo spieghi scientificamente: il socialismo sì. Io credo nel socialismo scientifico basato sulle teorie marxiste-leniniste che ho studiato con cura. Presto studierò anche Il Capitale: è in programma nella nostra base. Voglio conoscerlo bene prima di sposarmi» .
Ti sposi, Rascida?
«Sì, tra un mese. Il mio fidanzato è quello lì» . (E additò il giovanotto dal volto dolcissimo. Lui arrossì gentilmente e parve affondare dentro la poltrona).
Congratulazioni. Avevi detto che nella tua vita non c’è posto per i sentimenti.
«Ho detto che capisco le cose solo da un punto di vista scientifico e il mio matrimonio è la cosa più scientifica che tu possa immaginare. Lui è comunista come me, fidayin come me: la pensiamo in tutto e per tutto nel medesimo modo. Inoltre v’è attrazione fra noi ed esaudirla non è forse scientifico? Il matrimonio non c’impedirà di combattere: non metteremo su casa. L’accordo è incontrarci tre volte al mese e solo se ciò non intralcia i nostri doveri di fidayin. Figli non ne vogliamo: non solo perché se restassi incinta non potrei più combattere e il mio sogno più grande è partecipare a una battaglia, ma perché non credo che in una situazione come questa si debba mettere al mondo bambini. A che serve? A farli poi morire o almeno restare orfani?»
(Allora si alzò il fidanzato, che si chiamava Thaer, e con l’aria di scusarsi venne a sedere presso di me. Guardandomi con due occhi di agnello, parlando con voce bassissima, dolce come il suo viso, disse che conosceva Rascida da circa tre anni: quando lei insegnava nel Kuwait e lui studiava psicologia all’università. «Mi piacque come essere umano, pei suoi pregi e i suoi difetti. Dopo la guerra del 1967 le scrissi una lettera per annunciarle che sarei diventato fidayin, per spiegarle che l’amavo, sì, ma la Palestina contava più del mio amore. Lei rispose: “Thaer, hai avuto più fiducia in me di quanta io ne abbia avuta in te. Perché tu m’hai detto di voler diventare fidayin e io non te l’ho detto. Abbiamo gli stessi progetti, Thaer, e da questo momento mi considero davvero fidanzata con te”.» «Capisco, Thaer. Ma cosa provasti a sapere che Rascida aveva ucciso ventisette persone senza un fucile in mano?» Thaer prese fiato e congiunse le mani come a supplicarmi di ascoltarlo con pazienza. «Fui orgoglioso di lei. Oh, so quello che provi, all’inizio la pensavo anch’io come te. Perché sono un uomo tenero, io, un sentimentale. Non assomiglio a Rascida. Il mio modo di fare la guerra è diverso: io sparo a chi spara. Ma ho visto bombardare i nostri villaggi e mi sono rivoltato: ho deciso che avere scrupoli è sciocco. Se invece d’essere uno spettatore obbiettivo tu fossi coinvolta nella tragedia, non piangeresti sui morti senza il fucile. E capiresti Rascida.») Certo è difficile capire Rascida. Ma vale la pena provarci e, per provarci, bisogna avere visto i tipi come Rascida nei campi dove diventano fidajat: cioè donne del sacrificio. Lunghe file di ragazze in grigioverde, costrette giorno e notte a marciare sui sassi, saltare sopra altissimi roghi di gomma e benzina, insinuarsi entro reticolati alti appena quaranta centimetri e larghi cinquanta, tenersi in bilico su ponticelli di corde tese su trabocchetti, impegnarsi in massacranti lezioni di tiro. E guai se sbagli un colpo, guai se calcoli male il salto sul fuoco, guai se resti impigliato in una punta di ferro, guai se dici basta, non ce la faccio più. L’istruttore che viene dalla Siria, dall’Iraq, dalla Cina, non ha tempo da perdere con le femminucce: se hai paura, o ti stanchi, ti esplode una raffica accanto agli orecchi. Hai visto le fotografie. Ch’io sappia, neanche i berretti verdi delle forze speciali in Vietnam, neanche i soldati più duri dei commandos israeliani vengono sottoposti ad addestramenti così spietati. E da quelli, credi, esci non soltanto col fisico domato ma con una psicologia tutta nuova. Dice che in alcuni campi (questo io non l’ho visto) le abituano perfino alla vista del sangue. E sai come? Prima sparano su un cane lasciandolo agonizzante ma vivo, poi buttano il cane tra le loro braccia e le fanno correre senza ascoltarne i guaiti. Dopo tale esperienza, è dimostrato, al dolore del corpo e dell’anima non badi più. Al campo Schneller conobbi una fidajat che si chiamava Hanin, Nostalgia. La intervistai e mi disse d’avere venticinque anni, un figlio di sei e una figlia di due. Le chiesi: «Dove li hai lasciati, Hanin?». Rispose: «In casa, oggi c’è mio marito». «E cosa fa tuo marito?» «Il fidayin. Oggi è in licenza.» «E quando non c’è tuo marito?» «Qua e là.» «Hanin, non basta un soldato in famiglia?» «No, voglio passare anch’io le linee, voglio andare anch’io in combattimento.» Poi ci mettemmo a parlare di altre cose, del negozio di antiquariato che essi possedevano a Gerusalemme, del fatto che non gli mancassero i soldi eccetera. La conversazione era interessante, si svolgeva direttamente in inglese, e io non mi curavo del lieve sospiro, quasi un lamento, che usciva dalle pieghe del kaffiah. I grandi occhi neri erano fermi, la fronte era appena aggrottata, e pensavo: poverina, è stanca. Ma poi l’istruttore chiamò, era giunto il turno di sparare al bersaglio, e Hanin si alzò: nell’alzarsi le sfuggì un piccolo grido. «Ti senti male, Hanin?» «No, no. Credo soltanto d’essermi slogata un piede. Ma ora non c’è tempo di metterlo a posto, lo dirò quando le manovre saranno finite.» E raggiunse le compagne, decisa, col suo piede slogato. Per capire Rascida, o provarci, bisogna anche avere visto le donne che hanno fatto la guerra senza allenarsi: affrontando di punto in bianco la morte, la consapevolezza che la crudeltà è indispensabile se vuoi sopravvivere. In un altro campo conobbi Im Castro: significa Madre di Castro. Im essendo l’appellativo che i guerriglieri palestinesi usano per le donne, e Castro essendo il nome scelto da suo figlio maggiore: fidayin. Im Castro era un donnone di quarant’anni, con un corpo da pugile e un volto da Madonna bruciata dalle intemperie. Acqua, vento, sole, rabbia, disperazione, tutto era passato su quei muscoli color terracotta riuscendo a renderli più forti e più duri anziché sgretolarli. Contadina a Gerico, era fuggita nel 1967 insieme al marito, il fratello, il cognato, due figli maschi e due femmine. Qui era giunta dopo Karameh e qui viveva sotto una tenda dove non possedeva nulla fuorché una coperta e un rudimentale fornello con due pentole vecchie. Le chiesi: «Im Castro, dov’è tuo marito?». Rispose: «È morto in battaglia, a Karameh». «Dov’è tuo fratello?» «È morto in battaglia, a Karameh.» «Dov’è tuo cognato?» «È morto in battaglia, a Karameh.» «Dove sono i tuoi figli?» «Al fronte, sono fidayin.» «Dove sono le tue figlie?» «Agli addestramenti, per diventare fidajat. » «E tu?» «Io non ne ho bisogno. Io so usare il Kalashnikov, il Carlov, e queste qui.» Sollevò un cencio e sotto c’era una dozzina di bombe col manico. «Dove hai imparato a usarle, Im Castro?» «A Karameh, combattendo col sangue ai ginocchi.» «E prima non avevi mai sparato, Im Castro? » «No, prima coltivavo grano e fagioli.» «Im Castro, cosa provasti ad ammazzare un uomo?» «Una gran gioia, che Allah mi perdoni. Pensai: hai ammazzato mio marito, ragazzo, e io ammazzo te.» «Era un ragazzo?» «Sì, era molto giovane.» «E non hai paura che succeda lo stesso ai tuoi figli?» «Se i miei figli muoiono penserò che hanno fatto il loro dovere. E piangerò solo perché essendo vedova non potrò partorire altri figli per darli alla Palestina.» «Im Castro, chi è il tuo eroe?» «Eroe è chiunque spari la mitragliatrice.» Le guerre, le rivoluzioni, non le fanno mai le donne. Non sono le donne a volerle, non sono le donne a comandarle, non sono le donne a combatterle. Le guerre, le rivoluzioni, restano dominio degli uomini. Per quanto utili o utilizzate, le donne vi servono solo da sfondo, da frangia, e neanche la nostra epoca ha modificato questa indiscutibile legge. Pensa all’Algeria, pensa al Vietnam dove esse fanno parte dei battaglioni vietcong ma in un rapporto di cinque a venti coi maschi. Pensa alla stessa Israele dove le soldatesse son così pubblicizzate ma chi si accorge di loro in battaglia se non sono una figlia di Moshe Dayan. In Palestina è lo stesso. Dei duecentomila palestinesi mobilitati da Al Fatah, almeno un terzo son donne: intellettuali come Rascida, madri di famiglia come Hanin, signore borghesi come Najat, contadine come Im Castro. Però quasi tutte sono in fase di riposo o di attesa, pochissime vivono nelle basi segrete, e solo in casi eccezionali partecipano a un combattimento. È indicativo, ad esempio, che tra i fidayin al fronte non ne abbia incontrata nessuna e che l’unica di cui mi abbian parlato sia una cinquantaquattrenne che fa la vivandiera per un gruppo di Salt. È indiscutibile, inoltre, che l’unica di cui si possa vantare la morte sia quella Sheila cui scoppiò una bomba in mano. A usare le donne nella Resistenza non ci sono che i comunisti rivali di Al Fatah i quali le impiegano senza parsimonia per gli atti di sabotaggio e di terrorismo. La ragione è semplice e intelligente. In una società dove le donne hanno sempre contato quanto un cammello o una vacca, e per secoli sono rimaste segregate al ruolo di moglie di madre di serva, nessuno si aspettava di trovarne qualcuna capace di dirottare un aereo, piazzare un ordigno, maneggiare un fucile. Abla Taha, la fidajat di cui si parlò anche alle Nazioni Unite per gli abusi che subì in prigione sebbene fosse incinta, racconta: «Quando mi arrestarono al ponte Allenby perché portavo esplosivo, gli israeliani non si meravigliarono mica dell’esplosivo. Si meravigliarono di scoprirlo addosso a una donna. Per loro era inconcepibile che un’araba si fosse tolta il velo per fare la guerra». La stessa Rascida, del resto, spiega che al corso di addestramento le donne venivano incluse come «elemento di sorpresa ». Il discorso cui volevo arrivare, comunque, la morale della faccenda, non è questo qui. È che la sorpresa su cui gli uomini della Resistenza palestinese contavano per giocare il nemico, ha colto di contropiede anche loro. «Tutto credevamo,» mi confessò un ufficiale della milizia fidayin «fuorché le donne rispondessero al nostro appello come hanno fatto. Ormai non siamo più noi a cercarle, sono loro a imporsi e pretendere di andare all’attacco.» «E qual è la sua interpretazione?» gli chiesi. L’ufficiale non era uno sciocco. Accennò una smorfia che oscillava tra il divertimento e il fastidio, rispose: «Lo sa meglio di me che l’amore per la patria c’entra solo in parte, che la molla principale non è l’idealismo. È... sì, è una forma di femminismo. Noi uomini le avevamo chiuse a chiave dietro una porta di ferro, la Resistenza ha aperto uno spiraglio di quella porta ed esse sono fuggite. Hanno compreso insomma che questa era la loro grande occasione, e non l’hanno perduta. Le dico una cosa che esse non ammetterebbero mai in quanto è una verità che affoga nel loro subcosciente: combattendo l’invasore sionista esse rompono le catene imposte dai loro padri, dai loro mariti, dai loro fratelli. Insomma dal maschio». «E sono davvero brave?» «Oh, sì. Più brave degli uomini, perché più spietate. Abbastanza normale se ricorda che il loro nemico ha due facce: quella degli israeliani e la nostra. » «E crede che vinceranno?» «Non so. Dipende dal regime politico che avrà la Palestina indipendente. Capisce cosa voglio dire?» Voleva dire ciò che dice, silenziosamente, Rascida. La società araba non è una società disposta a correggere i suoi tabù sulla donna e sulla famiglia. Le tradizioni mussulmane sono troppo abbarbicate negli uomini del Medio Oriente perché a scardinarle basti una guerra o il progresso tecnologico che esplode con la guerra. Finché dura l’atmosfera eroica, lo stato di emergenza, può sembrare che tutto cambi: ma, quando sopraggiunge la pace, le vecchie realtà si ristabiliscono in un battere di ciglia. Lo si è visto già in Algeria dove le donne fecero la Resistenza con coraggio inaudito e dopo ricaddero svelte nel buio. Chi comanda oggi in Algeria? Gli uomini o le donne? Che autorità hanno le Rascide che un tempo piazzavano le bombe? Perfino gli ex guerriglieri hanno quasi sempre sposato fanciulle all’antica, senza alcun merito militare o politico. Maometto dura: dura più di Confucio. Sicché tutto fa credere che i palestinesi, pur essendo tra gli arabi più europeizzati e moderni, commettano in futuro la stessa scelta o ingiustizia degli algerini: «Brave, bravissime, sparate, aiutate, ma poi via a casa». Ma, sotto sotto, le loro donne lo sanno e, poiché la Storia non offre solo l’esempio dell’Algeria, corrono fin da ora ai ripari. Come? Buttandosi dalla parte di coloro che abbracciano l’ideologia della Cina maoista: cioè il Fronte Popolare di George Abash. In Cina le donne non sono mica tornate a lavare i piatti; stanno anch’esse al potere, hanno vinto. Per vincere è necessario annullare ogni sentimento, incendiare le case dei vecchi, gli ospedali dei bambini, il più innocuo supermarket? E va bene. Per vincere è necessario imbruttirsi, sacrificare i genitori, credere nel socialismo scientifico, rendersi odiose? E va bene. Ciò che conta è non ricadere nel buio come le algerine, quando la pace verrà. Ciò che conta è non rimettere il velo quando gli uomini saranno in grado di cavarsela, come sempre, da soli. Può sembrare un paradosso, e forse lo è. Ma vuotando quei due bussolotti di marmellata e ficcandoci dentro esplosivo, Rascida non fece che comprarsi il domani. In fondo le ventisette creature che essa maciullò a Gerusalemme morirono perché lei si togliesse per sempre il velo e lo trasferisse sul volto dolcissimo del suo fidanzato, l’ignaro Thaer. Amman, marzo 1970 (Tratto da Intervista con il potere, Rizzoli 2009)
"Decapitazioni e orrore, Medusa tra di noi". Il sentimento di Marco Belpoliti per il 2015. Il suo sguardo era scomparso da secoli dall’iconografia collettiva, ma le immagini con le decapitazioni dell’Isis lo hanno fatto tornare. E di nuovo ci pietrifica. Lo scopo dei carnefici non è solo quello di uccidere, bensì d’infierire sul corpo. Esattamente come accadeva nei supplizi precedenti l’Illuminismo, scrive Marco Belpoliti “L’Espresso” Il primo è stato il fotoreporter americano James Foley. Poi nell’arco di un mese sono stati decapitati un altro reporter statunitense, Steven Sotoff, e il cooperante scozzese David Haines. Il rito pressoché identico prevede che il condannato sia vestito di un camicione arancione, mentre il boia è in nero, con il capo e il viso occultati. Tiene in mano un coltello esibito come strumento di morte. La decapitazione ha generato un immediato senso di orrore lasciando attonita l’intera platea televisiva occidentale. Le immagini della decollazione sono state viste da milioni di persone e commentate da giornali, televisioni, siti internet. Basta? No. Pochi giorni fa la notizia che un commando di talebani pakistani entra in una scuola a Peshawar e uccide a freddo 132 bambini e i loro insegnanti, per poi essere a loro volta uccisi dalle forze di sicurezza. L’orrifico è entrato nelle case degli abitanti dell’Europa e dell’America. Qualcosa che era scomparso da due secoli almeno dalle piazze del Vecchio Continente ha fatto così la sua cruenta riapparizione - per quanto negli ultimi anni ci siano state molte altre decapitazioni, per esempio nelle guerre combattute nell’ex Jugoslavia così come in altri sequestri di ostaggi. Basti ricordare il reporter americano Daniel Pearl, sequestrato in Pakistan e decapitato nel 2002, e il giovane imprenditore Nicholas Berg in Iraq nel 2004: ma non sempre furono così platealmente visibili all’opinione pubblica, e soprattutto non prevedevano la “serializzazione” che caratterizza orrendamente le decapitazioni di oggi. Che appaiono quasi come puntate di una atroce serie, in cui ciascun episodio contiene l’annuncio del successivo. All’inizio del suo volume “Sorvegliare e punire” (1975) Michel Foucault racconta un supplizio, tratto dalla “Gazzetta di Amsterdam”, cui è condannato il 2 marzo 1757 tale Robert-François Damiens. Il suo corpo è squartato tra terribili tormenti sulla pubblica piazza a opera di sei cavalli, che tirano le membra da parti opposte. Nell’arco di pochi decenni da quella data in Europa si smette di amputare, fare a pezzi e marchiare i condannati; il corpo non è più oggetto dello spettacolo pubblico, così da scomparire come “principale bersaglio della repressione penale”. Salvo poi fare la sua terribile ricomparsa con il Terrore, attraverso l’uso della ghigliottina e delle teste mozzate esibite, ancora sulle piazze, durante la Rivoluzione francese. Nel sistema giuridico americano, dove tutt’ora esiste la pena di morte cancellata invece in Europa, ha ricordato di recente Giorgio Mariani, è contemplata l’uccisione del condannato mediante una iniezione letale, sistema indolore e privo di spettacolarità. Nella cultura puritana di quel Paese, almeno sul suo territorio, è respinta come barbara ogni forma di decollazione: la testa non può e non deve essere separata dal corpo, il quale va conservato nella sua integrità nel momento in cui viene eseguita una sentenza di morte. L’orrore che hanno suscitato i filmati dell’Isis proviene anche da questa tradizione, oltre che dal culto del corpo che negli ultimi settant’anni si è diffuso in Occidente. Questo nonostante che nei decenni passati in Europa, come in altri luoghi del Pianeta, siano accaduti fatti terribili, le guerre e i conseguenti massacri della ex-Jugoslavia, o le vicende del genocidio in Uganda, con amputazioni, decapitazioni, squartamenti. In Europa la decapitazione degli ostaggi americani e inglesi nelle mani dei membri dell’Isis sono state vissute come un ritorno al passato, a pratiche medievali, barbariche. Questo nonostante che nella nostra tradizione iconografica sia ben presente l’immagine della decollazione, quella di san Giovanni Battista, o quella di Giuditta nei confronti di Oloferne, come ci ha ricordato non molti anni fa la mostra allestita da Julia Kristeva al Museo del Louvre, poi raccolta in “La testa senza il corpo” (Donzelli). C’è persino un santo, San Dionigi, protettore di Parigi, il cui miracolo è consistito nel mettersi sotto braccio la propria testa tagliata, per mano dei soldati romani, e risalire la collina che prende ora il suo nome nella capitale francese. Per quanto espunto dalla nostra giustizia, l’orrore ritorna continuamente nelle nostre cronache. Si è letto solo pochi giorni fa di una madre che avrebbe ucciso il proprio bambino. L’orrore è cosa ben diversa dal terrore che con gli atti di decapitazione l’Isis vorrebbe provocare nel mondo occidentale, qualcosa di più profondo e radicale. La parola “orrore”, ricorda Adriana Caravero, viene dal verbo latino horreo, di incerta etimologia ma di sicuro significato: indica il rizzarsi dei peli del corpo, il suo tremolio per via dello spavento. Secondo uno studio, a rizzarsi sarebbero i capelli, azione inconsueta ma possibile, che si conserverebbe nel significato della parola italiana “orripilante”. La filosofa nel suo libro “Orrorismo” (Feltrinelli), il cui titolo costituisce un neologismo, sostiene che esiste una “fisica dell’orrore”, collegata a quella dell’agghiacciarsi, reazione fisiologica al freddo, che provoca la cosiddetta “pelle d’oca”. Sono tutti stati del corpo che colpiscono chi è esposto a spettacoli orripilanti. Primo Levi, all’inizio della “Tregua”, descrive la reazione dei giovani soldati russi che raggiungono il Lager dove il deportato si trova nel gennaio del 1945. I russi osservano dall’alto dei loro cavalli lo spettacolo bestiale dei cumuli dei cadaveri abbandonati dai nazisti in fuga. Orrore e insieme ripugnanza, qualcosa di diverso dalla paura, una forma di ribrezzo che in un libro, “Poteri dell’orrore” (Spirali), Julia Kristeva ha definito “ribrezzo”. C’è una figura classica che incarna perfettamente l’orrore di cui si parla: Medusa. La sua visione agghiaccia, paralizza, pietrifica. L’orrore è tale che chiunque ne fissi il viso - gli occhi, lo sguardo, ma anche i capelli a forma di serpenti come l’ha dipinta Caravaggio - viene trasformato in roccia. Quelle che si presentano al nostro sguardo nei film rilasciati nel web dai carnefici dell’Isis sono immagini inguardabili, ripugnanti, che fanno ribrezzo. Lo scopo di questi carnefici non è solo quello di uccidere, bensì d’infierire sul corpo, esattamente come accadeva nei supplizi che precedono le riforme penali prodotte dall’Illuminismo nel diritto occidentale. Si vuole distruggere l’unità del corpo provocando negli spettatori l’orrore. Più questo, ribadisce Caravero, che non il terrore. C’è un’altra figura mitologica che viene spesso evocata proprio per definire l’altro aspetto dell’orrore, cui ci hanno abituato le cronache recenti: Medea. Ripudiata da Giasone a vantaggio della figlia del re di Corinto, Medea uccide i suoi figli per vendetta, come racconta Euripide nella tragedia. Lei, che aveva aiutato il suo uomo a conquistare il Vello d’oro, diventa il modello degli infanticidi a seguire. In una versione del mito citata da Károly Kerényi, Medea taglia a pezzi i corpi delle sue vittime, evocando così la fantasia orripilante dello smembramento. Adriana Cavarero sottolinea come non esista un analogo mito maschile per descrivere l’orrore dell’uccisione dei propri congiunti, e come l’orrore dell’infanticidio sia ascritto alla madre quale segno di una follia estrema. Per riscattare Medea, o almeno cercare di capire l’orrore che la abita, la filosofa ricorda un episodio presente nel libro di W. G. Sebald, “Storia naturale della distruzione” (Adelphi), dedicato ai bombardamenti con cui gli Alleati distrussero le città tedesche nel corso del Secondo conflitto mondiale. Durante una fuga dalle tempeste di fuoco, a una donna si aprì di colpo la valigia che recava. Non conteneva gioielli o oggetti, ma il cadavere di suo figlio. Sebald riporta altri casi in cui le madri recarono con loro nella fuga corpi di bambini soffocati dal fumo o uccisi dai bombardamenti. Nella disperazione, scrive l’autrice, in cui l’orrore le aveva immerse, queste donne cercavano di curare le loro inermi creature oltre la stessa morte. Un modo per salvare i corpi dall’orrore terribile di quella distruzione. Davanti all’orrore delle immagini trasmesse dal web o sui canali televisivi, riportate nelle pagine dei giornali sotto forma di fotografie, a Gaza come in Afghanistan, in Cecenia come in Siria, possiamo decidere legittimamente di distogliere lo sguardo, cambiare canale, girare pagina, per non restare paralizzati, pietrificati da quello che si vede. Per quanto evochino qualcosa di pornografico – piacere morboso insieme all’orrore, com’è stato giustamente detto – non possiamo esimerci dal sapere che queste immagini hanno un valore etico, come ci ha ricordato Susan Sontag in “Davanti al dolore degli altri” (Mondadori). Fanno sorgere domande decisive e ci rendono consapevoli del fatto che esseri umani commettono cose terribili nei confronti di altri esseri umani. Cavarero la chiama “la violenza sull’inerme”, ed è questo il vero orrore che suscitano in noi.
Fatwa e morte. Così uccidono la satira, scrive Simone Di Meo su “Il Tempo”. Si dice che quando l'uomo con la penna incontra l'uomo con la pistola, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Si dice, però. Perché la scia di sangue che ha macchiato libri, pellicole e paginate di giornale fresche d'inchiostro è ben più lunga di quella freschissima lasciata sulle vignette di Charlie Hebdo. Il settimanale che, ironia del destino, nel 2006 aveva deciso di mandare in edicola per solidarietà, insieme a numerosi quotidiani europei, anche italiani, le caricature di Maometto pubblicate l'anno prima sul quotidiano danese Jyllands-Posten e successivamente sul giornale norvegese Magazinet. In uno dei disegni, il profeta dell'Islam era raffigurato con una bomba al posto del turbante (il vignettista Kurt Westergaard da allora vive sotto costante protezione della polizia e solo per miracolo i tentativi di assassinio ai suoi danni non sono riusciti). Alla pubblicazione di quelle immagini, successe il finimondo: dall'Africa, al Medioriente, all'Afghanistan, all'Indonesia esplosero le proteste di piazza. In Nigeria morirono 130 persone negli scontri. A quel punto, il premier norvegese Anders Fogh Rasmussen all'inizio del 2006 raggiunse un accordo con la Lega Araba per la distribuzione di una lettera che era sostanzialmente di scuse e che, pur difendendo il principio della libertà di espressione, stigmatizzava la «demonizzazione» di alcuni gruppi in base all'appartenenza religiosa ed etnica. Il 30 gennaio giunsero le scuse anche del direttore del Jyllands-Posten. L'8 febbraio, una provocazione dell'allora ministro leghista Roberto Calderoli legata alle vignette incriminate, portò ad una violenta protesta in Libia e ad un attacco al consolato italiano di Bengasi, nel quale morirono 11 manifestanti. Ancor prima, il 2 novembre del 2004, c'era stato l'omicidio di Theo van Gogh, il regista olandese di “Submission”, un cortometraggio che aveva fatto scandalo nel mondo islamico per la scelta di scrivere dei versi di una sura del Corano sulla schiena della protagonista. L'assassino, Mohammed Bouyeri, in possesso della doppia cittadinanza olandese e marocchina, intercettò van Gogh nel centro di Amsterdam, esplodendo contro di lui otto colpi di pistola. Gli tagliò anche la gola e gli piantò nella pancia due coltelli, in uno dei quali era conficcato un documento contenente minacce ai governi occidentali, agli ebrei e ad Ayaan Hirsi Ali, deputata di origini somale ed autrice del film insieme a van Gogh. Il film fu ritirato e anche il produttore, Gijs van Vesterlaken, subì gravi minacce. Fino ad allora, l'unica condanna a morte nei confronti di un intellettuale inviso al regime islamico risaliva al 1989 ed era stata spiccata nei confronti dello scrittore britannico di origine indiana Salman Rushdie, all'epoca già una star affermata della narrativa internazionale. Nel suo libro, “I versetti satanici”, aveva fatto allusivamente riferimento alla figura del profeta Maometto. Fu per questo che a febbraio di quell'anno l'ayatollah Khomeini emanò una fatwa nella quale condannava a morte Rushdie, colpevole, a giudizio della massima autorità iraniana, di bestemmia. I killer non riuscirono a trovarlo ma nel 1991, fu accoltellato a morte da uno sconosciuto il traduttore giapponese dell'opera, Hitoshi Igarashi; e nello stesso anno, fu ferito anche il traduttore italiano, Ettore Capriolo, mentre nel 1993 fu la volta dell'editore norvegese del libro. Dopo la morte di Khomeini, la fatwa fu confermata nel 2005 dall'ayatollah Ali Khamenei, ma lo stesso Rushdie ammise che la condanna a morte aveva ormai un valore più retorico che reale. Anche se, nel 2012, lo scrittore fu costretto a rinunciare alla partecipazione al festival internazionale di letteratura di Jaipur, in India. I fanatici della Mecca erano tornati a farsi vivi.
Giannelli: «Non sapremo reagire La nostra società si è assuefatta al peggio», scrive “Luca Rocca su “Il Tempo”. L’uccisione dei giornalisti satirici del Charlie Hebdo, a Parigi, non sorprende Giannelli. Di una cosa il vignettista appare certo: stanno cercando di intimidirci. Ed è anche convinto, inoltre, che l’Occidente sia così assuefatto al peggio, che neanche di fronte a una strage di questa portata sarà in grado di reagire.
Giannelli, tre terroristi imbracciano un kalashnikov e colpiscono al cuore la nostra libertà.
«In questo mondo non mi stupisce più niente. La barbarie del nostro tempo supera qualsiasi immaginazione. Chi mai, fino a pochi anni fa, poteva immaginare che saremmo entrati in un tunnel così buio? Bisognerebbe scavare a fondo alla vicenda, capire le radici di questo odio, da dove proviene».
Nella sua carriera, si è mai imbattuto nell’intolleranza dell’Islam?
«Tanti anni fa, quando collaboravo con Repubblica, io e Forattini fummo convocati da Eugenio Scalfari, il quale ci raccomandò di andarci cauti con le vignette sull’Islam. Ho pensato che avesse ricevuto messaggi allarmanti. Personalmente però non ho mai ricevuto minacce».
Perché colpire la satira?
«L'integralismo islamico è intolleranza all'ennesima potenza, non riguarda solo la satira. Ma è vero che verso lo humor l’Islam ha una chiusura ermetica. Credo, però, che un attacco come quello al Charlie Hebdo rappresenti soprattutto un’intimidazione. Dopo una strage come quella avvenuta in Francia, infatti, anche se inconsciamente, prima di pubblicare un'altra vignetta contro Maometto, ci pensi due volte».
Saremo capaci di reagire?
«Io sono vecchio, ero ottimista e non lo sono più. Ho la sensazione che le reazioni della nostra società siano sempre meno frequenti. Siamo capaci di assuefarci a tutto. Ciò che un tempo ci sarebbe sembrato enorme, adesso ci appare quasi accettabile».
Quello di ieri è l’11 settembre della stampa?
«In un certo qual modo è così, ma non vedremo la stessa reazione vista dopo l’attacco del 2001 alle Torri Gemelle. E sa perché? Perché sono passati più di 10 anni, e lentamente ci siamo abituati a ogni efferatezza».
Krancic: «Per proteggere l’Islam l’Occidente si sta suicidando» , scrive “Il Tempo”. È una tappa del suicidio dell’Occidente. A dirlo, nel giorno in cui gli integralisti islamici assaltano il cuore dell’Europa uccidendo dei disegnatori di satira che la loro «libertà di matita» la indirizzavano anche contro Allah, è uno dei maggiori vignettisti italiani, Alfio Krancic, che si dice sconvolto.
Qual è stato il suo primo pensiero alla notizia della la strage nella redazione del Charlie Hebdo?
«Sono ancora frastornato. Aver colpito un settimanale simbolo della trasgressione satirica, è indicativo del clima di odio che si è scatenato verso le manifestazioni di libertà dell'Occidente».
Lei ha mai realizzato vignette sull'Islam?
«Certo, anche sull’Isis e il “califfo nero” al Baghdadi, prendendo sempre le parti di Assad, Gheddafi, Saddam. Meglio quei regimi arabi laici che salvaguardano le altre religioni e ci proteggono dal fanatismo islamico. Perché quando in quei paesi le dittature cadono, non arriva la democrazia. E lo dimostra anche l'attentato in Francia».
Hai ricevuto minacce per quelle vignette?
«No. In Italia, fortunatamente, la minaccia islamica non ha mai preso di mira la satira, ma qualche giornalista, come Magdi Allam, o qualche politico, come Roberto Calderoli, rei di avere idee non in linea con il pensiero islamico e di manifestarle come desiderano».
Perché la satira sull’Islam provoca morte?
«La colpa è anche del politicamente corretto. Corretto unilateralmente, visto che protegge alcune espressioni religiose, come l'Islam, ma non la nostra religione, il cristianesimo. Una forma sadomasochistica ha pervaso le menti dell'Occidente. Siamo persino arrivati a contemplare il reato di islamofobia. L'Occidente si sta suicidando».
Un massacro come quello di ieri può segnare la fine del multiculturalismo in Europa?
«È molto difficile. Le forze culturali e intellettuali che dominano in Europa sono troppo forti. Impediranno ad alcuni movimenti politici e culturali di prendere il sopravvento sul multiculturalismo. Al contempo, però, la strage inevitabilmente aumenterà l'intolleranza verso gli intolleranti».
Vauro: «Difendo il diritto al gioco della libertà e alla libertà del gioco», scrive Massimiliano Lenzi su “Il Tempo”. «La satira è tale perché da sempre sbeffeggia i potenti ed i prepotenti». Vauro, vignettista e satirico a sinistra da una vita (da Il Manifesto a Servizio Pubblico, su La7) - che trent'anni e passa fa, come racconta a Il Tempo, «ha lavorato pure al Charlie Hebdo» - il giorno dopo l'attentato dei fondamentalisti islamici al giornale satirico francese, è sconvolto ed addolorato. «Sono fuori di me, perché la satira è la libertà assoluta e nessuno deve violentarla. Mai. Perché la satira è da sempre contro tutti i tipi ed ogni forma di fondamentalismi».
Gli chiediamo cosa, secondo lui, toscano che attinge la propria ironia da Cecco Angiolieri in avanti, rappresenti per le nostre libertà ciò che è successo a Parigi.
«Si è colpita un'arte – risponde –, la satira, che è la cosa meno violenta che si possa immaginare perché qualsiasi tema affronti è sempre un gioco. C'è sempre un elemento di gioia e di poesia nell'ironia satirica e l'irruzione di una violenza così assurda e demente incarna un attentato contro la fantasia degli uomini e delle donne. È come se i terroristi assassini avessero fatto irruzione durante l'ora di ricreazione in una scuola, compiendo una strage efferata di bambini, Erodi contro ogni libertà, perché vede, la satira ha sempre una propria componente infantile. E poi devo dirle che che c'è un'altra cosa, ancora, che mi preoccupa...».
Che cosa?
«Quello che mi preoccupa è che sento già parlare di scontri e di guerre di religione. Io – aggiunge – vorrei sperare che la satira non diventi arruolabile da nessuno, mai. Vede, sui social media ieri mi sono arrivati inviti a fare vignette contro Maometto, per dimostrare di avere le palle. Ma io non credo si possa fare satira per dimostrare di avere le palle, perché la forza del ridere deve essere più forte della fine, anche della morte. Quello che voglio ostinatamente difendere, continuare a difendere, è il diritto al gioco della libertà ed alla libertà del gioco. Perché dopo l'attentato vigliacco di Parigi al Charlie Hebdo siamo tutti meno liberi. Ed anche meno felici».
Vincino: «L’Islam non c’entra? Certi soloni vadano a quel paese», scrive ancora Lenzi. «La cosa tragica e divertente, sa quale è? È ascoltare certi Soloni dire che l'Islam non c'entra niente, perché è buono e non c'entra che i killer, uccidendo, hanno gridato di vendicare Maometto, con la frase di rito "Allah akbar": ma andate tutti quanti a quel paese, ipocriti!». Vincino, vignettista de Il Foglio ed anticonformista da una vita intera, non si rassegna all'ecatombe delle libertà che si è consumata ieri nel cuore di Parigi, e alla mollezza di certe reazioni italiane ed occidentali. «Ieri hanno centrato ed ucciso un posto come verità, e non come simbolo. Perché il Charlie Hebdo era il luogo dove è nata la libertà di satira in Europa, ed anche la mia. "Il Male" con i suoi autori nacque anche grazie a loro, tutte la rubriche delle copertine rifiutate ad esempio, una colonna straordinaria con 4 vignette terribili in cui potevi mettere le cose più libere ed inimmaginabili». Poi Vincino si sofferma sulle persone, e spiega che «all'interno di Hebdo trovavi poeti veri, come Georges Wolinski, figlio di un polacco e di un'italiana emigrati in Tunisia, un poeta dell'amore e del sesso. E vedere Wolinski morire durante una riunione di satira mi commuove». Perché Vincino, sulla satira, come spiega al nostro giornale, «ha fatto un festival, a Roma, all'epoca di Nicolini. Wolinski era come tutti i veri umili, semplice e generoso. Ma liberi totalmente. E questo vale per il Charlie Hebdo, che perciò va a cozzare con le religioni. Sempre. Poi, oggi, ci sono le religioni che sono un po' più buone ed altre in alcune parti del mondo, più cattive. Cattivissime. L'Hebdo non ha mai ceduto un centimetro sulla vivisezione delle religioni, sia cattolica che islamica. Avevano capito per primi la questione della libertà poste dalle vignette pubblicate dal giornale danese Jyllands-Posten su Maometto, e seguite da mobilitazione contro nei paesi arabi. Roberto Calderoli, una vignetta se la mise su una maglietta sotto la giacca. Noi, comunque sia, speriamo di non finire mai in una maglietta di Calderoli ma quello che ieri è stato attaccato sono l'illuminismo e la nostra civiltà».
Ecco i nomi delle dodici vittime dell'attacco del 7 gennaio 2015 alla redazione di Charlie Hebdo:
- Stephane Charbonnier, alias Charb, vignettista e direttore;
- Georges Wolinski, vignettista;
- Jean Cabut, alias Cabu, vignettista;
- Bernard Verlhac, alias Tignous, vignettista;
- Philippe Honoré, vignettista;
- Bernard Maris, economista ed editorialista;
- Elsa Cayat, psicologa e giornalista;
- Michel Renaud, ex consigliere del sindaco di Clermont Ferrand;
- Mustapha Ourrad, correttore di bozze;
- Fréderic Boisseau, addetto alla portineria;
- Franck Brinsolaro, poliziotto;
- Ahmed Merabet, poliziotto.
Decapitato l’umorismo francese. Quattro celebri vignettisti tra le vittime: Charb, Cabu, Tignous e Wolinski Sull’ultimo numero la caricatura di un terrorista: «Gli auguri entro gennaio», scrive Antonio Angeli su “Il tempo”. Cinque minuti di puro terrore, un muro di piombo e fuoco: alla fine in terra, senza vita, restano in 12. Parigi e il mondo piangono il più grave e sanguinoso atto di terrorismo degli ultimi anni: sono rimasti uccisi 8 giornalisti, 2 agenti, un ospite della redazione e il portiere dello stabile. Delle vittime alcuni sono celebri: vignettisti, inguaribili umoristi, di quelli che se cerchi di mettergli il bavaglio diventano più tenaci, e gli è costata cara, soni diventati bersaglio di una violenza inaudita; una strage che ricorda quella all’inizio di un vecchio film di spionaggio: «I tre giorni del Condor».
Ucciso il direttore del settimanale satirico parigino «Charlie Hebdo», Stéphane Charbonnier detto «Charb» , celebre disegnatore satirico, classe 1967, in passato già minacciato più volte per le vignette su Maometto, e per questo messo sotto la protezione della polizia. Non gli è servito, non è stato sufficiente. Nel numero uscito proprio la scorsa settimana c’è la sua ultima vignetta, profetica e agghiacciante, ora che si è consumato il massacro. Il titolo dell’illustrazione: «Ancora nessun attentato in Francia», sotto il pupazzetto che raffigura un terrorista islamico, con la barba e il mitra sulle spalle, che dice: «Aspettate! Abbiamo tempo fino alla fine di gennaio per fare gli auguri». Caduti sotto il fuoco dei terroristi i tre più importanti vignettisti della testata: Cabu, Tignous e Georges Wolinski, molto famoso anche in Italia, da anni. Nell’attentato è rimasto ucciso anche l’economista Bernard Maris, azionista della testata parigina.
Jean Cabut meglio noto come Cabu , 76 anni, antimilitarista e di spirito anarchico, ha collaborato con tutte le principali testate francesi come caricaturista e disegnatore di fumetti. Attualmente disegnava sia per «Charlie Hebdo» che per il suo principale concorrente, «Le Canard Enchainé». Per «Pilote», una delle principali riviste francesi di fumetti, aveva creato il personaggio del «Grand Duduche», liceale maldestro. Era il padre del cantante Mano Solo, morto di malattia nel 2010. Charb, 47 anni, disegnatore satirico, collaborava anche con il quotidiano del partito comunista «L’Humanité» e due delle principali riviste francesi di fumetti, «Fluide Glacial» e «L’Echo des Savanes». Sue le strisce, irriverenti e al limite del pornografico, del cane Maurice, bisessuale e anarchico, e Patapon, gatto asessuato e fascista.
Ucciso anche Bernard Verlhac, detto Tignous , 57 anni. I suoi disegni venivano pubblicati da «Charlie Hebdo», «Marianne» e «Fluide Glacial».
E poi c’era il più famoso di tutti, fumettista e vignettista noto, non solo in Francia, ma anche in Europa, per il suo caratteristico taglio caustico nel rappresentare la quotidianità. È Georges Wolinski , con «Charlie Hebdo» collaborava da anni. Nato a Tunisi il 28 giugno del ’34, Wolinski aveva esordito come disegnatore per la rivista «Hara-Kiri», dalla quale era poi passato a «Action», «Paris-Presse», «Hara-Kiri Hebdo», «L’Humanité», e infine «Paris-Match». Attualmente era anche capo redattore di «Charlie Mensuel». Wolinski aveva ottenuto la popolarità con i fatti del maggio del ’68, attraverso la rivista «Action». La sua cifra stilistica era costituita dalla capacità di porre l’accento sui personaggi, dall'ampio uso di doppi sensi, anche sessuali - tanto da farlo conoscere a molti come l'umorista del sesso - e dal taglio caustico nel rappresentare il cinismo quotidiano. Il fumettista era anche noto per avere collaborato, negli anni ’70, con Georges Pichard creando il personaggio di Paulette.
Bernard Maris era invece un professore d’economia allo Iep di Tolosa e attualmente insegnava anche all’Istituto di studi europei dell’università Parigi-VIII. Il 68enne era anche una firma per diversi giornali, come «Le Monde», «Le Figaro Magazine» e «Le Nouvel Observateur». Del settimanale satirico era stato uno dei fondatori, con l’11% delle azioni, e fino al 2008 direttore aggiunto. Era uno dei principali studiosi della globalizzazione «etica e sociale». Un grande intellettuale francese, tra le sue attività, anche la scrittura, con la pubblicazione di diverse opere letterarie.
Non tutte le firme del settimanale satirico sono state messe a tacere. È una carneficina che «ha decapitato» il settimanale, come succede in «Siria e in Iraq»: così ha reagito Bernard «Willem» Holtrop, vignettista di «Charlie Hebdo», scampato all’assalto che ricorda che le vittime «non sono dei colleghi, sono degli amici». E la carneficina del settimanale parigino ha scatenato una silenziosa, gigantesca reazione, a livello mondiale. In Francia tantissime persone sono scese in strada con un cartello: «JeSuisCharlie», «Io sono Charlie», con il chiaro riferimento alla testata. L'ambasciata americana a Parigi ha anche cambiato la sua icona Twitter in #JeSuisCharlie, in segno di sostegno alla Francia. «La libertà di espressione è un diritto umano», ha twittato Amnesty Italia.
Charlie Hebdo, una storia di satira irriverente. La testata è nota per le vignette e illustrazioni, ma anche per gli articoli incentrati su politica, cultura, estrema destra, cattolicesimo, islam e giudaismo, scrive “Il Tempo”. Charlie Hebdo è un settimanale satirico di tradizione libertaria, dal tono irriverente e anticonformista. Il giornale difende le libertà individuali e ha un orientamento di sinistra, fortemente anti religioso. Charlie Hebdo è noto per le vignette e illustrazioni, ma anche per gli articoli incentrati su politica, cultura, estrema destra, cattolicesimo, islam e giudaismo. Anche se prende di mira principalmente i politici di destra, il settimanale non risparmia neanche i partiti di sinistra francesi. Secondo l'attuale direttore, il disegnatore Stéphane Charbonnier, noto come Charb, il giornale riflette "tutte le componenti del pluralismo di sinistra e perfino dell'astensionismo".
Nel 2006 il giornale suscitò polemiche pubblicando una serie di caricature del profeta Maometto, diffuse inizialmente dal quotidiano danese Jyllands-Posten. Nella settimana precedente le illustrazioni avevano suscitato proteste in alcuni Paesi musulmani. Diverse organizzazioni musulmane francesi, tra cui il Consiglio francese del culto musulmano, chiesero di seguito di mettere al bando il numero del settimanale contenente altre caricature di Maometto, ma la richiesta non fu accolta.
Nel 2011 la sede del giornale venne colpita da alcune bombe molotov; l'attacco fu lanciato prima dell'uscita nelle edicole di un numero con in copertina un'altra vignetta satirica con Maometto. Il sito web del settimanale fu invece preso di mira da hacker. La storia di Charlie Hebdo comincia negli anni '60 ed è strettamente legata a quella del mensile Hara-Kiri, lanciato da Georges Berniere e François Cavanna, e definito da loro stessi "un giornale stupido e cattivo".
La rivista fu al centro di diverse polemiche e fu interdetta dalla magistratura nel 1961 e poi nel 1966. Trasformata successivamente in settimanale, a novembre del 1970 la rivista suscitò critiche dopo la morte di Charles de Gaulle, titolando in copertina "Bal tragique à Colombey - un mort", ossia 'Ballo tragico a Colombey, un mortò, con un riferimento alla residenza del generale. Di seguito le pubblicazioni di Hara-Kiri vennero bloccate dal ministero dell'Interno francese, ma i giornalisti aggirarono il divieto lanciando una nuova pubblicazione, Charlie Hebdo, che deve il nome al famoso personaggio del fumetto Peanuts. Il settimanale rimase chiuso tra il 1981 e il 1992 dopo un calo del numero di lettori. Prima di Charb a guidarlo furono François Cavanna e Philippe Val. La rivista è pubblicata ogni mercoledì.
Matite satiriche. Satiriche come le penne di sinistra che alzano le sopracciglia quando si parla di satira di destra.
Charlie Hebdo, parlano Staino, Altan, Vauro e Makkox: «La satira non si fa intimidire». Dopo l'attentato al giornale satirico francese, che ha causato dodici vittime, parlano alcuni dei più celebri fumettisti italiani. Che piangono gli amici scomparsi e dicono: "Questi omicidi devono far crescere la nostra voglia di contrastare l'oscurantismo", scrive Daniele Castellani Perelli su “L’Espresso”. Hanno la voce rotta. Cercano le parole giuste. Promettono che nulla cambierà nel loro lavoro, ma temono che niente sarà più come prima. Alcuni dei più noti vignettisti italiani, da Staino a Altan, da Vauro a Makkox, commentano al telefono con “l'Espresso” la tragedia parigina, l'assalto al giornale satirico “Charlie Hebdo”.
Il dolore più grande è quello di Sergio Staino, che nell'attacco ha perduto un amico, il disegnatore Georges Wolinski. «La mia prima reazione è stata di andare a vedere se tra le vittime ci fosse Georges. Lo reputavo improbabile, visto che non lavora all'interno della redazione. E invece hanno ammazzato anche lui, significa che sapevano che oggi era prevista la riunione», racconta Staino: «Avevo conosciuto Wolinski all'inizio degli anni Ottanta, quando ero andato a visitare la redazione di “Charlie Hebdo” a Parigi. Poi era stato più volte mio ospite, e aveva anche partecipato a un mio film del 1992, “Non chiamarmi Omar”, con Ornella Muti, ricordo che si era innamorato di Stefania Sandrelli». Staino, storico disegnatore dell'“Unità”, ha fatto vignette su Hamas e l'Islam politico, ma mai sulla religione musulmana in sé. Tuttavia ha sempre difeso il diritto alla libertà di espressione, anche quando, dice, «le vignette erano artisticamente di scarso valore, come quelle su Maometto, una peggiore dell'altra, pubblicate in Danimarca dallo“Jyllands Posten”». La cosa che più lo colpisce è che i terroristi abbiano voluto colpire i più deboli: «Non sono andati a colpire che ne so la Cia, ma dei vignettisti. È come attaccare la Croce Rossa, è una cosa da vigliacchi». E ora? Cambierà qualcosa nel mondo della satira? I vignettisti si autocensureranno? «No, non succederà mai», risponde Staino: «La nostra molla sono la ricerca della verità, lo sberleffo dei fondamentalisti, il dubbio, l'antidogmatismo. Questi omicidi accresceranno la nostra voglia di contrastare l'oscurantismo».
È d'accordo anche Vauro, storica matita del “Manifesto” prima e di “Servizio pubblico” e “Annozero” poi. «Non credo che reagiremo con quella forma tremenda di censura che è l'autocensura. Noi che viviamo di satira siamo, che piaccia o no, degli istintivi. In noi domina quell'elemento ludico, infantile, anche inopportuno come spesso sono inopportuni i bambini, un elemento che non si fa intimorire dalle minacce di un gruppo di intolleranti». Vauro conosceva Wolinski, e dice di essere rimasto annichilito davanti alla notizia dell'attacco. Lo hanno colpito molto anche certi inviti che gli sono arrivati sui social network, che gli dicevano «Ora disegna Maometto se hai le palle». «Io ho disegnato Maometto, e ho anche “affrescato” i muri dell'ospedale di Emergency a Kabul al tempo dell'oscurantismo talebano. Non mi farò fermare dai fondamentalisti islamici, ma non devo neanche dimostrare niente a nessuno».
Anche Francesco Tullio Altan, storico vignettista di “Espresso” e “Repubblica”, ha perso degli amici oggi. Non nasconde che ora possa diventare più difficile, per un vignettista, ironizzare sull'Islam, ma non crede che l'attacco sia da intendersi contro il mondo della satira: «Come gli attentati alle metropolitane o ai treni, questo non è che un episodio della grande guerra contro la libertà in generale».
Makkox, infine. Il disegnatore del “Post” e di “Gazebo” ammette di aver sentito crescere in sé una rabbia davanti alla notizia. «Quei nomi, quei colleghi di cui a casa ho i libri...», dice incredulo, per poi confessare il suo tormento interiore: «Oggi cambia tutto. Questo attacco ci radicalizzerà tutti, spingerà tutti noi a essere manichei, è come una chiamata alle armi. Il discorso pubblico verrà sconvolto. Da un lato vorrei dire liberamente che non mi piacciono le vignette contro Maometto o Gesù, che non le trovo efficaci, che il problema sono l'Isis e i preti pedofili e non le religioni, però poi penso subito che un'opinione così non potrò più esprimerla, perché potrei essere accusato di stare dalla parte dei “nemici”. Dall'altra la rabbia che provo mi spinge a prendere posizione, a non tirarmi indietro». La satira si farà più cauta? «Sì farà magari meno cauta, si radicalizzerà, il rischio è che perderemo tutti un po' il senso critico, vincerà l'estremista che è in noi, mentre proprio ora avremmo bisogno di essere razionali».
Tutti sono consapevoli dei tanti rischi che si aprono. Dice Vauro: «Quello che è successo a Parigi, una vera azione militare, non deve innescare nuove guerre, non dobbiamo inventare nuovi nemici dove non ce ne sono e generare nuovi conflitti armati». Guardando all'Italia, Staino aggiunge: «Il pericolo è ora che nella vicenda inzuppino il pane i fondamentalisti di casa nostra, la destra becera e intollerante. A destra come a sinistra abbiamo bisogno che le persone più illuminate guidino il dibattito, e aiutino la parte migliore del mondo musulmano a farsi sentire».
Vauro Senesi e il "coccodrillo" per Charlie Hebdo: pioggia di insulti sui social. La doppia morale di Vauro Senesi. Va in tv con la maglia "Je suis Charlie", salvo scordarsi le sue feroci critiche alle vignette di "Charb". Su twitter infatti è scoppiata la bufera dopo il coccodrillo in diretta tv del vignettista di Santoro a Sevizio Pubblico dedicato alle vittime del massacro di Charlie Hebdo: "Parliamo ancora di guerra santa, sembra di essere nel medioevo, abbiamo fatto passi da gigante indietro nel tempo. Siamo in guerra, ma perché facciamo le guerre. Questi mostri li abbiamo creati noi", afferma Vauro da Santoro. Ma dimentica quelle sue parole di qualche tempo fa contro le vignette di Charlie Hebdo: "Questi disegni sono messaggi violenti che provocano reazioni violente". Implacabile la reazione del web: "Vauro sei un paraculo".
Criticava Charlie, ora lo piange Tutti contro il coccodrillo Vauro. Il vignettista di Santoro indossa la maglietta di solidarietà, ma quando i francesi pubblicarono i disegni anti islam li accusò di provocare "reazioni violente". E il web si scatena: "Che paraculo", scrive Luigi Mascheroni su “Il Giornale”. Sui social, che non sono la rappresentazione del mondo, ma ne incorniciano comunque un pezzo, c'è chi ricorda che le vignette contro i cristiani non hanno mai prodotto vittime, ecco la differenza tra noi e loro: «Bella la vita Vauro, neh!». C'è chi spegne la tv, perché non può sopportare «Vauro, Ruotolo e tutti quei quaquaraquà che ora alzano le matite al cielo, ma fino a ieri invece...». C'è chi non si ricorda, fino l'altro giorno, vignette di Vauro sull'Islam, e chi ricorda invece che Vauro attaccò le vignette danesi anti-Maometto perché, disse, «messaggi violenti provocano reazioni violente». C'è chi ironizza sul fatto che ora «in Italia aspettiamo la risposta di Vauro, che con sprezzo del pericolo farà una vignetta molto aggressiva. Su Berlusconi o Renzi». E chi, esagerando come solo Twitter è capace di esagerare, nel suo micidiale mix di sintesi e cinismo, digrigna la tastiera: «Vauro con la maglietta "Jesuischarlie", lui, amico dei terroristi islamisti...». E in effetti, l'altra sera, in una trasmissione come Servizio Pubblico di Santoro che faticava parecchio, tra distinguo e cautele, tra buonismo e correctness politica, ad avvicinare i termini «terrorismo» e «Islam», faceva impressione (per alcuni pena) vedere Vauro Senesi, in arte Vauro, in pratica un disegnatore con le sue debolezze e i suoi talenti, come tutti noi, indossare a favore di telecamera la t-shirt con la scritta Je suis Charlie . Che, si vedeva, era fuori taglia, e non solo metaforicamente. Perché a Vauro quella maglietta stava strettissima. Piange i colleghi francesi, ma nega che ci sia una guerra in corso. Condanna i terroristi, ma non dice mai «terroristi islamici». Sbuffa: «Parliamo ancora di guerra santa, sembra di essere nel Medioevo, abbiamo fatto passi da gigante indietro nel tempo», ma dimentica che i passi li ha fatti la civiltà cristiana, in avanti: e infatti per quanto ritenga esecrabili le vignette satiriche contro il Papa, Comunione e liberazione non ha mai organizzato una crociata su Parigi. Un po' troppi «ma», quando ci sono persone uccise a colpi di Ak47 in nome di Allah. Ieri, sul Corriere della sera , in un pezzo nascosto a pagina 15, non richiamato in prima né postato sul sito del quotidiano, Pierluigi Battista ha firmato un pezzo dal titolo «Vauro e gli altri che bocciarono quelle vignette "provocatorie"», smascherando l'ipocrisia di chi, come Vauro appunto o come Ruotolo, oggi piangono gli eroici giornalisti di Charlie Hebdo , ma ieri li consideravano irresponsabili, dei provocatori. E Vauro ha subito risposto su Dagospia invocando, per par condicio, la censura subita per una vecchia vignetta su Berlusconi. Perdendo sia il senso della misura sia quello del ridicolo. «Siamo in guerra, ma perché facciamo le guerre - ha detto - Questi mostri li abbiamo creati noi». La colpa, anche se a sparare sono gli «altri», è sempre nostra. Per il resto, quella che ci stanno disegnando davanti agli occhi, è una vignetta già vista tante volte. Dentro ci sono molte matite perfettamente appuntite nell'offendere il sentimento religioso cristiano, più spuntate nel farlo con i simboli musulmani. Un'unica mina, una doppia morale. E non fa ridere.
Quell'odio a ritmo di rap dove "balla" il deputato Pd. Molti dei jihadisti, tra cui uno di quelli di Parigi, cantavano le rime violente in voga nelle comunità islamiche, Italia inclusa. In un video compare l'onorevole Chauki, scrive Paolo Giordano su “Il Giornale”. Ormai non si può più. Ora che il video del killer parigino Chérif Kouachi in versione rapper ha fatto il giro del mondo (ma è stato girato nel 2005), è impossibile non riconoscere il fil rouge che collega tanti jihadisti a questa espressione musicale. Dopotutto anche il presunto carnefice dell'ostaggio decapitato James Foley è l'inglese Abdel-Majed Abdel Bary che, prima di sparire, aveva un microscopico seguito londinese come rapper. E pure qui in Italia le rime violente vanno di moda, con varie sfumature. Si va da Amir Issa che nel video Ius Music , (in cui canta «da Palermo a Torino scoppierà un casino»), ha ospitato un deputato Pd di origini marocchine (Khalid Chauki), ai rapper che incitano all'odio mortale come Anas El Abboubi, ora ventenne, arrestato a giugno 2013 per «addestramento finalizzato al terrorismo internazionale» però poi rilasciato dopo pochi giorni: adesso sarebbe ad Aleppo con il nome di Anas Al-Italy e, come si legge sul suo profilo Facebook, di professione «lavora presso la Jihad». Quand'era in Italia, lui di origini marocchine ma arrivato giovanissimo in provincia di Brescia, rappava: «Il martirio mi seduce, voglio morire a mano armata, tengo il bersaglio sulla Crociata». Hai letto bene. Dopo, dalla Siria ha annunciato, keffiah al collo e kalashnikov in mano, di aver abbracciato la sharia con i ribelli siriani. Certo i toni sono diversi, ma sempre aggressivi. Intollerabilmente. Ci sono rapper ultrafamosi come Busta Rhymes, Ice Cube, Nas, Everlast o Jay Z che hanno inserito nelle proprie rime espliciti e tolleranti riferimenti alla fede musulmana. E uno, non proprio famoso per coerenza come Snoop Dogg, si è convertito all'Islam per tre anni dal 2009 prima di passare al Rastafarianesimo. Rap islamico si può ascoltare pure in rete e scaricare in free download e, per quanto aggressivo e colorito, rimane lontano dall'integralismo. Come quello celebrato quattro anni fa a Lignano Sabbiadoro dai Giovani Musulmani d'Italia con il concorso di «anashid islamiyà», ossia canzoni islamiche in arabo. Un altro conto sono le rime che inneggiano alla lotta armata e mortale. Sono un segno di quanto pericolosamente, e nell'indifferenza pressoché totale di quasi tutta la politica e l'informazione, la Jihad abbia fatto propri gli strumenti di comunicazione tipici del mondo giovanile: il rap è il linguaggio musicale più usato dagli under 30 e i terroristi lo hanno capito. Dopo una prima e lunga fase di totale chiusura a forme musicali (ad esempio l'Afghanistan talebano era un paese orfano di ogni tipo di musica) hanno drammaticamente assorbito i linguaggi giovanili occidentali per piegarli alla propria propaganda assassina. Ad aprile il rapper olandese-libanese Hozny ha pubblicato un video che mostrava la macabra messinscena dell'esecuzione del deputato Geert Wilders. E proprio in quei giorni il tedesco Deso Dogg (vero nome Denis Mamadou Cuspert) è morto combattendo con i ribelli dell'Isis in Siria. Follie totali. Ora, anche in questo caso, il rischio emulazione si dilata. E senza dubbio il rap, stile di protesta nato negli anni '70 per cantare il bisogno dei neri americani di uscire dai «ghetti» metropolitani, offre la metrica adatta e soprattutto l'indice di penetrazione popolare più alto in tutto l'Occidente. Quindi non sarà difficile che in un futuro immediato saltino fuori altri esempi di integralismo rap. Mutatis mutandis , il punk o il metal sono stati passioni fugaci di terroristi in epoche non troppo lontane. Ma il segreto per non trasformare le eccezioni in una regola è non generalizzare. Oltre che un errore, l'equazione rap = terrorismo sarebbe un assist imperdonabile alla peggiore delle propagande.
Terrorismo, provate a mettervi nei panni di un musulmano. Khalid Chaouki, parlamentare del Pd, parla a cuore aperto dei fatti di Parigi e delle colpe dell'Islam, scrive Carmelo Abbate su “Panorama”. Khalid Chaouki è nato a Casablanca, in Marocco. Ha 32 anni, è arrivato in Italia da bambino, è cresciuto tra Parma e Reggio Emilia. È tra i fondatori dell’associazione “Giovani musulmani d’Italia”, della quale è diventato presidente, siede nella consulta per l’islam istituita al ministero dell’Interno, da ultimo è stato eletto alla Camera dei deputati nelle file del Partito Democratico.
Come vive un musulmano quello che sta succedendo a Parigi?
«Con grande tensione, paura e sconcerto. Con la consapevolezza che bisogna tradurre in azione concreta e positiva le sensazioni che affollano la nostra mente».
Proprio in questo momento leggiamo che i terroristi sono rimasti uccisi durante le irruzioni delle forze speciali, ma tra i morti ci sarebbero anche alcuni ostaggi.
«Altri morti innocenti. Spero almeno sia la fine di un incubo, spero che le prossime ore siano di silenzio e raccoglimento».
Torniamo a voi musulmani.
«I fatti di questi giorni impongono una riflessione a tutti noi musulmani, ci dobbiamo guardare dentro, aprire una riflessione e interrogare sul ruolo che vogliamo avere nella società del futuro. Una riflessione che deve essere trasparente, visibile, alla luce del sole».
Cosa c’è dentro il cuore di un musulmano?
«C’è grande dispiacere. C’è angoscia, per l’immagine e l’utilizzo che viene fatto della tua religione. C’è vergogna, nel vedere la tua fede che viene associata alla morte. C’è un dolore profondo, che non viene percepito dall’esterno».
Basta manifestarlo, urlare se serve.
«Infatti, io credo che noi musulmani proprio in queste ore dobbiamo fare un passo avanti, andare oltre e costruire le basi di quello che sarà il modello di convivenza nel futuro».
Trasformare questi eventi tragici in occasione positiva?
«Nella loro tragicità, i fatti di Parigi ci offrono l’opportunità per toglierci di dosso il peso che noi musulmani ci portiamo dietro dall’11 settembre. È arrivato il momento di urlare al mondo la nostra rabbia per il modo in cui viene sottomessa e manipolata la nostra religione».
La moschea in Italia viene considerata come una sorta di Rubicone, la linea che non bisogna attraversare, la bandierina che non bisogna issare sul nostro territorio. Alla luce di quello che sta succedendo in Francia e nel mondo, non pensa che sia una scelta controproducente? Non pensa che sarebbe più facile la prevenzione contro i cosiddetti cani sciolti se ci fossero dei luoghi di aggregazione e preghiera con regole chiare e accettate da tutti? E con possibilità di controllo maggiore da parte delle autorità?
«Sarebbe tutto molto più semplice. Purtroppo l’Italia ha sprecato troppi anni in balia della propaganda, senza ragionare da paese serio. Il diritto al culto va regolamentato, e la moschea può diventare una occasione per isolare chi si nasconde e fa proselitismo dentro gli scantinati».
I fatti a cui assistiamo in diretta televisiva dalla Francia, lei come li giudica, atti di terrorismo o guerra?
«Si tratta di guerra, una guerra asimmetrica che va combattuta con una forte controffensiva culturale da parte di tutti, con il mondo musulmano che deve diventare il nostro principale alleato».
Cosa rimprovera al mondo musulmano?
«Il tentativo di etichettare questi fatti come la deriva violenta di un piccolo gruppo criminale. Non è così. La questione è molto più ampia e ci investe nel profondo. Nel mondo musulmano c’è un problema di reinterpretazione dei testi sacri alla luce della modernità, va sancito in modo solenne il rapporto pacifico con l’Occidente. Ci sono nodi teologici irrisolti che poi portano a gesti criminali».
C’è il pericolo di gesti inconsulti nei confronti delle comunità musulmane?
«Sta già accadendo in Svezia e in Francia, sono state lanciate molotov contro moschee. Serve un senso di unità molto forte, serve lo sforzo di tutti, come sta avvenendo in Francia, con i musulmani che si stanno riversando sulle strade per manifestare sgomento, indignazione e condanna».
Lei è oggetto di insulti sui social network, come li vive, come li sopporta?
«Il mio impegno civile è sempre stato di frontiera, vengo criticato anche da molti islamici che mi accusano di essere troppo moderato».
Non ha paura?
«A volte fa male, a volte fa paura. Ma se accetti una sfera pubblica e ti impegni per un’Italia migliore, allora devi essere preparato a fare i conti con una società impaurita dai fomentatori di odio professionisti».
Cosa le fa più male delle immagini che ci arrivano da Parigi?
«Il senso di impotenza che sta vivendo un grande paese come la Francia. Il totale black-out di una città meravigliosa come Parigi, che adoro e che ho visitato con mia moglie. Le fotografie di una Parigi deserta ci sbattono in faccia il fallimento di tutti noi».
Charlie Hebdo siamo tutti noi. La strage nel giornale parigino è un attacco alla nostra stessa idea di civiltà. Una sfida portata dall’estremismo fondamentalista che l’occidente deve affrontare e vincere. Perché in gioco c’è il nostro modello di convivenza, scrive Gigi Riva su “L’Espresso”. Hanno sparato e ucciso nella sede del giornale satirico francese “Charlie Hebdo” ma è come se lo avessero fatto nelle case di noi tutti. Perché quelle pallottole sono idealmente indirizzate contro uno dei valori su cui si regge la nostra idea di civiltà, progresso, democrazia. È un pilastro fondativo della modernità occidentale il considerare che la satira è, deve essere, libera e nessun potere, fosse anche un potere che fa ascendere la propria fanatica legittimità direttamente da un dio, si può arrogare il diritto di imbrigliarla. “Charlie hebdo” ha avuto il coraggio di ribadirlo, nella sua gloriosa e travagliata storia (irridente anche nei confronti dei regnanti di Francia), davanti alle minacce per i titoli, gli editoriali e le vignette che hanno avuto come bersaglio l’Islam e Maometto (l’ultima, pubblicata sul sito pochi minuti prima dell’assalto, la vedete qua sotto). La vignetta di “Charlie Hebdo” con il califfo che augura: “e soprattutto la salute”Ma l’estremismo fondamentalista non tollera lo sberleffo, mette al bando il sorriso. Vuole pervadere di cupezza censoria e regolare nei dettagli la vita di sudditi da ridurre all’obbedienza. Tutto il contrario di quanto l’Europa e i suoi cittadini hanno deciso per se stessi, almeno dai Lumi in poi, da quando la libertà di espressione è diventata un diritto inalienabile accanto agli altri che definiscono la dignità degli umani. Che l’attacco a queste conquiste, a questo modo di intendere la partecipazione alla vita pubblica, avvenga a Parigi, aggiunge una suggestione simbolica che rende ancor più potente l’atto e chiama a una reazione altrettanto decisa e coesa. La capitale francese è il luogo dove i valori alla base della nostra convivenza hanno trovato la culla. Anche quello dove la laicità si è declinata in quella dottrina dell’assimilazionismo per cui coloro che abitano nel Paese sono perciò “citoyen de la République”, tutti uguali davanti alla legge secolare, con l’opportunità di esercitare il culto che preferiscono a patto che non interferisca coi supremi diritti dello Stato. Un modello di integrazione che ha coinvolto mezzo milioni di ebrei, cinque milioni di musulmani e recentemente entrato in sofferenza anche, e soprattutto, a causa di una crisi economica che ha contrapposto immigrati vecchi e nuovi e francesi delle classi meno agiate. Mai tuttavia, nemmeno nelle rivolte delle banlieue datate 2006, era stato messo in discussione l’ordine dei valori. Anzi: i disperati rivoltosi chiedevano di essere “più francesi”, di avere le stesse chance degli altri “citoyen”. ma ora che il conflitto si è radicalizzato in Medioriente, ora che lo Stato Islamico offre una terra, un credo e un irresistibile richiamo alla violenza nichilista, ecco che alcune frange esportano la guerra in Europa in un furore iconoclasta che ha l’obiettivo di radere al suolo, e a casa nostra, ciò che rende l’occidente un originale e riuscito paradigma di emancipazione. Non siamo ancora a quella catarsi catastrofista che lo scrittore Michel Houellebecq tratteggia nel suo ultimo romanzo “Sottomissione”, ma il livello dello scontro col fanatismo islamista si è alzato con “Charlie Hebdo” e merita che si aprano finalmente gli occhi. Ci si renda conto della realtà emergenziale e si chiami alla comune difesa di un modo di vivere a cui non vogliamo rinunciare, gli stessi fratelli islamici europei non infatuati del Jihad. Per fortuna, la stragrande maggioranza.
1. MOSTRARE O CENSURARE I DISEGNI DI CHARLIE HEBDO: ORA I MEDIA SI DIVIDONO. Enrico Franceschini per “la Repubblica”. Siamo tutti Charlie Hebdo: lo dicono i cartelli della gente nelle strade di tutta Europa, lo affermano i titoli dei giornali di tutto l’Occidente. Ma non tutti i giornali occidentali — pur condannando come barbaro l’attacco di Parigi e difendendo il diritto del settimanale francese di fare satira come vuole su quello che vuole — hanno ripubblicato le vignette messe sotto accusa dagli estremisti islamici. Il mondo dei media si è per il momento diviso fra chi non pubblica nulla o soltanto vignette che non ritraggono Maometto e chi invece ha pubblicato proprio il materiale che ha fatto infuriare gli islamisti, come la famosa copertina di Charlie Hebdo in cui il Profeta ammonisce: «Vi farò dare 100 frustate se non morite dal ridere!» Adesso un appello lanciato da Timothy Garton Ash, docente di relazioni internazionali a Oxford, columnist del Guardian e di Repubblica, autore di saggi di successo, chiede a tutti i giornali d’Europa di pubblicare le vignette più “forti” del settimanale francese come gesto collettivo in difesa della libertà di stampa. Ma le opinioni in materia appaiono contrastanti. In Gran Bretagna nessun quotidiano ha pubblicato le vignette di Charlie Hebdo. «Siamo dei codardi», scrive amaramente un columnist del Times. Viceversa Tony Barber, commentatore del Financial Times, definisce «editorialmente stupida» la scelta del settimanale parigino di provocare consapevolmente l’ira dei musulmani e lo giudica «non il miglior campione di libertà di espressione»: uscito prima sul sito, il suo articolo è stato ritoccato ieri sera, cancellando questi due severi giudizi, che hanno scatenato sdegno sui social network, ma li ha ripristinati nella versione cartacea pubblicata ieri mattina. Non finisce qui. In America il Washington Post afferma: «Non pubblichiamo mai immagini che possono offendere qualunque religione» e il New York Times segue la stessa linea. Ma il quotidiano del Watergate deve incassare le critiche di una delle sue firme di punta, Carl Bernstein, che con Bob Woodword fece esplodere quello scandalo. In Danimarca alcuni giornali hanno pubblicato le vignette e altri no. L’ Huffington Post, il Daily Beast, Slate e altre testate online le hanno pubblicate; la Bbc e la Cnn no. D’altra parte, come denuncia il blog statunitense Gawker, considerato in patria una sorta di “tempio” della controinformazione, il Daily Telegraph britannico e il New York Daily News hanno pensato bene di “pixelare”, quindi rendendole irriconoscibili, le copertine più controverse contro il Profeta e l’Islam. Stephen Pollard, direttore del Jewish Chronicle, un giornale britannico, pone il dilemma in questi termini: «Il mio istinto giornalistico mi dice di pubblicare tutto, ma che diritto ho di rischiare la vita dei miei redattori?».
2. MA PER L’AMERICA I DISEGNI SUL PROFETA MANCANO DI RISPETTO. Paolo Mastrolilli per “La Stampa”. L’attacco terroristico di Parigi sta spaccando i media americani. Non nella condanna dell’attentato, ovviamente unanime, ma nella opportunità di ripubblicare le vignette del periodico Charlie Hebdo, che hanno provocato la furia degli estremisti. I grandi giornali come New York Times, Washington Post, Wall Street Journal e Usa Today hanno scelto di non farlo. La linea usata dai loro direttori è abbastanza simile: non pubblichiamo immagini che sono state pensate con lo scopo dichiarato di offendere la religione e mancarle di rispetto. Descriverle basta, per compiere il servizio di informazione dovuto al lettore. Questa posizione per certi versi si riflette nella prudenza che la stessa Casa Bianca aveva usato nel settembre del 2012, quando la diffusione di un video giudicato offensivo verso Maometto aveva generato proteste in molti Paesi del Medio Oriente. Era seguito poi l’assalto al consolato americano di Bengasi, che però in seguito si è scoperto essere un’operazione premeditata di un gruppo terroristico. Allora il portavoce del presidente Obama, Jay Carney, aveva commentato proprio alcune vignette pubblicate da Charlie Hebdo, dicendo che non metteva in discussione il diritto di stamparle, ma il giudizio della direzione che aveva deciso di farlo. In altre parole, la libertà di espressione andava sempre difesa, ma forse si potevano evitare le provocazioni. Più dura ancora è stata la reazione ieri del gruppo cattolico conservatore Catholic League. Il suo direttore, Bill Donohue, ha detto che «i musulmani hanno il diritto di essere arrabbiati». Naturalmente Donohue non giustifica l’attentato, però aggiunge che «se Stephane Charbonnier, direttore di Charlie Hebdo, fosse stato meno narcisista, oggi sarebbe ancora vivo. Maometto per me non è sacro, ma non mi è mai passato per la testa di insultare deliberatamente i musulmani offendendolo». Questa linea non è stata condivisa da tutti, nelle redazioni dei giornali americani. La pagina degli editoriali del Washington Post, che nella tradizione dei media Usa ha una gestione separata e autonoma dalla direzione, ha pubblicato una vignetta di Charlie Hebdo, e lo stesso ha fatto l’edizione online del Wall Street Journal. Usa Today invece ha optato per mettere le altre vignette che hanno condannato l’attacco di Parigi, mentre diversi giornali hanno stampato foto in cui si vedono i disegni contestati del periodico francese. L’editorialista del New York Times Ross Douthat ha commentato così: «Se qualcuno vuole ammazzarti per una cosa che vuoi dire, significa che quella cosa va detta». Il dibattito dunque è aperto, fra l’opportunità di prendere decisioni editoriali che non siano apertamente mirate a creare guai, e il dovere di evitare sempre la censura e difendere la libertà.
3. PLANTU: “CONTINUEREMO A PRENDERE IN GIRO. CON LE MATITE DENUNCIAMO LE VIOLENZE”. Cesare Martinetti per “la Stampa”. E adesso? «Il faut continuer se moquer», dice Plantu, non dobbiamo smettere di prendere e prendersi in giro con i disegni. Dunque la satira vive, a Parigi, a cominciare dal grande bureau di Jean Plantu, al settimo piano di Le Monde. Il suo studio è una foresta popolata dalle sagome dei suoi personaggi, la sua scrivania un accumulo di bruillon, schizzi, prove, colori. Plantu ci mostra la vignetta che ha appena concluso per il giornale di oggi: una macchia rossa in strada, il tricolore a mezz’asta sulla tour Eiffel, la bandiera di Charlie Hebdo sull’ingresso dell’Eliseo, una Marianna in lacrime, due barbuti che si allontanano con il kalashnikov sulle spalle e il topolino (l’alter ego del disegnatore) che li guarda reggendo un cartello: «gros connards», diciamo grandi bastardi.
Plantu dal 1985 disegna la vignetta sulla prima pagina di Le Monde e dieci anni fa ha creato «Cartoonist for peace». Che fate?
«Cerchiamo ogni giorno di dialogare con disegnatori cristiani, ebrei, musulmani, agnostici, atei e arriviamo talvolta a fare dei ponti con le nostre piccole matite là dove altri con le loro asce scavano fossati».
Nel vostro programma c’è l’impegno ad essere rispettosi dei credenti. Ci riuscite sempre?
«Ci sono mille modi di raccontare le cose, ho passato la notte qui al giornale a ricevere disegni dal medioriente, dal maghreb di tutte le religioni. C’è l’immagine seria e rispettosa e ci può essere quella un po’ folle. E noi vogliamo tentare di essere più forti degli intolleranti, essere impertinenti senza offendere i credenti. Bisogna continuare la battaglia avendo rispetto per il dolore delle persone che vivono in Iraq o in Afghanistan e smettere di dire che la guerra è lontana. No è qui, a casa nostra».
Ma se c’è di mezzo la religione tutto si complica. Come si superano queste divisioni?
«A noi non interessa sapere se Gesù Cristo ha camminato sulle acque o cosa ha fatto Maometto. Quello che ci interessa è: c’è una donna lapidata? Non è un problema di religione ma di diritti umani, e prendiamo matite e pennarelli per denunciare le violenze. E capita che ci riusciamo perché l’arte e la creatività sono sempre più forti dell’intolleranza».
Lei ora si sente un bersaglio?
«Non lo considero un problema. Io lavoro molto con le scuole. Un disegno è qualcosa che ognuno vede, se ne appropria, ci si può esprimere in mille modi, lascio la mia matita a qualcun altro. Oggi siamo con tutto il cuore con Charlie Hebdo e tutti possono firmare questo disegno, la mano è anonima».
A Charlie Hebdo qualcuno aveva passato il segno del rispetto?
«Io penso che gli artisti abbiano tutti i diritti, di disegnare e fare il ritratto di chiunque. Ciò detto siamo nel 2015, e bisogna fare attenzione perché laggiù all’angolo della strada c’è un mascalzone che aspetta soltanto che gli facciamo un regalo per liberare la sue folle armate di kalashnikov e granate. Abbiamo creato l’associazione dieci anni fa per battere l’imbecillità dei farabutti».
I quattro di Charlie erano nell’associazione?
«Solo Tignous».
4. LA LIBERTÀ DEGLI ALTRI. Francesco Merlo per “la Repubblica”. Non ci piacciono le vignette anti islamiche di Charlie Hebdo , anche se abbiamo sempre pensato che fosse suo pieno diritto pubblicarle. Erano coerenti infatti con la natura canzonatoria e provocatoria di quel giornale, con la sua idea di satira vasta e disinteressata, con quell’accanimento derisorio portato alle estreme conseguenze dinanzi al quale, scriveva Italo Calvino «mi faccio piccolo piccolo». «Perché — aggiungeva — supera la soglia del particolare per mettere in questione l’intero genere umano, confinando con una concezione tragica del mondo». E tuttavia non ci piacciono quelle vignette neppure dopo l’enormità dell’atto terroristico e l’immenso dolore per la morte di 12 persone libere e innocenti. Appartengono infatti alla grammatica della blasfemia e non a quella della trasgressione, anche se, sbeffeggiando il profeta Maometto, più che bestemmia in senso stretto quelle caricature erano empietà aggressiva in una città, Parigi, dove tantissime jeunes filles musulmane passeggiano per gli Champs-Élysées con i capelli al vento. A Parigi sono musulmane le studentesse universitarie, le impiegate, le giornaliste, e sono arabi musulmani i grandi chirurghi e i piccoli venditori di frutta, le star del pop e i professori universitari, gli edicolanti e i camerieri dei ristoranti. Tutti laici come i calciatori eredi di Zidane e come il poliziotto finito con un colpo di Kalashnikov dal fanatico terrorista, con un accanimento selvaggio che offende tutti i codici militari e in nome di un Dio killer che svilisce qualsiasi Dio. Di sicuro al Dio macellaio la stragrande maggioranza dei musulmani francesi non crede e non crederà mai. Dunque sono un pretesto le vignette blasfeme. Se Charlie Hebdo non fosse mai esistito i terroristi avrebbero sparato in un bar, in una stazione del metrò o in un aeroporto. Le vignette sono l’alibi dell’attacco e del ricatto all’Occidente, più insidioso per noi, spaventati da una violenza irriducibile dalla quale è difficile difendersi, che per le frustrazioni nazionaliste, etniche e religiose di quella minoranza di profughi ribelli e di barbuti arrabbiati e confusi dalla quale provengono i terroristi in cerca di una scusa per uccidere. Dal punto di vista militare questo nuovo terrorismo diffuso prova a rilanciare, a partire dalla città più civile tollerante e laica d’Europa, il famoso scontro di civiltà. Ma la strage nella sede di un giornale rischia di armare di più i francesi tentati da Marine Le Pen che i francesi musulmani che, per la verità, non sono tentati né dallo Stato Islamico né da Al Qaeda. La bestemmia diventa così uno di quei dispositivi accidentali della storia, come il naso di Cleopatra per esempio. E basta guardare la felicità dei leghisti italiani e le reazioni scomposte dei fanatici delle Leghe Sante. I 12 morti di Parigi sono come un richiamo della foresta per i nostri cristianisti con il Crocifisso tra i denti che papa Francesco aveva messo a cuccia, un ritorno alla natura per l’estrema destra razzista pronta alla difesa di una Francia e di un’Europa bianche e cristiane. La paura sui cui soffiano è quella dall’islamizzazione immaginata nel romanzo Sottomissione da Houellebecq, preso in giro proprio dalla copertina di Charlie Hebdo: «Le predizioni del mago Houellebecq: “Nel 2015 perdo i denti... ” (i suoi problemi odontoiatrici sono noti) e “nel 2022, faccio il Ramadan!”». La verità è che persino la rabbia delle squadracce di banlieue a Parigi, anche se araba e violenta, non è governata dagli integralisti islamici. E in fondo questi terroristi così barbari sono quelli che non ce l’hanno fatta, gli scarti feroci di un’integrazione che è invece riuscita, non solo in Francia. E sono due volte disadattati, sia in Francia sia nelle milizie islamiche dove devono sempre conquistarsi i quarti di nobiltà terrorista sgozzando e massacrando più degli altri. Ieri a caldo una vignetta di Charlie Hebdo mostrava un energumeno tutto bardato di nero incappucciato e sudato che entrava in Paradiso mitragliando e gridando: «dove sono le mie vergini?». Riceveva questa risposta al tempo stesso canzonatoria e malinconica: «Sono nel paradiso dei vignettisti ». Disadattato anche là. È già stato scritto che Charlie Hebdo aveva deriso, e certamente avrebbe continuato a farlo, anche i simboli delle altre religioni. E ricordo bene le natiche del Papa, il matrimonio omosessuale tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e la masculinità di Shiva, senza risparmiare neppure Buddha, un dio “parzialmente scremato”. Si rideva forte e facile con Charlie Hebdo, perché la scurrilità di Maometto, raffigurato prono con le stelline sulle terga, quando ti arriva sotto gli occhi, è più veloce del pensiero. E certo è ancora libertà d’espressione la violazione dei codici del rispetto delle religioni. Ma non avere stampato le bestemmie è stato il nostro codice di libertà di espressione, coniugata, ancora di più adesso che siamo tutti sotto choc, con il controllo degli istinti. La laicità e la secolarizzazione comportano infatti anche un governo dell’invocazione e dell’imprecazione: della preghiera, che non è un selvaggio rito collettivo, e della bestemmia, soprattutto del Dio altrui. Ma viviamo in una parte del mondo — ecco la differenza — dove la libertà è la cosa più importante. Non conta che gli altri la pensino come me: ma che siano liberi di pensare e di esprimere le loro idee con il solo limite del rispetto delle leggi. Ecco perché difendiamo la libertà di Charlie di esprimersi secondo la sua natura e le sue modalità, le sue libere scelte, anche quando non sono le nostre. Facciamo sapere a tutti gli estremisti religiosi del mondo che mai rinunzieremo alla critica e alla satira, anche delle religioni, e non accetteremo un ritorno all’inquisizione e alla punizione fisica delle bestemmie, al medioevo islamico. Anche se non diventeremo mai, come vorrebbero gli estremisti islamofobi, tutti sbeffeggiatori di Maometto.
Terrorismo islamico a Parigi: massacro al giornale Charlie Hebdo. Due terroristi fanno irruzione nella redazione di Charlie Hebdo armati di kalashnikov, poi fuggono a Reims. Tra i dodici morti c'è il direttore Charb. Un poliziotto giustiziato per strada, scrive Andrea Indini su “Il Giornale”. Armati di kalashnikov due terroristi hanno assaltato la redazione di Charlie Hebdo. Cinque minuti di sangue e quello che è l'attentato più cruento commesso in Francia dal 1961, ai tempi della guerra di Algeria, fa ripiombare Parigi e l'intera Europa nell'incubo del fondamentalismo islamico. Al grido di "Vendicheremo il Profeta" due uomini incappucciati e vestiti di nero hanno fatto irruzione nella reception del settimanale satirico e hanno aperto il fuoco. A terra i cadaveri crivellati di colpi di dodici persone. Tra questi il direttore Stephane Charbonnier, che firma le vignette Charb, e altri sette giornalisti. Una raffica di colpi, almeno una trentina, con i mortali AK47. Dodici morti a terra e i giornalisti in fuga sui tetti. Un assalto che porta la firma della jihad islamica. La colpa di Charb e dei disegnatori di Charlie Hebdo? Aver pubblicato vignette satiriche su Maometto. Già nel 2011 la redazione fu distrutta da una molotov. L’attentato, che non provocò vittime, avvenne nel giorno dell'uscita del numero speciale dedicato alla vittoria elettorale degli islamisti in Tunisia. Il titolo "Maometto direttore responsabile di Charia Hebdo" era un gioco di parole sulla sharia. Anche nell'ultimo numero non è mancata la provocazione: in copertina campeggia una foto dello scrittore Michel Houellebecq, al centro di polemiche per il romanzo Sottomissione che racconta l’arrivo al potere in Francia di un presidente islamico. A fare irruzione è stato un commando armato formato da Said e Cherif Kouachi, due fratelli franco-algerini di 32 e 34 anni legati alla rete terrorista yemenita e da poco tornati dalla Siria. Oltre a Charb i due hanno ammazzato otto giornalisti (tra questi Jean Cabut detto Cabu, Tignous, Georges Wolinski, Bernard Maris e Philippe Honoré), il poliziotto Franck D., un ospite della redazione (Michel Renaud) e il portinaio. Tra gli undici feriti c'è il giornalista Philippe Lançon. Dopo il blitz sono scappati a bordo di una Seat guidata dal 18enne Hamyd Mourad. Durante la fuga hanno investito un passante e hanno ingaggiato un secondo scontro a fuoco con le forze di polizia. Immagini di violenza inaudita che sono state riprese dai tetti: l'agente Ahmed Merabet è stato giustiziato con un colpo alla testa mentre si trovava, inerme, ferito a terra. Solo dopo diverse ore le teste di cuoio dei reparti Raid sono riuscite a localizzarli a Reims. Il presidente francese Francois Hollande ha parlato di "attentato terroristico di eccezionale barbarie, un attentato alla nostra libertà". Un attentato che arriva a stretto giro da altri tre inquietanti attacchi al grido "Allah hu Akbar". Il 22 dicembre a Nantes, nella Francia nord occidentale, un camion è stato lanciato sul tradizionale mercatino natalizio ferendo undici persone. Nemmeno ventiquattr'ore prima a Digione, nel nord est del Paese, un 40enne alla guida di una Renault Clio aveva travolto la folla mandando all'ospedale 13 persone. Sempre al grido di "Allah hu Akbar". Vicende troppo simili e troppo vicine per non metterle in relazione tra loro. A queste va poi aggiunta una terza, quella di Jouè-lès-Tours dove un convertito all'Islam è entrato nel commissariato cittadino e ha aggredito tre poliziotti. Una scia di sangue nel nome di Allah.
Dal direttore Charb al mitico Wolinski, la strage della satira nella redazione di Charlie Hebdo. Tra le dodici vittime dell'assalto anche cinque celebri vignettisti: il direttore, il vecchio e storico creatore di "Paulette", Cabu, Tignous e Honoré, scrive Francesco Fasiolo su “La Repubblica”. Un giornale satirico simbolo della libertà di stampa e di espressione. Questo è diventato Charlie Hebdo nel corso degli anni. E per questo è tragicamente divenuto anche l'obiettivo simbolo del terrorismo. Dieci collaboratori uccisi in redazione, tra loro alcuni dei grandi vignettisti famosi ben oltre i confini francesi. Una storia cominciata nel 1960, quando nacque Hara-Kiri, definito dai suoi fondatori (tra cui Cabu e Georges Wolinski, tra le vittime dell'attentato) "un giornale stupido e cattivo", da subito protagonista di innumerevoli battaglie e censurato un paio di volte dalla magistratura francese. E' nel 1970 che lo stesso gruppo, dopo l'ennesimo scandalo (una copertina che ironizzava sulla morte di Charles De Gaulle e che costò al giornale il blocco delle pubblicazioni) diede vita al "Charlie Hebdo", riferimento al celebre Charlie Brown dei Peanuts. Da allora sono stati attacchi, sarcasmo e ironie contro la destra, ma anche la gauche, su tutti i fronti e tutti i temi.
Vignette su Maometto. È però nel 2006 che l'Hebdo diventa noto al pubblico internazionale con la scelta di ripubblicare le dodici controverse vignette su Maometto del giornale danese Jyllands-Posten. Immediate arrivarono le proteste di esponenti del mondo islamico, il giornale fu incriminato per razzismo e l'allora direttore Philippe Val fu assolto nel 2008 da un tribunale francese. Nel novembre 2011 esce "Charia Hebdo", il numero speciale dedicato alla vittoria degli islamisti in Tunisia. In copertina una immagine di Maometto che promette "Cento frustate se non morite dal ridere". Prima che l'edizione arrivasse nelle edicole, la sede della rivista viene distrutta da un incendio provocato da un lancio di molotov. Il numero vende 400.000 copie, il direttore Charb viene minacciato di morte e messo sotto protezione.
Le vittime. Charb era il nome d'arte di Stéphane Charbonnier, 47 anni, alla guida del settimanale dal maggio 2009. Insieme a lui, nell'attentato sono morti anche altri quattro vignettisti: Cabu, Tignous, Philippe Honoré e Georges Wolinski. E' proprio quest'ultimo il nome più noto anche fuori dalla Francia. Controcorrente e provocatorio Wolinski, nato a Tunisi nel 1934, lo è sempre stato. Gli italiani lo hanno conosciuto sin dagli anni 70, quando leggevano su Linus le sue storie dissacranti. Disegnatore e sceneggiatore, con Georges Pichard crea il personaggio di Paulette, inizialmente su Charlie Mensuel e poi protagonista di pubblicazioni autonome. La protagonista è una giovane ricchissima, che ha almeno due particolarità: è di sinistra e appare spesso, in pratica sempre, nuda o seminuda. Le sue storie sono sempre in bilico tra l'erotico e il politico, perché la ragazza, in opposizione con la sua vantaggiosa situazione economica e sociale, è pienamente calata nel clima degli anni '70, tra lotte studentesche, manifestazioni contro la guerra in Vietnam, suggestioni hippy. Se in passato Wolinski è stato al centro di polemiche, accusato di immoralità o pornografia per le nudità e le tematiche trattate (tra i suoi libri "Il porcone maschilista" e "Le donne pensano solo a quello") , a 80 anni era uno dei nomi più importanti del fumetto mondiale. Una fama che gli è stata riconosciuta nel 2005, con la vittoria del Grand Prix di Angouleme, in pratica l'equivalente nel mondo dei comics dell'Oscar alla carriera, e con una grande retrospettiva del 2012 alla Bibliotheque Nationale de France, dove sono custoditi tutti i suoi archivi. Cabu, vero nome Jean Cabut, 76 anni, era uno dei pilastri di Charlie Hebdo, sin dalla fondazione di Hara-Kiri. Il suo nome era rimbalzato sui media di tutto il mondo quando nel febbraio 2006, in piena polemica per le vignette danesi su Maometto, disegnò in copertina il Profeta che insultava i fondamentalisti. Tra i suoi lavori, molto famoso in Francia è "Mon Beauf", serie su un francese medio, razzista e maschilista. Bernard Verlhac era invece il vero nome di Tignous, 57 anni, che lavorava anche per Fluide glacial, storicamente uno dei più importanti magazine francesi di fumetti. Al suo attivo otto libri. Il più recente, intitolato "5 ans sous Sarkozy" (Cinque anni sotto Sarkozy) è stato pubblicato nel 2011. Fa venire i brividi oggi l'ultima vignetta di Charb, pubblicata sull'ultimo numero di Charlie Hebdo, mostrava un terrorista islamico sotto la scritta: "Ancora nessun attentato in Francia". "Aspettate" diceva l'uomo armato "Abbiamo ancora tutto gennaio per farvi i nostri auguri".
Il dissacrante Charlie Hebdo, nato alla sinistra della sinistra, scrive Anna Maria Merlo su “Il Manifesto”. Il settimanale. Da sempre indipendenti, dagli industriali e dalla pubblicità. Vignette e reportage corrosivi. Non solo contro l’islam: il primo bersaglio sono state la chiesa cattolica e l’estrema destra. Cabu e Wolinski, che sono stati assassinati ieri assieme al più giovane Charb, nell’attentato che ha fatto 12 vittime nella redazione del settimanale Charlie Hebdo, sono stati protagonisti fin dagli anni ’60 dell’avventura, iniziata con Hara-Kiri, della stampa satirica libertaria francese della seconda metà del XX secolo. All’inizio, c’erano personalità come Topor, Reiser, lo scrittore François Cavanna, che hanno l’idea di pubblicare la versione francese di Linus italiano. Nel ’70, dopo varie censure di cui è vittima Hara-Kiri – l’ultima, a novembre, dopo la morte di De Gaulle, per un titolo dissacrante – il gruppo fonda Charlie Hebdo (dal nome di un personaggio di Schultz e con un riferimento ironico a Charles De Gaulle). Della prima versione di Charlie Hebdo usciranno, fino all’81, 580 numeri. Un altro numero uscirà nell’82. Nel ’92, la testata rinasce. Fa effetto oggi, di fronte agli avvenimenti, ricordare che la società costiuita allora per il rilancio si chiamava Les Etitions Kalachnikof. Nel ’92 partecipa già Charb, che dal 2009 era diretore della pubblicazione. Charlie Hebdo ha radici nella sinitra della sinistra, ma non ha mai avuto una linea editoriale precisa. La sua storia è fatta di battaglie, di scontri, di abbandoni, di ostracismi, di ritorni. E di molte polemiche, anche interne alla redazione: nel 2002, un articolo a difesa del libro La rabbia e l’orgoglio di Oriana Fallaci, viene subito criticato. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 ci sono prese di posizione conflittuali contro una parte dell’estrema sinistra, accusata di non aver condannato gli islamisti per antiamericanismo. Philippe Val, che all’inizio degli anni 2000 diventa direttore della pubblicazione, accusa Tariq Ramadan di essere un propagandista antisemita. Val nel 2005 difende il «sì» al referendum sul Trattato costituzionale europeo, altri difendono il «no» – che sarà vittorioso – sulle pagine del settimanale. Charlie Hebdo non si limita alla satira, ma pubblica anche reportage sulla società e sulle grandi questioni dell’attualità mondiale (in particolare, alla fine degli anni ’70, importanti inchieste sull’estrema destra). Oncle Bernard (l’economista Bernard Maris, assassinato anch’egli ieri) ha firmato cronache economiche sempre di grande interesse. La caratteristica di Charlie Hebdo, con le sue vignette corrosive che molto spesso hanno disturbato, è sempre stata l’indipendenza, dalle ideologie come dal denaro. «Non vogliamo ricchi industriali come azionisti – aveva detto Charb nel 2010 – e non vogliamo neppure dipendere dalla pubblicità. Non prendiamo quindi gli aiuti di Stato che vanno ai giornali cosiddetti “di deboli introiti pubblicitari”, visto che non abbiamo pubblicità. L’indipendenza, l’indipendenza totale, ha un prezzo». Charlie Hebdo ha sempre lottato contro tutti i fanatismi. Il primo bersaglio è stata la chiesa cattolica, in quanto religione maggioritaria in Francia. Le vignette sono state sempre corrosive, a volte anche con una certa pesantezza. Il settimanale molte volte è stato denunciato, dai politici, dai cattolici, di recente dai musulmani. Charb ha sempre precisato: la critica è sull’«alienazione delle fede», qualunque essa sia. Nel 2006, Charlie Hebdo pubblica le caricature di Maometto del giornale danese Jyllands Posten, arricchite da altre vignette firmate dai disegnatori del settimanale. Il Consiglio francese del culto musulmano chiede la censura del numero e sporge denuncia. L’allora presidente, Jacques Chirac, condanna le «provocazioni manifeste». Ne seguirà un processo nel 2007, dove ha testimoniato, a favore della libertà di stampa, anche François Hollande, non ancora presidente. La storia delle caricature di Maometto, che sembra all’origine del massacro di ieri, era già stata la causa di un incendio criminale di cui era stata vittima la sede di Charlie Hebdo nel novembre 2011. La redazione, allora, era stata ospitata per due mesi da Libération. Altre caricature di Maometto susciteranno polemiche e denunce nel 2012. La copertina in edicola di Charlie Hebdo questa settimana prende in giro lo scrittore Michel Houellebecq, di cui ieri è uscito l’ultimo libro, Soumission, che racconta dell’elezione di un islamista alla presidenza della Repubblica francese nel 2022.
L'attentato che spazza via le certezze della sinistra. L'attentato terroristico di Parigi è riuscito là dove le innumerevoli stragi dei cristiani hanno fallito: ha risvegliato la coscienza della sinistra italiana ed europea contro l'Islam. Tutto, compreso quello moderato, scrive Roberto Bettinelli su “L’Informatore”. Il massacro nella redazione del giornale satirico Charles Hebdo è riuscito là dove le innumerevoli stragi dei cristiani in tutto il mondo hanno fallito: ha risvegliato l’ottusa coscienza della sinistra italiana ed europea contro l'Islam. Michele Serra su Repubblica ha evocato «la terza guerra mondiale» sentenziando che «esiste un fanatismo islamista terrificante contro il quale l’Islam per primo è chiamato a mobilitarsi». Fino ad ora nessuno mai nel campo della sinistra, e men che meno un esponente illustre della sua intellighenzia come l’ex direttore di Cuore, si era spinto fino a pronunciare una condanna che per la prima volta varca il confine fra l’Islam moderato e l’Islam dei terroristi. Serra l’ha fatto, e nel farlo, ha sicuramente interpretato lo stato d’animo di gran parte del popolo della sinistra che è stato scosso in profondità e con una forza mai provata in precedenza dalla ferocia di un fondamentalismo che ha preso di mira un valore intoccabile come la libertà di stampa e di satira. Una reazione inedita che rivela come per la cultura politica che anima Repubblica esista una gerarchia delle libertà. E fra queste la libertà di stampa e di satira, uno dei generi prediletti dalla sinistra, siano da collocare su un gradino più alto della libertà di religione. La prova che non ci sbagliamo è che in questa occasione Serra e il giornale più letto e autorevole della sinistra italiana hanno preso posizione contro tutto l'Islam, anche quello moderato, rompendo con la lettura ideologica che li separa nettamente e che non è disposta a tollerare nessuna sovrapposizione. E sono stati costretti a farlo da una macabra beffa che cade tragicamente a poche settimane dalla risoluzione del parlamento europeo che ha riconosciuto, per iniziativa del Pse, il diritto alla Palestina di costituire uno stato autonomo. Un'azione diplomatica che sembrava assicurare la pace ma che ha contribuito a innescare la risposta dei terroristi che hanno attaccato il giornale diretto da Stephan Charbonnier, colpevole di aver ripetutamente pubblicato vignette e fumetti contro Maometto e Al Baghdadi, il leader dell’Isis. Lo scenario non poteva essere più chiaro. Da un lato l'Europa che, sulla spinta di un’adesione incondizionata e irresponsabile al dogma del multiculturalismo, riconosce il diritto palestinese di formare un proprio stato nonostante la massiccia presenza di formazioni legate ad Al Quaeda nella striscia di Gaza e in Cisgiordania; dall’altro il terrorismo islamico che colpisce a morte una delle capitali più importanti dell’Unione Europea, uccide 12 persone tra giornalisti e poliziotti, getta nell’incubo perenne degli attentati l’intero occidente. Adesso che i ‘lupi solitari’ hanno travolto con la loro furia omicida un simbolo della libertà di stampa e di satira come Charles Hebdo, la sinistra insorge e attacca l’Islam, tutto, che dovrebbe ribellarsi e comportarsi «come fece la sinistra con le Brigate Rosse». Così suggerisce Serra stabilendo un parallelo fra quello che avrebbe fatto il Pci negli anni di piombo e quello che dovrebbero fare oggi i mussulmani che non si riconoscono nella brutalità di Al Quaeda e dell’Isis. Il consiglio di Serra è apprezzabile, ma ha l’odore fastidioso dell’ipocrisia. A sconfiggere le Brigate Rosse non fu il Pci ma furono i carabinieri del generale Alberto Dalla Chiesa. L’Italia divenne il teatro di uno scontro spietato. Vinse lo Stato. E per un solo motivo: fra i due contendenti fu il più duro e implacabile. Lo stesso deve valere per i terroristi che ammazzano e muoiono nel nome di Allah. Ci saranno altri attentati e altri morti. L’alleanza dell’Islam moderato può essere utile ai fini della vittoria finale. Ma non può bastare. L’Europa e l’occidente, se non vogliono soccombere, non hanno altra scelta che porre fine alle illusioni di un multicuralismo che è l'esatto contrario del rispetto delle identità dei popoli. Ma soprattutto devono accettare di avere di fronte un nemico che vuole la loro fine con tutti i mezzi disponibili. E fare altrettanto.
Charlie Hebdo, quella satira “cattiva” che disturbava i perbenisti. Il giornale francese è stato bersaglio di polemica da parte degli esponenti musulmani per le sue vignette su Maometto. Venne più volte chiuso e poi riaperto, scrive Cesare Martinetti su “La Stampa”. Un simbolo del giornalismo francese, un giornale nato e cresciuto negli anni 70, che si autodefiniva con ironia “bete e méchant”, bestiale e cattivo, iconoclasta, un giornale che disturbava l’opinione pubblica perbenista, capace anche di ironizzare su Charles De Gaulle il giorno della sua morte e che per questo chiuso per un po’. Nato dalle ceneri di Hara-Kiri, lanciato da Georges Bernier e François Cavanna, Charlie Hebdo è un giornale a fumetti satirico che ha fatto della provocazione la sua cifra costituente. “Journal bete et méchant”, secondo l’autodefinizione degli autori. Vi hanno lavorato negli anni caricaturisti come Francis Blanche, Topor, Fred, Reiser, Wolinski, Gébé, Cabu. Più volte chiuso e poi riaperto in seguito a denunce e a crisi editoriali. Il nome Charlie viene scelto nel 1969 quando il giornale appare sostanzialmente come versione francese dell’italiano Linus e come quest’ultimo prendi il nome da un personaggio dei Peanuts (Charlie Brown). Nel 1992 assume l’attuale identità. Il giornale è sostanzialmente espressione di una sinistra culturale. Tuttavia vi si trovano le opinioni e le posizioni più diverse e anche contrapposte. Nel 2002 aveva preso posizione a favore di Oriana Fallaci quando venne pubblicata in Francia “La rabbia e l’orgoglio”, il suo pamphlet contro i cedimenti occidentali all’islamismo. Nel 2006 CB pubblicò le famose vignette di satira su Maometto e i costumi musulmani che erano uscite sul settimanale danese Jyllands-Posten provocando manifestazioni violente di protesta in tutto il mondo islamico. Disegnatori e giornalisti danesi vennero minacciati ripetutamente. Charlie Hebdo scelse di pubblicare quelle vignette aggiungendone altre francesi per solidarietà e per marcare una linea di libertà di espressione contro tutte le intolleranze religiose. La pubblicazione provocò proteste nella comunità musulmana francese, il Consiglio del culto musulmano chiese che il giornale venisse sequestrato, lo stesso presidente della Repubblica Jacques Chirac censurò la scelta di Charlie Hebdo. Da allora il giornale – che pure tratta con articoli e vignette tutti i temi di società - è stato bersaglio di polemica da parte degli esponenti musulmani. Da allora un presidio di polizia era stato istituito davanti alla sede del giornale.
Charlie Hebdo, la storia della rivista già colpita per le vignette su Maometto. Il settimanale ha un orientamento libertario, di sinistra e fortemente anti-religioso. Pubblicato la prima volta nel 1970, scatena subito polemiche all'indomani dei funerali del generale Charles de Gaulle. Nel 2011 la sede viene incendiata, scrive F. Q. su “Il Fatto Quotidiano”. Satirico, irriverente e anticonformista. E’ questo lo spirito di Charlie Hebdo, il settimanale francese che questa mattina è stato preso di mira da un commando di terroristi armati che hanno compiuto una strage nella sede parigina. Il giornale ha un orientamento libertario, di sinistra e fortemente anti-religioso. E si pone l’obiettivo di difendere le libertà individuali. La rivista è soprattutto nota per le sue vignette e illustrazioni politicamente scorrette, ma anche per gli articoli incentrati su politica, cultura, estrema destra, cattolicesimo, islam e giudaismo. E anche se prende di mira principalmente i politici di destra, il settimanale non risparmia i partiti di sinistra francesi. Secondo l’attuale direttore, il disegnatore Stéphane Charbonnier, noto come Charb, il giornale riflette “tutte le componenti del pluralismo di sinistra e perfino dell’astensionismo”. Nel 2006 il giornale suscitò polemiche pubblicando una serie di caricature del profeta Maometto, diffuse inizialmente dal quotidiano danese Jyllands-Posten e vendendo 400.000 copie. In Italia le vignette vennero riprese dal ministro delle Riforme Roberto Calderoli che in un’intervista televisiva indossò una maglietta con le illustrazioni, un episodio che scatenò forti reazioni popolari nel mondo arabo, culminate con alcuni morti in Libia. Il numero di Charlie Hedbo incendiò proteste violente nei Paesi mussulmani. Diverse organizzazioni musulmane francesi, tra cui il Consiglio francese del culto musulmano, chiesero di seguito di mettere al bando il numero del settimanale contenente altre caricature di Maometto, ma la richiesta non fu accolta. A fine 2011, la redazione venne completamente distrutta da un incendio doloso e il sito del giornale venne attaccato dagli hacker dopo un numero speciale denominato Sharia Hebdo. Attacchi di matrice islamica, secondo gli inquirenti. Temporaneamente, la redazione si trasferì nei locali del quotidiano Liberation, per poi migrare in nuovi locali; l’attacco fu lanciato prima dell’uscita nelle edicole di un numero con in copertina un’altra vignetta satirica con Maometto. La storia di Charlie Hebdo comincia negli anni ’60 ed è strettamente legata a quella del mensile Hara-Kiri, lanciato da Georges Berniere e François Cavanna, e definito da loro stessi “un giornale stupido e cattivo”. La rivista fu al centro di diverse polemiche e fu interdetta dalla magistratura nel 1961 e poi nel 1966. Trasformata successivamente in settimanale, uscì in edicola per la prima volta nel 1970, ispirato a Charlie Brown. A novembre dello stesso anno la rivista suscitò critiche dopo la morte di Charles de Gaulle, titolando in copertina ‘Bal tragique à Colombey – un mort’, ossia ‘Ballo tragico a Colombey, un morto’, con un riferimento alla residenza del generale. Di seguito le pubblicazioni di Hara-Kiri vennero bloccate dal ministero dell’Interno francese, ma i giornalisti aggirarono il divieto lanciando una nuova pubblicazione, Charlie Hebdo, che deve il nome al famoso personaggio del fumetto Peanuts. Il settimanale rimase chiuso tra il 1981 e il 1992 dopo un calo del numero di lettori. Prima di Charb a guidarlo furono François Cavanna e Philippe Val. La rivista è pubblicata ogni mercoledì, ha una tiratura media settimanale di 100.000 copie, con 15.000 abbonati.
Giuliano Ferrara alza i toni l’8 gennaio 2015 durante «Servizio Pubblico» su La7. Il direttore de Il Foglio ritiene che la strage di Parigi non sia "terrorismo" ma che faccia parte di un'ampia strategia voluta dal mondo islamico per «andare contro l'Occidente cristiano-giudaico». «Questa è una Guerra Santa, se non lo capite siete dei coglioni!», tuona Ferrara.
Vietato parlare di Islam, scrive Maurizio Belpietro su “Libero Quotidiano”. Dopo la strage di Parigi esiste ancora la libertà di stampa? Si può ancora pubblicare oppure no un’opinione anche quando questa è politicamente scorretta? Ieri tutti i quotidiani traboccavano di articoli di fondo inneggianti alla libertà minacciata dall’assassinio a sangue freddo del direttore e dei principali collaboratori di Charlie Hebdo. E però gli stessi quotidiani si guardavano bene dal prendere di petto la questione, preferendo nascondere se non cancellare la parola islam. Sulla prima pagina del Corriere per trovarla ci si doveva sottoporre a una vera caccia al tesoro. Il titolo a tutta pagina non parlava di strage islamica o di terrorismo islamico, ma di «Attacco alla libertà. Di tutti». Ah sì? E da parte di chi? Per scoprirlo bisognava leggere il sommario su una colonna: «Al grido di “Allah è grande” tre terroristi assaltano il giornale delle vignette satiriche su Maometto: 12 vittime». Per capire poi che l’islam c’entra qualcosa, l’occhio doveva cascare sull’occhiello sfumato (una colonna) che sovrastava l’editoriale di Ernesto Galli Della Loggia: «Islam, la vera questione». Ecco, la notizia era lì, nell’occhiello. Solo allora si scopriva che l’islam c’entra qualcosa in quello che è accaduto a Parigi, perché Galli della Loggia scriveva che esiste un problema islam, «un insieme di religione, di cultura e storia, riguardante in totale circa un miliardo e mezzo di esseri umani dove nel complesso (nel complesso perché vi sono anche le eccezioni e sarebbe da stupidi ignorarle) vigono regole diverse e perlopiù incompatibili con quelle che vigono in quasi tutte le parti del mondo». Questo è il punto. Ma il Corriere ha pensato bene di nasconderlo il più possibile, titolando sull’11 settembre dell’Europa, di cui peraltro nell’articolo non si fa nemmeno cenno e che comunque sarebbe sbagliato perché l’Europa ha già avuto i suoi 11 settembre con le bombe nel metrò di Londra (52 morti) e sui treni alla stazione di Madrid (191 morti).
Vietato illudersi: l'islam è il nemico, continua Belpietro. "È un nemico che trattiamo da amico. Che tuttavia ci odia e ci disprezza con intensità". Sono passati dieci anni da quando Oriana Fallaci scrisse queste frasi sulla prima pagina del Corriere. La più conosciuta e stimata giornalista italiana era appena stata denunciata per vilipendio all’Islam, perché nei suoi libri e nei suoi articoli si era permessa di metterci in guardia contro il Mostro, così lo chiamava, e di mettere in dubbio la fandonia dell’Islam buono contro quello cattivo. Oriana si opponeva alla nascita della moschea di Colle val d’Elsa, sosteneva che il mondo occidentale era in guerra e doveva battersi, attaccava il multiculturalismo, la teoria dell’accoglienza indiscriminata, la dottrina cattolica che insegna ad amare il nemico tuo come te stesso. E per questo, per quel che scriveva, fu considerata pazza dall’intellighezia progressista mondiale, quasi che l’integralista fosse lei, lei armata di penna e taccuino e non gli islamici armati di esplosivi, coltelli e kalashnikov che noi abbiamo invitato nelle nostre case e nelle nostre città, consentendo loro - in virtù della libera circolazione imposta dal trattato di Schengen - di viaggiare a loro piacimento, senza controlli e con la possibilità di organizzare qualsiasi massacro. Oriana è morta da anni, ma le sue nere profezie si stanno realizzando puntuali come erano state previste. Quel che è accaduto ieri nella redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo, una delle poche testate che anni fa difesero nel silenzio generale il coraggio della scrittrice toscana, è esattamente ciò che lei aveva immaginato.
Il lungo incubo di Coco: «Ho aperto quella porta e hanno sparato a tutti». Parla la vignettista che per prima ha incontrato i due attentatori del «Charlie Hebdo» I due boia incappucciati le hanno puntato i kalashnikov alla testa, scrive Elisabetta Rosaspina “Il Corriere della Sera”. «Faccio attenzione quando si tratta di religione. Ci penso due volte prima di fare un disegno. Ma non mi autocensuro, è fuori questione» garantiva tre anni fa «Coco» al sito della cittadina di Carquefou (Loira Atlantica) dove ogni anno, dal 2000, si organizza il festival dei caricaturisti. Era stata lei, Corinne Rey, giovane disegnatrice, allora non ancora trentenne, ma già affermata nel mondo della stampa, a disegnare il manifesto dell’happening del 2011. Un signore dalle grandi fauci che inghiotte il mondo infilzato su uno stecchino, come fosse un’oliva. È lei, Corinne Rey, la mamma cui mercoledì mattina, sotto gli uffici di Charlie Hebdo , a Parigi, i due boia incappucciati hanno puntato i kalashnikov alla testa, ingiungendole di comporre il codice d’ingresso alla sede della redazione, l’ultimo ostacolo tra i killer e le loro prede. Gli assassini non l’hanno riconosciuta come una delle firme del settimanale e, forse, l’hanno risparmiata per questo. O perché, come invece ha ipotizzato lei, non si sono accorti che scivolava al riparo di una scrivania. Ma quella carneficina resterà negli occhi della giovane donna per sempre. «Superato l’ingresso hanno sparato a Wolinski poi a Cabu. Erano seduti uno accanto all’altro. Tutto è durato cinque minuti, forse anche meno. Una pioggia di colpi», ha rivissuto poco dopo il suo incubo, parlando al telefono con i colleghi de «L’Humanité ». Sotto choc, ma anche sotto protezione, come testimone diretta e ravvicinata di quel bagno di sangue, Coco si è salvata perché era andata a prendere la figlioletta all’asilo. Come lei, è scampata al massacro anche un’altra disegnatrice della redazione decimata, Catherine Meurisse, arrivata in provvidenziale ritardo alla riunione settimanale. Catherine ha fatto in tempo a incrociare i due uomini mascherati mentre fuggivano dal palazzo e ha intuito che qualcosa di terribile doveva essere accaduto. Anche se qualche altro passante si era fermato incuriosito, convinto che si stesse girando un film d’azione. È salva Coco, anche se ha visto e sentito morire i suoi colleghi e se non potrà più togliersi dalle orecchie e dalla memoria le urla di soddisfazione dei carnefici che gridavano i nomi delle loro vittime mentre sparavano, come in un sordido appello: «Pagherete per aver insultato il Profeta».
Sottomissione è il romanzo più visionario e insieme realista di Michel Houellebecq, capace di trascinare su un terreno ambiguo e sfuggente il lettore.
A Parigi, in un indeterminato ma prossimo futuro, vive François, studioso di Huysmans, che ha scelto di dedicarsi alla carriera universitaria. Perso ormai qualsiasi entusiasmo verso l’insegnamento, la sua vita procede diligente, tranquilla e impermeabile ai grandi drammi della storia, infiammata solo da fugaci avventure con alcune studentesse, che hanno sovente la durata di un corso di studi. Ma qualcosa sta cambiando. La Francia è in piena campagna elettorale, le presidenziali vivono il loro momento cruciale. I tradizionali equilibri mutano. Nuove forze entrano in gioco, spaccano il sistema consolidato e lo fanno crollare. È un’implosione improvvisa ma senza scosse, che cresce e si sviluppa come un incubo che travolge anche François. Sottomissione è il romanzo più visionario e insieme realista di Michel Houellebecq, capace di trascinare su un terreno ambiguo e sfuggente il lettore che, come il protagonista, François, vedrà il mondo intorno a sé, improvvisamente e inesorabilmente, stravolgersi.
La Parigi "sottomessa" di Houellebecq divide i politici francesi. Il romanzo sull'islam fa discutere. Hollande: "Non si deve cedere a paura e angoscia". Le Pen: "E' fiction ma potrebbe diventare realtà", scrive Alessandro Gnocchi su “Il Giornale”. Questa sera Michel Houellebecq si difenderà dalle accuse scatenate dalle anticipazioni del suo nuovo romanzo Sottomissione (da domani in Francia, in Italia dal 15 gennaio per Bompiani). Lo farà sul canale televisivo France2, intervistato da David Pujadas. Ma lo scrittore ha già rivendicato il diritto, sulla Paris Review , di trattare temi d'attualità, anche scomodi. Respinte le accuse di razzismo e islamofobia, ha osservato la crisi dei valori dell'Illuminismo, il rifiuto crescente della modernità, il ritorno delle religioni, il suicidio dell'Europa e la lotta dei francesi per restare in vita. Il libro entra in pieno nel dibattito in corso da tempo in Francia sull'identità nazionale e sul corretto rapporto con l'immigrazione, specie quella di matrice religiosa musulmana. In Sottomissione , le elezioni presidenziali del 2022 sono vinte dal candidato del neonato partito musulmano, che batte la destra di Marine Le Pen grazie all'appoggio sia dei socialisti sia dei repubblicani. Parigi accetta di buon grado l'islamizzazione morbida propugnata dal nuovo governo. La Francia, forse l'intera Europa, rinuncia alla libertà avvertita come un inutile fardello, il retaggio di un passato ormai finito. La sfiduciata cultura occidentale non può non cedere di fronte alle forti rivendicazioni identitarie dei musulmani. Il protagonista di Sottomissione , un professore esperto di Joris Karl Huysmans, accetta senza opporsi l'islamizzazione dell'università, e in questo segue a suo modo le orme dell'oggetto dei suoi studi. Huysmans, l'autore di A ritroso , passò infatti dal Naturalismo al Cattolicesimo («lo fece per ragioni estetiche, restando freddo di fronte alle grandi domande di Pascal», precisa Houellebecq nella citata intervista alla Paris Review ). Fantapolitica? Dipende dai punti di vista. Dopo critici, filosofi e opinionisti, sono intervenuti i pesi massimi della politica francese. Il presidente della Repubblica, il socialista François Hollande, ha detto che leggerà Sottomissione non appena possibile. Nel frattempo osserva che la tentazione di denunciare «la decadenza, il declino, di esternare pessimismo e dubitare di se stessi» è una costante di molta letteratura, non solo di questo secolo. «Ciascun autore è libero di esprimere quello in cui crede. Il mio compito, invece, è invitare i francesi a non cedere alla paura, all'angoscia». Perché nel Paese ci sono «forze positive» capaci di porre rimedio alle situazioni incerte e di migliorare le condizioni generali. Del resto, pochi giorni prima di Natale, Hollande aveva dichiarato che gli immigrati servono, e il resto è demagogia. Di parere radicalmente opposto la leader del Fronte Nazionale, Marine Le Pen, tra i personaggi del romanzo stesso: « Sottomissione è un libro interessante. È fiction ma potrebbe diventare realtà. Il patto pro islam tra socialisti e repubblicani, in opposizione alla nostro destra, si può già osservare a livello comunale o regionale».
Houellebecq, l’ultimo “Charlie Hebdo” dedicato al suo nuovo libro. Il romanziere sotto scorta ora piange l’amico morto. Disse: «Non sento una responsabilità particolare per quello che scrivo. Un romanzo non cambia la storia», scrive Stefano Montefiori su “Il Corriere della Sera”. Michel Houellebecq è scoppiato in singhiozzi, ieri, quando ha saputo che tra i morti c’era il suo amico Bernard Maris, economista alla Banca di Francia ed editorialista a “Charlie Hebdo”. Sul numero della rivista uscito poche ore prima della strage, Maris conclude con queste parole quello che sarà l’ultimo articolo della sua vita: «Ancora un romanzo magnifico. Ancora un colpo da maestro». Si riferisce a “Sottomissione”, il libro di Houellebecq che negli stessi momenti cominciava finalmente a essere venduto nelle librerie, dopo settimane di indiscrezioni, distribuzioni illegali su Internet e polemiche che, come solo in Francia può accadere, passano rapidamente dalla letteratura alla politica. È stata una giornata spaventosa per tutti. Michel Houellebecq non ha potuto che viverla in modo ancora più drammatico, per le persone colpite a lui vicine e perché quella, fino alle 11 e 30 era la «sua» giornata, quella dell’uscita del libro più atteso dell’anno, da giorni sulle prime pagine di tutti i giornali. Una giornata preceduta la sera prima da un suo intervento al tg delle 20 sul canale pubblico France 2, in cui lo scrittore di tanti romanzi tra analisi della società e profezia aveva risposto con la consueta flemma alle domande del conduttore David Pujadas. «Non sente di avere una responsabilità particolare, lei che è uno scrittore così importante e seguito?», chiedeva Pujadas. «No - aveva risposto Houellebecq -, forse un saggio può cambiare la storia, non un romanzo». Il giornalista alludeva a una voglia di provocazione - tante volte negata - di Houellebecq, che in “Sottomissione” mette in scena il fantasma più angosciante per la società francese di questi giorni: un Islam trionfante, che ha ragione per vie democratiche di una civiltà giudaico-cristiana ormai estenuata, spossata dall’Illuminismo e dal fardello di libertà che pesa su ogni essere umano. Meglio la sottomissione, allora, suggerisce François, il protagonista del romanzo: delle donne all’uomo (la poligamia viene incoraggiata, più mogli smettono di lavorare e restano a casa ad accudire un unico marito), e di tutta la società a Dio. Anzi, ad Allah. Per questo, Houellebecq è stato accusato di soffiare sul fuoco, di usare la paura per vendere libri. Ma Houellebecq è uno scrittore, di sicuro il più celebre e forse il migliore scrittore francese contemporaneo, non un opinionista né tantomeno un uomo politico. Ha il diritto di descrivere la realtà, e anche di offrirci la sua idea di quel che la realtà potrà diventare tra qualche anno, «esagerando e velocizzando», come dice lui stesso. Da quando in autunno si è saputo che il suo prossimo romanzo avrebbe dipinto questa Francia del 2022 in mano all’Islam, l’Islam per certi versi rassicurante (donne a parte) del nuovo presidente della Repubblica Mohammed Ben Abbes, il dibattito culturale - e politico - francese ha cominciato a incentrarsi su Sottomissione , fino a esserne completamente monopolizzato. L’azione militare dei terroristi è stata talmente efficace da essere probabilmente pianificata da mesi, dicono le fonti di polizia: l’uscita di Sottomissione e l’ultimo numero della rivista non c’entrano nulla. I piani si sovrappongono perché c’è la coincidenza dell’uscita nelle librerie, e perché l’ultimo Charlie Hebdo esibisce in copertina una splendida vignetta firmata Luz, almeno lui per fortuna scampato al massacro, che dipinge Houellebecq con l’eterna sigaretta e un ridicolo cappello con stelle e pianeti. Titolo: «Le predizioni del mago Houellebecq», e lo scrittore che dice «Nel 2015 perdo i denti...» (i suoi problemi odontoiatrici sono noti) e «Nel 2022, faccio il Ramadan!». Nell’ultima pagina di Charlie Hebdo , come sempre, «le copertine alle quali siete scampati»: e riecco Michel Houellebecq in braccio a una Marine Le Pen sognante che canta «Sarai il mio Malraux», disegnato da Cabu, morto nell’attentato; Houellebecq in ginocchio che sniffa una pista di cocaina stesa per strada e il titolo «Houellebecq convertito all’Islam?», disegnato da Coco, alias Corinne Rey, la donna che sotto la minaccia delle armi ha aperto la porta della redazione ai terroristi; infine, ecco un ritratto poco avvenente di Houellebecq, lo strillo «Scandalo!» e il titolo «Allah ha creato Houellebecq a sua immagine!». La firma è di Charb, il direttore, l’uomo che più di tutti gli assassini volevano uccidere. Michel Houellebecq è ovviamente sotto la protezione della polizia, come lo sono le redazioni di tutti i giornali e i locali della casa editrice Flammarion, che ieri sono rimasti chiusi. Nel romanzo, gli islamici prendono il potere vincendo le elezioni grazie a un’alleanza con gli esangui partiti di centrosinistra e di centrodestra. Prima che l’ordine coranico regni sovrano sulla Francia e l’Europa, in base al sogno di Ben Abbes di rifondare un impero romano con l’Islam al posto del Cristianesimo, in Sottomissione (uscirà in Italia il 15 gennaio per Bompiani) ci sono scontri, un timido debutto di guerra civile. E la guerra civile, il caos, sono evocati nelle dichiarazioni di mesi fa di Éric Zemmour, l’opinionista che con il bestseller Le suicide français ha generato furiose polemiche su razzismo e islamofobia, con la sua accusa rivolta ai musulmani di Francia di essere «un popolo nel popolo».
Negli ultimi giorni i migliori intellettuali e scrittori francesi, da Michel Onfray a Emmanuel Carrère, si sono pronunciati sulla polemica Houellebecq. Charlie Hebdo, Michel Houellebecq sospende la promozione di Sottomissione, scrive Angela Iannone. L'attentato di matrice terroristica al settimanale satirico francese coincide con la pubblicazione del romanzo di Michel Houellebecq, "Sottomissione". Michel Houellebecq ha deciso di "sospendere la promozione" del suo libro "Sottomissione" perché "profondamente turbato dalla morte del suo amico Bernard Maris, ucciso nell'attacco terrorista al settimanale Charlie Hebdo, nel quale sono state uccise altre undici persone". Lo ha annunciato il suo agente Francois Samuelson, secondo quanto riportato dai media francesi. Lo scrittore, che è sotto scorta, lascerà Parigi, come ha precisato il suo editore Flammarion. L'attentato terroristico alla redazione di "Charlie Hebdo", il settimanale satirico attaccato da un commando armato stamattina, coincide con due pubblicazioni. La prima è la copertina del settimanale stesso, che aveva proprio oggi come protagonista Michel Houellebecq, lo scrittore francese che nel suo ultimo romanzo "Sottomissione", immagina una Francia governata nel 2022 dai Fratelli Musulmani e lancia un allarme sulla progressiva islamizzazione del Paese. La seconda è proprio la pubblicazione di "Sottomissione", che è in uscita oggi nelle librerie francesi. Charlie Hebdo riportava oggi la caricatura dello scrittore travestito da mago, il cui titolo era "Le previsioni del mago Houellebecq" con lo scrittore francese che dice "Nel 2015 perdo i miei denti" e poi "Nel 2022 faccio il Ramadan". Sottomissione è un romanzo fantapolitico che ipotizza una Francia futura nelle mani dell'integralismo islamico. Un Paese in cui un leader musulmano impone l'islamizzazione forzata a tutti gli abitanti. Circa 300 pagine con una tiratura di 150mila copie diffuse illegalmente già prima della pubblicazione ufficiale, suscitando non poche polemiche tra l'opinione pubblica francese, che si è divisa commentando il titolo come "sublime" o "irresponsabile". Intervistato dalla radio France-Inter, Houellebecq ha minimizzato lo scandalo, ritenendo che non è sia quello il vero senso del libro e che "la parte del romanzo che fa paura è piuttosto precedente all'arrivo dei musulmani al potere. (...) Si può dire che quello è terrificante, questo regime". "Nel mio libro -continua - l'Islam non è per nulla radicale, al contrario, è una delle religioni più pacifiche che si possano immaginare. Non penso che il mio libro dipinga un Islam minaccioso".
Charlie Hebdo, Houellebecq e Sottomissione, il libro fatale. La strage nel giorno dell'uscita di Sottomissione, scrive “L’Ansa”. Gli assalitori che hanno sparato e ucciso nella sede del settimanale satirico Charlie Hebdo non hanno scelto un giorno a caso: oggi, 7 gennaio 2015, esce in Francia l'ultimo libro di Michel Houellebecq, Sottomissione (traduzione letterale della parola Islam), che in Italia arriverà il 15 gennaio. Proprio a questo libro del controverso autore di Le particelle elementari, Piattaforma, La possibilità di un'isola, il numero di Charlie Hebdo aveva dedicato un articolo e la copertina con una vignetta che ritrae lo scrittore vestito da mago e il titolo: Le previsioni del mago Houellebecq; le profezie dello scrittore sono: Nel 2015 perderò i denti, nel 2022 farò il ramadan. Perché Sottomissione proprio di questo parla: di una Francia governata nel 2022 dai Fratelli Musulmani, che riescono ad andare al governo grazie ad una (poco) incredibile alleanza con quel resta di centristi e sinistra alleate al musulmano moderato Mohammed Ben Abbes, leader di Fraternité musulmane, contro lo strapotere di Marine Le Pen. Non è solo l'ennesimo allarme di Houellebecq contro la progressiva islamizzazione del Paese. Come ha scritto Emmanuelle Carriere, Houellebecq ha il merito di essere l'unico a parlare di un problema che esiste ma che molti intellettuali sembrano ignorare. Non solo: per Carriere quella di Houllebecq è una posizione politicamente e sociologicamente ragionevole. L'Occudente si arrende per così dire dolcemente all'Islam, sfinito da secoli di razionalità e illuminismo eccessivamente responsabilizzanti. Nell'acceso dibattito intellettuale francese sul libro e sullo scrittore, non è l'unica recensione positiva incassata da Houellebecq: un altro intellettuale 'scorretto', Michel Onfray , noto per il suo trattato di ateologia e per le sue posizioni anti-cristiane e favorevole al libertinismo, ha parlato di Europa come Continente morto che volontieri si consegna all'Islam dopo averlo fatto con i mercati. E dunque, per Sottomissione, di uno scenario assolutamente plausibile. Proprio ieri, Houllebecq aveva parlato al canale francese France 2 per rivendicare il suo diritto di trattare temi di attualità e soprattutto di sottolineare la crisi dei valori dell'illuminismo e della modernità.
"Ecco la mia Francia nelle mani dell'Islam". Parla lo scrittore Michel Houellebecq. I musulmani prendono il potere. E opprimono le donne. Lo scrittore più provocatorio d’Oltralpe qui racconta “Sottomissione” il suo nuovo romanzo. E dice: «Il Corano è decisamente meglio di quello che pensavo, di lettura in rilettura. La conclusione più evidente è che i jihadisti sono cattivi musulmani», scrive Sylvain Bourmeau su “L’Espresso”. Michel Houellebecq, lo scrittore più controverso di Francia, non ama parlare con i giornalisti. Per il lancio del suo nuovo romanzo, “Sottomissione”, ha dato una sola intervista al critico Sylvain Bourmeau, che in vent'anni lo ha incontrato decine di volte e che, malgrado le critiche sincere che gli riserva anche in questa occasione, si è guadagnato la sua fiducia. “L'Espresso” pubblica in esclusiva per l'Italia il lungo colloquio che parte dalla trama del nuovo romanzo, ancora più provocatorio dei precedenti. Il libro è uscito in Francia proprio nel giorno dell'attentato a Charlie Hebdo (in Italia esce il 15 per Bompiani). E lo scrittore, che dopo aver subito un processo per islamofobia non vive più in Francia ma è a Parigi per il lancio del libro, è stato posto sotto scorta. Al centro di “Sottomissione” c'è una Francia trasformata in uno stato islamico dopo la vittoria alle presidenziali del leader di un partito musulmano. Un'ipotesi irrealistica? Non secondo Houellebecq, che ipotizza un ballottaggio con la leader della destra xenofoba Marine Le Pen. «Per la Le Pen mi pare del tutto verosimile che arrivi al ballottaggio già alle elezioni del 2017», spiega lo scrittore. «Quanto al partito musulmano, mi sono reso conto che i musulmani vivono in una situazione del tutto alienata. Sono molto lontani dalla sinistra e ancor di più dagli ecologisti. E non si vede perché dovrebbero votare per la destra, che li rifiuta. Quindi l'idea di un partito musulmano mi sembra plausibile». Il nuovo romanzo sfrutta la paura dell'Islam che serpeggia per la Francia, ammette Houellebecq. Che però è convinto che «non si può definire “Sottomissione” una predizione pessimista». Anche perché, dichiara a sorpresa, «il Corano è decisamente meglio di quello che pensavo, di lettura in rilettura. La conclusione più evidente è che i jihadisti sono dei cattivi musulmani. La guerra santa di aggressione non è permessa per principio, e solo la predicazione è valida. Dunque si può dire che ho cambiato un po’ opinione. È per questo che non ho l’impressione di essere nella situazione di dover avere paura. Ho l’impressione che ci si possa mettere d’accordo».
«La civiltà dell’Europa è sfinita». Onfray promuove Houellebecq. «È un continente morto, oggi in mano ai mercati. Domani forse all’islam», scrive Stefano Montefiori su “Il Corriere della Sera”. Il nuovo romanzo di Michel Houellebecq, Sottomissione , immagina una Francia del 2022 governata da un presidente musulmano e un nuovo ordine sociale che prevede poligamia e donne che restano a casa a occuparsi di mariti e figli in omaggio a una religione - l’islam - che ha trionfato sulla civiltà dell’Illuminismo. Prima ancora dell’uscita (il 7 gennaio in Francia per Flammarion e il 15 gennaio in Italia per Bompiani) il libro scatena polemiche e discussioni, tra riconoscimento del valore letterario e critiche a una presunta voglia di provocazione. Il «Corriere» ha sollecitato l’opinione di Michel Onfray, uno dei più noti intellettuali francesi, autore di decine di opere tra le quali il celebre Trattato di ateologia e una Controstoria della filosofia (Ponte alle Grazie); un pensatore ateo che ha letto - e amato - il romanzo del momento.
Visto che «Sottomissione» è un romanzo e non un saggio, è possibile separare il valore letterario dal contenuto profetico?
«È un esercizio di stile, una fiction politica ma anche metafisica: un romanzo sull’ignavia delle persone, degli universitari in particolare. Un romanzo molto anarchico di destra. Un libro sulla collaborazione, vecchia passione... francese! Come un universitario specialista di Huysmans può convertirsi all’islam? Ne scopriamo le ragioni poco alla volta: la promozione sociale in seno all’istituzione riccamente finanziata dai Paesi arabi, gli stipendi mirabolanti dei convertiti, la possibilità della poligamia, una ragazza per il sesso, un’altra meno giovane per la cucina, una terza se si vuole, il tutto continuando a bere alcool... Questo libro è meno un romanzo sull’islam che un libro sulla collaborazione, la fiacchezza, il cinismo, l’opportunismo degli uomini...».
La parte più scioccante è forse il destino riservato alle donne. Qual è la sua opinione? È concepibile nella nostra società un’evoluzione simile?
«La nostra epoca è schizofrenica: bracca il minimo peccato contro le donne e, per fare questo, milita per la femminilizzazione dell’ortografia delle funzioni, la parità nelle assemblee, la teoria di genere, il colore dei giocattoli nelle bancarelle di Natale; la nostra epoca prevede che ci si arrabbi se si continua a rifiutare auteure o professeure (femminili di autore e professore ), ma fa dell’islam una religione di pace, di tolleranza e di amore, quando invece il Corano è un libro misogino quanto può esserlo la Bibbia o il Talmud. Se si vuole continuare a essere misogini con la benedizione dei sostenitori del politicamente corretto, l’islam alla Houellebecq è la soluzione!».
In una sua prima intervista alla «Paris Review», Houellebecq decreta la fine dell’Illuminismo e il grande ritorno della religione (l’islam, ma non solo). In quanto pensatore ateo, qual è la sua reazione?
«Credo che abbia ragione. I suoi romanzi colgono quel che fa l’attualità del nostro tempo: il nichilismo consustanziale alla nostra fine di civiltà, la prospettiva millenarista delle biotecnologie, l’arte contemporanea fabbricata dai mercati, le previsioni fantasticate della clonazione, il turismo sessuale di massa, i corpi ridotti a cose, la loro mercificazione, la tirannia democratica, la sessualità fine a se stessa, l’obbligo di un corpo performante, il consumismo sessuale, eccetera. Quindi, utilizzare i progressi incontestabilmente compiuti dall’islam in terra d’Europa per farne una fiction sull’avvenire della Francia è un buon modo per pensare a quel che è già».
Houellebecq descrive una società francese ed europea stanca, affaticata dalla perdita di valori tradizionali. Cosa pensa? L’Europa è condannata, come dicevano i neocon americani?
«Houellebecq continua a dipingere il ritratto di una Francia post-68. E ha ragione di vedervi un esaurimento, meno in rapporto con il breve termine del Maggio 68 che con il lungo periodo della civiltà giudaico-cristiana che crolla. Questa civiltà è nata con la conversione di Costantino all’inizio del IV secolo, il Rinascimento intacca la sua vitalità, la Rivoluzione francese abolisce la teocrazia, il Maggio 68 si accontenta di registrarne lo sfinimento. Siamo in questo stato mentale, fisico, ontologico, storico. Houellebecq è il ritrattista terribile di questo Basso Impero che è diventata l’Europa dei pieni poteri consegnati ai mercati. L’Europa è morta, ecco perché i politici vogliono farla!».
La mia impressione, leggendo il libro, è che si finisca per credere alla profezia. In questo sta l’abilità di scrittore di Houellebecq? O la sua previsione è davvero plausibile?
«È in effetti uno dei talenti di questo libro: il racconto è estremamente filosofico perché è estremamente credibile... Sottomissione rivaleggia con 1984 di Orwell, Fahrenheit 451 di Bradbury, Il mondo nuovo di Huxley. Per me è il migliore libro di Houellebecq, e di gran lunga. La sottomissione di cui diamo prova nei confronti di ciò che ci sottomette è attualmente sbalorditiva. È un altro sintomo del nichilismo nel quale ci troviamo».
Evocando l’islam, Houellebecq agita un fantasma molto presente nella Francia di oggi, come dimostrano i libri di Alain Finkielkraut e Éric Zemmour. È giustificata, questa preoccupazione dell’identità?
«Ricorrere alla parola fantasma è già un modo di prendere una posizione ideologica. Esiste una realtà che non è un fantasma e che coloro che ci governano nascondono: divieto di statistiche etniche sotto pena di farsi trattare da razzisti ancor prima di avere detto alcunché su queste cifre, divieto di rendere note le percentuali di musulmani in carcere sotto pena di farsi trattare da islamofobi al di fuori di qualsiasi interpretazione di queste famose cifre, eccetera. Non appena si nasconde qualcosa, si attira l’attenzione su quel che è nascosto: se non esiste che un fantasma, allora che si diano le cifre, saranno loro a parlare...».
Edward Luttwak: Islam significa «sottomissione», E questo è il suo vero obiettivo finale. L'ambiguità vi porta al macello. L'Europa, in particolare, tiene il piede in due scarpe, scrive di Goffredo Pistelli su “Italia Oggi”. A Edward Luttwak il politically correct non fa velo. Questo ebreo americano d'origine rumena, politologo e esperto di studi strategici, quando viene chiamato a parlare di terrorismo islamico, non infiocchetta distinguo ma dice quello che pensa. E il suo pensiero è spesso durissimo. È il caso di questa conversazione che ci ha concesso a poche ore dalla strage del Charlie Hebdo a Parigi.
Domanda. Mr. Luttwak questo attentato, nel cuore dell'Europa, è per gli Europei un brutto risveglio, non trova?
Risposta. Il punto non è solo di svegliarsi ma di agire.
D. Vale a dire?
R. Quello che c'è da fare è chiaro: dovete delegittimare questo trionfalismo musulmano.
D. Ma come, c'è un attacco terroristico e lei mi parla del trionfalismo? Che c'entra?
R. Centra, perché il trionfalismo è quello che crea un'atmosfera per cui qualcuno si sente in diritto di uccidere la gente.
D. Ma a quale trionfalismo si riferisce?
R. Quello praticato da persone, ragazze magari, che vanno con il hijab indosso per dimostrare la loro partecipazione a questa forma estrema di islamismo. Magari parlano perfettamente l'italiano, sono carine e gentili, dicono «non siamo affatto sottomesse», ma poi difendono Hamas, con la sua costituzione genocida.
D. Si riferisce a quel dibattito piuttosto animato che ha avuto in dicembre durante una puntata di Announo (in cui Luttwak, collegato dagli Usa, si toglieva l'auricolare quando parlava una giovane esponente musulmana in studio, ndr)?
R. Non mi riferisco a niente in particolare. Dico che queste persone vendono falsità a cominciare dall'etimologia stessa di Islam, che vuol dire «sottomissione», mentre loro dicono che significhi «amore».
D. Quella musulmana non è una religione come tutte le altre?
R. No, perché appunto vuole tutte le altre sottomesse. E in questa sottomissione prevede che le persone e gli Stati chinino il capo. Il disegno è che lo faccia Roma, Parigi, Washington.
D. Non c'è possibilità di discussione, quindi?
R. È inutile perdersi in chiacchiere con gente come Tariq Ramadani (scrittore e imam ginevrino di origine egiziana, che piace molto al mondo francofono, ndr), dovete sfrondare, dovete smettere di legittimarli o vi ritroverete quattro pazzoidi col kalashinikov in pugno, come questi di Parigi, che magari fino a ieri avevano fatto il ragioniere, l'architetto, il medico.
D. Sfrondare come?
R. Smettendo per esempio di parlare per acronimi: basta dire Isis. Cominciate a chiamarlo Stato islamico. E a cessare di trattare la religione musulmano come le altre. Capisco, che sia troppo spinoso, ma dovete ammettere che l'unico scopo di quel credo è sottomettere gli altri.
D. Nessuno la fa, secondo lei?
R. Ci sono già editori e giornalisti che, in Europa, hanno deciso di non occuparsi di questi cose e stare alla larga da queste vicende. La sottomissione comincia così.
D. E con gli islamici europei nessun dialogo è possibile allora?
R. L'unico dialogo è questo: «Riformatevi e diventate un altro tipo di religione». Non possono venire a dirci che non stanno con Isis perché sono brutti e cattivi, in quanto tagliatori di teste, e schierarsi con Hamas che, all'articolo 7 della propria Costituzione, prevede l'uccisione di tutti gli ebrei. Il giornalista, l'intellettuale e chiunque altro appoggi Hamas non merita di stare nella società civile, in quanto sostiene un'intenzione genocida proclamata.
D. Ma l'Europa della politica che cosa dovrebbe fare?
R. Essere meno ipocrita. Francois Hollande lo è quando avalla l'idea di un Islam moderato. È una falsa moderazione: l'imam che non perde un congresso sul dialogo interreligioso, lo trovi poi su YouTube con le prediche in arabo con cui chiama tutti alla jihad, alla guerra santa. I politici europei smettano di essere ipocriti perché, così facendo, indeboliscono milioni di post-islamici del Vecchio Continente.
D. Di chi parliamo?
R. Di quegli immigrati, oggi spesso cittadini francesi, tedeschi, belgi, olandesi, che hanno voltato le spalle alla religione musulmana perché hanno capito che è irreformabile. Sono quelli che lasciano andare le loro moglie vestite all'occidentale, che non menano le loro figlie perché si scoprono le braccia. Vivono in Europa e oggi sono in imbarazzo a causa dell'ipocrisia di tanti vostri primi ministri.
D. Che cosa c'è nelle menti di chi ha organizzato l'attentato di Parigi? Le bombe ai treni in Spagna, nel 2004, spodestarono José Maria Aznar, impedendone la rielezione. Le raffiche parigine vogliono favorire l'avvento delle destre in Europa? Vogliono alzare il livello di scontro?
R. Alzare il livello dello scontro sarebbe sbagliato. Però siete di fronte a una scelta: o delegittimate l'Islam o delegittimate la democrazia.
Macellai islamici. Una dichiarazione di guerra all'Europa e alla libertà. Ma noi #nonabbiamopaura, scrive Alessandro Sallusti su “Il Giornale”. Questa è guerra. Altro che islam buono e islam cattivo, altro che multiculturalismo come risorsa e porte aperte all'immigrazione come dovere, altro che «cani sciolti». Hanno fatto strage di giornalisti nel cuore di Parigi, cioè nel cuore dell'Europa, in nome di Allah. Qualcuno li ha addestrati, qualcuno li ha istruiti, qualcuno li ha mandati a sparare agli inermi colleghi del settimanale satirico Charlie Hebdo (la cui testata oggi è affiancata alla nostra in segno di solidarietà). E siccome loro hanno urlato, tra una raffica e l'altra, che il mandante è Allah, ecco allora io dico: per loro Allah è il capo dei terroristi che vogliono sopprimere le basilari libertà dell'Occidente. Dico che l'immigrazione selvaggia è il grimaldello per entrare nella nostra storia, nelle nostre città. Dico che non ci sarà mai possibilità di integrazione, perché come scriveva Oriana Fallaci «non è vero che la verità sta sempre nel mezzo, a volte sta da una sola parte». E non ho dubbi che la parte giusta è la nostra, quella di una «civiltà superiore» (sempre per citare Oriana) che mai si sognerebbe di alzare un dito su Crozza per le sue imitazioni satiriche di Papa Francesco. Abbiamo un problema di polizia, di servizi segreti che fanno acqua, ma prima ancora abbiamo un problema politico e culturale di soggezione (vero presidente Boldrini?) nei confronti dei nostri carnefici, passati (vedi le scuse per Guantanamo), presenti (le cautele e i distinguo di oggi) e futuri. Io odio questa gente, così come gli uomini liberi hanno odiato nazisti e stalinisti. Il problema non è farsi ammazzare, ma farlo in silenzio. È spalancare le porte di casa senza nulla chiedere in cambio al nemico che si presenta con la faccia affamata e sofferente del profugo. È rinunciare a crocefissi, presepi e tradizioni per non offenderli. È inculcare - anche da parte di eminenti cardinali della Chiesa - nei nostri bambini l'idea che Gesù e Allah pari sono. È stato rinunciare - e lo dico da laico - a inserire le «radici cristiane» nella Costituzione europea. È non capire che siamo sull'orlo di una guerra civile europea tra islamici di passaporto europeo e il resto d'Europa. Non kamikaze invasati, ma banditi con tecniche brigatiste che vogliono salvare la loro vita, togliendola agli altri in nome di Allah. Per ribadire la nostra libertà, oggi ripubblichiamo quelle vignette che sono costate la vita ai colleghi francesi, senza che una sola di esse violasse le leggi di quel Paese. A noi i terroristi non hanno mai fatto paura. Ci fanno più paura le «attenuanti culturali» con cui la nostra magistratura troppo spesso giustifica le violazioni delle nostre leggi. E il termine «inarrestabile» usato per arrendersi all'immigrazione selvaggia. Avanti così, qui di «inarrestabile» ci sarà solo la fine dell'Occidente. E a questo gioco, noi non ci staremo mai. Che piaccia o no ad Allah.
L'editoriale-shock del Financial Times: "Stupidi i giornalisti di Charlie Hebdo", scrive “Libero Quotidiano”. È una voce fuori dal coro, una presa di posizione durissima e controcorrente mentre tutto il mondo condannava la strage nella redazione di Charlie Hebdo stringendosi alle famiglie dei morti. E' quella del quotidiano britannico Financial Times, che in un editoriale sul suo sito online afferma che i giornalisti e i vignettisti della rivista satirica francese si sono comportati in modo “stupido”. Il Ft accusa il magazine, che in passato era stato già colpito per la pubblicazione delle vignette su Maometto, di aver peccato di “stupidità editoriale” attaccando l’Islam. “Anche se il magazine si ferma poco prima degli insulti veri e propri, non è comunque il più convincente campione della libertà di espressione“, si legge ancora. Sui social network gli altri media offrono giornalisti e solidarietà, ma il giornale della City invece attacca chi ha con quelle vignette causato la reazione terroristica. “Con questo non si vogliono minimamente giustificare gli assassini, che devono essere catturati e giudicati, è solo per dire che sarebbe utile un po’ di buon senso nelle pubblicazioni che pretendono di sostenere la libertà quando invece provocando i musulmani sono soltanto stupidi”. L'editoriale si chiede anche “quale impatto” gli omicidi “avranno sul clima politico, e in particolare le sorti di Marine Le Pen e il suo estrema destra Fronte Nazionale“.
Altro che moderati. Nel Corano i precetti dei killer. La carneficina della redazione del giornale francese mostra all'Occidente la verità che ci rifiutiamo di vedere. È il Corano a prescrivere l'omicidio contro gli "infedeli", scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Ciò che veramente mi sconvolge è il fatto che, subito dopo la condanna di rito e scontata della strage nella sede di Charlie Hebdo , la preoccupazione generale di tutti, quasi tutti, dal presidente americano Obama al presidente della Camera Boldrini, è di scagionare l'islam sostenendo che l'islam è una religione di pace, che Maometto non c'entra, che la stragrande maggioranza dei musulmani «moderati» sono contrari alla violenza e che i terroristi islamici sono una scheggia impazzita che offende il «vero islam». Eppure se c'è un caso emblematico che ci fa toccare con mano la contiguità e la consequenzialità sul piano del pensiero e dell'azione tra i sedicenti musulmani moderati e i terroristi islamici è proprio questo caso specifico che mette a confronto il divieto assoluto di raffigurare Maometto, precetto condiviso da tutti i fedeli di Allah, con l'esercizio della libertà d'espressione che è il fulcro della nostra civiltà occidentale. Questa strage è la punta dell'iceberg di un contesto saturo di odio per la diffusione di vignette satiriche nei confronti del profeta dell'islam, alimentato e condiviso da lunghi anni da tutti i musulmani di Francia. A partire dai «moderati» della Grande Moschea di Parigi, che rappresenta l'islam istituzionale ed è il referente del governo francese, e dai militanti «moderati» dell'Uoif (Unione delle organizzazioni islamiche in Francia) che s'ispirano all'ideologia dei Fratelli musulmani, che nel 2007 intentarono e persero un processo contro Charlie Hebdo perché aveva ridiffuso delle vignette su Maometto bollate come blasfeme pubblicate dal quotidiano danese Jyllands-Posten . Così come altri terroristi islamici, evidentemente meno professionisti di quelli di ieri, avevano devastato nel 2011 la sede di Charlie Hebdo con una bottiglia molotov. Quella di ieri è stata una vera e propria azione di guerra condotta da terroristi che hanno combattuto e che uccidono spietatamente i nemici di Allah. Probabilmente si tratta di reduci dalla Siria o dall'Irak, dove si stima che almeno 600 cittadini francesi si siano uniti ai terroristi dell'Isis, dello Stato islamico dell'Irak e del Levante. Una realtà che ci obbliga a prendere atto che il terrorismo islamico nella sua versione più feroce è ormai un fenomeno endogeno, interno all'Europa, e che i suoi protagonisti sono cittadini europei musulmani. Così come nel maggio 2013 due terroristi islamici britannici, di origine nigeriana, decapitarono a Londra il soldato venticinquenne Lee Rigby, ieri a Parigi abbiamo assistito a un atto di guerra inedito per il contesto urbano europeo. La Francia, che è il Paese europeo che accoglie il maggior numero di musulmani è, insieme alla Gran Bretagna, il Paese multiculturalista per antonomasia, quello più a rischio di attentati terroristici islamici. E non è un caso. Quanto è accaduto evidenzia il fallimento di un modello di convivenza che precede il fallimento dell'attività dei servizi di sicurezza. Alla base c'è l'ideologia del relativismo con cui noi europei ci autoimponiamo di non usare la ragione per non entrare nel merito dei contenuti delle religioni, perché aprioristicamente le vogliamo mettere sullo stesso piano attribuendo così a ebraismo, cristianesimo e islam la stessa valenza, finendo per legittimare l'islam a prescindere da ciò che prescrive il Corano e da ciò che ha detto e ha fatto Maometto. Così come c'è l'ideologia parallela del multiculturalismo che ci ha portato a concedere a ciascuna comunità etnico-confessionale il diritto di autogovernarsi anche se, ad esempio, la poligamia e l'uccisione dell'apostata in cui credono indistintamente tutti i musulmani, sono in flagrante contrasto con il nostro Stato di diritto. Il fallimento dei servizi di sicurezza è anch'esso legato a un deficit culturale frutto della tesi ideologica secondo cui l'islam è buono a prescindere mentre i terroristi islamici non sarebbero dei «veri musulmani», anche se - come si è ripetuto ieri - massacrano invocando «Allah è grande» e chiarendo «vendicheremo il nostro profeta Maometto». Noi europei saremo inesorabilmente condannati ad essere sconfitti fintantoché non prenderemo atto che il terrorista islamico è solo la punta dell'iceberg di un retroterra che l'ha fatto emergere e che si sostanzia di una filiera che inizia laddove si pratica il lavaggio di cervello predicando e inculcando l'odio, la violenza e la morte nei confronti dei nemici dell'islam. La strage di Charlie Hebdo sostanzia il frutto avvelenato del reato di «islamofobia», il divieto di criticare l'islam, il Corano e Maometto. Si tratta di un pericolo che conosciamo bene anche in Italia. Quell'atrocità potremmo viverla anche qui a casa nostra.
Quell'islam moderato che dietro le quinte finanzia la guerra santa. Dai movimenti che in Italia bruciano false bandiere dell'Isis a Turchia e Qatar, che fingono amicizia con l'Occidente e danno soldi alla jihad, scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Non ho mai avuto dubbi che i musulmani possono essere delle persone moderate, essendolo stato per 56 anni. Ma non credo affatto nei militanti del cosiddetto «islam moderato». Quelli che ad esempio lo scorso 21 settembre in Piazza Affari a Milano, usando uno stratagemma e ingannando il pubblico credulone compresi i giornalisti, diedero alle fiamme non la bandiera dell'Isis, che reca la scritta «Non vi è altro dio al di fuori di Allah» e «Maometto è l'inviato di Allah», bensì un drappo nero su cui avevano scritto a mano in italiano «Isis». Eppure stampa e tv hanno titolato: «I musulmani moderati bruciano la bandiera dell'Isis»! La verità è semplice: di islam ce n'è uno solo, Allah è lo stesso per i moderati e per i terroristi, Maometto è il profeta a cui si rifanno tutti i musulmani indistintamente. Bisogna ammettere che in fatto di bandiere fasulle i musulmani nostrani eccellono. Quando il 5 gennaio 2009 circa un migliaio di islamici arruolati dall'Ucoii (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia) occuparono lo spazio antistante la Basilica di San Petronio a Bologna (che custodisce l'affresco di Giovanni da Modena con Maometto all'Inferno tra i seminatori di discordie, così come lo volle Dante), e diedero alle fiamme le bandiere israeliane, la Procura di Bologna li assolse perché erano da considerarsi «un drappo artigianalmente predisposto con un simbolo grafico», che deve essere ritenuto «un simulacro» e «un tentativo di emulazione», ma non la bandiera israeliana ufficiale! In realtà la contiguità tra i militanti del sedicente «islam moderato» e i terroristi islamici non si limita alla devozione dei nomi di Allah e di Maometto che fanno sì che la bandiera dell'Isis non possa essere bruciata, ma abbraccia l'insieme di un'ideologia che promuove la conversione all'islam, l'instaurazione della sharia e la riesumazione del Califfato. Il caso eclatante è quello della Turchia del regime islamico di Erdogan. A partire dal 2005 l'Occidente si è affidato totalmente alla Turchia nell'illusione che sarebbe riuscito a portare l'«islam moderato» dalla sua parte nella guerra contro Al Qaida. Assecondando la volontà di Erdogan, Stati Uniti e Unione Europea legittimarono politicamente i Fratelli Musulmani che sono riusciti a prendere il potere nei Territori palestinesi con Hamas, in Tunisia con Ennahda, in Libia e in Egitto, mentre in Siria hanno scatenato la guerra del terrore contro Assad. Ebbene la verità è che i turchi sono presenti in massa al vertice e nelle fila delle organizzazioni terroristiche, 2000 in seno a Jabhat al Nusra, affiliata ad Al Qaeda in Siria, e 3000 in seno all'Isis, forti del sostegno di Erdogan che fornisce loro assistenza militare, cure mediche e denaro in cambio del petrolio estratto nello «Stato islamico». Altro caso significativo della contiguità tra l'«islam moderato» e il terrorismo islamico è quello del Qatar, principale finanziatore dei Fratelli Musulmani in tutto il mondo e dei gruppi terroristici affini in Siria, Libia e Tunisia, particolarmente impegnato negli investimenti in Europa come copertura alla più massiccia campagna di costruzione di moschee. Soltanto in Italia, a fronte dell'acquisto di alberghi di lusso, il St. Regis e l'InterContinental a Roma, il Gallia a Milano, il Four Seasons a Firenze e i resort sulla Costa Smeralda, il Qatar Charity Foundation ha donato 6 milioni di dollari ai centri islamici in Sicilia, mentre altre decine di milioni di dollari sono state donate - così come si legge sul suo sito - ai centri islamici a Saronno, Colle Val d'Elsa, Frosinone, Lecco, Roma, Ferrara, Bergamo, Sesto San Giovanni, Modena, Città di Castello, Vicenza, Verona, Torino, Mortara, Olbia, Mirandola, Taranto, Milano, Argenta (Ferrara), Gavardo (Brescia), Quingentole (Mantova). La verità è che il loro jihad, la guerra santa islamica, si traduce comunque nella nostra sottomissione: noi «perdiamo la testa» sia quando i terroristi ci decapitano, sia quando i «moderati» ci condizionano a tal punto da impedirci di usarla per salvaguardare la nostra civiltà.
Il predicatore radicale Choudary: "L'islam non crede alla libertà di pensiero". Dopo l'attacco a Charlie Hebdo difende l'idea che ci debbano essere dei limiti. "Le conseguenze sono note a tutti", scrive Lucio Di Marzo su “Il Giornale”. "L'islam non è pace, ma piuttosto sottomissione ai comandi del solo Allah. Per questo i musulmani non credono nell'idea della libertà d'espressione, perché le loro parole e azioni sono determinate dalla rivelazione divina e non basate sui desideri della gente". La pensa così Anjem Choudary, un predicatore radicale tra i più ascoltati in Europa, intervistato su queste pagine alcuni mesi fa da Barbara Schiavulli, per un reportage nell'Europa estremista. Dopo l'attacco contro la redazione del Charlie Hebdo, in cui sono morte dodici persone, tra le quali giornalisti e il direttore del magazine satirico, ha riassunto in una lettera pubblicata da Usa Today il suo pensiero sui fatti, in netta contraddizione con opinioni molto più moderate espresse da altri imam e fedeli musulmani. "Persino i non musulmani che sposano l'idea della libertà di pensiero sono d'accordo sul fatto che comporti delle responsabilità", scrive Choudary, che ammonisce: "Le potenziali conseguenze dell'insultare il Messaggero Muhammad sono note a musulmani e non musulmani". Parole che suonano come un tentativo di giustificare fatti impossibili da legittimare. "Proprio perché l'onore del Profeta è qualcosa che tutti i musulmani vogliono difendere, molti prenderanno la legge nelle proprie mani", aggiunge il predicatore radicale, che ricorre poi a un argomento molto utilizzato da chi si colloca su posizioni estremiste come le sue. "I governi occidentali sono contenti di sacrificare libertà e diritti quando complici di torture e rendition - scrive - o quando limitano la libertà di movimento ai musulmani, sotto le mentite spoglie della difesa della sicurezza nazionale". E al governo francese chiede perché "mettere a rischio i propri cittadini" continuando a provocare il mondo islamico, come accusa il Charlie Hebdo di avere fatto. Parole, quelle del predicatore, che stupiscono fino a un certo punto. Già in passato aveva lodato gli attentatori dell'11 settembre e al Giornale aveva detto: "Bin Laden è il nostro eroe. Purtroppo è morto, ma la lotta continua anche senza di lui".
Chi l'ha visto il servizio pubblico sulla carneficina dei giornalisti? La figuraccia della Rai, scrive Maurizio Caverzan su “Il Giornale”. Il servizio pubblico della Rai? Chi l'ha visto?. Ma anche L'apprendista stregone e Che Dio ci aiuti . Sono i programmi trasmessi nella serata della strage terroristica di Parigi, definita da molti osservatori l'11 settembre dell'Europa. Niente speciali, zero edizioni straordinarie. Titoli che, riletti oggi, svelano un sapore autocritico verso quella che è una delle pagine più nere dell'informazione pubblica. Facevi zapping da un canale all'altro, mercoledì sera, e trovavi un programma di cronaca nera, un film qualsiasi, su Raiuno addirittura la replica di una fiction. L'informazione può attendere. E il famigerato approfondimento, totem dei talk show che sgomitano quotidianamente nei nostri teleschermi, può mettersi in fila. Senza spingere. Quando invece ci sono dodici morti causati da un atto terroristico nella redazione di un giornale della capitale francese, tutti assenti. In vacanza o chissà. Dopo i tg che hanno conquistato ascolti ben al di sopra della media, lo Speciale TgLa7 di Enrico Mentana è stato un approdo obbligato come lo zapping sulle reti all news , a cominciare da Rainews24 , la più solerte fin dal mattino a rendersi conto della gravità dell'accaduto. Su Mediaset, Retequattro ha aperto una lunga finestra dopo il tg con Mario Giordano e Paolo Del Debbio, mentre Matrix di Luca Telese è andato in onda in edizione straordinaria. In Rai solo a notte inoltrata arriverà uno spezzone di Porta a Porta nel tentativo di tamponare una falla gigantesca. Ma dopo il collegamento con Di Bella e le dichiarazioni del ministro Alfano, vedere Gigi D'Alessio e Lina Sastri commuoversi per la scomparsa del povero Pino Daniele aveva un inevitabile effetto-extraterrestre. Servizio pubblico latitante. Lacunoso. Ritardatario. Sui social network è un diluvio di proteste, di lamentele contro un canone - il cui pagamento la Tv pubblica ricorda in questi giorni con petulanza - purtroppo non corrisposto da servizi all'altezza in un momento storico come questo. Il ritardo sulla notizia si è accumulato fin dalla tarda mattinata quando, come ha notato tal Nicolino Berti su Twitter , «solo Raitre in edizione straordinaria su Parigi, Raiuno deve prima far scolare la pasta alla Clerici». I telegiornali Rai hanno fior di corrispondenti nella Ville Lumière, anche uno di lunga esperienza come Antonio Di Bella. Ma quella di mercoledì 7 gennaio, prima giornata post-festività, rimarrà una pagina buia. Il giorno dopo, la polemica infiamma. Il sindacato dei giornalisti Rai si straccia le vesti («Come si può parlare di riforma se poi di fronte a una vicenda di questa portata, il servizio pubblico non reagisce mettendo in campo almeno su una delle tre reti uno speciale di prima serata?»). Proteste arrivano da quasi tutte le forze politiche che hanno deciso di chiedere spiegazioni al dg Luigi Gubitosi. Riflessi appannati dai troppi dolciumi nelle calze della befana? Sottovalutazione dell'accaduto? Disabitudine alle dirette su fatti internazionali? Intoppi o veti burocratici sembrano da escludere. Non risulta, infatti, che siano state avanzate richieste di modifica dei palinsesti della prima serata dai vari direttori di rete o di testata ai quali compete la valutazione degli avvenimenti. Spostare la replica di Che Dio ci aiuti non sarebbe stato difficile nemmeno per i vertici di Viale Mazzini. Ora, dopo l'ennesima giornata nera, ci si augura che qualcosa cambi. E che Dio aiuti la Rai.
Toh, sui giornali i terroristi non sono più «islamici», scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. I «terroristi islamici» non esistono. Oggi vengono occultati dai mezzi di comunicazione di massa con l'eufemismo «jihadisti». Ma quanti italiani sanno che cosa significhi «jihadisti» o «jihad»? Il motto dei Fratelli musulmani evidenzia il significato più genuino del jihad : «Allah è il nostro obiettivo. Il Profeta è il nostro leader. Il Corano è la nostra legge. Il jihad è il nostro sentiero. Morire lungo il sentiero di Allah è la nostra aspirazione massima». Il divieto di usare il termine «terrorismo islamico» fu formalizzato nel 2006 (...)(...) dall'Unione europea. È sconvolgente il fatto che mentre i terroristi islamici sgozzano, decapitano e massacrano in ottemperanza ai versetti coranici e ai detti e fatti attribuiti a Maometto, l'Occidente - pur di negare l'evidenza - si sia spinto fino a «scomunicare» i terroristi islamici. Lo scorso 14 settembre, dopo la decapitazione dell'ostaggio britannico David Haines, il premier Cameron ha detto che i terroristi islamici dell'Isis «non sono musulmani ma mostri», «dicono di fare questo in nome dell'islam. È assurdo, l'islam è una religione di pace». Anche il presidente americano Obama, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu lo scorso 24 settembre, ha scagionato l'islam: «Gli Stati Uniti non saranno mai in guerra contro l'islam. L'islam insegna la pace». Ma lo sanno Obama e Cameron che il capo supremo del sedicente «Stato islamico», l'autoproclamato califfo Abu Bakr al-Baghdadi, oltre ad essere musulmano ha un dottorato di ricerca in Scienze islamiche? Secondo loro questi tagliatori di teste se non sono musulmani che cosa sarebbero? Di quale islam parlano? Il Corano è unico e di Maometto ce n'è solo uno. Il vescovo di Mosul, Emile Nona, intervistato da l'Avvenire lo scorso 12 agosto, ha detto che l'ideologia dei terroristi islamici «è la religione islamica stessa: nel Corano ci sono versetti che dicono di uccidere i cristiani, tutti gli altri infedeli», e che i terroristi islamici «rappresentano la vera visione dell'islam». Eppure il 23 ottobre, sotto l'egida della presidente della Camera Laura Boldrini, la stampa cattolica ( L'Avvenire , Famiglia Cristiana e la Fisc), hanno promosso la campagna «Anche le parole possono uccidere», in cui si denuncia anche l'uso della parola «terrorista» in rapporto ai musulmani. Sempre la Boldrini aveva sponsorizzato nel 2007, da portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con l'Ordine nazionale dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa, la «Carta di Roma», in cui si chiede di sostituire la parola «clandestino» con «migrante». Ebbene, dopo che nessun mezzo di comunicazione di massa usa più la parola «clandestino», ci ritroviamo in un'Italia in cui la clandestinità non solo non è più reato ma in cui risorse nazionali sono spese per favorire l'auto-invasione. Inevitabilmente accadrà lo stesso con l'abolizione della parola «terrorista islamico». Già oggi i terroristi islamici con cittadinanza europea, che rientrano dopo aver ucciso, sgozzato e decapitato in Siria e Irak, vengono accolti con la disponibilità riservata al figliol prodigo della parabola evangelica. Consentiamo che nelle moschee e sui siti Internet si predichi l'odio e la violenza nei nostri confronti, concependolo come libertà d'espressione fintantoché non si traduce concretamente nella nostra morte. Di questo passo finiremo per giustificare i terroristi islamici fino a legittimarli, sottoscrivendo noi stessi il nostro suicidio e la fine della nostra civiltà.
L'unica paura della sinistra? Che vincano gli "islamofobi". Dal Pd agli intellettuali progressisti il grande timore non è per la diffusione del radicalismo omicida islamico, ma per la crescita di consensi della destra, scrive Paolo Bracalini su “Il Giornale”. Una minaccia paurosa, un nemico dentro casa, travestito da anonimo cittadino ma pronto a colpire con la forza cieca dell'odio: è lui, l'«islamofobo». Sì c'è qualche terrorista islamico armato di kalashnikov e lanciarazzi che stermina innocenti, ma il vero problema, il vero pericolo che corrono Francia, Italia ed Europa, adesso, più che l'ascesa degli islamisti, è l'ascesa dei terribili «islamofobi», che con la scusa degli sterminii in nome di Allah rischiano di prendere parecchi voti, e questo l'Occidente non può accettarlo. Bernardo Valli su Repubblica , in un commento a caldo sui dodici morti di Charlie Hebdo, ha subito ravvisato, con un brivido lungo la schiena, il vero rischio implicito nell'attentato: «Attizzare l'islamofobia». Un pericolo da combattere con uno spiegamento di forze speciali, intelligence, ed editorialisti istruiti per educare il volgo, che sennò si impressiona e poi vota male. Scende in campo anche Federico Rampini, sempre sul giornale di De Benedetti, con la domanda che in queste ore attanaglia l'Europa dopo gli attentati jihadisti e le minacce di nuovi morti: «E adesso Marine Le Pen all'Eliseo?». Cioè la domanda non è «E adesso come ci difendiamo?» o «Adesso che fare con il radicalismo islamico», ma «E adesso Marine Le Pen all'Eliseo?». La sconvolgente conseguenza politica della carneficina, osserva l'esperto di esteri di Repubblica , è infatti che si rafforzano «i partiti xenofobi in tutta l'Europa», mentre sarebbe bene si rafforzasse il centrosinistra che piace più a De Benedetti. Adesso «una vittoria di Marine Le Pen nella corsa all'Eliseo è più probabile», mentre la Lega Nord e le formazioni «anti-immigrati» in ascesa ovunque «raccoglieranno più consensi». Ci sarebbe da arrestare i terroristi solo per il favore fatto a Le Pen e Salvini. Terrorizzato anche Khalid Chaouki, deputato Pd di origine marocchina, tra i fondatori dei Giovani Musulmani d'Italia : «Questa tragedia rischia di trasformarsi in un'occasione d'oro per l'estrema destra francese e italiana e per gli ambienti antislamici - scrive preoccupato su Il Garantista - Temo che Marine Le Pen non si lascerà sfuggire l'occasione di cavalcare l'ondata emotiva francese e soffiare sul fuoco pericoloso dell'islamofobia; perciò è doveroso ribadire con forza che noi siamo contro il terrorismo di qualsiasi matrice ma anche contro l'islamofobia, che ne è l'altra faccia». Le feroci cellule islamofobe, fagocitate dai famosi «ambienti antislamici». Gente pericolosa da cui difendersi. Nessun problema culturale di integrazione dell'Islam trova invece l'ex ministro (per mancanza di prove, direbbe Dagospia ) Cécile Kyenge, miracolata da un seggio all'Europarlamento, che invece ravvede una seria minaccia nei fondamentalisti delle brigate Salvini, riconoscibili dalle felpe: «L'unico problema culturale lo ha creato chi come Salvini e la Lega Nord avvelena la società con i suoi proclami di odio e emargina il diverso, stigmatizzandolo» spiega l'ex ministra di origine congolese, che poi mette sullo stesso piano l'Isis e la Lega Nord. «Dobbiamo fermare tutti i moderni califfi fomentatori di odio, inclusi i nuovi professionisti dell'odio politico» come l'odiato Salvini. Sempre dal Pd è il giorno di Lia Quartapelle, giovane promessa di partito alla Farnesina e poi sfumata, che su La7 ha ripetuto la vecchia storia sulle paure sfruttate dagli estremisti di destra, «che fanno lo stesso gioco dei terroristi», mentre «nessun terrorismo è di matrice religiosa». Tutti allievi, però, di Laura Boldrini, che vorrebbe persino epurare il dizionario: «la parola “clandestino” - spiegò - andrebbe cancellata, è carica di pregiudizio e negatività». Gli islamofobi, invece, direttamente ai campi di rieducazione.
A Servizio Pubblico l'islam che sta coi macellai di Parigi: "Fascisti, se la sono cercata". Gli inviati di Santoro nelle banlieue francesi danno voce alla rabbia dei musulmani: "Hanno fatto bene ad ammazzarli, erano razzisti", scrive Sergio Rame su “Il Giornale”. È la storia di due ragazzi di banlieue sprofondati nell’abisso dell’estremismo e del terrore. Sono Cherif e Said Kouachi, i due franco-algerini di 32 e 34 anni, che ieri hanno insanguinato la Francia nella strage contro Charlie Hebdo. Eppure, il primo era ben noto all’antiterrorismo di Parigi, condannato nel 2008 per aver partecipato alla filiera delle Buttes-Chaumont, cellula islamica del nord della capitale che tra il 2003 e il 2005 era impegnata nella recluta di combattenti per al Qaeda in Iraq. Ed è proprio in queste banlieue che, ieri sera, Servizio Pubblico ha portato le proprie telecamere. Nel salotto di Michele Santoro va in scena il volto violento dell'islam. "Hanno fatto bene ad ammazzarli - tuona un intervistato - erano razzisti". "Non sono stati gli islamici - fa eco un altro - è tutta una trappola". La strage alla redazione parigina di Charlie Hebdo fa da margine. Eppure le dodici persone ammazzate gridano ancora vendetta. I jihadisti che le hanno fatte fuori a colpi di kalashnikov sono ancora a piede libero. E a Servizio Pubblico c'è pure chi li giustifica, chi li difende, chi è pronto a stare dalla loro parte. Dalla parte dei violenti. Per Santoro, invece, è l'occasione buona per invitare i francesi a non votare il Front National di Marine Le Pen. Perché, a conti fatti, l'unica paura della sinistra è che alla fine vincano i partiti che loro considerano "islamofobi". Dal Partito democratico all'intellighenzia progrsessista non c'è una voce che grida contro il violento diffondersi dell'estremismo islamico. Sono tutti concentrati a tuonare contro la destra che, dall'Italia alla Francia, vede crescere i propri consensi di giorno in giorno. Eppure gli stessi servizi trasmessi dagli inviati di Servizio Pubblico parlano chiaro. Il quartiere di Saint Denis è la fotografia della polveriera su cui siede l'intera europa. Qui la concentrazione di immigrati è altissima. La stragrande maggioranza sono di fede islamica. E sono pronti a difendere, anche davanti alle telecamere, il massacro alla redazione di Charlie Hebdo. "Adesso daranno la colpa a noi - si lamenta un giovane - è sempre così". "Se è successo quello che è successo - fa eco un altro - è perché qualche colpa quelli di Charlie Hebdo ce l'hanno avuta". E ancora: "Se si offende il Profeta è naturale che qualcuno si vendichi". Mentre nelle piazze parigine si manifesta al grido Je suis Charlie, a Saint Denis di solidarietà per le dodici persone ammazzate non c'è spazio. Anche a Reims, città dei fratelli Said e Cherif Kouachi, la musica è la stessa. Nel quartiere di Croix Rouge, dove vivevano i due terroristi islamici, sono molti disposti a difenderli: "Li conoscevo, non sono terroristi". "Non possono essere stati loro - assicura un altro - è tutto un complotto".
Non eravate americani, ora non siete Charlie. Ieri come oggi dichiararsi tutti paladini della libertà è una menzogna vigliacca. Perché abbiamo rinunciato da tempo alla certezza di stare dalla parte giusta, scrive Giuseppe De Bellis su “Il Giornale”. Bugiardi, quelli che dicono o scrivono «Siamo tutti Charlie Hebdo». Mentono ora, come hanno mentito quasi 14 anni fa, quando scrivevano o dicevano «siamo tutti americani», all'indomani dell'11 settembre. È una vigliacca menzogna e qui non si parla del sentirsi oggi paladini della libertà di stampa e di satira. Qui si parla di molto di più. Dell'Occidente che si mette sul petto o sull'account dei social network lo slogan per sentirsi parte di qualcosa alla quale in realtà ha rinunciato da tempo: la certezza di stare dalla parte giusta. Ci abbiamo rinunciato quando abbiamo accettato che passasse la filosofia dei «distinguo». Il fanatismo islamico non conosce differenze: colpisce Stati e persone, militari e civili, cultura e satira. Uccide senza pietà, come ha fatto a Parigi. E la nostra risposta è il dubbio che in fondo ce la siamo cercata. O di più: che magari ci sia sotto la complicità o la manina di chissà quale potere o servizio segreto. La teoria del complotto sulla strage di Charlie Hebdo adesso appartiene a Beppe Grillo, ma presto penetrerà un pezzetto alla volta esattamente come è accaduto 14 anni fa per le Torri Gemelle. È uno dei sintomi della nostra sconfitta preventiva, questo. Aiuta la rimozione, la presa di distanza dall'evento che sconvolge le nostre coscienze nell'immediato, ma poi passa via. Il paragone con l'11 settembre sta in questo: è un ricordo sbiadito, una memoria residua, una rievocazione appannata. Dov'è finito il «siamo tutti americani» del giorno dopo? Non c'è: è sparito così in fretta da non lasciare più spazio nemmeno alla retorica. Quattordici anni sono pochi per ridurre solo a una data il momento che ha cambiato la storia, eppure non c'è un altro fatto che sia diventato passato con la stessa velocità. Sembra che l'Occidente abbia un pudore tutto suo ad alimentare la memoria e a piangere i propri morti: qualcosa che assomiglia alla paura di dare fastidio all'islam e alla vergogna per essersi sentiti tutti colpiti al cuore. Ricordiamo ossessivamente il 25 aprile, nonostante molti di noi non fossero neanche nati quel giorno e invece dimentichiamo l'11 settembre che invece abbiamo vissuto in diretta. Il secondo sintomo della nostra sconfitta sta nell'incapacità di accettare che a una guerra sporca si risponde con leggi straordinarie e a volte anche con qualcosa che sta al confine con la legge. L'hanno fatto tutti i Paesi occidentali quando hanno battuto il terrorismo domestico. Con il terrore internazionale no. Di più, abbiamo messo in discussione tutto: l'apertura di Guantanamo, gli interrogatori ai presunti terroristi, gli arresti dei sospetti. Abbiamo fatto passare i servizi segreti di tutto il mondo per criminali. Abbiamo rinunciato di fatto alla guerra in Afghanistan, convinti che i presupposti fossero sbagliati. Così via alla guerra del drone che ha pulito molte coscienze, ma in realtà ha fatto molti più morti. Anche la clamorosa campagna di autocritica sulle torture è stata un errore colossale. Noi processiamo (soprattutto noi stessi), loro fanno stragi. Allora, che significato ha il nostro senso di colpa? È una sconfitta doppia, perché rende l'Occidente ancora più vulnerabile. Qualcuno davvero pensa che se i governi avessero usato o usassero solo mezzi totalmente leciti la violenza cesserebbe o si ridurrebbe? No. Anzi, forse è il contrario. L'Occidente darebbe il segnale della sua debolezza e presterebbe il fianco a un'escalation del fanatismo. I fondamentalisti attaccano nel centro di una metropoli europea con i kalashnikov e noi applichiamo leggi ordinarie? Non abbiamo capito. Non capiamo. Non capisce soprattutto la politica, assente da 14 anni nel dibattito sulla guerra al terrorismo. Guardate l'imbarazzante reazione dell'Europa ai fatti di Parigi: non una sola voce comune, né tantomeno una voce forte di condanna o di presa d'atto che si tratta di una guerra dichiarata sul nostro territorio. L'Europa non esiste, punto. E più che sull'euro, sulla crisi, sull'austerità, lo dimostra sul terrorismo. Siamo in balia della nostra apatia e della nostra ideologia remissiva: la verità è che ci siamo autoconvinti che l'Occidente sia colpevole. Le immagini di Parigi hanno fatto rimbalzare quelle di Londra 2013, quando due inglesi di origine nigeriana uccisero sgozzandoli due agenti nell'indifferenza collettiva. Nessuna reazione. Paura, punto. L'Occidente si protegge chiedendo scusa. Perché? Ci siamo dimenticati che non siamo noi quelli dalla parte sbagliata. Ci siamo dimenticati che noi siamo le vittime.
Sull'islam aveva ragione quella "pazza" di Oriana Fallaci. L'odio per l'Occidente, il fallimento dell'integrazione: in queste righe sembra di leggere la cronaca di oggi, scrive Oriana Fallaci su “Il Giornale”. Leggete queste righe come fossero un saggio scritto ieri, e avrete una valida analisi dei fatti di attualità degli ultimi giorni. Ma, com'è ovvio, le righe che seguono sono state scritte da Oriana Fallaci non in queste ore, ma all'indomani dell'11 settembre del 2001, dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Parole scritte con rabbia e con l'intensità di cui lei era capace, ma anche con coraggio. Un coraggio che dette fastidio a chi preferiva non intendere le sue ragioni. Abbiamo deciso di ripubblicare un estratto dei suoi scritti sul rapporto tra l'Islam e l'Occidente, che si possono leggere in versione integrale nei libri editi da Rizzoli:
Con "La rabbia e l'orgoglio" (2001), Oriana Fallaci rompe un silenzio durato dieci anni, dalla pubblicazione di "Insciallah", epico romanzo sulla missione occidentale di pace nella Beirut dilaniata dallo scontro tra cristiani e musulmani e dalle faide con Israele. Dieci anni in cui la Fallaci sceglie di vivere ritirata nella sua casa newyorchese, come in esilio, a combattere il cancro. Ma non smette mai di lavorare al testo narrativo dedicato alla sua famiglia, quello che lei chiama "il-mio-bambino", pubblicato postumo nel 2008, "Un cappello pieno di ciliege". L'undici settembre le impone di tornare con furia alla macchina da scrivere per dar voce a quelle idee che ha sempre coltivato nelle interviste, nei reportage, nei romanzi, ma che ha poi "imprigionato dentro il cuore e dentro il cervello" dicendosi "tanto-la-gente-non-vuole-ascoltare". Il risultato è un articolo sul "Corriere della Sera" del 29 settembre 2001, un sermone lo definisce lei stessa, accolto con enorme clamore in Italia e all'estero. Esce in forma di libro nella versione originaria e integrale, preceduto da una prefazione in cui la Fallaci affronta alle radici la questione del terrorismo islamico e parla di sé, del suo isolamento, delle sue scelte rigorose e spietate. La risposta è esplosiva, le polemiche feroci. Mentre i critici si dividono, l'adesione dei lettori, in tutto il mondo, è unanime di fronte alla passione che anima queste pagine.
"La forza della ragione" (2004) voleva essere solo un post-scriptum intitolato "Due anni dopo", cioè una breve appendice a "La rabbia e l'orgoglio". Ma quando ebbe concluso il lavoro, Oriana Fallaci si rese conto di aver scritto un altro libro. L'autrice parte stavolta dalle minacce di morte ricevute per "La rabbia e l'orgoglio" e, identificandosi in tal Mastro Cecco che a causa di un libro venne bruciato vivo dall'Inquisizione, si presenta come una Mastra Cecca che, eretica irriducibile e recidiva, sette secoli dopo fa la stessa fine. Tra il primo e il secondo rogo, l'analisi di ciò che chiama l'Incendio di Troia, ossia di un'Europa che a suo giudizio non è più Europa, ma Eurabia, colonia dell'Islam.
Oriana Fallaci intervista se stessa (2004). “Scrivere per libertà e disobbedienza”: è il monito che ha sempre guidato Oriana Fallaci e che ha ispirato anche questo libro, terzo e ultimo volume della Trilogia iniziata con La Rabbia e l’Orgoglio (2001) e proseguita con La Forza della Ragione (2004). Completando le sue riflessioni sul declino morale e intellettuale della nostra civiltà, la grande scrittrice costruisce una lunga intervista a sé stessa e la arricchisce con uno straordinario Post-Scriptum che si rifà all’Apocalisse dell’evangelista Giovanni. Con la sua scrittura magistrale, potente, provocatoria, la Fallaci ci offre un’accorata testimonianza della sua vita e del suo pensiero: scrive con la consueta schiettezza di terrorismo islamico e della crisi europea, racconta la sua lotta contro il cancro, rimarca principi etici da difendere senza compromessi, colpisce con durissimi fendenti la pavidità della politica e traccia il ritratto senza sconti di un Occidente rassegnato e indifeso, sempre più prossimo al rischio di andare in frantumi.
Un atto di giustizia rileggerli oggi che il quadro è ancora più chiaro e molti, che le davano della pazza, sono costretti ad ammettere che invece ci aveva visto giusto.
***
Sono anni che come una Cassandra mi sgolo a gridare «Troia brucia, Troia brucia». Anni che ripeto al vento la verità sul Mostro e sui complici del Mostro cioè sui collaborazionisti che in buona o cattiva fede gli spalancano le porte. Che come nell'Apocalisse dell'evangelista Giovanni si gettano ai suoi piedi e si lasciano imprimere il marchio della vergogna. Incominciai con La Rabbia e l'Orgoglio . Continuai con La Forza della Ragione . Proseguii con Oriana Fallaci intervista sé stessa e con L'Apocalisse . I libri, le idee, per cui in Francia mi processarono nel 2002 con l'accusa di razzismo-religioso e xenofobia. Per cui in Svizzera chiesero al nostro ministro della Giustizia la mia estradizione in manette. Per cui in Italia verrò processata con l'accusa di vilipendio all'Islam cioè reato di opinione. Libri, idee, per cui la Sinistra al Caviale e la Destra al Fois Gras ed anche il Centro al Prosciutto mi hanno denigrata vilipesa messa alla gogna insieme a coloro che la pensano come me. Cioè insieme al popolo savio e indifeso che nei loro salotti viene definito dai radical-chic «plebaglia di destra». E sui giornali che nel migliore dei casi mi opponevano farisaicamente la congiura del silenzio ora appaiono titoli composti coi miei concetti e le mie parole. Guerra all'Occidente, Culto della Morte, Suicidio dell'Europa, Sveglia Italia Sveglia.
Il nemico è in casa. Continua la fandonia dell'Islam «moderato», la commedia della tolleranza, la bugia dell'integrazione, la farsa del pluriculturalismo. E con questa, il tentativo di farci credere che il nemico è costituito da un'esigua minoranza e che quella esigua minoranza vive in Paesi lontani. Be', il nemico non è affatto un'esigua minoranza. E ce l'abbiamo in casa. Ed è un nemico che a colpo d'occhio non sembra un nemico. Senza la barba, vestito all'occidentale, e secondo i suoi complici in buona o in malafede perfettamente inserito nel-nostro sistema sociale. Cioè col permesso di soggiorno. Con l'automobile. Con la famiglia. E pazienza se la famiglia è spesso composta da due o tre mogli, pazienza se la moglie o le mogli le fracassa di botte, pazienza se non di rado uccide la figlia in blue jeans, pazienza se ogni tanto suo figlio stupra la quindicenne bolognese che col fidanzato passeggia nel parco. È un nemico che trattiamo da amico. Che tuttavia ci odia e ci disprezza con intensità. Un nemico che in nome dell'umanitarismo e dell'asilo politico accogliamo a migliaia per volta anche se i Centri di accoglienza straripano, scoppiano, e non si sa più dove metterlo. Un nemico che in nome della «necessità» (ma quale necessità, la necessità di riempire le strade coi venditori ambulanti e gli spacciatori di droga?) invitiamo anche attraverso l'Olimpo Costituzionale. «Venite, cari, venite. Abbiamo tanto bisogno di voi». Un nemico che le moschee le trasforma in caserme, in campi di addestramento, in centri di reclutamento per i terroristi, e che obbedisce ciecamente all'imam. Un nemico che in virtù della libera circolazione voluta dal trattato di Schengen scorrazza a suo piacimento per l'Eurabia sicché per andare da Londra a Marsiglia, da Colonia a Milano o viceversa, non deve esibire alcun documento. Può essere un terrorista che si sposta per organizzare o materializzare un massacro, può avere addosso tutto l'esplosivo che vuole: nessuno lo ferma, nessuno lo tocca.
Il crocifisso sparirà. Un nemico che appena installato nelle nostre città o nelle nostre campagne si abbandona alle prepotenze ed esige l'alloggio gratuito o semi-gratuito nonché il voto e la cittadinanza. Tutte cose che ottiene senza difficoltà. Un nemico che ci impone le proprie regole e i propri costumi. Che bandisce il maiale dalle mense delle scuole, delle fabbriche, delle prigioni. Che aggredisce la maestra o la preside perché una scolara bene educata ha gentilmente offerto al compagno di classe musulmano la frittella di riso al marsala cioè «col liquore». E attenta a non ripeter l'oltraggio. Un nemico che negli asili vuole abolire anzi abolisce il Presepe e Babbo Natale. Che il crocifisso lo toglie dalle aule scolastiche, lo getta giù dalle finestre degli ospedali, lo definisce «un cadaverino ignudo e messo lì per spaventare i bambini musulmani». Un nemico che in Inghilterra s'imbottisce le scarpe di esplosivo onde far saltare in aria il jumbo del volo Parigi-Miami. Un nemico che ad Amsterdam uccide Theo van Gogh colpevole di girare documentari sulla schiavitù delle musulmane e che dopo averlo ucciso gli apre il ventre, ci ficca dentro una lettera con la condanna a morte della sua migliore amica. Il nemico, infine, per il quale trovi sempre un magistrato clemente cioè pronto a scarcerarlo. E che i governi eurobei (ndr: non si tratta d'un errore tipografico, voglio proprio dire eurobei non europei) non espellono neanche se è clandestino.
Dialogo tra civiltà. Apriti cielo se chiedi qual è l'altra civiltà, cosa c'è di civile in una civiltà che non conosce neanche il significato della parola libertà. Che per libertà, hurryya, intende «emancipazione dalla schiavitù». Che la parola hurryya la coniò soltanto alla fine dell'Ottocento per poter firmare un trattato commerciale. Che nella democrazia vede Satana e la combatte con gli esplosivi, le teste tagliate. Che dei Diritti dell'Uomo da noi tanto strombazzati e verso i musulmani scrupolosamente applicati non vuole neanche sentirne parlare. Infatti rifiuta di sottoscrivere la Carta dei Diritti Umani compilata dall'Onu e la sostituisce con la Carta dei Diritti Umani compilata dalla Conferenza Araba. Apriti cielo anche se chiedi che cosa c'è di civile in una civiltà che tratta le donne come le tratta. L'Islam è il Corano, cari miei. Comunque e dovunque. E il Corano è incompatibile con la Libertà, è incompatibile con la Democrazia, è incompatibile con i Diritti Umani. È incompatibile col concetto di civiltà.
Una strage in Italia? La strage toccherà davvero anche a noi, la prossima volta toccherà davvero a noi? Oh, sì. Non ne ho il minimo dubbio. Non l'ho mai avuto. E aggiungo: non ci hanno ancora attaccato in quanto avevano bisogno della landing-zone, della testa di ponte, del comodo avamposto che si chiama Italia. Comodo geograficamente perché è il più vicino al Medio Oriente e all'Africa cioè ai Paesi che forniscono il grosso della truppa. Comodo strategicamente perché a quella truppa offriamo buonismo e collaborazionismo, coglioneria e viltà. Ma presto si scateneranno. Molti italiani non ci credono ancora. Si comportano come i bambini per cui la parola Morte non ha alcun significato. O come gli scriteriati cui la morte sembra una disgrazia che riguarda gli altri e basta. Nel caso peggiore, una disgrazia che li colpirà per ultimi. Peggio: credono che per scansarla basti fare i furbi cioè leccarle i piedi.
Multiculturalismo, che panzana. L'Eurabia ha costruito la panzana del pacifismo multiculturalista, ha sostituito il termine «migliore» col termine «diverso-differente», s'è messa a blaterare che non esistono civiltà migliori. Non esistono principii e valori migliori, esistono soltanto diversità e differenze di comportamento. Questo ha criminalizzato anzi criminalizza chi esprime giudizi, chi indica meriti e demeriti, chi distingue il Bene dal Male e chiama il Male col proprio nome. Che l'Europa vive nella paura e che il terrorismo islamico ha un obbiettivo molto preciso: distruggere l'Occidente ossia cancellare i nostri principii, i nostri valori, le nostre tradizioni, la nostra civiltà. Ma il mio discorso è caduto nel vuoto. Perché? Perché nessuno o quasi nessuno l'ha raccolto. Perché anche per lui i vassalli della Destra stupida e della Sinistra bugiarda, gli intellettuali e i giornali e le tv insomma i tiranni del politically correct , hanno messo in atto la Congiura del Silenzio. Hanno fatto di quel tema un tabù.
Conquista demografica. Nell'Europa soggiogata il tema della fertilità islamica è un tabù che nessuno osa sfidare. Se ci provi, finisci dritto in tribunale per razzismo-xenofobia-blasfemia. Ma nessun processo liberticida potrà mai negare ciò di cui essi stessi si vantano. Ossia il fatto che nell'ultimo mezzo secolo i musulmani siano cresciuti del 235 per cento (i cristiani solo del 47 per cento). Che nel 1996 fossero un miliardo e 483 milioni. Nel 2001, un miliardo e 624 milioni. Nel 2002, un miliardo e 657 milioni. Nessun giudice liberticida potrà mai ignorare i dati, forniti dall'Onu, che ai musulmani attribuiscono un tasso di crescita oscillante tra il 4,60 e il 6,40 per cento all'anno (i cristiani, solo 1'1 e 40 per cento). Nessuna legge liberticida potrà mai smentire che proprio grazie a quella travolgente fertilità negli anni Settanta e Ottanta gli sciiti abbiano potuto impossessarsi di Beirut, spodestare la maggioranza cristiano-maronita. Tantomeno potrà negare che nell'Unione Europea i neonati musulmani siano ogni anno il dieci per cento, che a Bruxelles raggiungano il trenta per cento, a Marsiglia il sessanta per cento, e che in varie città italiane la percentuale stia salendo drammaticamente sicché nel 2015 gli attuali cinquecentomila nipotini di Allah da noi saranno almeno un milione.
Addio Europa, c'è l'Eurabia. L'Europa non c'è più. C'è l'Eurabia. Che cosa intende per Europa? Una cosiddetta Unione Europea che nella sua ridicola e truffaldina Costituzione accantona quindi nega le nostre radici cristiane, la nostra essenza? L'Unione Europea è solo il club finanziario che dico io. Un club voluto dagli eterni padroni di questo continente cioè dalla Francia e dalla Germania. È una bugia per tenere in piedi il fottutissimo euro e sostenere l'antiamericanismo, l'odio per l'Occidente. È una scusa per pagare stipendi sfacciati ed esenti da tasse agli europarlamentari che come i funzionari della Commissione Europea se la spassano a Bruxelles. È un trucco per ficcare il naso nelle nostre tasche e introdurre cibi geneticamente modificati nel nostro organismo. Sicché oltre a crescere ignorando il sapore della Verità le nuove generazioni crescono senza conoscere il sapore del buon nutrimento. E insieme al cancro dell'anima si beccano il cancro del corpo.
Integrazione impossibile. La storia delle frittelle al marsala offre uno squarcio significativo sulla presunta integrazione con cui si cerca di far credere che esiste un Islam ben distinto dall'Islam del terrorismo. Un Islam mite, progredito, moderato, quindi pronto a capire la nostra cultura e a rispettare la nostra libertà. Virgilio infatti ha una sorellina che va alle elementari e una nonna che fa le frittelle di riso come si usa in Toscana. Cioè con un cucchiaio di marsala dentro l'impasto. Tempo addietro la sorellina se le portò a scuola, le offrì ai compagni di classe, e tra i compagni di classe c'è un bambino musulmano. Al bambino musulmano piacquero in modo particolare, così quel giorno tornò a casa strillando tutto contento: «Mamma, me le fai anche te le frittelle di riso al marsala? Le ho mangiate stamani a scuola e...». Apriti cielo. L'indomani il padre di detto bambino si presentò alla preside col Corano in pugno. Le disse che aver offerto le frittelle col liquore a suo figlio era stato un oltraggio ad Allah, e dopo aver preteso le scuse la diffidò dal lasciar portare quell'immondo cibo a scuola. Cosa per cui Virgilio mi rammenta che negli asili non si erige più il Presepe, che nelle aule si toglie dal muro il crocifisso, che nelle mense studentesche s'è abolito il maiale. Poi si pone il fatale interrogativo: «Ma chi deve integrarsi, noi o loro?».
L'islam moderato non esiste. Il declino dell'intelligenza è il declino della Ragione. E tutto ciò che oggi accade in Europa, in Eurabia, ma soprattutto in Italia è declino della Ragione. Prima d'essere eticamente sbagliato è intellettualmente sbagliato. Contro Ragione. Illudersi che esista un Islam buono e un Islam cattivo ossia non capire che esiste un Islam e basta, che tutto l'Islam è uno stagno e che di questo passo finiamo con l'affogar dentro lo stagno, è contro Ragione. Non difendere il proprio territorio, la propria casa, i propri figli, la propria dignità, la propria essenza, è contro Ragione. Accettare passivamente le sciocche o ciniche menzogne che ci vengono somministrate come l'arsenico nella minestra è contro Ragione. Assuefarsi, rassegnarsi, arrendersi per viltà o per pigrizia è contro Ragione. Morire di sete e di solitudine in un deserto sul quale il Sole di Allah brilla al posto del Sol dell'Avvenir è contro Ragione.
Ecco cos'è il Corano. Perché non si può purgare l'impurgabile, censurare l'incensurabile, correggere l'incorreggibile. Ed anche dopo aver cercato il pelo nell'uovo, paragonato l'edizione della Rizzoli con quella dell'Ucoii, qualsiasi islamista con un po' di cervello ti dirà che qualsiasi testo tu scelga la sostanza non cambia. Le Sure sulla jihad intesa come Guerra Santa rimangono. E così le punizioni corporali. Così la poligamia, la sottomissione anzi la schiavizzazione della donna. Così l'odio per l'Occidente, le maledizioni ai cristiani e agli ebrei cioè ai cani infedeli.
La Parigi della Fallaci capitale d'Eurabia e dei collaborazionisti. Nella Trilogia, molti passi sulla Francia ormai contro-colonizzata dall'immigrazione musulmana. Colpa (anche) degli intellettuali,, scrive Alessandro Gnocchi su “Il Giornale”. Secondo Oriana Fallaci, Parigi era la capitale d'Eurabia. Quest'ultimo termine, introdotto nel dibattito dalla storica Bat Ye'Or (in Eurabia , Lindau), descrive il futuro del Vecchio Continente dilaniato al suo interno dallo scontro con l'islam. Alla radice ci sono gli accordi di cooperazione tra Europa e Paesi arabi firmati negli anni Settanta. L'Europa avrebbe fornito tecnologia ai Paesi arabi in cambio di greggio e manodopera. Si teorizzava la necessità di una forte immigrazione, presto diventata accesso incontrollato, verso le nostre sponde. La massiccia presenza di stranieri in Europa, secondo la Fallaci, era il cavallo di Troia di una colonizzazione al contrario. Rileggiamo La Forza della Ragione (Rizzoli, 2004). Per i difensori dell'Occidente, Parigi è persa. «Non è facile avere coraggio in un Paese dove esistono più di tremila moschee» e i musulmani sono così numerosi (ben oltre l'ufficiale dieci per cento della popolazione). In Francia «il razzismo islamico cioè l'odio per i cani-infedeli regna sovrano e non viene mai processato, mai punito». Gli imam dichiarano di voler sfruttare la democrazia «per occupare territorio» e sovvertire le leggi laiche in favore della sharia. L'antisemitismo è in crescita. I quartieri di troppe città, stravolte dal cambiamento demografico, hanno perso l'identità francese per acquisire quella magrebina. Di fronte a queste tesi, l'intellighentia scese compatta in campo per screditare la Fallaci. La giornalista fu tra i primi, in Europa, a sperimentare strumenti ed effetti del politicamente corretto. Ripercorriamo questa vicenda esemplare. La Rabbia e l'Orgoglio (Rizzoli) esce a Parigi nel maggio 2002. Mentre la prima tiratura di 25 mila copie va esaurita in due settimane, gli intellettuali si esibiscono sui giornali. Ad aprire la polemica è il settimanale Le Point . Secondo il filosofo Bernard-Henri Lévy, il libro della Fallaci è paragonabile alle peggiori opere antisemite come Bagatelle per un massacro di Louis-Ferdinand Céline: «È un libro razzista. Con meno talento, è un Bagatelle antiarabo». Stessa linea per Françoise Giroud su Le Nouvel Observateur : «La Fallaci tocca nel lettore qualcosa di profondo, d'inconfessato, che egli negherà sempre di aver pensato ma che queste pagine cariche di odio e di disprezzo rischiano di illuminare brutalmente». Il sociologo Gilles Kepel su Le Monde imputa al libro di aver sancito la vittoria di Osama bin Laden, trascinando l'Occidente sul campo della reazione isterica. Una voce fuori dal coro? Charlie Hebdo ammette la verità di fondo del libro. Ma anche il settimanale satirico, di fronte alla reazione dei lettori, è costretto a «ritrattare» (in parte). All'inizio di giugno, la Fallaci risponde sul Corriere della Sera . L'articolo Eppure con la Francia non sono arrabbiata è accompagnato da brani composti in francese per La Rabbia e l'Orgoglio e ora tradotti in italiano. In breve: la specie tutta europea dei «voltagabbana» (o collaborazionisti) trova la sua origine e massima espressione in Francia fin dal Medioevo. Tra i voltagabbana più abili nello schierarsi sempre dalla parte vincente, ci sono gli intellettuali. Oggi ha vinto il politicamente corretto. E quindi... «Queste creature patetiche, inutili, questi parassiti. Questi falsi sanculotti che vestiti da ideologi, giornalisti, scrittori, teologi, cardinali, attori, commentatori, puttane à la page, grilli canterini, giullari usi a leccare i piedi ai Khomeini e ai Pol Pot, dicono solo ciò che gli viene ordinato di dire. Ciò che gli serve a entrare o restare nel jet-set pseudointellettuale, a sfruttarne i vantaggi e i privilegi, a guadagnar soldi». Gli intellettuali hanno rimpiazzato l'ideologia marxista con la «viscida ipocrisia» che «in nome della Fraternité (sic) predica il pacifismo a oltranza cioè ripudia perfino la guerra che abbiamo combattuto contro i nazifascismi di ieri, canta le lodi degli invasori e crucifigge i difensori». La cultura è il regno delle mode. La moda «o meglio l'inganno che in nome dell'Humanitarisme (sic) assolve i delinquenti e condanna le vittime, piange sui talebani e sputa sugli americani, perdona tutto ai palestinesi e nulla agli israeliani». La moda «o meglio la demagogia che in nome dell'Égalité (sic) rinnega il merito e la qualità, la competizione e il successo». La moda «o meglio la cretineria che in nome della Justice (sic) abolisce le parole del vocabolario e chiama gli spazzini “operatori ecologici”». La moda «o meglio la disonestà, l'immoralità, che definisce “tradizione locale” e “cultura diversa” l'infibulazione ancora eseguita in tanti paesi musulmani». La moda di magnificare le conquiste culturali dell'islam per farlo apparire superiore all'Occidente. E infine la moda «che permette di stabilire un nuovo terrorismo intellettuale: quello di sfruttare a proprio piacimento il termine “razzismo”. Non sanno che cosa significa eppure lo usano lo stesso». Passano dieci giorni. Tre associazioni francesi denunciano la Fallaci per islamofobia e incitazione al razzismo. Era accaduto, poco prima, anche a Michel Houellebecq, a causa dei duri giudizi sull'islam contenuti nel romanzo Piattaforma (Bompiani) e ribaditi in un'intervista. Il tribunale di Parigi assolve la Fallaci mentre La Rabbia e l'Orgoglio supera le duecentomila copie. Quanta fatica sprecata per liquidare la Fallaci. Oriana guardava lontano mentre gli intellettuali non si sono accorti dei processi storici e delle ideologie di morte che hanno davanti agli occhi.
Magdi come la Fallaci processati per le loro idee. La scrittrice finì alla sbarra in Italia, Francia e Svizzera per i suoi scritti sul pericolo islamico E anche lei diceva: «Non mi faccio intimidire», scrive “Il Giornale”. L i chiamava «i miei trofei». E di «trofei», alias processi per reato d'opinione a causa delle idee sull'islam espresse in libri e articoli, Oriana Fallaci ne ha subiti diversi nel corso della sua vita, in tutta Europa, dalla Francia alla Svizzera. E naturalmente pure in Italia, anche se l'ultimo, a Bergamo, è cominciato a giugno del 2006, due mesi prima che lei morisse, il 15 settembre. Oriana Fallaci come Magdi Cristiano Allam, anzi molto di più. A parte «l'amicizia complessa», così la definì Allam quando lei morì, che li legava sul fronte comune della denuncia dei pericoli del fondamentalismo islamico e del suo radicamento in Europa, c'è anche la persecuzione per via giudiziaria delle opinioni che li accomuna. Per Allam, oggi, si tratta di un procedimento avviato dal Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti che lo accusa di «islamofobia». Per la Fallaci, all'epoca, erano invece veri e propri processi penali, per vilipendio all'islam, razzismo, xenofobia. La sostanza, però, non cambia: vietato essere critici nei confronti dei musulmani, pena la gogna, anche giudiziaria. Si arrabbiava, la Fallaci, per quei quattro processi: due in Francia, a partire dal 2002 (quello per «razzismo», nel 2003, si chiuse con la sua assoluzione) e uno in Svizzera, tutti legati a La rabbia e l'orgoglio ; e un altro in Italia, nel 2006, finito con la sua morte. Li chiamava sì trofei ma li riteneva profondamente ingiusti. Ecco come lei stessa li raccontava a novembre del 2005 nel discorso di ringraziamento per il conferimento dell' Annie Taylor Award , il cui testo è stato pubblicato qualche giorno fa da Libero : «I trofei che chiamo processi. Si svolgono in ogni Paese nel quale un figlio di Allah o un traditore nostrano voglia zittirmi e imbavagliarmi nel modo descritto da Tocqueville, quei processi. A Parigi, cioè in Francia, ad esempio. La France Eternelle , la Patrie du Laïcisme , la Bonne Mère du Liberté-Egalité-Fraternité , dove per vilipendio all'islam soltanto la mia amica Brigitte Bardot ha sofferto più travagli di quanti ne abbia sofferti e ne soffra io. La France Libérale, Progressiste , dove tre anni fa gli ebrei francesi della Licra (associazione ebrea di Sinistra che ama manifestare alzando fotografie di Ariel Sharon con la svastica in fronte) si unì ai musulmani francesi del Mrap (associazione islamica di Sinistra che ama manifestare levando cartelli di Bush con la svastica sugli occhi). E dove insieme chiesero al Codice penale di chiudermi in galera, confiscare La Rage et l'Orgueil (La rabbia e l'orgoglio, ma la richiesta fu respinta, ndr ) o venderla con il seguente ammonimento sulla copertina: “Attenzione! Questo libro può costituire un pericolo per la vostra salute mentale”. Oppure a Berna, in Svizzera. Die wunderschöne Schweits , la meravigliosa Svizzera di Guglielmo Tell, dove il ministro della Giustizia osò chiedere al mio ministro della Giustizia di estradarmi in manette. O a Bergamo, Nord Italia, dove il prossimo processo avverrà il prossimo giugno grazie a un giudice che sembra ansioso di condannarmi a qualche anno di prigione: la pena che per vilipendio dell'islam viene impartita nel mio paese». Era furibonda, la Fallaci, per il processo di Bergamo, legato ad alcune affermazioni contenute in La forza della ragione . Un processo travagliato, partito dalla denuncia, nel 2004, di Adel Smith, il presidente all'epoca del'Unione dei Musulmani d'Italia che aveva definito il crocifisso un «cadaverino nudo inventato per spaventare i bambini musulmani». Il pm aveva chiesto l'archiviazione per la Fallaci, ma il gip l'aveva rigettata, imponendo l'imputazione coatta. Ecco cosa scriveva la stessa Fallaci a luglio del 2005, sul Corriere della Sera , nel celebre articolo dopo gli attentati di Londra «Il nemico che trattiamo da amico» : «Mi ascolti bene, signor giudice di Bergamo che ha voluto incriminarmi per vilipendio all'islam ma che non ha mai incriminato il mio persecutore per vilipendio al cristianesimo. Nonché per istigazione all'omicidio. (Il mio). Mi ascolti e mi condanni pure. Mi infligga pure quei tre anni di reclusione che i magistrati italiani non infliggono nemmeno ai terroristi islamici beccati con l'esplosivo in cantina. Il suo processo è inutile. Finché avrò un filo di fiato io ripeterò ciò che ho scritto nei miei libri e che riscrivo qui. Non mi sono mai fatta intimidire, non mi faccio mai intimidire dalle minacce di morte e dalle persecuzioni, dalle denigrazioni, dagli insulti contro i quali Lei si è guardato bene dal proteggermi, anche come semplice cittadino. Quindi si figuri se mi faccio intimidire da Lei che mi nega il costituzionale diritto di pensare ed esprimere la mia opinione. Però, prima del processo, una curiosità me la deve togliere. Nella cella mi ci terrà tutta sola o coi carabinieri che lo Stato italiano mi ha cortesemente imposto affinché non venga ammazzata come Biagi o come Theo Van Gogh? Glielo chiedo perché il ministro dell'Interno dice che nelle nostre carceri oltre il cinquanta per cento dei detenuti sono musulmani, e suppongo che di quei carabinieri avrei più bisogno in galera che a casa mia». Al processo, iniziato il 9 giugno del 2006, la Fallaci non si presentò per scelta. Per quel processo ricevette attestati di solidarietà da mezzo mondo, pure dall'ex presidente polacco Lech Walesa. E quel processo finì nel nulla. Alla fine lo beffò la morte della giornalista e scrittrice, il 15 settembre del 2006.
La guerra siriana si combatteva in Italia. Tra il 2011 e il 2012 sono state commesse, tra Milano e Roma, più di venti azioni violente di chiara matrice jihadista con obiettivo soprattutto i cristiani. A rivelarlo è un'indagine della polizia e dai magistrati anti-terrorismo, scrive Paolo Biondani su “L’Espresso”. Un piccolo spezzone della guerra civile siriana si è combattuto in Italia. Ma era ancora troppo presto per capirlo. Tra il 2011 e il 2012 sono state commesse, tra Milano e Roma, più di venti azioni violente di chiara matrice jihadista: ferimenti, aggressioni, pestaggi, danneggiamenti, devastazioni, minacce e intimidazioni. Le vittime appartengono alle minoranze politico-religiose più perseguitate dalle milizie islamiste in Siria: le violenze in Italia hanno colpito soprattutto cristiani. A rivelarlo è un'indagine, avviata dalla polizia e dai magistrati anti-terrorismo di Milano, che viene ricostruita in un articolo del settimanale “l'Espresso”. Da quando è esplosa la guerra civile in Siria, le forze di polizia di tutti i Paesi occidentali hanno cominciato a sorvegliare le partenze degli estremisti verso i fronti di guerra. A Milano la Digos ha messo sotto controllo, in particolare, un gruppo di siriani residenti da anni tra Milano, Como e Monza: spariti dall’Italia, sono ricomparsi, mitra in pugno, in una serie di foto e video pubblicati su Internet tra febbraio e luglio del 2012. Solo a quel punto la polizia, ricostruendo le loro precedenti attività in Italia, ha scoperto che quegli stessi jihadisti siriani avevano già colpito, segretamente, anche a casa nostra. L’unica azione visibile si è svolta nella notte del 10 febbraio 2012 nel centro di Roma: un plotone di oppositori siriani ha dato l’assalto all’ambasciata di Damasco, che è stata occupata e devastata. Quel raid di protesta contro il regime del presidente-dittatore Bashar El-Assad è stato organizzato proprio dal gruppo di estremisti che poi sono partiti per la guerra in Siria. Nei mesi successivi le indagini della polizia hanno collegato alla stessa cellula jihadista molte altre azioni violente, mai denunciate per paura. Tra le vittime, due siriani di fede cristiana, che gestivano un bar a Cologno Monzese. Il loro locale è stato devastato nell'estate 2011 da un commando di oltre trenta uomini armati di bastoni e spranghe di ferro. Sulla saracinesca è poi comparsa una scritta in arabo: «Per tutti i siriani: quelli che sono a favore del presidente devono stare attenti. In Siria ci penseremo noi. Quelli che ammazzano nel jihad, vivono con Dio». Nella primavera 2012, dopo altre gravi intimidazioni, i due cristiani hanno ceduto il bar e si sono trasferiti. Un altro agguato di stampo jihadista ha colpito due siriani che lavorano regolarmente tra Milano e la Brianza: uno è cristiano, l’altro della minoranza sciita-alauita, ma i loro amici più cari sono sunniti. Il 16 luglio 2011 hanno partecipato a una fiaccolata filo-Assad organizzata da un'associazione di cui fanno parte anche cittadini italiani. Mentre tornavano a casa in macchina, sono stati circondati e picchiati ferocemente da almeno 15 sprangatori jihadisti. Le due vittime, sanguinanti a terra, sono state salvate dall'arrivo dei carabinieri. Il cristiano è stato ricoverato al San Raffaele con una gamba spappolata e operato più volte. A una spedizione punitiva è sfuggito anche un religioso legato alla Fratellanza Musulmana, il partito allora al potere in Egitto, che aveva messo al bando le sette jihadiste dalle moschee milanesi. A quel punto l’ala dura dei salafiti siriani lo ha minacciato di morte: «Sei un traditore.... Ti uccideremo a coltellate... Ti sgozzeremo come un cane». Dopo mesi di indagini, la Digos ha smascherato gli esponenti più violenti del gruppo jihadista milanese. Ma a quel punto erano già partiti tutti per la guerra. Uno dei più sanguinari è stato identificato in due video-choc, girati in Siria nel maggio 2012 (e scoperti da un fotoreporter della Rai): con il mitra a tracolla, si è fatto riprendere con un plotone di uomini armati, mentre uccidevano con un colpo alla testa sette prigionieri di guerra, legati e torturati.
LA VERA MAFIA E’ LO STATO. E PURE I GIORNALISTI? DA ALLAM ALLA FALLACI.
Le vera mafia è lo Stato che ci vessa. È arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e di avere il coraggio di dire la verità: la mafia è questo Stato, scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Per la prima volta un Papa ha scomunicato la mafia. Benissimo! È arrivato il momento di far luce su chi sia la mafia. Chi potrebbe non essere d'accordo con la condanna assoluta di chi usa la violenza nelle sue varie forme, psicologica, economica e fisica, per sottomettere le persone al proprio arbitrio, al punto da violare i diritti inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà? Ma chi è veramente il Male che sta devastando la nostra esistenza? È la criminalità organizzata che impone il pizzo ai commercianti e fa affari con il traffico di droga e dei clandestini? È la massoneria che gestisce in modo più o meno occulto il potere ovunque nel mondo? È il Gruppo Bilderberg che associa chi più conta nella finanza e nell'economia sulla Terra? Certamente queste realtà interferiscono con la nostra vita con conseguenze tutt'altro che trascurabili. Ma si tratta di realtà che o non riguardano tutti noi o non ne conosciamo bene i contenuti e i risvolti. Viceversa siamo tutti, ma proprio tutti, più che consapevoli delle vessazioni che tutti i giorni lo Stato ci impone attraverso leggi inique e pratiche del tutto arbitrarie. Chi è che ci ha imposto una nuova schiavitù sotto forma del più alto livello di tassazione al mondo, fino all'80% di tasse dirette e indirette? Chi è talmente spregiudicato da speculare sulla nostra pelle legittimando e tassando il gioco d'azzardo, gli alcolici e le sigarette? Chi è a tal punto disumano da tassare la casa, il bene rifugio dell'80% delle famiglie italiane? Chi è che condanna a morte le imprese applicando un centinaio di tasse e balzelli in aggiunta a un centinaio di controlli amministrativi? Chi è che sta accrescendo la disoccupazione e la precarietà in tutte le fasce d'età e lavorative? Chi ha permesso che 4 milioni e 100mila italiani non abbiano i soldi per comperare il pane? Chi protegge le grandi banche e le grandi imprese che continuano a privatizzare gli utili e a socializzare le perdite? Chi ha finora istigato al suicidio circa 4.500 italiani attraverso le cartelle esattoriali di Equitalia o coprendo le vessazioni delle banche quando non erogano credito o ingiungono di rientrare negli affidamenti entro 24 ore? Chi ha svenduto la nostra sovranità monetaria, legislativa e giudiziaria all'Europa dei banchieri e dei burocrati? Chi è responsabile della crescita inarrestabile del debito pubblico e privato dal momento che siamo costretti a indebitarci per ripianare il debito acquistando con gli interessi una moneta straniera? Chi sta devastando le famiglie obbligando entrambi i genitori a lavorare sodo per riuscire a sopravvivere? Chi ci ha portato all'ultimo posto di natalità in Europa e ci sta condannando al suicidio demografico? Chi sta incentivando l'emigrazione dei nostri giovani più qualificati perché in Italia non hanno prospettive? Chi sta danneggiando gli italiani promuovendo l'invasione di clandestini e umiliando i più poveri tra noi favorendo gli immigrati nell'assegnazione di case popolari, posti all'asilo nido e assegni sociali? Chi sta consentendo l'islamizzazione del nostro Paese riconoscendo il diritto a moschee, scuole coraniche, enti assistenziali e finanziari islamici a prescindere dal fatto che confliggono con i valori fondanti della nostra civiltà, indifferenti al fatto che sull'altra sponda del Mediterraneo i terroristi islamici stanno massacrando i cristiani e riesumando dei califfati in cui il diritto alla vita è garantito solo a chi si sottomette ad Allah e a Maometto? Ebbene è questo Stato che si è reso responsabile dell'insieme di questi comportamenti che ci stanno impoverendo e snaturando, trasformandoci da persone con un'anima in semplici strumenti di produzione e di consumo della materialità, assoggettati al dio euro e alla dittatura del relativismo. Ecco perché è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e di avere il coraggio di dire la verità: la mafia è questo Stato. Di ciò sono certi tutti gli italiani perché è una realtà che pagano sulla loro pelle giorno dopo giorno. Quindi caro Papa Francesco lei ha scomunicato le alte personalità che ha ricevuto in Vaticano, a cui ha stretto la mano e ha augurato successo. Per noi sono loro i veri mafiosi che stanno negando agli italiani il diritto a vivere con dignità e libertà.
Magdi come la Fallaci processati per le loro idee. La scrittrice finì alla sbarra in Italia, Francia e Svizzera per i suoi scritti sul pericolo islamico E anche lei diceva: «Non mi faccio intimidire», scrive “Il Giornale”. Li chiamava «i miei trofei». E di «trofei», alias processi per reato d'opinione a causa delle idee sull'islam espresse in libri e articoli, Oriana Fallaci ne ha subiti diversi nel corso della sua vita, in tutta Europa, dalla Francia alla Svizzera. E naturalmente pure in Italia, anche se l'ultimo, a Bergamo, è cominciato a giugno del 2006, due mesi prima che lei morisse, il 15 settembre. Oriana Fallaci come Magdi Cristiano Allam, anzi molto di più. A parte «l'amicizia complessa», così la definì Allam quando lei morì, che li legava sul fronte comune della denuncia dei pericoli del fondamentalismo islamico e del suo radicamento in Europa, c'è anche la persecuzione per via giudiziaria delle opinioni che li accomuna. Per Allam, oggi, si tratta di un procedimento avviato dal Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti che lo accusa di «islamofobia». Per la Fallaci, all'epoca, erano invece veri e propri processi penali, per vilipendio all'islam, razzismo, xenofobia. La sostanza, però, non cambia: vietato essere critici nei confronti dei musulmani, pena la gogna, anche giudiziaria. Si arrabbiava, la Fallaci, per quei quattro processi: due in Francia, a partire dal 2002 (quello per «razzismo», nel 2003, si chiuse con la sua assoluzione) e uno in Svizzera, tutti legati a La rabbia e l'orgoglio ; e un altro in Italia, nel 2006, finito con la sua morte. Li chiamava sì trofei ma li riteneva profondamente ingiusti. Ecco come lei stessa li raccontava a novembre del 2005 nel discorso di ringraziamento per il conferimento dell' Annie Taylor Award , il cui testo è stato pubblicato qualche giorno fa da Libero : «I trofei che chiamo processi. Si svolgono in ogni Paese nel quale un figlio di Allah o un traditore nostrano voglia zittirmi e imbavagliarmi nel modo descritto da Tocqueville, quei processi. A Parigi, cioè in Francia, ad esempio. La France Eternelle , la Patrie du Laïcisme , la Bonne Mère du Liberté-Egalité-Fraternité , dove per vilipendio all'islam soltanto la mia amica Brigitte Bardot ha sofferto più travagli di quanti ne abbia sofferti e ne soffra io. La France Libérale, Progressiste , dove tre anni fa gli ebrei francesi della Licra (associazione ebrea di Sinistra che ama manifestare alzando fotografie di Ariel Sharon con la svastica in fronte) si unì ai musulmani francesi del Mrap (associazione islamica di Sinistra che ama manifestare levando cartelli di Bush con la svastica sugli occhi). E dove insieme chiesero al Codice penale di chiudermi in galera, confiscare La Rage et l'Orgueil (La rabbia e l'orgoglio, ma la richiesta fu respinta, ndr ) o venderla con il seguente ammonimento sulla copertina: “Attenzione! Questo libro può costituire un pericolo per la vostra salute mentale”. Oppure a Berna, in Svizzera. Die wunderschöne Schweits , la meravigliosa Svizzera di Guglielmo Tell, dove il ministro della Giustizia osò chiedere al mio ministro della Giustizia di estradarmi in manette. O a Bergamo, Nord Italia, dove il prossimo processo avverrà il prossimo giugno grazie a un giudice che sembra ansioso di condannarmi a qualche anno di prigione: la pena che per vilipendio dell'islam viene impartita nel mio paese». Era furibonda, la Fallaci, per il processo di Bergamo, legato ad alcune affermazioni contenute in La forza della ragione . Un processo travagliato, partito dalla denuncia, nel 2004, di Adel Smith, il presidente all'epoca del'Unione dei Musulmani d'Italia che aveva definito il crocifisso un «cadaverino nudo inventato per spaventare i bambini musulmani». Il pm aveva chiesto l'archiviazione per la Fallaci, ma il gip l'aveva rigettata, imponendo l'imputazione coatta. Ecco cosa scriveva la stessa Fallaci a luglio del 2005, sul Corriere della Sera, nel celebre articolo dopo gli attentati di Londra «Il nemico che trattiamo da amico» : «Mi ascolti bene, signor giudice di Bergamo che ha voluto incriminarmi per vilipendio all'islam ma che non ha mai incriminato il mio persecutore per vilipendio al cristianesimo. Nonché per istigazione all'omicidio. (Il mio). Mi ascolti e mi condanni pure. Mi infligga pure quei tre anni di reclusione che i magistrati italiani non infliggono nemmeno ai terroristi islamici beccati con l'esplosivo in cantina. Il suo processo è inutile. Finché avrò un filo di fiato io ripeterò ciò che ho scritto nei miei libri e che riscrivo qui. Non mi sono mai fatta intimidire, non mi faccio mai intimidire dalle minacce di morte e dalle persecuzioni, dalle denigrazioni, dagli insulti contro i quali Lei si è guardato bene dal proteggermi, anche come semplice cittadino. Quindi si figuri se mi faccio intimidire da Lei che mi nega il costituzionale diritto di pensare ed esprimere la mia opinione. Però, prima del processo, una curiosità me la deve togliere. Nella cella mi ci terrà tutta sola o coi carabinieri che lo Stato italiano mi ha cortesemente imposto affinché non venga ammazzata come Biagi o come Theo Van Gogh? Glielo chiedo perché il ministro dell'Interno dice che nelle nostre carceri oltre il cinquanta per cento dei detenuti sono musulmani, e suppongo che di quei carabinieri avrei più bisogno in galera che a casa mia». Al processo, iniziato il 9 giugno del 2006, la Fallaci non si presentò per scelta. Per quel processo ricevette attestati di solidarietà da mezzo mondo, pure dall'ex presidente polacco Lech Walesa. E quel processo finì nel nulla. Alla fine lo beffò la morte della giornalista e scrittrice, il 15 settembre del 2006.
L’ordine dei giornalisti contro Allam così si calpesta la libertà di opinione, scrive Pierluigi Battista su “Il Corriere della Sera”. Trasformare in un crimine un’opinione, per quanto criticabile, non dovrebbe rientrare nei compiti di uno Stato che voglia conservare la sua anima liberale, figurarsi di un Ordine professionale come quello dei giornalisti. E invece mettere sotto accusa le opinioni di un commentatore come Magdi Cristiano Allam è diventato l’occupazione estiva dell’Ordine dei giornalisti. Una parodia dell’Inquisizione che fa di un’associazione di categoria, nata durante il fascismo e senza eguali in nessun’altra democrazia liberale con l’eccezione del post-salazariano Portogallo, un tribunale abusivo che si permette di interpretare a suo modo i princìpi della libertà di espressione e che si permette di emettere verdetti sulle opinioni espresse da un proprio associato. Già l’Italia è caricata da una pletora di reati d’opinione mai smaltiti in tutti gli anni della Repubblica post-fascista. Non c’è bisogno di processi aggiuntivi istruiti da chi si arroga il diritto di giudicare le opinioni altrui solo perché munito del tesserino di un Ordine professionale. Se un giornalista commette un reato, dovrà essere giudicato come tutti gli altri cittadini da un Tribunale della Repubblica. Piccoli tribunali del popolo che si impancano a misuratori dell’eventuale «islamofobia» di Allam sono invece pallide imitazioni di epoche autoritarie che non distinguevano tra reato e opinione. Mentre la libertà d’opinione, dovremmo averlo imparato, è indivisibile e non dovrebbe essere manipolata a seconda delle predilezioni ideologiche. Si vuole criticare Allam? In Italia c’è il pluralismo della critica e dell’informazione e il conflitto delle idee è il sale di una democrazia liberale. La giustizia fai da te, i tribunali delle corporazioni che si permettono di intromettersi non su un comportamento, o su una grave negligenza professionale, bensì sul contenuto di un articolo, sono invece il residuo di un’intolleranza antica, e che non sopporta la diversità delle opinioni, anche delle più estreme. Per cui i censori dell’Ordine potrebbero rimettere nel cassetto i loro processi, togliersi la toga dell’inquisitore e ammettere di aver commesso un errore. Non è mai troppo tardi per la scoperta della libertà.
Caso Allam, una decisione sconcertante. Su "Il Giornale", il presidente dell'Odg: "Magdi potrà difendersi". Ma la vicenda resta sconcertante risponde Alessandro Sallusti.
Caro direttore, leggo i servizi dedicati all'Odg in relazione a una vicenda che riguarda Magdi Cristiano Allam. Debbo dirti che alcuni toni e non poche espressioni mi sconcertano. L'idea che ci siano degli intoccabili non appartiene alla mia cultura né, a leggere il Giornale, alla tua. Potrei tacere, perché solo un ignorante (nel senso che non conosce le cose) può non sapere che il Consiglio nazionale di disciplina è organismo autonomo, voluto come tale da una legge dello Stato. Ma, come ben sai personalmente, non amo le fughe, tanto da essere stato - doverosamente, a mio avviso, ma ugualmente andando contro «corrente» - accanto a te quando a Milano eri sotto processo. Se non si trattasse di Allam mi verrebbe il sospetto che questa vicenda vien cavalcata per riaccendere l'attenzione su un impegno personale e politico. Ma le cose non stanno esattamente come si afferma, pur citando correttamente i passaggi di un capo di incolpazione. Non so, essendo estraneo all'organismo, come finirà. Ma so che ad Allam sono state accordate, doverosamente, tutte le opportunità di acquisire i documenti, contenuti nel fascicolo, che riterrà utili. Di più: ha eccepito che i termini di 30 giorni non gli erano sufficienti e gli uffici, mi assicurano, gli hanno formalizzato un prolungamento che, mi riferiscono, è stato di sua soddisfazione. Ma si tende a trasmettere una informazione distorta. Allam non è stato processato. Ci si è limitati a ritenere «non manifestamente infondato» un esposto presentato da una associazione (sconosciuta, perchè sul web non c'è traccia), «Media e diritto», che si duole per alcune affermazioni contenute suoi articoli. Personalmente non mi sarei sentito oltraggiato (ma non mi sento «intoccabile», come scritto in premessa), ma, anzi, avrei colto la notizia non tanto (né solo) come l'opportunità di rivendicare la possibilità di dire quel che penso, ma anche per argomentarne più approfonditamente le ragioni. Ancor di più, non mi sarei scandalizzato perché questa procedura conferma che non ci sono «intoccabili» e che le ragioni di tutti vengono valutate con attenzione. Una differenza non marginale, ad esempio e senza generalizzazioni, con chi vive di una giustizia, sommaria e tutta sua, sgozzando davanti alla telecamera un giornalista. Enzo Iacopino, Presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti.
Caro presidente, in effetti ho provato sulla mia pelle la tua solidarietà e te ne sono riconoscente e grato. Il che non ha impedito che nostri solerti colleghi mi ri-processassero, nonostante la «grazia» che mi ha concesso il presidente Napolitano, e condannassero a due mesi di sospensione (l'appello, come saprai è a giorni). Ma questa è un'altra storia. È vero, come dici, che non ci devono essere intoccabili, ma chissà perché chi la pensa in un certo modo è più toccato di altri. E quando ad allungare le mani sono colleghi od organi che sia pure autonomi riconducibili all'Ordine dei giornalisti, allora mi preoccupo. Mi piacerebbe che l'Ordine, e tutto ciò che ruota attorno ad esso, si battesse sempre e comunque per la libertà di pensiero ed espressione, di chiunque. Perché è questo, per stare in tema, che distingue la nostra società da quella islamica, il più delle volte fondata sulla sharia. A quei signori che hanno fatto l'esposto bastava spiegare questa semplice verità non trattabile: ci spiace, ma da noi si è liberi di pensare, dire e scrivere, ciò che si crede, per eventuali reati rivolgersi alla magistratura ordinaria. Alessandro Sallusti.
Vogliono toglierci la libertà di critica. Il cardine della democrazia è mettere in discussione (anche) le religioni, scrive Ida Magli su "Il Giornale". Islamofobia: strano concetto da usare in un procedimento disciplinare. «Fobia» è, infatti, termine medico che definisce un particolare disturbo psichico, presente in genere nelle nevrastenie, e che si presenta come paura, ripulsione non infrenabile nei confronti di un qualsiasi fenomeno della realtà. Freud ha aggiunto poi, con le teorie psicoanalitiche sull'inconscio, una spiegazione ulteriore del comportamento fobico affermando che il paziente è indotto a razionalizzare la propria fobia attribuendola agli aspetti negativi degli oggetti o delle persone di cui teme. Siamo sempre nel campo della psichiatria. Da qualche anno tuttavia, in Europa, e in Italia in particolar modo, le accuse di «fobia» si sprecano. Non si può aprire bocca su un qualsiasi argomento senza incorrere in questo rischio. Sarebbe bene, invece, cominciare a ricordarsi quanto cammino abbiamo fatto, quante lotte intellettuali e fisiche abbiamo dovuto sostenere, soprattutto noi, gli italiani, per giungere alla civiltà cui oggi apparteniamo. Abbiamo sofferto e pagato con il carcere e con il sangue non tanto la libertà concreta, quanto la certezza della ricerca scientifica e delle sue conoscenze, disgiunta dal pensiero filosofico, da quello politico e da qualsiasi fede religiosa. Finalmente siamo giunti anche noi, italiani, a poter godere di una democrazia totalmente laica in cui il rispetto per le convinzioni dei singoli cittadini non comporta l'impossibilità di discuterle. Questo è il punto fondamentale di una democrazia sicura di se stessa e della forza della propria libertà: ogni cittadino può e deve poter parlare con tutti gli altri di qualsiasi argomento perché vive in un gruppo ed è la vita di gruppo che forma una società e un popolo. È secondo questi principi di convivenza nella democrazia che si ha il diritto, ma soprattutto il dovere, di discutere delle religioni. Oggi nessuno ritiene, in nessuna parte del mondo, che le religioni non facciano parte integrante delle culture e delle società. E ogni religione, proprio perché religione (religio è legame fra più individui) non è un fatto privato, né può essere trattato da nessuno, né singoli né governi né istituzioni, come un fatto privato. In Italia, poi, per la sua particolare storia, le discussioni e le critiche, anche fortissime, ad associazioni cattoliche, a vescovi, a parroci, a Papi, non sono mai mancate. Sarebbe sufficiente ricordarsi i dibattiti appassionati per la legislazione sul divorzio e sull'aborto. I cattolici hanno fatto allora tutto il possibile per sostenere le loro tesi che erano appunto fondate su norme dettate da un testo sacro, il Vangelo; altrettanto hanno fatto i partiti laici, e alla fine si sono svolti con assoluta libertà i relativi referendum. Cosa sarebbe stato dell'Italia, della democrazia in Italia, se qualcuno avesse pensato che i giornalisti non potevano discutere delle norme di un testo sacro, che bisognava porre loro il bavaglio, o intimorirli con provvedimenti disciplinari? Ho citato esplicitamente il Vangelo perché gli italiani possono supporre che il Corano, scritto diversi secoli dopo la venuta di Gesù, debba in qualche modo somigliargli, riprendere qualcuna delle sue tesi fondamentali. Siccome è vero il contrario perché il Corano è fondato sull'Antico Testamento, sulla legge del taglione, sulla vendetta contro i nemici, sull'obbligo di convertire gli infedeli, sui tabù dell'impurità, è quindi agli antipodi del Vangelo e agli antipodi della civiltà in cui viviamo. Visto che i musulmani sono già numerosissimi sul suolo italiano e aumentano ogni giorno, è dovere e diritto degli italiani sapere quali siano le norme di comportamento imposte da Maometto ai suoi fedeli, i quali, appunto in quanto fedeli, dovrebbero ritenerle giuste e averle fatte proprie. Ma chi dovrebbe informarli se non i giornalisti? L'ipocrisia non è nell'interesse di nessuno oggi in Italia. Intervengano i musulmani o i loro giornalisti (non gli imam) insieme a noi sui giornali e ci assicurino che, pur essendo fedeli a Maometto, ritengono sbagliate la giustizia del taglione, le norme sull'inferiorità e l'impurità delle donne, sulla fustigazione degli omosessuali, sulla lapidazione delle adultere, sull'uccisione degli infedeli... Noi gli crederemo.
Haisam Sakhanh, il jihadista che andava in tv all'Infedele di Gad Lerner, scrive “Libero Quotidiano”. L'orrore dei tagliagole, giorno dopo giorno, ora dopo ora, sconvolge l'Occidente. Solo poche ore fa, il video delle quattro sospette spie decapitate dai fanatici dell'Islam. Immagini strazianti, terrificanti, e che fanno ancor più paura perché è sempre più chiaro che i seguaci della jihad ce li abbiamo in casa. Sono molti, alcuni noti, altri no. C'è un Imam che giura: "Ci prenderemo il Vaticano". E c'è anche chi invece, in passato, andò in televisione. Due anni fa, per la precisione. Stiamo parlando di Haisam Sakhanh, nome di battaglia Abu Omar, che un tempo viveva nel milanese e che, una volta, si fece vedere negli studi de L'Infedele, la trasmissione di Gad Lerner su La7. Da mercoledì la procura di Milano ha fatto sapere di star indagando su di lui: la sua foto, ora, appare su tutti i giornali. Eppure era chiaro da tempo chi fosse, questo Abu Omar. Come ricorda Il Giornale, già nell'aprile del 2013 fu girato un video in cui il siriano-milanese si rese protagonista dell'orrore: assieme ad altri militanti prese parte all'esecuzione di 7 soldati filo-governativi, un colpo e testa e via, gli uomini in ginocchio vengono ammazzati. Nel 2012, inoltre, le autorità italiane non ritennero necessario svolgere qualche approfondimento su mister Haisam, ex elettricista a Cologno Monzese, e la sua rete: fu arrestato al termine di un assalto all'ambasciata di Roma. Haisam e i suoi vengono interrogati, indagati per danneggiamento, violazione di domicilio e violenza privata aggravata e rinviati a giudizio per direttissima. Ma non accadde nulla: tornò libero e riprese a fare proselitismi, nel nostro Paese, a Milano e hinterland. La replica di Lerner, via blog, arriva nel pomeriggio ed è velenosa. "Fra gli altri siriani che parteciparono alla trasmissione come pubblico, senza intervenire, scopriamo ora da una fotografia pubblicata su Facebook che si infiltrò un elettricista di Cologno Monzese, tale Haisam Sakhanh, che nel frattempo è entrato nella milizia Isis col nome di battaglia Abu Omar". "Naturalmente - spiega Lerner - io non ho invitato proprio nessun jihadista in trasmissione, né tre anni fa né mai. Tanto meno costui ha mai preso la parola all'Infedele. Ma per certe testate ogni occasione è buona per insultare".
Noi censurati, il jihadista invitato in tv da Lerner. L'elettricista di Cologno andato a combattere per l'Isis in Siria è indagato per terrorismo, ma due anni fa in Italia veniva trattato da eroe della rivolta, scrive Gian Micalessin su "Il Giornale. I tagliagole amici e complici dell'Isis li avevamo in casa. Vivevano e manifestavano a Milano, mentre a Roma godevano delle migliori coperture. E così quando polizia della Capitale li arrestava mentre assaltavano e devastavano le sedi diplomatiche, i magistrati li rimettevano in libertà. Del resto i ministri del governo Monti, gli stessi che rispedivano i nostri marò nella trappola indiana, ricevevano i loro capi politici alla Farnesina trattandoli alla stregua di eroi. Gad Lerner, nel frattempo, li invitava nel suo salotto televisivo. E Pier Luigi Bersani, allora segretario del Pd, non si faceva problemi ad appoggiarli concionando da un palco adornato con la bandiera dei ribelli. La stessa bandiera in cui s'avvolgevano le sprovvedute attiviste Vanessa Marzullo e Greta Ramelli inghiottite qualche settimana fa dall'inferno siriano. Ma siamo nel Belpaese. Un paese dove l'Ordine dei Giornalisti indaga chi critica l'Islam, ma si guarda bene dall'obbiettare se qualcuno da voce ad un terrorista. E dunque non succedeva nulla. E così anche quando Il Giornale , si permetteva di mostrare i volti e documentare le atrocità di questi signori tutti facevano vinta di non vedere, di non sapere, di non capire. Guardate questo signore. Il suo vero nome è Haisam Sakhanh, il suo nome di battaglia è Abu Omar. Da mercoledì, da quando l'assai sollecita procura di Milano ha fatto sapere di star indagando su di lui, tutti fanno a gara a parlarne. La sua foto campeggia dal Corriere della Sera a Repubblica e i telegiornali fanno a gara nel descriverlo come il reclutatore dei jihadisti di Milano e dintorni. Bella scoperta. Sul Giornale la sua foto era già comparsa l'11 gennaio accanto a un titolo che recitava «Cercate killer islamici? Eccone uno». Come lo sapevamo? Semplice. A differenza degli «ignari» magistrati, politici, diplomatici e di tanti colleghi, sempre pronti a chiuder gli occhi quando le notizie non sono politicamente corrette, non c'eravamo fatto scrupoli a identificare i protagonisti dell' agghiacciante video girato nell'aprile 2013 nella provincia siriana di Idlib e pubblicato lo scorso settembre sul sito web del New York Times . In quel video il siriano-milanese Sakhanh-Abu Omar è protagonista, assieme ad altri militanti guidati dal comandante Abdul Samad Hissa, della spietata esecuzione di 7 soldati governativi appena catturati. Nel filmato indossa un giubbotto marroncino, impugna il kalashnikov e ascolta il comandante che spiega a lui e altri nove militanti perché sia giusto e doveroso ammazzare i prigionieri. Subito dopo preme il grilletto e infila un proiettile nella nuca di un soldato denudato e fatto inginocchiare ai suoi piedi. A gennaio dopo la nostra denuncia nessuno muove un dito. Ma questa non è una novità. Ben più grave è che nessuno si curi di accertare i contatti e i collegamenti di Haisam alias Abu Omar nel febbraio 2012 quando il militante viene arrestato al termine di un vero e proprio assalto all'ambasciata siriana di Roma. Un assalto durante il quale guida alcuni complici all'interno degli uffici della sede diplomatica devastandoli e malmenando alcuni impiegati. Interrogati dal giudice Marina Finiti e indagati per danneggiamento, violazione di domicilio e violenza privata aggravata Haisam e i suoi vengono rinviati a giudizio per direttissima. Ma anche allora non succede nulla. Lui torna libero, continua a far proseliti e a guidare il suo gruppetto basato a Milano e dintorni. Tra questi si distingue l'amico Ammar Bacha che il 19 agosto 2012 non si fa problemi a pubblicare un video in cui i decapitatori dell'Isis (Stato Islamico dell'Iraq e del levante) illustrano la propria attività con il consueto corollario di atrocità e violenze. Anche stavolta tutti fanno finta di non vedere. Del resto solo pochi mesi prima, il 13 maggio 2012, il ministro Giulio Terzi ha incontrato alla Farnesina il Presidente del Consiglio Nazionale Siriano (Cns), Bourhan Ghalioun, capo politico di quei ribelli già allora finanziati dal Qatar e monopolizzati dall'estremismo di Al Qaida e dell'Isis. E così qualche mese dopo pm e polizia si guardano bene dal fermare il signor Sakhanh e il suo sodale. E loro fuggono in Turchia e poi in Siria. Dove possono finalmente dedicarsi alla loro attività più congeniale. Ovvero uccidere e massacrare.
Le decapitazioni di Isis e gli allarmi della Fallaci. Il video dell'uccisione di James Foley riporta alla mente le parole (inascoltate) della scrittrice, scrive Marco Ventura su Panorama. E quindi non è "un conflitto di civiltà" quello che è sotto gli occhi di tutti in Iraq, Siria, Africa? Il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, sempre così graziosamente politically correct, nega in Parlamento la matrice di "civiltà" nei sanguinosi eventi di queste ore e nella risposta di Stati Uniti e Europa, quasi dovessimo vergognarci di difendere i valori dell'Occidente contro una versione esasperata e integralista dell'Islam globale. Ma è così? Arancione e nero. Sapete a cosa penso guardando quell’immagine surreale, terribilmente cinematografica, del giornalista americano James Foley in tuta arancione come i prigionieri di Guantanamo inginocchiato davanti a un paesaggio desertico, il busto eretto e il mento dritto, la postura fiera incongruente con le parole che deve pronunciare, e poi guardando quella figura di morte nera accanto a lui, in piedi, quel tagliagole mascherato dell’Is, coltello in mano, che si rivolge direttamente in inglese a Barack Obama (“You, Obama”) prima di decapitare la sua vittima? Penso, ecco, a Oriana Fallaci. Ai profeti inascoltati che l’Italia ha avuto, e al fatto che per vedere meglio nel futuro si sono dovuti trasferire all’estero, negli Stati Uniti, e da lì vaticinare, puntare l’indice, declamare il j’accuse, le loro omelie laiche da italiani che amano l’Italia e disprezzano però una certa Italia (e Europa). La Fallaci come Prezzolini, isolato nel suo esilio americano (e svizzero). Penso a quanti hanno criticato la Fallaci degli ultimi anni considerando i suoi scritti, le sue invettive finali (o definitive) contro l’invasione islamica, il pericolo islamico, la brutalità islamica, una sorta di metastasi del pensiero, quasi un cancro dello spirito parallelo al male che le consumava il corpo. Ascoltate (sì, ascoltate) quello che Oriana scriveva “Ai lettori” all’indomani dell’11/9, in apertura de “La rabbia e l’orgoglio” (Rizzoli): “Dall’Afghanistan al Sudan, dall’Indonesia al Pakistan, dalla Malesia all’Iran, dall’Egitto all’Iraq, dall’Algeria al Senegal, dalla Siria al Kenya, dalla Libia al Ciad, dal Libano al Marocco, dalla Palestina allo Yemen, dall’Arabia Saudita alla Somalia, l’odio per l’Occidente cresce. Si gonfia come un fuoco alimentato dal vento, e i seguaci del fondamentalismo islamico si moltiplicano come i protozoi d’una cellula che si scinde per diventare due cellule poi quattro poi otto poi sedici poi trentadue. All’infinito”. Ognuno di quei paesi evoca oggi qualcosa di terribile che è avvenuto (che avviene). I talebani comandano ancora in Afghanistan (fino in Pakistan). In Egitto la primavera araba è morta con l’avvento dei Fratelli musulmani, finalmente stroncati dalla restaurazione del generale Al-Sisi. In Libia gli islamisti proclamano il Califfato di Bengasi, guerreggiano e spargono odio e caos anche se nelle elezioni hanno dimostrato di valere poco più del 10 per cento. Tra Somalia e Kenya i guerriglieri islamisti di Al Shabaab fanno incursioni omicide lungo le strade, stragi nei centri commerciali a Nairobi. In paesi come la Nigeria che la Fallaci non citava (la sua lista oggi sarebbe più lunga) i massacri islamisti e i rapimenti delle studentesse sono firmati dalle milizie di Boko Haram. Nello Yemen dei sequestri operano cellule di Al-Qaeda. In Palestina, Hamas usa i civili come scudi umani e lancia razzi su Israele con l’obiettivo di cancellare lo Stato ebraico dalle mappe. Con l’Iran rimane il contenzioso nucleare. Di Iraq e Siria sappiamo. In Libano spadroneggiano gli Hezbollah. L’Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo non sono ancora usciti dall’ambiguità, chi più e chi meno, di sostenere o chiudere un occhio sui finanziamenti alle formazioni integraliste. E così via. Dal 2001 sono passati 13 anni e le parole de “La rabbia e l’orgoglio” si avverano. “Non capite o non volete capire che se non ci si oppone, se non ci si difende, se non si combatte, la Jihad vincerà. E distruggerà il mondo che bene o male siamo riusciti a costruire, a cambiare, a migliorare, a rendere un po’ più intelligente cioè meno bigotto o addirittura non bigotto. Distruggerà la nostra cultura, la nostra arte, la nostra scienza, la nostra morale, i nostri valori, i nostri piaceri…”. Oriana tuonava contro “i nuovi Mori”. Dietro le figure in nero, che c’erano anche allora, vedeva i colletti bianchi, che ci sono ancora. Ascoltiamola. “I nuovi Mori con la cravatta trovano sempre più complici, fanno sempre più proseliti. Per questo diventano sempre di più, pretendono sempre di più. E se non stiamo attenti, se restiamo inerti, troveranno sempre più complici. Diventeranno sempre di più, otterranno sempre di più, spadroneggeranno sempre di più. Fino a soggiogarci completamente. Fino a spegnere la nostra civiltà. Ergo, trattare con loro è impossibile. Ragionarci, impensabile. Cullarci nell’indulgenza o nella tolleranza o nella speranza, un suicidio. E chi crede il contrario è un illuso”. Chissà che non dovremo darle ragione, nonostante il nostro perbenismo intellettuale, pure sui rischi dei flussi migratori. Proprio in conclusione del suo pamphlet la Fallaci scrive infatti dell’Italia che “nonostante tutto esiste. Zittita, ridicolizzata, sbeffeggiata, diffamata, insultata, ma esiste. Quindi guai a chi me la tocca. Guai a chi me la invade, guai a chi me la ruba. Perché (se non l’hai ancora capito te lo ripeto con maggiore chiarezza) che a invaderla siano i francesi di Napoleone o i tedeschi di Hitler o i compari di Osama Bin Laden, per me è lo stesso. Che per invaderla usino i cannoni o i gommoni, idem”. E per finire: “Stop. Quello che avevo da dire l’ho detto… Ora basta. Punto e basta”.
Oriana Fallaci, la sua lezione su Libero Quotidiano: Maestra di libertà. la profezia sull'Islam fanatico, gli insulti della sinistra, i processi. Il testo di cui oggi iniziamo la pubblicazione - per gentile concessione di Edoardo Perazzi, nipote e erede della Fallaci - è quello di un discorso pronunciato da Oriana Fallaci nel novembre del 2005. La grande toscana fu insignita del Annie Taylor Award, un premio conferito dal Centro Studi di cultura popolare di New York. Il suo discorso, in versione integrale inglese, fu pubblicato pochi giorni dopo da Il Foglio. Poi, il primo dicembre del 2005, Libero ne pubblicò la versione italiana, col permesso della stessa Fallaci, che volle rivederne personalmente la forma (modificandola tramite memorabili telefonate con l'allora responsabile delle pagine culturali Alessandro Gnocchi). Abbiamo deciso di ripubblicare questo testo perché pensiamo che oggi, a quasi dieci anni di distanza, sia più attuale che mai. Bé: un premio intitolato a una donna che saltò sopra le Cascate del Niagara, e sopravvisse, è mille volte più prezioso e prestigioso ed etico di un Oscar o di un Nobel: fino a ieri gloriose onorificenze rese a persone di valore ed oggi squallide parcelle concesse a devoti antiamericani e antioccidentali quindi filoislamici. Insomma a coloro che recitando la parte dei guru illuminati che definiscono Bush un assassino, Sharon un criminale-di-guerra, Castro un filantropo, e gli Stati Uniti «la-potenza-più-feroce, più-barbara, più-spaventosa-che-il-mondo-abbia-mai-conosciuto». Infatti se mi assegnassero simili parcelle (graziaddio un’eventualità più remota del più remoto Buco Nero dell’Universo), querelerei subito le giurie per calunnia e diffamazione. Al contrario, accetto questo «Annie Taylor» con gratitudine e orgoglio. E pazienza se sopravvaluta troppo le mie virtù. Sì: specialmente come corrispondente di guerra, di salti ne ho fatti parecchi. In Vietnam, ad esempio, sono saltata spesso nelle trincee per evitare mitragliate e mortai. Altrettanto spesso sono saltata dagli elicotteri americani per raggiungere le zone di combattimento. In Bangladesh, anche da un elicottero russo per infilarmi dentro la battaglia di Dacca. Durante le mie interviste coi mascalzoni della Terra (i Khomeini, gli Arafat, i Gheddafi eccetera) non meno spesso sono saltata in donchisciotteschi litigi rischiando seriamente la mia incolumità. E una volta, nell’America Latina, mi sono buttata giù da una finestra per sfuggire agli sbirri che volevano arrestarmi. Però mai, mai, sono saltata sopra le Cascate del Niagara. Né mai lo farei. Troppo rischioso, troppo pericoloso. Ancor più rischioso che palesare la propria indipendenza, essere un dissidente cioè un fuorilegge, in una società che al nemico vende la Patria. Con la patria, la sua cultura e la sua civiltà e la sua dignità. Quindi grazie David Horowitz, Daniel Pipes, Robert Spencer. E credetemi quando dico che questo premio appartiene a voi quanto a me. A tal punto che, quando ho letto che quest’anno avreste premiato la Fallaci, mi sono chiesta: «Non dovrei esser io a premiare loro?». E per contraccambiare il tributo volevo presentarmi con qualche medaglia o qualche trofeo da consegnarvi. Mi presento a mani vuote perché non sapevo, non saprei, dove comprare certa roba. Con le medaglie e i trofei ho un’esigua, davvero esigua, familiarità. E vi dico perché. Anzitutto perché crediamo di vivere in vere democrazie, democrazie sincere e vivaci nonché governate dalla libertà di pensiero e di opinione. Invece viviamo in democrazie deboli e pigre, quindi dominate dal dispotismo e dalla paura. Paura di pensare e, pensando, di raggiungere conclusioni che non corrispondono a quelle dei lacchè del potere. Paura di parlare e, parlando, di dare un giudizio diverso dal giudizio subdolamente imposto da loro. Paura di non essere sufficientemente allineati, obbedienti, servili, e venire scomunicati attraverso l’esilio morale con cui le democrazie deboli e pigre ricattano il cittadino. Paura di essere liberi, insomma. Di prendere rischi, di avere coraggio. «Il segreto della felicità è la libertà. E il segreto della libertà è il coraggio», diceva Pericle. Uno che di queste cose se ne intendeva. (Tolgo la massima dal secondo libro della mia trilogia: La Forza della ragione. E da questo prendo anche il chiarimento che oltre centocinquanta anni fa Alexis de Tocqueville fornì nel suo intramontabile trattato sulla democrazia in America). Nei regimi assolutisti o dittatoriali, scrive Tocqueville, il dispotismo colpisce il corpo. Lo colpisce mettendolo in catene o torturandolo o sopprimendolo in vari modi. Decapitazioni, impiccagioni, lapidazioni, fucilazioni, Inquisizioni eccetera. E così facendo risparmia l’anima che intatta si leva dalla carne straziata e trasforma la vittima in eroe. Nelle democrazie inanimate, invece, nei regimi inertamente democratici, il dispotismo risparmia il corpo e colpisce l’anima. Perché è l’anima che vuole mettere in catene. Torturare, sopprimere. Così alle sue vittime non dice mai ciò che dice nei regimi assolutisti o dittatoriali: «O la pensi come me o muori». Dice: «Scegli. Sei libero di non pensare o di pensare come la penso io. Se non la pensi come la penso io, non ti sopprimerò. Non toccherò il tuo corpo. Non confischerò le tue proprietà. Non violenterò i tuoi diritti politici. Ti permetterò addirittura di votare. Ma non sarai mai votato. Non sarai mai eletto. Non sarai mai seguito e rispettato. Perché ricorrendo alle mie leggi sulla libertà di pensiero e di opinione, io sosterrò che sei impuro. Che sei bugiardo, dissoluto, peccatore, miserabile, malato di mente. E farò di te un fuorilegge, un criminale. Ti condannerò alla Morte Civile, e la gente non ti ascolterà più. Peggio. Per non essere a sua volta puniti, quelli che la pensano come te ti diserteranno». Questo succede, spiega, in quanto nelle democrazie inanimate, nei regimi inertamente democratici, tutto si può dire fuorché la Verità. Perché la Verità ispira paura. Perché, a leggere o udire la verità, i più si arrendono alla paura. E per paura delineano intorno ad essa un cerchio che è proibito oltrepassare. Alzano intorno ad essa un’invisibile ma insormontabile barriera dentro la quale si può soltanto tacere o unirsi al coro. Se il dissidente oltrepassa quella linea, se salta sopra le Cascate del Niagara di quella barriera, la punizione si abbatte su di lui o su di lei con la velocità della luce. E a render possibile tale infamia sono proprio coloro che segretamente la pensano come lui o come lei, ma che per convenienza o viltà o stupidità non alzano la loro voce contro gli anatemi e le persecuzioni. Gli amici, spesso. O i cosiddetti amici. I partner. O i cosiddetti partner. I colleghi. O i cosiddetti colleghi. Per un poco, infatti, si nascondono dietro il cespuglio. Temporeggiano, tengono il piede in due staffe. Ma poi diventano silenziosi e, terrorizzati dai rischi che tale ambiguità comporta, se la svignano. Abbandonano il fuorilegge, il criminale, al di lui o al di lei destino e con il loro silenzio danno la loro approvazione alla Morte Civile. (Qualcosa che io ho esperimentato tutta la vita e specialmente negli ultimi anni. «Non ti posso difendere più» mi disse, due o tre Natali fa, un famoso giornalista italiano che in mia difesa aveva scritto due o tre editoriali. «Perché?» gli chiesi tutta mesta. «Perché la gente non mi parla più. Non mi invita più a cena»). L’altro motivo per cui ho un’esigua familiarità con le medaglie e i trofei sta nel fatto che soprattutto dopo l’11 Settembre l’Europa è diventata una Cascata del Niagara di Maccartismo sostanzialmente identico a quello che afflisse gli Stati Uniti mezzo secolo fa. Sola differenza, il suo colore politico. Mezzo secolo fa era infatti la Sinistra ad essere vittimizzata dal Maccartismo. Oggi è la Sinistra che vittimizza gli altri col suo Maccartismo. Non meno, e a parer mio molto di più, che negli Stati Uniti. Cari miei, nell’Europa d’oggi v’è una nuova Caccia alle Streghe. E sevizia chiunque vada contro corrente. V’è una nuova Inquisizione. E gli eretici li brucia tappandogli o tentando di tappargli la bocca. Eh, sì: anche noi abbiamo i nostri Torquemada. I nostri Ward Churchill, i nostri Noam Chomsky, i nostri Louis Farrakhan, i nostri Michael Moore eccetera. Anche noi siamo infettati dalla piaga contro la quale tutti gli antidoti sembrano inefficaci. La piaga di un risorto nazi-fascismo. Il nazismo islamico e il fascismo autoctono. Portatori di germi, gli educatori cioè i maestri e le maestre che diffondono l’infezione fin dalle scuole elementari e dagli asili dove esporre un Presepe o un Babbo Natale è considerato un «insulto ai bambini Mussulmani». I professori (o le professoresse) che tale infezione la raddoppiano nelle scuole medie e la esasperano nelle università. Attraverso l’indottrinazione quotidiana, il quotidiano lavaggio del cervello, si sa. (La storia delle Crociate, ad esempio, riscritta e falsificata come nel 1984 di Orwell. L’ossequio verso il Corano visto come una religione di pace e misericordia. La reverenza per l’Islam visto come un Faro di Luce paragonato al quale la nostra civiltà è una favilla di sigaretta). E con l’indottrinazione, le manifestazioni politiche. Ovvio. Le marce settarie, i comizi faziosi, gli eccessi fascistoidi. Sapete che fecero, lo scorso ottobre, i giovinastri della Sinistra radicale a Torino? Assaltarono la chiesa rinascimentale del Carmine e ne insozzarono la facciata scrivendoci con lo spray l’insulto «Nazi-Ratzinger» nonché l’avvertimento: «Con le budella dei preti impiccheremo Pisanu». Il nostro Ministro degli Interni. Poi su quella facciata urinarono. (Amabilità che a Firenze, la mia città, non pochi islamici amano esercitare sui sagrati delle basiliche e sui vetusti marmi del Battistero). Infine irruppero dentro la chiesa e, spaventando a morte le vecchine che recitavano il Vespro, fecero scoppiare un petardo vicino all’altare. Tutto ciò alla presenza di poliziotti che non potevano intervenire perché nella città Politically Correct tali imprese sono considerate Libertà di espressione. (A meno che tale libertà non venga esercitata contro le moschee: s’intende). E inutile aggiungere che gli adulti non sono migliori di questi giovinastri. La scorsa settimana, a Marano, popolosa cittadina collocata nella provincia di Napoli, il Sindaco (ex seminarista, ex membro del Partito Comunista Italiano, poi del vivente Partito di Rifondazione Comunista, ed ora membro del Partito dei Comunisti Italiani) annullò tout-court l’ordinanza emessa dal commissario prefettizio per dedicare una strada ai martiri di Nassiriya. Cioè ai diciannove militari italiani che due anni fa i kamikaze uccisero in Iraq. Lo annullò affermando che i diciannove non erano martiri bensì mercenari, e alla strada dette il nome di Arafat. «Via Arafat». Lo fece piazzando una targa che disse: «Yasser Arafat, simbolo dell’Unità (sic) e della Resistenza Palestinese». Poi l’interno del municipio lo tappezzò con gigantesche foto del medesimo, e l’esterno con bandiere palestinesi. La piaga si propaga anche attraverso i giornali, la Tv, la radio. Attraverso i media che per convenienza o viltà o stupidità sono in gran maggioranza islamofili e antioccidentali e antiamericani quanto i maestri, i professori, gli accademici. Che senza alcun rischio di venir criticati o beffati passano sotto silenzio episodi come quelli di Torino o Marano. E in compenso non dimenticano mai di attaccare Israele, leccare i piedi all’Islam. Si propaga anche attraverso le canzoni e le chitarre e i concerti rock e i film, quella piaga. Attraverso uno show-business dove, come i vostri ottusi e presuntuosi e ultra-miliardari giullari di Hollywood, i nostri giullari sostengono il ruolo di buonisti sempre pronti a piangere per gli assassini. Mai per le loro vittime. Si propaga anche attraverso un sistema giudiziario che ha perduto ogni senso della Giustizia, ogni rispetto della giurisdizione. Voglio dire attraverso i tribunali dove, come i vostri magistrati, i nostri magistrati assolvono i terroristi con la stessa facilità con cui assolvono i pedofili. (O li condannano a pene irrisorie). E finalmente si propaga attraverso l’intimidazione della buona gente in buona fede. Voglio dire la gente che per ignoranza o paura subisce quel dispotismo e non comprende che col suo silenzio o la sua sottomissione aiuta il risorto nazi-fascismo a fiorire. Non a caso, quando denuncio queste cose, mi sento davvero come una Cassandra che parla al vento. O come uno dei dimenticati antifascisti che settanta e ottanta anni fa mettevano i ciechi e i sordi in guardia contro una coppia chiamata Mussolini e Hitler. Ma i ciechi restavano ciechi, i sordi restavano sordi, ed entrambi finirono col portar sulla fronte ciò che ne L’Apocalisse chiamo il Marchio della Vergogna. Di conseguenza le mie vere medaglie sono gli insulti, le denigrazioni, gli abusi che ricevo dall’odierno Maccartismo. Dall’odierna Caccia alle Streghe, dall’odierna Inquisizione. I miei trofei, i processi che in Europa subisco per reato di opinione. Un reato ormai travestito coi termini «vilipendio dell’Islam, razzismo o razzismo religioso, xenofobia, istigazione all’odio eccetera». Parentesi: può un Codice Penale processarmi per odio? Può l’odio essere proibito per Legge? L’odio è un sentimento. È una emozione, una reazione, uno stato d’animo. Non un crimine giuridico. Come l’amore, l’odio appartiene alla natura umana. Anzi, alla Vità. È l’opposto dell’amore e quindi, come l’amore, non può essere proibito da un articolo del Codice Penale. Può essere giudicato, sì. Può essere contestato, osteggiato, condannato, sì. Ma soltanto in senso morale. Ad esempio, nel giudizio delle religioni che come la religione cristiana predicano l’amore. Non nel giudizio d’un tribunale che mi garantisce il diritto di amare chi voglio. Perché, se ho il diritto di amare chi voglio, ho anche e devo avere anche il diritto di odiare chi voglio. Incominciando da coloro che odiano me. Sì, io odio i Bin Laden. Odio gli Zarkawi. Odio i kamikaze e le bestie che ci tagliano la testa e ci fanno saltare in aria e martirizzano le loro donne. Odio gli Ward Churchill, i Noam Chomsky, i Louis Farrakhan, i Michael Moore, i complici, i collaborazionisti, i traditori, che ci vendono al nemico. Li odio come odiavo Mussolini e Hitler e Stalin and Company. Li odio come ho sempre odiato ogni assalto alla Libertà, ogni martirio della Libertà. È un mio sacrosanto diritto. E se sbaglio, ditemi perché coloro che odiano me più di quanto io odi loro non sono processati col medesimo atto d’accusa. Voglio dire: ditemi perché questa faccenda dell’Istigazione all’Odio non tocca mai i professionisti dell’odio, i mussulmani che sul concetto dell’odio hanno costruito la loro ideologia. La loro filosofia. La loro teologia. Ditemi perché questa faccenda non tocca mai i loro complici occidentali. Parentesi chiusa, e torniamo ai trofei che chiamo processi. Si svolgono in ogni paese nel quale un figlio di Allah o un traditore nostrano voglia zittirmi e imbavagliarmi nel modo descritto da Tocqueville, quei processi. A Parigi, cioè in Francia, ad esempio. La France Eternelle, la Patrie du Laïcisme, la Bonne Mère du Liberté-Egalité-Fraternité, dove per vilipendio dell’Islam soltanto la mia amica Brigitte Bardot ha sofferto più travagli di quanti ne abbia sofferti e ne soffra io. La France Libérale, Progressiste, dove tre anni fa gli ebrei francesi della LICRA (associazione ebrea di Sinistra che ama manifestare alzando fotografie di Ariel Sharon con la svastica sulla fronte) si unì ai mussulmani francesi del MRAP (associazione islamica di Sinistra che ama manifestare levando cartelli di Bush con la svastica sugli occhi). E dove insieme chiesero al Codice Penale di chiudermi in galera, confiscare La Rage et l’Orgueil o venderla con il seguente ammonimento sulla copertina: «Attenzione! Questo librò può costituire un pericolo per la vostra salute mentale». (Insieme volevano anche intascare un grosso risarcimento danni, naturalmente). Oppure a Berna, in Svizzera. Die wunderschöne Schweitz, la meravigliosa Svizzera di Guglielmo Tell, dove il Ministro della Giustizia osò chiedere al mio Ministro della Giustizia di estradarmi in manette. O a Bergamo, Nord Italia, dove il prossimo processo avverrà il prossimo giugno grazie a un giudice che sembra ansioso di condannarmi a qualche anno di prigione: la pena che per vilipendio dell’Islam viene impartita nel mio paese. (Un paese dove senza alcuna conseguenza legale qualsiasi mussulmano può staccare il crocifisso dai muri di un’aula scolastica o di un ospedale, gettarlo nella spazzatura, dire che il crocifisso «ritrae-un-cadaverino-nudo-inventato-per-spaventare-i-bambini-mussulmani». E sapete chi ha promosso il processo di Bergamo? Uno dei mai processati quindi mai condannati specialisti nel buttare via i crocifissi. L’autore di un sudicio libretto che per molto tempo ha venduto nelle moschee, nei Centri Islamici, nelle librerie sinistrorse d’Italia. Quanto alle minacce contro la mia vita cioè all’irresistibile desiderio che i figli di Allah hanno di tagliarmi la gola o farmi saltare in aria o almeno liquidarmi con un colpo di pistola nella nuca, mi limiterò a dire che specialmente quando sono in Italia devo essere protetta ventiquattro ore su ventiquattro dai Carabinieri. La nostra polizia militare. E, sia pure a fin di bene, questa è una durissima limitazione alla mia libertà personale. Quanto agli insulti, agli anatemi, agli abusi con cui i media europei mi onorano per conto della trista alleanza Sinistra-Islam, ecco alcune delle qualifiche che da quattro anni mi vengono elargite: «Abominevole. Blasfema. Deleteria. Troglodita. Razzista. Retrograda. Ignobile. Degenere. Reazionaria. Abbietta». Come vedete, parole identiche o molto simili a quelle usate da Alexis de Tocqueville quando spiega il dispotismo che mira alla Morte Civile. Nel mio paese quel dispotismo si compiace anche di chiamarmi «Iena», nel distorcere il mio nome da Oriana in «Oriena» e nello sbeffeggiarmi attraverso sardoniche identificazioni con Giovanna d’Arco. «Le bestialità della neo Giovanna d’Arco». «Taci, Giovanna d’Arco». «Ora basta, Giovanna d’Arco».
Scontro di (in)civiltà. Oriana Fallaci: le galline della sinistra in ginocchio dagli islamici. Per gentile concessione dell’erede Edoardo Perazzi, continuiamo la pubblicazione del discorso che Oriana Fallaci pubblicò nel 2005, quando fu insignita del «Annie Taylor Award», prestigioso riconoscimento statunitense. I temi che la Fallaci affronta sono quelli delle sue celebri opere, tutte edite da Rizzoli. Lo scorso agosto venni ricevuta in udienza privata da Ratzinger, insomma da Papa Benedetto XVI. Un Papa che ama il mio lavoro da quando lesse Lettera a un bambino mai nato e che io rispetto profondamente da quando leggo i suoi intelligentissimi libri. Un Papa, inoltre, col quale mi trovo d’accordo in parecchi casi. Per esempio, quando scrive che l’Occidente ha maturato una sorta di odio contro sé stesso. Che non ama più sé stesso, che ha perso la sua spiritualità e rischia di perdere anche la sua identità. (Esattamente ciò che scrivo io quando scrivo che l’Occidente è malato di un cancro morale e intellettuale. Non a caso ripeto spesso: «Se un Papa e un’atea dicono la stessa cosa, in quella cosa dev’esserci qualcosa di tremendamente vero»). Nuova parentesi. Sono un’atea, sì. Un’atea-cristiana, come sempre chiarisco, ma un’atea. E Papa Ratzinger lo sa molto bene. Ne La Forza della Ragione uso un intero capitolo per spiegare l’apparente paradosso di tale autodefinizione. Ma sapete che cosa dice lui agli atei come me? Dice: «Ok. (L’ok è mio, ovvio). Allora Veluti si Deus daretur. Comportatevi come se Dio esistesse». Parole da cui desumo che nella comunità religiosa vi sono persone più aperte e più acute che in quella laica alla quale appartengo. Talmente aperte ed acute che non tentano nemmeno, non si sognano nemmeno, di salvarmi l’anima cioè di convertirmi. Uno dei motivi per cui sostengo che, vendendosi al teocratico Islam, il laicismo ha perso il treno. È mancato all’appuntamento più importante offertogli dalla Storia e così facendo ha aperto un vuoto, una voragine che soltanto la spiritualità può riempire. Uno dei motivi, inoltre, per cui nella Chiesa d’oggi vedo un inatteso partner, un imprevisto alleato. In Ratzinger, e in chiunque accetti la mia per loro inquietante indipendenza di pensiero e di comportamento, un compagnon-de-route. Ammenoché anche la Chiesa manchi al suo appuntamento con la Storia. Cosa che tuttavia non prevedo. Perché, forse per reazione alle ideologie materialistiche che hanno caratterizzato lo scorso secolo, il secolo dinanzi a noi mi sembra marcato da una inevitabile nostalgia anzi da un inevitabile bisogno di religiosità. E, come la religione, la religiosità finisce sempre col rivelarsi il veicolo più semplice (se non il più facile) per arrivare alla spiritualità. Chiusa la nuova parentesi. E così ci incontrammo, io e questo gentiluomo intelligente. Senza cerimonie, senza formalità, tutti soli nel suo studio di Castel Gandolfo conversammo e l’incontro non-professionale doveva restare segreto. Nella mia ossessione per la privacy, avevo chiesto che così fosse. Ma la voce si diffuse ugualmente. Come una bomba nucleare piombò sulla stampa italiana, e indovina ciò che un petulante idiota con requisiti accademici scrisse su un noto giornale romano di Sinistra. Scrisse che il Papa può vedere quanto vuole «i miserabili, gli empi, i peccatori, i mentalmente malati» come la Fallaci. Perché «il Papa non è una persona perbene». (A dispetto di ogni dizionario e della stessa Accademia della Crusca, il «perbene» scritto "per bene"). Del resto, e sempre pensando a Tocqueville, alla sua invisibile ma insuperabile barriera dentro-la-quale-si-può-soltanto-tacere-o-unirsi-al-coro, non dimentico mai quello che quattro anni fa accadde qui in America. Voglio dire quando l’articolo La Rabbia e l’Orgoglio (non ancora libro) apparve in Italia. E il New York Times scatenò la sua Super Political Correctness con una intera pagina nella quale la corrispondente da Roma mi presentava come «a provocateur» una «provocatrice». Una villana colpevole di calunniare l’Islam... Quando l’articolo divenne libro e apparve qui, ancora peggio. Perché il New York Post mi descrisse, sì, come «La Coscienza d’Europa, l’eccezione in un’epoca dove l’onestà e la chiarezza non sono più considerate preziose virtù». Nelle loro lettere i lettori mi definirono, sì, «il solo intelletto eloquente che l’Europa avesse prodotto dal giorno in cui Winston Churchill pronunciò lo Step by Step cioè il discorso con cui metteva in guardia l’Europa dall’avanzata di Hitler». Ma i giornali e le TV e le radio della Sinistra al Caviale rimasero mute, oppure si unirono alla tesi del New York Times. Tantomeno dimentico ciò che è avvenuto nel mio paese durante questi giorni di novembre 2005. Perché, pubblicato da una casa editrice che nella maggioranza delle quote azionarie appartiene ai miei editori italiani, e da questi vistosamente annunciato sul giornale che consideravo il mio giornale, in un certo senso la mia famiglia, un altro libro anti- Fallaci ora affligge le librerie. Un libro scritto, stavolta, dall’ex vice-direttore del quotidiano che un tempo apparteneva al defunto Partito Comunista. Bé, non l’ho letto. Né lo leggerò. (Esistono almeno sei libri su di me. Quasi tutti, biografie non-autorizzate e piene di bugie offensive nonché di grottesche invenzioni. E non ne ho mai letto uno. Non ho mai neppure gettato lo sguardo sulle loro copertine). Ma so che stavolta il titolo, naturalmente accompagnato dal mio nome che garantisce le vendite, contiene le parole «cattiva maestra». So che la cattiva maestra è ritratta come una sordida reazionaria, una perniciosa guerrafondaia, una mortale portatrice di «Orianismo». E secondo l’ex vice-direttore dell’ex quotidiano ultracomunista, l’Orianismo è un virus. Una malattia, un contagio, nonché un’ossessione, che uccide tutte le vittime contaminate. (Graziaddio, molti milioni di vittime. Soltanto in Italia, la Trilogia ha venduto assai più di quattro milioni di copie in tre anni. E negli altri ventun paesi è un saldo bestseller). Ma questo non è tutto. Perché nei medesimi giorni il sindaco milanese di centro-destra mi incluse nella lista degli Ambrogini: le molto ambite medaglie d’oro che per la festa di Sant’Ambrogio la città di Milano consegna a persone note, o quasi, nel campo della cultura. E quando il mio nome venne inserito, i votanti della Sinistra sferrarono un pandemonio che durò fino alle cinque del mattino. Per tutta la notte, ho saputo, fu come guardare una rissa dentro un pollaio. Le penne volavano, le creste e i bargigli sanguinavano, i coccodè assordavano, e lode al cielo se nessuno finì al Pronto Soccorso. Poi, il giorno dopo, tornarono strillando che il mio Ambrogino avrebbe inquinato il pluriculturalismo e contaminato la festa di Sant’Ambrogio. Che avrebbe dato alla cerimonia del premio un significato anti-islamico, che avrebbe offeso i mussulmani e i premiati della Sinistra. Quest’ultimi minacciarono addirittura di respingere le ambite medaglie d’oro e promisero di inscenare una fiera dimostrazione contro la donna perversa. Infine il leader del Partito di Rifondazione Comunista dichiarò: «Dare l’Ambrogino alla Fallaci è come dare il Premio Nobel della Pace a George W. Bush». Detto questo, onde rendere a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, devo chiarire qualcosa che certo dispiacerà ad alcuni o alla maggioranza di voi. Ecco qua. Io non sono un Conservatore. Non simpatizzo con la Destra più di quanto non simpatizzi con la Sinistra. Sebbene rifiuti ogni classificazione politica, mi considero una rivoluzionaria. Perché la Rivoluzione non significa necessariamente la Presa della Bastiglia o del Palais d’Hiver. E certamente per me non significa i capestri, le ghigliottine, i plotoni di esecuzione, il sangue nelle strade. Per me la Rivoluzione significa dire «No». Significa lottare per quel «No». Attraverso quel «No», cambiare le cose. E di sicuro io dico molti «No». Li ho sempre detti. Di sicuro vi sono molte cose che vorrei cambiare. Cioè non mantenere, non conservare. Una è l’uso e l’abuso della libertà non vista come Libertà ma come licenza, capriccio, vizio. Egoismo, arroganza, irresponsabilità. Un’altra è l’uso e l’abuso della democrazia non vista come il matrimonio giuridico dell’Uguaglianza e della Libertà ma come rozzo e demagogico egualitarismo, insensato diniego del merito, tirannia della maggioranza. (Di nuovo, Alexis de Tocqueville...). Un’altra ancora, la mancanza di autodisciplina, della disciplina senza la quale qualsiasi matrimonio dell’uguaglianza con la libertà si sfascia. Un’altra ancora, il cinico sfruttamento delle parole Fratellanza-Giustizia-Progresso. Un’altra ancora, la nescienza di onore e il tripudio di pusillanimità in cui viviamo ed educhiamo i nostri figli. Tutte miserie che caratterizzano la Destra quanto la Sinistra. Cari miei: se coi suoi spocchiosi tradimenti e le sue smargiassate alla squadrista e i suoi snobismi alla Muscadin e le sue borie alla Nouvel Riche la Sinistra ha disonorato e disonora le grandi battaglie che combatté nel Passato, con le sue nullità e le sue ambiguità e le sue incapacità la Destra non onora certo il ruolo che si vanta di avere. Ergo, i termini Destra e Sinistra sono per me due viete e antiquate espressioni alle quali ricorro solo per abitudine o convenienza verbale. E, come dico ne La Forza della Ragione, in entrambe vedo solo due squadre di calcio che si distinguono per il colore delle magliette indossate dai loro giocatori ma che in sostanza giocano lo stesso gioco. Il gioco di arraffare la palla del Potere. E non il Potere di cui v’è bisogno per governare: il Potere che serve sé stesso. Che esaurisce sé stesso in sé stesso.
Maestra di libertà. Oriana Fallaci e l'Islam: "Diventeremo l'Eurabia. Il nemico è in casa nostra e non vuole dialogare". Per gentile concessione dell'erede Edoardo Perazzi, continuiamo la pubblicazione del discorso che Oriana Fallaci pubblicò nel 2005, quando fu insignita del Annie Taylor Award, prestigioso riconoscimento statunitense. I temi che la Fallaci affronta sono quelli delle sue celebri opere, tutte edite da Rizzoli. Questo può apparir demagogico, semplicistico, e perfino superficiale: lo so. Ma se analizzate i fatti vedrete che la mia è pura e semplice verità. La verità del bambino che nella fiaba dei Grimm, quando i cortigiani lodano le vesti del re, grida con innocenza: Il re è nudo. Pensateci ragionando sull'attuale tragedia che ci opprime. Perbacco, nessuno può negare che l'invasione islamica dell'Europa sia stata assecondata e sia assecondata dalla Sinistra. E nessuno può negare che tale invasione non avrebbe mai raggiunto il culmine che ha raggiunto se la Destra non avesse fornito alla Sinistra la sua complicità, se la Destra non le avesse dato il imprimatur. Diciamolo una volta per sempre: la Destra non ha mai mosso un dito per impedire o almeno trattenere la crescita dell’invasione islamica. Un solo esempio? Come in molti altri paesi europei, in Italia è il leader della Destra ufficiale che imita la Sinistra nella sua impazienza di concedere il voto agli immigrati senza cittadinanza. E questo in barba al fatto che la nostra Costituzione conceda il voto ai cittadini e basta. Non agli stranieri, agli usurpatori, ai turisti col biglietto di andata senza ritorno. Di conseguenza, non posso essere associata né con la Destra né con la Sinistra. Non posso essere arruolata né dalla Destra né dalla Sinistra. Non posso essere strumentalizzata né della Destra né della Sinistra. (E guai a chi ci prova). E sono profondamente irritata con entrambe. Qualunque sia la loro locazione e nazionalità. Attualmente, per esempio, sono irritata con la Destra americana che spinge i leader europei ad accettare la Turchia come membro dell’Unione Europea. Esattamente ciò che la Sinistra europea vuole da sempre. Ma le vittime dell’invasione islamica, i cittadini europei, non vogliono la Turchia a casa loro. La gente come me non vuole la Turchia a casa sua. E Condoleezza Rice farebbe bene a smetterla di esercitare la sua Realpolitik a nostre spese. Condoleezza è una donna intelligente: nessuno ne dubita. Certo, più intelligente della maggioranza dei suoi colleghi maschi e femmine, sia qui in America che al di là dell’Atlantico. Ma sul paese che per secoli fu l’Impero Ottomano, sulla non-europea Turchia, sulla islamica Turchia, sa o finge di sapere assai poco. E sulla mostruosa calamità che rappresenterebbe l’entrata della Turchia nell’Unione Europea conosce o finge di conoscere ancora meno. Così dico: Ms. Rice, Mr. Bush, signori e signore della Destra americana, se credete tanto in un paese dove le donne hanno spontaneamente rimesso il velo e dove i Diritti Umani vengono quotidianamente ridicolizzati, prendetevelo voi. Chiedete al Congresso di annetterlo agli stati Uniti come Cinquantunesimo Stato e godetevelo voi. Poi concentratevi sull’Iran. Sulla sua lasciva nucleare, sul suo ottuso ex-sequestratore di ostaggi cioè sul suo presidente, e concentratevi sulla sua nazista promessa di cancellare Israele dalle carte geografiche. A rischio di sconfessare l’illimitato rispetto che gli americani vantano nei riguardi di tutte le religioni, devo anche chiarire ciò che segue. Come mai in un Paese dove l’85 per cento dei cittadini dicono di essere Cristiani, così pochi si ribellano all’assurda offensiva che sta avvenendo contro il Natale? Come mai così pochi si oppongono alla demagogia dei radicals che vorrebbero abolire le vacanze di Natale, gli alberi di Natale, le canzoni di Natale, e le stesse espressioni Merry Christmas e Happy Christmas, Buon Natale, eccetera?!? Come mai così pochi protestano quando quei radicals gioiscono come Talebani perché in nome dei laicismo un severo monumento a gloria dei Dieci Comandamenti viene rimosso da una piazza di Birmingham? E come mai anche qui pullulano le iniziative a favore della religione islamica? Come mai, per esempio, a Detroit (la Detroit ultra polacca e ultra cattolica le ordinanze municipali contro i rumori proibiscono il suono delle campane) la minoranza islamica ha ottenuto che i muezzin locali possano assordare il prossimo coi loro Allah-akbar dalle 6 del mattino alle 10 di sera? Come mai in un paese dove la Legge ordina di non esibire i simboli religioni nei luoghi pubblici, non consentirvi preghiere dell’una o dell’altra religione, aziende quali la Dell Computers e la Tyson Foods concedono ai propri dipendenti islamici i loro cortili nonché il tempo per recitare le cinque preghiere? E questo a dispetto del fatto che tali preghiere interrompono quindi inceppano le catene di montaggio? Come mai il nefando professor Ward Churchill non è stato licenziato dall’Università del Colorado per i suoi elogi a Bin Laden e all’11 Settembre, ma il conduttore della Washington radio Michael Graham è stato licenziato per aver detto che dietro il terrorismo islamico v’è la religione islamica? Ed ora lasciatemi concludere questa serata affrontando altri tre punti che considero cruciali. Punto numero uno. Sia a Destra che a Sinistra tutti si focalizzano sul terrorismo. Tutti. Perfino i radicali più radicali. (Cosa che non sorprende perché le condanne verbali del terrorismo sono il loro alibi. Il loro modo di pulire le loro coscienze non pulite). Ma nel terrorismo islamico non vedo l’arma principale della guerra che i figli di Allah ci hanno dichiarato. Nel terrorismo islamico vedo soltanto un aspetto, un volto di quella guerra. Il più visibile, sì. Il più sanguinoso e il più barbaro, ovvio. Eppure, paradossalmente, non il più pernicioso. Non il più catastrofico. Il più pernicioso e il più catastrofico è a parer mio quello religioso. Cioè quello dal quale tutti gli altri aspetti, tutti gli altri volti, derivano. Per incominciare, il volto dell’immigrazione. Cari amici: è l’immigrazione, non il terrorismo, il cavallo di Troia che ha penetrato l’Occidente e trasformato l’Europa in ciò che chiamo Eurabia. È l’immigrazione, non il terrorismo, l’arma su cui contano per conquistarci annientarci distruggerci. L’arma per cui da anni grido: «Troia brucia, Troia brucia». Un’immigrazione che in Europa-Eurabia supera di gran lunga l’allucinante sconfinamento dei messicani che col beneplacito della vostra Sinistra e l’imprimatur della vostra Destra invadono gli Stati Uniti. Soltanto nei venticinque paesi che formano l’Unione Europea, almeno venticinque milioni di musulmani. Cifra che non include i clandestini mai espulsi. A tutt’oggi, altri quindici milioni o più. E data l’irrefrenabile e irresistibile fertilità mussulmana, si calcola che quella cifra si raddoppierà nel 2016. Si triplicherà o quadruplicherà se la Turchia diventerà membro dell’Unione Europea. Non a caso Bernard Lewis profetizza che entro il 2100 tutta l’Europa sarà anche numericamente dominata dai musulmani. E Bassan Tibi, il rappresentante ufficiale del cosiddetto Islam Moderato in Germania, aggiunge: «Il problema non è stabilire se entro il 2100 la stragrande maggioranza o la totalità degli europei sarà mussulmana. In un modo o nell’altro, lo sarà. Il problema è stabilire se l’Islam destinato a dominare l’Europa sarà un Euro-Islam o l’Islam della Svaria». Il che spiega perché non credo nel Dialogo con l’Islam. Perché sostengo che tale dialogo è un monologo. Un soliloquio inventato per calcolo dalla Realpolitik e poi tenuto in vita dalla nostra ingenuità o dalla nostra inconfessata disperazione. Infatti su questo tema dissento profondamente dalla Chiesa Cattolica e da Papa Ratzinger. Più cerco di capire e meno capisco lo sgomentevole errore su cui la sua speranza si basa. Santo Padre: naturalmente anch’io vorrei un mondo dove tutti amano tutti e dove nessuno è nemico di nessuno. Ma il nemico c’è. Lo abbiamo qui, in casa nostra. E non ha nessuna intenzione di dialogare. Né con Lei né con noi. Di Oriana Fallaci.
Montanelli Fallaci, libro a 4 mani. Finì a “ti disprezzo” e “ti credevo migliore”, scrive Riccardo Galli su Blitz Quotidiano. Il titolo lo si sarebbe potuto trovare facilmente e avrebbe potuto, magari, suonare più o meno così: “L’impossibile libro a 4 mani”. E’, anzi era il progetto editoriale targato Rizzoli che poco meno di mezzo secolo fa avrebbe voluto dare i natali ad un libro scritto da due monumenti del giornalismo italiano: Indro Montanelli e Oriana Fallaci. Un progetto naufragato però ancor prima di reificarsi a causa delle personalità delle due “penne”. Personalità a dir poco ingombranti e, di certo, poco disponibili ad una posizione di non protagonista assoluto. Foss’anche nella stesura di un libro. Un progetto abortito e sconosciuto, almeno sino a che Paolo Di Paolo, raccogliendo materiale per un libro su Montanelli, non si è ritrovato tra le mani una lettera della Fallaci. Una lettera in cui la giornalista, da New York, scriveva alla moglie di Montanelli parlandole proprio del libro in questione: “Niente schemi rigidi, niente cattedre da una parte o dall’altra”. Da questo frammento è partita una ricerca che ha svelato la storia, o almeno parte di essa, del libro mai nato. Una storia che Di Paolo racconta sul Corriere della Sera. “Cinque anni prima – agosto 1971 – erano stati (Montanelli e la Fallaci ndr.) sul punto di scrivere un volume a quattro mani, ma il progetto naufragò. Questo libro mai nato rischiava di essere un capo lavoro: provate ad immaginare due penne simili – così sopra la media di chiunque scriva oggi, così brillanti, così feroci e libere – nello stesso spazio editoriale”. “’Niente schemi rigidi, niente cattedre da una parte o dall’altra’ precisa la Fallaci scrivendo alla moglie di Indro, Colette Rosselli, il 7 agosto del ’71,. Mentre lavoravo ad un libro su Montanelli – racconta Di Paolo sul Corriere – ho ritrovato questa curiosa lettera: l’Oriana racconta a Colette di aver tardato ad iniziare il lavoro per una serie di ragioni – una febbre tropicale presa durante un servizio in Asia, la malattia della madre e dello zio Bruno, ma anche una ‘comprensibile paura, una comprensibile timidezza che un po’ per volta mi aveva invaso’”. Da questa traccia si possono quasi immaginare i due, Montanelli e la Fallaci, uno al di qua e una al di là dell’Atlantico, da New York dove viveva, scambiarsi appassionate lettere. Internet, e con lui le e-mail, erano ancora lontani da venire e, per comunicare, i due dovevano per forza di cose ricorrere all’unico sistema allora efficiente: carta e penna. E allora lettere. Lettere in cui la Fallaci confida un pizzico di timore reverenziale alla moglie di quello che comunque, complici i 20 anni di differenza, considera in qualche modo un maestro. E lettere in cui il “maestro” manifesta comunque l’ammirazione per quella che ai suoi occhi è una “ragazzina”, seppur piena di talento. Lettere in cui dalla timidezza si passa alle idee e, rapidamente, allo scontro e alla fine ai veri e propri insulti. Una parabola in cui si possono riconoscere i caratteri dei due che, idee politiche a parte, hanno effettivamente contribuito a fare la storia del giornalismo italiano. La rabbia e l’orgoglio che, prima di divenire il titolo del libro probabilmente più celebre della Fallaci, erano parte integrante e caratterizzante della giornalista. E poi l’indisponibilità ad accettare lezioni da una “ragazzina” e le differenti visioni del mondo e, soprattutto, della Resistenza che Montanelli e che la Fallaci hanno e che saranno alla base della rottura tra i due. Dall’idea di un lavoro fatto insieme infatti a questo si arriva: ad una rottura praticamente definitiva tra i due. Anche se, entrambi, non smetteranno di riconoscere il valore dell’altro. “Ti disprezzo”, scriverà Montanelli. “Ti credevo migliore” le risponderà la Fallaci. Epitaffio di una collaborazione che avrebbe potuto essere magnifica ma che non poteva in realtà essere.
E poi c'è quello che nessuno ha mai detto. L'Oriana Fallaci che visse la storia di Gesù in diretta. "Stampo da mezzo secolo L'Evangelo di Maria Valtorta, 10 volumi. Contiene dettagli inediti che solo una testimone oculare può aver visto", scrive Stefano Lorenzetto su “Il Giornale”. Immaginate un'Oriana Fallaci al fianco di Gesù, pronta a osservare e a riferire tutto ciò che vede, con una dovizia di particolari da lasciare attoniti; una cronista dalla penna insuperabile, molto più attenta di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, i quattro evangelisti che narrarono la vita del Nazareno in modo succinto o riferendo episodi dei quali non furono testimoni diretti. Quella donna è esistita. Si chiamava Maria Valtorta. La cosa incredibile è che nacque a Caserta il 14 marzo 1897 e morì a Viareggio il 12 ottobre 1961. Ciononostante ha lasciato 122 quaderni di scuola - in tutto 13.193 pagine - compilati in uno stato di ascesi mistica fra il 1943 e il 1947, nei quali descrive per filo e per segno l'infanzia, la predicazione, i miracoli, la passione, la morte, la resurrezione e l'ascensione al cielo del Salvatore, citando luoghi, personaggi e dialoghi che nei Vangeli non compaiono. Ho potuto vedere alcuni di questi quaderni: la grafia, sgorgata da sette penne stilografiche tuttora conservate, è nitida, regolare, senza ombra di correzioni o tremori. Eppure la Valtorta era paraplegica, rimase inchiodata nel letto per 27 anni, fino al decesso, e come scrittoio doveva usare le proprie ginocchia arcuate, che infatti al momento di chiuderla nella bara erano ancora piegate in quella posa innaturale. Emilio Pisani, 79 anni, laureato in giurisprudenza, è da sempre il curatore e l'editore unico dell'opera monumentale ricavata da questi quaderni, L'Evangelo come mi è stato rivelato. Sono 10 volumi, per un totale di 5.000 pagine. Oltre 10 milioni di caratteri. Ciò significa che il racconto valtortiano è 25 volte più lungo dei quattro Vangeli canonici. «Quante copie sono in circolazione? Non lo so, c'è chi dice milioni», si sottrae pudico lo stampatore. Una cosa è certa: dal 1956 a oggi è stato tradotto persino in arabo, cinese, coreano, giapponese, russo, lituano, ucraino, croato, indonesiano, vietnamita, malayalam, tamil, rwandese e swahili. Oltre una trentina di lingue. Pisani, fondatore del Cev, il Centro editoriale valtortiano, va considerato un editore unico anche per il fatto che nessun altro suo collega al mondo ha in catalogo un solo autore. Né mi era mai capitato d'incontrare un editore che arde nel caminetto di casa i manoscritti inediti di questo suo autore. In gioventù Maria Valtorta perse il padre molto presto e così si risolse a scrivere un romanzo autobiografico, Il cuore di una donna, dal quale sperava di ricavare qualche soldo per la famiglia. In realtà non volle mai pubblicarlo e ordinò a Marta Diciotti, la governante-infermiera che la assistette dal 1935 sino alla fine, di distruggerlo. La donna non ebbe però il coraggio di farlo. «Nel 2001, prima di morire, la Diciotti consegnò il testo a me e a mia moglie», rievoca Pisani. «Lo aprimmo soltanto 10 anni più tardi. Erano pagine fittissime. Senza leggere neppure una riga , ci parve giusto bruciarle. Le ceneri le spargemmo qui fuori, nell'aiuola delle rose, che da allora fioriscono ancora più rigogliose». La villetta dei Pisani è nel giardino in cui ha sede la casa editrice, a Isola del Liri. Dal 2012 è più vuota: Claudia Vecchiarelli, insegnante di lettere e traduttrice che aveva aiutato il marito a diffondere il verbo della Valtorta, è morta di tumore. Il suo Emilio, un uomo mite dagli occhi limpidi come l'acqua delle cascate che si ammirano nel paesino della provincia di Frosinone, le ha dedicato un libro, Lettera a Claudia, in cui ripercorre la straordinaria avventura capitata a entrambi. Insieme hanno dato vita alla Fondazione Maria Valtorta Cev onlus, che amministra l'eredità materiale e spirituale della veggente e che ha acquistato dai Servi di Maria la sua casa di Viareggio, ora trasformata in museo. Per testamento sono finiti a loro tutti i documenti autografi della «evangelista», inclusi i famosi quaderni, oggi custoditi a Isola del Liri. Proprio in questi giorni gli italiani Marco Ruopoli e Matteo Ferretti e il mauritano Mor Amar, della cooperativa Sophia di Roma, hanno ultimato di digitalizzarli in alta definizione, per cui presto saranno consultabili in Pdf. Dopodiché gli originali finiranno in un caveau climatizzato, isolati dalla luce e dalla polvere.
Com'è diventato l'editore di Maria Valtorta?
«Cominciai come correttore di bozze con mio padre Michele, che negli anni Venti aveva aperto insieme al cognato Arturo Macioce una tipografia specializzata nella stampa di vite dei santi e trattati di teologia per il Vaticano e gli istituti religiosi. Una copia dell' Evangelo, dattilografata con la carta carbone dal direttore spirituale della Valtorta, il servita padre Romualdo Migliorini, fu data in lettura a Camillo Corsanego, notaio dei conclavi e decano degli avvocati concistoriali per le cause dei santi, il quale, benché sposato e padre di 6 figli, poteva fregiarsi del titolo di monsignore. Un'altra copia andò all'arcivescovo Alfonso Carinci, che era stato insegnante del futuro Pio XII all'Almo Collegio Capranica. Un'altra ancora al famoso endocrinologo Nicola Pende, che rimase impressionato dalla “perizia con cui la Valtorta descrive, nella scena dell'agonia di Gesù sulla croce, una fenomenologia che solo pochi medici consumati saprebbero esporre”. Quando i Servi di Maria chiesero al Sant'Uffizio il permesso di pubblicare il testo, la risposta fu negativa. Al che mio padre, che era stato convocato a Roma per stamparlo, si assunse l'onere di farlo come editore in proprio e nel 1952 firmò il primo contratto di edizione con la Valtorta».
Lei l'ha conosciuta?
«Certo. Andai a trovarla a Viareggio, dove il Venerdì santo del 1943 ebbe la prima rivelazione e il primo dettato».
Fu una visione? O udì una voce?
«Penso a un fenomeno interiore. Diceva di vedere Gesù e Maria accanto a sé e di essere stata fisicamente presente agli episodi narrati nei Vangeli. Leggendo la sua Autobiografia, mi ero convinto che fosse una grande donna. Giaceva nel letto e ripeteva spesso: “Che sole c'è qui!”, anche se fuori pioveva. Era in uno stato di isolamento psichico, come se avesse offerto il suo intelletto a Dio. Non le interessava comunicare con il resto dell'umanità. Quando nel 1956 ebbe fra le mani il primo volume del suo Evangelo che avevamo appena stampato, lo guardò distrattamente e lo appoggiò sulla coperta, come se non le appartenesse».
Che cosa sa della mistica?
«Era la figlia unica di Giuseppe Valtorta, mantovano, ufficiale di cavalleria, e di Iside Fioravanti, cremonese, docente di francese. A 4 anni, nell'asilo delle orsoline a Milano, le sue coetanee erano spaventate da un Cristo deposto dalla croce, raffigurato con crudo verismo nella cappella dell'istituto. Lei, invece, avrebbe voluto aprire l'urna in cui era deposto per mettergli nella mano trafitta dal chiodo il confetto che la nonna le dava ogni mattina accompagnandola a scuola. Studiò nel collegio Bianconi di Monza e nel 1917 entrò nel corpo delle infermiere volontarie che a Firenze curavano i feriti della Grande guerra. Si fidanzò due volte e per due volte sua madre, una donna fredda, dispotica, terribile, le mandò a monte il matrimonio. Nel 1920 fu aggredita per strada da un giovane facinoroso, che le diede una mazzata sui reni gridando: “Abbasso i signori e i militari!”. A causa dell'aggressione, nel 1934 rimase paralizzata dalla cintola in giù».
Ma che ha di speciale L'Evangelo ?
«Introduce personaggi e racconti che nei Vangeli sinottici non appaiono. Giovanni dice solo che Giuda era un ladro. Nell' Evangelo si spiega che rubò del denaro a Giovanna di Cusa, moglie di un intendente di Erode. Lo stesso Giuda si accorge che il Maestro piange dopo aver resuscitato il figlio della vedova di Nain, al quale la Valtorta dà per la prima volta un nome, Daniele. Interrogato dal discepolo traditore sul motivo di quelle lacrime, Gesù risponde: “Penso a mia madre”. L' Evangelo presenta figure sconosciute, come Giovanni di Endor, ex ergastolano, e Sintica, schiava greca assai colta, convertiti al cristianesimo. Per una delazione di Giuda al sinedrio, vengono esiliati ad Antiochia, da dove inviano lettere al Nazareno in cui descrivono la città della Siria con immagini e toponimi che hanno sbalordito lo studioso francese Jean-François Lavère e il mineralogista Vittorio Tredici. Quest'ultimo era di casa in Palestina e annotò come la Valtorta superasse “la normale cognizione geografica o panoramica” facendola diventare “addirittura topografica e più ancora geologica”».
L'autrice potrebbe aver attinto questi particolari in qualche biblioteca.
«E quale, considerato che non era in grado di muoversi? I libri che teneva in casa li ho io e nessuno di essi tratta della città di Seleucia Pieria, o dei monti Casio e Sulpio, o dei colonnati di Erode. Ma la cosa più strabiliante è che la Valtorta riporta in modo minuzioso la pianta e persino il colore rosso delle pareti di un palazzo che Lazzaro di Betania, resuscitato da Gesù a quattro giorni dalla morte, possedeva sulla collina di Sion. Soltanto nel 1983 un'équipe di archeologi diretta dal professor Nahman Avigad della Hebrew University di Gerusalemme ritrovò i resti della dimora, perfettamente corrispondenti alla descrizione fattane dalla mistica 40 anni prima».
Mi sfugge il senso di tanta meticolosaggine narrativa.
«Ma non sfugge a Gesù, che il 25 gennaio 1944 impartì alla Valtorta - è lei a riportarlo - questo comando: “Ricorda di essere scrupolosa al sommo nel ripetere quanto vedi. Anche una inezia ha un valore e non è tua, ma mia. Più sarai attenta ed esatta e più sarà numeroso il numero di coloro che vengono a Me”».
L'Osservatore Romano il 6 gennaio 1960 bollò L'Evangelo come «una vita di Gesù malamente romanzata».
«Inevitabile. Pochi giorni prima, il 16 dicembre 1959, era stato condannato dal Sant'Uffizio. Fu l'ultima opera messa nell' Indice dei libri proibiti, prima che Paolo VI lo abolisse: per non liberare il carcerato, demolirono il carcere. Il tutto a causa di qualche passaggio giudicato scabroso, come il racconto di Aglae, un'ex prostituta che confida a Maria di Nazaret il modo in cui un soldato romano la adescò dopo averla vista nuda».
Però nel 1985 l'allora cardinale Joseph Ratzinger ribadì la condanna.
«Con un distinguo: spiegò che la pubblicazione fu a suo tempo vietata “al fine di neutralizzare i danni che può arrecare ai fedeli più sprovveduti”. Quindi ai fedeli più avveduti non può arrecare danno, non essendovi in essa nulla contro la fede. Il cardinale Dionigi Tettamanzi, quand'era segretario della Cei, avrebbe preteso che inserissi nel colophon una postilla per avvertire i lettori che l'opera non è di origine soprannaturale. Ma chi sono io per arrogarmi questa autorità?».
È vero che Pio XII stimava la Valtorta?
«È vero che lesse l' Evangelo in dattiloscritto e che disse a padre Migliorini: “Pubblicatelo così com'è. Chi legge capirà”. Di sicuro lo capì San Pio da Pietrelcina. La bolognese Rosi Giordani nel 1989 mi scrisse che Elisa Lucchi di Forlì chiese al frate in confessione: “Padre, ho udito parlare dei libri di Maria Valtorta. Mi consigliate di leggerli?”. La risposta fu: “Non te lo consiglio, ma te lo ordino!”».
Ha notato che i veggenti, così numerosi nei secoli scorsi, sono spariti?
«Non sono mai stato né a Lourdes, né a Fatima, né a Medjugorje, pur rispettando chi ci va. Non aggiungerebbero nulla alla mia fede. La Valtorta non ambì mai a farsi conoscere. Il suo Evangelo doveva camminare nel mondo senza essere del mondo; pretese persino che la prima edizione uscisse in forma anonima. Una sola volta lo reclamizzai con un'inserzione a pagamento su Tuttolibri della Stampa: ebbene, nelle settimane seguenti ricevetti un unico ordine, evento mai capitato in precedenza. Come se l'opera rifiutasse la pubblicità».
Sorprendente.
«Le dico di più. Nel 1973 la salma della Valtorta fu esumata a Viareggio per essere traslata a Firenze, nella Basilica della Santissima Annunziata, dove vi è il celebre affresco della Madonna, a lei molto caro, che secondo Pietro Bargellini sarebbe stato completato da un angelo. Il servita Corrado Berti si aspettava un evento straordinario, per esempio il ritrovamento del corpo incorrotto. Invece affiorarono poche ossa, che fecero l'estremo viaggio con me alla guida dell'auto, mia moglie accanto e la governante Marta sul sedile posteriore».
Perché me lo racconta?
«Perché sul letto di morte la Valtorta aveva la mano sinistra già bluastra, mentre la destra, quella con cui aveva scritto L'Evangelo, era ancora rosea, come se fosse viva: nel 1961 fu considerato un segno del cielo. E la vuol sapere una cosa? Le uniche ossa che mancavano quando la disseppellimmo erano proprio quelle della mano destra. Dissolte. Come se la mistica volesse dirci per l'ultima volta: “Non pensate a me. Pensate a Lui”».
INCOSCIENTI DA SALVARE? COME SI FINANZIA IL TERRORISMO ISLAMICO.
Papa Francesco condanna la strage di Charlie Hebdo, ma "non si può insultare la fede", scrive “Libero Quotidiano”. "È una aberrazione uccidere in nome di Dio" ma "non si può insultare la fede degli altri". Con queste parole, pronunciate a bordo dell’aereo diretto nelle Filippine e riferite da Radio Vaticana, Papa Francesco interviene sull’azione dei terroristi islamici a Parigi contro Charlie Hebdo. "Non si può prendere in giro la fede", avverte il Papa. "C’è un limite, quello della dignità di ogni religione". Per Bergoglio, sia la libertà di espressione che quello di una fede a non essere ridicolizzata "sono due diritti umani fondamentali". Alla domanda di un cronista francese che gli chiedeva "fino a che punto si può andare con la libertà di espressione", il Pontefice ha chiarito: sì alla libera espressione "ma se il mio amico dice una parolaccia sulla mia mamma, si aspetti un pugno". Questo il limite che secondo il Papa regola la libertà religiosa: "Non si giocattolizza la religione degli altri", dice Bergoglio. Francesco ha ricordato che la "libertà di espressione è un diritto, ma anche un dovere". Neppure, dice il Papa, "si offende la religione", ma in questo caso "non si reagisce con violenza". Poi ha spiegato, "senza mancare di rispetto a nessuno" che "dietro ogni attentato suicida c'è uno squilibrio, non so se mentale, ma certamente umano". In una nota diramata subito dopo la strage Bergoglio aveva condannato "ogni forma di violenza, fisica e morale, che distrugge la vita umana, viola la dignità delle persone, mina radicalmente il bene fondamentale della convivenza pacifica fra le persone e i popoli, nonostante le differenze di nazionalità, di religione e di cultura". Il Papa aveva precisato che "qualunque possa esserne la motivazione, la violenza omicida è abominevole, non è mai giustificabile e la vita e la dignità di tutti vanno garantire e tutelate con decisione. Ogni istigazione all’odio va rifiutata, il rispetto dell’altro va coltivato". E ancora: tre giorni fa Bergoglio, ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, aveva detto che "la tragica strage avvenuta a Parigi" è una dimostrazione che "gli altri non sono più percepiti come esseri di pari dignità, come fratelli e sorelle in umanità, ma vengono visti come oggetti: l’essere umano da libero diventa schiavo, ora delle mode, ora del potere, ora del denaro e perfino di forme fuorviate di religione". Rispetto alle minacce dirette dai terroristi fondamentalisti di matrice islamica contro il Vaticano e il pontefice, Papa Francesco assicura di affrontare questo pericolo "con una buona dose di incoscienza". Il Papa - come riferisce ancora Radio Vaticana - afferma semmai di "temere soprattutto per l’incolumità della gente", con migliaia di fedeli che tradizionalmente affollano le sue udienze generali in piazza San Pietro e gli ’Angelus’ dal Palazzo Apostolico e sottolinea che "il miglior modo per rispondere alla violenza è la mitezza".
Ferrara su Papa Francesco: "Le sue parole su Charlie non sono una gaffe. Sono molto peggio", scrive “Libero Quotidiano”. "Se dici una parolaccia su mia mamma ti devi aspettare un pugno", ha detto ieri Papa Francesco a proposito della libertà di espressione e della blasfemia. "È aberrante uccidere in nome di Dio", ha detto il gesuita Bergoglio, ma è sbagliato anche "insultare le religioni". Parole molto forti pronunciate mentre era in aereo in volo verso le Filippine che hanno in qualche modo hanno stupito cattolici e non. E proprio a quelle parole Giuliano Ferrara dedica oggi il suo editoriale sul Foglio sottolineando che "il fantasma di Voltaire e della sua irrisione delle religioni, dai maomettani ai papisti agli ebrei, il fantasma di un Charlie del Settecento, è ancora troppo vivo, nonostante si faccia finta di averne cancellato anche il ricordo con il Concilio ecumenico vaticano II". "Perché il Papa ha parlato in modo da essere identificabile come il tutore dell' autodifesa della dignità delle religioni invece che come il custode della sacralità della vita umana e del diritto alla libertà d' espressione?", si chiede il direttore del Foglio. La risposta arriva un paragrafo più sotto: "Non credo sia una gaffe, modalità a parte, ché il magistero posta aerea è effettivamente un po' troppo colloquiale per valere erga omnes. Non ha perso la brocca, il Papa, il che sarebbe umano, possibile, riparabile. C' è dell'altro. C'è la convinzione, comune al Papa e a molta cultura irenista occidentale, che si debba convivere con l'orrore, che il distacco concettuale e spirituale dell'islam dalle pratiche violente del jihad è una conquista che spetta eventualmente all'islam di realizzare, che non esiste alternativa alla sottomissione o all'abbandono al dialogo interreligioso". Del resto, spiega Ferrara nell'articolo firmato con l'elefantino rosso, "per quanto si voglia essere Papa del secolo e nel secolo, per quanti omaggi si facciano, anche per i creduloni, alla libertà piena di coscienza come fondamento della fede, della possibilità della fede, alla fine quel che conta è non perdere il contatto con l'universo islamico, e la chiesa sa bene, ben più e meglio di altri, che il nemico violento non è il terrorismo ma l'idea coranica radicalizzata di cui il terrorismo è il frutto". "Parole e gesti del Papa, le risate risuonate nella carlinga del suo aereo, la metafora del pugno risanatore che colpisce e ripara l'offesa alla dignità, la declamazione tra pause teatrali del concetto "è normale, è normale", tutto questo non è gaffe", conclude Ferrara. "E' di più e peggio". "La piazza araba militante, gli imam che predicano nelle moschee e riluttano a un rigorosa condanna della decimazione con fucile a pompa di redazioni di giornale e negozi ebraici, da ieri si sentono meno isolati, meglio protetti dalla convergenza con il Papa di Roma".
Giuliano Ferrara: "#JeSuisKouachi e #JeSuisCoulibaly, vi spiego perché provo pena e ammirazione per gli stragisti di Parigi", scrive “Libero Quotidiano”. Controcorrente. Sempre. Sin dal principio della questione, che ne è anche il presupposto, ossia quell'idea di essere in "guerra santa" contro l'islam gridata negli studi di Servizio Pubblico, idea espressa pochi minuti dopo l'attacco al Charlie Hebdo in un videoeditoriale sul sito del Il Foglio. "Guerra santa", appunto, il presupposto di Giuliano Ferrara, un concetto rifiutato con sdegno da gran parte dell'auditorio, da chi opera dei distinguo forse necessari, ma non per l'Elefantino. E sul tema, Ferrara, ci torna nel suo editoriale su Il Foglio di lunedì, pur prendendolo da una prospettiva diametralmente opposta che emerge sin dal - controverso - titolo: "#JeSuisKouachi e #JeSuisCoulibaly: ecco perché". Il direttore parafrasa lo slogan #JeSuisCharlie e lo dedica ai tre protagonisti dell'orrore di Parigi, ai tre terroristi islamici. Ferrara spiega nell'attacco: "Una pena profonda e un'ammirazione per il loro fanatico coraggio mi legano ai nemici, ai fratelli Said e Sherif Kouachi e Amely Coulibaly. In un certo senso di origine cristiana, #JeSuisKouachi e #JeSuisCoulibaly". L'Elefantino prosegue: "Hanno assassinato persone più o meno come me, libertini della mia razza culturale e civile, gente che disegnava e rideva e sbeffeggiava, con una tinta blasfema che non ho ma che comprendo perfettamente nella dismisura anarchica e fragile e folle del loro essere artisti in una società secolarizzata e nihilista". Il direttore traccia nitidamente i contorni del suo sentimento, della "pena" e dell'"ammirazione", e sottolinea: "Mi vengono non da quella abbondanza di misericordia e di accoglienza che è diventata una pappa senza intimo rigore logico, senza giustizia linguistica, senza verità che non sia sentimentale. Non dal cuore ma dalla testa. Perché non è vero che tutto questo, come ha infelicemente detto Francois Hollande e come ripete lo stolto collettivo sul teatro mondiale della correttezza politica, non ha nulla a che fare con l'islam". I dettagli multiculturali - Ferrara nel suo editoriale si addentra nel "diritto come sharia, come legge divina", parla di Egitto, di Torquato Tasso dell'eroe cristiano Tancredi. Un lungo presupposto per rimarcare come "i dettagli meno multiculturali della storia tragica di Parigi sono come scomparsi". E secondo lui, senza comprendere a fondo quei "dettagli", non si può comprendere a fondo l'intera vicenda, che come Ferrara ha ripetuto negli ultimi giorni non è "terrorismo", bensì "guerra santa". Tornando sui terroristi, l'Elefantino ricorda come "hanno scelto di eseguire un ordine divino che impone di castigare la blasfemia come è accaduto a Charlie Hebdo". E ancora: "Hanno scelto la morte degli altri, e la loro, in un rito culturale di conversione e arruolamento, di esecuzione della legge coranica, al quale hanno saputo corrispondere fino alla fine nella follia della testimonianza di gioventù, uscendo allo scoperto e sparando all'impazzata davanti alla falange dei gendarmi di cuoio, oppure pregando alle cinque, ora del blitz, e correndo poi verso l'esecuzione nel negozio kosher". I dettagli, appunto. Ferrara insiste ancora sui dettagli, e nella conclusione dell'articolo di fondo ribadisce: "Sono dettagli importanti, sono il punto di vista che conta, più della rapida capacità di allineamento menzognero al mainstream politico islamo conformista di un capo Hezbollah o di un presidente iraniano che si dissociano a sorpresa". Il punto, per il direttore, è che il pensiero buonista e dominante rischia di far perdere il fuoco dell'obiettivo. Così Ferrara sottolinea, riferendosi ai terroristi: "Se li degradate a lupi, degradate voi stessi. Disconoscete il nemico. Non sarete mai capaci di combatterlo né di amarlo. Al posto del vangelo, libro eccelso, primitivo e terribile e selvaggio, metterete il prontuario della cultura del piagnisteo, una specie di ideologia che fa dello scontro di religione e di civiltà in atto una storiaccia di cronaca nera e di impazzimento terrorista". Ma per Ferrara, bene ribadirlo ancora una volta, è tutt'altro: è "guerra santa".
Mario Giordano: Basta, ecco perché non posso più dire "Je suis Charlie Hebdo", scrive su “Libero Quotidiano”. Scusate, ma devo dire una cosa un po’ difficile, forse persino un po’ dolorosa. Anche per me stesso. Però devo dirvela: è da stamattina che non mi sento più tanto Charlie. Anzi, proprio per nulla. Je ne suis pas Charlie. Je ne suis plus Charlie. Ne ho avuto la netta sensazione sfogliando il nuovo numero del settimanale satirico francese appena arrivato in edicola. Guardavo le pagine, diventate loro malgrado il simbolo della nostra civiltà offesa, e pensavo: ma possono essere davvero il simbolo della nostra civiltà offesa? Abbiate pazienza, ma io in quelle vignette non mi riconosco. Nemmeno un po’. Anzi, al contrario: penso che qui dentro, dentro questi fogli della sinistra sessantottarda, dentro questa cultura anarchica e distruttiva, dentro questi schizzi blasfemi che fanno a pezzi i nostri valori, dentro gli sberleffi che mettono alla berlina i nostri credi, ci sia il motivo vero della debolezza occidentale. Il motivo per cui siamo in balia di un nemico così terribile come quello islamico. Sia chiaro: da questo nemico terribile Charlie Hebdo va difeso con ogni mezzo perché dobbiamo salvare la libertà di espressione. Ed è stato giusto, per una settimana, essere diventati tutti Charlie, con quello slogan che ha riempito le piazze, Je suis Charlie, Nous sommes Charlie... Ma un conto è difendere la libertà di esprimersi, un conto è difendere ciò che viene espresso: la differenza, ne converrete, non è nemmeno così sottile. Siamo pronti alla battaglia per garantire la libertà di Charlie Hebdo di disegnare e scrivere ciò che vuole. Ma allo stesso modo dobbiamo essere liberi di dire che quello che Charlie Hebdo disegna e scrive non ci piace. Nemmeno un po’. Perché Charlie Hebdo incarna in sé il peggio del nichilismo post-Sessantotto, il peggio del gauchisme radical-nullista, il peggio della rivoluzione permanente ed effettiva. Si sono messi contro gli islamici perché amano da sempre mettersi contro tutto: contro gli ebrei, contro i cattolici, contro la Patria, contro l’esercito, contro le istituzioni, contro la famiglia, contro l’ordine, contro la sicurezza, contro la polizia, contro il commercio, contro le imprese, contro l’idea stessa di nazione e contro ogni Dio. Amano, cioè, mettersi contro tutto quello che costituisce il fondamento stesso di questa società occidentale, che pure oggi li difende a spada tratta. Ma da cui loro - ne siamo sicuri - continuano a sentirsi estranei. Anzi: avversari. Perché, diciamocela tutta, questa società occidentale che li difende a spada tratta a loro fa un po’ schifo. E allora Je suis Charlie, sicuro, fin che devo difendere il diritto di questi colleghi a dire la loro opinione. Ma Je ne suis plus Charlie se devono identificarmi con loro, che bestemmiano Dio, insultano le tradizioni, e usano il sacrosanto diritto di opinione per minare la società che glielo garantisce. Dunque, da oggi, visto che il settimanale è di nuovo uscito, scusate ma Je ne suis plus Charlie. Je ne suis plus Charlie perché non voglio e non posso accettare che i simboli della nostra società attaccata dal terrore islamico diventino proprio coloro che la nostra società la odiano. Coloro che la vorrebbero abbattere. E che la mettono in pericolo ogni giorno attaccandola nei suoi valori fondamentali. Se, in questa battaglia, dobbiamo metterci in fila dietro una bandiera, mi piacerebbe che essa fosse la bandiera della libertà dell’Occidente. Non un foglio che l’Occidente, al contrario, lo disprezza. Invece si sta compiendo proprio questo. Un po’ per interesse (operazione Hollande), un po’ per soggezione culturale (la predominanza della sinistra), alla fine la difesa dell’Europa colpita al cuore si è trasformata nella difesa tout court dei contenuti (assai discutibili) di una rivista. Fateci caso: anche se nella carneficina di Parigi sono morti agenti, ebrei, custodi di palazzo, alla fine tutto si riduce al simbolo di Charlie Hebdo. Al suo messaggio irresponsabile e irriverente. Questo è l’errore fondamentale. Perché non dobbiamo dimenticare che nella guerra contro il fondamentalismo islamico la loro forza è la nostra debolezza. Se loro osano alzare le armi contro di noi è perché noi siamo in ginocchio, se credono di poterci sottomettere ai loro valori è perché noi abbiamo rinunciato ai nostri, se ritengono di poterci imporre le loro tradizioni è perché noi abbiamo rinunciato alle nostre. E di questa rinuncia il settimanale francese è la dimostrazione più lampante. Perciò, dopo essere stato per una settimana Cabu, Charb, Wolinski, Tignous, da oggi mi sento in dovere di dirvi: maintenenat non plus. Ora non più. Per difenderci davvero non possiamo essere Charlie.
Dopo Charlie Hebdo: perché bisogna fermare la censura dei buoni. Si comincia a ritenere che chi critica vignette blasfeme sia contro la libertà. E chi ha una posizione culturale ben definita ostacoli l'integrazione, scrive Marco Cobianchi su “Panorama”. Temo che dalla grandiosa marcia parigina nasca un nuovo tipo di censura. La censura dei buoni. La censura di quelli che vogliono abbassare i toni; quelli che se dici che siamo di fronte ad una guerra e non a dei terroristi, fomenti l’odio; quelli che sanno ciò che è opportuno dire e cosa no e se non collabori, allora sei un guerrafondaio, un estremista, un fondamentalista anche tu. Oppure un cretino. La censura dei buoni è funzionale al disegno del potere: nessun leader europeo (Hollande è scusato) ha osato esprimere un’opinione diversa dal “sono terroristi, la religione non c’entra” e così i assassini diventano “sedicenti islamici” e a chi fa notare che mentre macellavano innocenti gridavano “Allah Akbar” viene tacciato di perseguire lo scontro di civiltà. Ecco perché i terroristi sono diventati "sedicenti islamici". Davanti a chi ha una posizione diversa i buoni sono pronti a sventolare il ditino inquisitore spiegando che così non si fa il bene dell’umanità che consiste nell’integrazione e nel dialogo. E siccome l’ostacolo maggiore al dialogo sarebbe avere una posizione culturale, religiosa, sociale ben definita, allora la colpa della mancata integrazione è tua. L’unica posizione culturale accettata diventa così quella laica che, indifferente a tutto, non fomenta l’odio. Perciò bisogna, adesso più di prima, stare attenti a non cadere nell’eccesso contrario facendo passare l’idea che Charlie Hebdo è un giornale di anarchici scapigliati e va difeso mentre chi ritiene le sue vignette volgari, blasfeme e ripugnanti sta armando le mani degli assassini. Bisogna stare attenti a non accusare chi esercita la propria libertà di critica di intelligenza con il nemico. Bisogna vigilare, perché questo tipo di censura dei buoni è in grado di devastare lo spazio pubblico togliendo libertà a chi non è allineato con il pensiero mainstream. Quello secondo il quale solo chi non crede in niente accetta tutto ed è pronto a dialogare con chiunque. Per dirsi cosa, poi, non si sa. La censura dei buoni è quella che pensa che la pace nel mondo, che si raggiunge con l’integrazione, è un fine talmente nobile che della libertà della singola persona si può anche fare a meno.
Solidarietà già finita: "Charlie se l'è cercata". E Greta e Vanessa no? Buonismo addio, per i vignettisti trucidati spuntano i distinguo. Per le nostre cooperanti amiche dei nostri nemici, invece..., scrive Riccardo Pelliccetti su “Il Giornale”. Dire che non siamo sorpresi ci farebbe apparire presuntuosi, nonostante avessimo segnalato, già dal giorno della strage di Parigi, il diffondersi dell'opinione che i giornalisti di Charlie Hebdo se lo sono cercata. Certo, nel mondo dell'islam radicale hanno esultato perché chi ha offeso Maometto, secondo il loro delirante pensiero, va punito con la morte. Ma scoprire che, anche in Europa, ci sia più d'uno che definisca l'orrendo massacro solo una brutale conseguenza delle continue provocazioni del settimanale satirico, ci fa inorridire. Perché questo significa abbracciare le tesi dei fondamentalisti e diventare, di fatto, loro fiancheggiatori. Esageriamo? Tutt'altro. È come se si giustificassero le stragi delle foibe, perpetrate dai partigiani di Tito contro la popolazione italiana di Venezia Giulia e Dalmazia alla fine della seconda guerra mondiale: il regime fascista è stato brutale durante l'occupazione dell'ex Jugoslavia, quindi è naturale e giusto che tutti gli italiani, indistintamente, siano sterminati. Una tesi riprovevole, anche se tanto cara, fino a pochi anni fa, ai comunisti nostrani. Ma Charlie Hebdo non è stato neppure un regime brutale. Ha esagerato nella sua satira anti religiosa? Secondo la legge, no. E, fino a prova contraria, nei Paesi del Vecchio Continente sono in vigore norme in sintonia con la democrazia moderna e non con la sharia. Se la maggioranza dei cittadini deciderà in futuro di modificare le leggi sulla libertà d'espressione, allora giornali e tv si adegueranno. Ma guai a farlo per compiacere qualcuno o nel nome del «politicamente corretto». Se uno crede che la satira superi i limiti della decenza, può sempre rivolgersi a un tribunale e chiedere giustizia. Nei Paesi civili funziona così, almeno fino a quando anche in Europa, grazie alla politica delle porte aperte, non nasceranno le prime teocrazie. È comprensibile che Papa Francesco ritenga inaccettabile che la fede sia ridicolizzata, lui è un leader religioso. Meno accettabile è che lo sostengano esponenti laici, garanti della libertà d'espressione o, addirittura, fondatori di giornali satirici, come Henri Roussel, uno dei padri di Charlie Hebdo , che ha criticato il direttore assassinato per le sue scelte editoriali. La blasfemia non è più un reato, grazie alla laicità dello Stato, e in Francia questo è accaduto già nel 1789. Non sappiamo se a spingere queste persone sia la paura o altro, ma il loro modo di interpretare le stragi del terrorismo jihadista è uno schiaffo ai nostri valori e un assist a chi dell'estremismo continua a fare la sua bandiera. Se si usasse la stessa malevolenza, oggi si dovrebbe dire che Vanessa Marzullo e Greta Ramelli andavano lasciate al loro destino perché se la sono cercata. Sono entrate illegalmente in Siria attraverso la Turchia, sapevano di andare in un Paese dove era in corso una guerra civile, hanno fatto una scelta di parte diventando amiche del «nemico». Cosa si aspettavano, che sventolare una bandiera anti Assad avrebbe fornito loro l'immunità?
Siria, Candiani (Ln): Magistratura indaghi onlus per circonvenzione d'incapaci, scrive “Libero Quotidiano”. “Nella vicenda di Greta e Vanessa consiglierei ai magistrati di aprire un filone di indagine anche per ‘circonvenzione d’incapaci’: devono essere perseguite anche quelle associazioni ed onlus poco serie che spingono le persone a rischiare la vita, senza le adeguate tutele e i minimi requisiti di sicurezza”. A dirlo il senatore leghista Stefano Candiani, in relazione alla liberazione delle due cooperanti. “La magistratura faccia approfondite indagini sui ‘reclutatori’ che, indottrinando al terzomondismo, mandano allo sbaraglio i giovani e li espongono così ai peggiori pericoli”. Candiani punta il dito contro “l’atteggiamento irresponsabile e colpevole di chi fa ideologia a basso costo, mettendo a rischio la vita di attivisti, militanti, cooperanti, e di chi è poi chiamato a occuparsi dei rapimenti”. “Oggi i cattivi maestri sono responsabili di aver messo a repentaglio vite umane e, nella malaugurata ipotesi (peraltro non smentita da Gentiloni) che sia stato pagato un riscatto, anche di tutti gli italiani nel mondo, che oggi rischiano di essere prede facili del crimine internazionale, che ha capito la scarsa serietà del paese italico”.
Ma così siamo il bancomat dei terroristi, scrive Francesco Maria De Vigo su “Il Giornale”. Sono libere. Sono vive. È una buona notizia e, ora più che mai, ne abbiamo bisogno. Ma ci sono tanti “ma”. E non si possono tacere. Il primo è che se loro stanno bene, in compenso, il nostro stato non gode di altrettanta buona salute. Il governo infatti avrebbe pagato dodici milioni di euro di riscatto per Greta e Vanessa. Un conto salatissimo in un Paese che, per legge, congela i beni dei parenti di chi è stato sequestrato. Ma qui i parenti, si fa per dire, sono lo Stato, siamo noi. Ed è noto che per lo Stato non valgono le leggi dello Stato. Bene, dunque dobbiamo farci una domanda: è giusto pagare i terroristi? Perché è chiaro che se noi – gli italiani, gli occidentali -, paghiamo il riscatto per ogni nostro concittadino, ogni nostro concittadino – italiano, occidentale -, diventa un salvadanaio deambulante per qualsiasi tagliagola. Una slot machine facile da sbancare. Ma così ci trasformiamo nel bancomat dei terroristi. Ed è abbastanza stupido. Dodici milioni sono tanti, abbastanza per armare un plotone di jihadisti (nel deep web con 1500 euro si compra un kalashnikov). Non possiamo dare la paghetta, e che paghetta!, a chi ci vuole sbudellare. Parliamoci chiaro: possiamo farci carico di tutti gli sprovveduti che pensano di farsi una “vacanza intelligente” in una zona di guerra, di fare il buon samaritano a spese nostre? No. Non lo dico solamente perché le due ragazze pensavano che Assad fosse il babau e i suoi nemici dei chierichetti vessilliferi della libertà più specchiata (questo lo pensava – erroneamente o con complicità – anche buona parte della stampa internazionale). Lo dico perché lo Stato italiano non può fare da badante a qualunque suo cittadino, che si tratti del più stupido o del più intelligente, si cacci nei guai nell’ultimo pertugio del mondo. Specialmente in un periodo in cui non riesce a garantire la minima sussistenza anche a chi se ne sta comodamente seduto sul divano di casa sua. Ma avanza un’altra domanda: perché lo Stato che non ha trattato (giustamente) con le Br tratta con gli jihadisti? Trattare significa arrendersi. E in questo momento è l’ultima cosa da fare.
L’Italia finanzia il terrorismo internazionale a forza di riscatti, scrive Giusi Brega su “L’Ultima Ribattuta”. Il nostro Governo ha l’abitudine di pagare i riscatti chiesti dai terroristi per restituirci i nostri connazionali rapiti. In questo modo contribuisce a finanziare le organizzazioni eversive internazionali come l’Isis e innesca un circolo vizioso. In queste ore stanno avendo luogo le trattative per il rilascio di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due cooperanti italiane rapite in Siria e apparse, il 31 dicembre, in un video postato su YouTube nel quale le ragazze supplicano il nostro governo di riportarle a casa prima che vengano uccise. Le fonti non escludono che il video sia stato girato per dare alle autorità italiane la prova in vita delle due ragazze e che successivamente è stato reso pubblico dai rapitori per «alzare il prezzo del riscatto». Riscatto che l’Italia è sicuramente pronta a pagare visto che, ogniqualvolta il nostro Governo si ritrovi a trattare con il terrorismo internazionale per la liberazione degli ostaggi, finisce sempre con l’aprire il portafogli: i prigionieri tornano a casa e, anche se le Istituzioni si guardano bene dal confermarlo, è risaputo che dietro alla liberazione c’è stato il pagamento di un riscatto che va a confluire dritto dritto nelle tasche delle organizzazioni eversive: un giro di affari che a livello internazionale è stimato in 125 milioni di dollari (dal 2008 ad oggi) a cui l’Italia contribuisce in maniera considerevole. Fare i terroristi costa. Il business degli ostaggi rende parecchio. Ed è un guadagno facile. Soprattutto se si ha a che fare con un Paese come l’Italia sempre pronta a pagare quanto chiesto. Fonti di stampa sostengono, infatti, che dal 2004 ad oggi il nostro Paese abbia pagato complessivamente 61 milioni di euro per 14 ostaggi catturati dai terroristi operativi nelle zone a rischio del mondo. Qualche esempio: per liberare lo scorso maggio il cooperante italo-svizzero Federico Motka, il nostro governo ha versato nelle casse degli jihadisti qualcosa come 6 milioni di euro. Anche per il rilascio del giornalista Domenico Quirico (sequestrato in Siria il 9 aprile 2013 e rilasciato l’8 settembre) sembra sia stato pagato un riscatto di oltre 4 milioni di dollari. Ricordate Giuliana Sgrena? La giornalista del Manifesto fu rapita nel febbraio del 2004 in Iraq e liberata un mese dopo grazie al sacrificio del funzionario del Sismi Nicola Calipari e a fronte del pagamento di 6 milioni di dollari. E le due Simone? Simona Pari e Simona Torretta furono rilasciate nel settembre 2004 dopo aver fatto pagare un riscatto di 11 milioni di dollari. E poi Marco Vallisa (il tecnico italiano rapito in Libia nel luglio scorso) per il quale sembra sia stato pagato un riscatto di 4 milioni di dollari. I nostri governi dal 2004 ad oggi si sono guadagnati la fama di “pagatori di riscatti” elargendo milioni di euro di denaro pubblico finanziando così la follia omicida di organizzazioni come l’Isis pronte a usare il denaro per uccidere e torturare, mettendo a repentaglio la sicurezza e la democrazia mondiale. Come se ciò non bastasse, questo atteggiamento mette a repentaglio l’incolumità dei nostri connazionali all’estero trasformandoli in “merce preziosa”. Per fare in modo che i sequestri non siano più considerati una risorsa di finanziamento e rompere questo circolo vizioso basterebbe applicare le norme internazionali in vigore che proibiscono di pagare riscatti ai terroristi come stabilito da una risoluzione delle Nazioni Unite (approvata dopo l’11 settembre 2001) e da un accordo sottoscritto dai Paesi del G8. D’altra parte se il sequestro avviene in Italia, la magistratura blocca i beni del sequestrato. Non si capisce perché se il sequestro avviene all’estero si finisca sempre col pagare un riscatto milionario (con i soldi dell’erario, cioè i nostri).
Vanessa e Greta: I commenti di Magdi Allam e Adriano Sofri, scrive Niccolò Inches su “Melty”. Il video messaggio di Vanessa e Greta, detenute in Siria dal gruppo jihadista Al Nusra, ha scatenato il dibattito sull'opportunità dell'iniziativa umanitaria delle due attiviste. Il punto di vista di Adriano Sofri e Magdi Cristiano Allam. La pubblicazione del video messaggio di Vanessa e Greta, le due attiviste umanitarie scomparse nel luglio scorso mentre si trovavano in Siria, ha confermato l'ipotesi del rapimento. Le due ragazze sarebbero nelle mani del gruppo jihadista Al Nusra, cellula legata ad Al Qaeda, attiva nel paese arabo in cui è in corso una guerra civile tra i corpi militari fedeli al regime di Bachar Al Assad e i ribelli, tra i quali non figurano solo forze democratiche ma anche numerosi nuclei del fondamentalismo islamico. In Siria era detenuto anche il giornalista de “La Stampa” Domenico Quirico, liberato nel 2013 quando soffiava il vento di una “guerra lampo” pensata dagli Stati Uniti di Barack Obama (poi mai realizzata per via della resistenza della Russia di Putin e della Cina). Su Quirico, però, non si scatenò il vespaio di commenti offensivi e sessisti apparsi sul web per attaccare la presunta irresponsabilità delle due giovani cooperanti. Ogni conflitto porta con sé il rischio di sequestri e violenze nei confronti di cittadini stranieri: il caso di Vanessa e Greta si accoda a quanto successo in passato a Giuliana Sgrena, le due Simone, Daniele Mastrogiacomo e altri in Iraq. Come puntualmente si verifica ad ogni notizia di rapimento, inoltre, scoppia dunque la polemica tra i partigiani dell'intransigenza, quelli che il racconto della guerra o un aiuto umanitario non possono valere il prezzo di un riscatto (specialmente se dovesse servire a riempire le casse dei terroristi), e coloro che tessono le lodi di una – pur rischiosa – iniziativa, in nome di valori universali e cosmopoliti. Sul rapimento di Vanessa e Greta (ecco chi sono le due cooperanti) sono intervenuti due illustri rappresentanti di entrambi i fronti, all'interno di due editoriali: la critica di Magdi Cristiano Allam, autore di “Non perdiamo la testa” (pamphlet di denuncia della presunta cultura violenta veicolata dall'Islam) e firma del Giornale da una parte, dall'altra l'ossequio dell'ex esponente di Lotta Continua – condannato per l'omicidio Calabresi - Adriano Sofri, oggi penna di Repubblica. Ne riportiamo alcuni passaggi.
Magdi Allam: i riscatti finanziano i terroristi. “Le due ragazze erano simpatizzanti degli stessi gruppi islamici che le avrebberosequestrate. In un cartello in arabo con cui si sono fatte immortalare nel corso di una manifestazione svoltasi in Italia si legge: «Agli eroi della Brigata dei Martiri - Grazie dell'ospitalità - Se Allah vorrà presto Idlab sarà liberata - E noi ci torneremo». La «Brigata dei Martiri», in arabo Liwa Shuadha, è un gruppo di terroristi islamici il cui capo, Jamal Maarouf, ha ammesso di collaborare con Al Qaida. Si stima che dal 2004 l'Italia abbia pagato complessivamente 61 milioni di euro per liberare Simona Pari e Simonetta Torretta, Maurizio Agliana, Umberto Cupertino e Salvatore Stefio, Giuliana Sgrena, Clementina Cantoni, Daniele Mastrogiacomo, Rossella Urru, Maria Sandra Mariani, Sergio Cicala e Philomene Kabouree, Federico Motka, Domenico Quirico (…) Il governo vieti alle nostre associazioni civili di operare nelle zone dove imperversano il terrorismo islamico o i conflitti armati. È ora di dire basta alle sedicenti associazioni «senza scopo di lucro» che lucrano con il denaro degli italiani, soldi pubblici e privati, per sostenere la causa dei nemici della nostra civiltà. E poi ci tocca pure pagare ingenti riscatti quando vengono sequestrati o si fanno sequestrare. Basta!”
Adriano Sofri difende le due cooperanti. “Furono istruttive certe reazioni al sequestro. Con tanti auguri di uscirne sane e salve, per carità, ma con un abietto versamento di insulti, a loro e famiglie. Stiano a casa a giocare con le bambole, sono andate a farsi il selfie coi terroristi, non ci si sogni di riscattarle con “i nostri soldi”, paghino gli irresponsabili genitori… Un genitore si sentì costretto a spiegare che sua figlia era maggiorenne, che lui l’aveva dissuasa, che non poteva legarla… Io mi sforzerei di dissuadere una ragazza che, per amore dei bambini senza cibo senza medicine e senza amore, volesse partire per la Siria. Non potrei legarla, e soprattutto non potrei fare a meno di ammirarla (...) Greta e Vanessa [sono] donne, e giovani: troppo giovani e troppo donne, verrebbe da dire, in questa euforica infantilizzazione anagrafica universale. Avevano alle spalle un’esperienza da invidiare di conoscenza e aiuto al proprio prossimo in Africa e in Asia, e della stessa Siria erano veterane. Questa volta andavano ad Aleppo col proposito preciso della riparazione di tre pozzi, per gente privata anche dell’acqua (…) I ritratti che ne fanno delle creaturine in balia di slogan e smancerie sono contraddetti da una loro mania contabile scrupolosa ed efficiente, e dall’idea che la rivoluzione sia l’autorganizzazione di ospedali, scuole, mense… (…) Gli insulti contro Vanessa e Greta avevano argomenti come il tifo per Bashar al Assad e il precetto di farsi gli affari propri: farsi gli affari di Bashar al Assad, insomma (…) perché riscattare vite a pagamento? Perché sì, perché la minaccia che incombe su una persona, la mano già alzata sul suo capo –era vero per Aldo Moro- viene prima della preoccupazione sul vantaggio che il carnefice trarrà dall’incasso di oggi”.
Vanessa Marzullo e Greta Ramelli: vittime del cuore o “incoscienti da salvare”? Scrive “Blitz Quotidiano”. Il sequestro ad Aleppo di Vanessa Marzullo e Greta Ramelli ha provocato sul Giornale un titolo di prima pagina un po’ fuori falsariga nazionale: “Due italiane rapite in Siria. Altre incoscienti da salvare”. È il titolo a un articolo di Luciano Gulli, sulla stessa linea, che si stacca dal tono generale degli articoli sul rapimento ad Aleppo di Vanessa Marzullo e Greta Ramelli che ha suscitato un turbine di solidarietà e notizie, mentre certamente i servizi segreti italiani hanno iniziato a prelevare, dai conti segreti e fuori della giurisdizione del Fisco, i milioni di euro che serviranno per pagare il loro riscatto. Proprio pochi giorni fa il New York Times aveva messo in fila tutti i rapimenti opera di gruppi terroristici, indicando tutti i paesi che hanno alimentato le casse di Al Qaeda con i riscatti per liberare connazionali. La cosa sorprendente è che non solo L’Italia paga, ma anche Francia, Austria, Svizzera e la rigorosissima Germania. Vicende angosciose come i rapimenti si risolvono in bagni di lacrime collettive e pagamenti occulti, exploit come ai tempi di Maurizio Scelli, e poi tutti tornano ai loro problemi di tutti i giorni, in attesa del prossimo. Luciano Gulli invece va giù piatto e definisce Vanessa Marzullo e Greta Ramelli “due incoscienti da salvare sull’orlo del baratro” scrivendo così: “Solidarietà, certo, mancherebbe. Come si fa a non essere vicini, a non sperare il meglio per due ragazze che invece di andarsene al mare con gli amici decidono di passare l’estate in Siria, tra le macerie, sotto le bombe, ogni giorno col cuore in gola per dare una mano ai bambini di quel martoriato Paese? Meno bello – e questo è l’aspetto che varrà la pena sottolineare, quando tutto sarà finito – è gettare oltre l’ostacolo anche i soldi dei contribuenti per pagare riscatti milionari o imbastire complesse, rischiose, talvolta mortali operazioni di recupero di certe signorine che oltre alla loro vita non esitano a mettere a repentaglio anche quella degli altri. Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, sparite nel nulla sei giorni fa ad Aleppo, sequestrate da una banda di tagliagole torneranno, ne siamo certi. Ma quando saranno di nuovo tra noi qualcuno dovrà spiegar loro che la guerra, le bombe, quei territori «comanche» dove morire è più facile che vivere sono una cosa troppo seria, troppo crudele per due ragazzine. Che sognare di andare in battaglia «per dare una mano», per «testimoniare», come troppe volte abbiamo visto fare a tante anime belle, dalla Bosnia all’Irak di Saddam, è una cosa che si può sognare benissimo tra i piccioni di piazza del Duomo, un selfie dopo l’altro, abbracciate strette strette, quando il rischio maggiore è di beccarsi un «regalo» dai pennuti. Ma senza i nervi, la preparazione, il carattere, l’esperienza che ti dice cosa fare e cosa non fare; senza quel rude pragmatismo che ti viene dopo aver battuto i marciapiedi di tante guerre è meglio stare a casa. Non ci si improvvisa reporter di guerra e non ci si improvvisa neppure cooperanti senza aver imparato come si fa, come ci si comporta, come è fatto il sorriso che ti salverà la vita quando ti troverai di fronte a un mascalzone che vuole i tuoi soldi e le tue scarpe, o al ragazzino che sbuca dall’angolo di una casa, e per rabbia, per vendetta, o anche solo per paura, lascia partire una raffica di mitra che può spedirti all’altro mondo in un amen. Sono le stesse cose che scrivemmo nel settembre di dieci anni fa, quando a Bagdad vennero liberate Simona Torretta e Simona Pari. Le «due Simone» uscirono incolumi da un’avventura durata tre settimane. Non così andò l’anno dopo, quando sempre a Bagdad rapirono la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena. Per liberarla, quella volta, morì l’agente del Sismi Nicola Calipari. Che dire di più, in queste ore? Niente. Fermiamoci qui. Intrecciamo le dita, sperando di rivedere presto queste altre «Simone»”.
Vanessa e Greta a Roma: l'incubo è finito, scrive Giulia Vola su “Magazine delle donne”. Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le volontarie rapite in Siria a luglio sono tornate in Italia questa mattina. Ad accoglierle il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. A far discutere il maxi riscatto che l'Italia avrebbe pagato per la loro liberazione. Libere. Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le volontarie ventenni rapite in Siria lo scorso luglio sono tornate in Italia questa mattina all'alba accolte all'aeroporto di Ciampino dal ministro degli Esteri Paolo Gentiloni: è festa grande a Gavirate (Varese), il paese di Greta, e a Brembate (Bergamo), quello di Vanessa. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di giovedì con un tweet di Palazzo Chigi, seguito dalla conferma - alla Camera - del ministro per le Riforme Maria Elena Boschi. Nel frattempo il premier Matteo Renzi aveva chiamato la famiglia di Greta per anticipare quella notizia che ha cambiato la vita di due famiglie che per mesi hanno temuto il peggio ma non hanno mai perso la fiducia. Nemmeno quando, lo scorso 31 dicembre, erano apparse in quel video diffuso dai rapitori in supplicavano "il nostro governo di riportarci a casa". Ieri la richiesta è stata esaudita e nei due piccoli centri lombardi le campane hanno suonato a festa spezzando quell'attesa straziante durata sei mesi, da quando le tracce delle due ragazze si erano perse ad Abizmu, poco lontano da Aleppo, nel Nord della Siria. Eppure, mentre in Lombardia si festeggia, a Roma c’è (già) chi fa polemica. Soprattutto dopo che la tv di Dubai al Aan - ripresa anche dal Guardian - ha parlato di 10 milioni di dollari, poco più di 12 milioni di euro versati nelle tasche dei rapitori. Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini tuona contro l’eventualità che si sia pagato un riscatto: "Se veramente per liberare le due amiche dei siriani il Governo avesse pagato 12 milioni sarebbe uno schifo" ha commentato senza mezzi termini seguito a ruota dal compagno di partito Roberto Calderoli e dalla forzista Maria Stella Gelmini, tutti accomunati dalla stessa domanda: è legittimo pagare sapendo che il denaro finanzierà gruppi terroristi? Nella polemica è entrato anche Roberto Saviano. Lo scrittore anticamorra, che vive una vita da sequestrato in casa, ha affidato a Facebook una lettera sfogo: “Care Greta e Vanessa, sono felice per la vostra liberazione, e come me lo sono in tanti. Ma vi aspetterà anche un’Italia odiosa, che vi considera ragazzine sprovvedute che invece di starsene a casa sono andate a giocare in Siria. Diranno che sono stati spesi molti soldi, molto più del valore della vostra vita". Secondo Saviano quelle dichiarazioni sono frutto del "senso di colpa per non avere coraggio, dell’insofferenza dell’incapace che fermo al palo cerca di mitigare la propria mediocrità latrando contro chiunque agisca". D'altra parte, anche di Saviano, costretto a uno strettissimo regime di protezione che annulla la sua libertà personale, molti hanno detto che se l’è andata a cercare sfidando la camorra con il suo lavoro. "Spero saprete sottrarvi a questo veleno - scrive alle due volontarie -. Un’altra parte di questa Italia è convinta che il vostro sia stato un atto di coraggio e di umanità, e che nessuno possa essere considerato causa del proprio rapimento”. I commenti al post di Saviano sono il ritratto di un paese in difficoltà con il concetto di eroe e di coraggio: madri e padri trepidanti che condividono la gioia delle famiglie si mescolano a insulti contro le due ragazze e recriminazioni sul presunto riscatto. Uno scenario che si ripete: dopo Je suis Charlie, ora è la volta di Je suis Greta e Vanessa, identità che sui Social, in questi momenti, va per la maggiore. Il governo italiano naturalmente nega di aver pagato (ma non potrebbe fare diversamente). Resta il fatto che la La Jabhat al-Nusra, "il fronte di sostegno per il popolo siriano" vicino ad al Qaeda che aveva in custodia Greta e Vanessa e gli altri gruppi terroristici più o meno affiliati incassano, secondo il New York Times, circa 2 milioni di euro a ostaggio liberato. Denaro versato "in gran parte dagli europei" sottolinea il quotidiano del Paese che ha scelto la linea dura rifiutandosi di pagare. Ma oggi è il giorno della felicità e delle prime dichiarazioni che le ragazze faranno in Procura a Roma. Per le recriminazioni e le polemiche c'è tutto il tempo: ''Quando la vedrò le darò un grande abbraccio - ha commentato emozionato Salvatore Marzullo, il papà di Vanessa -. Portiamola a casa e poi ci saranno tante cose da dirle''.
15 gennaio 2015. Vanessa e Greta liberate: si festeggia? No! Scrive Alberta Ferrari su “L’Espresso”. E’ ufficiale da poche ore: Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, giovanissime cooperanti sequestrate a luglio in Siria da terroristi jihadisti sono state liberate; stanotte giungeranno in volo dalla Turchia in Italia. Prima di sapere il loro destino e ignorando volutamente la querelle sollevata da chi metteva in discussione motivazioni e/o imprudenza delle delle ragazze, avevo stigmatizzato l’inaudita violenza sessista che “la pancia” degli italiani riversava nei loro confronti in rete, con modalità becere e inaccettabili indipendentemente dal merito delle questioni. Come da previsioni e in linea con la politica estera italiana (differente, per esempio, da quella degli USA) è ovvio che sia stato pagato un riscatto, del quale iniziano a circolare cifre non confermate: 12 milioni di euro. E immediatamente, con le giovani non ancora a casa, persino tra i commentatori più pacati oltre il 90% esprime aperto malumore. Qualcuno premette che è un sollievo che siano state liberate, ma la maggior parte si limita a commenti come questo: “un solo pensiero nella mente di tutti gli italiani: E IO PAGOOOOOOOOOO”. Su facebook, cloaca massima di eiezioni senza filtro cerebrale, il concetto comincia a prender forma con le tristemente note modalità: invettiva, insulto, augurio di torture stupro morte etc. che rendono impossibile ogni civile argomentazione. Facciamocene una ragione perché questo background culturale si applica a tutte le donne: un caso apparentemente lontanissimo come l’annuncio di Emma Bonino di avere un tumore al polmone è stato gratuitamente accolto con analoga marea di triste commentario insultante e sessista, in cui la malattia diventa l’arma con cui colpire e augurare ogni male. Questo è il popolo che si riversa senza filtro sui social ed è bene conoscere, non ignorare. Perché il fenomeno denuncia che il degrado della pancia degli italiani sta arrivando alla barbarie e che le donne sono tipicamente oggetto delle più violente invettive. Nessuno stupore se nel nostro Paese i femminicidi non accennano a diminuire. Chi poi politicamente a questa “pancia” fa facile riferimento titillandone i riflessi pavloviani, ricordi che le masse strumentalizzate sono pericolose e volubili: si innamorano dell’uomo forte, pronti a rinnegarlo e sputare addosso al suo cadavere quando cambia il vento. Accusata personalmente da un commentatore di “becero buonismo” per il fatto che additavo la barbarie degli insulti alle ragazze senza addentrarmi in giudizi sul loro comportamento, oggi che sono in salvo mi permetto di esprimere anche riflessioni nel merito. Purchè rimanga ben chiaro che invettive e insulti rimangono condannabili in sè. Bene, Vanesssa e Greta: bentornate. Potrei essere vostra madre e forse a 20 anni ero più fulminata di voi. Tuttavia vi prego: appena scese dall’aeroporto non dite (come si è sentito in passato) “siamo pronte a tornare”. Non andate a fare le eroine nei talk show. Magari invece, riflettete con persone autorevoli, che si intendono di volontariato e di Paesi in guerra e fate tesoro, magari autocritica, di questa esperienza a lieto fine. Perché vedete, il problema dei milioni di euro di riscatto contiene sì tanta ipocrisia (basterebbe rinunciare a una costosa arma bellica o recuperare denaro da chi delinque o evitare gli sprechi che sono la vera piaga del nostro Paese), ma non merita per questo indifferenza: è pur sempre denaro dei vostri concittadini, che di questi tempi non se la passano troppo bene. Inoltre come pensate che verrà usato? Le vostre vite salvate al prezzo di altre, quando questo denaro diventerà altre armi (che sono arrivate e arrivano nonostante voi, ridimensioniamo anche questa ricorrente e ipocrita colpevolizzazione). Io non sono esperta del settore, quindi mi sono documentata attraverso contatti a me molto vicini; persone esperte che ideologicamente avrebbero ogni motivo per sostenere la vostra posizione. Il problema è che la vostra posizione non è sostenibile. perché, come sostiene la collega Chiara Bonetti (un anno in Mozambico, 6 mesi in Uganda, un anno in Tibet): nella scelta di andare all’estero in qualità di membro onlus o ong governativa, è fondamentale evitare personalismi e schieramenti. All’estero in veste ufficiale non sono ammesse improvvisazioni: si va nel mondo a titolo non personale, bensì a rappresentare il proprio Paese (che infatti si fa carico dei tuoi rischi), una civiltà e un modo di lavorare. Nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di esporsi a pericoli inaccettabili: proprio perché il prezzo del rischio non si paga di persona ma coinvolge potenzialmente tutti coloro che svolgono un’attività anche lontanamente simile, nonché i contribuenti del vostro Paese. All’estero esistono regole molto diverse da quelle con cui si è cresciuti: è imperativo non improvvisare. Ci vuole umiltà, cultura (tanta), una rete d’appoggio, esperienza. Tutte cose che a 20 anni con una onlus fai-da-te (con un terzo individuo che si è smarcato ed è rimasto a casa) sono ampiamente mancate. Ragazze, io diversamente da altri non entro nel merito della vostra buona fede, della nobiltà dei vostri obiettivi: non posso sapere. Ma l’avventatezza è analoga a quella di sciatori fuoripista/scalatori imprudenti che si mettono nei guai dopo aver contravvenuto a regole da bollino rosso o per semplice, sventata inesperienza: possono provocare smottamenti che uccideranno altre persone, oppure mettere a repentaglio la vita di chi deve soccorrerli in condizioni estreme. Termino lasciandovi le riflessioni di due grandi uomini, Walter Bonatti e Reinhold Messner, fini acrobati tra coraggio e paura: “Non esiste il coraggio senza la paura – dice Bonatti – bisogna aver paura delle cose paurose, di ciò che è sconosciuto, ma per combattere il terrore bisogna cercare di conoscere ciò che fa paura. Bisogna costruire il coraggio e poi usarlo”. “La paura – dice Messner – ti spiega bene il limite che non devi superare: fin qui va bene, oltre… scendi. Come è successo a te, davanti alla parete del Pilier d’Angle”. “Ho provato una paura spaventosa – confessa Bonatti – ed ero già molto esperto. Quella notte sono arrivato con il mio compagno, Luigi Zampieri, sotto al Col de la Fourche, a un’ora dall’attacco sono rimasto impietrito di fronte a quella parete che con un gioco di riflessi lunari mi è apparsa una lavagna levigatissima. L’unica cosa evidente che spiccava erano i grandi seracchi pronti a caderti addosso. Ho avuto una paura folle e sono stato un bel po’ a pensare, a chiedermi come fare. Fino a quando, saggiamente, ho concluso che era meglio tornare a casa. E sono tornato a casa. Qualche mese dopo sono tornato, la montagna non era più in condizioni così favorevoli, ma era favorevole il mio spirito, ero pronto. L’abbiamo attaccata e l’abbiamo spuntata”. Buon rientro ragazze, sono felice di riavervi a casa.
Le “stronzette di Aleppo” se la sono cercata, scrive Alberta Ferrari. Vanessa Marzullo e Greta Ramelli sono due giovanissime cooperanti italiane di 20 e 21 anni rapite in Siria a luglio 2014. Sulla loro presenza in una zona tanto pericolosa e in assenza di una solida organizzazione alle spalle le polemiche sono state sempre accese, spesso con toni grossolani e cinici (vedi “le stronzette di Aleppo” di Maurizio Blondet). Il tema di fondo: “due incoscienti sprovvedute” ci mettono nei guai. Linguaggio offensivo, squalificante e, stupore!, sessista: “con la guerra non si scherza e da bambine è bene che non si giochi alle piccole umanitarie, ma con la barbie”. Tra i commenti più soavi. Le due ragazze avevano fondato con il 47enne Roberto Andervill il progetto Horryaty per raccogliere aiuti destinati alla popolazione civile in Siria. Certo sprovvedute queste giovanissime entusiaste, ma non improvvisate. Vanessa, di Brembate, studia mediazione linguistica e culturale all’Università di Milano. Greta, di Besozzo, studentessa, è una volontaria della Croce Rossa e ha già prestato attività di cooperazione in Zambia e in India. Partono per la Siria a febbraio 2014 e vi tornano a luglio attraversando il confine turco con il giornalista de “Il Foglio” Daniele Ranieri. Tre giorni dopo vengono rapite ad Abizmu dopo essere state attirate nella casa del “capo del Consiglio rivoluzionario” locale, mentre Ranieri riesce a fuggire e a dare l’allarme. Per inciso, tocca notare un silenzio assordante – diversamente dai commenti al vetriolo riservati alle ragazze – su questo accompagnatore più che adulto che riesce a darsela a gambe. Nessuno che si stracci le vesti: “incosciente, quella è guerra vera e hai pure coinvolto due ragazze, ma stare a casa a giocare ai soldatini no? minimo meritavi il sequestro pure tu”. Sull’identità dei rapitori si avvicendavo ipotesi: jihadisti dell’Isis, gruppi criminali intenzionati a chiedere un riscatto, compravendita delle ragazze. Capodanno ci sorprende con un importante aggiornamento. Un video su youtube chiarisce che le giovani sono sequestrate dal gruppo jihadista al-Nusra. Le ragazze sono state private del loro abbigliamento e vestono la tunica nera abaya. Parla Greta Ramelli senza mai alzare lo sguardo (“supplichiamo il nostro governo e i suoi mediatori di riportarci a casa prima di Natale. Siamo in estremo pericolo e potremmo essere uccise”) mentre Vanessa Marzullo espone un cartello che riporta la data del 17 dicembre 2014. Personalmente, cercando di non cadere in trappole di superficiale buonismo, ritengo che l’eccessivo rischio e le relative conseguenze che ora non possiamo non fronteggiare, siano ragionevolmente da attribuire più alla responsabilità di chi autorizza e deve controllare viaggi in Paesi sede di guerre da bollino rosso che non all’entusiasmo giovanile dell’impegno fai-da-te. Mi ha turbato, leggendola come segno di imbarbarimento, l’impressionante sequenza di commenti intrisi di cinismo e grettezza che ho letto su Facebook, a commento della notizia del video riportata da Ilfattoquotidiano.it. In base al giornale, commentatori più “collocati a sinistra”, in teoria.
Riporto un campione di questi commenti: del resto fortemente ripetitivi.
Gianni C. ALTRI EURI di chi fa fatica buttati a PUTTANE…………
Fabrizio T. Riportarli a casa in cambio di armi? ? Mai!! Così per colpa di queste 2 idiote ne muoiono 1000.
Gianni P. io penso che “quelli che se la cercano” se la debbano poi sbrogliare.
Maria C. Se le tenessero. Nessuna pietà per chi si caccia nei guai, pur sapendolo.
Fiorni R. Quelle son andate per far carriera, vedi la nostra boldrinazza, vedi simona pari e dispari.
Giuseppe T. Che se le tenessero!
Giulio S. Tenetevele.
Donatella N. Ah si? Tenetevele.
Antonio M. Spero proprio di non avere figli così stupidi.
Angelo M. Per queste due nessuna pietà. ….all’inizio erano contente del sequestro ora che le scarpe gli vanno strette chiedono aiuto. ….tempo scaduto adesso subite il velo e la schiavitù di questo popolo musulmano.
Michele C. Ma fanculo stateve a casa.
Leone B. La guerra nn è un gioco per bambine in cerca di visibilità.
Lamberto C. SE NE STAVANO A CASA LORO NN GLI SAREBBE SUCCESSO NULLA. Se la son cercata.
Bartolomeo A. …. due incoscienti che non possono essere lasciate sole, due imbecilli che da presuntuose epocali, hanno pensato che i loro bei visini, accompagnati dai soliti buoni propositi terzomondialisti o giù di lì, potessero intenerire le carogne in generale che si contendono la siria e non solo…
Enrico D. sono andate li per supportare i tagliagole. se dovessero essere liberate dovrebbero essere processate per aver appoggiato dei terroristi! luride scrofe!
Carlo F. adesso la bandiera arcobaleno non la sventolano più ahahhahahhaahahhaaha.
Antonella R. Visto che non le ha obbligate nessuno ad andare la !!! Sono solo cavoli loro !! A me non me ne importa niente!!
Mino T. Credo che i buonisti, che sono la vera metastasi di questo paese , dovrebbero dare il buon esempio e partire per la Siria a loro spese (…) Per quanto mi riguarda hanno avuto ciò che si meritano.
Graziella T. Prima i nostri maro’, visto che sono andati per lavoro? Loro nonostante che gli si è detto di NON ANDARE, loro sono andate …se la sono cercata.
….. qualche timida voce fuori dal coro si trova ….
Roberto D. Per estendere il concetto, molti hanno perfino contrastato il ritorno in italia del medico italiano che curava l’ebola in africa. Il concetto è: “fai il medico in africa? WOW sei mitico… cosa? ti sei ammalato e vuoi tornare qui e così ci infetti tutti? Ma stai in africa, d’altronde…te la sei andata a cercare”. Ecco di questa gente stiamo parlando.
Daniela C. Son state delle sprovvedute ma vanno portate a casa.
Dominique B. Leggendo gran parte delle risposte invece, mi chiedo chi siano le bestie, quelli che hanno sequestrato le ragazze o quelli che commentano qui…
Emma R. Non ho mai letto tanta cattiveria pressapochismo crudeltà cinismo etc etc nei commenti ad un solo post !!!!! Complimenti a tutti.
Marianna L. Cercasi umanità
Concludo facendo mio il commento al video di Marina Terragni: “Che queste ragazze possano tornare a casa presto e levarsi quegli stracci dalla testa”.
“Menefreghismo assoluto per le attiviste rapite in Siria” e I CARE, continua la Ferrari Poiché i commenti violenti, odiosi e sessisti da me segnalati con stupore e raccapriccio due giorni fa verso le due cooperanti Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, rapite in Siria si sono rivelati vero allarme di una deriva crescente, qualcuno ieri alle 13.00 ha avuto l’idea geniale di creare una pagina Facebook che raccogliesse il turpe dileggio e le offese rivolte in questi giorni con sadico e ottuso accanimento . A seguire uno de tanti post della pagina. In 24 ore 1250 like alla pagina. Per darvi un’idea: io nella mia pagina professionale, che si occupa di salute della donna e i particolare di tumore al seno, il più frequente nel sesso femminile ad ogni età, non sono arrivata a 5000 like in oltre 2 anni. Il che dimostra chiaramente il potere d’attrazione che l’invettiva sessista esercita su gran parte di persone becere, quelli che girano sul social e si esprimono come al bar, offrendo un affresco sociologico veramente degno d’attenzione e preoccupazione. Sul mio post precedente, che segnalava la violenza brutale montante contro le due ragazze ricercandone retroterra culturali e contraddizioni (sugli adulti che le hanno aiutate / accompagnate, silenzio totale), si è aperto con mio sollievo un nutrito dibattito. I commenti hanno riguardato varie criticità della questione, compresa la scelta delle ragazze di addentrarsi in una zona di guerra senza protezione e la loro presunta simpatia per una fazione di combattenti (gli stessi peraltro che le avrebbero rapite), tuttavia il confronto di punti di vista differenti si è svolto in modo civile, contribuendo ad affrontare il problema con più strumenti conoscitivi. A chi invoca il menefreghismo, che evoca il triste “me ne frego” passato alla storia senza gloria né onore, contrappongo, fuori da un contesto religioso ma come espressione basilare di umanità, l’invito di Sabrina Ancarola (che giustamente non dimentica gli altri ostaggi in Siria) che ci ricorda il motto di don Milani: I Care.
Le stronzette di Aleppo, scrive Maurizio Blondet su “Il Punto di Prato”. Vanessa e Greta. Anni 20 e 21.Andate in Aleppo presso i ribelli anti-regime per un progetto umanitario. Progetto che,a quanto è dato dedurre, consisteva in questo:farsi dei selfie e postarli sui loro Facebook:su sfondi di manifestazioni anti-Assad, sempre teneramente abbracciate (Inseparabili, lacrimano i giornali), forse per fare intendere di essere un po’ lesbiche (è di moda), nella città da tre anni devastato teatro di una guerra senza pietà e corsa da milizie di tagliagole. La loro inutilità in un simile quadro è palese dalle loro foto, teneramente abbracciate, con le loro tenere faccine di umanitarie svampite, convinte di vivere dalla parte del bene in un mondo che si apre, angelicamente, grato e lieto al loro passo di volontarie. Una superfluità che i giornali traducono così: Le due ragazze avevano deciso di impegnarsi in prima persona per dare una risposta concreta alle richieste di aiuto siriane. Vanessa è studentessa di mediazione linguistica e culturale, Greta studentessa di scienze infermieristiche: niente-popò-di-meno! Che fiori di qualifiche! Due studentesse ( m’hai detto un prospero!), che bussando a varie Onlus erano riuscite a far finanziare il Progetto Horryaty, da loro fondato. Secondo una responsabile della Onlus che ha sganciato i quattrini alle due angeliche, il loro progetto era finalizzato ad acquistare kit di pronto soccorso e pacchi alimentari,da distribuire al confine. Ostrèga, che progettone! Nella loro ultima telefonata,chiedevano altri fondi. Pericolo per le loro faccine angeliche, o le loro tenerissime vagine? No,erano sicure:avevano capito una volta per tutte che i cattivi erano quelli di Assad,e loro stavano coi buoni,i ribelli. E i buoni garantivano per loro. Si sentivano protette. Nell’ultima telefonata hanno detto che avevano l’intenzione di restare lì. Un Paese serio le abbandonerebbe ai buoni, visto che l’hanno voluto impicciandosi di una guerra non loro di cui non capiscono niente, in un mondo che a loro sembra ben diviso tra buoni e cattivi. Tutt’al più, candidarle al Premio Darwin (per inadatti alla lotta per la vita), eventualmente alla memoria… Invece la Farnesina s’è sùbito attivata, il che significa una cosa:a noi contribuenti toccherà pagare il riscatto che i loro amici, tagliagole e criminali, ossia buoni, chiederanno. E siccome le sciagure non vengono mai sole, queste due torneranno vegete, saranno ricevute al Quirinale, i media verseranno fiumi di tenerezza, e pontificheranno da ogni video su interventi umanitari, politiche di assistenza, Siria e buoni e cattivi di cui hanno capito tutto una volta per tutte. Insomma, avremmo due altre Boldrini.
La liberazione di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due cooperanti italiane rapite in Siria sei mesi fa, ha innescato due reazioni contrapposte: sollievo e soddisfazione espresse dalle istituzioni (lungo applauso in Parlamento dopo l'annuncio del ministro Boschi in Aula), polemiche e livore da rappresentanti delle opposizioni a cui è seguita una corsa all'emulazione sui social network, scrive “Ibtimes”. Non poteva mancare il commento di Matteo Salvini: "La liberazione delle due ragazze mi riempie di gioia ma l'eventuale pagamento di un riscatto che permetterebbe ai terroristi islamici di uccidere ancora sarebbe una vergogna per l'Italia. Presenteremo oggi stesso un'interrogazione al ministro degli Esteri per appurare se sia stato pagato un solo euro per la liberazione delle due signorine". Ma la palma dell'uscita più strumentale è del capogruppo di Forza Italia in Emilia-Romagna, Galeazzo Bignami: "Le due ragazze amiche dei ribelli siriani e sequestrate dai ribelli siriani sono state liberate immagino dietro pagamento di lauta ricompensa ai ribelli siriani. Ora che sono libere penso si possa dire con chiarezza che di chiaro in questa storia non c'è nulla. A partire dal fatto che questo sequestro pare proprio un gran favore fatto dalle loro amiche ai ribelli. Per inciso si liberano queste qui mentre chi porta la divisa e rappresenta lo stato è ancora in arresto in india. Bello schifo". Altri esponenti di centrodestra hanno puntato l'indice sulla questione riscatti. "Finita la fase di legittima soddisfazione, serve che il ministro Boschi ci dica se è in grado di escludere che da qualunque fonte di finanziamento pubblico sia stato un centesimo per riportare le due ragazze a casa" le parole di Massimo Corsaro (Fratelli d'Italia). "Doveroso chiederci se un eventuale riscatto pagato a dei terroristi non sia una fonte di finanziamento per portare la morte in Europa e altrove" sostiene anche l'ex ministro Maria Stella Gelmini. Le strumentalizzazioni hanno dato il là a commenti simili anche degli utenti sui social network. "Un riscatto milionario per due sceme", "sia chiaro a tutti che sono ben altri i cervelli da far rientrare". Altri ancora imitano Bignami nell'improprio parallelo con la vicenda dei marò. Oppure si leggono frasi sulla guerra "non adatta" alle donne. O ancora che non è giusto pagare 12 milioni di dollari (questa la presunta cifra pagata per liberare le due ragazze) per gente che "va in vacanza". Legittimo discutere sugli effetti collaterali delle possibile impreparazione delle cooperanti in zone di guerra, che si pongono in una situazione di oggettivo pericolo e mettono in difficoltà il paese. Ma non in quanto donne, né si può sostenere che le due fossero in Siria per prendere il sole. Strumentale, improprio e spesso in malafede, ogni altro genere di discorso o commento. Cosa c'entra la vicenda dei due marò, accusati di omicidio in India? Suggeriscono forse di corrompere gli indiani allo scopo di ottenere la liberazione di Latorre e Girone? Ipocrita anche la reazioni sul pagamento del riscatto, non perché sul tema non ci sia da discutere ma perché viene da pensare "da che pulpito parte la predica?". Il fatto che l'Italia (come Francia, Spagna o Svizzera) abbiano pagato in passato riscatti milionari ai sequestratori è il segreto di Pulcinella. Simona Pari e Simona Torretta (altre due cooperanti, stavolta in Iraq, 2004), Giuliana Sgrena (2005), Clementina Cantoni (2005), Rossella Urru (2011) e Mariasandra Mariani (2011) sono tutti sequestri che si sono probabilmente conclusi con il pagamento di un riscatto (ad Al-Qaeda o altre organizzazioni legate al fondamentalismo). Chi governava in quegli anni? Quel centrodestra che oggi attacca a testa bassa.
Ostaggi italiani, non sempre è finita bene, scrive “La Voce D’Italia”. Il primo rapimento recente di italiani nel mondo a lasciare il segno nella memoria collettiva è del 2004, in Iraq. Vengono sequestrati a Baghdad 5 contractor, Fabrizio Quattrocchi, Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. Quattrocchi viene ucciso, gli altri liberati. Indimenticabile il video in cui la vittima dice ai carnefici: “vi faccio vedere come muore un italiano”. Lo stesso anno sempre in Iraq vengono rapiti il freelance Enzo Baldoni, ucciso poco dopo, e le due cooperanti Simona Torretta e Simona Pari, liberate dopo 19 giorni. Nel 2005 tocca alla giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena. Subito dopo la sua liberazione, un militare americano uccide per sbaglio il funzionario del Sismi Nicola Calipari che era andato a prenderla. Nel 2007 in Afghanistan viene rapito dai talebani il giornalista di Repubblica Daniele Mastrogiacomo, poi liberato. In Mali nel 2009 Al Qaida rapisce due coniugi italiani, Sergio Cicala e Philomene Kabouré. Vengono liberati l’anno dopo. L’inviato della Stampa Domenico Quirico viene rapito due volte: la prima volta nel 2011 in Libia per due giorni (con i colleghi Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina, entrambi del Corriere della Sera, e Claudio Monici di Avvenire); la seconda volta nel 2013 in Siria per cinque mesi. I pirati somali nel 2011 catturano due navi mercantili italiane, la Savina Caylyn, con 5 italiani a bordo, e la Rosalia D’Amato, con 6 italiani. Gli ostaggi vengono liberati insieme alle unità lo stesso anno, dopo mesi di prigionia. Nel 2011 nel Darfur in Sudan viene catturato dai ribelli locali il cooperante di Emergency Francesco Azzarà, liberato dopo 124 giorni. Lo stesso anno gli shabaab somali catturano al largo della Tanzania l’italo-sudafricano Bruno Pellizzari, mentre si trova sulla sua barca a vela con la fidanzata sudafricana. Viene liberato dopo un anno e mezzo con un blitz dell’esercito somalo. In Algeria nel 2011 i terroristi islamici sequestrano la turista Sandra Mariani e la cooperante Rossella Urru. Entrambe vengono liberate nel 2012. In quello stesso anno finisce invece tragicamente il rapimento in Nigeria dell’ingegnere Franco Lamolinara, sequestrato dai jihadisti nel 2011: l’italiano viene ucciso dai sequestratori durante un blitz delle forze speciali di Londra, che volevano liberare un ostaggio britannico tenuto con lui. Nessuna notizia dopo oltre tre anni del cooperante Giovanni Lo Porto, sequestrato in Pakistan nel 2012 mentre lavorava per una ong tedesca, né del gesuita padre Paolo Dall’Oglio. Quest’ultimo scompare in Siria nel 2013, mentre cerca di mediare a Raqqa per la liberazione di un gruppo di ostaggi. Voci contrastanti lo danno prima per morto, poi prigioniero dell’Isis. Nel 2014 in Libia vengono rapiti due tecnici italiani, in due diversi episodi: l’emiliano Marco Vallisa e il veneto Gianluca Salviato, entrambi liberati dopo diversi mesi.
Greta e Vanessa a casa, polemiche sul riscatto: «Pagati 10 milioni di dollari», scrive “Il Messaggero”. È stata la tv di Dubai al Aan a ipotizzare che possa essere stato pagato un riscatto di 12 milioni di dollari (poco più di 10 milioni di euro) ai qaedisti anti-Assad del Fronte al Nusra per il rilascio di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due giovani italiane rapite in Siria nel luglio scorso e liberate giovedì. La voce, denunciata in Italia dal leader della Lega Matteo Salvini, è ripresa anche dal Guardian online, secondo cui si tratta di «un'informazione non confermata». «Se veramente per liberare le due amiche dei siriani il governo avesse pagato un riscatto di 12 milioni, sarebbe uno schifo!», scrive in un tweet Salvini. Il governo italiano, come d'uso, nega di avere pagato un riscatto e incassa intanto l'ennesimo successo sul fronte della liberazione di ostaggi (sono stati oltre una dozzina negli ultimi 10 anni gli italiani sequestrati all'estero). A dare consistenza alle voci sul pagamento tuttavia in questo caso c'è anche un tweet di un account ritenuto vicino ai ribelli siriani anti-Assad in cui si parla di un "riscatto di 12 milioni di dollari” per la liberazione delle due italiane. La Jabhat al-Nusra, «il fronte di sostegno per il popolo siriano», è cresciuto esponenzialmente grazie alle vittorie sul campo ma anche a una incredibile disponibilità di armi e fondi per combattere contro le forze del presidente siriano Bashar al Assad. La sua fonte principale di finanziamento, oltre alle generose donazioni che arrivano dall'estero, è proprio quello che arriva dai riscatti: il New York Times ha stimato che al Qaida e i gruppi affiliati abbiano incassato oltre 125 milioni di dollari negli ultimi 5 anni, la massima parte versati «dagli europei». Il Fronte è stato fondato alla fine del 2011, nel pieno della rivolta contro il governo siriano, quando l'allora emiro di al Qaida in Iraq, e ora leader dell'Isis, Abu Bakr al-Baghdadi, inviò i primi combattenti in Siria. Considerato "meno sanguinario" del ramo iracheno di al Qaida, il Fronte si è attribuito diversi attacchi anche contro i civili: nei primi tre mesi del 2012 si rende protagonista di diversi attentati, alcuni kamikaze, a Damasco e Aleppo contro le forze governative siriane, decine i morti. Nel 2013 Nusra finisce al centro di quello che evolverà in scontro violento tra Baghdadi e Ayman al Zawahri: il califfo dichiara che al Nusra è parte di al Qaida in Iraq nella nuova formazione Isis. Ma a giugno il leader di al Qaida lo smentisce. L'ostilità tra Nusra e Isis sfocia in aperti combattimenti che secondo alcune fonti lasciano sul campo 3.000 uccisi tra i jihadisti dei due fronti. Alla fine dell'anno Nusra rapisce 13 monache da un monastero cristiano che verranno rilasciate nel marzo del 2014. Pochi mesi dopo, il 27 agosto, mentre l'Isis guadagna le prime pagine per la barbara esecuzione di James Foley, Nusra in controtendenza libera lo scrittore americano Peter Theo Curtis, rapito due anni prima. Il Qatar gioca un ruolo di primo piano nelle trattative per il rilascio. Alla famiglia era stato chiesto un riscatto di 3 milioni di dollari «cresciuti fino a 25». Il giorno dopo la liberazione dell'americano, il 28, il Fronte gruppo avanza in Golan e cattura 45 peacekeeper dell'Onu, che vengono liberati l'11 settembre. L'ultima stima dei think tank Usa è che il Fronte possa contare su oltre 6.000 combattenti ben addestrati, dislocati soprattutto nella regione di Idlib. Nelle zone controllate da Nusra vige la Sharia e sono state introdotte le corti islamiche.
Due video «cifrati» in 15 giorni. Così i rapitori hanno alzato il prezzo. I ribelli: «Pagati 12 milioni di dollari». La banda di terroristi non è legata all’Isis. Le stragi di Parigi usate per alzare la posta. La cifra diffusa sembra comunque esagerata, scrive Fiorenza Sarzanini su “Il Corriere della Sera”. Lo scambio sarebbe avvenuto tra domenica e lunedì, dopo l’arrivo di un video che forniva la nuova prova in vita delle due ragazze rimaste prigioniere in Siria quasi sei mesi. Un filmato per sbloccare definitivamente la trattativa, con la consegna della contropartita ai sequestratori. Sembra esagerata la cifra di dodici milioni di dollari indicata dai ribelli al regime di Assad, ma un riscatto è stato certamente pagato, forse la metà. E tanto basta a scatenare la polemica, alimentata da chi sottolinea come il versamento sarebbe avvenuto proprio nei giorni degli attentati a Parigi. È l’ultimo capitolo di una vicenda a fasi alterne, con momenti di grande preoccupazione, proprio come accaduto dopo la strage di Charlie Hebdo e del supermercato kosher, quando i mediatori avrebbero tentato di alzare ulteriormente la posta. Saranno Greta Ramelli e Vanessa Marzullo a fornire ai magistrati i dettagli della lunga prigionia, compreso il numero delle case in cui sono state tenute. Ieri sera, dopo essere arrivate in un luogo sicuro - probabilmente in Turchia - e prima di essere imbarcate sull’aereo per l’Italia, sono state sottoposte al «debriefing» da parte degli uomini dell’ intelligence , come prevede la procedura che mira a ottenere notizie preziose sul gruppo che le ha catturate il 31 luglio scorso e su quelli che le hanno poi gestite nei mesi seguenti. Attivare i primi contatti per il negoziato non è stato semplice, anche se si è avuta presto la certezza che a rapirle era stata una banda di criminali, sia pur islamici, e non i jihadisti dell’Isis. A metà agosto, quando il Guardian ha rilanciato l’ipotesi che fossero tra gli ostaggi internazionali del Califfo Abu Bakr al-Baghdadi, i mediatori italiani si sono affrettati a smentire proprio nel timore che la trattativa potesse fermarsi. Circa un mese dopo è arrivata la prima prova per dimostrare che le ragazze stavano bene. E da quel momento è partita la trattativa degli 007, coordinata da Farnesina e Palazzo Chigi. Secondo le notizie iniziali a organizzare il sequestro è il «Free Syrian Army», l’esercito di liberazione della Siria. Ma la gestione delle prigioniere avrebbe avuto fasi alterne, con svariati cambi di «covo» e nell’ultima fase ci sarebbe stata un’interferenza politica di «Jabat al-Nusra», gruppo della galassia di Al Qaeda che avrebbe preteso un riconoscimento del proprio ruolo da far valere soprattutto rispetto alle altre fazioni e contro l’Isis. Non a caso, poco dopo la conferma dell’avvenuto rilascio delle due giovani, un uomo che dice di chiamarsi Muahhed al Khilafa e si firma sulla piattaforma Twitter con l’hashtag dell’Isis posta un messaggio per attaccare «questi cani del fronte al-Nusra che rilasciano le donne crociate italiane e uccidono i simpatizzanti dello Stato Islamico». Del resto è proprio la situazione complessa della Siria ad alimentare sin da subito la sensazione che il sequestro non possa avere tempi brevi. E infatti la «rete» attivata per dialogare con i sequestratori ha a che fare con diversi interlocutori, non tutti affidabili. Con il trascorrere del tempo le richieste diventano sempre più alte, viene accreditata la possibilità che i soldi non siano sufficienti per chiudere la partita, che possa essere necessario concedere anche altro. A novembre si sparge la voce che una delle due ragazze ha problemi di salute, si parla di un’infezione e della necessità che le vengano dati farmaci non facilmente reperibili in una zona così segnata dalla guerra. Qualche giorno dopo arrivano invece buone notizie, un emissario assicura che Greta e Vanessa sono in una casa gestita esclusivamente da donne. Informazioni controverse che evidentemente servono a far salire la tensione e dunque il valore della contropartita per la liberazione. A fine novembre c’è il momento più complicato. I rapitori cambiano infatti uno dei mediatori facendo sapere di non ritenerlo più «attendibile». Si cerca un canale alternativo e alla fine si riesce a riattivare il contatto, anche se in scena compare «Jabat al-Nusra» e la trattativa assume una connotazione più politica. La dimostrazione arriva quando si sollecita un’altra prova in vita di Greta e Vanessa e il 31 dicembre compare su YouTube il video che le mostra vestite di nero, mentre chiedono aiuto e dicono di essere in pericolo. È la mossa che mira ad alzare il prezzo rispetto ai due milioni di dollari di cui si era parlato all’inizio. Quel filmato serve a chiedere di più, ma pure a lanciare il segnale che la trattativa può ormai entrare nella fase finale. Anche perché contiene una serie di messaggi occulti che soltanto chi sta negoziando può comprendere, come il foglietto con la data «17-12-14 wednesday» che Vanessa tiene in mano mentre Greta legge il messaggio, che sembra fornire indicazioni precise. Si rincorre la voce che entro qualche giorno possa avvenire il rilascio. Ma poi c’è una nuova complicazione. Il 7 gennaio i terroristi entrano in azione a Parigi, quattro giorni dopo arriva un nuovo video. Questa volta viaggia però su canali riservati. L’intenzione dei sequestratori sembra quella di alzare ulteriormente la posta, la replica dell’Italia è negativa. Si deve chiudere e bisogna farlo in fretta. L’ intelligence di Ankara fornisce copertura per il trasferimento oltre i confini siriani delle due prigioniere. Ieri mattina gli 007 avvisano il governo: è fatta, tornano a casa.
Greta e Vanessa, malate e maltrattate nelle mani dei sequestratori, scrive “Libero Quotidiano”. Sono stati mesi molto duri quelli trascorsi da prigioniere. Greta Ramelli e Vanessa Marzullo ora sono finalmente libere, ma ciò che hanno dovuto subire durante il sequestro le ha molto provate sia psicologicamente che fisicamente. A rivelarlo sono gli 007 che hanno trovato fin dall'inizio della vicenda un canale di mediazione e dunque un interlocutore che ha permesso ai nostri servizi di "monitorare" costantemente le cooperanti per tutta la durata della trattativa. Hanno vissuto momenti molto difficili, rivela al Messaggero chi ha seguito in questi mesi la sorte di Greta e Vanessa. Una delle due è stata poco bene in salute, ma le sono stati forniti i medicinali e gli antibiotici per curarsi. Hanno subito soprusi, sorvegliate di continuo da uomini armati. L'intelligence spiega che le due ragazze erano nelle mani di banditi comuni e che Jahbat Al Nusra, il movimento vicino ad al Quaeda in Siria al quale era stato attribuito erroneamente il sequestro, avrebbe solo fornito soprattutto copertura politica, proprio perché quella parte di territorio a Nord della Siria è totalmente nelle loro mani. A sequestrarle, in realtà, sarebbero stati membri del Jaish al-Mujahideen, sigla che racchiude una decina di gruppi islamisti (alleati del Free Syrian Army, l' esercito siriano libero), una forza armata che combatte contro il governo di Bashar al-Assad. Poi sarebbero state "vendute" più volte, senza mai finire, fortunatamente, nelle mani dell' Isis, né in territori controllati da loro. Tutto quello che hanno passato resterà indelebile nella loro mente e nel loro cuore, ma oggi è il momento della gioia. All'alba Greta e Vanessa sono arrivate a Ciampino accolte dal ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, che alle 13 riferirà sulla vicenda alla Camera. Poi sono state condotte all’ospedale militare del Celio per gli opportuni controlli medici. Più tardi saranno ascoltate in procura a Roma. Solo al termine della deposizione potranno tornare finalmente nelle loro città che ieri, dopo mesi di tensione e angoscia, alla notizia della loro liberazione sono esplose di gioia. "E' un momento di grande felicità - ha detto il fratello della ragazza, Matteo Ramelli -, speriamo che Greta possa tornare presto a casa. La Farnesina ha fatto un lavoro fantastico, e anche i nostri concittadini sono stati meravigliosi". Alcuni automobilisti, passando davanti alla casa di Greta a Gavirate, un paese affacciato sul lago di Varese, hanno suonato il clacson, in segno di giubilo per la liberazione. E ieri sera il parroco del paese, don Piero Visconti, ha voluto "ringraziare il Signore" durante in momento di preghiera nell'oratorio di Gavirate. "Se tutti i giovani sapessero rischiare come ha fatto Greta - spiega - il mondo sarebbe un posto migliore. Spero che il suo esempio possa sostenere anche le tante altre persone che vogliono vivere donando amore agli altri". Il sindaco del paese, Silvana Alberio, ha incontrato i genitori, per esprimere la vicinanza di tutta la comunità. "Siamo felicissimi - racconta la madre di Greta - non vediamo l'ora di riabbracciarla". Altrettanta gioia è stata espressa dai familiari di Vanessa. "E' una grande gioia - dice emozionato Salvatore Marzullo, il papà che lavora in un ristorante di Verdello, il paese dove da qualche tempo vive appunto con la figlia. Appresa la notizia è scoppiato in lacrime. Dopo "un'angoscia unica", è arrivata "una gioia immensa che aspettavamo da mesi e che non si può descrivere", ha aggiunto. Momenti di sfiducia? "No - ha risposto - c'era preoccupazione e tristezza, ma abbiamo avuto sempre fiducia nel risultato. La Farnesina ci rassicurava sempre, devo ringraziare loro che sono riusciti a farci restare sempre ottimisti". "Quando la vedrò - ha concluso - le darò un grande abbraccio. Portiamola a casa e poi ci saranno tante cose da dirle".
Greta e Vanessa liberate in Siria, il retroscena sulla trattativa: i banditi, Al Nusra, il riscatto milionario, scrive “Libero Quotidiano”. La trattativa per liberare e riportare in Italia Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le giovani cooperanti lombarde rapite in Siria lo scorso 31 luglio e atterrate nella notte tra giovedì e venerdì a Ciampino, accolte dal ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Nonostante la smentita dell'intelligence italiana, tutte le ricostruzioni non escludono l'ipotesi di un riscatto di 12 milioni di dollari pagato dalle nostre autorità ai rapitori, anzi. Innanzitutto, però, occorre fare chiarezza su chi siano i "rapitori". "Banditi verniciati da islamisti": così li avrebbero etichettati i servizi italiani che hanno lavorato al caso di Greta e Vanessa. Di sicuro, non erano né dello Stato islamico né della fazione jihadista rivale, Al Nusra. A dare supporto logistico a questa banda più o meno improvvisata sarebbero stati i ribelli anti-Assad del Syrian Free Party, l'esercito libero siriano. Attraverso mediatori vicini ai ribelli "buoni" siriani Farnesina e intelligence hanno cercato per mesi un canale per risolvere positivamente la vicenda. A dicembre, però, improvvisamente si complica tutto. Tra 23 e 31, riporta Repubblica, a inizio mese secondo il Corriere della Sera, vengono meno i contatti. Poi, la sera di Capodanno, spunta in rete il video delle due italiane vestite di nero dal covo dei rapitori. Sarebbe stato un segnale al governo italiano: per liberare Greta e Vanessa servono soldi, più di quanti ipotizzati. La posta, insomma, si è alzata e il perché si scopre presto: sarebbero cambiati i mediatori. I rapitori si sarebbero infatti avvicinati ad Al Nusra, i "rivali" dell'Is che qualcuno, in maniera molto ottimistica, definisce "meno feroci" dei tagliagole del Califfato. L'unica differenza in realtà è che se questi ultimi i prigionieri li sgozzano in diretta video, i primi preferiscono venderli per fare soldi, molti soldi. Che servono ad acquistare armi, addestrare milizie (anche kamikaze), corrompere governi ed eserciti. Insomma, alimentare l'industria del terrore. Al Nusra fa pubblicare quel video, la notte del 31 dicembre, contro la volontà dei servizi italiani. Seguono giorni frenetici, fino agli attentati di Parigi che emotivamente potrebbero portare il governo di Roma a pagare ancora di più per non avere sulla coscienza la morte atroce di due ragazze. I jihadisti lo sanno, e alzano la posta. L'Italia chiede un'altra prova che le rapite siano vive e gli uomini di Al Nusra girano un secondo video, questa volta riservato e non pubblicato sul web. E' il segnale: Greta e Vanessa stanno bene e si possono liberare. A che prezzo, forse non lo si scoprirà. Lo scrittore Erri De Luca, che già in passato ha espresso posizioni controverse sulla questione della linea Alta velocità Torino-Lione, ha commentato la liberazione dal suo account twitter. "Se è stato pagato un riscatto - ha scritto -, per una volta sono stati spesi bene i soldi pubblici". A tal proposito, il leader della Lega Matteo Salvini ha affermato: "La liberazione delle due ragazze mi riempie di gioia ma l'eventuale pagamento di un riscatto che permetterebbe ai terroristi islamici di uccidere ancora sarebbe una vergogna per l'Italia". Come dire: i terroristi islamici si finanziano anche con questi riscatti.
Vanessa e Greta, samaritane innamorate del kalashnikov. Sui loro profili Facebook frasi pesanti e immagini forti. E amicizie con combattenti che posano con i cadaveri, scrive Fausto Biloslavo su “Il Giornale”. Fotomontaggi con il kalashnikov avvolto dai fiori, l'appello per salvare un barcone di clandestini, insulti alle Nazioni Unite e amici combattenti in Siria sono le tracce lasciate su Facebook di Vanessa Marzullo e Greta Ramelli prima di sparire. Non proprio profili di buone samaritane, ma piuttosto di attiviste che appoggiano la lotta armata contro il regime di Damasco. Peccato che proprio fra i loro amici combattenti si annidino i presunti rapitori pronti a lucrare sulle due ragazze prese in ostaggio. Adesso che è apparsa la «prova in vita», ovvero il primo video delle due sequestrate, raccontiamo chi sono Vanessa e Greta attraverso le loro stesse parole o immagini postate in tempi non sospetti. Marzullo pubblica sul suo profilo la foto di un gruppo di soldatini di plastica. In mezzo c'è una ballerina dipinta di rosa, che imbraccia un fucile mitragliatore. Il primo ottobre 2013, un certo Ahmad Lion of Islam scrive in inglese: «Carina. Così adesso vieni a combattere con noi eroina. In qualsiasi momento sei la benvenuta». Un altro post mostra il fotomontaggio di un kalashnikov avvolto dai fiori ed il 24 luglio 2013 Vanessa si rivolge al presidente siriano, Bashar al Assad, con una frase che lo invita a darsi fuoco, dopo aver bruciato tutto nel suo Paese. Il primo aprile non ha dubbi e scrive: «Assad non è siriano, non è musulmano, non è laico (…). Assad non è neppure umano». L'8 febbraio, posta un inequivocabile «Onu di merda. Posso descrivere solo così il mio stato d'animo in questo momento». La deriva a favore dei ribelli siriani è evidente anche dalle risposte ad uno strano questionario in inglese che chiede cosa bisognerebbe fare in Siria? La prima risposta è «armare l'Esercito libero siriano». I giornalisti come Monica Maggioni, direttore di Rai news 24 che osa intervistare Assad, vengono insultati e sbeffeggiati. Il pensiero a senso unico delle due ragazze in ostaggio in Siria risulta evidente dalle immagini postate su Facebook. Un cartello del novembre 2012 è rivolto all'Occidente con la seguente scritta in inglese: «Allah o Akbar è un grido di vittoria. Nessun panico». Oppure un diretto «Cari Onu…Usa…Nato Vi odio». Il 3 giugno Vanessa lancia un appello «urgente» salva clandestini di Nawal Syriahorra, che chiede a «siriani/arabofoni di contattare» un telefono satellitare «presente sull'imbarcazione di cui ha parlato in questi giorni, con almeno 450 persone a bordo abbandonate al mare. Chiamare sperando che qualcuno risponda e chiedere: sono tutti vivi? c'è gente in acqua? la donna ha partorito? sono stati raggiunti da italiani o maltesi? Al più presto!». Il vero cognome di Nawal potrebbe essere Sofi, una fervente attivista della fallita primavera araba di Damasco di origine marocchina, che favorirebbe l'arrivo dei profughi siriani in Italia. La pasionaria partecipava alle stesse manifestazioni dove è stato fotografato Hassam Saqan, che in Siria si è fatto immortalare in un video di brutale esecuzione di soldati governativi prigionieri dei ribelli. Vanessa su Facebook ha postato una frase in italiano non perfetto scritta su un muro e firmata da Nawal Sofi: «Qui in Siria unico terrorista Bashar el Assad 15/3/2013 Mc- Italy».Greta Ramelli non è da meno come amicizie in rete con combattenti in Siria. Le piace molto una foto con dei miliziani in mimetica nella zona di Idlib, dove probabilmente le due ragazze sono trattenute in ostaggio. La didascalia non è proprio un esempio di pacifismo: «La bellezza e la forza sconvolgente della natura: tanto è stato il sangue versato che ora al suo posto spuntano dei meravigliosi fiori rossi». Abu Wessam, un giovane ribelle mascherato, amico in rete di Greta, posta le foto delle due ragazze in piazza Duomo a Milano con la bandiera dell'Esercito siriano libero. Su Facebook l'amico più importante dell'attivista «umanitaria» è Mohammad Eissa, il comandante delle Brigate dei martiri di Idlib, che in rete si fa fotografare davanti a una dozzina di corpi di nemici uccisi. Il gruppo islamista ha avuto rapporti altalenanti con l'Esercito libero, formazione laica e filoccidentale della guerriglia, ma pure con Al Nusra, la costola di Al Qaida in Siria, che rivendica il rapimento. Probabilmente il barbuto comandante aveva garantito protezione anche nei viaggi precedenti in Siria alle due ragazze innamorate della rivolta siriana. Questa volta qualcosa è andato storto e gli «amici» ribelli di Vanessa e Greta si sono trasformati in carnefici, o almeno così sembra.
Greta e Vanessa, il giornalista del Foglio: "Non mi trovavo con loro". Daniele Raineri scrive che, quando avvenne il sequestro delle due italiane, era ad alcuni chilometri di distanza. "Cercavano anche me", scrive Lucio Di Marzo su “Il Giornale”. C'era anche Daniele Raineri con Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, la sera che le due italiane sono state rapite in Siria? Questo si è detto dal giorno del loro sequestro, sostenendo che l'inviato del Foglio fosse riuscito a fuggire dall'abitazione dove si trovavano tutti e tre, mentre le due volontarie venivano catturate. Una storia su cui oggi ha detto la sua anche il diretto interessato, che in un articolo pubblicato sul quotidiano di Giuliano Ferrara sostiene invece che no, quella notte non si trovava con le due ragazze italiane. "Ero a circa venticinque chilometri dalla casa dov'erano loro", scrive Raineri. In una casa di campagna, usata come base dai ribelli, "a sud di Aleppo". La versione del giornalista sembra dunque smentire uno dei dettagli legati al sequestro, spiegando che nell'abitazione ("Il capo della casa era un ex soldato delle forze speciali di Assad") ci è rimasto fino al mattino alle cinque. Poi alcuni colpi alla porta e la notizia, portata da due siriani, del sequestro di Greta e Vanessa, per mano di un gruppo che in quel momento non si riesce a identificare. Forse - prova a ricostruire il Fatto Quotidiano, grazie ad alcuni documenti del Ros - sono "rimaste vittime proprio di quelli che volevano soccorrere", se è vero che il loro progetto era anche in funzione di supporto a quell'Esercito libero composto da gruppi che l'Occidente ha spesso identificato come moderati.
Greta e Vanessa, due ingenue o due fiancheggiatrici del terrorismo? Si chiede Milano Post. Greta e Vanessa, due ragazze ventenni, lombarde volontarie del Progetto Horryaty, una Onlus fondata da Roberto Andervill poche settimane prima del presunto rapimento delle due cooperanti. Progetto Horryaty opera in maniera del tutto svincolata dalle varie Ong presenti in territorio siriano e, stando alle dichiarazioni ufficiali dei responsabili della Onlus, in Italia si occupano di raccolta fondi e sensibilizzazione, in Turchia comprano gli aiuti, teoricamente materiale sanitario, che vengono poi distribuiti in zone diverse della Siria. Questo ufficialmente, scavando e cercando la verità troviamo un Roberto Andervill nel cui profilo Facebook, al momento chiuso, si leggevano frasi di odio verso i presidenti delle Comunità Ebraiche italiane, contro Magdi Allam e, giusto per non deludere la sua sinistra ideologia, messaggi di pace (eterna) verso gli Ebrei. Detto questo passiamo direttamente ad osservare Greta e Vanessa e vi siete mai chiesti cosa c’è scritto sul cartello che reggono in quella famosa foto in cui vengono ritratte avvolte dalla bandiera siriana in Piazza Duomo?
Sveliamo l’arcano, il quel cartello c’è scritto:” Agli eroi di Liwa Shuhada grazie per l’ospitalità e se D-o vuole vediamo la città di Idlib libera quando ritorneremo”. Chi sono gli eroi di Liwa Shuhada? Presto detto: Liwa Shuhada Al-Islam, in italiano Brigata dei martiri dell’Islam, è un’organizzazione, secondo i maggiori esperti di terrorismo internazionale, terroristica di stampo jihadista, molto vicina al Fronte Al-Nusra, il nome di Al-Qaeda in Siria per intenderci, e responsabile di numerosi attentati a Damasco. Inoltre, stando alle ultime indiscrezioni, pare, dalle varie intercettazioni in mano ai R.O.S., che le due ragazze avesse già intessuto da tempo rapporti con cellule del fronte anti-Assad, in Italia, cellule che oggi chiamiamo “foreign fighters” e che in Francia hanno seminato morte e terrore pochi giorni fa. Quindi ho forti dubbi che si trattasse di due ventenni ingenue e sprovvedute, considerato che erano già state in Siria, che avevano già dato aiuti ai “guerriglieri” e che si stavano recando ancora in Siria per distribuire kit di pronto soccorso ai membri della Brigata dei Martiri dell’Islam, probabilmente gli stessi che le hanno “rapite”, o sarebbe meglio dire nascoste da occhi indiscreti, messe all’ingrasso per poi richiedere il solito riscatto per la “liberazione” dei presunti ostaggi. Certo però che rispetto alle due Simone, in Iraq, e della Sgrena, Greta e Vanessa sono state decisamente più “professionali”. Mentre le prime hanno fruttato alla causa del terrorismo “solo” undici milioni di dollari (5 per le due cooperanti e 6 per la Sgrena), Greta e Vanessa hanno da sole fatto regalare ai terroristi ben 12 milioni di dollari, anche se negati dal ministro degli Esteri Gentiloni, si sa che Italia, Francia, Germania e Spagna preferiscono pagare. “Non c’è nulla per cui si debba chiedere scusa” queste le parole del padre di Vanessa. Eh no caro signore, c’è invece da chiedere scusa. Sua figlia e la sua amica devono chiedere scusa ai cittadini italiani, visto che i soldi pagati per “liberarle” da una prigionia a pane e kebab, provengono dalle tasse che egli italiani pagano. Devono porgere le loro scuse, implorando il perdono, a tutte quelle famiglie che perderanno un loro caro ed a tutte le innocenti vittime che quei 12 milioni di dollari, regalati al terrorismo islamico, causeranno in Medio Oriente o in Europa.
Vanessa e Greta, cosa non torna nella loro storia: le quattro accuse di Maurizio Belpietro su “Libero Quotidiano”. Il governo si è dato da fare per smentire di aver pagato un riscatto in cambio della liberazione di Vanessa e Greta. «Solo illazioni» ha dichiarato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, il quale subito dopo ha però aggiunto che nel caso delle due cooperanti italiane l’esecutivo si è comportato come i precedenti (che infatti pagavano), precisando che per Palazzo Chigi e dintorni dà la priorità al salvataggio di vite umane (tradotto: pazienza se ci sono costate 12 milioni, tanto sono soldi dei contribuenti). Con il rientro delle due ragazze e le rassicurazioni del ministro si vorrebbe così chiudere la faccenda, mettendo una pietra sopra l’imbarazzante trattativa con i terroristi. Si dà il caso che però la vicenda sia tutt’altro che archiviabile ma necessiti di ulteriori approfondimenti, soprattutto dopo la rivelazione di una serie di antefatti. Ieri in un articolo del Fatto quotidiano si dava conto dell’esistenza di una informativa dei Ros sulla missione siriana di Vanessa e Greta. Non un rapporto compilato dopo la sparizione delle due ragazze, ma una nota predisposta prima della partenza. Quanto prima? Leggendo l’articolo non è dato sapere, ma si capisce che la relazione del reparto operativo dei carabinieri risale al periodo in cui le due giovani lombarde stavano organizzando il viaggio. Vi state chiedendo perché l’Arma si occupasse di due esponenti di un’organizzazione non governativa intenzionate a partire per la Siria? Perché le due entrano in contatto con un pizzaiolo emiliano che i Cc tengono d’occhio ritenendolo un militante islamico. Così, per caso, intercettano Vanessa e Greta che si mettono d’accordo con il tipo e a lui raccontano nel seguente ordine due cose: di voler partire per la Siria per consegnare kit di pronto soccorso alla popolazione civile ma anche ai combattenti islamici, così che gli oppositori al regime di Assad possano curarsi in caso di ferite. Secondo, Greta in una conversazione spiega di godere di una specie di lasciapassare, in quanto sostenitrice della rivoluzione e protetta dall’Esercito Libero. La ragazza non dice al telefono di essere in contatto con gente dello stato islamico, anzi, assicura che quelli dell’Esercito Libero non impongono neppure il velo alle donne. Come è finita si sa, con un sequestro che le ha consegnate nelle mani di una banda vicina ad Al Qaeda, cioè l’organizzazione che poi l’avrebbe rapita. Nell’articolo si fa cenno anche a un universitario in collegamento con i ribelli ed anche ad un medico. Risultato: leggendo il Fatto si apprendono le seguenti informazioni. La prima, forse scontata ma fino a ieri non molto documentata, è che sul territorio italiano operano dei militanti che inviano denaro e aiuti ai combattenti islamici. Due: Vanessa e Greta non sono partite per la Siria per andare ad aiutare i bambini, per lo meno non solo: in Siria sono andate per consegnare kit di pronto soccorso ai miliziani, che se non è un aiuto a chi combatte poco ci manca. Tre: le giovani appoggiavano la rivoluzione e consegnando i medicinali volevano contribuire materialmente a sostenerla. Quattro: se sono finite nelle mani di tagliagole che le hanno rapite e segregate per più di cinque mesi, liberandole solo in cambio di un riscatto multimilionario, è perché qualcuno dei loro amici le ha tradite. Ne consegue che i carabinieri sapevano tutto, del viaggio e anche dei contatti con i militanti islamici, ma nessuno ha fatto niente, lasciando partire le ragazze e dunque facendole finire nelle mani dei rapitori. Non solo: qualcuno in Italia si dà addirittura da fare per agevolare la partenza e poi forse per agevolare anche il sequestro, così che la fiorente industria dei rapimenti ad opera dei militanti islamici possa prosperare e soprattutto finanziare la guerriglia e il terrorismo. Infine, come spiegava ieri il nostro Francesco Borgonovo, risulta evidente da questo rapporto che molte delle organizzazioni non governative in apparenza dicono di voler aiutare chi soffre, ma nella sostanza hanno rapporti poco trasparenti con chi combatte. Altro che ragazzine finite in un gioco più grande di loro. Greta e Vanessa pensavano di fare la rivoluzione e invece sono finite in una prigione dalle parti di Aleppo, perché la rivoluzione non è un pranzo di gala e se poi è islamica si va a pranzo con il boia. Risultato: la faccenda è tutt’altro che chiusa e il governo non può pensare di cavarsela con l’intervento reticente del ministro Gentiloni. Essendoci di mezzo la sicurezza nazionale (la gente che aiuta i combattenti l’abbiamo in casa) e soprattutto i soldi dei contribuenti vorremmo andare fino in fondo. E state sicuri che per quanto ci riguarda faremo di tutto per farlo.
Crolla l'alibi pacifista. Ecco tutte le prove delle amicizie jihadiste. Altro che pacifiste: i kit di pronto soccorso portati in Siria somigliano più a quelli militari. Ed erano destinati a gruppi di combattimento, scrive Gian Micalessin su “Il Giornale”. Il ministro Paolo Gentiloni, protagonista in Parlamento di una difesa a spada tratta di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, avrebbe fatto meglio a consultarsi prima con i carabinieri del Ros. Carabinieri che, magari, avrebbero potuto mostrare pure a lui le intercettazioni delle telefonate, pubblicate da Il Fatto Quotidiano , tra le due suffragette lombarde e alcuni fiancheggiatori dei gruppi jihadisti siriani. Telefonate assai scomode e imbarazzanti. Telefonate da cui emerge con chiarezza come le due ragazzine non ambissero al ruolo di crocerossine neutrali, ma piuttosto a quello di militanti schierate e convinte. Militanti tradite dai propri stessi «amichetti» e riportate a casa solo grazie al trasferimento nella cassaforte della formazione al qaidista di Jabat Al Nusra, o di qualche altro gruppetto jihadista, di una decina di milioni di euro sottratti ai cittadini italiani. Milioni con cui i fanatici siriani, o quelli europei passati per le loro fila, potrebbero ora organizzare qualche atto di terrorismo in Italia o altrove nel Vecchio Continente.
Che Greta e Vanessa progettassero di mettere in piedi qualcosa di diverso da una normale organizzazione umanitaria, Il Giornale lo aveva intuito subito dopo il sequestro. Esaminando su Facebook le gallerie fotografiche di «Horryaty» - l'associazione creata assieme al 46enne fabbro di Varese Roberto Andervill - quel che più saltava agli occhi era l'aspetto chiaramente «militare» dei «kit di pronto soccorso» distribuiti da Greta e Vanessa in Siria. I kit, contenuti in tascapane mimetici indossabili a tracolla, assomigliavano più a quelli in dotazione a militanti armati o guerriglieri che non a quelli utilizzati da infermieri o personale paramedico civile. Anche perché la prima attenzione di medici e infermieri indipendenti impegnati sui fronti di guerra non è quella di mimetizzarsi ma piuttosto di venir facilmente identificati come personaggi neutrali, non coinvolti con le parti in conflitto. Un concetto assolutamente estraneo a Greta Vanessa. Nelle telefonate scambiate prima di partire con Mohammed Yaser Tayeb - un 47enne siriano trasferitosi ad Anzola in provincia di Bologna ed identificato nelle intercettazioni del Ros come un militante islamista - Greta Ramelli spiega esplicitamente di voler «offrire supporto al Free Syrian Army», la sigla (Esercito Libero Siriano) che riunisce le formazioni jihadiste non legate al gruppo alaaidista di Jabat Al Nusra o allo Stato Islamico. L'acquisto dei kit di pronto soccorso mimetici da parte di Greta e Vanessa è documentato dalle ricevute pubblicate sul sito di Horryaty il 12 maggio di quest'anno, subito dopo la prima trasferta siriana delle due «cooperanti». La ricevuta, intestata a Vanessa Marzullo, certifica l'acquisto in Turchia di 45 kit al costo di 720 lire turche corrispondenti al cambio dell'epoca a circa 246 euro. La parte più interessante è però la spiegazione sull'utilizzo di quei kit. Nel rapporto pubblicato su Horryaty, Greta e Vanessa riferiscono con precisione dove hanno spedito o portato latte, alimenti per bambini, medicine e ogni altro genere di conforto non «sospetto». Quando devono spiegare dove sono finiti quei tascapane mimetici annotano solo l'iniziale «B.» facendo intendere di parlare di un avamposto militare dei gruppi armati il cui nome completo non è divulgabile per ragioni di sicurezza. Nelle telefonate con l'«amichetto» Tayeb registrate dai Ros, Greta Ramelli si spinge invece più in là. In quelle chiacchierate Greta spiega che i kit verranno distribuiti «a gruppi di combattimento composti solitamente da 14 persone». Spiegazione plausibile e circostanziata visto che in ambito militare una squadra combattente, dotata di uno specialista para-medico, conta per l'appunto dalle 12 alle 15 unità. L'elemento più inquietante, annotato dai Carabinieri del Ros a margine delle intercettazioni, sono però i contatti tra l'«amichetto» Tayeb e Maher Alhamdoosh, un militante siriano iscritto all'Università di Bologna e residente a Casalecchio del Reno. Con Maher Alhamdoosh s'erano coordinati - guarda un po' il caso e la sfortuna - anche Amedeo Ricucci, Elio Colavolpe, Andrea Vignali e Susan Dabous, i giornalisti italiani protagonisti nella primavera 2013 di un reportage in Siria conclusosi anche in quel caso con un bel sequestro. Un sequestro seguito da immancabile ed esoso riscatto pagato, anche allora, dai generosi contribuenti italiani. Quel silenzio su Giovanni Lo Porto rapito tre anni fa in Pakistan. Il cooperante palermitano sparito il 19 gennaio 2012 durante una missione per conto della ong tedesca Welt Hunger Hilfe, scrive Gianluca Mercuri su “Il Corriere della Sera”. Oggi 19 gennaio 2015 sono tre anni che Giovanni Lo Porto è sparito. Era arrivato da tre giorni in Pakistan per fare il suo lavoro - ridare alloggi alle popolazioni colpite dall’alluvione del 2010 - per conto della ong tedesca Welt Hunger Hilfe. Il 19 gennaio 2012 l’hanno rapito insieme al collega Bernd Muehlenbeck, che lo scorso ottobre è stato liberato dalle forze speciali di Berlino: si sa che non era più insieme a Giovanni da un anno e nulla di più. Intorno al cooperante palermitano, un silenzio che ha oscillato tra la prudenza d’obbligo e la reticenza pelosa. Il governo chiede il basso profilo, parenti e amici non ci stanno e lanciano appelli che raccolgono migliaia di adesioni. Un segnale è arrivato finalmente dal ministro degli Esteri, che rispondendo venerdì in Parlamento su Greta e Vanessa ha ricordato sia padre Dall’Oglio sia Giovanni, «due vicende alle quali lavoriamo con discrezione giorno per giorno». Lo Porto ha un profilo inattaccabile perfino dagli sciacalli del web: 40 anni, studi solidi tra Londra e Giappone, esperienze sul campo in Croazia, Haiti e anni prima nello stesso Pakistan, dove nel 2012 era tornato con un progetto finanziato dall’Ue. Insomma, tutto fuorché un avventuriero. Gentiloni va preso alla lettera, fino a prova contraria: l’Italia non lascia indietro nessuno dei suoi cittadini e per nessuno lesina mezzi. Tre anni dopo, è il minimo che si deve a Giovanni Lo Porto.
Greta e Vanessa tradite da chi volevano aiutare, scrive “Libero Quotidiano”. Greta e Vanessa sarebbero state rapite proprio da chi volevano aiutare. Le due ragazze infatti, riporta il Fatto, erano partite per la Siria non per aiutare i civili, le vittime della guerra, ma per sostenere i combattenti islamici anti-Assad con kit di salvataggio. E' il retroscena sul sequestro delle due volontarie che si legge in alcune informative del Ros dove vengono riportate alcune intercettazioni di aprile tra Greta Ramelli - che stava organizzando il suo viaggio in Medioriente - e un siriano di Aleppo di 47 anni, Mohammed Yaser Tayeb, pizzaiolo di Anzolo in Emilia, che gli investigatori considerano un militante islamista legato ad altri siriani impegnati in "attività di supporto a gruppi di combattenti operativi in Siria a fianco di milizie contraddistinte da ideologie jihadiste". In sostanza il progetto delle due cooperanti era "rivolto a offrire supporto al Free Syrian Army ora supportato dall'occidente in funzione anti Isis ma anch'esso composto da frange di combattenti islamisti alcuni dei quali vicini ad Al Qaeda", a sostenere "un lavoro in favore della rivoluzione", e non a dare un aiuto neutrale. Si legge nell'informativa una telefonata tra Greta e Mohammed Yasser Tayeb così sintetizzata: "Greta precisa che un primo corso si terrà in Siria con un operatore che illustrerà ai frequentatori (circa 150 persone tra civili e militari) i componenti del kit di primo soccorso e il loro utilizzo. la donna dice che ha concordato con il leader della zona di Astargi di consegnare loro i kit e cje a loro volta li distribuiranno ai gruppi di combattenti composti da 14 persone in modo che almeno uno degli appartenenti a questi gruppi fosse dotato del kit e avesse partecipato al corso". Tayeb secondo gli investigatori si attivò concretamente per aiutarle e le mise in contatto con un altro siriano residente a Budrio, Nabil Almreden, nato a Damasco, medico chirurgo in pensione. Tayeb gli chiede di inviare in siria una lettera di raccomandazione per Vanessa, "verosimilmente - annota il ros - un accredito presso una non meglio istituzione all'interno del territorio siriano".
Greta Ramelli e Vanessa Marzullo sono libere. Incassato con sollievo l'annuncio di Palazzo Chigi, con le due giovani cooperanti italiane rapite in Siria lo scorso 31 luglio e già di ritorno in Italia, il mondo politico e non solo già si divide, perché in ballo ci sono 12 milioni di dollari, scrive “Libero Quotidiano”. Quelli che secondo i ribelli siriani sarebbero stati pagati per la liberazione delle italiane, notizia che i nostri servizi hanno smentito seccamente. "Se veramente per liberare le due amiche dei siriani il governo avesse pagato un riscatto di 12 milioni, sarebbe uno schifo!", ha incalzato il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. E c'è chi come il capogruppo di Forza Italia alla Regione Emilia Romagna, Galeazzo Bignami, arriva a chiedere un "contrappasso" per le giovani volontarie temerarie: "Adesso le due tipe si mettano a lavorare gratis fino a quando non ripagheranno all'Italia quanto noi abbiamo dovuto versare, in nome della loro amicizia, ai ribelli siriani". "Sono state liberate immagino dietro pagamento di lauta ricompensa ai ribelli siriani - scrive Bignami su Facebook -. Ora che sono libere penso si possa dire con chiarezza che di chiaro in questa storia non c'è nulla. A partire dal fatto che questo sequestro pare proprio un gran favore fatto dalle loro amiche ai ribelli". Sui social network e sui siti, il commento di molti utenti è critico. E anche tra i lettori di Liberoquotidiano.it l'umore non è di sola soddisfazione per la liberazione delle due giovani. E' tutto il centrodestra ha porre la questione al governo. Secondo Mariastella Gelmini di Forza Italia, è "doveroso chiederci se un eventuale riscatto pagato a dei terroristi non sia una fonte di finanziamento per portare la morte in Europa e altrove. Non vorrei che l'Occidente finisse vittima di un corto circuito provocato dai terroristi che dispensano la morte e la vita a secondo delle convenienze". Se la Gelmini chiede spiegazioni al ministro degli Esteri Paolo Gentoloni ("Lui e il governo faranno bene a chiarire rapidamente la vicenda in tutti i suoi aspetti rilevanti"), sulla stessa linea si pone Massimo Corsaro di Fratelli d'Italia: Greta e Vanessa "hanno esposto loro stesse e l'intero Stato italiano a una situazione di rischio e difficoltà coscientemente con la loro volontaria presenza in un Paese in gravi condizioni e una pesante presenza del terrorismo, il ministro Boschi ci dica se è in grado di escludere che da qualunque fonte di finanziamento pubblico sia stato un centesimo per riportare le due ragazze a casa".
"Pagato riscatto da 12 milioni" Quante armi compreranno? Giallo sui soldi, un tweet dei rapitori fa scoppiare la polemica Dal 2004 a oggi abbiamo versato già 61 milioni ai terroristi, spiega Riccardo Pelliccetti su “Il Giornale”. Non possiamo che gioire per la liberazione di Vanessa Marzullo e di Greta Ramelli, le quali, dopo essere state quasi sei mesi nelle mani dei tagliagole jihadisti, potranno oggi finalmente riabbracciare le loro famiglie. Fatta questa doverosa premessa, non possiamo esimerci dall'esprimere un senso di vergogna e di disapprovazione per le modalità con cui il governo ha risolto la questione. È vero che siamo da anni abituati a pagare riscatti a talebani, pirati e terroristi per riportare a casa chi si avventura in zone altamente pericolose, ma averlo fatto consapevoli di foraggiare l'industria dei sequestri è perlomeno riprovevole. «Dodici milioni di dollari» proclamano i rapitori del Fronte Al Nusra, cioè circa dieci milioni di euro per riempire le casse del gruppo qaedista siriano, che fa dei sequestri una delle sue principali fonti di finanziamento per procurarsi armi e reclutare combattenti. C'è poco da scherzare o da sorridere. Secondo una stima fatta dal New York Times , Al Qaeda e i gruppi affiliati avrebbero incassato negli ultimi cinque anni almeno 125 milioni di dollari, versato in gran parte dai governi europei. I riscatti pagati dalla sola Italia dal 2004 a oggi a vari gruppi combattenti, ammontano a 61 milioni di euro. Un'industria fiorente, con un fatturato considerevole, alimentato proprio dai quei Paesi disposti e abituati a sborsare denaro per soddisfare le richieste dei terroristi. Quali clienti migliori per i piccoli eredi di Osama bin Laden. E l'Italia è un obiettivo «privilegiato». E pensare che Amedy Coulibaly, il terrorista islamico protagonista della strage nel supermercato ebraico di Parigi, aveva chiesto un mutuo di poco più di 30mila euro per finanziare la sua azione e quella dei fratelli Kouachi nella redazione di Charlie Hebdo. Fate una semplice calcolo di quanti Coulibaly si potrebbero mettere in pista con i dieci milioni di euro pagati dal nostro governo…. Inevitabili quindi, le proteste e le polemiche scaturite subito dopo l'annuncio del pagamento di un riscatto per liberare Vanessa e Greta. Lega, Fdi e Forza Italia hanno subito chiesto chiarimenti in Parlamento. «La liberazione delle due ragazze mi riempie di gioia - ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini -. Ma l'eventuale pagamento di un riscatto, che permetterebbe ai terroristi di uccidere ancora, sarebbe una vergogna per l'Italia». La Lega presenterà un'interrogazione al ministro degli Esteri proprio «per appurare se sia stato pagato un solo euro per le due signorine». «Un fatto assai grave - gli ha fatto eco il deputato leghista Molteni -. Il primo pensiero va alle famiglie. Va detto però che noi non abbiamo mai condiviso né giustificato le motivazioni della loro missione pseudomondialista». Chiede chiarezza anche Mariastella Gelmini, vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia. «Quando si riconquista la libertà e la vita, ogni persona ragionevole non può che esultare - ha affermato - Adesso, con altrettanta ragionevolezza, il governo e il ministro degli Esteri devono riferire sulle modalità di questa liberazione».
Ora li paghiamo pure per farci mettere il velo. Il governo deve riportarle a casa. Ma ci costerà milioni e così finanzieremo i terroristi. Vietiamo alle Ong di andare in quei posti, scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Tranne improbabili e comunque non auspicabili colpi di scena, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo rientreranno presto in Italia. Le trattative volgono alla fine e concernono esclusivamente, così come è stato sin dall'inizio del loro singolare sequestro lo scorso 31 luglio, l'entità della cifra da pagare. Le due ragazze erano simpatizzanti degli stessi gruppi islamici che le avrebbero sequestrate. In un cartello in arabo con cui si sono fatte immortalare nel corso di una manifestazione svoltasi in Italia si legge: «Agli eroi della Brigata dei Martiri - Grazie dell'ospitalità - Se Allah vorrà presto Idlab sarà liberata - E noi ci torneremo». La «Brigata dei Martiri», in arabo Liwa Shuadha, è un gruppo di terroristi islamici il cui capo, Jamal Maarouf, ha ammesso di collaborare con Al Qaida. Comunque sia, nel caso degli ostaggi italiani detenuti dai terroristi islamici i riscatti si misurano in milioni di euro, per la precisione dai 5 milioni in su per i sequestri in Siria e Irak, «solo» un milione o poco più per i sequestri finora verificatisi in Libia. Si stima che dal 2004 l'Italia abbia pagato complessivamente 61 milioni di euro per liberare Simona Pari e Simonetta Torretta, Maurizio Agliana, Umberto Cupertino e Salvatore Stefio, Giuliana Sgrena, Clementina Cantoni, Daniele Mastrogiacomo, Rossella Urru, Maria Sandra Mariani, Sergio Cicala e Philomene Kabouree, Federico Motka, Domenico Quirico. Per avere un riferimento dell'entità della cifra da corrispondere ai terroristi islamici che detengono le due ragazze italiane, teniamo presente che l'ultimo ostaggio italo-svizzero, Federico Motka, sequestrato anche lui in Siria il 12 marzo 2013, è stato rilasciato il 26 maggio scorso dietro il pagamento di un riscatto di 6 milioni di euro. Nel video postato su YouTube Greta e Vanessa sono sostanzialmente tranquille, recitano un copione impartito loro, i loro sguardi s'incrociano con quelli dei carcerieri dietro la telecamera per assicurarsi di essere state diligenti. È un video diretto a noi cittadini italiani per prepararci psicologicamente ad abbracciare le due ragazze in cambio del pagamento di un lauto riscatto. Sostanzialmente diverso era il video del 2005 che ci mostrò Giuliana Sgrena disperata e in lacrime supplicando le autorità di intervenire per il suo rilascio. Ebbene quel drammatico messaggio era diretto al governo, forse inizialmente restio a sborsare la cifra richiesta tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Saremo tutti contenti di riavere vive Greta e Vanessa. Però è ora di porre fine a queste tragiche farse il cui conto salatissimo paghiamo noi italiani. Il governo vieti alle nostre associazioni civili di operare nelle zone dove imperversano il terrorismo islamico o i conflitti armati. È ora di dire basta alle sedicenti associazioni «senza scopo di lucro» che lucrano con il denaro degli italiani, soldi pubblici e privati, per sostenere la causa dei nemici della nostra civiltà. E poi ci tocca pure pagare ingenti riscatti quando vengono sequestrati o si fanno sequestrare. Basta!
Finché "mandiamo" ostaggi siamo più vulnerabili. Che cosa aspetta il nostro ministero degli Esteri a vietare tassativamente a tutti i cittadini italiani di recarsi nei Paesi dove imperversa il terrorismo? Continua Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Che cosa aspetta il nostro ministero degli Esteri a vietare tassativamente a tutti i cittadini italiani di recarsi nei Paesi dove imperversa il terrorismo islamico, a cominciare da Irak, Siria, Libia, Nigeria e Somalia? Nel caso specifico dell'Italia dobbiamo farlo sia perché avendo dato prova di essere un «buon pagatore», finiamo per alimentare le risorse finanziarie con cui i terroristi islamici accrescono i loro efferati crimini, sia perché le recenti decapitazioni di quattro ostaggi occidentali (due americani e due britannici) evidenziano che i terroristi islamici sono del tutto indifferenti al fatto che fossero degli «amici», solidali con i musulmani. Si stima che dal 2004 l'Italia abbia pagato complessivamente 61 milioni di euro per liberare Simona Pari e Simonetta Torretta, Maurizio Agliana, Umberto Cupertino e Salvatore Stefio, Giuliana Sgrena, Clementina Cantoni, Daniele Mastrogiacomo, Rossella Urru, Maria Sandra Mariani, Sergio Cicala e Philomene Kabouree, Federico Motka, Domenico Quirico. Con noi i terroristi islamici vanno sul sicuro: hanno la certezza che il governo italiano pagherà. Esattamente l'opposto della politica adottata dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. La prova: mentre l'italo-svizzero Federico Motka, sequestrato il 12 marzo 2013 insieme al britannico David Haines, entrambi operatori umanitari, è stato rilasciato il 26 maggio scorso dietro il pagamento di un riscatto di 6 milioni di euro, Haines è stato decapitato dai terroristi dell'Isis (Stato Islamico dell'Irak e del Levante) il 14 settembre scorso. Diciamo che probabilmente i terroristi islamici considerano più vantaggioso sfruttare gli ostaggi italiani per finanziare la loro guerra criminale, rispetto al tornaconto politico che potrebbero avere dalla reazione alla loro decapitazione prendendo realisticamente atto che l'Italia conta poco sulla scena internazionale. Eppure avrebbero dovuto ringraziare Haines per l'aiuto dato ai musulmani. Era stato ribattezzato lo «scozzese matto» per la sua estrema disponibilità e dedizione a favore dei bisognosi. Aiutava tutti, soprattutto i musulmani. Anche l'altro britannico, Alan Henning, decapitato lo scorso 3 ottobre, semplice autista di taxi di Eccles, vicino Manchester, era amico dei musulmani. Sua moglie Barbara aveva invano implorato i terroristi dell'Isis: «Alan è un uomo pacifico, altruista, che ha lasciato la sua famiglia e il suo lavoro per portare un convoglio di aiuti in Siria, per aiutare chi ha bisogno, insieme con i suoi colleghi musulmani e i suoi amici». Anche il giornalista americano James Foley, decapitato dai terroristi dell'Isis lo scorso 19 agosto, era un simpatizzante dei gruppi islamici che combattono il regime di Assad in Siria. La madre Diane, appresa la barbara esecuzione del figlio, ha detto: «Ringraziamo Jim per tutta la gioia che ci ha dato. È stato straordinario, come figlio, fratello, giornalista e persona, ha dato la propria vita cercando di mostrare al mondo le sofferenze del popolo siriano». Ugualmente il secondo giornalista americano, Steven Sotloff, decapitato lo scorso 3 settembre, era un ebreo affascinato dal mondo islamico. La madre Shirley si era rivolta direttamente al Califfo Abu Bakr Al-Baghdadi: «Steven è un giornalista che è venuto in Medio Oriente per raccontare la sofferenza dei musulmani nelle mani dei tiranni. È un uomo degno di lode e ha sempre aiutato i più deboli. Chiedo alla tua autorità di risparmiare la sua vita e seguire l'esempio del Profeta Maometto che ha protetto i musulmani». La prossima vittima preannunciata dei terroristi islamici, l'americano Peter Edward Kassig, di soli 26 anni, è anche lui un cooperante che ha fondato l'organizzazione umanitaria Special emergency response and assistance (Sera), addirittura convertito all'islam. Ebbene, nell'attesa che si ottenga la liberazione di Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, cooperanti simpatizzanti dei terroristi islamici rapite lo scorso 31 luglio, e padre Paolo Dall'Oglio, anche lui filo-islamico, rapito il 29 luglio 2013, il governo vieti tassativamente i viaggi degli italiani in questi Paesi sia per porre fine alla vergogna dei riscatti pagati ai terroristi islamici sia per prevenire l'assassinio dei nostri connazionali.
Greta e Vanessa libere: il dilemma davanti alla loro generosità. Pagare i riscatti per i prigionieri dei jihadisti è sbagliato e ingiusto. Eppure davanti alle due ragazze ci dobbiamo interrogare sull'indicibile, scrive Marco Ventura su “Panorama”. Questo articolo è stato scritto il 3 gennaio quando Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due amiche rapite in Siria, erano apparse in tv vestite di nero con il capo coperto. Lo riproponiamo oggi che le due giovani sono state liberate. Una riflessione su giudizi, generosità e difficoltà di decidere se e quando un riscatto va pagato. "Noi siamo Greta Ramelli e Vanessa Marzullo". Greta e Vanessa. Due amiche, unite dal desiderio di portare aiuto ai bambini in Siria. Ingenue, avventate, forse. Non giudichiamole. Ma noi non abbiamo il diritto di giudicarle. Mi urtano i (troppi) commenti che le dipingono in un linguaggio sprezzante come invasate manipolate e sprovvedute la cui prigionia crea un problema e pone un dilemma a chi deve gestirla (pagare o non pagare il riscatto? finanziare o no i rapitori? favorire o no con la trattativa altri sequestri?). Il capodanno e compleanno di Vanessa è stato terribile. Greta e Vanessa sono due giovani donne maggiorenni (il 31 dicembre Vanessa ha compiuto 22 anni, Greta ne ha uno di meno) che non fanno parte della schiera di chi non si cura degli altri, di chi bada solo a se stesso, di chi concepisce la propria esistenza fra routine e saltuari bagordi di fine settimana o fine anno. Il capodanno e compleanno di Vanessa è stato terribile. Ma è quella la strada che Vanessa, e con lei Greta, ha scelto. Voglio pensare che Vanessa e Greta fossero consapevoli di quel che facevano. Ma se anche non lo fossero state, credo nella verità dei loro intenti. Generosi. E coraggiosi. L'incoscienza che fa parte della vita. E se pure condivido il sospetto di molti, che non fossero del tutto lucide quando hanno valutato i rischi, credo che difficilmente si possano prevedere tutte le conseguenze di una decisione, nel momento della scelta. E, anzi, che una certa incoscienza faccia parte della vita, se la si vuole vivere. C’è chi ha parlato di plagio, insinuando una qualche adesione delle due giovani donne a un messaggio ideologico di chissà quale banda di predoni o gruppo islamico estremista che le tiene in ostaggio. Da quel video cosa si vede? Chi le guarda così, da lontano, da inesperto, le vede diversamente da come esemplarmente le ha viste (e ne ha scritto su “La Stampa”). Domenico Quirico, costretto pure lui da ostaggio, da “schiavo”, a registrare un messaggio. Dice Quirico che quel giorno lui era felice, perché il video era un modo per avvicinarsi alla famiglia e alla liberazione. Ma il commento si conclude con la distanza tra quelle immagini di Greta e Vanessa e la verità dell’avvicinamento, solo in quanto di nuovo visibili, alla loro vita di prima, alla famiglia. A se stesse. Ma da quel video si può solo dedurne il loro essere vive in quel momento. Gli anglosassoni non pagano riscatti. È una regola chiara. Un dovere forte. Sì, colpisce vedere la fotografia di Greta e Vanessa sorridenti, una accanto all’altra come lo sono nelle foto da amiche del cuore nei giorni di festa (e magari di protesta) e il fotogramma di quei 23 lunghissimi secondi in cui si ritrovano ancora vicine ma senza sorriso, vestite di nero col capo coperto, Greta che recita il messaggio rigorosamente a occhi bassi, Vanessa che mostra un foglietto ambiguo con una data non verificabile (il 17 dicembre) e per ben due volte alza gli occhi, prima subito riabbassandoli consapevole d’aver infranto una regola o commesso un’imprudenza, poi guardando di lato, quasi astraendosi dal messaggio, dal luogo e dall’ora, e assumendo un’espressione seria (ma da bambina, così simile a certe espressioni vaghe dei nostri figli, delle nostre figlie). Un dilemma terribile. Gli anglosassoni non pagano riscatti. È una regola chiara. Un dovere forte. Perché il riscatto finanzia il terrore. Perché pagando si incentiva il business dei rapimenti. Perché chi si vede pagata la liberazione ha la vita salva e gli altri, di altre nazionalità, no e questo non è giusto. E perché chi è adulto e affronta il pericolo deve anche esser pronto a subirne le conseguenze (il problema è di chi viene sequestrato, non del governo, soprattutto se non si ha indosso l’uniforme e non si svolge un ruolo istituzionale, da militare, ambasciatore, 007). E tuttavia, ci interroga la generosità di quelle giovani donne andate in Siria, credendoci. E mai come in questo caso si pone un dilemma terribile per chi è chiamato a fare di tutto per liberarle. C’è, qui, un fossato incolmabile tra il detto e l’indicibile.
5 motivi per cui non bisogna pagare riscatti. È bellissimo che Greta e Vanessa siano libere. Ma versare denaro ai sequestratori è sbagliato: condanna a morte altri ostaggi e indebolisce il paese, scrive Marco Ventura su “Panorama”. In Italia i rapimenti sono finiti grazie al blocco dei beni. Decisione terribile e a prima vista disumana. Ma giusta. Ma nel caso di Greta e Vanessa che sono tornate libere (ed è bellissimo che questo sia successo, che i genitori possano riabbracciarle, che siano vive), ci sono mille altre ragioni perché non accada mai più che venga pagato un riscatto. Ecco perché.
1 - Dare un tesoretto ai sequestratori. Che siano stati pagati 12 milioni, di meno, o di più, il punto è che le bande di sequestratori, che sono anche manipoli di guerriglieri nei teatri dell’avanzata islamista in Iraq e Siria, hanno oggi un tesoretto da investire in armi o in nuovi rapimenti. Esattamente come in Italia (in Sardegna, in Calabria) qualche decennio fa. Ricordate l’anonima sequestri?
2 - La condanna a morte degli altri ostaggi. Il pagamento del riscatto per gli ostaggi italiani condanna a morte gli ostaggi degli altri Paesi. Chi rifiuta categoricamente di trattare con i sequestratori (soprattutto se terroristi) vede sistematicamente i propri ostaggi uccisi, sgozzati, decapitati, mentre magari i loro compagni di “cella” vengono rilasciati a suon di quattrini. È giusto?
3 - Il presente costruisce il futuro. Il presente costruisce il futuro. Chi paga oggi, pagherà domani. E allora perché non continuare a rapire tutti gli sprovveduti/e italiani/e che mossi da sentimenti di generosità verso i sofferenti delle zone più sventurate del pianeta si tuffano a sprezzo del pericolo in tutte le avventure umanitarie? (Ovvio che qui si pone un serio problema di equilibrio tra volontariato e sicurezza: se lo pongono l’ONU e i grandi organismi internazionali, a maggior ragione dovrebbero porselo i singoli e le piccole associazioni fai-da-te).
4 - Chiudere la fabbrica degli ostaggi. L’ostaggio è sempre lo strumento di un ricatto. Un’arma. Lo Stato deve quindi porsi a sua volta la questione di come “chiudere” la fabbrica degli ostaggi. Può farlo sposando la tesi (che personalmente condivido) di Stati Uniti e Gran Bretagna, di dire in anticipo (e poi agire di conseguenza e coerentemente) che nessun riscatto sarà mai pagato. O lo si può fare cercando il più possibile di impedire che italiani si trovino nelle zone a rischio dove la probabilità di essere rapiti, date certe condizioni, è troppo alta.
5 - Sottomettersi o vincere. Perché uno Stato paga riscatti? Per mancanza di senso dello Stato dei suoi governanti. L’uccisione di un ostaggio, per un’opinione pubblica come quella italiana, è una sconfitta della quale ha colpa il governo, mentre la sua liberazione è una vittoria. Sbagliato. Qui gli errori sono due. Di chi ci governa, perché dimostra non saper essere leader. E di noi che non abbiamo la maturità nazionale dei Paesi anglosassoni che affrontano le guerre con lo spirito di chi vuol vincerle e non di chi si sottomette.
In Italia i rapimenti sono finiti grazie al blocco dei beni. Decisione terribile e a prima vista disumana. Ma giusta. Ma nel caso di Greta e Vanessa che sono tornate libere (ed è bellissimo che questo sia successo, che i genitori possano riabbracciarle, che siano vive), ci sono mille altre ragioni perché non accada mai più che venga pagato un riscatto. Ecco perché.
Vanno allo sbaraglio e noi paghiamo. L'unico consiglio a chi sogna un soggiorno in Medioriente per aiutarne i popoli è questo: lasciate perdere, scrive Vittorio Feltri su “Il Giornale”. La vedova di Enzo Baldoni, ucciso dieci anni orsono in Irak da assassini islamici (la cui umanità è nota), in un'intervista rilasciata alcuni giorni fa alla Repubblica , afferma di non essersi dimenticata di me e di Renato Farina che, all'epoca dei fatti, fummo molto critici con il povero pubblicitario-pubblicista perché aveva deciso di trascorrere le ferie nel Paese di Saddam Hussein (con l'ambizione di redigere un reportage) anziché - poniamo - a Rimini, dove non avrebbe rischiato nulla. Comprendo lo stato d'animo della signora e il suo rancore nei nostri confronti, visto come si è tragicamente conclusa l'avventura in Medioriente di suo marito. Ovvio, davanti alla morte, anche se avvenuta in circostanze sulle quali si può discutere, è giusto che prevalgano le ragioni del cuore su quelle del cervello. Ora il problema incarnato da Baldoni si ripropone negli stessi termini: mi riferisco al rapimento avvenuto in Siria di due ragazze italiane (alcune settimane fa) che si sono recate in quelle terre infuocate nei panni di cooperatrici. La storia di queste fanciulle è analoga a quella delle famose due Simone, loro coetanee, che, in occasione della seconda guerra del Golfo, erano andate a Bagdad per aiutare non si sa bene chi, e furono sequestrate dalle solite teste calde imbevute di Corano. La loro vicenda terminò felicemente. Nel senso che i nostri servizi segreti si mossero abilmente, trattarono sul riscatto, lo pagarono con i soldi dello Stato italiano, e liberarono entrambe le scriteriate turiste. Meglio così. Poi fu la volta di Giuliana Sgrena, giornalista del Manifesto, anch'essa finita ostaggio degli islamici e scarcerata grazie al pagamento di una somma rilevante versata dall'Italia ai banditi. Ma sorvoliamo per non farla tanto lunga. Ciò che ci preme osservare è l'inutilità dell'esperienza. C'è gente che, nonostante i precedenti, continua incoscientemente a sfidare il destino - notoriamente cinico e baro - e a mettere a repentaglio la pelle correndo in soccorso di chi non desidera essere soccorso, in Paesi in cui vige la legge del taglione, che non è neppure una legge, bensì una minaccia verso chiunque non adori Allah. Infatti, Greta Ramelli (di Varese) e Vanessa Marzullo (Brembate, lo stesso Comune di Yara, la tredicenne morta ammazzata 4 anni addietro), senza riflettere un secondo, quando hanno avuto l'opportunità di trasferirsi qualche giorno in Siria, sono partite piene di entusiasmo, appoggiate da un'organizzazione umanitaria, convinte di fare del bene. A chi? Ai siriani martoriati dalla guerra, dalle violenze che subiscono quotidianamente vittime di ingiustizie atroci. Ottime intenzioni, non abbiamo dubbi. Ma possibile che non ci sia nessuno in grado di far presente a chi si appresta a raggiungere il Vicino Oriente che non è il caso di affrontare certi viaggi densi di insidie? Possibile non informare i volontari che, persuasi di contribuire a salvare il mondo, in realtà vanno incontro a situazioni da cui è improbabile uscire vivi? Questo è il punto. Non condanniamo assolutamente coloro che, ignari delle trappole disseminate nei territori dove si combatte, vi si recano per il nobile scopo di aiutare persone in drammatiche difficoltà. Ma consentiteci di deplorare almeno quei pazzi che incitano tanti giovani a emigrare, sia pure temporaneamente, in luoghi nei quali uccidere una mosca o un cristiano è lo stesso. È sbagliato pensare che un atto d'amore sia sufficiente a rabbonire chi ti odia da secoli perché rappresenti, fisicamente, il nemico da eliminare. Occorre rieducare i diseducatori che in modo subdolo trascinano i giovani, e perfino vari adulti, a compiere imprudenze che non raramente portano all'irreparabile: sequestri ed esecuzioni capitali con metodi tribali. È un'operazione complicata e forse velleitaria. Ma non c'è altro da fare. Descrivere come eroi i Baldoni, le Simone, le Sgrene e anche le due ragazze tuttora in mano ai folli islamisti, cioè Greta e Vanessa, significa distorcere la realtà e la logica. Volare laggiù nel deserto, a qualsiasi titolo, equivale a percorrere l'autostrada contromano. Non si può pretendere di farla franca. L'evento più probabile è crepare ammazzati. Baldoni, pace all'anima sua, abbacinato da non si sa chi e che cosa, andò incontro alla propria fine senza valutare che in taluni casi la generosità sconfina nella stoltezza; le due Simone si salvarono perché al tempo avevamo ancora dei servizi segreti efficienti; idem la Sgrena; mentre Greta e Vanessa sono state abbandonate a se stesse. Auguriamo loro di tornare, ma non contino sui nostri 007, ormai disarmati e privi di forza contrattuale. L'unico consiglio a chi sogna un soggiorno in Medioriente per aiutarne i popoli è questo: lasciate perdere. Le vacanze più intelligenti hanno quale meta Viserbella o Milano Marittima, almeno finché non saranno state invase dai cammellieri.
Scandalizzarsi è un'ipocrisia Quante vite salvate da un patto. Dai sequestri De Martino e Cirillo ai rapimenti di Mastrogiacomo e Sgrena: i negoziati con camorra, Br e terroristi islamici hanno consentito di evitare spargimenti di sangue, scrive “Il Giornale”. Esiste uno Stato immaginario che non si piega e non scende a patti, e anche nei momenti più difficili preferisce affrontare le conseguenze più tragiche anziché trattare col nemico. Ed esiste poi uno Stato reale che ufficialmente fa la faccia feroce ma sotto traccia incontra, dialoga, si aggiusta. Che promette, e a volte mantiene. Che riceve promesse, e quasi sempre qualcosa incassa. Se davvero - perché di questo in fondo si tratta - qualcuno ha trattato con Cosa Nostra la consegna di Totò Riina, beh, non sarà stata né la prima né l'ultima volta che il do ut des ha fatto la sua silenziosa comparsa nella guerra tra Stato e antistato. Il catalogo è lungo e ricco, e appartiene in buona parte alle cronache del terrorismo: quello domestico, all'epoca della furia omicida delle Brigate rosse e dei loro epigoni, quanto quello islamico in giro per il mondo. Ma non è che le vicende del crimine organizzato non portino anch'esse traccia di accordi sottobanco: nella sentenza d'appello ai calabresi che nel 1997 rapirono a Milano Alessandra Sgarella, una piccola nota a piè di pagina dà atto che a un boss in carcere vennero promessi benefici penitenziari in cambio delle sue pressioni per la liberazione dell'ostaggio. Si poteva fare, non si poteva fare? Si fece e basta, e la Sgarella tornò a casa dopo quasi un anno di terribile prigionia. Non fu, giurano gli addetti ai lavori, l'unica volta che un sequestro dell'Anonima si risolse così. D'altronde esiste un precedente storico anche se poco esplorato, il memorabile sequestro di Guido De Martino, figlio del segretario del Psi, rapito nel 1977 dalla malavita napoletana e rilasciato dopo una colletta tra banche, partiti, servizi. Nei rapporti con il terrorismo di ogni risma ed etnia, la trattativa sotterranea è invece - almeno in Italia - una prassi e quasi un'arte, spesso esercitata quasi alla luce del sole. A partire dal caso più noto e peggio concluso, quando intorno al sequestro del presidente democristiano Aldo Moro sorse addirittura un «partito della trattativa» che agiva per pubblici proclami senza che nessuno si indignasse o aprisse inchieste; e persino gli emissari della trattativa nel fronte brigatista avevano nomi e cognomi di pubblico dominio, e pubblicamene discusse se erano le possibili contropartite alla liberazione di Moro. Poi finì come finì, ma nessuno finì sotto inchiesta per avere cercato di salvare Moro. Nessuno venne incriminato per avere trattato sottobanco con frange di brigatisti la consegna di James Lee Dozier, il generale americano sequestrato subito dopo Moro. Si indagò, invece, ma senza quagliare granché, sulla più spudorata delle trattative, quella che portò alla liberazione dell'assessore napoletano Ciro Cirillo, sequestrato anche lui dalle Brigate Rosse, e tornato a casa dopo che per salvarlo si era mosso una specie di circo fatto di agenti segreti, politici, imprenditori, tutti a baciare la pantofola di Raffaele Cutolo, il capo della Nuova camorra organizzata che nel supercarcere dove era richiuso riceveva visite una dopo l'altra. Il pasticcio era tale che qualche anno fa Cirillo, ormai ottuagenario, disse di non voler raccontare nulla fino alla morte. «È tutto scritto in un memoriale da un notaio». Ma dove la decisione di scendere a patti è stata una costante, tanto notoria quanto inconfessata, è quando l'Italia si è trovata a fare i conti con il terrorismo islamico: una prassi così costante da suscitare l'indignazione degli alleati e della loro intelligence, ma resa inevitabile dalla commozione con cui vengono seguiti i casi dei nostri connazionali rapiti qua e là per il mondo. Per i poveri Quattrocchi e Baldoni, rapiti e ammazzati in Irak, per allacciare una trattativa mancò il tempo, non la volontà. Da allora in poi, è quasi incalcolabile il fiume di fondi riservati dei servizi segreti finiti nelle tasche della jihad pur di riportare in patria i malcapitati. Si racconta che la telefonata a casa che i rapitori concessero a Domenico Quirico, l'inviato della Stampa sequestrato in Siria, sia costata all'erario una robusta bolletta. E cifre ben maggiori sono servite per ottenere il rilascio delle due Simone, la Pari e la Torretta, sequestrate nel 2004 a Baghdad, o dell'inviato speciale di Repubblica Daniele Mastrogiacomo. Qualche dettaglio emerse a margine della vicenda finita tragicamente della giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena: il 4 marzo 2005 un funzionario del Sismi consegnò a un emissario dei rapitori il riscatto, in Kuwait o negli Emirati Arabi. L'emissario diede il via libera, a Baghdad la giornalista venne liberata e consegnata a un'altra squadra del Sismi. Ma sulla strada per l'aeroporto l'auto dei nostri 007 fu attaccata per errore da un posto di blocco degli americani, nell'uragano di colpi il capodivisione Andrea Calipari perse la vita, il suo collega Andrea Carpani venne centrato al petto, anche l'autista venne sfiorato, e solo la Sgrena uscì miracolosamente incolume. Nonostante lo choc e le polemiche, neanche i retroscena di quella trattativa sono mai stati ufficialmente resi noti. La sostanza è che si tratta, da sempre. E forse anche nel 1992, quando magistrati e poliziotti venivano fatti saltare in aria col tritolo insieme a interi tratti di autostrada, ci fu chi decise di tastare gli umori dell'altra parte, e non arretrò inorridito quando la testa di Riina venne offerta in cambio di questa o quella concessione.
L'ideologia contro Quattrocchi: "I killer non erano terroristi". La Corte d'Assise riconsidera le motivazioni dell'esecuzione del contractor in Irak. Come se le uniche vite preziose fossero quelle della Sgrena o delle due Simone, scrive Gian Micalessin su “Il Giornale”. Incredibile e raccapricciante. Non vi sono altri aggettivi per definire le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Roma che manda assolti due degli assassini di Fabrizio Quattrocchi, la guardia privata rapita in Irak assieme a Salvatore Stefio, Maurizio Agliana e Umberto Cupertino che il 14 aprile 2004 davanti agli aguzzini pronti a freddarlo con un colpo alla nuca urlò «Vi faccio vedere come muore un italiano». Quell'atto di coraggio e di dignità gli valsero una medaglia d'oro al valor civile che il presidente della Repubblica Azeglio Ciampi così motivò: «Vittima di un brutale atto terroristico rivolto contro l'Italia, con eccezionale coraggio ed esemplare amor di Patria, affrontava la barbara esecuzione, tenendo alto il prestigio e l'onore del suo Paese». Ma gli atti di un Presidente della Repubblica non valgono nulla. Motivando la sentenza che lascia impuniti Ahmed Hillal Qubeidi e Hamid Hillal Qubeidi, due responsabili del rapimento catturati durante la liberazione di Stefio, Agliana e Cupertino, i giudici spiegano che l'identità dei due non è comprovata, il loro collegamento con gruppi eversivi non è evidente e - dulcis in fundo - l'esecuzione non è un atto di terrorismo. Insomma i due imputati, catturati mentre facevano la guardia a Stefio, Agliana e Cupertino, passavano di lì per caso e non sono stati identificati con precisione neppure durante gli anni trascorsi nella galera irachena di Abu Ghraib. I nostri giudici evidentemente la sanno più lunga degli inquirenti americani e iracheni che interrogarono i due imputati vagliandone generalità e responsabilità. Verrebbe da chiedersi come, ma porsi domande troppo complesse non serve. Dietro questa sentenza e le sue motivazioni non c'è il codice penale, ma l'ideologia. La stessa ideologia formulata dal giudice Clementina Forleo che nel gennaio 2005 assolse dall'accusa di terrorismo il marocchino Mohammed Daki e i tunisini Alì Toumi e Maher Bouyahia pronti a trasformarsi in kamikaze islamici in Irak. Nella motivazione del caso Quattrocchi quell'ideologia raggiunge la perfezione. Pur di mandare liberi due assassini i giudici arrivano a mettere in dubbio che l'uccisione di un eroe italiano decorato con la medaglia d'oro sia un atto terroristico. E per convincerci scrivono che «non è chiaro se quell'azione potesse avere un'efficacia così destabilizzante da poter disarticolare la stessa struttura essenziale dello stato democratico». Una motivazione sufficiente a far assolvere anche gli assassini di Moro visto che neppure quell'atto bastò a disarticolare lo stato italiano. Ma i magistrati superano se stessi quando tentano di convincerci che il collegamento dei due sospettati con i gruppi eversivi non è provato. L'assassinio di Quattrocchi viene deciso, come tutti sanno, per far capire al nostro governo che solo accettando il ritiro dall'Irak verrà garantita la salvezza degli altri rapiti. Ma evidentemente ricattare l'Italia uccidendo un suo cittadino e tenendone prigionieri altri tre per 58 giorni non è un atto sufficientemente eversivo. E a far giudicare eversori e terroristi gli assassini di Quattrocchi non basta neanche l'ammissione di uno degli aguzzini che racconta all'ostaggio Cupertino di aver partecipato all'attentato di Nassirya costato la vita a 19 italiani. Quelle per i magistrati sono semplici vanterie. Ma non stupiamoci troppo. Il problema anche qui non è la giustizia, bensì l'ideologia. In Italia, persino nelle aule giudiziarie, qualcuno continua a ritenere che le uniche vite preziose siano quelle di chi la pensa come lui. Soprattutto se quelli come lui sono «umanitari» di sinistra come le due Simone o giornaliste «democratiche» come Giuliana Sgrena. Le vite di chi non la pensa allo stesso modo invece valgono poco o nulla. Per questo uccidere l'eroe Fabrizio Quattrocchi non è reato.
Ostaggi «buoni» e «cattivi». Scontro tra destra e sinistra, scrive Paolo Conti su “Il Corriere della Sera” Possono esistere «buoni» e «cattivi», giudicati a seconda della necessità polemica da destra e da sinistra, persino tra gli italiani rapiti dai terroristi iracheni? Ora nelle loro mani, e sul video di Al Jazira, c'è Enzo Baldoni. Ma proviamo a fare un passo indietro, a tornare ad aprile, quando gli ostaggi si chiamavano Salvatore Stefio, Maurizio Agliana e Umberto Cupertino, quando Fabrizio Quattrocchi venne trucidato dalle Falangi di Maometto. Sui giornali della sinistra campeggiarono per intere settimane le stesse parole chiave: «mercenari», «vigilantes». Il manifesto parlò di «privatizzazioni da combattimento», l'Unità di «Mestiere della guerra». Scoppiò una durissima polemica quando Vauro, il giorno dopo l'assassinio di Fabrizio Quattrocchi, nella sua vignetta del giorno sul manifesto mostrò un dollaro penzolante da un pennone e sotto il titolo «morire per denaro» commentò con la battuta: «Banconote a mezz'asta». Liberazione insistette sulla tesi della collaborazione dei quattro italiani con i servizi segreti e irrise Piero Fassino che parlò di uccisione di un «civile inerme» («Viene da dire: ma di che cosa stanno parlando?»). Quando il centrodestra definì «eroico» il famoso ultimo momento di vita di Quattrocchi («ti faccio vedere come muore un italiano») ancora il manifesto titolò immediatamente «Eroi di scorta». Ora il rito in parte si ripete, specularmente opposto. La provocazione ieri è venuta da Libero: grande foto del pacifista Baldoni sotto il titolo «Vacanze intelligenti» e giù, nel sommario: «Aveva detto: "cerco ferie col brivido". E' stato accontentato». In perfetta linea con la titolazione il commento di Renato Farina. Si chiede come mai sia così rilassato nel video di Al Jazira: «Perché dovrebbero fargli del male? E' un giocherellone della rivoluzione... Dopo le ferie intelligenti, cominciamo a fare quelle sconvolgenti». Poi, più in là: «Signori di Al Qaeda, proprio dal vostro punto di vista, non vale la pena di ammazzarlo. Restituitecelo, farà in futuro altri danni all'Occidente come testimonial della crudeltà capitalistica». Quanto a Il giornale, è stato l'unico quotidiano a relegare la notizia in centro pagina, ben al di sotto di due inchieste. Commenta Franco Debenedetti, senatore ds: «Credo sia giusto cercare una logica nelle azioni di qualcuno, comprendere il senso delle scelte per esempio nel caso di un rapimento perché tutto questo può contribuire alla liberazione di un ostaggio. Ma i commenti così diversi propongono davvero una gran bella gara...» Qual è il suo giudizio su questo contrasto? «Ricordo che ai tempi dei tre rapiti, questo insistere sul loro ruolo di "mercenari" suggeriva quasi l'idea che si fossero andati a cercare una simile sorte. Un modo per esorcizzare il problema, di allontanarlo, come se il lavoro di vigilante non fosse onorevole come tanti altri, e anzi spesso indispensabile nella complessa ricostruzione dell' Iraq. E magari fosse meno nobile di un'occupazione intellettuale come quella del reporter». E quanto invece alla reazione di Libero? «Sinceramente mi sembra solo e soltanto agghiacciante. Comunque sia, insisto, mi pare davvero una bella gara...». Concorda Marcello Veneziani, intellettuale apprezzato dalla destra: «La figura di Quattrocchi combaciava con una mentalità che aveva caro il senso dell'onore e l'amor patrio. Invece Baldoni coltiva, lo abbiamo letto, valori dichiaratamente pacifisti. Motivazioni diverse, lontane, che hanno spinto le "tifoserie" a schierarsi da una parte e dall'altra, visto che in questa faccenda sembra contare ancora una labile appartenenza ideologica». E allora, Veneziani? «Allora sono state eccessive entrambe le reazioni. Voglio dire che sulla motivazione che spinge qualcuno a una scelta ci possono essere divisioni, diversità di vedute. Ma sulla vicenda in sé no: sono di rigore in ogni caso attenzione, rispetto, solidarietà...».
De Luca, quando la rivolta è un "marchio" da vendere. Dopo decenni di marxismo, sopravvive l'idea che uno scrittore debba essere militante. Ma di tanto impegno restano solo narcisismo e nostalgia attira-lettori, scrive Massimiliano Parente su “Il Giornale”. L'hashtag è #iostoconerri, e ci mancherebbe non stessi con lui, processato per essersi pronunciato contro la TAV e aver detto che secondo lui sabotarla è giusto. Uno potrà dire quello che vuole? Si può dire che gli Stati Uniti si sono abbattuti le Torri Gemelle da soli, si può essere perfino pro-Isis, Giulietto Chiesa è ancora stalinista, e portiamo in tribunale Erri De Luca? E poi sfiliamo con i cartelli Je suis Charlie? Ecco, Je suis Errì. Oddio, che effetto. E però che bello. È uno di quegli scrittori che invidio, e in Italia ce ne sono tantissimi. Non hanno bisogno di scrivere grandi opere, neppure opere medie. Errì poi scrive dei librini così tascabili che in tasca ce ne vanno venti, una pacchia. L'ultimo di Errì si intitola La parola contraria . Quattro euro e ve lo portate via, generosa la Feltrinelli. Piccolo ma denso: dentro c'è tutta la coscienza contraria di Errì. Per esempio Errì spiega che «può darsi che nella mia educazione emotiva napoletana ci fosse la predisposizione a una resistenza contro le autorità». Una cosa tipo: «Io i tass' nun le pag, ma vattenne và, accà niusciun'è fess». Oppure: «Chiust'o tren' che sa vò muov' veloce sa da fermà, compà». Je suis Errì, e un'altra cosa assurda è l'accusa di istigazione: ma vi pare che Errì possa aver istigato qualcuno a fare qualcosa? Casomai è stato istigato lui a diventare Errì. Come sono istigati tutti gli scrittori italiani, convinti da centocinquant'anni di marxismo intellettuale che si debba essere impegnati civilmente per essere intelligenti. Anzi peggio ancora: intellettuali. Non per altro perfino Aldo Busi, che non è di Napoli ma di Montichiari, su Alias denuncia il progresso tecnologico e rimpiange i casellanti. E Antonio Moresco, che non è di Napoli ma di Mantova, ha organizzato una nuova marcia della nota serie Cammina Cammina, la Repubblica Nomade, per essere tutti migranti. Che cagate. No, pardon, Je suis Errì. Che figate. Je suis Errì, e quanto erano belli i tempi di Lotta Continua. Dove c'erano tutti i migliori intellettuali, scrive Errì. Anche Pasolinì. E lo stesso Errì. Io non sono mai stato di Lotta Continua, neppure a favore di Lotta Continua, ma poi per caso ho scoperto che il mio amore Sasha Grey si è dichiarata simpatizzante di Lotta Continua. E quindi perfetto, je suis Errì, non voglio più essere Parente, che schifo. «Voglio essere lo scrittore incontrato per caso, che ha mischiato le sue pagine ai nascenti sentimenti di giustizia che formano il carattere di un giovane cittadino». Uno di quegli scrittori «che fa alzare d'improvviso e lasciare il libro perché è montato il sangue in faccia, pizzicano gli occhi e non si può continuare a leggere». E io che pensavo fosse l'allergia e stavo cercando un antistaminico. Invece è perché je suis Errì, il libro sta cominciando a fare effetto, mi sto trasformando in un giovane cittadino con dei sentimenti di giustizia e un'educazione emotiva napoletana con il sangue montato in faccia. A questo serve la letteratura. Per cui, siccome je suis Errì, ho buttato il libro e mi sono messo a protestare contro uno che ha parcheggiato sulle strisce pedonali, per sentimento di giustizia. Però poi mi sono accorto che il proprietario della macchina era negro, pardon di colore, e siccome je suis Errì mi sono scusato, sarà arrivato sicuramente da Lampedusa, e Errì dice che «dare cibo, acqua, vestiti, alloggio, premura per gli ammalati, i prigionieri, i morti: le sette opere di misericordia sono state compiute da loro, che vivono sul mare e usano leggi opposte. E non sono LampeduSanti, ma semplicemente LampeduSani. La rima nord e sud, Val di Susa e Lampedusa, riscatta oggi il titolo di cittadini da prepotenze che li vogliono sudditi». Ma come gli vengono, a Errì, questi giochi di parole? Val di Susa/Lampedusa, un genio. E poi ho pensato: chissà cosa succederebbe a scaricare qualche migliaio di profughi al mese direttamente da Lampedusa in Val di Susa, chissà dove lo manderebbero Errì, i valsusini. Ma poi ho pensato che era una malignità, i valsusini accoglierebbero tutti con rose e fiori e canti popolari e cantantando je suis Errì. Perché, questo il senso profondo delle parole del libro di Errì, «a ogni lettore spetta la sorpresa di fronte alla mescola improvvisa tra i suoi giorni e le pagine di un libro».
E quando avrete finito di leggere il libro avrete una bellissima mescola, vi assicuro. E anche voi potrete dire: Je suis Errì.
IL BUSINESS DEGLI ABITI USATI.
La Camorra nel business degli abiti usati. Così i boss lucravano sui cassonetti gialli. Un'organizzazione legata alla malavita campana ha fatto milioni gestendo il giro d'affari dei vestiti lasciati per beneficenza dai cittadini nei contenitori ai lati delle strade. Un giro gestito da cooperative sociali borderline e per cui sono finite in manette 14 persone. E sullo sfondo il ruolo di Carminati e Buzzi e la gestione anomala dell'Ama, scrive Giovanni Tizian su “L’Espresso”. Vestiti usati, stracciati, sporchi, sono oro per la camorra. Magliette, pantaloni, maglioni e giubbotti, che finiscono nei cassonetti gialli ben visibili ai lati delle strade di ogni quartiere sono il nuovo business per i clan e di Mafia Capitale. Così hanno saputo trasformare una merce senza più alcun valore in una montagna di quattrini. La scoperta della Squadra Mobile di Roma guidata da Renato Cortese e coordinata dalla procura antimafia di Roma ha dell'incredibile. Ma rende bene l'idea di come le cosche sappiano sfruttare qualunque possibilità di fare soldi. In manette sono finite quattordici persone accusate di traffico illecito di rifiuti e associazione per delinquere che aveva tra i suoi scopi quello di raccogliere, trasportare, cedere e gestire una quantità enorme di indumenti usati grazie agli appalti ricevuti dalle amministrazioni pubbliche che senza gara hanno affidato ad alcune cooperative il servizio. Lavori conquistati a Roma, in Abruzzo, in Campania. Ma il traffico vero e proprio aveva come terminali il Sud Africa, i Paesi del Nord Africa e l'Est Europa. A capo dell'organizzazione, secondo gli inquirenti, il boss della camorra Pietro Cozzolino elemento di vertice del clan di Portici-Ercolano (Napoli) e il fratello Aniello. Uno dei promotori sarebbe invece Danilo Sorgente, titolare della cooperativa New Orizon, una delle due coop che a Roma hanno gestito da monopoliste il settore del recupero degli abiti usati. «Un sistema collaudato di “rete” mediante il quale le imprese riescono ad acquisire affidamenti diretti per il servizio di raccolta della frazione tessile differenziata presso i Comuni di Lazio, Campania e Abruzzo, attraverso compiacenze politiche e collaudati meccanismi procedurali di facilitazione degli affidi» si legge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale della Capitale. Complicità politiche dunque, molte delle quali ancora tutte da scoprire. Sindaci, assessori, consiglieri comunali, che avrebbero intrattenuto, non solo a Roma e dintorni, rapporti con gli indagati e con le cooperative pigliatutto. In rapporto sia con Legacoop che con la Caritas per quanto riguarda il recupero degli indumenti usati. Imprese sociali che godevano anche di uno speciale regime fiscale e di agevolazioni per l'assunzione di persone svantaggiate, come per esempio i detenuti. La gestione dell'affare prevedeva il finto recupero della merce raccolta e la sistematica falsificazione dei documenti di trasporto e dei certificati di «igienizzazione»: la legge prevede che gli abiti raccolti prima di poterli reinserire nel mercato vadano disinfettati e ripuliti. L'associazione scoperta dalla polizia, invece, per risparmiare non avrebbe effetuato questo passaggio e spediva direttamente all'estero i prodotti, che senza questo passaggio potevano diventare nocivi per la salute. Un esempio: una delle cooperative coinvolte, Lapemaia onlus, nei primi otto mesi del 2012 ha smerciato quasi tre tonnellate di abiti usati tra la Tunisia la Polonia e la Campania, guadagnando mezzo milione di euro. Il ricarico su ogni chilo venduto all'estero andava dai 35 ai 58 cent. Spiccioli che vanno moltiplicati per le 12 mila tonnellate: a tanto corrisponde, secondo uno degli indagati, il business. La spedizione, dai porti di Salerno e Civitavecchia, avveniva attraverso società di intermediazione che servivano a facilitare la falsificazione dei documenti e la spedizione verso Nord Africa e Europa dell'Est. Il meccanismo insomma è sempre lo stesso. Il tipico giro bolla che permette di declassificare i rifiuti. Un meccanismo che gli imprenditori della camorra conoscono molto bene. Con questo meccanismo è stata infatti avvelenata la provincia di Caserta trasformandola in Gomorra. I documenti raccolti dalla squadra Mobile coinvolgono indirettamente la società partecipata dal Comune di Roma Ama Spa, l'ente che affida il servizio già coinvolta nell'indagine Mafia Capitale . Il giudice per le indagini preliminari ha un giudizio netto su come è stata gestita la società e punta il dito sul potere che esercita il braccio destro del boss Massimo Carminati sull'azienda : «Tutti (gli indagati ndr) trovano la premessa del loro agire nella disfunzionale gestione di Ama SpA, nel fattuale potere gestorio in essa esercitato dal referente di tutte le cooperative sociali, Salvatore Buzzi, il cui assenso è stato la premessa della ripartizione del territorio comunale per la raccolta del tessile». In altre parole è stato necessario il permesso del ras delle cooperative romane, Buzzi, perché la camorra e gli imprenditori indagati potessero lucrare sugli abiti usati. A Buzzi, pur non facendo parte di questa associazione scoperta dalla Mobile, «si deve, tuttavia, l’operatività del sistema», grazie a lui è possibile l'aggancio all'ambito istituzionale, al mondo di sopra. Insomma è Buzzi «il raccordo terminale delle consorterie che si dividono l’affare dei rifiuti tessili a Roma», e lo farebbe tramite un imprenditore, tale Mario Monge, presidente dell'importante consorzio Sol.co che dal Comune di Roma ha pure ottenuto la gestione di un bene confiscato alla mafia, il nuovo cinema Aquila. Così come la stessa cooperativa Horizons, che fa parte di Sol.co e che gestisce quello che un tempo era il quartier generale di Enrico Nicoletti, il cassiera della banda della Magliana. È Monge. secondo gli inquirenti, che organizza l'incontro tra i titolari delle cooperative coinvolte nel traffico, l'ex assessore della giunta capitolina ai tempi di Veltroni Dante Pomponi e i rappresentati della Coin, per programmare un eventuale affidamento del servizio a Roma Sud ed Est. Buzzi e Monge, stando agli atti dell'indagine, dialogano e sono in rapporti. Anzi gli investigatori su questo sono più precisi: «Chi vuole vincere non paga più – come un tempo – solo alla Pubblica Amministrazione, in un contesto che è solo corruttivo, ma paga al titolare di poteri di fatto all’interno della Pubblica Amministrazione, poteri che sono correlati al dominio della strada(cioè Buzzi e "er Cecato ndr), e che si proiettano nel mondo istituzionale, condizionandolo anche con la corruzione, poteri che sono, in una parola, di stampo mafioso». A conferma di ciò riportano un episodio: «Le cooperative che risultano vincenti all’apertura delle buste 2013 (per la raccolta degli indumenti usati) sono quelle che hanno rinunciato all’appalto per la raccolta del rifiuto multimateriale, e sono quindi gratificate dal Buzzi». Ama Spa è per gli investigatori roba di Carminati. «Ama S.p.a. società posseduta dal comune di Roma, all’interno della quale – sotto l’occhiuta regia di Carminati - si è svolta la collocazione in posizione apicale di soggetti che rispondono a un’organizzazione che non può che dirsi mafiosa, per i mezzi che utilizza, per i soggetti che la praticano e per la finalità che la animano». Parole pesanti che si aggiungono ai risultati dell'inchiesta su Mafia Capitale. Ma non finisce qui: «Buzzi , interfaccia economico di Carminati, che costituisce il regista anche dell’Ati Roma ambiente, aggregato di consorzi di imprese cooperative che è costola del più ampio disegno di ripartizione degli appalti distribuiti dall’Ama spa, in materia di verde pubblico , raccolta multimateriale dei rifiuti, raccolta del tessile». L'ipotesi della procura è che oltre a Mafia Capitale in Roma Ambiente ci sia anche la camorra guidata dal boss Cozzolino, uno degli artefici del grande traffico internazionale. Per questo secondo i detective della Mobile «vi è una concreta emergenza documentale, che consentono di chiarire che nemmeno gli appalti per i rifiuti tessili, connotati, peraltro, da un giro d’affari di milioni d’euro, sono sfuggiti alla regola della programmazione e del controllo nell’erogazione; e alla stura, anche, ad attività di interesse della criminalità organizzata, che hanno compromesso totalmente i beni della salute e dell’igiene pubblica, pur di massimizzare i profitti, nei Pesi esteri destinatati dell'invio».
Il business milionario degli abiti usati. Ogni anno circa 10mila tonnellate di vestiti finiscono nei cassonetti gialli presenti in tutte le città italiane. Ma solo una piccola parte arriva a chi ne ha davvero bisogno o viene utilizzata per sostenere progetti di solidarietà. Su questo enorme giro d'affari, grazie a regolamenti poco chiari e all'assenza di controlli, spuntano molte associazioni ambigue e la stessa criminalità organizzata. Come confermano anche gli ultimi sviluppi dell'inchiesta su Mafia Capitale che hanno portato all'arresto di 14 persone, scrivono Luigi Dell'Olio e Clemente Pistilli, con un commento di Carlo Ciavoni su “La Repubblica”.
Le troppe ambiguità di un circuito opaco scrive Luigi Dell'Olio. "Raccolta indumenti usati: grazie per il vostro aiuto", recita l'adesivo a caratteri cubitali apposto sul cassonetto giallo. Una scena che si può incontrare a Roma, Milano, Napoli, così come in centinaia di centri italiani di piccole e medie dimensioni. Ogni giorno decine di persone si recano presso i cassoni e vi depositano gli abiti che non utilizzano più, convinti di dare conforto ai più poveri. Complice la presenza di didascalie negli adesivi relativi alle principali destinazioni. Peccato che le cose non vadano sempre così: la maggior parte degli abiti raccolti, infatti, finisce nel circuito del riciclo, venduta a negozi specializzati in abiti vintage o a chi gestisce le bancarelle del mercato. Nel migliore dei casi, una piccola quota viene destinata a organizzazioni caritatevoli, ma la rendicontazione in merito è molto deficitaria e solo pochi (che fanno della trasparenza un tratto distintivo della loro attività) accettano di parlare. Così non sorprende che sul business si siano fondate organizzazioni criminali, che operano attraverso truffe ai cittadini e intimidazioni nei confronti degli operatori onesti. L'ultima conferma arriva dai 14 arresti eseguiti giovedì 15 gennaio dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale. La raccolta differenziata dei rifiuti tessili è cresciuta sensibilmente negli ultimi tempi fino a raggiungere il 12% del totale (che si aggira su 80mila tonnellate annue), pari a 2 kg a persona, secondo stime dell'Ispra (ministero dell'Ambiente). Che tali rimangono, dato che non esiste un censimento ufficiale proprio per la carenza informativa di cui si è già accennato. Gli operatori del mercato formano un ventaglio molto ampio: vi sono enti caritatevoli così come organizzazioni senza fini di lucro attive nella cooperazione internazionale, ma anche aziende commerciali, oltre che cooperative sociali. Senza trascurare i casi di società for profit che agiscono in collaborazione con associazioni per i poveri, ma destinando a queste ultime solo poche briciole (spesso gli impianti di raccolta vengono collocati strategicamente accanto alle chiese). Il tratto comune a quasi tutte queste iniziative è che quasi mai gli abiti raccolti finiscono per coprire e scaldare i più poveri. Anche se va riconosciuto che donare gli abiti resta un valore, così come l'attività di chi utilizza i proventi della rivendita per finalità sociali/caritatevoli. La maggior parte dei comuni italiani ha affidato il servizio a operatori che raccolgono gli abiti dai cassonetti e li vendono a ditte di stoccaggio per pochi centesimi al pezzo (da 20 a 30, in base alla loro qualità). Il trattamento degli abiti raccolti prevede prima la selezione (escludendo i capi destinati al riutilizzo, ad esempio perché troppo rovinati) e poi l'igienizzazione, da effettuare prima che gli abiti siano rimessi nel ciclo post consumo. Diverse inchieste della magistratura hanno però messo in luce la non corretta gestione della filiera degli abiti usati (senza le giuste autorizzazioni per lo stoccaggio e per il trasporto). Il fatto che non si abbia il pieno controllo della filiera presta il fianco ad attività di trattamento illecito di rifiuti. Un fenomeno che ha portato anche a diversi arresti e accertamenti da parte dei carabinieri per l'ambiente. La scorsa primavera la Procura di Roma ha aperto un'indagine in merito, rilevando il diffuso interesse della camorra per questo business (i cassonetti gialli sono 1.800 nella Capitale, per un incasso annuo intorno ai 2 milioni di euro), che si è manifestato anche attraverso intimidazioni alle aziende impegnate nella filiera, dirette a eliminare la concorrenza. Partendo da alcune denunce anonime, il sostituto procuratore della Capitale, Alberto Galanti, ha scoperto che gli abiti usati, una volta prelevati, venivano rivenduti (soprattutto all'estero) senza i dovuti trattamenti di igienizzazione che la normativa impone prima della commercializzazione. Un filone di questa indagine è passato sotto la competenza della Direzione Investigativa Antimafia, che messo nel mirino i presunti legami tra i clan camorristici e diverse aziende impegnate nell'igienizzazione dei capi, con sede a Capua e San Sebastiano al Vesuvio, che avrebbero rilasciato attestati di trattamenti conformi alla legge, in realtà mai avvenuti. Per la mala campana non si tratta di una novità dato che già nel 2011 la Dda di Firenze aveva eseguito un centinaio di arresti dopo la scoperta di un traffico illecito di indumenti usati provenienti dalla raccolta sul territorio, in larga parte gestito dal clan camorristico Birra-Iacomino di Ercolano. Il processo che è seguito ha portato per la prima volta alla condanna di mafia per un imprenditore toscano "per condotta connessa alla sua attività imprenditoriale". Raccolti alla rinfusa e imballati, spiega il Report Ecomafie di Legambiente, gli abiti erano stati messi in vendita al pubblico nelle bancarelle dei vari mercati rionali, senza alcuna precauzione igienica, saltando dunque le fasi di selezione, cernita e igienizzazione, previste dalla procedura. Nello stesso filone si è mossa anche l'indagine New Trade, che lo scorso anno ha portato la Dda di Firenze a indagare il titolare di una ditta di Prato, che avrebbe messo in piedi un sistema di traffici illeciti di rifiuti plastici e abiti usati verso Cina e Tunisia. Gli indumenti venivano rivenduti senza trattamenti igienico-sanitari in Africa e nei mercatini vintage italiani. Il traffico è stimato per migliaia di tonnellate. Secondo gli inquirenti, a gestire il traffico una rete organizzata di trafficanti, che parallelamente aveva messo in atto sul territorio anche attività di stampo mafioso come estorsioni e usura. Sono in attesa di processo anche gli imprenditori denunciati a Potenza in seguito all'operazione Panni Sporchi, che ha scoperto un flusso illegale di scarti tessili, con proiezioni anche verso l'Albania e alcuni paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. Fingendo un'attività umanitaria, gli indumenti usati venivano raccolti e rivenduti illegalmente in Italia e all'estero. L'operazione ha portato al sequestro preventivo di 18 automezzi impiegati nel trasporto in tutta la penisola e alla denuncia di 57 persone, indagate per associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, falso ideologico e truffa, per un giro d'affari valutato dai forestali "in alcuni milioni di euro l'anno". Tra i denunciati, anche 15 funzionari comunali che hanno autorizzato la raccolta degli stracci senza aver verificato il possesso delle relative autorizzazioni da parte degli addetti alla raccolta. "Girando di casa in casa o attingendo ai cassonetti adibiti al recupero di indumenti - scrivono gli investigatori del Corpo forestale dello Stato - i presunti responsabili hanno raccolto abiti usati per commercializzarli sul territorio nazionale e internazionale". Inoltre, spesso capita che qualcuno tiri fuori i sacchetti dai cassonetti e si appropri dei pezzi migliori, lasciando a terra il resto. Si tratta di illeciti, commessi da persone che vivono di espedienti: alcuni tra loro prelevano gli abiti per indossarli, ma la maggior parte li usa per venderli nei mercatini abusivi. Complessivamente, il danno alla raccolta è minimo, anche se questo produce un disordine ambientale. Vi è poi un mercato parallelo relativo alle aree private. Sarà capitato a tutti di trovare, affissi su portoni e citofoni, volantini per la raccolta di indumenti usati, con l'indicazione del giorno e dell'ora per il ritiro. Si tratta per lo più di biglietti anonimi o con indicazioni approssimative, che difficilmente consentono di risalire a chi gestisce il servizio. In questi casi, la raccomandazione è di segnalare il fatto alle autorità. A San Donato (Milano), addirittura, sono stati scoperti cassonetti abusivi collocati sui marciapiedi cittadini, di colore e conformazione simile a quelli ufficiali, ma abusivi (privi di logo e posizionati senza autorizzazioni). Le indagini dei carabinieri sono partite proprio grazie alla segnalazione di un cittadino. Al di là degli illeciti, la sensazione diffusa è di una scarsa trasparenza nel mercato. In pochi accettano di raccontare il proprio business, di spiegare quanta parte dell'incasso genera profitti e quanto invece viene destinata ad azioni caritatevoli. "Occorrerebbero normative per obbligare gli operatori del mercato a una maggiore trasparenza informativa nei confronti della comunità", osserva Karina Bolin, presidente dell'organizzazione umanitaria Humana People to People Italia, che nella Penisola gestisce 4.788 contenitori all'interno di 946 comuni e impiega 120 persone, con una raccolta che lo scorso anno è stata di 15,45 tonnellate. "Pubblichiamo ogni anno un bilancio delle attività svolte", rivendica Bolin ricostruendo la filiera: "Gli abiti estivi in buono stato vengono inviati in Africa (1,034 tonnellate lo scorso anno), dove sono regalati solo in casi di emergenza. Negli altri casi sono venduti a prezzi accessibili per ottenere fondi da impiegare per i progetti sociali attivi localmente. Gli abiti non adeguati all'invio in Africa, vengono venduti in Italia e in altri paesi europei, sia al dettaglio sia all'ingrosso. Con i fondi ricavati, oltre ad autofinanziare la nostra attività, impieghiamo gli utili per i progetti di sviluppo nei Paesi emergenti (pozzi, scuole e interventi sanitari) e per azioni sociali e di tutela ambientale in Italia. Andrebbe inoltre imposto l'obbligo di trasparenza dell'intera filiera, dalla raccolta degli abiti usati fino alla loro destinazione finale, e una rendicontazione adeguata", prosegue Bolin. "Anche perché non è giusto trarre in inganno i cittadini, inducendoli a pensare che i vestiti siano destinati a un'attività sociale: al contrario in questo settore si muovono molti operatori non in regola, spesso non controllati dalle istituzioni per la mancanza di adeguati strumenti di verifica".
Le mani della Camorra sugli stracci di Roma, scrive Clemente Pistilli. Gli abiti usati a Roma non hanno più la puzza degli stracci e neppure quell'odore acre ma caldo della beneficenza. Sulle pezze è ormai forte il profumo dei soldi e a imprimerlo sono state le mafie, camorra napoletana in testa. Un affare da oltre due milioni di euro l'anno quello dei 1.800 bidoni gialli sparsi nella capitale, dove i romani svuotano il guardaroba. Troppo ricco per sfuggire ai clan, che da circa un decennio - in base alle ultime indagini condotte dall'Antimafia capitolina - starebbero cercando di imporre la loro legge a suon di minacce e attentati, a partire da quelli alle tre principali cooperative che raccolgono i vestiti vecchi per conto dell'Ama, municipalizzata incaricata dell'igiene urbana, fino a trovare anche qualche forma di intesa con quelle che erano le loro vittime e a rientrare nella spartizione degli appalti pubblici con regista Mafia Capitale. Un business ideato dalle mafie ad Ercolano, in Campania, esportato in Toscana, a Prato, e infine nel Lazio e in Abruzzo, con protagonisti ex collaboratori di giustizia fuori controllo. I tentacoli stretti dai clan sulla capitale sono stati scoperti dopo due anni di indagini compiute dalla Mobile di Roma sulle tonnellate di stracci dirette in Africa e nell'Europa dell'Est, secondo la Dda senza disinfettare e ripulire gli abiti usati raccolti, e con una denuncia presentata nella scorsa primavera ai carabinieri di Cisterna di Latina da un imprenditore del posto, Alfonso Balido, originario di Napoli, impegnato nella Balidex, società che stocca vestiti vecchi. Un anello della catena delle pezze. L'Ama ha dato l'appalto per svuotare i cassonetti degli stracci a due consorzi, per i quali lavorano cinque cooperative. Le coop vendono i vecchi vestiti alle aziende come quella di Cisterna, che a loro volta li cedono a società campane che si occupano della cernita. E di passaggio in passaggio il valore delle pezze cresce. Basta poi evitare la sterilizzazione, o imporre i prezzi alle ditte di stoccaggio, e le somme schizzano verso l'alto. Proprio quello che fa la camorra. A Balido un gruppo di campani ha cercato di imporre il pizzo, furiosi perché aveva iniziato ad acquistare dalla coop New Horizons, prima appannaggio di una loro azienda con sede a Ferentino, nel frusinate. L'imprenditore, con la sua denuncia, il 12 giugno ha fatto arrestare dai carabinieri i fratelli Simone e Pietro Cozzolino, ex pentiti in libertà, e i nipoti dei due, Vincenzo Cozzolino e Vincenzo Scava. Le indagini sono poi andate avanti e le prove dell'estorsione mafiosa, per il pm antimafia romano Lina Cusano, sono talmente evidenti che ha chiesto e ottenuto dal gip Anna Maria Gavoni il giudizio immediato per i quattro, difesi dagli avvocati Giuseppe Bucciante e Giusi Grigoli, un processo iniziato il 16 dicembre a Latina. Gli inquirenti però hanno scoperto anche il cuore dell'infiltrazione della camorra delle pezze. Alla coop Lapemaia, tra il 2004 e il 2009, il deposito è stato bruciato tre volte e alla New Horizons una volta. Il titolare de Lapemaia, Marcelo Rodolfo Ocana, cinque anni fa, denunciò alla polizia: "Temo seriamente per la cooperativa, per la mia incolumità e quella dei miei venti dipendenti, considerando che, notoriamente, il mercato in questione interessa le organizzazioni criminali, camorra in particolare". Ma le intimidazioni sarebbero continuate. "Cozzolino a Cisterna fece capire - ha dichiarato lo scorso anno Ocana ai carabinieri - che la piazza di Roma era sua". Minacce infine anche alla coop Rau, come confermato agli inquirenti da un socio della cooperativa, Biagio Di Marzio: "Cozzolino mi minacciò in un bar sulla Prenestina Nuova". Ma c'è di più. A un tratto alcune delle coop vittime delle intimidazioni, come Lapemaia e la New Horizons, avrebbero preso parte all'affare illecito degli stracci che, senza alcuna sanitizzazione, venivano spediti all'estero, sotto la regia sempre di Pietro Cozzolino, e del fratello Aniello, latitante dal 2008, tanto che anche manager, come Ocana, e dipendenti delle cooperative sono stati arrestati giovedì scorso. Senza contare che per l'Antimafia sporchi sarebbero anche gli stessi appalti affidati dall'Ama per raccogliere gli stracci, frutto di "compiacenze politiche e collaudati meccanismi procedurali di facilitazioni degli affidi", in cui avrebbe avuto un ruolo di primo piano sempre quel Salvatore Buzzi ritenuto la cassaforte dei fasciomafiosi. E Balido? "La metà dei clienti che avevo a Napoli non vuole più lavorare con me", ci ha confessato due mesi fa, attendendo l'esito del processo in corso a Latina. Il prezzo che si paga denunciando la camorra. Come distinguere gli operatori seri. Come si è detto, nel settore della raccolta di indumenti usati regna la confusione in merito alle modalità di valorizzazione dei capi e dei ritorni per la comunità. Ma la situazione non è del tutto trasparente nemmeno sul fronte dei cassonetti perché, accanto a quelli posizionati in accordo con le amministrazioni comunali, spesso vi sono iniziative estemporanee, nelle quali è difficile persino capire chi sono i promotori e chi si occupa della raccolta. Alcuni accorgimenti possono aiutare a fare una scelta consapevole: sul contenitore per la raccolta degli indumenti devono essere indicati gli estremi della società o associazione che si occupa della raccolta, con un numero di telefono (se c'è solo un cellulare e non un fisso qualche sospetto può essere legittimo), l'indirizzo della sede e il sito Internet. È fondamentale, inoltre, che sia indicata la finalità dell'iniziativa di raccolta. Chi ha dubbi sulla conformità del cassonetto, può verificarne la regolarità telefonando al proprio Comune, che possiede la mappatura completa dei contenitori autorizzati. In alcuni centri queste indicano si trovano anche online.
Ogni città raccoglie a modo suo, scrive Luigi Dell'Olio. La situazione è molto diversificata a livello nazionale, quanto a modalità della raccolta e soggetti impegnati nell'attività. Il tratto comune (tranne poche eccezioni) è la scarsa trasparenza in merito all'incasso della raccolta e alla quota destinata effettivamente a iniziative sociali.
A Torino la municipalizzata Amia ha messo a punto un prontuario online con indicazioni puntuali: il materiale da conferire (abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, borse, scarpe e accessori per l'abbigliamento), le modalità ("gli abiti usati devono essere riposti in sacchetti o imballaggi ben chiusi") e le destinazioni ("il materiale in buono stato viene gestito da aziende che lo mandano nei Paesi in via di sviluppo, mentre ciò che resta viene riciclato per l'ottenimento di materie prime, quali ad esempio la lana rigenerata").
Genova si è dotata di un sistema di tracciabilità che privilegia la trasparenza. Collegandosi al sito Staccapanni si ricavano informazioni sul servizio - curato dalla Fondazione Auxilium e dalla Caritas Diocesana, in collaborazione Amiu (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana) e della cooperativa sociale Emmaus, che cura materialmente il servizio. Nello spazio Web sono presenti i numeri dell'attività (260 contenitori, 1.400 tonnellate raccolte), oltre alla destinazione dei capi, che segue tre strade: una parte viene selezionata e distribuita alle persone in stato di bisogno. Quello che avanza e risulta in buono stato, viene venduto ad operatori del mercato dell'abito usato, mentre il materiale in pessimo stato viene ritirato come pezzame industriale, senza che ciò produca ricavi economici.
A Milano la raccolta è affidata a un gruppo di cooperative sociali organizzate da Caritas Ambrosiana e Compagnia delle Opere, che provvedono al loro riutilizzo o riciclaggio. La capofila è la onlus Vesti Solidale, che ha messo a punto il sito Internet "Dona Valore", la stessa scritta che campeggia sui cassonetti che aderiscono all'iniziativa, con la rendicontazione delle attività svolte. "Complessivamente impieghiamo circa 50 lavoratori provenienti da situazioni di disagio", spiega il responsabile dalla onlus Carmine Guanci. "Dall'amministrazione comunale non riceviamo nulla; l'80% dei proventi della rivendita serve per coprire i costi del servizio e pagare gli stipendi. Il resto finisce nelle iniziative sociali". Nel 2013 sono stati destinati 290mila euro a sostegno dei progetti presentati dalle cooperative promosse da Caritas Ambrosiana e socie del Consorzio Farsi Prossimo. Un dato in crescita rispetto ai 228mila euro del 2012.
Il Comune di Padova ha affidato il servizio alla Caritas Diocesana, che ha predisposto il sito Internet "Che fine fanno", con l'intento di garantire trasparenza alla gestione del materiale riposto nei contenitori gialli. Il servizio è materialmente svolto da un gruppo di cooperative sociali - Città solare, Il Grillo, Cooperativa Ferracina, Montericco e Cooperativa Sociale insieme - che, attraverso accordi con alcuni comuni e con le società Etra, Acegas-Aps, Veritas, PadovaTre gestiscono la raccolta degli indumenti nel territorio della Diocesi patavina, che comprende cinque province venete. Al termine del processo di recupero e smaltimento le cooperative sociali destinano una parte degli utili derivanti dallo smaltimento o vendita (il 7%) per la realizzazione di alcuni progetti di Caritas Padova, rendicontati sul sito.
A Bologna hanno da poco debuttato i nuovi contenitori studiati da Hera, singolari per colorazione (il grigio, che si armonizza con i cassonetti stradali) e la "vestizione" (giocata su icone che hanno l'obiettivo di rendere facilmente comprensibile ai cittadini la funzione del cassone), con l'obiettivo di far crescere i numeri, dopo che già nel 2013 è stato raggiunto il livello ragguardevole di 647 tonnellate. Materialmente la raccolta è stata affidata al consorzio di cooperative sociali Ecobi, che è subentrato alla gestione frammentata che ha caratterizzato gli anni precedenti. Riunisce imprese locali, come La Fraternità (Ozzano), La Piccola Carovana (Crevalcore) e Pictor (Budrio). Vestiti e scarpe, per il momento, vengono stoccati presso gli impianti di due Onlus (Fraternità e Piccola Carovana). Una volta a regime, invece, Ecobi farà autorizzare a Ozzano un vero impianto di trattamento e selezione, che consentirà un puntuale controllo di tutta la filiera, dalla raccolta alla reimmissione sul mercato, posti di lavoro. Le cooperative infatti, potranno rivendere il materiale raccolto e tenere per le proprie attività sociali i ricavi. Questo sistema permette di non avere costi per Hera né, per il Comune.
A Roma lo scorso anno sono state raccolte 9.500 tonnellate di abiti usati (contro le 7.250 dell'anno precedente), attraverso 1.800 contenitori (nel 2008 erano appena 504), dislocati in tutto il territorio della capitale. Il prelievo (effettuato una volta a settimana, con l'impiego di 61 operai) viene svolto dall'associazione temporanea di impresa Roma Ambiente, composta da due consorzi, l'Alberto Bastiani e Il Solco. Entrambi contattati per questo servizio, non hanno voluto fornire numeri sulla raccolta e sulle destinazioni dei proventi. Di certo si sa che i numeri in gioco sono rilevanti: l'incasso stimato annuo è di 2 milioni di euro all'anno, tanto che ora l'Ama (spa del Comune di Roma) ha in corso il nuovo bando per l'assegnazione triennale del servizio, dal quale conta di incassare una somma consistente. La raccolta viene effettuata da un totale di 61 operatori (le coop danno lavoro anche a ex-detenuti, offrendo loro una possibilità di reinserimento), in media una volta a settimana. Il 15% circa degli abiti usati raccolti finisce nei negozi di vintage, il 45% nei Paesi in via di sviluppo soprattutto in Africa, il 25% viene impiegato come pezzame e il resto diventa scarto o finisce in beneficenza.
Infine a Napoli tre anni fa è stata bandita una gara d'appalto, che ha visto primeggiare il duo composto dalla Onlus Ambiente Solidale e della F. lli Esposito Sas. Gli aggiudicatari, che hanno posizionato un contenitore ogni 1.500 residenti, sono tenuti a corrispondere ad Asia (Agenzia servizi di igiene ambientale) Napoli 3 centesimi per ogni Kg di rifiuto raccolto. Somme che compongono un fondo impiegato per attività umanitarie.
Beffa atroce, ma resistiamo al cinismo, commenta Carlo Ciavoni. La solidarietà, il sentimento umano di aiutare il prossimo, che prende forma in azioni organizzate o individuali e spontanee, mostra a volte il suo volto fasullo, furbo, arcigno. Tutto così diventa più sgradevole, molto di più di quando ci si sente semplicemente fregati, da qualcuno che t'infila le mani in tasca per rubare, o ti raggira con un trucco. L'atto solidale, sospinto da ideali religiosi o laici che siano - quando viene tradito e sbeffeggiato, in chi lo compie si trasforma in un dolore acuto, come un chiodo nella propria intimità etica. La storia dei cassonetti gialli, con tutti quegli indumenti regalati a chi ne ha bisogno, si aggiunge ad altre beffe compiute alle spalle di chi cerca di cambiare in meglio la vita dei disgraziati di questo mondo i quali, senza chiederlo, dovrebbero ricevere senza troppi maneggi ciò che viene loro donato. Purtroppo, l'universo della Cooperazione e del volontariato nella sua complessità non è stato ancora analizzato a fondo. C'è da comprendere, infatti, quali proporzioni abbia davvero il fenomeno della speculazione sugli aiuti umanitari, se esiste, e che profilo ha il volto nascosto della Cooperazione, in ogni sua forma possibile. Si calcola, ad esempio, che nel mondo operino circa 50mila Organizzazioni non governative (Ong) e che le attività riferibili al cosiddetto Terzo settore (cioè Ong, Onlus, fondazioni, enti di carità, cooperative, soprattutto agenzie Onu) muovano un mare di denaro di circa 400 miliardi di dollari. Valentina Furlanetto - giornalista a Radio 24 - un paio d'anni fa ha scritto un saggio, assai contestato per la verità, anche con ottime ragioni, ma che ha avuto comunque il merito di accendere l'attenzione su un aspetto in questo ambito di cose, altrimenti nascosto dalla "nebbia" dei buoni sentimenti. Il saggio s'intitola L'industria della carità - Da storie e testimonianze inedite il volto nascosto delle beneficenza - Chiarelettere - 243 pagine, 13.90 euro). La Furlanetto sferra un attacco frontale al mondo della Cooperazione e del volontariato. E traccia un elenco di organizzazioni da lei annoverate fra le più ricche: Save the Children, World Visione Feed the Children (circa 1,2 miliardi di dollari di bilancio ciascuna). Poi si domanda da dove provengano quei soldi e si risponde che arrivano da enti pubblici o da donazioni private. La giornalista denuncia sprechi, ma anche i vuoti del nostro sistema d'assistenza e sottolinea come il Terzo settore sia lievitato negli ultimi quarant'anni: da una ventina che erano negli anni '60, le Ong italiane (una piccola porzione del Terzo settore) oggi riconosciute ufficialmente sono 248, coinvolte in 3.000 progetti in 84 Paesi del mondo, e impegnano 5.500 persone, con un budget gestito di circa 350 milioni di euro l'anno. Bene, detto tutto ciò, va però precisato che, semmai tutto questo "esercito" non ci fosse - e sono tutti a dirlo - quella parte del mondo, circa l'80% dell'umanità, non avrebbe compiuto enormi progressi per quanto riguarda la riduzione delle morti per fame, nel calo vistoso della mortalità infantile e della povertà in genere, oltre che aver aumentato complessivamente la scolarità. La macchina solidale costa: è vero. E sicuramente il rapporto tra quanto viene investito nei progetti di aiuto e il valore reale che resta sul terreno potrà (dovrà) migliorare di molto, a vantaggio dei beneficiari. Ma è altrettanto vero che la stragrande maggioranza dei cooperanti (che non vanno confusi con i missionari) lavora compiendo scelte spesso difficili di distacco dal proprio ambiente, con stipendi nient'affatto faraonici (almeno nella stragrande maggioranza dei casi) e che comunque riescono sempre a portare a termine programmi di sviluppo o interventi d'emergenza in contesti spessissimo difficili e pericolosi. In casi come questo dei cassonetti di raccolta fasulli, dunque, sarebbe bene non dar sfogo a fantasie che mettano tutto e tutti nello stesso calderone, in una baraonda "de magna-magna" che davvero sarebbe sbagliato e ingiusto associare a questo complicatissimo mondo. La totalità delle organizzazioni che lavorano per aiutare il prossimo, nelle emergenze, nei progetti di sviluppo, o nel lavoro sottile e complesso di chi punta sulla crescita della consapevolezza dei diritti (ignorati da intere popolazioni nel modo povero) lo fanno in totale trasparenza. Tutto è migliorabile, certo, ma sarebbe un grave errore mescolare tutto questo patrimonio di passioni e competenze con fattacci di cronaca nera dai quali, come nella vicenda dei cassonetti gialli, non a caso, fa capolino anche la camorra.
COME SIAMO O COME CI HANNO FATTI DIVENTARE.
«Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano in 2 e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Parlano lingue incomprensibili, forse dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina; spesso davanti alle chiese donne e uomini anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano sia perché poco attraenti e selvatici, sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano dal lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, di attività criminali. Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano pur che le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione».
____________________________
Fonte: Relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso degli Stati Uniti sugli immigrati italiani, ottobre 1919.
Razzismo, la gaffe di Germano: falso il testo letto ai bimbi rom. Elio Germano, attore figo, impegnato e perciò di sinistra, ha pensato bene di dare il suo contributo alla mobilitazione contro Salvini. Ma ha fatto una clamorosa gaffe, scrive Giampaolo Rossi su “Il Giornale”. Elio Germano, attore figo, impegnato e perciò di sinistra, ha pensato bene di dare il suo contributo alla mobilitazione delle anime belle contro Salvini e il pericolo della destra intollerante e, soprattutto, ignorante. Per questo ha realizzato un video contro il razzismo; ha preso un gruppo di bambini Rom sullo sfondo di una roulotte, si è seduto in mezzo a loro e ha iniziato a leggere un documento con tono recitato (come si addice ai grandi attori) e l’aria di chi sta svelando al mondo una verità nascosta ma scontata. Il testo è una descrizione offensiva e razzista degli italiani emigrati in America agli inizi del ‘900, definiti ladri, puzzolenti, stupratori, abituati a vivere dentro baracche fatiscenti e organizzati secondo regole di clan. Elio Germano spiega che quel testo è un documento dell’allora Ispettorato per l’Immigrazione degli Stati Uniti. L’obiettivo dell’attore è ovvio: dimostrare che certi italiani di oggi sono razzisti verso gli immigrati e i Rom, come lo erano gli americani verso gli italiani all’inizio del secolo. Tutto molto bello e politically correct, se non fosse che, a quanto pare, quel documento è una patacca, un falso. Il testo, che gira da molti anni su internet, fu già utilizzato nel 2013 da Roberto Saviano (uno che di patacche se ne intende) nel salottino televisivo di Fabio Fazio. Più recentemente, Carlo Giovanardi, l’agguerrito deputato di centrodestra, ha pubblicato il vero documento originale della Commissione Dillingham sull’Immigrazione, che non contiene nulla di quanto letto dagli antirazzisti di mestiere, ma al contrario è un’attenta analisi dell’immigrazione italiana del periodo. Che giudizi sprezzanti e spesso offensivi contrassegnassero l’opinione pubblica americana nei confronti degli italiani (soprattutto meridionali) è cosa appurata storicamente da diversi studi. Ma quel documento che i fulgidi artisti di sinistra si passano di mano in ogni occasione per dare del razzista a chiunque contesti l’immigrazione clandestina, è una patacca degna della loro inutile demagogia.
Saviano va in tv a spiegare che una volta eravamo noi italiani gli zingari d’America. Ma è una bufala. Giugno 12, 2013 Carlo Giovanardi. Ospite di Fabio Fazio, lo scrittore cita «un documento dell’Ispettorato per l’immigrazione Usa» che tratta gli italiani come zecche. Peccato che sia una patacca Domenica 26 maggio Roberto Saviano, intervistato da Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa, per combattere quella da lui definita l’ondata di «odio morale verso gli immigrati» ha letto un testo. Cito testualmente le sue parole: «Avevo visto e trascritto qui alcune parole della relazione dell’Ispettorato per l’immigrazione del Congresso americano, quindi un documento ufficiale del governo americano del 1912, così descrive gli italiani». Ecco il testo letto da Saviano: «Gli italiani sono generalmente di piccola statura e di pelle scura, non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane, si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Si presentano di solito in due, cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci, tra loro parlano lingue a noi incomprensibili probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina, fanno molti figli che poi faticano a mantenere. Dicono siano dediti al furto, e le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si parla di stupri o agguati in strade periferiche. Propongo che si privilegino le persone del nord, veneti e lombardi, corti di comprendonio e ignoranti, ma disposti più degli altri a lavorare». Concludeva poi Saviano: «Incredibile che il nostro paese tutto questo non lo ricordi, non ne faccia memoria attiva, ma lo trasferisca quando si rivolge ad altre comunità o “etnie”». Conosco bene la storia dell’emigrazione italiana e delle terribili discriminazioni e umiliazioni di cui i nostri connazionali sono stati vittime all’estero ma, trovandomi per caso quella sera davanti alla tv di Stato, mi è parso del tutto evidente il fumus di “patacca” che emanava da frasi così volgari ed offensive in un documento ufficiale del Senato degli Stati Uniti nei confronti di un intero popolo. Una rapida ricerca su Google mi ha permesso di scoprire che già Paolo Attivissimo sul sito del CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale), aveva a suo tempo verificato che di quel testo erano in circolazione varie versioni, una delle quali, lanciata da Rainews24, citava come fonte il giornalista e conduttore televisivo Andrea Sarubbi che nel 2009 aveva pubblicato un articolo con quella citazione. Sarubbi, interpellato, aveva precisato di non aver tratto la citazione direttamente dal documento statunitense originale. La sua frase: «Ho fra le mani un documento dell’Ispettorato per l’immigrazione», non era quindi letterale, ma derivava da una fonte italiana, «un articolo pubblicato un anno fa sul giornale Il Verona dall’avv. Guarenti». Guarenti, a sua volta, dichiarava di averlo trovato «in un libro di un anno fa» ma non era in grado di citare il titolo del libro. Insomma, concludeva Attivissimo: «Siamo di fronte ad una situazione almeno di terza mano di cui non si sa la fonte intermedia». Sulla traccia di Attivissimo ho interpellato pertanto formalmente l’ambasciata americana che mi ha risposto il 30 maggio: «La commissione sull’immigrazione degli Stati Uniti conosciuta come la Dillingham Commission dal nome del senatore del Vermont che l’ha presieduta ha lavorato dal 1907 al 1911 e ha pubblicato 41 volumi di rapporti contenenti dati statistici sull’immigrazione negli Stati Uniti, l’occupazione degli immigrati, le condizioni di vita, la scolarizzazione dei bambini, le organizzazioni sociali e culturali, delle comunità degli immigrati e la legislazione sull’immigrazione a livello statale e federale». Continuava poi l’ambasciata americana: «Questi sono gli unici rapporti ufficiali sull’immigrazione elaborati in quegli anni e disponibili al pubblico. Da una visione superficiale, la citazione da lei riportata nella sua mail non appare in nessuno di questi rapporti, ma per esserne certi bisognerebbe eseguire una ricerca più accurata, per la quale purtroppo noi non siamo in grado di aiutarla in questo momento». Aiutati che Dio ti aiuta, ho consultato tramite la mail inviatami dall’Ambasciata tutti i volumi senza trovar traccia del documento citato da Saviano, ma viceversa una interessantissima disamina sull’immigrazione dell’Italia che ho fatto tradurre dall’inglese e si può leggere sul sito www.carlogiovanardi.it. Per il resto ringrazio Saviano che mi permette di aggiungere il XII ed ultimo capitolo al libro intitolato Balle che sto pubblicando, dove spiego come l’opinione pubblica italiana fonda le sue convinzioni su vere e proprie bufale che vengono troppo spesso disinvoltamente spacciate come verità.
61ª legislatura, Documento n. 662, RELAZIONI DELLA COMMISSIONE SULL'IMMIGRAZIONE. DIZIONARIO DELLE RAZZE O POPOLI. Presentato da DILLINGHAM il 5 dicembre 1910 alla Commissione sull'immigrazione [...] ITALIANO. La razza o il popolo dell'Italia. L'Ufficio dell'immigrazione [Bureau of Immigration] divide questa razza in due gruppi: Italiani settentrionali e Italiani meridionali. Fra i due gruppi vi sono delle differenze materiali, riconducibili a lingua, aspetto fisico e carattere, e delle differenze relative, rispetto alla distribuzione geografica. Il primo gruppo identifica gli italiani nativi del bacino del Po (compartimenti del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emelia [sic], i distretti italiani in Francia, Svizzera e Tirolo (Austria) e i loro discendenti. Tutti i popoli della penisola geograficamente definita e delle isole della Sicilia e della Sardegna sono Italiani meridionali. Anche Genova è meridionale.
Linguisticamente, l'italiano rappresenta una delle grandi divisioni del gruppo di lingue romanze derivate dal ceppo latino della famiglia ariana. Esso è articolato in molti dialetti, la cui separazione e conservazione è favorita dalla configurazione geografica dell'Italia. Hovelacque divide questi dialetti in tre gruppi: superiore, centrale ed inferiore. Il primo comprende i dialetti genovese, piemontese, veneto, emiliano e lombardo; il gruppo centrale comprende toscano, romanesco e còrso; il gruppo inferiore comprende napoletano, calabrese, siciliano e sardo. Questi dialetti differiscono fra di loro molto più che i dialetti inglesi o spagnoli. Si dice che è difficile per un Napoletano o un Sardo farsi capire da un nativo della pianura padana. Forse più che in qualsiasi altro paese, le classi colte restano tenacemente aggrappate all'uso del dialetto in àmbito familiare, preferendolo alla forma letteraria nazionale della lingua. Tale forma letteraria è rappresentata dal dialetto toscano di Firenze, come codificato nella letteratura di Dante, Petrarca e Bocaccio [sic] nel XIV secolo. Anche altri dialetti, tuttavia, hanno una considerevole letteratura, soprattutto il veneto, il lombardo, il napoletano e il siciliano. Quest'ultimo ha una poesia particolarmente ricca. Tutto il gruppo superiore di dialetti – per restare alla definizione di Hovelacque – tranne il genovese, è settentrionale. Tali dialetti contengono molti elementi gallici o celtici e mostrano affinità con le lingue provenzali e retoromanze (ladino e friulano), con le quali confinano ovunque tranne che al sud. Il genovese e i dialetti del gruppo centrale ed inferiore sono parlati dagli Italiani meridionali.
Fisicamente, gli Italiani sono una razza tutt'altro che omogenea. La catena montuosa degli Appennini forma una linea geografica che costituisce un confine fra due gruppi etnici distinti. La regione a nord di questa linea, la valle del Po, è abitata da persone – i Settentrionali – abbastanza alte e con la testa larga (la razza "alpina"). Gli abitanti delle zone orientali ed occidentali di questa regione mostrano apporti teutonici in Lombardia ed un'infusione di sangue slavo in Veneto. Tutta l'Italia a sud dell'Appennino e tutte le isole adiacenti sono occupate da una razza "mediterranea", di bassa statura, scura di pelle e con il viso lungo. Si tratta dei "Meridionali", che discenderebbero dall'antica popolazione italica dei Liguri, strettamente imparentati con gli Iberici della Spagna e i Berberi del Nordafrica. Il principale etnologo italiano, Sergi, li fa derivare dal ceppo amitico (v. Semitico-Amitico) del Nordafrica. Bisogna ricordare che gli Amitici non sono negritici, né veri africani, sebbene si possa rintracciare un apporto di sangue africano in alcune comunità in Sicilia e in Sardegna, oltre che in Nordafrica. L'Ufficio dell'immigrazione pone gli Italiani settentrionali nella divisione "celtica" e quelli meridionali in quella "iberica". La commistione fra i due gruppi etnici è stata relativamente scarsa, anche se molti Italiani settentrionali hanno doppiato gli Appennini ad est, facendo ingresso nell'Italia centrale. Pertanto, la linea di demarcazione fra Emiliani e Toscani è molto meno netta che fra Piemontesi e Genovesi. Un sociologo italiano, Niceforo, ha indicato che questi due gruppi etnici differiscono profondamente fra di loro, da un punto di vista sia fisico sia caratteriale. Egli descrive il Meridionale come irritabile, impulsivo, molto fantasioso, testardo; un individualista poco adattabile ad una società ben organizzata. Al contrario, descrive il Settentrionale come distaccato, risoluto, paziente, pratico e capace di grandi progressi nell'organizzazione politica e sociale della civiltà moderna. Sia i Settentrionali sia i Meridionali sono dediti alla famiglia, d'animo buono, religiosi, artistici ed industriosi. Sono quasi tutti di religione cattolica. La maggior parte dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti è reclutata fra le classi contadine ed operaie. In America, tuttavia, essi non hanno conseguito successo come agricoltori, con l'eccezione della frutticoltura e dell'enologia, soprattutto in California, dove figurano ai primi posti.
L'esperto di statistica italiano Bosco ammette che l'Italia è tuttora al primo posto in termini di numero di reati contro la persona, anche se questi sono diminuiti notevolmente in seguito al miglioramento del sistema di istruzione e all'ampio flusso di emigrazione. Su questo versante l'Italia è seguita nella graduatoria dall'Austria, dalla Francia e, a una certa distanza, dall'Irlanda, la Germania, l'Inghilterra e la Scozia. Niceforo indica, sulla base dei dati statistici italiani, che tutti i reati, soprattutto i crimini violenti, sono molto più numerosi tra i Meridionali che tra i Settentrionali. Il gioco d'azzardo è diffuso. Il gioco del lotto è un'istituzione nazionale che viene utilizzata per alimentare le casse dello Stato. Il brigantaggio è ormai pressoché estinto, fatta eccezione per alcune parti della Sicilia. Le organizzazioni segrete come la Mafia e la Comorra [sic], istituzioni molto influenti tra la popolazione che esercitano la giustizia in proprio e sono responsabili di molta parte della criminalità, prosperano nell'Italia meridionale. La maggiore difficoltà nella lotta alla criminalità sembra risiedere nella propensione degli Italiani a non testimoniare contro alcuno in tribunale e a riparare i torti ricorrendo alla vendetta (v. Còrsi).
E' indicativo il fatto che l'Italia sia uno dei paesi con il maggiore tasso di analfabetismo in Europa. Nel 1901 il 48,3% della popolazione dai sei anni in su non sapeva leggere e scrivere. In quell'anno in Calabria, la parte più meridionale della penisola, il tasso di analfabetismo tra le persone dai sei anni in su era pari al 78,7%. Il tasso di analfabetismo più basso si registra nella valle del Po, nell'Italia settentrionale. I Lombardi e i Piemontesi sono gli italiani più istruiti. La situazione è tuttavia migliorata dopo che il governo ha reso l'istruzione gratuita e obbligatoria tra i 6 e i 9 anni nei comuni dove vi erano le sole scuole elementari e dai 6 ai 12 anni nei comuni dove erano presenti scuole di più alto grado.
Tra le classi più umili la povertà è estrema; le persone vivono in alloggi miseri e hanno accesso a un'alimentazione carente, basata principalmente su granoturco mal conservato. Perfino a Venezia sembra che un quarto della popolazione viva ufficialmente di carità.
I confini geografici della razza italiana sono più ampi di quelli dell'Italia. Gruppi numerosi sono presenti in paesi vicini come Francia, Svizzera ed Austria. Le province del Tirolo e dell'Istria, in Austria, sono per un terzo italiane. Ampi gruppi sono inoltre presenti nel Nuovo Mondo. L'Italia stessa è quasi interamente italiana. Ha una popolazione di 34 milioni di persone e comprende solo piccoli bacini di altre razze (circa 80.000 Francesi nell'Italia nordoccidentale, 30.000 Slavi nell'Italia nordorientale, circa 30.000 Greci nell'Italia meridionale, circa 90.000 Albanesi in Italia meridionale e in Sicilia e 10.000 Catalani (Spagnoli) in Sardegna. Un certo numero di Tedeschi, forse meno di 10.000, è presente nelle Alpi italiane. Circa due quinti della popolazione dell'Italia si trovano nella valle del Po, ovvero in meno di un terzo della lunghezza del paese. Suddivisa approssimativamente in compartimenti, la popolazione di quest'area, occupata da Italiani settentrionali, conta circa 14 milioni di persone. Questa cifra include i Friulani dell'Italia nordorientale i quali, pur parlando una lingua latina distinta dall'italiano, sono difficilmente distinguibili dagli Italiani settentrionali. Il loro numero si situerebbe, a seconda delle diverse stime, tra 50.000 e 450.000. La popolazione dei distretti meridionali è di circa 19.750.000 persone, di cui 125.000 appartengono ad altre razze. La maggior parte degli Italiani della Francia, della Svizzera e dell'Austria sono sul piano della razza Italiani settentrionali. Quelli della Corsica, isola appartenente alla Francia, sono Italiani meridionali.
Distribuzione degli Italiani (stima riferita al 1901)
In Europa:
Italia 33.200.000
Francia 350.000
Svizzera 200.000
Austria 650.000
Corsica 300.000
Altre parti d'Europa 300.000
Totale 35.000.000
Altrove:
Brasile 1.000.000
Rep. Argentina 620.000
Altre parti del Sudamerica 140.000
Stati Uniti 1.200.000
Africa 60.000
Totale 3.020.000
Totale nel mondo (cifra approssimata) 38.000.000
A partire dal 1900, in alcuni anni oltre mezzo milione di italiani è emigrato nelle diverse regioni del mondo. All'incirca la metà di tale flusso ha come destinazione altri paesi europei ed è di carattere temporaneo, in quanto riguarda sopratutto la popolazione maschile. Dal 1899 fino a tutto il 1910 negli Stati Uniti sono stati ammessi 2.284.601 immigrati italiani, ed è stata altresì consistente l'immigrazione italiana verso l'America del Sud. La maggior parte delle persone che giunge negli Stati Uniti rientra successivamente in patria. Tuttavia, soprattutto a New York e negli altri Stati dell'Est il numero di coloro che rimangono è elevato. Nel 1907 gli immigrati provenienti dall'Italia meridionale sono stati oltre 240.000, un numero più che doppio rispetto alla razza di immigrazione che come consistenza si colloca subito dopo quella degli immigrati italiani meridionali. Il numero degli arrivi di Italiani settentrionali è solo un quinto di tale cifra. La notevole capacità della razza italiana di popolare altre parti del mondo risulta evidente dal fatto che la presenza italiana supera numericamente quella degli Spagnoli nell'Argentina spagnola e dei Portoghesi in Brasile, nonostante quest'ultimo sia un paese "portoghese". (vedi Ispanoamericani). Attualmente, ai fini dello studio del fenomeno dell'immigrazione il flusso migratorio degli Italiani verso gli Stati Uniti è forse il più significativo, e non solo perché risulta essere molto più consistente di ogni altro gruppo nazionale in qualunque anno di riferimento e perché è elevata la percentuale degli Italiani per ogni mille immigranti che entra sul territorio degli Stati Uniti. Ancora più significativo è il fatto che questa razza è più numerosa di qualsiasi altra tra la decina di razze che figurano ai primi posti come tasso di immigrazione. In altre parole, in virtù di una popolazione di 35.000.000 e di un elevato tasso di natalità, questa razza continuerà a primeggiare anche quando la spinta delle altre razze, attualmente responsabili dell'ondata di immigrazione, tra cui gli Ebrei (8.000- 000[sic]), gli Slovacchi (2.250.000) e il gruppo Sloveno-Croato (3.600.000), sarà esaurita, come di fatto sta già avvenendo per gli Irlandesi. Un fatto non necessariamente noto è che nel decennio 1891-1900 l'Italia era il principale paese di origine dell'immigrazione in America. All'inizio degli anni ottanta, ovvero quasi trent'anni fa, l'Italia aveva già cominciato a guadagnare terreno rispetto ai paesi dell'Europa settentrionale. Tuttavia bisognava attendere il 1890 per vedere gli Stati Uniti sorpassare l'America meridionale come destinazione privilegiata dei flussi migratori provenienti dall'Italia. Nel decennio precedente e nei periodi antecedenti il Brasile ha accolto più italiani della Repubblica Argentina, sebbene si ritenga erroneamente che sia quest'ultima ad ospitare la più grande comunità italiana dell'America meridionale. Nel 1907 gli Stati Uniti hanno accolto 294.000 dei 415.000 Italiani emigrati oltreoceano. Nello stesso anno le persone emigrate, per lo più temporaneamente, dall'Italia verso altri paesi europei sono state 288.774. L'immigrazione italiana negli Stati Uniti è stata finora prevalentemente di carattere temporaneo. Mosso calcola che il periodo medio di permanenza degli Italiani negli Stati Uniti sia di otto anni. L'emigrazione più consistente verso oltreoceano dall'Italia ha la sua origine nelle regioni a sud di Roma, abitate dagli Italiani meridionali. Gli emigrati provengono soprattutto dalla Sicilia e dalla Calabria, ovvero dai territori meno produttivi e meno sviluppati del paese. L'emigrazione dalla Sardegna (Vedi) è scarsa. Il compartimento della Liguria, territorio di provenienza dei Genovesi, anch'essi appartenenti alla razza degli Italiani meridionali, registra più emigrazione di qualsiasi altra provincia dell'Italia settentrionale. Il flusso complessivo dell'immigrazione verso l'America da alcuni compartimenti italiani ha raggiunto proporzioni ingenti, al punto da superare più volte il tasso di crescita naturale della popolazione. Questo ha già causato il parziale spopolamento di alcuni distretti agricoli. Se confrontati con altre razze di immigrati e con il numero assoluto degli arrivi, gli Italiani meridionali sono i più numerosi: 1.911.933 nei dodici anni compresi tra il 1899 e il 1910, seguiti dagli Ebrei, 1.074.442, dai Polacchi, 949.064, dai Tedeschi, 754.375 e dagli Scandinavi, 586.306. I Settentrionali sono al nono posto nell'elenco relativo allo stesso periodo: 372.668, subito dopo gli Inglesi e gli Slovacchi, ma prima dei Magiari, dei Croati e degli Sloveni e dei Greci. Per quanto riguarda il tasso del movimento transatlantico, è piuttosto evidente un contrasto tra Settentrionali e Meridionali: ad esempio, nel 1905 l'emigrazione dalla Calabria è stata undici volte maggiore di quella proveniente dal Veneto. Nel 1907 l'indice dello spostamento dei Settentrionali verso gli Stati Uniti è stato di circa il 3 per 1000 della relativa popolazione presente in Italia, mentre quello degli Italiani meridionali è stato del 12 per 1000. L'indice di movimento dei Settentrionali è stato più o meno lo stesso di quello degli Svedesi e dei Finlandesi, è stato il triplo di quello dei Tedeschi, ma solo la metà di quello dei Ruteni provenienti dall'Austria-Ungheria. Il tasso di movimento dei Meridionali verso gli Stati Uniti, d'altra parte, è superato solo dal gruppo Croato-Sloveno, che nel 1907 è stato del 13 per mille della popolazione, e dagli Ebrei e dagli Slovacchi che, nello stesso anno, è stato del 18 per mille della popolazione. Gli immigrati italiani giungono negli Stati Uniti, oltre che dall'Italia, principalmente dai seguenti paesi: il Nordamerica britannico (3.800 nel 1907), l'Austria-Ungheria (1.500), il Regno Unito (600), il Sudamerica (600) e la Svizzera (200). Quelli provenienti dalla Svizzera e dall'Austria-Ungheria generalmente sono Settentrionali.
Nei dodici anni tra il 1899 e il 1910, le principali destinazioni negli Stati Uniti dei due gruppi di Italiani sono state le seguenti:
Settentrionali
New York 94.458
Pennsylvania 59.627
California 50.156
Illinois 33.525
Massachusetts 22.062
Connecticut 13.391
Michigan 13.355
New Jersey 12.013
Colorado 9.254
Meridionali
New York 898.655
Pennsylvania 369.573
Massachusetts 132.820
New Jersey 106.667
Illinois 77.724
Connecticut 64.530
Ohio 53.012
Louisiana 31.394
Rhode Island 30.182
West Virginia 23.865
Michigan 15.570
California 15.018
Una poesia per i pataccari di sinistra, scrive “L’Anarca” (Giampaolo Rossi ) su “Il Giornale”. I discepoli intellettuali del politically correct hanno l’abitudine di prendersi troppo sul serio; succede sopratutto quando si cimentano nel nobile mestiere dell’impegno sociale mettendo la loro fama e la loro arte a disposizione della lotta all’oscurantismo reazionario. È successo anche a Elio Germano, l’attore militante che ha realizzato il video-patacca contro il razzismo di cui abbiamo denunciato il falso in questo articolo di ieri. Il video si conclude con l’attore che legge, ad un gruppo di bambini Rom visibilmente annoiati e usati come scudi della sua vanità ideologica, una poesia di Trilussa in romanesco. Per non essere da meno, ho deciso di scrivere una poesia anche io, proprio nel dialetto di Trilussa, dedicandola a Elio Germano, ai maestrini radical-chic e alle loro false “verità assolute” diffuse come un virus. Un piccolo omaggio ironico all’abitudine pataccara della sinistra intellettuale e artistica di spargere scemenze spacciandole per verità.
L’ARTISTA DE SINISTRA
Il razzismo, se sa, è brutta robba.
È segno de incivile intolleranza tipica de chi ragiona co’ la panza.
Ma, di certo, ‘na cosa assai più brutta
è l’intellettuale quanno rutta.
Quanno se erge cor dito moralista
e come er Padreterno,
dei buoni e dei cattivi fa la lista.
Filosofo o scrittore, poeta o cantautore, attore o saltimbanco,
è come se la storia s’inchinasse all’astio livoroso e intelligente
de chi se crede sempre er più sapiente.
Spesso nun sa manco de che parla, ma parla per parla’
e per l’impegno preso e coltivato con lo sdegno
de chi è convinto che deve lascià un segno.
L’artista de sinistra in tracotanza,
dall’alto del suo ego trasformato,
diventa un drogato de arroganza.
Lui se convince de esse come un Faro,
invece, spesso, è solo un gran Cazzaro.
Con gli islamisti non si può dialogare. Un cosa è combattere militarmente il terrorismo per ragioni di sicurezza; un'altra è venire politicamente a patti con una teocrazia, scrive Piero Ostellino su “Il Giornale”. Rispetto al fondamentalismo islamico, e all'esigenza di conviverci senza danni per noi, alcuni studiosi americani suggeriscono che l'Occidente prenda ad esempio la propria storia degli ultimi cinquecento anni. Gli Asburgo, la maggior dinastia europea, «erano dei principi - scrive John M. Owen in Confronting political Islam, Six lessons from the West's Past - non dei preti». E si comportarono di conseguenza. Di fronte al radicalismo genericamente anticattolico del protestantesimo, non fecero di ogni erba un fascio, confondendo eretici estremisti ed eretici moderati e trattandoli allo stesso modo, ma constatarono che il protestantesimo era diviso fin dalla nascita in varie fazioni - luterani, calvinisti, anabattisti - e si acconciarono a sfruttarne le divisioni. Fu un grosso rischio? L'approccio non era meno rischioso di quello di fare la faccia feroce ad entrambi, ma ha funzionato. Parimenti, nel XX secolo, gli Stati Uniti dovettero fronteggiare la moderna sinistra politica, ostile alla democrazia liberale, al capitalismo e al libero mercato. Ma non la considerarono, e per lo più non la trattarono, come faceva la destra, come fosse un monolite, bensì utilizzarono ciò che divideva i socialisti dai comunisti. E hanno avuto la meglio sul comunismo. L'islamismo moderato - a differenza di quello fondamentalista, che ricorre volentieri alla violenza - utilizza i mezzi pacifici e legali della democrazia liberale per diffondere la sharia, la morale islamica. Non è liberale, ma rimane una teocrazia che ha fatto una scelta strategica contro la violenza. Ciò non significa, ovviamente, che l'Occidente possa, e debba, instaurare con esso «un dialogo», come suggeriscono certe nostre anime belle. La stessa storia della cooperazione fra gli Asburgo, cattolici, e i protestanti contro i calvinisti insegna che distinguere fra fondamentalisti e moderati non è sempre facile e, se può rivelarsi positivo nel breve termine, minaccia di essere fallimentare nel lungo. La prudenza non è mai troppa. Un cosa è combattere militarmente il terrorismo per ragioni di sicurezza; un'altra è venire politicamente a patti con una teocrazia; che, rispetto alla democrazia liberale, rimane pur sempre una soluzione clericale. Forse, c'è un altro esempio che l'Occidente dovrebbe seguire: quello di Edmund Burke, il liberal-conservatore che difese il diritto delle colonie americane di tassare i propri cittadini solo secondo i dettami delle proprie assemblee e non secondo quelli del Parlamento di Londra. «I vostri affari - aveva scritto Burke ai suoi amici francesi a proposito della Rivoluzione del 1789 - riguardano voi soli; noi ce ne siamo occupati come uomini, ma ce ne teniamo alla larga perché non siamo cittadini della Francia». È il linguaggio che, auspicabilmente, l'Occidente dovrebbe usare nei confronti dell'islamismo...
Niente paura, leggete il Corano. Ci troverete le radici del Male. Per 56 anni ho creduto che l'islam potesse essere riformabile grazie a musulmani moderati come me. Mi sbagliavo. Il libro sacro è la negazione della civiltà, scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. «Allah Akhbar! Allah Akhbar! Ash-hadu an-la ilaha illa Allah, Ash-hadu anna Muhammad-Rasul Allah». «Allah è Grande! Allah è Grande! Testimonio che non c'è altro dio all'infuori di Allah, Testimonio che Maometto è il Messaggero di Allah». Per vent'anni la mia giornata è stata cadenzata dall'adhan, l'appello alla preghiera diffuso dall'alto dei minareti nella mia città natale, Il Cairo, ribattezzata la «Città dai mille minareti». Per 56 anni mi sono impegnato più di altri, da musulmano moderato, ad affermare un «islam moderato» in Italia, aderendo e sostenendo sostanzialmente la tesi del Corano «creato», che per l'ortodossia islamica pecca ahimè di una fragilità teologica che scade nell'eresia. Perché così come il cristianesimo è la religione del Dio che si è fatto Uomo e che s'incarna in Gesù, l'islam è la religione del loro dio Allah che si è fatto testo e che si «incarta» nel Corano dopo essere stato rivelato a Maometto attraverso l'Arcangelo Gabriele. Per i musulmani quindi il Corano è Allah stesso, è della stessa sostanza di Allah, opera increata al pari di Allah, a cui ci si sottomette e che non si può interpretare perché si metterebbe in discussione Allah stesso. Per contro, la tesi del Corano «creato», che sottintende che solo Allah è increato, consente l'uso della ragione per entrare nel merito dei contenuti del Corano, che possono essere oggetto di culto da parte della fede ma anche oggetto di valutazione e critica; così come consente la contestualizzazione nel tempo e nello spazio dei versetti rivelati per distinguere ciò che è da considerarsi attuale e lecito da ciò che è invece è da ritenersi prescritto e caduco; ci mette in ultima istanza nella possibilità di poter affermare la dimensione «plurale» dell'islam e, in questo contesto di pluralismo, ci consente di far primeggiare la scelta dell'«islam moderato» che concili la prescrizione coranica con il rispetto dei valori fondanti della nostra comune umanità. Per 56 anni ho scelto di battermi in prima persona, costi quel che costi, per affermare la bontà del Corano quale testo sacro dell'islam pur nella denuncia del terrorismo islamico. Nel 2003, dopo aver conosciuto Oriana Fallaci ed aver instaurato con lei un rapporto che, al di là della reciproca stima professionale, della condivisione della denuncia del terrorismo islamico e della pavidità dell'Occidente, si fondava su un affetto sincero e una solida amicizia, tuttavia il nostro rapporto fu turbato dal mio rifiuto di abbandonare l'islam e di concepire che la radice dell'islam risieda nel Corano. Mi sentivo contrariato quando scriveva: «L'islam è il Corano, cari miei. Comunque e dovunque. E il Corano è incompatibile con la Libertà, è incompatibile con la Democrazia, è incompatibile con i Diritti Umani. È incompatibile col concetto di civiltà». Eppure, all'indomani della mia conversione al cristianesimo il 22 marzo 2008, ho scritto: «Ho dovuto prendere atto che, al di là della contingenza che registra il sopravvento del fenomeno degli estremisti e del terrorismo islamico a livello mondiale, la radice del male è insita in un islam che è fisiologicamente violento e storicamente conflittuale». L'errore in cui incorsi fu di immaginare che l'islam potesse essere riformabile al suo interno grazie all'impegno dei musulmani moderati. Alla fine, dopo oltre cinque anni trascorsi da condannato a morte dai terroristi islamici e reiteratamente minacciato dagli estremisti islamici, mi sono arreso di fronte all'evidenza: si può essere musulmani moderati come persone, ma non esiste un islam moderato come religione. Oggi più che mai dobbiamo avere l'acume intellettuale e il coraggio umano di leggere ad alta voce il Corano e di affermare pubblicamente i suoi contenuti. Non possiamo essere vittime, da un lato, dei musulmani moderati che difendono aprioristicamente e acriticamente l'islam pur di salvaguardare la loro credibilità ed onorabilità, dall'altro, degli occidentali che per paura di offendere i musulmani sostengono in modo altrettanto aprioristico e acritico che il Corano insegna l'amore e la pace, che i terroristi islamici non centrano nulla con l'islam. Solo leggendo il Corano scopriamo la specificità di una religione che condanna di eresia l'ebraismo e il cristianesimo; la realtà di Allah che era il dio supremo del Pantheon politeista arabo, clemente e misericordioso con chi si sottomette all'islam ma vendicativo e violento con i miscredenti; la verità di Maometto che è stato un guerriero vittorioso che ha fondato una «Nazione di credenti» combattendo e uccidendo i suoi nemici per ordine di Allah. Solo leggendo il Corano potremo capire le radici di un'ideologia che legittima l'odio, la violenza e la morte, che ispira il terrorismo islamico ma anche la dissimulazione praticata dai «musulmani moderati», perseguendo il comune obiettivo di sottomettere l'intera umanità all'islam, che è fisiologicamente incompatibile con la nostra civiltà laica e liberale negando la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta. Solo leggendo il Corano potremo capire chi siamo veramente noi, se siamo ancora o non più in grado di riscattare la civiltà di verità e libertà, di fede e ragione, di valori e regole. L'Italia non ha subito gravi attacchi dal terrorismo islamista, ma non può considerarsi al sicuro se si tiene conto che da anni diversi imam predicano odio, dozzine di centri islamici sono impegnati nel proselitismo e nel finanziamento a gruppi terroristici e che il Paese sta esportando combattenti nei teatri della jihad. Lo rileva un rapporto del Centro militare di studi strategici del ministero della Difesa. La comunità islamica italiana è composta da 1,6 milioni di persone, un terzo degli stranieri presenti, cui si aggiungono 60-70mila convertiti. Sono una ventina le organizzazioni principali, più di 100 le moschee, 159 i centri islamici, decine le scuole coraniche, tanti i siti internet. Secondo il dossier, «la radicalizzazione della comunità islamica rappresenta una potenziale seria minaccia». Dal 2001 ad oggi, circa 200 persone sono state arrestate con l'accusa di terrorismo. Milano è l'epicentro del radicalismo islamico in Italia.
MILANO: DA CAPITALE MORALE A CAPITALE DEL CAZO.
Milano si è riappropriata "del ruolo di capitale morale del Paese, mentre Roma sta dimostrando di non avere quegli anticorpi di cui ha bisogno e che tutti auspichiamo possa avere". Lo ha detto il presidente dell'Autorità Nazionale anti corruzione, Raffaele Cantone, ricevendo dalle mani del sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, il Sigillo della Città. Alla cerimonia di consegna del 28 ottobre 2015 hanno partecipato anche il prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca, e il procuratore Edmondo Bruti Liberati. “Modello Expo difficile da esportare a Roma” - Per il presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, inoltre, il modello realizzato per Expo a Milano, caratterizzato da "profonda sinergia istituzionale è difficilmente esportabile senza questa sinergia. Stiamo cercando di esportarlo a Roma ma a Roma è questo che manca". E ha continuato: "Ho incontrato difficoltà, in parte superate anche con l'impegno perché il Comune di Roma non è fatto solo dei soggetti di Mafia Capitale, ma è fatto di moltissime persone per bene. Il problema è trovare una squadra che funzioni. Nell'Amministrazione abbiamo trovato punti di riferimento importanti, anche nel Comune, ma la sinergia che si è verificata a Milano è difficile da esportare come modello. L'idea di lavorare tutti con lo stesso obiettivo, pur nel rispetto della divisione dei ruoli, non è sempre facile da esportare in altre realtà". "Le mie parole non sono critiche" - Cantone, dopo le polemiche seguite al suo intervento, ha poi voluto precisare che le sue parole non "sono critiche a Roma ma un pungolo" per stimolare l'idea che si formi anche nella Capitale un modello di sinergia istituzionale".
Ho dovuto risentirlo più volte...non potevo crederci..., "Milano è Capitale morale" lo ha detto Cantone e fra i presenti, (non posso smettere di ridere), c'era Bruti Liberati, il Procuratore denunciato per irregolarità nell'assegnazione di fascicoli sulla corruzione nella Pubblica amministrazione…..
Quanto gli italiani hanno la memoria corta....
Dopo Roma tocca a Milano: è una nuova Tangentopoli, scrive Marco Scotti su “Il Ghirlandaio” il 14 ottobre 2015. Mentre l’eco delle dimissioni della giunta Marino, di Mafia Capitale e degli altri scandali che hanno scosso Roma durante l’estate non accenna ad attenuarsi, scoppia un nuovo caso di corruzione, questa volta a Milano. Così, la storica dicotomia tra capitale morale e capitale reale, tra sole e nebbia, tra romani e milanesi, trova un punto d’unione e di contatto di cui è bene non andare troppo fieri: la corruzione. Il caso è quello di Mario Mantovani, già assessore alla sanità della Regione Lombardia e oggi vicepresidente della giunta guidata da Roberto Maroni. L’accusa mossa nei confronti di Mantovani, che è stato arrestato nella giornata di ieri, è di corruzione e concussione per faccende relative alla sanità, compresa una gara sul trasporto dei dializzati. Ogni condizionale è d’obbligo, e ci mancherebbe, anche perché siamo ancora in una fase preliminare delle indagini. Ironia della sorte, oggi l’ex assessore alla sanità avrebbe dovuto presenziare a una giornata sulla legalità. Impegno, ovviamente, annullato, visto che per lui sono scattate le manette. Il vero problema per la giunta di Maroni, però, non è rappresentato dall’arresto di Mantovani, ma dalle conseguenze che questo ennesimo scandalo potrebbe avere. Se, infatti, non è difficile dimostrare lo scarso coinvolgimento di Regione Lombardia nella vicenda – d’altronde Maroni aveva rimosso Mantovani dal suo incarico – è più complicata la posizione di Massimo Garavaglia, assessore all’economia della giunta e uomo forte di Maroni. Per lui la procura di Milano ipotizza il reato di turbativa d’asta. Le carte dell'inchiesta lo accusano, insieme a Mantovani, di aver agito per turbare la gara "per l'affidamento del servizio di soggetti nefropatici sottoposti al trattamento dialitico". Una bella gatta da pelare. Anche perché Garavaglia, al contrario di Mantovani, continua a essere un pezzo da 90 all’interno della giunta lombarda, che Maroni guida da due anni e mezzo. Che fare ora? Perfino tra i fedelissimi dell’ex ministro dell’Interno c’è chi chiede a gran voce un corposo rimpasto della giunta che permetta di spazzare via ogni dubbio di legittimità. Perché, ricordano sempre i fedelissimi, per molto meno “saltò per aria” la giunta guidata da Roberto Formigoni, padre padrone del Pirellone per quattro mandati consecutivi. Sembra che Milano, dopo la serenità ritrovata grazie all’Expo (concluso a tempo di record dopo le infiltrazioni della criminalità organizzata che avevano obbligato l’Anac di Cantone a prendere il controllo della situazione) stia ripiombando in un nuovo incubo da cui non ci si riesce a svegliare: Tangentopoli. Che ha perso – se mai l’ha avuto – ogni connotato folcloristico (da Paolo Brosio davanti a Palazzo di Giustizia al linguaggio di Di Pietro) ma ha mantenuto quei tratti inquietanti che rendono la corruzione un cancro difficile da estirpare. Perché quando si pensa di aver ottenuto un risultato confortante, torna, sotto forme diverse e con differenti peculiarità. Gli anni ‘80 e ’90, caratterizzati da un Partito Socialista che poco aveva a che fare con il nome che portava, sono un ricordo lontano, così come lo sono la Milano da bere e le invettive di Craxi in Parlamento. Eppure rimane lo stesso retrogusto amaro quando ci si imbatte in fenomeni di questo tipo, quando l’appetito predatorio di una classe politica, che non ha ancora completato la transizione verso la Terza Repubblica, è lo specchio palese della sua inadeguatezza. L’Italia non è certo l’unico paese in cui la corruzione esista e sia diffusa. Ma i dati relativi ai costi sociali di questo fenomeno restituiscono una fotografia impietosa, in cui il nostro paese è agli ultimi posti, in Europa e tra i paesi del “primo mondo”, nelle speciali classifiche redatte periodicamente. La stima ufficiosa è che ogni anno la corruzione costi al nostro paese 60 miliardi di euro. Ma c’è chi, come il professor Alberto Vannucci dell’università di Pisa, considera questa stima sballata, ma al ribasso. Perché secondo la Corte dei Conti, la corruzione genera un costo superiore del 40% per appalti e forniture di servizi rispetto alla media europea. Calcolatrice alla mano, si tratta di circa 100 miliardi di euro. All’anno. Un fenomeno, quindi, che entra prepotentemente nel tessuto economico italiano, inquinando la possibilità del nostro paese di avere conti in ordine e maggiori posti di lavoro. Che si tratti di piccole commesse o di opere pubbliche di valore strategico, rimane un costo, interamente a carico della collettività, che non è più sostenibile. Anche perché genera un circolo vizioso da cui è difficile, se non impossibile, uscire. E la credibilità del nostro paese? Minata dalle fondamenta, con gli investitori stranieri che vengono letteralmente messi in fuga da almeno tre fattori: burocrazia, nessuna certezza del diritto e corruzione. Il primo fenomeno si manifesta in un apparato elefantiaco che rende difficile anche ciò che potrebbe essere semplicissimo; il secondo nelle norme che continuano a cambiare. La corruzione, soprattutto all’estero, è un fenomeno difficilmente comprensibile e intollerabile. Ma allora come si esce da questo “eterno ritorno” di Tangentopoli? Affidandosi a persone di valore, come Raffaele Cantone e la sua Anac, e cercando di migliorare progressivamente una classe politica che deve incarnare, una volta per tutte, quegli “aristoi” di antica memoria. L’Italia, e gli italiani, si meritano tutto questo.
Milano, capitale morale è solamente un ricordo, scrive "Blasting News". Milano, ex capitale morale d’Italia, ormai ha perso questo primato e la redenzione giunta dopo la Tangentopoli del 1992 è solo un lontano ricordo. Gli scandali si susseguono e si fa persino fatica a seguirli tutti. Un dato è certo, i beni pubblici lombardi sono gestiti spesso male, quando non oggetto di veri e propri abusi o frodi. Ultimo scandalo in ordine di tempo, è quello che ieri ha coinvolto il management di Ferrovie Nord. Ma ripercorriamo le tappe degli scandali più significativi che hanno colpito Milano in questi ultimi mesi.
TRENORD – i pendolari sono costretti a tour de force per essere puntuali tra continui ritardi e/o blocchi di treni e i manager di TRENORD si occupano di altro e sono sotto l’attenzione della Procura di Milano con l’accusa di peculato. Questa è l’ipotesi di reato rivolta ai vertici dell’azienda in un blitz eseguito il 10 marzo presso gli uffici della società. La Repubblica descrive l’irruzione dei Carabinieri di ieri. Sono stati sequestrati note spese di dirigenti e sono al vaglio degli inquirenti tutte le spese sostenute con carte di credito aziendali. Si va dal pagamento di ristoranti, agli hotel, ai cellulari, al pagamento di multe. In particolare, per le multe sono stati spesi da TRENORD 120 mila, e una buona parte sono riconducibili a multe prese da familiari di dirigenti, quindi poco o nulla hanno a che fare con l’azienda. Seguiremo l’evolversi della vicenda che ha una sola nota positiva: la denuncia dei fatti è partita dall’interno dell’azienda verso la Procura.
ALER – la società che gestisce le Case Popolari a Milano e in Lombardia è ormai da anni travolta dagli scandali, senza che nessuno riesca ad intervenire. Il Fatto Quotidiano in un articolo del 09 Marzo elenca le storture “mostruose” nella gestione dell’azienda che con la costruzione di vere e proprie scatole societarie ha distribuito finanziamenti pubblici perdendone il controllo. Il buco nel bilancio di ALER è di 500 Milioni di Euro. E con questi numeri, ALER si prende il lusso nel 2014, in barba a qualsiasi controllo o verifica, di assumere 40 custodi con contratti a tempo determinato di 88 anni.
EXPO – un blitz della Procura di Milano eseguito l’08 maggio 2014 dalla Guardia di Finanza e dalla DIA porta alla luce un vera e propria cupola degli appalti. Finiscono agli arresti il Direttore Generale di EXPO Angelo Paris e con lui altri 6 manager, tutti con importanti ruoli nel Progetto. L’organizzazione capitanata da Paris aveva contatti politici importanti e pilotava gli appalti Expo verso società che pagavano tangenti o che, addirittura, erano in odore di mafia. L’inchiesta su EXPO nasce da una costola dell’inchiesta Infinito sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia.
Inchieste giudiziarie, Roma e Milano a confronto. La giunta Pisapia è rimasta indenne, ma in Regione ci sono ancora guai. L’arrivo di Pignatone ha scoperchiato il marcio nella Capitale. A Milano sono serviti 23 anni per recuperare il titolo di «capitale morale d’Italia», perso nel 1992 con lo scandalo di Tangentopoli, scrivono Paolo Colonnello e Francesco Grignetti su “la Stampa” il 29 ottobre 2015. «Piena e totale fiducia nella magistratura» non è mai stata una frase di rito. Non per Giuliano Pisapia, avvocato penalista di fama prima ancora che sindaco di una città che stando alle dichiarazioni del presidente dell’anticorruzione Cantone si è riconquistata i galloni di «capitale morale d’Italia», primato perduto nel febbraio del 1992 quando esplose «Mani Pulite» che rivelò l’esistenza di una città dedita alle tangenti: per recuperare terreno c’è voluta una rincorsa durata 23 anni. Un’altra epoca, se si pensa che persino gli ultimi recentissimi scandali di Milano, l’arresto di quattro funzionari legati al settore dell’edilizia pubblica - uno dei quali trovato con dei lingotti d’oro nascosti in casa, un altro invece ripagato con un I-pad - riguardano funzionari e dirigenti nominati dalla precedente giunta, quella di Letizia Moratti. Così come quell’Antonio Acerbo, ex megadirigente comunale diventato poi subcommissario di Expo, condannato a tre anni (patteggiati) e a un risarcimento di 100 mila euro per aver pilotato gli appalti sulle Vie d’Acqua, progetto mai compiuto e dimenticato nella grande ubriacatura dovuta al successo dell’Esposizione Universale. Che pure ha relegato nell’oblio scandali e scandaletti nati dalla fretta necessaria per concludere le opere di Expo, riassunti nella formula della cosiddetta «cupola degli appalti», per ora ferma ai quattro pensionati della tangente (capitanati da Frigerio, Grillo e Greganti) e ad alcuni imprenditori, dalla Maltauro alla Mantovani, coinvolti in una più vasta ragnatela che passa dal Mose di Venezia alla costruzione di Palazzo Italia. In tutto ciò la giunta di Pisapia, in carica da quattro anni, è riuscita a passare indenne, tranne per l’ombra della vendita Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, ceduta in buona parte dal Comune di Milano al fondo gestito dal manager Vito Gamberale per un totale di 385 milioni di euro. Vicenda che fu anche alla base della dura battaglia tra il procuratore Edmondo Bruti Liberati e l’allora suo aggiunto Alfredo Robledo. «Ombra» spazzata via da una sentenza di proscioglimento per Gamberale che escluse accordi irregolari per truccare la gara. Ben altra musica si è respirata invece nella Regione governata prima da Roberto Formigoni, travolto dallo scandalo sui rimborsi per la sanità, e poi dal leghista Roberto Maroni, coinvolto nella vicenda delle raccomandazioni di due collaboratrici. Per finire con l’arresto recentissimo dell’ex vicepresidente della Regione, Mario Mantovani, il «Faraone» di Arconate.
L’infezione e la cura. I poteri marci che frenano la risalita della Capitale, scrive Mario Ajello su “Il Messaggero”. Paragonando Roma a Milano, e ad altri centri minori, Camillo Benso di Cavour era convinto che «Roma è la sola città d’Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali». E insisteva nei suoi discorsi parlamentari della primavera del 1861: «In Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali che devono farne la naturale capitale di un grande Stato». Mettere in dubbio una realtà come questa, espressa oltretutto da una delle menti più raffinate e lungimiranti che l’Italia abbia avuto, è storicamente complicato. E sembra anche poco opportuno riproporre il tema tradizionalissimo del dualismo tra Roma e Milano, in una fase così delicata per entrambe. Nessuno può meritarsi la patente di «capitale morale», che ora Raffaele Cantone attribuisce a Milano mentre Roma «sta dimostrando di non avere gli anticorpi di cui ha bisogno». E sicuramente questo attestato di superiorità etica non lo si può attribuire alla metropoli lombarda, anche se proviene da un personaggio autorevole come il presidente dell’Autorità anti-corruzione. Perchè dai tempi della «Milano degli scandali» e di Tangentopoli, fino alla recente inchiesta con tanto di arresti sulle tangenti e le raccomandazioni nella sanità, passando dalle vicende di Formigoni, dalle infiltrazioni della ’ndrangheta padrona, dalle storie del San Raffaele e dalle mazzette delle Ferrovie Nord e da tante altre smentite plateali della virtuosità della politica meneghina, questa città ha mostrato un «lato oscuro».
Milano capitale morale? Ma di che? Le parole di Raffaele Cantone possono essere interpretate come uno sprone a non lasciare l'Italia preda dei signori della mazzetta. Ma non sono purtroppo giustificate dalla storia recente delle grandi opere dell'Expo 2015, scrive Ciro Pellegrino su Fan Page”. "Non esiste alcun sistema preventivo sicuro per la corruzione: a volte appalti perfetti celano fenomeni di corruzione. Non ho nessuna sicurezza che i nostri controlli impediscano la corruzione, la rendono sicuramente più difficile". Così parlava Raffaele Cantone ed era giusto un anno fa, in audizione davanti alla Commissione Antimafia. Oggi evidentemente il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, folgorato sulla via dei Navigli non la pensa ugualmente. Milano "si riappropria del ruolo di capitale morale d'Italia" dice il magistrato campano, contrapponendola a Roma che invece "non ha anticorpi". Da un uomo della statura morale di Raffaele Cantone accettiamo questa dichiarazione ritenendola come uno sprone a non arrendersi, a non lasciare il Paese nelle mani dei predoni degli appalti, degli sciacalli della Pubblica amministrazione, degli avvoltoi della spesa pubblica le opere, le speranze e i sogni del Paese. Tuttavia non possiamo non ricordare che nemmeno un anno fa lo stesso Cantone implorava il commissariamento delle gare d'appalto delle architetture di servizio di Expo 2015 (luglio 2015), che denunciava la mancanza di un sistema di controllo sui padiglioni stranieri dell'Esposizione Universale (ottobre 2015). Non vorremmo ricordare, poi, il caso delle Vie d'acqua e di Primo Greganti e la raffica di interdittive antimafia per aziende in odore di ‘ndrangheta. Dunque di quale capitale morale stiamo parlando? Della città che faticosamente, con l'ausilio di strumenti straordinari e tuttavia troppo tardi, è riuscita ad arginare le fameliche formiche degli appalti? Non certo dei campioni d'onestà da fiction di Raiuno. All'ombra del Duomo non c'è un clima da Suburra, siamo d'accordo. Ma solo perché i protagonisti di questo romanzo criminale girano invisibili tra capitolati d'appalto e ricorsi al Tar.
Sicuri che Milano sia la Capitale morale?
Per Cantone la città di Expo batte Roma. Ma tra scandali, mazzette e infiltrazioni..., scrive Francesca Buonfiglioli su “Lettera 43”. Cecati e mondo di mezzo, mazzette che filano una via l'altra come «ciliegie» o «antidolorifici», funerali sfacciati con elicotteri che gettano petali di rosa, sparatorie in periferia che sanno tanto di regolamenti di conti. Roma come Suburra. Peggio di Suburra. Seicento chilometri più a Nord, a Milano, invece non si parla che del successo di Expo: file infinite ai tornelli e attese di 9 ore ai padiglioni. Una città rinata, che ha ritrovato - almeno così si legge - il suo respiro da metropoli europea. Dopo la Milano da bere, ecco la Milano da esporre. Basta dire che se a Roma la candidatura a sindaco - sempre che Ignazio Marino confermi le dimissioni - suona come una roulette russa, a Milano c'è la fila per raccogliere l'eredità di Giuliano Pisapia con tanto di azzuffatine pre-primarie. Sarà anche per questo che Raffaele Cantone,presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione, ricevendo dalle mani del primo cittadino ambrosiano il Sigillo della città ha sentenziato: «Milano si è riappropriata del ruolo di capitale morale del Paese, mentre Roma sta dimostrando di non avere quegli anticorpi di cui ha bisogno e che tutti auspichiamo possa avere». Con buona pace delle inchieste sugli appalti dell'esposizione universale, sulle infiltrazioni della 'ndrangheta all'ombra della Madonnina e su quelle della Regione Lombardia, il cui ex presidente Roberto Formigoni è a giudizio per associazione per delinquere e corruzione e l'attuale, Roberto Maroni, è a processo per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e induzione indebita per presunte pressioni per far ottenere un lavoro e un viaggio a Tokyo a 2 ex collaboratrici. Ma si sa, «gli italiani hanno la memoria corta», dice a Lettera43.it Francesco Calderoni, docente di Sociologia della devianza e ricercatore di Transcrime, il Centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale della Cattolica. E aggiunge semiserio: «Cantone avrà voluto omaggiare la città e il sindaco che lo stava premiando...». La criminalità e lo spread tra Roma a Milano. Al di là dei convenevoli, sul primato morale di Milano «bisognerebbe andare cauti», continua Calderoni: «Da Tangentopoli in poi non ci siamo fatti mancare proprio nulla in materia di vicende corruttive». Anche se le differenze con Roma ci sono. «Vanno analizzate le strategie di indagine delle Procure», sottolinea il docente. A Milano, è il ragionamento, i fenomeni sono stati tenuti distinti: si è parlato di tangenti Expo, o allargando l'obbiettivo a tutto il Nord, di scandali Mose o Aemilia. «Nessuno ha abusato del termine 'mafia'». Anche se sono state scoperte collusioni tra criminalità, economia e politica. A Roma, invece, c'è la tendenza ad affibbiare «etichette», come accadde con la P3. Per cui l'associazione a delinquere condita da elementi mafiosi come l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà viene semplificata con la definizione «mafia Capitale». Dimenticando, precisa Calderoni, «che tutto quello che abbiamo letto sui giornali finora non è che l'ipotesi d'accusa. Non è ancora stata convalidata da un giudice, e per il Gip è sufficiente avere un sospetto». Poi è innegabile che da quando Giuseppe Pignatone è arrivato con i suoi uomini a Roma, la procura capitolina da "Porto delle nebbie" «si è trasformata in un bastione dell'antimafia». E a Milano? «Si è parlato di mafia e 'ndrangheta al Nord, di infiltrazioni. Con più cautela». Una questione di stile? Questione di stile. «A Roma si spara ancora per strada», spiega il professore. «Ci sono i figli e i nipoti della Magliana o le famiglie campane che risalgono la costa tirrenica fino alla Capitale». Il loro controllo sulla città è sfacciato, alla luce del sole. Sintomo di come questi gruppi abbiano preso possesso e controllo del territorio. A Milano la criminalità c'è, ma è nascosta. Fa affari, non spara. Non ci sono i Casamonica con la loro allure folk e cafona. Almeno non in città. Anche perché la «Capitale morale» in confronto a Roma non è che un paesone. «Per un confronto attendibile, bisogna considerare l'intera provincia di Milano: i Buccinasco, i Quarto Oggiaro, i Desio e i Corsico». E la prospettiva allora cambia. Ma lo spread tra Roma e Milano non è solo una questione di dimensioni. La 'ndrangheta e la camorra al Nord «sono più sottotono», conferma Calderoni. «Nel tempo hanno strangolato i piccoli centri dell'hinterland. Ma la reazione c'è stata. L'operazione Infinito partita nel 2003 ha portato all'arresto di quasi 200 persone scoperchiando l'infiltrazione delle cosche calabresi al Nord». Segno che il sistema giustizia è stato efficiente. Quanto a dimensione corruttiva, le cose non cambiano molto lungo quei 600 chilometri. Se nella Capitale ha casa il potere - ci sono il parlamento, i ministeri, le sedi delle società partecipate - a Milano ci sono gli appalti, come hanno dimostrato le recenti inchieste su Expo, Sanità e Regione. Caratteristiche che attirano gli appetiti criminali e sono un humus perfetto per la mazzetta. Ma le notizie passano e gli scandali si archiviano. «Fino a ieri l'Esposizione era la madre di tutti i mali», fa notare Calderoni. «Giuseppe Sala fu addirittura accusato di avere diffuso dati falsi sugli ingressi in Consiglio comunale. E ora?». E ora si parla di sistema Expo da esportare in tutta Italia e molti, Matteo Renzi compreso, vorrebbero il commissario a Palazzo Marino. A questo punto, come nei film da botteghino sugli stereotipi settentrionali e meridionali, si potrebbe fare un esperimento. «Spostare qualche ministero» nella integerrima Lombardia, conclude Calderoni, avverando così il sogno leghista che naufragò nelle sale deserte della Villa Reale di Monza. E chissà, magari a quel punto spunterebbe pure una Mafia del panettone.
LA CAPITALE MORALE? NON ESISTE. L'arresto di Mario Mantovani e di altri esponenti politici della Regione Lombardia confermerebbe ancora una volta, nel caso le ipotesi dei magistrati risultassero fondate, che non esistono differenze etiche tra Milano e Roma, scrive Francesco Anfossi su "Famiglia Cristiana”. Dopo lo shock di Mafia Capitale e le polemiche successive alle dimissioni del sindaco di Ignazio Marino c'è chi ha parlato di due capitali, una politica e l'altra morale, contrapponendo Roma a Milano. La metropoli dove scorrono fiumi di denaro, del "mondo di mezzo" dove si incontrano faccendieri, criminali e politici del sottobosco contrapposta alla capitale europea onesta e laboriosa, vagamente calvinista, persino giacobina e ossessionata dalla legalità. In realtà questa differenza non esiste. E se le ipotesi di reato venissero confermate, la vicenda legata a Mario Mantovani, il vicepresidente della Regione Lombardia arrestato nell'ambito di un'inchiesta che contempla le ipotesi di concussione, corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti, non farebbero che confermare l'equivoco. Si è detto giustamente che Mantovani si sarebbe dovuto fermare prima, dato che questo formidabile accumulatore di cariche pubbliche (senatore, sindaco di una cittadina del milanese, sottosegretario alle Infrastrutture,assessore, plenipotenziario lombardo di Forza Italia) è il fondatore di una cooperativa che si occupa di residenze per anziani, molte delle quali convenzionate con la Regione. Come è stato possibile che gli venisse assegnato l'assessorato alla Sanità? Il re delle case di riposo era in evidente conflitto di interessi, anche se dal punto di vista legale la cosa era possibile. Ma una politica che si vanta di governare la capitale morale del Paese e la Regione più progredita del Paese non può avallare incarichi del genere. Al di là degli esiti processuali (perché bisogna essere sempre garantisti e avere rispetto per chi viene privato della libertà e non convocare sprezzanti conferenze stampa con le arance da portare a San Vittore sul tavolo, come hanno fatto i Cinque Stelle) avrebbe dovuto essere la politica a fermare un passo prima Mantovani, e non la Procura. Qualcuno ribatte che la superiorità di Milano sta proprio nel saper scoperchiare le malefatte della politica, da Tangentopoli in poi. Ma tutto questo non è sufficiente a incoronare una metropoli capitale morale. Anche perché a ben vedere è stata Roma che ha fatto progressi in questo senso, attraverso una Procura che da "porto delle nebbie" si è trasformata in uno degli uffici giudiziari più efficienti e coraggiosi, senza più alcun timore reverenziale. Il problema, come si ripete fino alla nausea negli inutili talk show è "politico".
Da capitale morale a Capital del cazo e viceversa (si spera), scrive Daria Bignardi su “Vanity Fair”. Nel 1992 ero a Siviglia per scrivere dell’Expo, per Panorama. Ricordo ancora il mattino in cui lessi sul País: «Milano se muestra como la capital del cazo». Il termine cazo in spagnolo si usa anche per «corruzione»: era cominciata Mani pulite, e io, che vivevo a Milano da otto anni ed ero tra quelli cui la cosiddetta Milano da bere faceva venire l’afta epizootica, l’avevo trovata un’assonanza esilarante: «Sì, proprio la capital del cazo! Pareva anche a me». In quegli anni, se non eri yuppie dentro, a Milano non ti sentivi a tuo agio. Hanno un bel dire gli amici del folle che la settimana scorsa ha ucciso tre persone al Palazzo di giustizia che allora «si stava bene, girava il grano, passavamo da un locale all’altro», come ha riportato il Corriere: quel che ricordo io è soprattutto un clima sovraeccitato e superficiale, e quel che ribolliva sotto la superficie patinata lo abbiamo appreso con l’inchiesta Mani pulite. Come ha scritto spicciamente ma efficacemente Beppe Severgnini: «Gli anni Ottanta avevano trasformato la corruzione da episodio patologico a normalità fisiologica, che manteneva la politica, arricchiva i politici, appesantiva la spesa pubblica. Un gruppo di magistrati di Milano intervenne, mescolando senso civico e protagonismo: così nacque Mani pulite. Bossi e la Lega la cavalcarono e all’inizio la protessero. Silvio Berlusconi, perduto l’appoggio dei socialisti plurinquisiti, si spaventò, si mise in proprio e fondò Forza Italia. Il resto, più o meno, lo sappiamo». La serie 1992 di Sky in onda in queste settimane è un irresistibile fumettone che, superata la delusione per il fatto che non abbia nulla a che vedere con lo stile di Gomorra, si fa guardare con gusto per diversi motivi. Il primo è la vicenda storica: come è noto la cosiddetta Tangentopoli ha segnato la fine della Prima repubblica. Il Palazzo di giustizia di Milano, che purtroppo abbiamo appena rivisto nei Tg, è stato per mesi il teatro della prima grande inchiesta su corruzione, concussione e finanziamenti illeciti ai partiti. Sono passati più di vent’anni ma non abbiamo ancora capito fino in fondo cosa abbia significato l’inchiesta Mani pulite per la nostra storia: rivedere i fatti di quel periodo, per quanto romanzati in una serie televisiva, non può che indurre riflessioni interessanti in chi allora c’era e soprattutto in chi non c’era. Tutto è meglio dell’oblio, anche il rendersi conto che non è cambiato poi molto. Un altro buon motivo per seguire 1992 è che contiene quel mix di interpretazioni riuscite, come quelle di Antonio Di Pietro, Luca Pastore e molti altri personaggi veri o immaginari, e altre imbarazzanti, che lo fanno guardare anche per ridere alle spalle di alcuni interpreti, come accade in tutte le serie più popolari. Poi c’è Miriam Leone, tanto carina e audace che da sola credo sia per molti un buon motivo per non perdersi una puntata. E poi c’è Milano, che nel bene e nel male non è mai stata centrale come in questo periodo. Dall’Expo, per cui ormai contiamo i giorni, alla figura del prossimo sindaco, che incuriosisce e preoccupa in egual misura, al profilo della città che cambia ogni giorno: anche i più pessimisti non possono non essere curiosi e stimolati – magari preoccupati o mortificati per fatti come quello appena accaduto al Palazzo di giustizia, che però poteva accadere, ed è accaduto, in qualunque altro posto – dal futuro prossimo di Milano. Da capitale morale a capital del cazo e ritorno, o almeno si spera.
Dal 1881 ad oggi l'Expo ripropone il mito di Milano capitale "morale", scrive Roberto Cicala su “La Repubblica”. «Un nodo scorsoio» stringe l'anima di Milano, secondo Testori, tra lavoro, affari e ricerca di dignità e sentimenti. Così uno dei figli di questa «città sconciata epperò bellissima» descriveva ieri le contraddittorie potenzialità che oggi l'Expo ripropone e ingigantisce. Viene da chiedersi quanto l'occasione espositiva favorirà una riflessione sull'identità della "capitale morale", definizione resuscitata dopo il successo su Smirne e covata fin dalla stagione dei lumi intorno al Caffé ma diventata una bandiera nel Risorgimento. Non si fraintenda: la "moralità" non è etica ma deriva dall'orgoglio di «essere guida effettiva, non ufficiale del Paese». Lo annota Giovanna Rosa, presidente dei modernisti italiani, nel suo studio su Il mito della capitale morale con cui la Bur ripropone sue ricerche precedenti puntando su "Identità, speranze e contraddizioni della Milano moderna", come recita il sottotitolo, dove non si parla di quella letteratura che tuttavia fa la parte del leone nelle 300 pagine di un libro intelligente e ricco di citazioni fin dall'emigrato siculo Giovanni Verga: per lui «è la città più città d'Italia». Non è un caso che l'autore dei Malavoglia debba sbarcare a Milano per trovare il successo pubblicando il suo capolavoro da Treves nell'anno dell'Esposizione Nazionale del 1881, di cui descrive lo spettacolo della «fiumana del progresso». Si ripeterà nei prossimi mesi rinverdendo con la tecnologia ecosostenibile i fasti che nel 1881 hanno il culmine nel Ballo Excelsior alla Scala, contraltare alle «cose serie, cose sode» della città. Il volume di Rosa illumina il caso degli intellettuali che, radunati sulla carta stampata da Hoepli e Sonzogno, danno voce alla classe dirigente cercando un'identità nuova e «sollecitando la collettività a riconoscersi nell'etica del lavoro produttivo» a partire dai self made man come l'ingegner Pirelli e dal pilastro dell'editoria che fa di Milano una capitale. Nasce un dibattito in cui trova posto Valera con una Milano sconosciuta chiusa tra orti, navigli e viuzze malfamate dove «il progresso economico sembra non creare miglioramenti per il popolo». Al centro sta l'idea di «modernità» retta su due parole d'ordine indicate dal direttore di Casabella nel '32 e ancora valide: «culto testardo della metropoli» e «corsa verso l'Europa». La contraddizione «genetica, implicita» di essere capitale morale sta poi nel fare da «guida effettiva del Paese senza mai assumere la responsabilità della direzione politica» a dispetto di recenti presidenti del Consiglio lombardi. Il filo rosso che lega Expo 1881 e 2015 è nel superamento del "mito" e nella necessità di una consapevolezza del ruolo di metropoli reso visibile anche dall'architettura, che può sventare il rischio dei non-luoghi creati dalla somma di tutti i luoghi comuni della modernità patinata e commerciale. Serve non «edificare soltanto l'universo delle merci», secondo la visione di Benjamin, e non fermarsi dell'autorappresentazione come propone il numero 154 della rivista Nuova corrente: «la città non sia solo un touch screen». Nelle pagine ingiallite di Il ventre di Milano è curioso leggere di alimentazione, accoglienza e libertà nella «città che sale» del futuristi e «che cresce» dei socialisti come Turati che credono nella «capitale morale», cioè «patria di chiunque vi giunga». È così per Verga, ma anche per Stendhal, Berengo Gardin o Gae Aulenti: tutti dimostrano che Milano deve sforzarsi di non essere un «nodo scorsoio». Ha ragione il poeta Franco Loi: siamo nell'«unica città italiana internazionale. L'unico posto che mescola il mondo».
L'IDENTITÀ. Simbolo di modernità, oggi reso più evidente dai nuovi grattacieli.
LA STORIA. Un'immagine dell'Esposizione Nazionale del 1881, che celebrò il primato di Milano e il suo ruolo trainante nello sviluppo dell'Italia Fu in quella occasione che fu presentato alla Scala il famoso ballo "Excelsior".
IL VOLUME. La copertina del libro "Il mito della capitale morale" di Giovanna Rosa, Bur, pp 318,13 euro. Parte dall'Expo 1881 per riflettere sulle prospettive attuali.
Quando nacque il mito di "Milano, Capitale Morale"? La definizione – usata e abusata – di “Milano capitale morale” si presta a facili ironie in periodi di scandali come questo. Ma quando è nato (e perché) questo modo di dire? Lo inventò un napoletano nell’Ottocento, lo fortificò un vecchio expò, e a lungo ha poggiato sui valori della produzione am..., scrive Alessandro Marzo Magno “L’Inkiesta”. Capitale morale: un premio di consolazione. Siccome la capitale vera era stata messa a Roma, alla città più industriosa d’Italia non restava altro che la medaglia di latta, simile a quella della “vittoria morale” che nel 1934 avrebbe assegnato Nicolò Carosio all’Italia sconfitta con onore dai maestri inglesi del calcio. Milano, per un breve tratto della sua storia, diventa capitale davvero. In epoca napoleonica, nel ballottaggio tra Venezia e Milano, i francesi non hanno dubbi: tra la capitale di una repubblica durata oltre un migliaio d’anni e la sede di un ex governatorato spagnolo, ci mettono un amen a decidere chi debba abbassare la cresta. La contessa vicentina Ottavia Negri Velo nel 1806 scrive così: «La gara tra Milano e Venezia sembra dichiarata. Milano è una provinciaccia che ha sempre ubbidito, Venezia è una capitale in cui il dominio è originario». Proprio per questo il vicerè d’Italia, Eugène de Beauhrnais, ovvero il principe Eugenio, preferisce Milano come capitale del Regno d’Italia. Le istituzioni centrali vengono spostate in Lombardia: la nuova banca di Stato, il Monte Napoleone, assorbe il veneziano Banco Giro, che viene costretto a chiudere. Ma anche l’Accademia di Brera si avvale di una regalia di opere di celebri pittori veneti, spostate d’imperio dalla laguna ai navigli. Gli Asburgo replicano: hanno combattuto la Serenissima per mezzo millennio (salvo brevi parentesi, tipo Lepanto e le guerre contro i turchi di fine Seicento), hanno fatto di Trieste un porto franco per sottrarre all’ormai decaduta repubblica il dominio sull’Adriatico, e ora, riusciti finalmente a mettere le mani sullo spennato leone di San Marco, è ovvio che come capitale del Lombardo-Veneto, gli preferiscano Milano, che oltretutto era città dei loro cugini spagnoli. Assaporato il gusto del comando, Milano viene retrocessa dai Savoia. Ma ormai la città si è avviata sulla via dell’industrializzazione, è l’unico centro italiano legato da «un cordone ombelicale all’Europa», come disse lo storico Renzo De Felice che aggiunse: «Milano rappresenta un’instancabile incubatrice del nuovo che nasce nel Paese». Giovanni Verga la definisce «la città più città d’Italia». La consacrazione definitiva arriva con la Fiera industriale (oggi diremmo Expo) del 1881 quando Milano si mette in vetrina. La definizione di “capitale morale” sembra essere più o meno di quel periodo, assegnata oltretutto da un napoletano, Ruggero Bonghi, che in quegli anni dirigeva il quotidiano milanese La Perseveranza. Il successo (della definizione) è virale: va bene a tutti, ai milanesi per consolarsi, ai romani per consolarli. Come scriveva Guido Lopez «la mostra avvalorava l’operosità alacre di una città che si proclamava con orgoglio consapevole “capitale morale d’Italia”. Traduzione moderna del vecchio proverbio popolare Milan dis, e Milan fa. Renzo De Felice però non era d’accordo: «L’Italia ha solo due capitali: Napoli e Palermo», le uniche che ricordano Parigi, Madrid, Vienna, come sottolineò lo storico. Tuttavia Milano sembra effettivamente diventata una fucina non solo industriale. Roberto Sacchetti, nel suo La vita letteraria a Milano nel 1880 la butta sull’etica: «A Milano non si commette la ridicolaggine di chiamare il conte Maffei, il cavaliere Boito, il cavaliere Ponchelli, il cavaliere Verga. Si dice Boito, Verga… e si crede di dir molto». Ognuno è considerato per quel che fa, insomma, non per quel che è. Dice Gaetano Salvemini: «Quello che oggi pensa Milano, domani lo penserà l’Italia». La città sembra voler pungolare un’Italia che ha voluto, che ha contribuito a costruire, ma che non è come avrebbe dovuto essere. Luigi Albertini schiera il quotidiano più influente del Paese, il Corriere della Sera, su posizioni interventiste, in contrapposizione al neutralismo del piemontese Giovanni Giolitti. E il fascismo sarà una faccenda tutta milanese: Benito Mussolini direttore de l’Avanti!, con sede in città, frequenta la casa milanese di Filippo Turati e Anna Kulishioff, dove conosce e diventa amante della veneziana Margherita Sarfatti che gli inculcherà il mito della romanità. Ed è nella milanese piazza San Sepolcro che il futuro Duce fonda i Fasci italiani di combattimento, il 23 marzo 1919. Il mito continua anche nel secondo dopoguerra, quando Milano diventa più che mai l’ombelico dell’Italia industriale, il centro dell’immigrazione (qualora si eccettui la Fiat). I primi ad arrivare sono i veneti, da allora qualificati con l’aggettivo di “terroni del Nord), seguono i siciliani, i pugliesi e tutti gli altri. Recita un proverbio: “Chi ghe volta el cü a Milan, ghe volta el cü al pan” (chi gira il culo a Milano, gira il culo al pane). Per parecchi anni la città vive una crisi di rappresentanza politica: la “capitale morale” conta relativamente poco nei palazzi del potere romano, dove non brilla un astro meneghino di prima grandezza fino all’avvento del socialista Bettino Craxi. Ma ormai siamo negli anni Ottanta e il mito comincia a offuscarsi. Alla “Milano da bere” immortalata, verso la metà del decennio, in un celeberrimo spot pubblicitario dell’amaro Ramazzotti, si contrappone la “Duomo connection”, un’inchiesta giudiziaria promossa tra il 1989 e il 1990 dal pubblico ministero Ilda Boccassini (ebbene sì, proprio lei) e attuata dal celeberrimo capitano Ultimo (al secolo Sergio De Caprio, capitano dei carabinieri). Un paio d’anni più tardi esplode Tangentopoli e l’effetto collaterale è l’entrata in scena di un altro milanese che avrebbe segnato parecchio la vita politica italiana: il cavalier Silvio Berlusconi. E tra “Berlusconi” e “morale” la contrapposizione è definitiva.
Milano, Capitale Morale? Un mito. Meglio Napoli e Palermo. Gli storici De Felice e Rumi riconoscono la vocazione europea della città, ma bocciano le tentazioni di separatismo. Milano "capitale morale": realtà o solo un mito? E Roma è davvero capitale? O l'Italia ha capitali "alternative"? Nel post Tangentopoli l'interrogativo potrebbe ricevere una risposta sbrigativamente liquidatoria, se non ironica. Ma se a porsi le domande è Renzo De Felice, la cronaca (magari nera) si riscatta. E la storia, se non proprio maestra di vita, qualcosa può aiutare a capire. Anche perchè De Felice fa riflessioni provocatorie, presentando un prezioso, illustratissimo volume edito dalla Cariplo, Milano nell'Italia liberale: 1898 1922. Due date fatidiche, che vedono il capoluogo al centro della vita nazionale: tra le cannonate di Bava Beccaris (100 cittadini morti) e la partenza di Mussolini in vagone letto per "marciare" su Roma. Ieri come oggi non si può mai dire: lo studioso rifiuta accostamenti. Ma sviluppa argomenti che valgono piu' di riferimenti all' attualità. In sostanza, la vocazione di Milano sembra snodarsi a metà fra il mito e la reale forza economica, la fattività. Due sono la caratteristiche di questa Milano ("che vanno tutt'altro che in un senso pro Bossi"): "la proiezione europea", soprattutto al Nord, verso il mondo germanico e anglosassone: una bella differenza, quindi, "fra una proiezione europea e una balcanica o mediterranea". E la "tradizione moderata" di Milano, che si esprime persino in certe forme "sovversive". Turati e la Kulishoff sono cosa diversa dai socialisti di altre parti; anche i "fasci di combattimento" milanesi differiscono dai toscani e dagli emiliano romagnoli. Se Milano piange, Roma non ride. Azzarda De Felice: "Se c'è un mito della capitale morale, c'è un mito anche di quella reale". Paradosso o provocazione? Roma ha una storia, la romanità e i papi, ma "l'Italia ha solo due capitali: Napoli e Palermo", le uniche che ricordano Parigi, Madrid, Vienna. A De Felice dà man forte Giorgio Rumi (lo storico che con Adele Carla Buratti e Alberto Cova ha curato il volume, introdotto da Roberto Mazzotta). E vero, "Milano rappresenta un'instancabile incubatrice del nuovo che nasce nel Paese", ma resta "ambigua". E l'unica terra italiana per vicende storiche legata da "un cordone ombelicale all' Europa", ma "ha usato la politica europea per sopravvivere, per difendersi". Metaforicamente, come emerge dalla ricerca della Buratti, è il succedersi di progetti d'architettura, senza però che poi il disegno riesca a trovare la dimensione attuativa, propositiva. Anche se lo storico per mestiere si astiene dal presente, almeno pone le premesse per la morale da trarre: 1898 1922; ritornano espressioni come "lo Stato di Milano" (Crispi) e "ducato di Milano" (Sturzo); è il busillis dell'"ingovernabile Settentrione". Milano che volle l'unità, col Risorgimento, e si alleò per realizzarla al Piemonte che aveva monarchia, esercito, diplomazia, viene presto presa - dice Rumi - "da tentazioni ricorrenti di separatezza". L'inquietudine e l'insofferenza verso l'Italia uscita dal Risorgimento nascono da Milano, tra cattolici e socialisti; da qui parte l'interventismo di Albertini, ma anche Mussolini. Insomma, Milano tormentata tra uno Stato che vuole e ha contribuito a costruire, ma che invece non è come avrebbe dovuto essere. Insomma, un'Italia che non si riesce a incarnare. Ieri come oggi. Con l'angoscia, per chi non fa lo storico, di dover lavorare in tale dilemma. E vivere. Pagina 46 (17 dicembre 1993) - Corriere della Sera...
IL DUALISMO MILANO ROMA. LA RIVALITA' TRA DUE METROPOLI IN SOSTANZA UGUALI NEL DELINQUERE.
Corruzione, efficienza, calcio: ecco perché Milano batte Roma (6-0). Il portale economico finanziario Bloomberg ha provato a sfatare alcuni luoghi comuni sulle due metropoli, con numeri e dati alla mano, scrive Elmar Burchia sul milanesissimo "Corriere della Sera".
1. La storica rivalità. Il problema dei milanesi con Milano? La criticano, sempre, comunque. Appena possono, infatti, fuggono dalla città. Dicono di non volerci vivere. Nonostante l’happy hour, nonostante la vita notturna, nonostante le opportunità di lavoro, nonostante lo shopping. Per i romani, invece, niente è come Roma: l’ottima cucina, il clima mite, la storia millenaria, la bellezza sfrontata. D’altronde, anche Audrey Hepburn in Vacanze Romane aveva risposto in maniera inequivocabile alla domanda su quale fosse la sua città preferita: «Roma! Certamente, Roma!». Se il New York Times ha piazzato il capoluogo lombardo al primo posto tra 52 destinazioni nel mondo da vedere nel 2015, la capitale d’Italia è finita in questi mesi sulle prime pagine dei giornali per altre ragioni - davvero poco invidiabili. La rivalità tra le due città esiste da sempre: tra un «c’avete solo la nebbia» e un «Roma Ladrona», la (spesso) interminabile discussione si sposta quasi sempre sul calcio. Il portale economico finanziario Bloomberg ha provato a sfatare alcuni miti e luoghi comuni sulle due metropoli, con numeri e dati alla mano: ecco, in sei punti, le conclusioni a cui gli analisti sono arrivati.
2. Resilienza economica. Nel corso della recessione più lunga dalla Seconda Guerra Mondiale (2000-2015), il pil pro capite nella regione Lazio è sceso del 24,3 per cento (da circa 36 mila euro a circa 29 mila), secondo le proiezioni Bloomberg. In Lombardia il calo è stato dell’8,5% (da circa 37 mila euro a poco più di 36 mila).
3. Disoccupazione. Il tasso di disoccupazione nella provincia di Roma è salito all’11,3 per cento nel 2014 (dati Istat). Milano e la Lombardia hanno registrato rispettivamente l’8,4% e l’8,2% di persone in cerca di lavoro - una situazione meno critica rispetto al resto all’Italia (ormai al 12,7%). C’è poi il problema del numero esorbitante di dipendenti pubblici, che affligge la capitale. Per esempio l’Atac (l’azienda che gestisce i servizi di trasporto a Roma) ha circa 12 mila dipendenti, mentre l’Atm di Milano ne ha circa 9 mila. Il Comune di Roma da solo conta circa 24 mila dipendenti, e aggiungendo anche le municipalizzate di acqua, rifiuti e trasporti si superano i 50 mila addetti.
4. Efficienza. Nel 2015, la rete metropolitana milanese ha superato i 100 chilometri, mentre Roma è ferma a 62 km. Vale la pena ricordare che Roma è sette volte più grande di Milano, con quasi il doppio della popolazione. Bisogna dire che creare una rete sotterranea per la metro nella città eterna è parecchio complesso. I mezzi pubblici a Milano trasportano ogni anno quasi 750 milioni di passeggeri; a Roma, i passeggeri che utilizzano autobus e tram sono circa 927 milioni, solo 273 milioni per la metropolitana. Il bike sharing nella capitale è stato un fiasco. Il servizio BikeMi a Milano invece riscuote sempre più successo: ha contato nel 2014 oltre 2,4 milioni di noleggi, un incremento del 244,7% dall’esordio (nel 2009), con un ulteriore +26,7% rispetto al 2013.
5. Fascino. È vero che la città eterna attira più di 10 milioni di turisti stranieri l’anno, rispetto ai circa 7 milioni che arrivano a Milano. Tuttavia, grazie a Expo 2015, il numero di turisti nel capoluogo lombardo è aumentato del 9 per cento a maggio e del 12 per cento a giugno di quest’anno (a Roma è salito del 5 per cento nel mese di giugno 2015).
6. Corruzione. Sia Roma che Milano sono finite al centro di vari scandali. Gli appetiti della mafia sui grandi lavori di Expo sono un fatto ormai, tristemente assodato. Lo testimoniano le decine di inchieste giudiziarie e gli arresti (oltre 15 da marzo 2014) che hanno messo in luce i legami tra imprenditori e famiglie mafiose. Ma nel 2015 Roma è finita sulle prima pagine per la sporcizia, i rifiuti e «Mafia Capitale»: da dicembre sono circa 80 le persone finite in manette e oltre 100 gli indagati.
7. Calcio. «Milan e Inter? Sono squadre di calcio. Roma e Lazio: sono religioni». Alla fine, scrive Bloomberg, si torna quasi sempre a parlare di pallone, di giocatori, di campionato. E di quale città può vantare più scudetti: Milan e Inter hanno entrambi 18 scudetti, la Roma ne ha 3 e la Lazio 2. E così la «finalissima» (sempre secondo Bloomberg) vede Milano vincente su Roma per 6 a 0. Anche se nell’ultimo campionato...
PARADOSSI SUL WEB. Ecco le ragioni per cui Milano è «la peggiore città al mondo». BuzzFeed, il popolare sito americano esprime - con ironia - tutta la propria ammirazione per il capoluogo lombardo, scrive ancora Elmar Burchia sul milanesissimo "Corriere della Sera". Gli americani adorano Milano. Non lo dicono solo i numeri: dei 3,8 milioni di turisti giunti nei primi cinque mesi di Expo, al primo posto si collocano proprio gli statunitensi. E per puro divertimento BuzzFeed, il popolare sito con oltre 200 milioni di utenti unici al mese, ha pubblicato nei giorni scorsi una classifica delle 32 ragioni per cui «Milano è il peggio in assoluto». Il sito, con una carrellata di foto e didascalie assolutamente ironiche, esalta per antitesi il capoluogo lombardo, proprio come aveva fatto ad aprile, poco prima dell’apertura di Expo, con le «39 ragioni per cui l'Italia è il peggior Paese al mondo».
1. Dunque, hai sentito grandi cose su Milano? Inizia così, con una bella immagine del Duomo, il singolare racconto di BuzzFeed che elogia la città di Milano. Il titolo: «Dunque, hai sentito grandi cose su Milano?».
2. Pensi che valga la pena farci una breve vacanza? La seconda immagine è quella della galleria Vittorio Emanuele II, uno dei punti di forza di Milano: grazie soprattutto alla presenza delle tante boutique griffate, la splendida struttura in stile neorinascimentale viene percorsa ogni giorno da migliaia di turisti, che rimangono affascinati dal passaggio coperto. Anche chi fa la più breve delle vacanze non può non vederla.
3. Be’, risparmia tempo e soldi...La terza immagine è quella di Borgo Pirelli, in zona Bicocca, un gioiello di 30 case in stile liberty nato nel 1921 per ospitare gli operai dell’omonima fabbrica che sorgeva proprio lì di fianco. Sullo sfondo le Alpi innevate in una (ahimé rara) giornata limpida.
4. Perché Milano non li vale...I Navigli: centro nevralgico della movida milanese. La (riuscita) riqualificazione della Darsena è uno dei progetti che Expo lascia in eredità a Milano e alla Lombardia.
5. E nessuno dovrebbe mai andarci! Altro gioiello: il Teatro alla Scala, il Piermarini.
6. Seriamente, guarda quanto è brutta! Ancora una veduta dei Navigli.
7. È come una brutta grande verruca sulla faccia dell'Italia. Di nuovo la Galleria Vittorio Emanuele, in uno scatto dall’interno.
8. È semplicemente ripugnante. Lo skyline di Milano visto dal Duomo: il santo sulla guglia sembra fissare i nuovi grattacieli di Porta Nuova.
9. Così ripugnante da essere al limite dell'insulto. La basilica di Santa Maria delle Grazie, situata nel cuore della città. L’imponente opera architettonica è legata in modo indissolubile all’affresco di Leonardo, il Cenacolo, conservato al suo interno, nel refettorio. Dal 1980 è sito patrimonio dell’umanità dell’Unesco.
10. Questa città non ha classe. Il Duomo: simbolo del capoluogo lombardo, per superficie è la terza chiesa cattolica nel mondo (dopo San Pietro e la cattedrale di Siviglia). Per Expo, il Duomo è stato consegnato in tutto il suo splendore ai milanesi e ai tanti visitatori. La ristrutturazione è costata decine di milioni di euro.
11. Nessun mordente. I variopinti graffiti sulle saracinesche sono piaciuti agli autori del sito americano. Sull’argomento i milanesi hanno pareri discordi.
12. Nessuna vita culturale. Il Teatro alla Scala, uno dei più celebri al mondo: da oltre duecento anni ospita artisti internazionalmente riconosciuti. Fu inaugurato il 3 agosto 1778 con «L’Europa riconosciuta», dramma per musica composto per l’occasione da Antonio Salieri.
13. Non c'è arte. Il Cenacolo di Leonardo da Vinci a Santa Maria delle Grazie. Databile al 1494-1498, è la più famosa rappresentazione dell’Ultima Cena, capolavoro di Leonardo e del Rinascimento italiano in generale.
14. Zero storia. L’espressione «Fabbrica del Duomo» è divenuta proverbiale per parlare di qualcosa che dura moltissimo tempo, perché la costruzione e la manutenzione della cattedrale di Milano sono un processo infinito. La Veneranda Fabbrica del Duomo fu istituita nel 1387, con il compito di provvedere all’amministrazione, alla conservazione e alla disponibilità per il culto del Duomo.
15. Davvero una pessima moda. Milano vuol dire moda. Assieme a New York, Londra e Parigi, è tra le capitali più importanti dell’industria del fashion. E gli americani questo lo sanno benissimo: alla Settimana della moda le star non mancano mai.
16. E assolutamente nessun senso per lo stile. Che i milanesi abbiano un sesto senso per la moda lo si può capire anche dal look dei motociclisti in strada. Il sito americano approva, i milanesi si lamentano del traffico.
17. Proprio no. Un’auto d'epoca in centro.
18. Qui non succede mai nulla. Il coro e l'orchestra del Teatro alla Scala durante l'evento di apertura di Expo 2015 in piazza Duomo.
19. Non c'è nessun posto dove andare nel fine settimana. Lago di Como, a circa 50 km da Milano
20. L'architettura è noiosa. Il Bosco Verticale, a Porta Nuova, progettato da Stefano Boeri, che si è aggiudicato l’International Highrise Award 2014 vincendo su 800 grattacieli di tutti i continenti.
21. Non hanno proprio immaginazione... Le Residenze Zaha Hadid a CityLife. L’architetto anglo-iracheno ha anche progettato lo «Storto», il secondo grattacielo di CityLife - 44 piani per 170 metri di altezza - che sarà pronto entro il 5 ottobre 2016. Il «Dritto», la torre Isozaki, aspetta i tremila dipendenti di Allianz (arriveranno nel 2017).
22. È datata. La Torre Unicredit, 239 metri di altezza, è collocata a ridosso di corso Como e della Stazione Garibaldi. Cuore del complesso è la piazza Gae Aulenti. È stata progettata dall’architetto César Pelli ed è sede della direzione generale di UniCredit. Tutt’altro che datata, è stata inaugurata l’11 febbraio 2014.
23. Il tutto è semplicemente orribile. E qui vien quasi voglia di dar ragione al titolo: risente proprio dello stile del Ventennio la «porta urbana» che, secondo il proposito dei progettisti, avrebbe segnato il passaggio dall’antica alla nuova città. Ma evidentemente agli autori del sito americano è piaciuto anche l’Arengario, palazzo costruito negli anni Trenta su progetto degli architetti Portaluppi, Muzio, Magistretti e Griffini e sopravvissuto ai bombardamenti del 1942. Ora ospita il Museo del Novecento.
24. Urta i miei sentimenti. Lo skyline di Porta Nuova: a sinistra il Diamante.
25. Davvero, vorresti andarci? L’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II.
26. Vorresti passeggiare per queste strade? Il nome Brera deriva da braida: terreno incolto, ortaglia. Oggi questo quartiere pullula di negozi, bar, ristorantini. E di tanti, ma davvero tanti, turisti.
27. Sederti su questa fontana? La «torta degli sposi» in piazza Castello, ricostruita dopo i lavori per la linea 1 della metropolitana. Il Castello Sforzesco, fondato da Galeazzo II Visconti, venne ricostruito da Francesco Sforza nel 1450, che affidò al fiorentino Antonio Averlino il compito di realizzare la spettacolare torre dell’orologio. Una curiosità: alla fine dell’Ottocento si pensò seriamente di abbatterlo per sostituirlo con una fila di palazzi residenziali. Alla fine venne salvato dall’intervento (provvidenziale) di Luca Beltrami che ne curò poi anche la ristrutturazione.
28. Guidare attraverso questo arco? In effetti non si può passare in auto sotto l’Arco della Pace, ma si vede che agli americani l’idea piace. La costruzione dell’Arco della Pace, progettato nel 1807 da Luigi Cagnola, fu interrotta dopo la disfatta di Napoleone a Waterloo; venne terminata per volontà di Francesco I d’Austria. È uno degli ingressi del Parco Sempione, e tutta l’area circostante è pedonale.
29. Dovresti essere pazzo per voler vivere in un posto del genere! Via della Spiga, una delle zone più lussuose e centro dello shopping dell’alta moda a livello mondiale. Sono in pochi quelli che possono dire di viverci.
30. Quindi credimi quando dico: non visitare mai Milano! Perché è la peggiore in assoluto! La carrellata si conclude con un’immagine tipica di turisti in piazza Duomo: un invito per i cittadini americani.
INVECE NO! TUTTI UGUALI. ROMA –MILANO, ITALIA. cOME NEL '92.
Questa volta nel mirino di Crozza finisce Mario Mantovani, il vicepresidente della regione Lombardia (ed ex assessore alla salute) finito in manette proprio poco prima di partecipare alla "giornata della legalità". come chiosa il comico genovese. “Oggi a Milano hanno arrestato il vicepresidente della Regione Lombardia, ex assessore alla sanità. Doveva partecipare alla giornata della trasparenza e della legalità, ma è stato arrestato "un secondo prima". Voi avete mafia capitale e a Milano abbiamo sanità criminale”, scherza il comico nella copertina Di Martedì del programma di La7 del 13 ottobre 2015, in onda su La7, condotto da Giovanni Floris. Quanto all'accusa di aver truccato gli appalti per il servizio di trasporto dei malati in dialisi, commenta "Di fronte a questo gli scontrini di Marino sono bazzecole", dice Crozza. «Voi avete Mafia Capitale a Roma e noi Sanità regionale. Tu mi dirai cosa c’entra? Da voi è Cosa Vostra, da noi Cosa Nostra, il bicamorrismo è perfetto». Crozza ha notato che l'accusa rivolta al vice presidente della Regione guidata da Bobo Maroni è quella di aver fatto "la grana sui dializzati". Se ne conclude che "mentre al Nord fottevano i malati, a Roma fottevano il medico", con riferimento alle dimissioni di Ignazio Marino: Marino come dottor House, solo che il bastone al momento non gliel'hanno messo proprio in mano. (...) Ieri al Campidoglio 2000 persone chiedevano a Marino di restare. Tutta gente che era stata a cena con lui, tra l'altro. Quindi un passaggio su "Sabrina Ferilli che fa il caxxiatone al Papa" e sulle idee del Premier per il post Marino nella Capitale: Renzi vuole sostituire Marino con 1 commissario e 8 sottocommissari. 9 al posto di 1, vedi che il Jobs Act funziona! Su Marino: «La data per le dimissioni ufficiali è il 2 novembre, il giorno dei morti. E’ sfigato, dai non gliene va bene una».
Se Roma Piange, Milano non ride. Maroni farebbe bene a dimettersi, scrive “On Line News”. Se Roma piange Milano non ride, espressione consunta ma tremendamente efficace. Mettiamo pure da parte il luogo comune ma la situazione si fa veramente difficile, la corruzione sembra una pianta inestirpabile che condizione sempre più la politica. Certo dove ci sono i grandi affari si sono i corrotti, i corruttibili e i corruttori. Milano e Roma in prima fila. Ma si poteva ragionevolmente pensare che la storia avesse insegnato qualcosa. Invece ci cascano tutti e gli sviluppi della corruzione scoperta, del malgoverno, del malaffare, trascinano a fondo la politica e i politici. Che reagiscono in modo diverso. Ma sostanzialmente lasciano malvolentieri incarichi e poltrone, come se la colpa fosse di altri, o almeno condivisa. Pochi che si facciano da parte spontaneamente. Marino è rimasto aggrappato al suo scranno come una cozza, si è fatto massacrare e difficilmente, al di là delle utopie, avrà un futuro politico. Maroni, presidente della regione Lombardia rischia di essere trascinato nello stesso vortice. Si fosse presentato alla stampa con le dimissioni in tasca con un discorsetto del tipo: non potevo non sapere e se non me ne sono accorto sono un pessimo presidente. Sarebbe stato un atto di dignità che gli avrebbe procurato applausi, consensi e lo avrebbe tenuto in partita. Così come si sta comportando, invece, rischia grosso. Credibilità a picco, palla nel campo avversario, demolizione mediatica. Provare per credere.
Mantovani e le tangenti in Lombardia. l’ira di Salvini, che si autodenuncia «Segnalavo associazioni benefiche». Il leader leghista: a Garavaglia accuse assurde, colpiti perché cresciamo, scrive Marco Cremonesi su “Il Corriere della Sera”. «Sono stanco. Stanco e inc...». Matteo Salvini è in tour per l’Emilia. Il tono è secco, molto più cupo del solito:
«Sa che faccio? Mi autodenuncio. Sono colpevole».
E di che cosa?
«Di segnalazione. Al posto di Garavaglia, lo avrei fatto anche io. Anzi, l’ho fatto: da consigliere comunale nel corso degli anni ho segnalato decine e decine di associazioni benefiche. E non mi ravvedo: lo rifarò».
Il segretario leghista sta arrivando a Parma per un comizio. Salvini mette fuori dal finestrino dell’auto il telefonino, si sentono rumoreggiare dei cori. Sono leghisti festanti? No, sono militanti dei centri sociali:
«Li sente? - grida Salvini nel telefono - sono i democratici urlanti e lancianti che cercano di impedirmi di parlare. Poi, però, chi viene indagata è una persona come Garavaglia perché avrebbe segnalato un’associazione di ambulanze. Senza prendere un euro, beninteso. Pazzesco, pazzesco...».
Secondo
la procura di Milano, Garavaglia avrebbe agito per mantenere o aumentare il suo
consenso elettorale. Almeno come ipotesi, è ammissibile. O no?
«Macché, mi faccia il piacere... Massimo Garavaglia è il migliore tra noi, una
persona che tutti conoscono come specchiata. Questa è un’indagine pazzesca su
uno dei leghisti più seri e onesti che io conosca».
Lui ha detto che ci deve essere un errore. Lei non la pensa così?
«Di nuovo, mi faccia il piacere... Guardi, giusto ieri (lunedì) ero stato un facile profeta. Al consiglio federale della Lega avevo detto: ragazzi, visto che siamo in crescita, prepariamoci. I sondaggi ci danno al 15,2 per cento e per fermarci le proveranno tutte. E in effetti, eccoci qui. Un’inchiesta che segna un primato».
Quale primato?
«È la prima indagine al mondo in cui si accusa una persona di aver cercato di dare una mano ad un’associazione benefica. Peraltro, senza riuscirci. Per l’ufficio di Garavaglia passano qualcosa come venti miliardi di euro».
Beh, la proroga dell’incarico all’associazione Croce azzurra Ticinia la avrebbe comunque favorita.
«Ma quale favorita, se poi non ha vinto? Comunque, ripeto: io l’avrei fatto e lo rifarei. Se c’è una Croce di qualsiasi colore, un’associazione che conosco e stimo, per farli partecipare a un bando io telefono anche al presidente della Repubblica».
La vicenda di Mantovani è altrettanto irrilevante, dal suo punto di vista?
«Non mi permetto di commentare l’indagine che riguarda Mantovani. E peraltro non ne so nulla, anche se lui mi pare una brava persona. In ogni caso, quella sembra un cosa diversa, che non riguarda l’aiuto alle ambulanze. Per quanto mi riguarda, mi permetto soltanto di dire che sono vicino a un padre a cui è nato un figlio dieci giorni fa (il capo di gabinetto dell’assessorato alla Sanità, Giacomo Di Capua), per un qualcosa che riguarda fatti che risalgono come minimo a un anno fa».
Insomma: un complotto?
«Beh, nel passato già ci hanno provato. Si ricorda
quando per due anni hanno cercato dei soldi che ci avrebbero dato degli indiani
per degli elicotteri. Poi, l’inchiesta (quella su Finmeccanica ndr ) è stata
archiviata. Perché non c’erano soldi, non c’erano indiani, non c’erano
elicotteri».
Ma quale sarebbe lo scopo?
«A qualcuno dà fastidio la sanità lombarda. Un solo numero: l’anno scorso in Lombardia sono venute da altre regioni per farsi curare tante persone da fare 872 milioni di fatturato. Un record europeo. Chissà, forse un po’ d’invidia...».
Scusi, che c’entra l’invidia?
«Massì, e allora la dico più chiara: forse qualcuno vuole coprire e far dimenticare i problemi del Pd e di Ignazio Marino? E Montepaschi? Nessuno ha pagato, tranne gli italiani. La Lombardia è la Regione meno costosa per i cittadini. E a qualcuno dà fastidio che la Lega, il partito delle ruspe e delle felpe, sia al governo nelle Regioni che producono il 30 per cento del Pil».
Come cambia Salvini se lo scandalo è a Roma o a Milano. Il leader della Lega tuona contro i giudici: "Si tratta di un attacco politico per nascondere i problemi del Pd e le cene di Marino". Il tutto a pochi giorni dalle dichiarazioni del governatore Maroni, che vede nel numero uno del Caroccio un buon candidato per la poltrona di sindaco di Milano, scrive Selene Ciluffo il 14 Ottobre 2015 su Today. Dopo l'arresto del vicepresidente della regione Lombardia, uno dei primi a schierarsi a fianco di Mario Mantovani è il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Lo fa "berlusconianamente" apparendo su tutti i media possibili (dalle televisioni ai giornali) e prendendosela con i giudici: "Un attacco politico alla Regione meglio governata d’Italia magari per nascondere i problemi del Pd e le cene di Marino e Renzi. C’è stata una giornata di sputtanamento mediatico sulla migliore sanità europea e anche sulla Lega". Per questo secondo il leader del Carroccio la giunta lombarda non sarebbe a rischio, nonostante la mozione di sfiducia pronta di Pd e M5s. D'accordo con lui anche il governatore Roberto Maroni: "Salvini ha ragione, si tratta di un attacco politico". Mantovani è accusato di corruzione per aver favorito un architetto, Gianluca Parotti, nell’ottenimento di incarichi in appalti pubblici, compresi lavori in diversi ospedali lombardi, in cambio di prestazioni gratuite nei propri affari immobiliari privati. La Lega fa quadrato intorno a un berlusconiano di ferro a pochi mesi dalle elezioni comunali milanesi, previste per la primavera del 2016. E quando si è parlato di un possibile candidato, Lega e berlusconiani si sono trovati d'accordo su un nome: Matteo Salvini. Ovviamente la procura milanese la pensa in maniera diversa dal leader della Lega: per il pm Giovanni Polizzia, l'unico modo per "interrompere il funzionamento della concatenazione delittuosa" è quello di "neutralizzare Mantovani". Parole pesanti, sottoscritte anche dal gip Stefania Pepe, nelle carte dell’inchiesta che ha portato all’arresto del vicepresidente della regione Lombardia. La sua sarebbe una "fittissima rete di relazioni" da cui risulta "evidente che l'unica misura effettivamente in gradi di prevenire sia la commissione di nuovi delitti che, soprattutto, le attività di condizionamento ed intervento sulla genuinità delle prove (già peraltro avviate) sia quella massima della custodia cautelare in carcere”. Il leader della Lega è anche entrato nel merito dell'inchiesta della procura, prendendo le difese anche di Massimo Garavaglia, assessore regionale all’Economia e braccio destro di Maroni. Garavaglia è indagato per turbativa d’asta, insieme a Mantovani e altri, nel filone di una gara d’appalto per il trasporto dei dializzati, cancellata a esito già stabilito, secondo l’accusa per far rientrare in gioco alcuni operatori delle Croci con sede nei bacini elettorali dei due politici. Salvini usa i social per schierarsi con gli indagati. “Da consigliere comunale nel corso degli anni ho segnalato decine e decine di associazioni benefiche. E non mi ravvedo: lo rifarò”. In realtà secondo la procura di Milano Garavaglia non ha semplicemente fatto delle segnalazioni, ma si sarebbe adoperato per annullare una gara d’appalto già assegnata per il servizio di trasporto dei malati di reni bisognosi del trattamento di dialisi. Ma questo al leader della Lega non interessa: “Massimo Garavaglia è il migliore tra noi, una persona che tutti conoscono come specchiata. Questa è un’indagine pazzesca su uno dei leghisti più seri e onesti che io conosca”. Per Salvini si tratta di una vera e propria campagna, visto che il Carroccio, in particolare negli ultimi mesi, ha aumentato i propri consensi nei sondaggi e di conseguenza "la giunta non deve dimettersi". Diversa invece era stata la reazione di Salvini quando lo scandalo aveva coinvolto la giunta e la città di Roma. Dopo lo scandalo di Mafia Capitale, Salvini aveva marciato sul Campidoglio chiedendo a gran voce le dimissioni del sindaco Marino. Non solo: in merito all'amministrazione capitolina, il leader della Lega non ha mai negato la necessità di "onestà, trasparenza e pulizia". Parametri però che non vengono applicati alla giunta lombarda, fatta secondo il leader del Caroccio da "brave persone". Eppure qualche dubbio la procura milanese su questo lo ha avuto: tanto da far scattare dei provvedimenti cautelari, come gli arresti domiciliari.
Tangenti nella sanità, arrestato il numero due del Pirellone Mario Mantovani. Uomo forte di Berlusconi in Regione, ex senatore e fino ad agosto assessore alla sanità. È accusato dei reati di concussione e corruzione aggravata. Indagato anche il Richelieu di Maroni, il leghista Massimo Garavaglia, scrive Michele Sasso il 13 ottobre 2015 su “L’Espresso”. Un terremoto scuote il Pirellone: arrestato Mario Mantovani, numero due in Regione Lombardia a fianco di Roberto Maroni e fino ad agosto potente assessore alla sanità. Il procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati, ha comunicato che è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Mario Mantovani per i reati di concussione, corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti. Arrestati, per gli stessi reati, Giacomo Di Capua, collaboratore di Mantovani e dipendente regionale, e Angelo Bianchi, ingegnere del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria. Nell’ambito della stessa indagine è indagato per turbativa d’asta anche l’assessore all’Economia della Regione Lombardia Massimo Garavaglia, ex parlamentare della Lega e potente Richelieu di Maroni: ogni decisione della giunta passa dalla sua approvazione. L'inchiesta riguarda il periodo tra il 6 giugno 2012 e il 30 giugno 2014 per tangenti negli appalti della sanità. In quel periodo Mantovani faceva la spola tra Roma come senatore e sottosegretario ai Trasporti nel governo Berlusconi e la sua città natale Arconate, dove ha fatto il sindaco ininterrottamente dal 2001. Solo nel 2013 ha lasciato la Capitale per diventare vicepresidente della regione Lombardia. Secondo il pubblico ministero Giovanni Polizzi, Mantovani avrebbe sfruttato l’influenza derivante dalle sue numerose cariche per pilotare alcune gare d’appalto nel settore sanitario, favorendo liberi professionisti in concorso con altri pubblici ufficiali e ottenendo in cambio «mazzette» non sotto forma di denaro, ma di prestazioni di professionisti. Arrivando al Senato, il presidente di Forza Italia commenta la notizia dell'arresto per corruzione di Mario Mantovani, vicepresidente della Regione Lombardia ed esponente di spicco dei forzisti a Milano di Marco Billeci e Angela Nittoli. Per esempio, avrebbe ottenuto che i lavori di ristrutturazione di alcuni immobili di sua proprietà venissero realizzati da un architetto «amico», che in cambio avrebbe ottenuto alcuni incarichi pubblici e vinto alcune gare d’appalto. L’accusa di turbativa d’asta deriva dal fatto che Mantovani avrebbe contribuito a pilotare gare pubbliche relative tra l’altro al trasporto di pazienti dializzati, all’edilizia scolastica e alle case di riposo. Nell’elenco sono finiti anche la casa di riposo Opera Pia Castiglioni a Cormano e la struttura di Casorezzo. Entrambe controllate dall’impresa di famiglia, la fondazione Mantovani (in memoria della sorella Ezia, Mario è presidente), e poi appartamenti e uffici ad Arconate, la cascina dove abita il politico e immobili di alcuni familiari. Secondo l’accusa avrebbe anche fatto pressioni a un dirigente del provveditorato alle Opere pubbliche per far ottenere incarichi a persone a lui vicine. Tra politica e business, Mantovani è l’uomo forte di Forza Italia: è stato il più votato dai lombardi (quasi 13mila preferenze nel 2013), tanto da autodefinirsi “sindaco di Lombardia”. Partito dal comune dell’hinterland milanese di Arconate, ha costruito da qui la sua carriera politica e imprenditoriale: 65 anni, docente, imprenditore, europarlamentare. Nel 2008 il grande salto a Roma come senatore e sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti. E allo stesso tempo coordinatore del Popolo della Libertà per tutta la regione-simbolo del potere degli azzurri. Negli affari il core business di questo epigono di Berlusconi è proprio la sanità, come raccontato da “l’Espresso” alla vigilia della campagna elettorale che ha portato Roberto Maroni all’ultimo piano di Palazzo Lombardia. Di Mantovani si è parlato per un conflitto d'interessi, visto che i suoi affari di famiglia prosperano grazie anche ai contributi della Regione. Gli assi nella manica sono la fondazione Mantovani e la cooperativa Sodalitas, dove siede come presidente del consiglio di amministrazione la moglie Marinella Restelli. L’attività principale è la progettazione, costruzione e gestione della residenze socio assistenziali, le Rsa per anziani. Già nel 1996 dalla giunta guidata dal compagno di partito Roberto Formigoni arrivano oltre 14 milioni dai fondi sanitari come strutture accreditate per la cura degli anziani: la Regione rimborsa con soldi pubblici una quota della retta giornaliera. Nelle voci a bilancio anche 4 milioni e 300 mila euro a fondo perduto per costruire "infrastrutture sociali" proprio ad Arconate. A San Vittore Olona nel 1997 la fondazione acquista dalla parrocchia locale il diritto di superficie per 40 anni, grazie all'imprimatur del Pirellone che certifica con una delibera che il progetto «è finalizzato alla realizzazione di una Rsa per 60 anziani non autosufficienti». L'affare delle case di riposo si allarga e vengono inaugurate nuove strutture, tutte nel milanese. Nel 2003 la casa famiglia di Affori, periferia nord di Milano, e a pochi chilometri un altro centro a Cormano. E poi l'Hospice di Cologno Monzese con posti letto ad hoc per malati terminali e centro diurno. Gli affari non si arrestano neppure con le inchieste della magistratura che svelano la corruzione milionaria della sanità lombarda e travolgono l’ex governatore Roberto Formigoni: ad aprile 2012 altri 40 posti per il centro di Cormano. Oggi i posti letto sono oltre 400, un piccolo impero di residenze che ha permesso alla cooperativa Sodalitas di chiudere il bilancio 2011 con un giro d'affari di 18 milioni e utili per 687 mila euro. A conti fatti la Regione ogni anno stacca un assegno da 6 milioni di euro per le due creazioni di Mantovani. E nessun dubbio quando è stato il momento di decidere a chi assegnare l’assessorato alla sanità, una poltrona cruciale dove si decidono finanziamenti per quasi 8 miliardi di euro. L’uomo forte di Berlusconi doveva fare il custode di questo tesoretto.
Il tuttofare del potente politico forzista si dovrà occupare di: "analisi dei costi delle spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, oltre che presidio ai tavoli tecnici". Peccato abbia solo il diploma e nessuna competenza in materia, scrivono Marzio Brusini ed Ersilio Mattioni il 21 luglio 2014 “L’Espresso”. Mario Mantovani, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Sanità, ha garantito una consulenza da 16 mila euro per il suo autista-segretario, il 21enne Fabio Gamba, per occuparsi di “analisi dei costi delle spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, oltre che presidio ai tavoli tecnici”. C'è da chiedersi con quali competenze. E infatti è lo stesso Gamba il 6 maggio scorso in un comune alle porte di Milano, Arconate, a svelare l'arcano: “Non ho nessuna esperienza - dice - e questo potrebbe essere apparentemente un problema, ma in realtà fortunatamente so di poter contare sulla competenza e sull’esperienza del nostro fuoriclasse, Mario Mantovani”. O più semplicemente basta essere il vicepresidente della Regione, per procurare al proprio autista-segretario un incarico. Non di certo il primo perché già nel 2013, il “fuoriclasse” Mantovani assicura al suo tuttofare una consulenza, da maggio a dicembre, per 10 mila euro per svolgere mansioni ancora oggi avvolte nel mistero. Il sito web di Regione Lombardia, alla voce consulenze, non brilla per trasparenza e l’interessato, interpellato all’epoca dei fatti, aveva risposto in modo evasivo: “Lavoro nello staff del vicepresidente”. "Non ho nessuna esperienza, ma so di poter contare sul nostro fuoriclasse, Mario Mantovani". Chi parla è Fabio Gamba: 21 anni, diplomato al liceo di Arconate e autista dello stesso Mantovani. L'occasione per questo discorso è la presentazione, lo scorso 6 maggio, di una lista per le elezioni comunali. Dopo Gamba a prendere la parola è lo stesso Mario Mantovani, assessore della Sanità e vicepresidente forzista della Lombardia, che ricorda come lui preferisca "segnalare la gente di Arconate". Detto, fatto: l'autista tuttofare, senza alcuna competenza, ha ottenuto una consulenza al Pirellone da 16 mila euro per "analisi dei costi della spesa farmaceutica territoriale ospedaliera, oltre che presidio tavoli tecnici"di Ersilio Mattioni. Anno nuovo, consulenza nuova. Ed ecco il nome di Gamba compare ancora nell’elenco degli incarichi fiduciari, ai sensi della legge regionale 20 del 2008. La normativa, 57 pagine, regola ogni tipo di rapporto di lavoro dentro il Pirellone. Leggendo il testo ci si imbatte decine di volte nelle parole “merito”, “controllo” e “trasparenza”. Fino all’articolo 23, quello relativo alle segreterie degli assessori. Il comma 7 recita testualmente: “Può essere assunto personale esterno all'amministrazione regionale”. E tanti saluti, fatta salva la competenza che deve possedere chi riceve un incarico. Nello specifico, l’autista-segretario di Mantovani dovrà dimostrare di intendersene del costo dei farmaci e pure del lavoro utilizzo negli ospedali. E vantando solo un diploma al liceo linguistico di Arconate non deve essere particolarmente facile. Il curriculum del ragazzo di bottega di Mantovani è comunque ricco di spunti interessanti. Nel 2009 è in stage “presso la segreteria politica del sottosegretario di Stato Sen. Mario Mantovani in via Giolitti 20 ad Arconate”; nel 2010 fa l’educatore al “centro vacanze giovani di Igea Marina, in provincia di Rimini”, gestito da una cooperativa della famiglia Mantovani; nel 2011 lavora nella sede romana del fu ‘Popolo della Libertà’ in via dell’Umiltà; nel 2012 presta una collaborazione occasionale in Rai, sempre a Roma, dove però nessuno si ricorda del suo passaggio. E’ iscritto all’università Bocconi di Milano, anche se gli esami, causa la sua intensa attività al fianco del vicepresidente della Lombardia, vanno un po’ a rilento. Il suo curriculum si chiude con una perla: “Ulteriori informazioni: La mia più grande passione è la Politica”. ‘P’ maiuscola, per carità. Ma per quale motivo questa grande passione deve essere spesata dai lombardi con consulenze fantasiose? Spesata dai lombardi pure la spedizione del mese scorso in terra giapponese in occasione della festa della Repubblica: tre notti a Tokyo da 2 giugno al 5 giugno. La Procura di Busto Arsizio ha aperto un’inchiesta sulle missioni internazionali del ‘World Expo Tour’, alle quali lavora anche Maria Grazia Paturzo, una delle due donne che il governatore Roberto Maroni avrebbe fatto assumere nella società Expo 2015 (stipendio mensile: 5 mila euro), mentre l’altra, Mara Carluccio, è finita in Eupolis, ente controllato dal Pirellone. Per i magistrati bustocchi quello di Tokyo sarebbe stato un “viaggio in stile prima Repubblica”. Di diverso avviso il capogruppo di Forza Italia al Pirellone, Claudio Pedrazzini, ex assistente di Mantovani a Strasburgo nel 1999: “Il viaggio sarebbe finito nel mirino dei magistrati. Ma sulle altre missioni analoghe nessuno ha nulla da dire?” Difesa rocciosa. Ma Pedrazzini riesce persino a peggiorare la situazione: “A quel viaggio hanno partecipato quattro persone (doveva andare il presidente Maroni, sostituito il giorno prima della partenza dallo stesso Mantovani) e il costo totale è stato inferiore ai 25mila euro”. In pratica, 6 mila euro a persona. Fra volo, alberghi e ristoranti i rappresentanti della Regione devono essersi trattati bene. Assieme all’assessore alla sanità c’era anche, non è ben chiaro a che titolo, il suo autista-segretario Gamba. Il quale, lo stesso 2 giugno, postava su Facebook una foto di Mantovani a Tokyo con tanto di messaggio del vicepresidente lombardo, che con la consueta modestia si attribuiva il merito di aver portato Expo a Milano: “Questa mattina ho preso parte alle celebrazioni per la festa della Repubblica presso l'ambasciata italiana a Tokyo, in rappresentanza della Lombardia e del nostro paese. Dopo essermi impegnato nel 2008, da parlamentare europeo, affinché Milano ottenesse l'assegnazione di Expo 2015, in questi giorni con il ‘World Expo Tour’ stiamo promuovendo con soddisfazione l'evento in tutto il mondo. Buona festa della Repubblica a tutti! Viva l'Italia!”. Gamba, interpellato il 6 giugno di ritorno dal Giappone dal cronista Paolo Puricelli del settimanale ‘Libera Stampa l’Altomilanese’ sulle spese del viaggio, aveva replicato: “Fortunatamente posso pagarmelo da solo (la famiglia Gamba-Trimboli è fra le più ricche di Arconate). Visto però il vostro interesse per i miei viaggi, la prossima volta vi manderò una cartolina”. Intanto basterebbe sapere a che titolo possa redigere un'analisi dei costi della spesa farmaceutica degli ospedali lombardi. Per le cartoline c'è sempre tempo.
Mario Mantovani e Massimo Garavaglia intercettati mentre discutevano del nostro articolo. Che aveva anticipato il nuovo business delle ambulanze., scrive Gianluca De Feo su “L’Espresso” il14 ottobre 2015. Mario Mantovani e Massimo GaravagliaI due uomini chiave del potere lombardo si scrivono via sms. Da una parte c'è il leghista Massimo Garavaglia, assessore all'Economia e braccio destro del governatore Roberto Maroni, ora indagato. Dall'altra Mario Mantovani, berlusconiano della prima ora, vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità, da ieri in cella a San Vittore. A preoccuparli è un'inchiesta de “l'Espresso”, pubblicata a marzo 2014, che metteva in luce il cuore dello scandalo: “Assalto all'ambulanza. Fuori i volontari, il soccorso diventa un affare”. I due si stavano muovendo proprio per azzerare un appalto sul trasporto di pazienti in dialisi: undici milioni l'anno. Una torta che vede scendere sul sentiero di guerra una galassia di croci e associazioni di lettighieri, alcune professionali, altre di puro volontariato, diverse con agganci politici. Garavaglia manda quindi un messaggino a Mantovani, intercettato dalle Fiamme Gialle. «Su l'Espresso questa settimana ho trovato un articolo dal titolo Assalto all'ambulanza. Evidenzia quel che dicevamo ieri. Il servizio è ad alto rischio. Mi arriva qs per croce azzurra». La risposta è sintetica: «Sto lavorando martedì ne parliamo». E il leghista chiude la chat: «Grazie». Poche frasi, che vengono incluse nell'ordine di cattura per il numero due del Pirellone, perché secondo gli inquirenti evidenziano l'interesse di Garavaglia e le attività illecite di Mantovani per riaprire un appalto pubblico già chiuso. Una gara dove venivano richieste garanzie finanziarie e tecniche, che avrebbero tagliato fuori alcune realtà più piccole del soccorso. Come la Croce Azzurra Ticinia Onlus, sponsorizzata da Garavaglia che si sarebbe attivato con il ras della Sanità Mantovani. L'interesse dei due politici è convergente: Mantovani interviene sul vertice della Asl Milano 1 «affinché non venissero escluse Croci definite dallo stesso assessore “nostre”». A muovere la coppia di assessori ci sono interessi di campanile: le associazioni di volontariato operano nei “loro” comuni, in quell'area dell'hinterland milanese dove Garavaglia è stato sindaco e Mantovani all'epoca lo era ancora. Il sostegno alle Croci che gestiscono le ambulanze significa voti e consenso. Ma nel momento in cui le Onlus – che per definizione non dovrebbero avere finalità di lucro – entrano in affari da decine di milioni di euro, il quadro cambia radicalmente. Perché le autolettighe diventano di fatto un'azienda, che gestisce fondi e assunzioni. Proprio quello che per primo “l'Espresso” ha raccontato con l'inchiesta di Michele Sasso: “Assalto all'ambulanza. Il soccorso diventa un business. L'obiettivo non è più salvare ma incassare”. Parole che vengono sottolineate dall'assessore Garavaglia nel suo sms allarmato per l'articolo: «Fuori i volontari il soccorso diventa un affare». La nostra inchiesta descriveva la metamorfosi del settore, dove una deregulation strisciante trasforma le onlus in cavalli di Troia per le operazioni di politici e mafiosi, il tutto a danno del vero volontariato. Un'analisi confermata dalla procura di Milano: «Il problema di queste Croci è di tipo economico. Tali associazioni pur essendo state escluse dalla gara non solo vogliono recuperare l'affidamento del servizio ma lo vogliono a condizioni più favorevoli di quelle previste nella gara». Il procedimento per turbativa d'asta può apparire una storia piccola. Matteo Salvini parla di «un'indagine pazzesca su uno dei leghisti più seri e onesti. Lo accusano di avere cercato di dare una mano a un'associazione benefica». Certo. Ma questa vicenda mostra come pur di assecondare il desiderio di un assessore si arrivi a svuotare una gara di appalto pubblica già conclusa, innescando un circuito colossale di conflitti di interesse fino a raggiungere il risultato. Vengono mobilitati decine di dirigenti regionali e funzionari delle Asl per garantire incassi di poche migliaia di euro alla Croce Azzurra Ticinia tanto cara a Garavaglia. E proprio seguendo le mani che si sono mosse per gestire questa pratica i magistrati hanno ricostruito gli assetti di potere nella Regione. Monitorando così i rapporti di forza tra Lega, Forza Italia e Ncd; i settori di lottizzazione e la mappa dei centri di spesa nella sanità pubblica dell'era Maroni. Un'attività di indagine che potrebbe presto portare a vicende molto più rilevanti delle ambulanze.
Sanità, il soccorso diventa business. L'obbiettivo non è salvare, ma incassare. In Italia si spendono ogni anno un miliardo e mezzo di euro per gli interventi di soccorso. Una pioggia di soldi che fa gola a politica e mafia, scrive Michele Sasso su “L’Espresso”. Esistono mestieri in cui la professionalità non basta, ma servono una motivazione profonda e una disponibilità totale. Per questo far parte dell’equipaggio di un’ambulanza è sempre stata un’attività per volontari, animati dallo spirito degli angeli custodi. Ogni chiamata al 118 è questione di vita o di morte, una corsa che in pochissimi minuti decide il destino di una persona. Il paziente è nelle mani dell’abilità del guidatore a destreggiarsi nel traffico, della capacità del personale nel massaggio cardiaco e nella rianimazione. Adesso invece anche il soccorso d’emergenza sta diventando un ricco business: in Italia si spende un miliardo e mezzo di euro per garantire gli interventi. Oggi si punta al profitto, tagliando sulla qualità, risparmiando sui mezzi e imbarcando soggetti senza qualifica. Una torta che attrae interessi spregiudicati e lottizzazioni politiche, un serbatoio di soldi facili e posti assicurati. Perché il settore di fatto è stato investito da una deregulation, che rischia di creare un Far West a sirene spiegate. Il ministero della Salute ha ceduto i controlli alle Regioni, che preferiscono affidarsi ai privati. Dalla Lombardia alla Calabria, dal Lazio alla Sicilia è scattato l’assalto all’ambulanza. Nunzia De Girolamo ha perso la poltrona di ministro proprio per uno scandalo sugli appalti del 118. Ovunque sono segnalati disservizi e a Sud nella mangiatoia si è infilata persino la criminalità. Questo ai danni di oltre 150 mila volontari, che vengono scacciati per fare spazio a organizzazioni spregiudicate. «Ci sono finti volontari che ricevono lo stipendio in nero mascherato da rimborso», spiega Mario, soccorritore di Torino. Il metodo è uguale da Milano a Napoli: le associazioni di pubblica assistenza, le cosiddette “Croci”, si iscrivono all’albo regionale e sgomitano per accaparrarsi le corse. L’obiettivo non è più salvare, ma incassare. «Abbiamo scoperto persino casi di autisti alcolizzati e soccorritori zoppi», racconta Mirella Triozzi, responsabile del settore per il sindacato medici italiani: «Con l’arrivo dei privati il soccorso è diventato un colossale affare, dimenticando che in ballo c’è la sopravvivenza di migliaia di persone». In Puglia le 141 basi delle ambulanze costano 68 milioni di euro l’anno. La pioggia di denaro pubblico ha scatenato la concorrenza tra decine di onlus, che sgomitano per conquistare le postazione delle ambulanze: averne tre (il massimo consentito) significa fare bingo e incassare 120mila euro ogni mese. «Ai presidenti delle associazioni rimangono in tasca 6 mila euro al mese», riconosce Marco De Giosa, responsabile del 118 della Asl di Bari. C’è più di un sospetto su come siano stati assegnati gli incarichi: la procura del capoluogo sta indagando su un sistema di tangenti che sarebbero state smistate ai funzionari arbitri degli appalti. Stando alle inchieste, i controlli fanno acqua da tutte le parti. Nessuno ha mai chiesto la fedina penale a Marcello Langianese, ex presidente dell’Oer, Operatori emergenza radio, un ente morale con 50 ambulanze e decine di dipendenti. Langianese era il manager del soccorso che gestiva diverse postazioni tra Bari e Modugno. Mentre veniva stipendiato per salvare i pazienti, è accusato di avere architettato una rapina clamorosa. Secondo i carabinieri ha avuto un ruolo chiave nell’attacco contro un furgone portavalori nel centro di Ortona: un colpo che ha fruttato quasi due milioni e mezzo di euro. Nella regione per il business delle ambulanze si combatte persino con le bombe incendiarie, che hanno distrutto i mezzi di alcune onlus a Bari, Trani, Barletta e Foggia. A Turi, sempre nel Barese, hanno bruciato un’autolettiga nuova di zecca. L’ipotesi investigativa è che si tratti di avvertimenti criminali. Per evitare che le associazione di volontari possano spezzare il monopolio di un cartello che invece agisce solo a scopo di lucro. L’intercettazione è esplicita: «Quando ti chiamano e abbiamo bisogno a quell’orario di un’autoambulanza, mi fotto 1500 euro». È agli atti dell’inchiesta sui Lo Bianco, la cosca di Vibo Valentia che dominava la Asl locale, e spiega come ogni uscita a sirene spiegate si trasforma in denaro contante. Guadagni sicuri, costi ridottissimi: per entrare nel settore non sono richieste competenze particolari. L’imprenditore mette il capitale, acquista o noleggia i mezzi e cerca gli autisti. Va bene chiunque. Uno degli indagati è stato registrato mentre ingaggia il personale: «La guideresti l’ambulanza? La patente è quella della macchina, sono 800 euro puliti». Non è l’unico caso. Nello scorso luglio è emersa la vicenda della Croce Blu San Benedetto di Cetraro nel Cosentino. I magistrati sostengono che a gestirla fosse Antonio Pignataro detto “Totò Cecchitella”, seppur privo di incarichi ufficiali. Pignataro non è una pedina qualunque: è stato arrestato per i legami con il boss Franco Muto, “Il re del pesce”. Quanti interessi si muovano dietro i 118 “liberalizzati” lo ha fatto capire la vicenda che ha travolto Nunzia De Girolamo. Le registrazioni dei colloqui tra l’esponente del centrodestra e i vertici della sanità sannita mostrano l’opacità del settore. Sono riuniti nel giardino di famiglia e Nunzia chiede: «In tutto questo si deve fare la gara?». La discussione verte su come “bypassare la gara pubblica” e favorire un’impresa amica. In quel luglio 2012 l’atmosfera attorno alle ambulanze di Benevento è incandescente, con i lavoratori che protestano per il mancato stipendio. Il servizio è nelle mani di due imprese: la Modisan e la Sanit che lo gestiscono in proroga intascando oltre quattro milioni di euro l’anno. La prima è molto vicina alla regina del Sannio, tanto da aver contribuito finanziariamente al congresso del suo partito. L’altra ditta, invece, non è allineata: «Quelli non li voglio», dice Michele Rossi, l’uomo messo dall’ex ministro alla guida dell’Asl. La lottizzazione riguarda pure la rete dell’assistenza, sfavorendo la copertura nei comuni guidati da giunte non allineate. Come racconta Zaccaria Spina, sindaco di Ginestra degli Schiavoni a 40 chilometri dal capoluogo:«Per venire da noi l’ambulanza ci mette un’ora. I cittadini ormai si sono rassegnati e se c’è un’emergenza si mettono in auto e scappano. Scoprire cosa c’era dietro quelle scelte dà molta amarezza». Nel Lazio uno strano appalto agita i sonni dell’agenzia regionale che gestisce migliaia di ambulanze. La cronica mancanza di risorse ha portato l’ex governatrice Renata Polverini a concedere ai privati quaranta basi, le postazioni dalle quali partono gli equipaggi che coprono la provincia di Roma. Un affare da dieci milioni l’anno, senza gara: vengono assegnate per affidamento diretto alla Croce rossa italiana. Un’istituzione storica seppur piena di debiti, che decide di “girare” l’attività operativa a una srl di Milano, la Cfs costruzioni e servizi: una società specializzata in pulizia e manutenzione di immobili, che applica la logica del ribasso. Così al personale assunto per la missione capitolina viene offerto un contratto singolare: quello da animatore turistico. Soccorritori trattati come se lavorassero in un villaggio vacanze. Perché? Semplice: con questo contratto si risparmia un terzo della paga. Solo dopo un esposto del sindacato è scoppiato il caso. «In questo settore c’è il divieto di dare subappalti, eppure è quanto ha fatto la Croce rossa con l’aggravante di aver avallato condizioni di lavoro ridicole», accusa Gianni Nigro della Cgil Lazio. In Sicilia anche le ambulanze sono diventate uno stipendificio: un pronto soccorso per favorire assunzioni di massa. Nel 2002 grazie a un corso per formare i guidatori-soccorritori con prove di guida banali e surreali test di comunicazione, ben 1600 persone vennero imbarcate in una società creata da Regione e Croce Rossa per garantire il salvataggio nell’isola. Un colosso con un totale di 3300 dipendenti. Che secondo la Corte dei Conti ha prodotto uno spreco di denaro pubblico. L’allora presidente Totò Cuffaro è stato condannato a pagare un danno erariale da 12 milioni per quell’infornata di autisti e soccorritori. Troppi. E troppo costosi. In Sicilia si spende per un’autolettiga 440 mila euro l’anno, contro 100 mila della Toscana. La ragione? Molte macchine sono praticamente ferme o escono solo per tre interventi al mese. L’ultima truffa da venti milioni di euro l’ha scovata l’assessore alla Salute Lucia Borsellino: negli ultimi due anni 160 dipendenti sarebbero stati regolarmente stipendiati mentre in realtà rimanevano a casa. Oltre 600 mila ore non lavorate ma retribuite. Nonostante lo sperpero di denaro, l’assistenza non soddisfa. E la giunta Crocetta ora vuole schierare la cavalleria dell’aria: sei elicotteri, con un costo per il noleggio di 178 milioni in sette anni. Non è una questione solo meridionale. Dietro le sirene si scoprono ovunque storie di sfruttamento e drammatici disservizi. In Lombardia ogni anno il Pirellone stanzia 315 milioni per dare assistenza rapida: ogni intervento è una fattura e inserirsi nelle metropoli permette di moltiplicare i guadagni. Ma a Milano un incidente stradale ha scoperchiato un sistema marcio: l’ambulanza ha bruciato un semaforo e si è andata a schiantare. Si è scoperto che l’autista non dormiva da tre giorni. Da lì sono partite le indagini che hanno svelato quanto sia pericolosa la trasformazione del soccorso in business: precari a bordo pagati a cottimo e obbligati a turni massacranti, mezzi fuori norma, corsi d’addestramento fantasma. Tre inchieste parallele della Finanza in corso dal 2010 stanno svelando lo stesso meccanismo di truffe e peculato. Con risultati raccapriccianti: i responsabili di tre onlus - Croce la Samaritana, Ambrosiana e San Carlo - usavano il denaro pubblico destinato alle emergenze e alla formazione per le loro vacanze, per l’asilo dei figli, scommesse ai videopoker, le auto personali e perfino l’acquisto di una casa. Spese senza freno e i rischi scaricati su migliaia di feriti. Loro stessi ne erano consapevoli e dicevano cinicamente: «Se stai male non chiamare le nostre ambulanze sennò muori». Hanno collaborato Antonio Loconte, Piero Messina, Claudio Pappaianni e Giovanni Tizian.
Mantovani, la notte insonne in cella. «Io, all’inferno da innocente». In carcere non ha potuto leggere i giornali. «Sono stato molto massacrato?», chiede il vice presidente della giunta regionale ed ex assessore alla Sanità, scrive Simona Ravizza su “Il Corriere della Sera”. Le lacrime in una notte insonne, la prima a San Vittore, passata a pensare ai figli, Lucrezia e Vittorio, tutti e due chiamati a raccolta l’altra mattina, «per un abbraccio e un saluto», prima di essere portato in carcere. Quando la Guardia di Finanza martedì si è presentata all’alba a Cascina Vittoria, l’abitazione di Arconate, Mario Mantovani, il «Faraone della Lombardia» arrestato per corruzione, pensava a una perquisizione, com’era già avvenuto del resto per il suo architetto di fiducia, Gianluca Parotti: «Mai mi sarei aspettato di finire qui», dice l’ex assessore della Sanità e numero due della Regione a chi è andato a trovarlo. All’avvocato Roberto Lassini, amico di vecchie campagne contro i pm ai tempi dei processi contro Silvio Berlusconi e oggi suo legale, consegna la linea di difesa: «Sono finito in un inferno da innocente». Con gli amici politici, invece, si lascia andare all’amarezza: «La mia immagine politica è distrutta». Cella 117, Terzo raggio, quello destinato ai colletti bianchi finiti nelle grane con la giustizia, dieci metri quadrati con un letto a castello e un altro di fianco. Una mini-cucina e il bagno. La televisione sempre accesa. Ora il suo mondo è questo. Mantovani vuole seguire in diretta le notizie che lo riguardano. Non può leggere i quotidiani e chiede informazioni, il desiderio è sapere quel che si dice - e scrive - fuori: «Sono stato molto massacrato?». In tuta da ginnastica scura, le scarpe da tennis, il volto segnato di chi ha trascorso la notte in prigione. Dopo tutti i dossier scottanti che ha maneggiato come assessore alla Sanità (prima che il governatore Roberto Maroni lo silurasse), adesso sfoglia nervosamente le 216 pagine con le accuse che l’hanno portato in carcere. Per «una spiccata attività criminale», scrive la Procura. Sull’ordinanza Mantovani mette punti interrogativi, punti esclamativi e parentesi. Prima di costruire un impero di case di riposo, foraggiate con soldi pubblici, era un insegnante: e adesso - racconta chi l’ha visto - sembra un docente impegnato a correggere i compiti a casa. Uno dei suoi compagni di cella, a San Vittore da 14 anni, prepara un piatto di spaghetti anche per lui. Ma lo sguardo torna subito sulla porta d’acciaio blindata e con il finestrino. La sensazione è quella di sentirsi rovinato. Anche se Mantovani è determinato a difendersi. Tra chi l’ha incontrato in carcere c’è anche Matteo Salvini, il leader della Lega, entrato a San Vittore non tanto da politico, ma come uomo preoccupato per le condizioni di un altro detenuto, il braccio destro di Mantovani Giacomo Di Capua, anche lui agli arresti per corruzione. È diventato papà da pochi giorni. Gli amici più stretti hanno sempre definito Mantovani «un uomo a cui spari, ma non riesci a fargli uscire sangue», proprio per la sua capacità di restare impassibile in qualsiasi situazione. Ma la giornata in carcere è lunga e l’avvocato Lassini è preoccupato: «Temo per la sua tenuta psicofisica - dice -. L’ho visto provato anche se è un uomo forte. Nei suoi occhi ho trovato lo smarrimento che fu il mio 20 anni fa (Lassini fu arrestato da sindaco di Turbigo, ma poi assolto, ndr ). Quello di un innocente».
COME NEL 92. Filippo Facci su "Libero Quotidiano": "E' tornata Tangentopoli".
Ma che bell'autunno tiepido: sembra di essere tornati al 1992, quando gli arresti erano un festival e ogni regola veniva stravolta con gioia e soavità. Naturalmente non ci sogniamo nemmeno di entrare nel merito delle accuse rivolte al vicegovernatore della Lombardia Mario Mantovani (più altri sei, compresi un suo collaboratore e un ex assessore regionale leghista) anche perché dalle carte non si capisce niente, o quasi, ma contiamo che per gli inquirenti sia diverso. Se dovessimo affidarci a quanto scritto da agenzie di stampa come LaPresse - che di norma bada al succo - dovremmo infatti accontentarci di roba così: «Per il gip Stefania Pepe, Mantovani andava arrestato perché gli "interessi illeciti" suoi e "dei suoi familiari" e la "fittissima rete di relazioni che il politico vanta nel territorio di Arconate di cui è stato sindaco per oltre dieci anni (e non solo) che potrebbe essere efficacemente strumentalizzata dall' indagato sia al fine di perpetrare ulteriori illeciti che di porre in essere attività svolte ad inquinare le prove, altresì del perpetuarsi ad oggi - secondo le più recenti acquisizioni investigative - delle già accertate dinamiche delittuose"». Chiaro, no? Ma stiamo barando: avevano detto che non entravamo nel merito. Dunque, a proposito di manette e clima da revival, limitiamoci a notare che:
1) Mantovani è stato arrestato all' alba a casa sua, ma fuori c'erano già cronisti e fotografi ad attenderlo: l'hanno anche salutato. Significa che lo sapevano da almeno la sera prima. Bello, bravi, la gente deve sapere.
2) Secondo quanto riferisce il suo legale, l'arresto è di ieri mattina all' alba, appunto: ma la richiesta del pm risale al settembre 2014. Più di un anno per la convalida. E dopo più di un anno, beh, non c'era altra strada che scegliere proprio il giorno in cui Mantovani doveva aprire i lavori della «Giornata della Trasparenza» organizzata dalla Giunta e dal Consiglio regionale. Niente di strano che il presidente Roberto Maroni, che doveva intervenire, abbia cambiato programma.
3) E niente di strano che le manette abbiano eccitato i Cinque Stelle tipo il capogruppo Dario Violi, che col suo bell'accentone di Costa Volpino (Bergamo) si è presentato al convegno con una mezza cassa di arance da associarsi tipicamente alla galera di Mantovani: senza sapere tra l'altro - come pochi sanno - che in carcere le arance sono proibite, al pari di angurie e banane. Senza sapere, in realtà, nulla di quanto andava succedendo. Ma c'erano le telecamere. È bastato.
4) Quanto alla necessità dell'arresto («extrema ratio») passa la voglia di occuparsene, ormai. Mantovani non era più un assessore «pesante» da tempo, si era dimesso dall'assessorato alla Salute (fulcro dei presunti illeciti, da quanto inteso) ed era soltanto assessore ai Rapporti con l'Unione Europea, alla Programmazione comunitaria e alle Relazioni internazionali: poltrone più che altro di rappresentanza. Fa niente, l'arresto era necessario lo stesso. Anzi, le dimissioni a quanto pare lo hanno favorito. Pericoli di fuga? È un anno che si vocifera dell' arresto: e Mantovani - i cui interessi economici non si spostano dalla Lombardia - non si è mai mosso. Tuttavia le cariche pubbliche e imprenditoriali, nonché la lunga carriera politica di Mantovani, nell'ordine d'arresto vengono snocciolate come indizio sostanziale di pericolosità sociale: le carte del gip sembrano un approfondito curriculum. Non ci sono di mezzo mazzette, comunque: ci sono utilità personali accumulate in una vita da politico. Secondo l'accusa sono illecite, secondo la difesa no. Difficile cogliere la necessità di un arresto proprio ora.
5) L'arresto di Mantovani fa calare la tela sulla presunta «tregua per Expo» concessa dalla procura di Milano e considerata, più o meno da tutti, come qualcosa di assodato e soprattutto lecito: peccato che la Costituzione, nonché l'obbligatorietà dell' azione penale, non contemplino niente del genere. Fu vera tregua? L'invito alla moderazione causa Expo (palesemente benedetta da Governo, Quirinale, Confindustria, Csm e procura di Milano) ha inaugurato un'ambiguità da cui ora pare difficile districarsi. Siamo a ottobre: significa che la tregua è finita, visto che sta per chiudere anche Expo? Dunque la tregua c' era? Dunque l' azione penale può andare ufficialmente a velocità differenziata, come in realtà sappiamo benissimo che - da sempre, in Italia - possa andare non ufficialmente? Se l'arresto di Mantovani era stato richiesto più di un anno fa, significa che, senza la tregua Expo, l' avrebbero ingabbiato prima? Sono tutte domande cervellotiche e da giornalisti all' italiana: ma che il fantasma della tregua Expo purtroppo ora autorizza. Se davvero Expo ha congelato inchieste e manette, aver caldeggiato Expo potrebbe divenire un indizio di colpevolezza. Avvisati.
Caso Mantovani: sta’ a vedere che ora i pm s’inventano anche la “mafia meneghina”, scrive Tiziana Maiolo su "Il Garantista. Chissà se nel corso dell’interrogatorio di garanzia cui sarà sottoposto oggi nel carcere milanese di San Vittore,al vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani, arrestato due giorni fa, sarà contestato anche il reato di associazione mafiosa. Non ci sarebbe di che stupirsi, ci troveremmo di fronte a una riedizione lombarda di “Mafia capitale”, una sorta di “Mafia meneghina”, insomma. Del resto, che cosa aspettarsi da un’inchiesta che i magistrati hanno voluto battezzare con il nome di “entourage”, quasi a voler processare un intero ambiente invece che singole persone? Si ha la sensazione, leggendo la corposa ordinanza di custodia cautelare, che i soliti noti hanno diffuso a piene mani ai giornalisti, che ormai, a Roma come a Milano, l’unico modello processuale possibile sia quello nel quale si perseguono i reati di mafia. Cioè il modello del maxiprocesso, nel quale si giudicano più gli ambienti e le situazioni che non – come invece vorrebbe il codice del 1989, che prevede un sistema di tipo accusatorio – il singolo imputato e il singolo reato. Ecco quindi che, nel caso di Mario Mantovani, si spendono molte pagine per elencare gli incarichi politici che nel corso del tempo il vicepresidente della Regione Lombardia ha ricoperto, quasi come se fosse strano che una persona di 60 anni si sia candidata diverse volte e diverse volte sia stata eletta (tra l’altro alle elezioni europee con il sistema delle preferenze e altrettanto alle regionali, in cui è arrivato primo tra i candidati di tutti i partiti con 13.000 preferenze). Tutto ciò evidentemente rappresenta un’aggravante, agli occhi di pubblici funzionari con carriera garantita, quali sono i magistrati. Fatto sta che, mentre a Roma stanno ancora contando gli scontrini di Ignazio Marino, per il quale nessuno tiene conto del fatto che è diventato sindaco con regolari elezioni e non con un colpo di Stato, ecco che si sgancia la bomba su Milano. Le elezioni di primavera sono servite. Se ne accorge anche la Lega (che non è proprio campionessa di garantismo) questa volta, dato che tra gli indagati spicca anche una figura di primo piano di quel partito e della Regione Lombardia, l’assessore al Bilancio Massimo Garavaglia. Il quale è indagato insieme a Mantovani per un episodio in realtà secondario, ma che ha acceso la fantasia della stampa perché riguardava il trasporto di pazienti dializzati e la richiesta che questo servizio fosse prorogato (per novanta giorni) in capo a un’associazione di volontariato prima di effettuare la gara. Una sorta di “raccomandazione”, insomma. Non certo una gara truccata. Sufficiente a giustificare un arresto? Mah. Ma c’è altro, ovviamente. E riguarda l’interessamento dell’assessore Mantovani nei confronti della carriera di un funzionario del provveditorato delle Opere pubbliche e parcelle non pagate a un architetto, che sarebbe stato compensato con qualche consulenza. È sufficiente tutto ciò per montare la panna e di conseguenza specchiarsi nelle prime pagine dei giornali al grido di “è tornata tangentopoli”? È tanto evidente il fatto che si è costruito un monumento su episodi più o meno commendevoli per creare il caso politico, che il Gip ha impiegato un anno a decidere sulle richieste di custodia cautelare, chieste dal Pm esattamente 12 mesi fa. Tanto che non c’è attività investigativa del 2015, ma fatti che vanno dal 2012 al 2014. Quanto tempo ci vorrà a far sgonfiare il soufflé? O davvero vogliamo davvero inventarci, dopo “Mafia capitale”, anche “Mafia meneghina”?
Mantovani reo di «consenso». Ecco i buchi neri dell'inchiesta. Incongruenze nelle accuse al vicepresidente della Regione Lombardia: dalle tangenti inesistenti alle «pressioni» negate dalla stessa vittima, scrive Luca Fazzo su “Il Giornale. C'è una vittima presunta che nega di essere una vittima. Ci sono favori promessi e in realtà mai ottenuti. Lavori fatti per la collettività e contestati invece come vantaggi personali. Nell'inchiesta che ha sbattuto in una cella di San Vittore il vicepresidente della Lombardia Mario Mantovani, vi sono indubbiamente spaccati eloquenti di un andazzo dove all'interesse pubblico si soppianta spesso quello del politico, della sua cordata, del suo bacino elettorale; e vi è altrettanto evidente il conflitto di interessi potenziale di uno stesso individuo che è businessman dell'assistenza e assessore alla Sanità. Ma vi sono anche buchi neri e incongruenze che lasciano alla difesa di Mantovani spazi ampi per una battaglia con la Procura che si annuncia aspra: a partire dalla richiesta di scarcerazione che quasi certamente l'avvocato Roberto Lassini, difensore di fiducia dell'ex senatore, presenterà dopo l'interrogatorio di oggi. Mantovani è accusato di concussione ai danni di Pietro Baratono, provveditore alle Opere pubbliche della Lombardia, per averlo costretto ad riaffidare incarichi operativi a Angelo Bianchi, un funzionario che era stato messo da parte in quanto inquisito per corruzione. A verbale, Baratono parla di «pressioni molto decise» da parte di Mantovani, ma dopo l'arresto dell'ex senatore, parlando col Giornale , ha modificato il tiro: «Non pressioni, direi consigli». Sta di fatto che Baratono si guardò bene dal denunciare le pressioni o i consigli di Mantovani, rimise Bianchi al suo posto, e ai pm spiegò: «Su Bianchi ho successivamente maturato un giudizio personale nel corso di quell'anno». «Tangenti sui dializzati», titolano ieri i giornali sull'arresto di Mantovani, affrontando il tema eticamente più delicato dell'affare, l'appalto per il servizio di trasporto pubblico dei nefropatici. In realtà, la Procura non ipotizza che siano passate tangenti, tant'è vero che a Mantovani e all'assessore Massimo Garavaglia viene contestato solo il reato di turbativa d'asta. I due sarebbero intervenuti per consentire ad alcune associazioni di volontariato della loro zona di continuare a svolgere il servizio («Te lo segnalo prima che poi ci rompono le balle che abbiamo escluso la croce azzurra», dice Garavaglia a Mantovani). E ieri al Giornale il presidente della onlus che Mantovani avrebbe «miracolato», la Ticinia, spiega: «Non abbiamo chiesto nessuna raccomandazione, abbiamo solo scritto a tutte le istituzioni che alle gare d'appalto non avrebbe potuto partecipare l'intero mondo del volontariato, che statutariamente non può svolgere servizi commerciali. E infatti noi quel servizio non lo svolgiamo più». L'accusa di corruzione mossa a Mantovani riguarda gli appalti e gli incarichi pubblici che avrebbe fatto avere all'architetto Gianluca Parotti in cambio di una serie di lavori svolti per lui dal professionista gratuitamente o a prezzo ridotto. Alcune di queste prestazioni riguardano Mantovani e i suoi familiari, ma altre sono state effettuate da Parotti a favore della collettività di Arconate. Ma Mantovani ci guadagnava ugualmente, dice il giudice, perché era il sindaco del paese e in questo modo «si avvantaggia in termini di consenso».
Istituzioni e fratture, le nostre regole perdute, scrive Sabino Cassese su “Il Corriere della Sera” del 30 ottobre 2015. Che brutto spettacolo! Un sindaco rivelatosi inadatto a svolgere la sua funzione, che prima si dimette, poi ritira le dimissioni. Funzionari della Agenzia delle Entrate che si rivoltano contro la Costituzione e la Corte costituzionale, sostenendo che è legittimo essere promossi senza concorso. Giudici amministrativi che esprimono opinioni su materie sottoposte al loro giudizio e critici che pretendono decisioni che i giudici non possono prendere, perché richiedono una legge. Una Procura che inizia una indagine sul vertice della Banca d’Italia, per poi dichiarare che la questione è tutta da verificare e da valutare. Il presidente dell’Autorità anticorruzione, chiamato a svolgere compiti onerosi e importanti, che dà pagelle alle città. Parlamentari che preannunciano bordate di emendamenti a documenti finanziari che dovrebbero essere o accettati o respinti. Sembra che tutti abbiano deciso di mettersi a giocare con le istituzioni, chi facendo appello al popolo, chi debordando dal suo compito, chi dimenticando le regole, chi cercando dalle corti quel che solo il Parlamento può dare, chi dando voce agli interessi più disparati, a danno dell’equilibrio di bilancio. È una specie di «rompete le righe», dal quale saggiamente il governo si è tenuto fuori, ma che richiede una riflessione sullo stato delle nostre istituzioni e sul modo nel quale esse vengono usate da chi le gestisce, mettendole - come è stato giustamente rilevato - sotto «stress». Questi sono casi che i sociologi chiamano di anomia, ovvero di assenza di norme o di disprezzo delle norme, siano esse leggi, siano esse regole di correttezza. E l’anomia danneggia la collettività. Mentre il sindaco di Roma dà e poi ritira le dimissioni, preoccupandosi solo del proprio ruolo, chi si interessa della città? I funzionari dell’Agenzia delle Entrate promossi senza concorso protestano e cercano sanatorie impossibili, ma chi si interessa di fare regolari concorsi per coprire quei posti? Poco opportunamente un magistrato del Consiglio di Stato ha manifestato opinioni su una questione che doveva decidere, mentre dall’altra parte si voleva la trascrizione in Italia dei legami familiari stabiliti fuori d’Italia. Così si perde di vista il vero problema, già indicato da anni dalla Corte costituzionale: bisogna dare riconoscimento a questi legami, e deve farlo il Parlamento. Era proprio necessario che la procura di Spoleto rendesse pubblica la notizia della indagine sulla Banca d’Italia prima di verificare e valutare la consistenza delle accuse, specialmente se si considera che si tratta di corruzione, abuso d’ufficio e truffa e che si procede nei confronti di una istituzione che regge le sorti del sistema bancario? Ha considerato la Procura la ferita che viene così inferta alla fiducia che deve circondare il credito e chi lo controlla? Il presidente Cantone ha un compito molto pesante: quel che importa è che continui a svolgerlo, senza distrazioni. La Costituzione vuole che i documenti finanziari, che necessariamente richiedono il rispetto di un equilibrio tra entrate e spese, siano elaborati e presentati dal governo al Parlamento: se questo si mette a riscriverli, con migliaia di emendamenti, dove va a finire l’equilibrio di bilancio? Abbiamo dimenticato tutti lo splendido finale di uno dei capolavori di Federico Fellini, Prova d’orchestra (1979), quello nel quale il direttore ricorda agli orchestrali, con accento tedesco, «ognuno deve dedicare attenzione al suo strumento. Le note salvano noi. La musica salva voi. Aggrappatevi alle note, seguite le note. Noi siamo musicisti, voi siete musicisti. E siamo qui per provare».
Anas, Rete ferroviaria italiana. Siamo un Paese marcio? Gli anticorpi da costruire contro la corruzione. Sembriamo incapaci di reagire a un male endemico. Invece tanti segnali dalla società civile ci dicono che non è così: possiamo adeguarci ai virtuosi standard internazionali, scrive Dario Di Vico su “Il Corriere della Sera” del 30 ottobre 2015. Accade spesso che la prima notizia importante del mattino sia un arresto, una retata o una nutrita serie di perquisizioni «in diverse città d’Italia». Ieri si è trattato di Rete ferroviaria italiana, qualche giorno prima dell’Anas, la settimana addietro di un grande Comune. I primi commenti che cominciano quasi subito a circolare in Rete recano «vergogna» come parola chiave e sono solo l’inizio di un fiume di improperi, recriminazioni, e insulti che ci accompagna fino ai talk showdella prima serata. Il motivo conduttore della corrente di indignazione è che siamo un Paese marcio, destinato a scomparire dalla mappa geo-politica del globo e che siamo riusciti a collezionare i peggiori amministratori pubblici del pianeta, i più corrotti funzionari dello Stato e gli imprenditori più infingardi che ci siano in circolazione nell’orbe terracqueo. Un’affermazione di questo tipo se fatta in pubblico garantisce quasi sempre applausi a manetta e i più bravi nello scandirla arrivano a conquistarsi una standing ovation. A dar loro ragione uscirà di sicuro nei giorni successivi una ricerca di un organismo internazionale che attesterà come il nostro Paese sia ormai al quattrocentesimo posto delle graduatorie mondiali della trasparenza appena sopra la Colombia dei narcos. Ma è davvero così? Siamo un Paese che ha perso totalmente la virtù e nel quale il malaffare avanza incontrastato? Per rispondere a domande così impegnative conviene procedere per approssimazioni successive. La prima riguarda il legame tra ampiezza della presenza pubblica in economia e diffusione della corruzione. Se a Roma saccheggiare l’Atac è diventato l’obiettivo numero uno del partito della mazzetta, è anche perché si è ridotto il perimetro dell’economia pubblica a disposizione delle incursioni affaristiche. Le privatizzazioni non saranno state uno straordinario esempio di politica industriale ma hanno comunque delimitato la presenza dello Stato e statisticamente ridotto le occasioni di corruzione. È chiaro che si tratta di una considerazione di carattere quantitativo, non sosterrei mai che basta privatizzare per eliminare il malaffare, mi limito a dire che è una condizione utile e che quando si verifica obbliga i faccendieri a ridurre il raggio delle proprie ambizioni. Se deve rubare su mense per i migranti e forestali siciliani il partito della corruzione registra un arretramento e non certo un’avanzata. Un ragionamento analogo si può fare in merito al valore aggiunto sprigionato dalla società civile italiana. Tradizionalmente grazie ai corpi intermedi il nostro tessuto sociale ha svolto un ruolo di coesione e di solidarietà che spesso ha surrogato l’assenza di politiche pubbliche efficaci. Abbiamo un terzo settore più ampio di altri Paesi anche perché l’azione dal basso ha fatto da surrogato alla carenza di indirizzi top down. Se fino al Novecento la società civile ha garantito questo tipo di legature con i processi di internazionalizzazione il suo ruolo è cambiato. Ha saputo in qualche maniera intercettare il cambio di paradigma e ha preso come riferimento la media di quello che fanno gli altri europei. Questo processo ha generato una crescita diffusa di competenze sottoposte a concorrenza internazionale e quindi vere. La ragione forte della differenza tra Milano e Roma, evocata da Raffaele Cantone, sta proprio nella diversa qualità delle rispettive società civili, nella loro differente esposizione al confronto (quantomeno) continentale. So bene che anche in questo caso tutto ciò non garantisce la morte della mazzetta ma ne riduce solo statisticamente — uso ancora questo avverbio — la frequenza. C’è quindi tanto da monitorare e studiare sull’evoluzione delle nostre società anche per capire come cambia la corruzione e questo compito tira inevitabilmente in ballo giornalisti e magistrati. Troppo spesso anche loro vittime della pigrizia.
L’INTELLIGENZA E’ DI SINISTRA?
Le persone di sinistra sono più intelligenti? Si Chiede su “La mente è Meravigliosa”. “Tutti i giorni la gente si sistema i capelli, perché non il cuore?” Vi sembra una frase intelligente? Queste parole sono state formulate dalla mente di Ernesto Che Guevara, il famoso rivoluzionario. Ci sono molte altre citazioni epiche di questo mito che sono sopravvissute fino ai giorni d’oggi. Ciò ha forse a che vedere con la sua ideologia di sinistra? Uno studio della Brock University sostiene di sì. Lo studio della Brock University nell’Ontario, Canada. Secondo i risultati ottenuti dai ricercatori della Brock University, nell’Ontario, Canada, coloro che sono meno intelligenti già durante l’infanzia sviluppano un’ideologia di destra e tendenze razziste e omofobe, rispetto alle ideologie di sinistra, che sono più aperte e comprensive. Per giungere a questa conclusione, i ricercatori si sono basati su studi condotti negli anni 1958 e 1970 nel Regno Unito. Questi studi analizzarono il livello d’intelligenza di migliaia di bambini tra i 10 e gli 11 anni, che poi risposero a domande di politica una volta raggiunta l’età di Cristo, 33 anni. Tra le domande poste ai bambini ormai adulti, c’erano questioni riguardo i pregiudizi di vivere affianco a vicini di una razza diversa o sulle preoccupazioni che sorgono quando bisogna lavorare con qualcun altro. Altre domande alle quali dovettero rispondere i soggetti riguardavano l’ideologia politica conservatrice, come rendere più severe le pene dei criminali o mostrare ai bambini la necessità di ubbidire all’autorità. Le persone di sinistra sono davvero più intelligenti? Alcune delle conclusioni a cui sono giunti i ricercatori della Brock University sostengono che i politici conservatori facilitano la nascita di pregiudizi. Basandosi sui risultati delle ricerche inglesi, i ricercatori sostengono che le persone meno intelligenti si localizzano nello spettro della destra politica, perché qui si sentono più sicuri. Secondo i creatori di questo studio, è l’intelligenza innata a determinare il livello di razzismo di una persona, molto più dell’educazione e dell’istruzione. Nemmeno lo status sociale ha un ruolo importante a proposito. Semplicemente affermano che l’ideologia conservatrice è la via giusta per trasformare bambini che hanno difficoltà a ragionare in persone razziste. Le capacità cognitive sono fondamentali per avere una mente aperta. Ciò significa che coloro che hanno capacità cognitive ridotte o molto ridotte tendono ad adottare ideologie conservatrici per la sensazione di ordine che implicano. Questa è un’altra delle conclusioni dello studio. Intelligenza innata. Secondo le ricerche condotte dalla Brock University, tutto ciò significa che l’intelligenza innata ha un ruolo determinante nell’ideologia ultima adottata da un individuo. Questo significa che essere di destra è sinonimo di stupidità? Assolutamente no. Oggigiorno, in tutto il mondo le ideologie politiche sono un po’ ingarbugliate. Niente è più ciò che sembra. Possiamo definire un regime comunista come quello imposto in Corea del Nord di sinistra? Qui, i cittadini si sono abituati a vivere sotto gli ordini di un dittatore che si definisce d’ideologia progressista, ma che manipola i destini di milioni di persone con un pugno di ferro. Esistono altri esempi di paesi in cui si è tentato di stabilire un regime di sinistra e comunista, ma senza successo. Russia o Cuba, per esempio, hanno sofferto terribili repressioni popolari durante la fase della dittatura del proletariato, che alla fine si è trasformata nel mandato di un singolo leader come Stalin o Castro, con accesso limitato alla libertà o al pensiero. Ciò significa che, tra i partiti della sinistra mondiale, c’è gente camuffata che in realtà è di destra? È possibile che nell’ideologia progressista si siano infilate persone poco intelligenti che in realtà sono conservatori? Non esiste una risposta chiara a questo tipo di domande, poiché le ideologie hanno sempre meno peso in un mondo mosso meramente da interessi economici e dei partiti. In realtà, ciò che importa è avere una mente aperta e curiosa. Imparate da tutti coloro che hanno qualcosa da apportarvi nella vita. Se non avete un’intelligenza innata che apra la vostra mente, almeno stimolate la vostra intelligenza emotiva. Siate sensibili a qualsiasi tipo di tendenze e modi di essere e adottate una vita piena e felice. Come diceva Ernesto Che Guevara, se siete in grado di avere capelli splendenti, siete anche capaci di avere un cuore nobile e buono.
Quell'ossessione dello Stato di regolare la nostra vita. In Italia, sul cibo, c'è la stessa ossessione regolamentatrice dell'Unione Sovietica, scrive Piero Ostellino su "Il Giornale". L'idea che si possano, anzi, si debbano, regolamentare i comportamenti sociali, non lasciando il minimo spazio allo spontaneismo individuale e collettivo è l'ossessione di ogni politica. Particolarmente affetto ne è quel filone della politica, eredità del razionalismo settecentesco, che si è storicamente incarnato nella sinistra dopo la Rivoluzione bolscevica e la nascita dell'Unione Sovietica. Ho ritrovato, e osservato, tale ossessione in due Paesi che hanno interpretato la politica da versanti opposti, pervenendo a risultati profondamente diversi. In Unione Sovietica non c'era ambito della società civile che la politica non volesse regolamentare e non regolamentasse. Il risultato era stata l'estrema esasperazione del sistema politico totalitario che aveva soffocato l'intera società civile russa, mentre, di converso, lo spontaneismo sociale promuoveva quella cinese, empirica e sperimentale. In Cina, la convinzione che solo lasciando alla società civile ampi ambiti di autonomia, soprattutto economica, il Paese sarebbe uscito dal dirigismo maoista e decollato verso la modernità e la crescita, ha dato i suoi frutti; oggi, la Repubblica popolare cinese è uno dei Paesi al mondo esemplari di più felice combinazione fra spontaneismo sociale e sviluppo economico, modernizzazione, crescita economica e sociale. Ricordo che, quand'ero in Cina, avevo osservato, e apprezzato lo spirito di iniziativa di certi cinesi, maschi e femmine, che avevano affrontato l'avventura liberista, godendo e approfittando della libertà che la politica lasciava loro di intraprendere e commerciare. Ho ritrovato la stessa ossessione regolamentatrice sovietica, da noi, in Italia, da parte soprattutto di quel filone politico, terreno di sperimentazione, da parte del Partito comunista, che aveva guardato all'Urss come ad un modello da imitare, e, entro certi limiti, da parte della cultura politica e sociale di matrice religiosa, non meno autoritaria di quella comunista. È stata la grande illusione razionalistica prodotta e diffusa dalla Rivoluzione francese con la pretesa di creare, e far crescere, la «società perfetta», dove nulla era lasciato al caso e tutto dipendeva dalla previsione e dalla programmazione politica. Non credo di sbagliarmi dicendo che l'Italia è il Paese al mondo col maggior numero di permessi, licenze, e divieti e anche quello dove queste forme di razionalismo condizionano la società civile e le impediscono di sviluppare autonomamente le proprie potenzialità. Il guaio è che l'ossessione regolamentatrice fa crescere la domanda di regolamentazione, e, quindi, di politica e di burocrazia ogni volta che si rivela inadeguata ad assolvere le funzioni che le sono impropriamente assegnate...Personalmente, sono cresciuto culturalmente all'ombra dell'empirismo anglosassone generatore dell'Illuminismo scozzese che si è distinto dal razionalismo francese proprio grazie al suo scetticismo rispetto alle virtù salvifiche della regolamentazione e della conseguente previsione-programmazione razionalistica. Sono liberale grazie anche a questa formazione culturale della quale sono debitore ad uno dei miei maestri all'Università di Torino di formazione anglosassone e col quale mi sono laureato, Alessandro Passerin d'Entreves, e ho imparato da Norberto Bobbio, l'altro mio grande maestro, a leggere i classici della cultura politica moderna, evitando, allo stesso tempo, di diventare prigioniero del positivismo politico, non meno di quello giuridico, cui era afflitto Bobbio, lui sì convinto erede del razionalismo francese. Grazie a Bobbio, ho letto David Hume e sono entrato in familiarità con l'empirismo anglosassone e l'Illuminismo scozzese. Detesto ogni pretesa previsionale e programmatrice proprio a ragione della loro scarsissima prevedibilità e capacità di programmazione razionale, e coltivo, con l'empirismo, un sano scetticismo sulle capacità razionali dell'uomo. Per intenderci: non vado in giro con la Dea Ragione sulle spalle come amano fare i razionalisti di tutte le tendenze e, in particolare, quelli di formazione transalpina. Ho imparato che il mondo è popolato da individui, ciascuno dei quali persegue i propri fini, con i propri mezzi, che coincidono solo inconsapevolmente con quelli degli altri - attraverso quell'empatia della quale parla Adam Smith nella Teoria dei sentimenti morali - in modo spontaneo ricercando il proprio Utile senza attenersi a calcoli previsionali e programmatici altrui... Se c'è qualcosa - diciamo pure molto! - che non va nella politica italiana è la convinzione si possano regolamentare i comportamenti sociali attraverso permessi, licenze, divieti che, poi, si rivelano l'ostacolo a quello spontaneismo che sta a fondamento della dottrina liberale e della nostra civilizzazione. Mi auguro, come ho scritto recentemente, che Berlusconi faccia iniezioni di empirismo e di liberalismo nella propria cultura politica e in quella di Forza Italia. Ce n'è effettivamente bisogno...
Mille euro al minuto a un comunista. L'ex ministro greco Varoufakis ospite da Fazio per 24mila euro. Il canone serve a questo? Si chiede Alessandro Sallusti su "Il Giornale" del 29/10/2015. Mille euro al minuto. È quanto la Rai ha pagato Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco, per sparare pirlate a «Che tempo che fa», il salotto televisivo personale di Fabio Fazio. Ventidue minuti, andati in onda il 27 settembre, che urlano vendetta. Non è la cifra in sé, 24mila euro appunto, più viaggio aereo pagato in prima classe, ma lo sperpero di denaro pubblico. Con in più la beffa che a staccare l'assegno è stato il più moralista dei conduttori tv a favore del più comunista dei politici europei, quello che aveva fatto accorrere ad Atene a osannarlo una nutrita pattuglia della sinistra italiana a inneggiare agli eroi di Tsipras. Lungi da noi cadere nel facile moralismo. Se uno ha mercato è giusto che incassi il dovuto. Non ci formalizziamo. È che non capiamo che mercato possa avere mister Varoufakis, economista messo al bando sia dall'Europa sia dal suo Paese. Lo hanno cacciato e a quanto risulta, nel suo girovagare per tv e salotti di mezzo mondo, noi italiani siamo stati gli unici a pagare per godere del suo verbo. Il che stride con il pianto, anche quello greco, di chi ci governa e lamenta mancanza di liquidità. Si tolgono soldi ai pensionati e poi, via Rai, si sprecano euro con i comunisti chic. Si sfora il debito e il premier si compra un nuovo lussuoso aereo. Si spendono 3 miliardi per l'emergenza immigrati e non c'è un soldo in più per i terremotati dell'Emilia e gli alluvionati della Campania. Se è così che Renzi e i neo-nominati vertici della Rai pensano di usare i soldi di quella nuova tassa occulta che è il canone in bolletta Enel, allora siamo alla truffa. Sanno gli italiani che la Rai spende due dei loro milioni ogni anno per pagare Fabio Fazio? E sanno che Luciana Littizzetto, spalla del conduttore buonista, è ricompensata con ventimila euro a puntata? Credo che a molti verrebbe voglia di farsi staccare la luce da Renzi, piuttosto che vedere buttati così i propri risparmi. Che tanto, per sapere «Che tempo che fa» basta leggere le previsioni o guardare fuori dalla finestra.
Lettera di Giampiero Mughini a Dagospia: Caro Dago, le consuete diatribe su quanto o quantissimo vengono pagate le star televisive sono davvero male impostate. Ci sono personaggi della televisione che marchiano a fuoco il programma da loro condotto. Lo faceva Michele Santoro, bravissimo nel suo genere (che non è il mio); lo fa Barbara D’Urso, irresistibile nei confronti del suo pubblico meridiano (i cui gusti sono distantissimi dai miei); lo fa Massimo Giletti, da anni ostinatissimo nel sorreggere lo “share” della domenica pomeriggio di Rai1. Se qualcuno obiettasse sui compensi di personaggi siffatti, io direi che non sanno di che cosa stanno parlando. Se una trasmissione di quelle che ho nominato fa o faceva due punti percentuali di ascolto in più, erano soldoni che venivano dalla pubblicità e che compensavano alla grande i cachet. La televisione funziona così, e quella pubblica e quella privata. Se paghi lautamente un ospite che ti fa scena e “ascolto” sono soldi spesi benissimo, e sta a zero l’invidia (inevitabile) di gente e scribacchini. Il caso Varoufakis è profondamente diverso. E’ figlio di una di una dinamica completamente diversa. Tanto è vero che solo alla Rai e in una televisione giapponese, il noto motociclista è stato trattato talmente con i guanti: e tanto più se stiamo parlando della Rai, di un’azienda in un cui un comune mortale tratta alla morte se avere trenta euro in più o in meno per una prestazione professionale. I 24mila euro netti (e dunque 50mila lordi) pagati all’ex ministro greco hanno tutt’altra logica. Nascono dalla necessità spasmodica di buona parte del palinsesto di Rai3 di “offrire” qualcosa di sinistra al suo pubblico che ne arde. Che di meglio di uno che da ministro greco faceva l’orgogliosissimo nel momento in cui il suo governo e il suo Paese chiedevano all’Europa i soldi di che sopravvivere sino al giorno dopo in ragione dell’Himalaya di debiti che avevano accumulato. Voi ricordate i commenti di tanti al risultato grottesco del referendum greco, all’annuncio che i greci non ne volevano sapere di pagare i loro debiti. Dio che orgogliosi, commentarono subito alcuni quaquaraquà del pronto intervento ideologico. E chi meglio del motociclista, che è poi un gran rivale di Fabrizio Corona quanto a turgore maschile, poteva rappresentare quell’orgoglio in una delle case madri della superiorità razziale della sinistra, ossia la trasmissione garbatamente condotta su Rai3 da Fabio Fazio? L’ho visto quando Varoufakis si è presentato e seduto. Da soli quella posa e quell’atteggiamento valevano i 24mila euro. Dio che cipiglio, Dio che turgore. Fuffa ideologica, la migliore di tutte. Non ha prezzo perché è una merce che ha un pubblico imponente, non meno grande di quello di Barbara D’Urso. Cappello. Che poi la Luciana Litizzetto abbia in quella trasmissione un cachet di 20mila euro a botta, davvero non so giudicare. Io non ho mai riso una volta nella mia vita alle sue battute. La mia compagna Michela sì, quasi sempre. Non so, davvero non so.
Pansa intervista Pansa su “Libero Quotidiano”: "Devo tutto alla guerra".
Caro Giampaolo, come ti senti adesso che hai compiuto gli ottant' anni?
«Tutto sommato, mi sento bene, a parte qualche acciacco inevitabile alla mia età. Ma il resto funziona e non posso che ringraziare il Padreterno. La testa è ancora lucida e la voglia di scrivere tanta. Devo confessare che il piacere di scrivere, invece di diminuire, con l'età è cresciuto. La mattina mi alzo presto e una delle prime cose che faccio è accendere il computer. Poi mi dedico a un articolo, al capitolo di un mio nuovo libro, a una lettera da inviare a un amico. Impegnarmi ogni giorno in questo esercizio mi gratifica molto. E mi ricorda che sono sempre stato un uomo fortunato».
In che cosa consiste la tua fortuna?
«Prima di tutto, nella data di nascita. Sono un ex ragazzo del 1935. L' essere venuto al mondo in quell' anno mi ha regalato molte opportunità. La prima è stata di vedere con i miei occhi il disastro di una guerra mondiale. È iniziata nel 1940 quando avevo cinque anni ed è finita nel 1945 quando mi avviavo a compierne dieci. Quello che ho visto, sia pure con lo sguardo di un bambino, mi ha insegnato che non bisogna mai lamentarsi di quanto ci accade, perché il peggio può sempre arrivare».
Il tuo ricordo più orribile del tempo di guerra?
«I bombardamenti aerei. Casale Monferrato, la mia città, non era un obiettivo strategico, ma aveva due ponti sul Po, uno pedonale e l'altro ferroviario, abbastanza vicini al centro. A partire dall' estate del 1944, gli apparecchi angloamericani tentarono di distruggerli come avevano iniziato a fare con tutti i ponti della Pianura padana. Nella convinzione che, dopo la liberazione di Roma, la guerra stesse per finire e dunque fosse necessario ostacolare la ritirata dei tedeschi. Il ponte pedonale lo colpirono subito, quello ferroviario mai. Per questo i bombardieri alleati ritornavano di continuo all' assalto».
E allora?
«Allora ho nella memoria lo schianto delle bombe. Un rumore da film degli alieni, che si insinuava dentro di te, si impadroniva del tuo corpo e ti faceva temere di morire. Invece l'andare nei rifugi antiaerei durante la notte, per me era divertente. Può sembrare una bestemmia, lo so. Ma da ragazzino precoce mi sentivo attratto dalle donne sempre un po' discinte. Se qualcuno mi chiedesse quando ho cominciato a osservare l'altro sesso, risponderei: nel grande rifugio della marchesa della Valle di Pomaro, situato a cento metri dal nostro appartamento, un palcoscenico straordinario di varia umanità».
Ma non avevi paura?
«Dopo il primo bombardamento sì, ho provato il terrore di essere ucciso. Poi mi sono abituato. Tanti anni dopo, nel leggere quel che era accaduto in Gran Bretagna, ho compreso che l'Italia, soprattutto nelle piccole città, era stata una specie di paradiso. Gli abitanti di Londra e di altri centri inglesi, come Coventry avevano vissuto l'inferno dei continui bombardamenti tedeschi. Gli inglesi stavano assai peggio di noi. Hanno sofferto la fame, da loro il tesseramento è rimasto in vigore sino agli anni Cinquanta. Noi ce la siamo cavata molto meglio».
Che cosa dicevano i tuoi genitori della guerra?
«La consideravano un castigo di Dio e speravano che finisse presto. Ma non hanno mai lasciato trasparire le loro paure con me e a mia sorella Marisa. Mio padre Ernesto, classe 1898, da giovanissimo si era sciroppato gran parte della Prima guerra mondiale, nel Genio radiotelegrafisti della III Armata, quella del Duca d' Aosta. E aveva visto gli orrori di quel conflitto. Gli inutili assalti alla baionetta, i cadaveri straziati dalle cannonate, i tanti feriti, i mutilati, i soldati con la malaria e il colera abbandonati in lazzaretti di fortuna. Era un uomo buono e pessimista, rimasto orfano di padre da bambino, insieme a cinque tra fratelli e sorelle. Mia madre Giovanna, invece, era una donna ottimista. Aveva un negozio di mode in centro, guadagnava tre volte lo stipendio di papà, operaio guardafili delle Poste. Insieme mi hanno insegnato come si deve stare al mondo».
Quando hai scoperto che ti piaceva scrivere?
«Alla conclusione della terza media. Eravamo nell' estate del 1947 e avevo dodici anni e mezzo, poiché nelle elementari avevo fatto insieme la quarta e la quinta. Come premio per un'ottima pagella, papà mi regalò una macchina per scrivere di seconda mano: una Underwood del 1914, fabbricata in America. Ho imparato subito a usarla e mi sono accorto di avere una vocazione: quella di diventare un giornalista. Cominciai presto a collaborare al settimanale della mia città, Il Monferrato. Non mi pagavano, però mi lasciavano fare. Quando sono andato all' università di Torino, a Scienze politiche, ho dedicato tutto il mio tempo alla tesi di laurea. L'argomento era la guerra partigiana tra Genova e il Po. L' avevo iniziata per partecipare a un concorso indetto dalla Provincia di Alessandria. Divenne un malloppo pazzesco, di ottocento pagine».
E che cosa accadde?
«Mi laureai con il massimo dei voti e la dignità di stampa. Era il luglio del 1959 e avevo 23 anni e nove mesi. Nel novembre del 1960 la mia tesi vinse il Premio Einaudi che mi fu consegnato dall' ex capo dello Stato, Luigi Einaudi, nella sua villa di Dogliani, con una cerimonia solenne. Quel premio convinse il direttore della Stampa, Giulio De Benedetti, a convocarmi per capire che tipo ero. Il nostro incontro durò meno di un quarto d' ora. E lui mi assunse, come in seguito fece con altri giovani laureati. Voleva svecchiare la redazione, così mi venne detto».
Un altro colpo di fortuna…
«Sì. Ma anche il risultato di una serie di circostanze che non riguardavano soltanto me. Quando iniziai a lavorare alla Stampa era il gennaio 1961. L' Italia era appena uscita del suo primo boom economico. I grandi quotidiani andavano a gonfie vele. A insidiarli non esisteva la televisione e meno che mai il maledetto web. Vendevano molte copie, raccoglievano tanta pubblicità, avevano la cassa piena di soldi».
Condizioni oggi irripetibili...
«Non c' è dubbio. Gli stipendi erano più che buoni, compresi quelli dei redattori alle prime armi. In compenso bisognava lavorare, o ruscare come diciamo noi piemontesi. Dieci ore di presenza dalle due del pomeriggio a mezzanotte. Nessuna settimana corta. Un rigore assoluto, garantito dai capi servizio, a loro volta onnipotenti. De Benedetti era un dittatore indiscusso. Quando entrava nella grande sala della redazione, tutti ci alzavamo in piedi. Soltanto quando Gidibì ringhiava: "Signori, seduti!", il lavoro riprendeva».
Fammi un esempio del rigore della «Stampa»…
«Eccone uno. Lavoravo da parecchio al notiziario italiano, quando Carlo Casalegno, il giornalista assassinato nel 1977 dalle Brigate rosse, mi chiese una recensione per la terza pagina, quella culturale. Riguardava un libro appena uscito in Italia: Il giorno più lungo di Cornelius Ryan, sullo sbarco alleato in Normandia nel giugno del 1944. La scrissi e la riscrissi con il cuore in gola. La consegnai al direttore e Gidibì la tenne nel cassetto per una settimana. Poi mi convocò e ruggì: "Questa non è una recensione, ma una cattiva cronaca dello sbarco in Normandia". Quindi iniziò a stracciarla in pezzi sempre più piccoli. E li fece nevicare sotto gli occhi».
Poi hai lasciato la «Stampa». Come mai?
«È un altro esempio della fortuna che assisteva un ragazzo del 1935. Negli anni Sessanta, un direttore che apprezzava il tuo lavoro aveva il potere assumerti da un giorno all' altro. Una circostanza irreale se guardiamo ai giorni nostri. Italo Pietra, allora direttore del Giorno, nel 1964 mi offrì un contratto da inviato speciale. Mi chiese: "Dove vuoi essere mandato in servizio: a Voghera o nel Golfo del Tonchino dove sta per cominciare una guerra che si estenderà al Vietnam?". Da monferrino sveglio risposi: "A Voghera, direttore". Pietra sorrise: "Risposta esatta. Ti assumo. Ecco il contratto da firmare. Se dicevi il Tonchino, non ti avrei mai assunto"…».
Quanto sei rimasto al «Giorno»?
«Sino alla fine del 1968. Poi Alberto Ronchey, il successore di Gidibì, mi rivolle alla Stampa, sempre come inviato. La mia base era Milano, una metropoli sconvolta dalla violenza e dagli attentati. Cortei militanti a tutto spiano, l'omicidio dell'agente di polizia Annarumma, la strage di Piazza Fontana, la fine oscura dell'anarchico Pinelli, l'arresto di Valpreda, i primi segni di vita delle Brigate rosse. Ho imparato a conoscere l'Italia, un paese ingovernabile, travolto dall' estremismo politico».
Se non sbaglio, nel 1973 sei passato al «Messaggero» dei Perrone…
«Sì, a fare il redattore capo, un mestiere che non era il mio. Ma la fortuna continuò ad assistermi. Piero Ottone mi volle al Corriere della sera. Ci rimasi sino al 1977, poi Eugenio Scalfari mi assunse a Repubblica, nata l’anno precedente. Rimasi con Barbapapà un'infinità di tempo. Quindi andai all' Espresso con Claudio Rinaldi, ero il suo condirettore. Nel 2008 lasciai il gruppone di Scalfari e mi arruolai nel Riformista di Antonio Polito. Di lì sono passato a Libero, dove sto con grande soddisfazione mia e, spero, del direttore Maurizio Belpietro e dell'editore Giampaolo Angelucci».
In tanti anni di professione, immagino che tu sia stato costretto ad affrontare non poche delle emergenze che hanno tormentato l'Italia. Quale di loro ricordi?
«Almeno tre. La prima è il terrorismo, soprattutto quello delle Brigate Rosse. Oggi non ce ne ricordiamo più, ma è stata una seconda guerra civile durata quasi un ventennio. Con un'infinità di morti ammazzati, centinaia di feriti, allora si diceva gambizzati, e un delitto che ricordo come fosse avvenuto ieri: il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. Tuttavia l'aspetto peggiore, e infame, di quel mattatoio fu il comportamento di una parte importante della borghesia di sinistra. Eccellenze della cultura, dell'università, del giornalismo, delle professioni liberali. E della politica comunista e socialista. Per anni negarono l'esistenza del terrorismo rosso. Sostenevano che si trattava di fascisti travestiti da proletari. Soltanto qualcuno ha fatto ammenda di quella farsa tragica. Ma pochi, per non dire pochissimi. Molti pontificano ancora e si considerano la crema dell'Italia».
E la seconda emergenza?
«È la corruzione, un cancro che intacca, con una forza sempre più perfida, partiti, aziende, pubblica amministrazione. È un virus che si estende anno dopo anno. Ha avuto un picco al tempo di Mani Pulite o di Tangentopoli. Era il 1992 e allora sembrò che le indagini del pool giudiziario di Milano avessero la meglio. Invece era soltanto una pausa breve. Infatti tutto è ricominciato alla grande. Devo dire la verità? L' Italia è una repubblica fondata sulla mazzetta. Non può consolarci il fatto che tante nazioni siano uguali a noi».
La terza emergenza?
«È il discredito sempre più devastante che ha mandato al tappeto il sistema politico italiano. Per anni ho seguito da vicino e ho raccontato la crisi dei nostri partiti. Li ho visti ammalarsi, peggiorare, arrivare vicini all' estinzione. Adesso mi sembrano malati terminali. Molte parrocchie politiche sono già morte. E altre moriranno. Alla fine resteranno in piedi soltanto pochi personaggi, i più scaltri, i più demagoghi. È facile prevedere che saranno loro a comandare in Italia».
Stai pensando a Matteo Renzi, il nostro presidente del Consiglio?
«Certo, penso al Fiorentino, ma non soltanto a lui. Renzi oggi comanda e temo che continuerà a comandare per parecchio tempo. Avremmo bisogno di un nuovo De Gasperi, ma l'Italia del 2015 è messa peggio di quella del 1948. Allora eravamo un paese senza pace, alle prese con tutti i guai del dopoguerra. Ma avevamo fiducia in noi stessi, voglia di rinascere, capacità di sacrificio, entusiasmo politico, anche faziosità all' ennesima potenza. Oggi siamo una nazione di morti che camminano, non parlano, non si occupano di quello che un tempo veniva chiamato il bene pubblico. Prevale la paura di diventare sempre più poveri».
Come vedi il futuro dell'Italia?
«Buio e tempestoso. Adesso qualche gregario di Renzi dirà che sono un vecchio gufo menagramo, ma è proprio il personaggio del Fiorentino a indurmi al pessimismo. Non è un leader politico poiché non ha la statura intellettuale e umana per esserlo. È soltanto l'utilizzatore finale di una crisi antica della Casta dei partiti, cominciata molti anni fa. Renzi sta dominando su uno scenario di macerie. A lui interessa soltanto il potere. Non è un generoso come sanno esserlo i veri numero uno. È un piccolo demagogo, egoista, vendicativo, che si è circondato di una squadra di yes man incompetenti, pronti a obbedirgli e a seguirlo fino a quando resterà in sella. Nessuno lo scalzerà dalla poltrona e lui seguiterà a vincere per abbandono di tutte le controparti».
Nemmeno il centrodestra riuscirà a scalzare Renzi?
«Ma non raccontiamoci delle favole! Il centrodestra mi ricorda l'ospizio dei poveri della mia città. Sono convinti, o fingono di esserlo, che soltanto loro abbatteranno il Fiorentino. Ma è un pio desiderio, nient' altro. In realtà tutti i capetti di una volta si combattono per spartirsi il poco che è rimasto dell'impero di Silvio Berlusconi. Giocano con il pallottoliere e, sommando una serie di piccoli numeri, si illudono di sconfiggere Renzi. Il loro futuro è persino più nero di quello italiano. Ce lo conferma la crisi drammatica del Cavaliere. Ha un anno meno di me e nel 2016 taglierà il traguardo degli ottanta. Gli auguro di conservare la villa di Arcore e di non sentire che un giorno, all' alba, bussa alla sua porta qualche scherano di Renzi con un'ordinanza di sfratto».
Sei certo che gli oppositori attuali di Renzi non siano in grado di fermarlo?
«Forse potrebbe farcela un'alleanza che oggi sembra una chimera. Quella fra Grillo, Salvini, la Meloni e quanto resta di Forza Italia. Ma nel caso molto improbabile che questo asse prenda forma, chi può esserne il leader? Viviamo in un'epoca che considera la figura del capo un fattore indispensabile per contendere il potere politico, con la speranza di conquistarlo. Però dove sta il nuovo leader del centrodestra? Io non lo vedo».
E del centrosinistra che cosa mi dice?
«Che sta peggio del centrodestra. Quando esisteva ancora la Democrazia cristiana, un anziano deputato doroteo di Caltanissetta mi disse: "Il mio partito ricorda la masseria dello curatolo Cicco: il primo che si alza, pretende di comandare". Non rimpiango di certo la scomparsa del Pci, ma la sua fine ha lasciato un vuoto enorme. Si sta realizzando una profezia del vecchio Pietro Nenni: rischiamo di diventare una democrazia senza popolo. È quello che accade in Italia, pensiamo al grande numero di elettori che non vanno più alle urne».
Nella prima e nella seconda Repubblica tu hai votato sempre a sinistra, se non sbaglio…
«Sì, ho votato per il Pci, per il Psi e per i radicali. Poi non sono più andato a votare, da quando ho scoperto la vera natura della sinistra italiana. Me ne sono reso conto del tutto nel 2003, dopo aver pubblicato il mio libro dedicato a quanto era accaduto dopo il 25 aprile 1945: Il sangue dei vinti. Un lavoro minuzioso, che non ha mai ricevuto una smentita o una querela. Posso definirlo una prova di revisionismo storico da sinistra? Eppure la sinistra italiana, in tutti i suoi travestimenti, mi ha maledetto. E non ha smesso di sputarmi addosso nemmeno quando si è resa conto che quel libraccio aveva un successo enorme. A tutt' oggi ha venduto un milione di copie».
Tu fai il giornalista dal 1961, ossia da cinquantaquattro anni. Ha ancora senso questo nostro mestiere?
«Penso di sì, anche se è diventato una professione proibita ai giovani. Nessuno li assume, i compensi per chi vuole iniziare sono minimi. Ma io sono difeso dalla mia età. A ottant' anni mi protegge un antico imperativo del filosofo tedesco Immanuel Kant. Recita: fai quel che devi, avvenga quel che può».
L'UGUAGLIANZA E L’INVIDIA SOCIALE.
Frasi, citazioni e aforismi sull’uguaglianza. Pubblicato da Fabrizio Caramagna.
Nasciamo uguali, ma l’uguaglianza cessa dopo cinque minuti: dipende dalla ruvidezza del panno in cui siamo avvolti, dal colore della stanza in cui ci mettono, dalla qualità del latte che beviamo e dalla gentilezza della donna che ci prende in braccio. (Joseph Mankiewicz)
Tutti gli uomini nascono uguali, però è l’ultima volta in cui lo sono. (Abraham Lincoln)
Ognuno è impastato nella stessa pasta ma non cotto nello stesso forno. (Proverbio Yiddish)
Dovunque sono uomini, sono diversità di opinioni, disparità di sentimenti, differenza di umori, tali e tante variazioni temporanee o permanenti, che il consenso perfetto è impossibile, non dico fra tutti o fra molti, ma fra pochi, fra due. (Federico De Roberto)
Equa distribuzione della ricchezza non significa che tutti noi dovremmo essere milionari – significa solo che nessuno dovrebbe morire di fame. (Dodinsky)
L’uguaglianza sarà forse un diritto, ma nessuna potenza umana saprà convertirlo in un fatto. (Honoré de Balzac)
È falso che l’uguaglianza sia una legge di natura: la natura non ha fatto nulla di eguale. La sua legge sovrana è la subordinazione e la dipendenza. (Marchese di Vauvenargues)
L’uguaglianza consiste nel ritenerci uguali a coloro che stanno al di sopra di noi, e superiori a coloro che stanno al di sotto. (Adrien Decourcelle)
Egalitarista. Il genere di riformatore politico e sociale interessato a fare scendere gli altri al proprio livello più che a sollevarsi a quello degli altri. (Ambrose Bierce)
In America tutti sono dell’opinione che non ci sono classi sociali superiori, dal momento che tutti gli uomini sono uguali, ma nessuno accetta che non ci siano classi sociali inferiori, perché, dai tempi di Jefferson in poi, la dottrina che tutti gli uomini sono uguali vale solo verso l’alto, non verso il basso. (Bertrand Russell)
Ci sono due dichiarazioni sugli esseri umani che sono vere: che tutti gli esseri umani sono uguali, e che tutti sono differenti. Su questi due fatti è fondata l’intera saggezza umana. (Mark Van Doren)
Davanti a Dio siamo tutti ugualmente saggi… e ugualmente sciocchi. (Albert Einstein)
Perché noi non siamo né al di sopra né al di sotto del resto: tutto quello che è sotto il cielo è sottoposto a una stessa legge e a una stessa sorte… Le anime degli imperatori e dei ciabattini sono fatte su uno stesso stampo. (Michel De Montaigne)
L’uguaglianza deve essere quella delle opportunità, non può essere ovviamente quella dei risultati. (John Dryden)
Ho letto tempo fa che nel futuro gli uomini saranno tutti uguali. Ugualmente ricchi o ugualmente poveri? (Zarko Petan)
Gli uomini sono nati uguali ma sono anche nati diversi. (Erich Fromm)
La figlia del re, giocando con una delle sue cameriere, le guardò la mano, e dopo avervi contato le dita esclamò: “Come! Anche voi avete cinque dita come me?!”. E le ricontò per sincerarsene. (Nicolas Chamfort)
Noi sosteniamo che queste verità sono per sé evidenti: che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, tra i quali sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini i governi, che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che, ogni qualvolta una forma di governo diventi perniciosa a questi fini, è nel diritto del popolo di modificarla o di abolirla. (Thomas Jefferson, Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America)
“Libertè, Egalitè, Fraternitè”. (Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, 1795)
Tutta la società diventerà un unico ufficio e un’unica fabbrica con uguale lavoro e paga uguale. (Vladimir Lenin)
Il vizio inerente al capitalismo è la divisione ineguale dei beni; la virtù inerente al socialismo è l’uguale condivisione della miseria. (Sir Winston Churchill)
Allo stato naturale… tutti gli uomini nascono uguali, ma non possono continuare in questa uguaglianza. La società gliela fa perdere, ed essi la recuperano solo con la protezione della legge. (Montesquieu)
La prima uguaglianza è l’equità. (Victor Hugo)
L’uguaglianza ha un organo: l’istruzione gratuita e obbligatoria. (Victor Hugo)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 3, 1947)
Nessuno vi può dare la libertà. Nessuno vi può dare l’uguaglianza o la giustizia. Se siete uomini, prendetevela. (Malcolm X).
Finché c’è una classe inferiore io vi appartengo, finché c’è una classe criminale io vi appartengo, finché c’è un’anima in prigione io non sono libero. (Eugene V. Debs)
Le lacrime di un uomo rosso, giallo, nero, marrone o bianco sono tutti uguali. (Martin H. Fischer)
C’è qualcosa di sbagliato quando l’onestà porta uno straccio, e la furfanteria una veste; quando il debole mangia una crosta, mentre l’infame pasteggia nei banchetti. (Robert Ingersoll)
L’uguaglianza non esiste fin a quando ciascuno non produce secondo le sue forze e consuma secondo i suoi bisogno. (Louis Blanc)
Amici miei, vi dico che, anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me un sogno. E’ un sogno profondamente radicato nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni: noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali. (Martin Luther King)
Vivere nel mondo di oggi ed essere contro l’uguaglianza per motivi di razza o colore è come vivere in Alaska ed essere contro la neve. (William Faulkner)
Fino a quando la giustizia non sarà cieca al colore, fino a quando l’istruzione non sarà inconsapevole della razza, fino a quando l’opportunità non sarà indifferente al colore della pelle degli uomini, l’emancipazione sarà un proclama ma non un fatto. (Lyndon B. Johnson)
Un uomo non può tenere un altro uomo nel fango senza restare nel fango con lui. (Booker T. Washington)
Viviamo in un sistema che sposa il merito, l’uguaglianza e la parità di condizioni, ma esalta quelli con la ricchezza, il potere, e la celebrità, in qualunque modo l’abbiano guadagnato. (Derrick A. Bell)
Se le malattie e le sofferenze non fanno distinzione tra ricchi e poveri, perché dovremmo farlo noi? (Sathya Sai Baba)
Se ci pungete non diamo sangue, noi? Se ci fate il solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate non moriamo? (William Shakespeare)
Guardo i volti delle persone che lottano per la propria vita, e non vedo estranei. (Robert Brault)
Qualunque certezza tu abbia stai sicuro di questo: che tu sei terribilmente come gli altri. (James Russell Lowell)
Lo stesso Dio che ha creato Rembrandt ha creato te, ed agli occhi di Dio tu sei prezioso come Rembrandt o come chiunque altro.” (Zig Ziglar)
È bello quando due esseri uguali si uniscono, ma che un uomo grande innalzi a sé chi è inferiore a lui, è divino. (Friedrich Hölderlin)
Se ti sedessi su una nuvola non vedresti la linea di confine tra una nazione e l’altra, né la linea di divisione tra una fattoria e l’altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola. (Khalil Gibran)
Il sole splende per tutti. (Proverbio latino)
La pioggia non cade su un tetto solo. (Proverbio africano)
In quanto uomini, siamo tutti uguali di fronte alla morte. (Publilio Siro)
La morte è questo: la completa uguaglianza degli ineguali. (Vladimir Jankélévitch)
Nella vita si prova a insegnare che siamo tutti uguali, ma solo la morte riesce ad insegnarlo davvero. (Anonimo)
Nella democrazia dei morti tutti gli uomini sono finalmente uguali. Non vi è né rango né posizione né prerogativa nella repubblica della tomba. (John James Ingalls).
Finito il gioco, il re e il pedone tornano nella stessa scatola. (Proverbio Italiano).
L’uguale distribuzione della ricchezza dovrebbe consistere nel fatto che nessun cittadino sia tanto ricco da poter comprare un altro, e nessuno tanto povero che abbia necessità di vendersi. (Armand Trousseau)
L’amore, è l’ideale dell’uguaglianza. (George Sand)
L’amore pretende di parificare, ma il denaro riesce a differenziare. (Aldo Busi)
Noi che siamo liberali e progressisti sappiamo che i poveri sono uguali a noi in tutti i sensi, tranne quello di essere uguali a noi. (Lionel Trilling)
La saggezza dell’uomo non ha ancora escogitato un sistema di tassazione che possa operare con perfetta uguaglianza. (Andrew Jackson)
Nessun uomo è al di sopra della legge, e nessuno è al di sotto di esso. (Theodore Roosevelt)
Siamo tutti uguali davanti alla legge, ma non davanti a coloro che devono applicarla. (Stanislaw Jerzy Lec)
La maestosa uguaglianza delle leggi proibisce ai ricchi come ai poveri di dormire sotto i ponti, di mendicare per strada e di rubare il pane. (Anatole France)
Perché in Italia la stupenda frase “La Giustizia è uguale per tutti” è scritta alle spalle dei magistrati? (Giulio Andreotti)
La scuola dava peso a chi non ne aveva, faceva uguaglianza. Non aboliva la miseria, però tra le sue mura permetteva il pari. Il dispari cominciava fuori. (Erri De Luca)
Qui vige l’eguaglianza. Non conta un cazzo nessuno!” (Dal film Full metal jacket)
Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. (George Orwell)
Per realizzare una democrazia compiuta occorre avere il coraggio di rimettere in discussione il diritto di voto. Non posso guidare un aeroplano appellandomi al principio di uguaglianza: devo prima superare un esame di volo. Perché quindi il voto, attività non meno affascinante e pericolosa, dovrebbe essere sottratta a un esame preventivo di educazione civica e di conoscenza minima della Costituzione? (Massimo Gramellini)
La via dell’uguaglianza si percorre solo in discesa: all’altezza dei somari è facilissimo instaurarla. (Conte di Rivarol)
La parità e l’uguaglianza non esistono né possono esistere. E’ una menzogna che possiamo essere tutti uguali; si deve dare a ognuno il posto che gli compete. (Pancho Villa)
Fu un uomo saggio colui che disse che non vi è più grande ineguaglianza di un uguale trattamento di diseguali. (Felix Frankfurter)
Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali. (Lorenzo Milani)
Quella secondo la quale tutti gli uomini sono eguali è un’affermazione alla quale, in tempi ordinari, nessun essere umano sano di mente ha mai dato il suo assenso. (Aldous Huxley)
L’uguaglianza è una regola che non ha che delle eccezioni. (Ernest Jaubert)
Nell’incredibile moltitudine che potrebbe venir fuori da una sola coppia umana, che disuguaglianze e varietà! Vi si trovano grandi e piccoli, biondi e bruni, belli e brutti, deboli e forti. Tutto vi figura: il peggiore e l’eccellente, la tara e il genio, la mostruosità in alto e quella in basso. Dall’unione di due individui, tutto può nascere. Punto di congiunzione da cui non si deve sperare tutto e temere tutto. La coppia più banale è gravida di tutta l’umanità. (Jean Rostand)
Anche tra egualitari fanatici il più breve incontro ristabilisce le disuguaglianze umane. (Nicolás Gómez Dávila)
Io non ho rispetto per la passione dell’uguaglianza, che a me sembra una semplice invidia idealizzata. (Oliver Wendell Holmes Jr)
Il significato della parola uguaglianza non deve essere “omologazione”. (Anonimo)
Sì, c’è qualcosa in cui noi ci assomigliamo: tu e io ci crediamo differenti in modo uguale. (Jordi Doce)
Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione. (Timothy Leary)
Assistere l’autodeterminazione del popolo sulla base della massima uguaglianza possibile e mantenere la libertà, senza la minima interferenza di qualsivoglia potere, neppure provvisorio. (Michail Bakunin)
L’uguaglianza non può regnare che livellando le libertà, diseguali per natura. (Charles Maurras)
I legislatori o rivoluzionari che promettono insieme uguaglianza e libertà sono o esaltati o ciarlatani. (Goethe)
Quando sicurezza e uguaglianza sono in conflitto, non bisogna esitare un momento: l’uguaglianza va sacrificata. (Jeremy Bentham)
Una società che mette l’uguaglianza davanti libertà otterrà né l’una né l’altra. Una società che mette la libertà davanti all’uguaglianza avrà un buon livello di entrambe. (Milton Friedman)
Libertà, Uguaglianza, Fraternità – come arrivare ai verbi? (Stanislaw Jerzy Lec)
“Libertà, Fraternità, Uguaglianza”, d’accordo. Ma perchè non aggiungervi “Tolleranza, Intelligenza, Conoscenza?” (Laurent Gouze)
Dicesi problema sociale la necessità di trovare un equilibrio tra l’evidente uguaglianza degli uomini e la loro evidente disuguaglianza. (Nicolás Gómez Dávila)
Credo nell’uguaglianza. Gli uomini calvi dovrebbero sposare donne calve. (Fiona Pitt-Kethley)
Nel mondo contemporaneo l’unico posto dove si realizza la perfetta uguaglianza è nel traffico. (Fragmentarius)
Nella troppa disuguaglianza delle fortune, egualmente che nella perfetta eguaglianza, l’annua riproduzione si restringe al puro necessario, e l’industria s’annienta, poiché il popolo cade nel letargo. (Pietro Verri)
Se ciò che io dico risuona in te, è semplicemente perché siamo entrambi rami di uno stesso albero. (William Butler Yeats)
Chiunque può fuggire nel sonno, siamo tutti geni quando sogniamo, il macellaio e il poeta sono uguali là. (EM Cioran)
Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri…(Bob Marley)
Il mio diritto di uomo è anche il diritto di un altro; ed è mio dovere garantire che lo eserciti. (Thomas Paine)
Chi vede tutti gli esseri nel suo stesso Sé, ed il suo Sé in tutti gli esseri, perde ogni paura. (Isa Upanishad)
«Fu il sangue mio d’invidia sì riarso
che se veduto avesse uomo farsi lieto,
visto m’avresti di livore sparso.
(Dante Alighieri, Purgatorio, XIV, vv.82-84)
L’invidia sociale, scrive Francesco Colonna, su ”Facci un salto”. Si sono impiegati molti decenni per sradicare il tratto fondamentale del marxismo, cioè la lotta di classe. Gli argomenti contrari a quel principio si riassumono in un concetto semplice: la collaborazione è più efficace della lotta. Permette di costruire di più, di fare più cose, di redistribuire meglio non solo i soldi, ma le competenze e la giustizia. Gli argomenti a favore invece erano e sono quella di una divergenza di interessi che si concilia male con l’idea di giustizia sociale. Non importa qui dibattere il tema. Quel che conta è quell’idea non circola più, e infatti nessuno ne parla e nessuno la usa per sostenere le proprie tesi. Di conseguenza, la logica sarebbe questa, tutto dovrebbe essere più tranquillo, una società più conciliante, meno aggressiva, più disposta alla collaborazione, nella quale i problemi si risolvono in modo pacifico e ragionato. E invece a quella ideologia (giusta o sbagliata che fosse non importa) si è sostituito non un pensiero o una filosofia nuovi ma un sentimento: l’invidia, alla quale si può aggiungere l’aggettivo “sociale”. L’invidia nelle sue forme più comuni si riferisce alla cose, invidia per ciò che non ho e altri hanno. Invece nella nostra società fatta di immagine e comunicazione (parole che sembrano sempre sottintendere una falsità o almeno una irrealtà) l’invidia è rivolta all’essere, ai modelli di successo, di fama o di notorietà. E questa invidia prende tante forme: dalla ostilità alla imitazione. E, per capire bene cosa significhi e comporti, basta guardare alla etimologia: invidere in latino vuol dire guardare storto, guardare in modo non corretto. Cioè l’invidia impedisce di vedere giusto e quindi di capire. Ed è trasversale, colpisce ovunque. Mentre la lotta di classe comunque dava una identità, una appartenenza, l’invidia sociale disgrega, atomizza la lotta, relegandola nell’intimo, pur esibendosi poi come ricerca di giustizia sociale. Difficile che in questa luce si possa trovare una strada comune, al massimo si cercano nemici, veri o presunti. Una caccia nella quale brillano il sospetto, la vendetta, il complotto, il pregiudizio. E con questo carico sulla coscienza diviene difficile ragionare e scegliere bene il tipo di società nel quale vivere.
Monti, Bersani, Vendola e Cgil: il club della patrimoniale. La tentazione di patrimoniale è sempre più forte: Bersani ne vuole una light, Vendola punta alle rendite finanziarie, la Cgil sogna una stangata da 40 miliardi, scrive Andrea Indini su “Il Giornale”. E, adesso, patrimoniale. La spinta è forte. In piena campagna elettorale, la tentazione di fare una tentazione extra sui grandi patrimoni sembra impossessarsi trasversalmente sui leader di molti partiti. Il primo a proporla è stata Mario Monti che, nella sua agenda, l'ha inserita (senza farsi troppi problemi) per riuscire a ridurre la pressione fiscale, a partire dal "carico fiscale gravante su lavoro e impresa". In men che non si dica, una schiera di amanti delle tasse hanno subito fatto propria la smania di andare a mettere le mani sui risparmi degli italiani. "I ricchi devono andare all'inferno". Sebbene si riferisse al Gerard Depardieu che, per l'eccessiva tassazione, ha deciso di lasciare la Francia e accogliere il passaporto russo offertogli da Vladimir Putin, l'imprecazione lanciata da Nichi Vendola dà una chiara idea della crociata che, in caso di vittoria alle politiche, la sinistra condurrà contro i beni degli italiani. Dove potrà, razzolerà per far cassa e appianare i debiti di una macchina statale che fagocita tutti i soldi che vengono versati nell'erario pubblico. Nel giorni scorsi, in una intervista a Radio24, il leader del Sel aveva poi spiegato che, quando sarà al governo, andrà a "stanare" la ricchezza che deriva dalle rendite finanziarie. "Se si immagina che quella finanziaria del Paese è stimata in 4mila miliardi di euro e che viceversa meno di mille persone dichiarano nella denuncia dei redditi più di un milione di euro all'anno di reddito, siamo di fronte a una ricchezza largamente imboscata - ha spiegato Vendola - la tassazione alle transazioni finanziarie e sugli attivi finanziari non è una proposta bolscevica". Nascondendosi dietro alla ragione economica tesa alla ricostruzione del Paese, il governatore della Puglia sembra muoversi solo per una ragione di invidia sociale. Il primo a parlare di patrimoniale è stato, però, il Professore. Nell'agenda presentata a dicembre, Monti ha spiegato che è possibile tagliare le tasse a scapito di altri cespiti: "Il carico corrispondente va trasferito su grandi patrimoni e sui consumi che non impattano sui più deboli e sul ceto medio". Si legga: patrimoniale e appesantimento dell’Iva sui beni di lusso. Insomma, al premier uscente sembra non bastare l'aver introdotto l'Imu che, è già di per sé, una patrimoniale sull'abitazione. E, su questo punto, si trova in perfetta sintonia con Pierluigi Bersani che ieri sera, negli studi di Ballarò, ha spiegato chiaramente che l’imu non è una patrimoniale "abbastanza progressiva" per i suoi gusti. "Nel prossimo anno non saremo in condizione di ridurre le entrate dell’imu ma potremmo fare un riequilibrio caricando sui possessori di grandi patrimoni immobiliari - ha spiegato il segretario del Partito democratico - a fronte di una detrazione del 5% dobbiamo caricare con un’imposta personale sui detentori di grandi patrimoni immobiliari dal valore catastale di 1,5 milioni di euro". La segreteria di via del Nazareno, modificando leggermente i propositi iniziali vagamente massimalisti, ha fatto balenare una patrimoniale light da applicare agli immobili oltre il milione e mezzo di valore catastale. Lo staff di Bersani ha, invece, specificato che si tratterebbe di circa tre milioni a prezzi reali. Al suo fianco si è subito schierato anche Antonio Ingroia che ha già annunciato di voler togliere l'Imu perché la ritiene "un peso insopportabile e intollerabile". Il progetto del leader di Rivoluzione civile è rendere "il sistema economico più equo" mettendo "una patrimoniale sui redditi più alti e sui patrimoni più consistenti". Il sindacato di Susanna Camusso, che garantisce un’area elettorale decisiva per il Pd, ha preparato una piano fiscale che presenterà a Roma il 25 e 26 gennaio. Piano che fa impallidire gli slogan anti ricchi di Vendola: la Cgil punta, infatti, a reperire 40 miliardi di euro all'anno dalla patrimoniale, 20 miliardi dalla "ristrutturazione della spesa pubblica", 10 miliardi dal riordino dei finanziamenti alle imprese e 10 miliardi dai fondi dell'Unione europea. Gli 80 miliardi rastrellati verrebbero destinati, ogni anno, al lavoro (creazione di nuovi posti, sostegno dell’occupazione e nuova riforma del mercato del lavoro), al welfare e alla "restituzione fiscale" attraverso il taglio della prima aliquota dal 23 al 20% e della terza dal 38 al 36%. Progetto che senza la patrimoniale da 40 miliardi non sta in piedi.
Ci volevate uguali? Ora sim tutti poveri, scrive Mimmo Dato su "L'Intraprendente". In questo nostro bel paese, mio caro Mictel o come ti chiami, abbiamo avuto imponenti correnti d’ispirazione populista, con orientamenti internazionali con sguardo alla sovietizzazione ed al marxismo, forse un po’ radicalizzanti ma certo, a loro dire, pacifisti. Insomma tutta gente all’opposizione che ha vissuto una vita a gridare quanto fosse giusto eliminare le diseguaglianze economiche e ridistribuire le ricchezze, per ovvio sempre prodotte dagli altri e mai da loro; che bisognava aumentare le spese dello Stato per attuare queste pseudo misure egualitarie. Insomma tutti questi contro tutti quelli che non ponevano quale obiettivo principe la massimizzazione dell’uguaglianza. Poi il sogno in Italia si avvera e i governi a marchio populista, pacifista, egualitario si succedono a raffica pur senza che nessuno li elegga ma la Costituzione non viene infranta per questo, per i comunisti il voto non serve, ed eccoci all’oggi, tutti poveri uguale. Tutte le decisioni per la sopravvivenza del paese sono state omesse come qualunque sistema libero e democratico farebbe, tasse da record mondiale, caccia alle streghe, si è omesso di rafforzare le forze di difesa e di cercare le alleanze a garanzia internazionale. Quindi tutte le decisioni sono tendenti alla massimizzazione dell’uguaglianza in povertà contro quelle tese a garantire l’indipendenza e la sopravvivenza del sistema economico e democratico, si legga la nuova legge elettorale che dovrebbe esser varata. Ma allora, caro Mictel, ti chiederai chi erano e chi sono i veri potenti? Forse i ceti abbienti che sostenevano gruppi di maggioranza senza aver avuto, per loro frazionamento ed opportunismo, la capacità di arrestare forme populiste egualitarie o questi ultimi che hanno preso il potere da anni e stanno perseguendo opzioni politiche da disastro, spesa pubblica e disoccupazione al cielo? Vedi Mictel se tu mi fai la domanda, e non me la fai, su come la penso credo che oggi esistano due gruppi di pensatori, quelli che non vogliono l’uguaglianza nemmeno come valore e quelli che pensano che sia comunque impossibile. A questo punto, inutili e terra di conquista, che ci compri la Russia o la Cina. Eppoi il tuo nome sembra americano e mi dici esser cinese. Come ho fatto a non capirlo quando sei sceso da quel macchinone di lusso?
Altro che tutti uguali. Meglio tutti più ricchi. Frankfurt: ridurre le differenze di reddito non è un ideale morale. Il problema è invece che troppi sono poveri, scrive Harry G. Frankfurt Martedì 27/10/2015 su "Il Giornale". In un recente discorso sullo stato dell'Unione, il presidente Barack Obama ha dichiarato che la disuguaglianza di reddito è «la sfida che definisce la nostra epoca». A me sembra, invece, che la sfida fondamentale per noi non sia costituita dal fatto che i redditi degli americani sono ampiamente disuguali, ma dal fatto che troppe persone sono povere. Dopo tutto, la disuguaglianza di reddito potrebbe essere drasticamente eliminata stabilendo semplicemente che tutti i redditi devono essere ugualmente al di sotto della soglia di povertà. Inutile dire che un simile modo di ottenere l'uguaglianza dei redditi - rendendo tutti ugualmente poveri - presenta ben poche attrattive. Eliminare le disuguaglianze di reddito non può quindi costituire, di per sé, il nostro obiettivo fondamentale. Accanto alla diffusione della povertà, un altro aspetto dell'attuale malessere economico è il fatto che, mentre molte persone hanno troppo poco, ce ne sono altre che hanno troppo. È incontestabile che i molto ricchi abbiano ben più di ciò di cui hanno bisogno per condurre una vita attiva, produttiva e confortevole. Prelevando dalla ricchezza economica della nazione più di quanto occorra loro per vivere bene, le persone eccessivamente ricche peccano di una sorta d'ingordigia economica, che ricorda la voracità di chi trangugia più cibo di quanto richiesto sia dal suo benessere nutrizionale sia da un livello soddisfacente di godimento gastronomico. Tralasciando gli effetti psicologicamente e moralmente nocivi sulle vite degli stessi golosi, l'ingordigia economica offre uno spettacolo ridicolo e disgustoso. Se lo accostiamo allo spettacolo opposto di una ragguardevole classe di persone che vivono in condizioni di grande povertà economica, e che perciò sono più o meno impotenti, l'impressione generale prodotta dal nostro assetto economico risulta insieme ripugnante e moralmente offensiva. Concentrarsi sulla disuguaglianza, che in sé non è riprovevole, significa fraintendere la sfida reale che abbiamo davanti. Il nostro focus di fondo dovrebbe essere quello di ridurre sia la povertà sia l'eccessiva ricchezza. Questo, naturalmente, può benissimo comportare una riduzione della disuguaglianza, ma di per sé la riduzione della disuguaglianza non può costituire la nostra ambizione primaria. L'uguaglianza economica non è un ideale moralmente prioritario. Il principale obiettivo dei nostri sforzi deve essere quello di rimediare ai difetti di una società in cui molti hanno troppo poco, mentre altri hanno le comodità e il potere che si accompagnano al possedere più del necessario. Coloro che si trovano in una condizione molto privilegiata godono di un vantaggio enorme rispetto ai meno abbienti, un vantaggio che possono avere la tendenza a sfruttare per esercitare un'indebita influenza sui processi elettorali o normativi. Gli effetti potenzialmente antidemocratici di questo vantaggio vanno di conseguenza affrontati attraverso leggi e regolamenti finalizzati a proteggere tali processi da distorsioni e abusi. L'egualitarismo economico, secondo la mia interpretazione, è la dottrina per cui è desiderabile che tutti abbiano le stesse quantità di reddito e di ricchezza (in breve, di «denaro»). Quasi nessuno negherebbe che ci sono situazioni in cui ha senso discostarsi da questo criterio generale: per esempio, quando bisogna offrire la possibilità di guadagnare compensi eccezionali per assumere lavoratori con capacità estremamente richieste ma rare. Tuttavia, molte persone, pur essendo pronte a riconoscere che qualche disuguaglianza è lecita, credono che l'uguaglianza economica abbia in sé un importante valore morale e affermano che i tentativi di avvicinarsi all'ideale egualitario dovrebbero godere di una netta priorità. Secondo me, si tratta di un errore. L'uguaglianza economica non è di per sé moralmente importante e, allo stesso modo, la disuguaglianza economica non è in sé moralmente riprovevole. Da un punto di vista morale, non è importante che tutti abbiano lo stesso, ma che ciascuno abbia abbastanza. Se tutti avessero abbastanza denaro, non dovrebbe suscitare alcuna particolare preoccupazione o curiosità che certe persone abbiano più denaro di altri. Chiamerò questa alternativa all'egualitarismo «dottrina della sufficienza», vale a dire la dottrina secondo cui ciò che è moralmente importante, con riferimento al denaro, è che ciascuno ne abbia abbastanza. Naturalmente, il fatto che l'uguaglianza economica non sia di per sé un ideale sociale moralmente cogente non è una ragione per considerarla un obiettivo insignificante o inopportuno in qualsiasi contesto. L'uguaglianza economica può avere infatti un importante valore politico e sociale e possono esserci ottime ragioni per affrontare i problemi legati alla distribuzione del denaro secondo uno standard egualitario. Perciò, a volte, può avere senso concentrarsi direttamente sul tentativo di aumentare l'ampiezza dell'uguaglianza economica piuttosto che sul tentativo di controllare fino a che punto ognuno abbia abbastanza denaro. Anche se l'uguaglianza economica, in sé e per sé, non è importante, impegnarsi ad attuare una politica economica egualitaria potrebbe rivelarsi indispensabile per promuovere la realizzazione di vari obiettivi auspicabili in ambito sociale e politico. Potrebbe inoltre risultare che l'approccio più praticabile per raggiungere la sufficienza economica universale consista, in effetti, nel perseguire l'uguaglianza. E ovviamente, il fatto che l'uguaglianza economica non sia un bene in sé lascia comunque aperta la possibilità che abbia un valore strumentale come condizione necessaria per ottenere beni che posseggono, questi sì, un valore intrinseco. Pertanto, una distribuzione di denaro più egualitaria non sarebbe sicuramente criticabile. Tuttavia, l'errore assai diffuso di credere che esistano potenti ragioni morali per preoccuparsi dell'uguaglianza economica in quanto tale è tutt'altro che innocuo. Anzi, a dir la verità, tende a essere una credenza piuttosto dannosa. (2015 Princeton University Press2015 Ugo Guanda Editore Srl)
GLI INTOCCABILI E LA SOCIETA’ DELLE CASTE.
Gli intoccabili. Il caso Saguto e la società delle caste, scrive Pino Maniaci su "Telejato" il 26 ottobre 2015. IL CASO SAGUTO E LA SOCIETÀ DELLE CASTE: L’ANTIMAFIA, I GIUDICI, I BUROCRATI, I POLITICI. E POI LA PLEBE. Di fronte a tutto quello che abbiamo visto, letto e ascoltato in questi ultimi tempi sul caso della gestione personalizzata dei beni sequestrati da parte di un nutrito numero di magistrati, componenti del CSM, cancellieri, funzionari della DIA, personale giudiziario e amministratori giudiziari, sappiamo solo che il CSM ascolterà nei prossimi giorni i giudici coinvolti (ce ne sono altri 4 che continuano ad operare a Palermo). Ci chiediamo, anche a tutela dell’immagine di migliaia di magistrati onesti: Se a un comune mortale cittadino italiano fossero stati contestati la metà dei fatti addebitati alla Saguto non sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari? Se fossero stati contestati a Renzi, piuttosto che a Crocetta o a Marino non si sarebbero dimessi? Invece nel suo caso si parla di trasferimento ad altra sede. Ci chiediamo ancora una volta, fermo restando la presunzione d’innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, ma è opportuno che a “Zà Silvana” indossi ancora la toga? È opportuno che tutte le persone coinvolte in favoritismi, raccomandazioni e assunzioni ad amici e parenti restino ancora al loro posto? È opportuno che funzionari della DIA al servizio di questo sistema continuino a svolgere ancora funzioni pubbliche? Non comprendiamo quale sia la differenza tra questi soggetti e chi incassa una tangente. Entrambi utilizzano i propri ruoli istituzionali per rubare soldi pubblici. La giustizia è davvero uguale per tutti? Non ci soddisfano più le assicurazioni che tutto sarà chiarito. Sarà chiarito da chi? Quando e davanti a chi? Tutti invece devono essere immediatamente rimossi dai loro pubblici incarichi, in modo trasparente perché come cittadini abbiamo concesso credito a giudici che abbiamo ritenuto credibili, che abbiamo rispettato per la loro vita blindata, giudici che abbiamo ascoltato e dei quali abbiamo rispettato il lavoro senza alcuna delegittimazione preventiva. Vengano rimossi senza stipendio per rispetto verso tutti quei magistrati che hanno onorato e onorano i valori di autonomia e indipendenza, assicurando credibilità alla Giustizia con i comportamenti di tutti i giorni. Vengano rimossi per rispetto a tutti quei servitori dello Stato caduti nell’adempimento del dovere. Vengano rimossi e gli vengano sequestrati i beni per rispetto a tutti coloro che chiamati a collaborare con l’autorità giudiziaria con compiti delicatissimi e complessi lo fanno con coraggio. Pochi giorni fa i deputati della nostra regione hanno approvato in Commissione in tempo record il ddl salva burocrati e nominati. La finanziaria del 2012 ed un parere del Cga del 2014 hanno stabilito la gratuità degli incarichi nelle società partecipate dalla Regione e vietato le superindennità aggiuntive agli alti dirigenti. Fatto questo che avrebbe comportato anche la restituzione delle somme. Ebbene la stessa Ars che fa le pulci ai gettoni di presenza ai consiglieri comunali per cifre irrisorie ha varato un ddl in 10 minuti per salvare i maxicompensi aggiuntivi agli alti burocrati e ai blindati. Il presidente della lotta alla manciugghia, Crocettino, è diventato il Santo protettore della casta. Ricordiamo che negli anni ’80, ’90, il sogno di tanti giovani era quello di una società nella quale se sei bravo e se ti impegni, farai strada. Adesso se nasci parìa crepi parìa. Tra una casta e l’altra ci sono muraglie cinesi. Non esiste più la media borghesia e neanche la piccola. Ci sono le caste e poi la plebe, il volgo. Hanno fatto quadrato tra di loro. Le caste hanno fatto rete, si coalizzano tra loro. La casta degli antimafia, come se l’antimafia fosse una categoria dello spirito, gli intoccabili ed unti dal Signore per antonomasia si è coalizzata con quella dei politici e spesso con quella dei burocrati. Ovunque ti giri ci sono i privilegiati che si fanno beffe di chi è dall’altra parte dello steccato. Ogni loro gesto è uno sputo in faccia a chi fatica onestamente, a chi si suda lo stipendio, a chi pur sudando non avrà mai un diritto. Le caste sono intoccabili. E in quanto tali trattano gli altri con arroganza e sfacciataggine. Ci sentiamo come si sentivano i poveracci alla vigilia della Rivoluzione francese, anzi peggio, perché adesso ti prendono in giro con l’ipocrisia della democrazia e l’illusione della libertà. Nella Francia della Rivoluzione c’era Maria Antonietta che ha detto “Se non c’è pane non possono mangiare grissini?”. Adesso abbiamo a “Zà Silvana” che dall’alto della casta dice: “18 mila euro di spesa non pagata al supermercato? Che sbadata. Mica faccio io la spesa”. È la Rivoluzione Francese ai tempi da “Zà Silvana”. Un ultimo e accorato appello a tutte le Associazioni Antiracket e Antimafia che non sentono la necessità di proferire parola neanche davanti a delle gravissime minacce ricevute dal Direttore di Telejato, Pino Maniaci, da parte della Saguto (a “Zà Silvana”) e del Prefetto Cannizzo, che parlando tra di loro hanno affermato: “Pino Maniaci ha le ore contate”. E ai ragazzi di Addiopizzo. Forza ragazzi fate sentire la vostra variopinta presenza e alzate in coro la voce organizzando graziosi sit-in di protesta nelle pubbliche piazze e davanti al Tribunale di Palermo, datevi da fare ad appendere sui pali e le vetrine di Palermo la scritta: “Un Magistrato e un Prefetto che usano il loro potere per fini personali sono persone senza dignità”.
Il caso Saguto e la società delle caste: l'antimafia, i giudici, i burocrati, i politici. E poi la plebe. L'inchiesta che riguarda il giudice Saguto, insieme ad una serie di altri fatti di cronaca mi hanno convinta che viviamo in una società divisa in caste. Da un lato gli intoccabili, i privilegiati, dall'altro la plebe. Ai tempi di Maria Antonietta lei diceva "mangiate biscotti se non avete pane", oggi c'è un giudice che non si accorge di 18 mila euro di conto non pagato al supermercato..., scrive domenica 25 Ottobre 2015 Rosaria Brancato su “Tempo Stretto”. Il caso Saguto non mi ha fatto dormire la notte. Per 10 giorni ho avuto il panico temendo quale cosa raccapricciante avrei letto il giorno dopo a proposito dell’inchiesta su Silvana Saguto, ormai ex presidente della sezione misure preventive del Tribunale di Palermo. L’indagine su quel che accadeva nella gestione dei beni confiscati alla mafia (che in Sicilia rappresentano il 43% del totale) sta facendo emergere di tutto. La Saguto spaziava dalle nomine di amministratori giudiziari nelle società confiscate in cambio di incarichi per il marito, i parenti e gli amici, all’utilizzo dell’auto blindata come taxi per prelevare la nuora e accompagnarla nella villa al mare, o delle sue ospiti per non incappare nel traffico palermitano, oppure dal farsi recapitare a casa per le cene 6 chili tonno fresco, lamponi, (di provenienza da aziende sotto sequestro) al conto da quasi 20 mila euro non pagato al supermercato confiscato (“una dimenticanza, non sono io quella che va a fare la spesa..”). La “zarina” delle misure preventive si è data da fare per la laurea del figlio ottenuta grazie all’aiuto del docente della Kore di Enna, Carmelo Provenzano che in cambio veniva nominato consulente. Il giovane laureato, stando alle intercettazioni, la festa proprio non la voleva “questa laurea è una farsa, gli altri sgobbano per averla” ma il giudice non sentì ragioni e affidò l’organizzazione proprio al professore Provenzano che oltre a scrivere la tesi ha provveduto al menù, così come avverrà per la successiva festa di compleanno della Saguto. Gli agenti della scorta infine venivano utilizzati per andare in profumeria a fare acquisti. Ciliegina sulla torta del dichiarazioni del giudice antimafia a proposito dei figli di Paolo Borsellino, Manfredi e Anna. Il 19 luglio, anniversario dell’assassinio di Borsellino, Silvana Saguto partecipa come madrina alla manifestazione Le vele della legalità, fa il suo bel discorso antimafia, poi sale a bordo dell’auto blindata ed al telefono dice ad un’amica: “Poi Manfredi che si commuove, ma perché minc...a ti commuovi a 43 anni per un padre che è morto 23 anni fa? Che figura fai? Ma che... dov'è uno... le palle ci vogliono. Parlava di sua sorella e si commuoveva, ma vaff....o". Di fronte a tutto questo sappiamo solo che il CSM ascolterà nei prossimi giorni i giudici coinvolti (ce ne sono altri 4 che continuano ad operare a Palermo). Mi chiedo, anche a tutela dell’immagine di migliaia di magistrati onesti ma se a Donna Sarina fossero stati contestati la metà dei fatti addebitati alla Saguto non sarebbe stata agli arresti domiciliari? Se fossero stati contestati a Renzi, piuttosto che a Crocetta o a Marino non si sarebbero dimessi? Invece nel suo caso si parla di trasferimento ad altra sede. Mi chiedo, fermo restando la presunzione d’innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, ma è opportuno che indossi ancora la toga? La giustizia è davvero uguale per tutti? Leggo anche dell’arresto per corruzione dell’ex direttrice del carcere di Caltanissetta Alfonsa Miccichè. La signora affidava progetti con somme inferiori ai 40 mila euro (quindi non soggetti ad evidenza pubblica) a società che in cambio assegnavano incarichi alla figlia ed al genero. Sempre in questi giorni scopro che al Comune di Sanremo il 75% dei dipendenti è assenteista e c’è chi è stato filmato mentre timbrava il cartellino in mutande e poi tornava a letto o lo faceva timbrare da moglie e figli. Il sindaco di Sanremo dichiara: “sto valutando i provvedimenti da prendere. Forse ANCHE il licenziamento”. A prescindere dal fatto che se licenzi questi ladri di lavoro almeno puoi assumere qualcuno onesto che ti fa funzionare il Comune e adesso è disoccupato, mi chiedo signor sindaco: che significa ANCHE il licenziamento? Che vorresti fare? Premiarli? Che differenza c’è tra questi assenteisti e l’impiegato che incassa la tangente? Entrambi rubano soldi pubblici. Torniamo in Sicilia dove pochi giorni fa i deputati hanno approvato in Commissione intempo record il ddl salva burocrati e nominati. La finanziaria del 2012 ed un parere del Cga del 2014 hanno stabilito la gratuità degli incarichi nelle partecipate e vietato le superindennità aggiuntive agli alti dirigenti. Fatto questo che avrebbe comportato anche la restituzione delle somme. Ebbene la stessa Ars che fa le pulci ai gettoni di presenza ai consiglieri comunali per cifre irrisorie ha varato un ddl in 10 minuti per salvare i maxi compensi aggiuntivi agli alti burocrati e ai blindati. Il presidente della lotta alla manciugghia è diventato il Santo protettore della casta. A Roma mentre la sottosegretaria alla cultura Francesca Barracciu viene rinviata a giudizio per peculato per rimborsi da 81 mila euro il presidente del Consiglio Renzi annuncia di voler togliere l’Ici sulla prima casa a TUTTI, sia che abbiamo un castello che un tugurio. E si definisce di sinistra….Ricordo negli anni ’80, ’90, il sogno della Milano da bere era quello di una società nella quale se sei bravo, se ti impegni, farai strada. Adesso se nasci parìa crepi parìa. Tra una casta e l’altra ci sono muraglie cinesi. Non esiste più la media borghesia e neanche la piccola. Ci sono le caste e poi la plebe, il volgo. Hanno fatto quadrato tra di loro. Le caste hanno fatto rete, si coalizzano tra loro. La casta degli “antimafia”, gli intoccabili ed unti dal Signore per antonomasia si è coalizzata con quella dei politici e spesso con quella dei burocrati. Ovunque ti giri ci sono i privilegiati che si fanno beffe di chi è dall’altra parte dello steccato. Ogni loro gesto è uno sputo in faccia a chi fatica onestamente, a chi si suda lo stipendio, a chi pur sudando non avrà mai un diritto. Le caste sono intoccabili. La Barracciu era la candidata che Renzi voleva ad ogni costo per la presidenza della Regione Sardegna. A causa dello scandalo, ha ripiegato per un posto di sottosegretario. La Barracciu, la Saguto, le leggi ad personam mentre la Sicilia muore di fame. E’ la sfacciataggine degli intoccabili. Mi sento come si sentivano i poveracci alla vigilia della Rivoluzione francese, anzi peggio, perché adesso ti prendono in giro con l’ipocrisia della democrazia e l’illusione della libertà. Nella Francia della Rivoluzione c’era Maria Antonietta che dice “ma se non c’è pane non possono mangiare grissini?”. Adesso abbiamo il giudice antimafia Silvana Saguto che dall’alto della casta dice: “18 mila euro di spesa non pagata al supermercato? Che sbadata. Mica faccio io la spesa”. E’ la Rivoluzione Francese ai tempi della Saguto. Rosaria Brancato.
Cultura antimafia con pregi e difetti, scrive Lionello Mancini su “Il Sole 24 ore” del 26 Ottobre 2015. I fatti e le parole sconvolgenti attribuiti alla presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo, Silvana Saguto, rimandano ancora una volta ai limiti con cui ciclicamente deve confrontarsi la cultura della legalità, nei diversi ambiti – istituzionali, imprenditoriali, professionali e associativi – in cui si esplica. Saguto, per anni nota e stimata esponente delle toghe antimafia, a suo tempo oggetto di minacce direttamente per bocca di Salvatore Riina, dirigeva fino a pochi giorni fa la sezione di Tribunale preposta al sequestro di beni ai mafiosi. Un incarico delicato, specie sull’isola di Cosa nostra e, per molti aspetti, pionieristico. Quantità, casistica e tipologia dei sequestri si sono ampliate e complicate giorno dopo giorno. I beni vanno gestiti e valorizzati fino alla confisca definitiva. Per questo i giudici delle misure di prevenzione di tutta Italia si consultano in continuazione, propongono modifiche alle leggi, creano una loro associazione per condividere le esperienze. Un lavoro meritorio e quasi sconosciuto. Nei mesi scorsi nascono a Palermo voci sui criteri e sull’accentramento delle deleghe su pochi nomi, seguono inchieste giornalistiche, la Procura di Caltanissetta apre un fascicolo. Emerge così una storia di favoritismi sfacciati, di gestione familistica della sezione, di ingenti debiti personali della presidente, di favori e regali scambiati o promessi, fino all’accusa di corruzione e alle dimissioni dalla funzione (non dalla magistratura). Fino alle intercettazioni ambientali che raccolgono insulti feroci alla famiglia Borsellino. Meglio non rifugiarsi nella tesi della “mela marcia”. Solo per restare in tema e agli ultimi anni, è già accaduto con Vincenzo Giglio, il presidente dell’omologa sezione di Reggio Calabria, appena condannato in via definitiva per corruzione e rapporti con i clan; e con Maria Rosaria Grosso, giudice della sezione fallimentare di Milano, indagata per tentata concussione e abuso d’ufficio. Certo, esiste un problema di qualità dei singoli cui viene conferito l’enorme potere decisionale ed economico della giurisdizione. Ma accade che i vertici palermitani debbano ammettere di non essere in grado di fornire una mappa degli incarichi agli amministratori giudiziari; accade che nessun collega della stessa sezione, o del Tribunale, abbia notato o segnalato alcuna anomalia in certe scelte, amicizie, parentele; che un magistrato ottimamente retribuito si indebiti fino alla disperazione senza che nessuno se ne accorga e anche per questo – sostiene Saguto – sfrutti il proprio ruolo per restare a galla. Al di là degli individui, tutto ciò significa che in ampie zone della magistratura, perno istituzionale dell’azione antimafia e ordine autogovernato come solo il Parlamento, non vige alcun tipo di verifica e di controllo. Solo malasorte? No. Esistono uffici giudiziari – anche molto meno esposti di Palermo – che ormai controllano i flussi di lavoro, gli incarichi, gli ammontari, popolando banche dati dalle quali estraggono informazioni in tempo reale; ci sono Tribunali, Procure e Corti d’appello che redigono il bilancio sociale per avere «una struttura organizzativa più efficiente, per migliorare la capacità di comunicazione con i cittadini, aumentando la trasparenza dell’azione svolta» (testuale dal sito del ministero) ed è certo che in questi uffici il livello di controllo è di ben altra efficacia. Non è impossibile, a volerlo fare. Ma bisognerebbe sentirsi meno casta intoccabile e un po’ più reparto pregiato dello schieramento che comprende commercianti iscritti alla Federazione antiracket, imprenditori con il rating di legalità, giovani delle associazioni, sacerdoti e sindaci coraggiosi, pubblici dipendenti che non prendono mazzette. Ognuno di questi protagonisti mostra pregi da emulare e difetti da correggere, ma premessa per avanzare è prendere onestamente atto dei propri limiti. Altrimenti si arretra a forza di indicare le responsabilità altrui, lasciando che la bufera mediatica e giudiziaria si plachi, per riprendere a sbagliare dal punto in cui si era stati interrotti.
QUESTIONI DI FAMIGLIA. I fatal mariti, scrive Sabato 19 Settembre 2015 Accursio Sabella su “Live Sicilia”. Silvana Saguto è costretta a lasciare il suo incarico a causa di una indagine che riguarda presunti favori al marito. La corsa di Anna Finocchiaro verso il Quirinale è stata frenata anche dal caso del Pta di Giarre che coinvolse il coniuge. E non sono gli unici casi, dalla consulenza del "signor Chinnici" al ritardo di "mister Monterosso". La moglie di Cesare deve apparire più onesta dell'imperatore. L'immagine è rievocata a ogni scandalicchio e parentopolina. Qualcuno, però, in questi anni ha forse dimenticato i mariti delle imperatrici. Fatal mariti, in molti casi. È il caso di Silvana Saguto, ma non solo il suo. Perché i coniugi delle donne di potere, in qualche caso, hanno finito per frenare e troncare carriere. O, in qualche caso, per trascinare nella centrifuga di polemiche più o meno sensate, le mogli. Ne sa qualcosa, come abbiamo già detto, Silvana Saguto, che ha lasciato l'incarico di presidente della Sezione misure di prevenzione. È indagata per corruzione e abuso d'ufficio. E la questione riguarda anche il marito, appunto. L'accusa al magistrato infatti è relativa ai rapporti con Gaetano Cappellano Seminara, il più noto degli amministratori giudiziari. A lui sono giunti diversi incarichi di gestione di beni confiscati alla mafia. Una fiducia ripagata – questa l'accusa, tutta da dimostrare – tramite consulenze che lo stesso Cappellano Seminara avrebbe assicurato a Lorenzo Caramma, marito della Saguto. Quanto basta, ovviamente, per fare da miccia a un'esplosione di veleni e accuse incrociate che pare ancora all'inizio. E ha già portato all'estensione dell'indagine ad altri tre magistrati. Intanto, la Saguto ha fatto le tende. Attenderà un altro incarico. Ma il “colpo” alla carriera del magistrato è stato durissimo. Marito, fatal marito. Che a pensarci bene, un'altra storia di coniuge “scomodo” potrebbe aver contribuito a chiudere le porte del Quirinale a una donna siciliana. È il caso di Anna Finocchiaro e soprattutto del fatal marito, Melchiorre Fidelbo. Quest'ultimo è infatti finito dentro una inchiesta su un maxi appalto dell'Asp di Catania destinato all'apertura del “Pta” di Giarre: una struttura sanitaria “intermedia” che avrebbero dovuto alleggerire il peso dei grossi ospedali. Fidelbo nell'ottobre del 2012 è stato anche rinviato a giudizio per abuso di ufficio e truffa: è accusato di aver fatto pressioni indebite sui dirigenti dell'Azienda sanitaria con lo scopo di ottenere l'affidamento. Una vicenda ovviamente tirata fuori dai detrattori della Finocchiaro, nei giorni caldi che hanno portato alla scelta del nuovo Capo dello Stato. Siciliano, ma uomo. Nonostante la Finocchiaro pare piacesse molto anche a Forza Italia. Ma quella storia... Chissà cosa si saranno detti, invece, Patrizia Monterosso e Claudio Alongi, suo marito. E no, non c'entrano nulla i potenziali conflitti di interesse tra un Segretario generale che contribuisce a scrivere le norme sui dipendenti regionali e il commissario dell'Aran che – visto il ruolo – con i dipendenti regionali deve discutere le norme che li riguardano. No, la storia è un'altra. Ed è, in fondo, sempre la stessa. Quella per la quale la plenipotenziaria di Palazzo d'Orleans è stata condannata dalla Corte dei conti a oltre un milione di risarcimento per la vicenda degli extrabudget nella Formazione professionale. Una condanna giunta nonostante l'appassionata difesa del marito-avvocato Claudio Alongi. Anzi, “tecnicamente” proprio a causa dell'avvocato-consorte. Perché il ricorso della Monterosso, al di là delle questioni di merito che, stando ai giudici sarebbero rimaste tutte in piedi, è stato respinto per un ritardo nella presentazione di alcuni documenti. Ritardo dei legali, appunto. Marito compreso. Paradossi delle vite coniugali che si intrecciano con le vite pubbliche. Ne sa qualcosa Caterina Chinnici. Fu lei la massima sostenitrice di una legge sulla trasparenza che finalmente poneva dei paletti (in questi anni a dire il vero, serenamente ignorati) riguardo alla pubblicazione degli atti, degli stipendi e degli incarichi pubblici. Il caso, però, ha voluto che a ignorare quelle disposizioni fosse anche un consulente dell'Asp di Siracusa, Manlio Averna. Marito di Caterina Chinnici. Un caso che creò anche tensioni all'interno della giunta di Raffaele Lombardo, con Massimo Russo, ad esempio, molto critico sulla “dimenticanza” dell'Azienda siracusana. "Non si può addebitare alla sottoscritta – replicò Caterina Chinnici - l'eventuale inadempienza di coloro che dovrebbero controllare”. Polemiche, ovviamente, poco più. Nulla a che vedere col “caso Saguto”, se non il ricorrere di questi “incroci pericolosi” tra il divano di casa e le scrivanie del sistema pubblico. Fastidi, o poco più, in cui il marito non sarà stato “fatale” per la carriera, ma che certamente ha regalato alla consorte qualche minuto o qualche giorno di tensione. Avvenne anche a Vania Contrafatto, attuale assessore all'Energia. E il casus belli fu addirittura una cena, organizzata da Sandro Leonardi, candidato dell'Idv al Consiglio comunale e marito della Contrafatto. All'appuntamento c'erano, tra gli altri, il procuratore Francesco Messineo e gli aggiunti Leonardo Agueci e Maurizio Scalia. Quest'ultimo era il magistrato che coordinava l'indagine sui brogli alle primarie del centrosinistra. Una rivelazione, quella, lanciata ironicamente nel corso di una conferenza stampa da Antonello Cracolici: “Per sapere qualcosa sui presunti brogli alle primarie - disse il capogruppo del Pd all'Ars - forse avremmo dovuto essere a una cena elettorale che si è tenuta sabato a Mondello alla quale hanno partecipato, oltre al candidato sindaco Leoluca Orlando, alcuni pm di Palermo che seguono le indagini sulla vicenda". Orlando aveva denunciato brogli a quelle consultazioni accusando il vincitore di quelle primarie, Fabrizio Ferrandelli. Tutto si sgonfiò presto, con una nota del pm Scalia con la quale il magistrato spiegò di aver preso parte “a un ricevimento in una casa privata di una collega e amica per festeggiarne l'inaugurazione”. Vania Contrafatto, appunto. Una delle cene probabilmente più indigeste per quello che sarebbe diventato il futuro assessore all'Energia. E un marito può essere fatale persino “a costo zero”. Chiedete a Valeria Grasso, nominata da Crocetta Soprintendente della Fondazione orchestra sinfonica. Tra i consulenti, ecco spuntare il marito Maurizio Orlando: “Ma è qui a titolo gratuito”, provò a spiegare l'imprenditrice antiracket. Pochi mesi dopo, Crocetta l'avrebbe rimossa dalla guida della Foss.
Lo scandalo dei beni sequestrati alla mafia e il ruolo della Massoneria, scrive Riccardo Gueci su "La Voce di New York" dekl 29 ottobre 2015. Tutti sapevano come veniva gestita la Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Ma nessuno parlava. E il motivo è semplice: perché dietro questo grande affare c’è la Massoneria. I grandi 'numeri' della holding di don Ciotti, Libera: chi guadagna sulle lucrose vendite dei prodotti agricoli di questa associazione antimafia? Sull’indegna questione che ha investito la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo vanno in scena le sceneggiate di tanti protagonisti. Il primo è un esponente del mondo politico. A recitarla è l'onorevole Claudio Fava, membro autorevole della Commissione parlamentare Antimafia. Salvo Vitale - come riportato nella pagina Facebook di Riccardo Compagnino - riprende una dichiarazione del deputato di Sinistra Ecologia e Libertà nella quale si legge: “C'è un punto di cui nessuno ci ha mai parlato, ovvero che il marito della presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, avesse una preziosa consulenza con lo studio del commercialista che si occupa della gran parte dei beni sequestrati”. A questa dichiarazione, Salvo Vitale, con la serenità di chi sa il fatto suo, ribatte: “A parte il fatto che Cappellano Seminara è un avvocato e non un commercialista, non è giusto, né corretto che tu faccia questa affermazione”. E, nel far trasparire che egli con quel deputato ha avuto una qualche frequentazione, continua: “Già un anno fa, quando è esploso il problema, ti sei schierato a fianco della Bindi (presidente della Commissione Antimafia, ndr) per 'tutelare' l'immagine di un settore della Procura di Palermo di cui da tempo avevamo denunciato le malefatte e lo strano modo di procedere. Le denunce del Prefetto Caruso sono state pressoché ignorate e tutto è stato lasciato al suo posto. Anche quando sei venuto a farci visita ti abbiamo informato su quello che c'era sotto, hai abbassato il capo, dicendo che bisognava intervenire, ma forse eri distratto”. Vitale prosegue nella sua replica affrontando un aspetto che, con tutta probabilità, è quello di maggiore rilevanza economica e sociale di questo andazzo affaristico-massonico: il fallimento di aziende, anche quelle sequestrate a gente che è risultata estranea agli affari di mafia. Questa serie di fallimenti ha concorso a determinare l'impoverimento dell'economia di Palermo e della sua provincia, che già di suo non è mai stata prosperosa. “Invece di lasciarsi prendere dalla paura di una destabilizzazione della magistratura - aggiunge Vitale - cosa peraltro ripetuta dal giudice Morosini - sarebbe stato più utile per la storia che ti porti appresso chiedere di far pulizia all'interno di essa, anche perché la fiducia dei cittadini non si conquista facendo credere che tutto è a posto, anche se tutto va male, ma intervenendo per far pulizia e mettere davvero tutto a posto, quando bisogna far pulizia in casa. Bastava guardare a Villa Teresa (Villa Santa Teresa, clinica privata confiscata all’ingegnere Michele Aiello ndr) - dove la scandalosa amministrazione del pupillo di Cappellano Seminara, Andrea Dara, che gli ha regalato un milione di euro per una consulenza, ha prodotto danni economici e gestionali incalcolabili - per renderti conto che la signora Saguto Silvana, il signor Caramma Elio, suo figlio, e il signor Caramma Lorenzo, suo marito, hanno effettuato radiografie, risonanze magnetiche, cervicale, dorsale, spalla, ginocchio senza che il loro nome risulti sulla lista dei pagamenti. Bastava chiedere alla signora Saguto una motivazione sul perché tanti incarichi nelle mani di poche persone e sul perché si sono emessi decreti di confisca quando la magistratura penale aveva escluso la provenienza mafiosa del bene. Bastava. E, invece, non si è fatto niente. E' facile dire che non sapevamo...è difficile crederci”. In sostanza, il deputato di Sel e vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia ha recitato la sua sceneggiata e Vitale con dovizia di particolari e di argomenti l'ha recensita a dovere. Fin qui l'arringa di Vitale. Ma c'è un'altra fonte di notizie che va tenuta in debita considerazione ed è quella di Pino Maniaci, direttore di TeleJato, la testata che per prima ha sollevato il caso. Maniaci è stato intervistato dal nostro Giulio Ambrosetti “per conoscere qualche dettaglio in più e le sue valutazioni sul caso” ed ha avuto modo di annotare alcune sue valutazioni assai interessanti. In particolare su quanto riportato in un articolo del Giornale di Sicilia che rende noti alcuni stralci delle intercettazioni telefoniche tra la dottoressa Silvana Saguto e l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, dove si fa riferimento all'impresa Calcestruzzi. Pino Maniaci, saggiamente, precisa: “Quando si parla di Calcestruzzi a chi si fa riferimento? Ricordo che Grimaldi, il figlio di un cancelliere (del Tribunale di Palermo ndr) amministra almeno dodici aziende di calcestruzzo”. Quindi l’affondo: “La dottoressa Saguto ha tirato in ballo Libera. Addiopizzo e il presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarnotta. A suo dire le associazioni antimafia e antiracket segnalavano i nomi degli amministratori giudiziari. Tutto questo a me sembra incredibile”. Ad una seconda domanda generica sulle associazioni antimafia, “parliamo un po' di Libera e di Addiopizzo”, Pino Maniaci puntualmente fa rilevare che “sia Libera, sia Addiopizzo sono partite da zero. Oggi sono delle holding. Ciò posto, il ruolo che hanno svolto è positivo. Su Libera mi sono posto e continuo a pormi qualche domanda. Per esempio: perché i prodotti di Libera debbono costare tanto? Un pacco di pasta 5/6 euro, un vasetto di caponata 5 euro. Sono prezzi proibitivi. Sarebbe auspicabile che tali prodotti diventino accessibili a tutte le tasche. Sull'argomento ho chiesto un parere a don Ciotti. Ma non ho avuto risposte”. Le tirate moralistiche di don Luigi Ciotti le dobbiamo considerare anch'esse sceneggiate? “Poi c'è la questione legata ai sequestri. Mi riferisco alla proposta di legge, che il Parlamento deve ancora iniziare a discutere, sulla gestione dei beni sequestrati. Questa proposta di legge - relatore il parlamentare Davide Matello, del PD, da sempre vicino a Libera - prevede di assegnare alle associazioni antimafia, in via provvisoria, i beni e le aziende sequestrate alla mafia. A me questa proposta sembra sbagliata. Ricordiamoci che un bene sequestrato può tornare al suo legittimo proprietario, là dove non dovessero emergere problemi”. E sempre a questo proposito, che risulta essere uno dei temi più delicati del sistema delle confische, Maniaci prosegue nel ricordare come in alcune vicende che hanno visto tante imprese avere avuto riconsegnate le loro aziende dopo il sequestro, svuotate di ogni attività, al limite del fallimento. Con questa procedura “è stata distrutta buona parte dell'economia di Palermo e della sua provincia”. Ed aggiunge “sarebbe interessante ascoltare le testimonianze degli imprenditori che hanno subito queste ingiustizie”. E ricorda la vicenda dell'impresa Niceta che con tutta probabilità chiuderà i battenti: “Della vicenda Niceta abbiamo le carte. Gli amministratori giudiziari hanno licenziato circa 50 dipendenti e ne hanno assunti 24. Alcuni di questi nuovi assunti sono amici del solito giro. L'ho detto e lo ribadisco: in questa vicenda tagliare le teste lasciando il corpo non serve a nulla. A che serve mandare via Virga se poi i coadiutori, nominati dallo stesso Virga, restano?”. E continua: “Dietro la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia ci sono interessi enormi. Vi siete chiesti perché la dottoressa Saguto non è stata toccata? Ve lo dico io: perché tiene in pugno personaggi importanti”. Fin qui l'intervista a Pino Maniaci. C'è poi un'altra sceneggiata, che sa di paradosso. Stavolta la limitiamo al massimo. La dottoressa Saguto, poverina, a causa del magro stipendio che le passa lo Stato per il suo lavoro di magistrato, si era ridotta a contrarre un debito con il supermercato - sequestrato alla mafia - dove faceva la spesa per sfamare la famiglia. Ed addirittura secondo un articolo apparso sul Giornale di Sicilia, la poverina non aveva i soldi per pagare la bolletta della luce. Le cronache ci consegnano questo quadro, al netto delle intercettazioni telefoniche che riguardano giudizi del tutto gratuiti sui figli di Paolo Borsellino, il magistrato fatto saltare con la sua scorta in via D'Amelio nel 1992, delle quali ci intratterremo in seguito. Queste cronache ci inducono a sottolinearne alcuni aspetti. Il primo riguarda il sistema gerarchico del Tribunale di Palermo. Se la Sezione Misure di prevenzione procede al sequestro di beni per i quali la stessa ‘macchina’ della Giustizia ha escluso la provenienza mafiosa, non c'è in quel sistema gerarchico qualcuno che faccia presente che quel sequestro è illegittimo? La ragione di questa 'assenza' è dovuta ad un potere occulto, che anche i ciechi e i sordi sanno fare capo alla Massoneria. Infatti, tutti gli uffici del Tribunale, specialmente Civile e in parte del Lavoro, sono largamente infiltrati dal potere massonico. Lo sanno tutti, ma nessuno parla. Nel giro è compresa larga parte dell'avvocatura. La cosa non è nuova, basta ricordare quello che è accaduto al dottor Alberto Di Pisa quando, sull'argomento, si 'permise' di esprimere qualche opinione. Ricordate la vicenda del “corvo”? Da allora non è cambiato nulla. Anzi! Non va trascurato il fatto che molto spesso tra la Massoneria e la mafia è esistita una intesa molto stretta. Infatti, tra sette segrete ci si intende più facilmente e si possono curare affari molto lucrosi se si opera di comune accordo. Intanto quelle aziende, affidate alle 'cure' di amministratori di fiducia vengono distrutte e, talora, riconsegnate ai legittimi proprietari semi fallite e con le maestranze licenziate. Con il bel risultato di avere provocato sia un danno all'economia, sia un contributo in più alla disoccupazione. Il secondo fa riferimento alle perplessità manifestate da Pino Maniaci a proposito di Libera, l'associazione creata dal don Luigi Ciotti per amministrare, attraverso un sistema di cooperative, i beni immobili, specialmente terreni agricoli confiscati alla mafia. Maniaci fa riferimento ai prezzi proibitivi dei prodotti agricoli di queste cooperative e di averne chiesto inutilmente le motivazioni a don Ciotti. E rileva che ormai Libera è una vera e propria holding. A proposito di tale questione va ricordato che le cooperative agricole, promosse da Libera, che gestiscono i terreni agricoli confiscati alla mafia sono finanziate con le risorse finanziarie europei dei PON, cioè dei Piani Operativi Nazionali, sezione fondi strutturali europei per la sicurezza. In definitiva quelle cooperative hanno i costi di gestione coperti dai fondi europei e, spesso, utilizzano locali di vendita dei loro prodotti anch'essi confiscati alla mafia. Non solo. Per l'uso dei terreni agricoli non pagano nulla, ancorché in affidamento. Il capitale investito dai loro soci è di entità simbolica. In sostanza, gestiscono soltanto utili. In presenza di queste condizioni irripetibili in nessuna parte del mondo, non si capisce la ragione economica del perché i loro prodotti abbiano questi prezzi proibitivi destinati al consumatore di reddito medio alto. A chi vanno questi ragguardevoli profitti? Un’indagine su costi, ricavi e investimenti delle cooperative di Libera non sarebbe del tutto fuori luogo. Il terzo riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Secondo quanto riferito dalla dottoressa Silvana Saguto, l'organo di autogoverno dei magistrati ha invitato tutti coloro che sono implicati nelle vergognose vicende ricordate in precedenza a chiedere il trasferimento. Questo è un punto delicato per la credibilità della Magistratura che rischia di farla apparire una corporazione al di sopra e al di fuori della legge che vale per tutti gli altri cittadini italiani. La questione, invece, è molto semplice: la dottoressa Saguto, nell'ambito dei suoi compiti d'istituto, ha compiuto quegli atti che le vengono addebitati? Allora: se quegli atti si configurano non conformi alla deontologia professionale o, addirittura, come reati, la dottoressa Saguto e i suoi complici vanno licenziati in tronco alla stregua di qualsiasi altro lavoratore che non svolga i compiti che gli sono assegnati con la dovuta correttezza. In questo caso nella condizione del licenziamento dovrebbe figurare pure il divieto perenne ad entrare in un'aula di qualsiasi Tribunale italiano, neanche come avvocato. Il congresso del sindacato italiano dei magistrati, ove volesse darsi un minimo di dignità, dovrebbe discutere di deontologia e di valori etici nell'esercizio della professione per dare più forza e credibilità alla funzione del magistrato. *Riccardo Gueci è un dirigente pubblico in pensione. Cresciuto nel vecchio Pci, non ha mai dimenticato la lezione di Enrico Berlinguer. Per lui la politica non può essere vista al di fuori della morale (Berlinguer, grande leader del Pci, a proposito della gestione del potere in Italia, parlava infatti di "Questione morale"). Per noi Gueci commenta i fatti legati alla politica estera e all'economia. Oggi affronta il tema delle polemiche che stanno accompagnando la gestione della Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Tema che affronta da una particolare angolazione: quella economica, per l'appunto. Sottolineando il ruolo che nell'economia siciliana - spesso in modo occulto - viene svolto dalla Massoneria.
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO: LITURGIA APPARISCENTE, AUTOREFERENZIALE ED AUTORITARIA.
Ogni anno, dopo il Natale, Capodanno e la Befana, si reitera la liturgia pagana dell’osanna all’ordine della Magistratura, con la liturgia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.
LITURGIA APPARISCENTE, AUTOREFERENZIALE ED AUTORITARIA.
Il commento del Dr. Antonio Giangrande, esperto di Diritto e di Giustizia, in quanto sul tema ha scritto “Impunitopoli, Legulei ed Impunità” e “Malagiustiziopoli” con “Giustiziopoli”: disfunzioni del sistema che colpiscono la collettività o il singolo. Il quale ritiene i magistrati, unti dal delirio di onnipotenza, gli unici responsabili del degrado sociale, culturale ed economico del nostro paese.
Sui media prezzolati e/o ideologicizzati si parla sempre dei privilegi, degli sprechi e dei costi della casta dei rappresentanti politici dei cittadini nelle istituzioni, siano essi Parlamentari o amministratori e consiglieri degli enti locali. Molti di loro vorrebbero i barboni in Parlamento. Nessuno che pretenda che i nostri Parlamentari siano all’altezza del mandato ricevuto, per competenza, dedizione e moralità, al di là della fedina penale o delle prebende a loro destinate. Dimenticandoci che ci sono altri boiardi di Stato: i militari, i dirigenti pubblici e, soprattutto, i magistrati. Corruzione nel cuore dello Stato. Solo alla Difesa 130 dipendenti sotto accusa. Al Mef c'è chi si porta via pure i timbri. Nel giro di due anni hanno subito provvedimenti disciplinari per reati penali anche 800 dipendenti della Guardia di Finanza. Neppure la Presidenza del Consiglio e il Consiglio di Stato sono immuni. Ecco la radiografia degli illeciti nelle istituzioni che non avete mai letto. Eppure la corruzione passa per il tribunale. Tra mazzette, favori e regali. Nei palazzi di giustizia cresce un nuovo fenomeno criminale. Che vede protagonisti magistrati e avvocati. C'è chi aggiusta sentenze in cambio di denaro, chi vende informazioni segrete e chi rallenta le udienze. Mai nessuno che si chieda: che fine fanno i nostri soldi, estorti con balzelli di ogni tipo. Se è vero, come è vero, che ci chiudono gli ospedali, ci chiudono i tribunali, non ci sono vie di comunicazione (strade e ferrovie), la pensione non è garantita e il lavoro manca. E poi sulla giustizia, argomento dove tutti tacciono, ma c’è tanto da dire. “Delegittimano la Magistratura” senti accusare gli idolatri sinistroidi in presenza di velate critiche contro le malefatte dei giudici, che in democrazia dovrebbero essere ammesse. Pur non avendo bisogno di difesa d’ufficio c’è sempre qualche manettaro che difende la Magistratura dalle critiche che essa fomenta. Non è un Potere, ma la sinistra lo fa passare per tale, ma la Magistratura, come ordine costituzionale detiene un potere smisurato. Potere ingiustificato, tenuto conto che la sovranità è del popolo che la esercita nei modi stabiliti dalle norme. Potere delegato da un concorso pubblico come può essere quello italiano, che non garantisce meritocrazia. Criticare l’operato dei magistrati nei processi, quando la critica è fondata, significa incutere dubbi sul loro operato. E quando si sentenzia, da parte dei colleghi dei PM, adottando le tesi infondate dell’accusa, si sentenzia nonostante il ragionevole dubbio. Quindi si sentenzia in modo illegittimo che comunque è difficile vederlo affermare da una corte, quella di Cassazione, che rappresenta l’apice del potere giudiziario. Le storture del sistema dovrebbero essere sanate dallo stesso sistema. Ma quando “Il Berlusconi” di turno si sente perseguitato dal maniaco giudiziario, non vi sono rimedi. Non è prevista la ricusazione del Pubblico Ministero che palesa il suo pregiudizio. Vi si permette la ricusazione del giudice per inimicizia solo se questi ha denunciato l’imputato e non viceversa. E’ consentita la ricusazione dei giudici solo per giudizi espliciti preventivi, come se non vi potessero essere intendimenti impliciti di colleganza con il PM. La rimessione per legittimo sospetto, poi, è un istituto mai applicato.
LITURGIA APPARISCENTE
Da Wikipedia si legge. L'Anno giudiziario, nell'ordinamento giudiziario italiano, è il periodo di tempo, corrispondente all'anno solare, nel quale è scandito lo svolgimento dell'attività giudiziaria, attraverso la fissazione del cosiddetto calendario giudiziario. Le modalità di svolgimento della cerimonia sono state modificate recentemente: fino al 2005, per ogni anno giudiziario, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e il Ministro della giustizia pronunciavano davanti al Presidente della Repubblica e alle altre autorità presenti una relazione generale sull’amministrazione della giustizia. Similmente, i procuratori generali presso ciascuna Corte d’appello comunicavano al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della giustizia la relazione per il proprio distretto. Questo in conformità all’articolo 86 del regio decreto n. 12 del 1941, più volte modificato negli anni. Dal 2006, a seguito di una modifica normativa, il Ministro della giustizia rende direttamente comunicazioni al Parlamento, sull’amministrazione della giustizia nell'anno appena trascorso e sugli interventi per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi che si intende attuare nell’anno che inizia. Successivamente si riuniscono in forma pubblica e solenne (cioè con la partecipazione di tutte le sezioni, i procuratori generali, i magistrati delle procure generali e i rappresentanti dell’Avvocatura dello Stato) prima la Corte suprema di cassazione e quindi le corti d'appello per ascoltare la relazione generale del Primo Presidente della Corte di cassazione e le relazioni per i singoli distretti dei Presidenti di corte d’appello; si passa quindi agli interventi (facoltativi) dei Procuratori generali e dei rappresentanti dell’Avvocatura dello Stato. L'inizio dell'Anno giudiziario è celebrato con apposite cerimonie solenni (nelle quali i magistrati indossano le toghe cerimoniali di colore rosso e bordate d'ermellino) presso la Corte suprema di cassazione e presso le corti d'appello dei distretti giudiziari italiani. Le cerimonie inaugurali sono occasione di prolusioni dei massimi esponenti dell'ordine giudiziario circa lo stato dell'amministrazione della giustizia nel territorio di competenza. In questo senso assume particolare rilevanza l'inaugurazione dell'Anno giudiziario presso la Corte suprema di cassazione, che precede di un giorno quelle presso i distretti giudiziari, e che si svolge alla presenza del Presidente della Repubblica. Anche i giudici speciali, come la magistratura amministrativa e quella contabile (il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti), ovvero la magistratura militare, hanno una propria cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario, che si svolge secondo modalità e con contenuti analoghi a quelli degli organi della magistratura ordinaria.
In queste occasioni si coglie in estrema sintesi la genuflessione dei media all’ordine giudiziario osannandone le virtù artefatte e riportandone le deliranti espressioni. I magistrati, che non vengono da Marte, si sentono e sono essi stessi giudici e legislatori. Il potere in mano al popolo: sia mai.
LITURGIA AUTOREFERENZIALE
In queste manifestazioni pubbliche, spesso, mancano le componenti contraddittorie insite nei processi, ossia l’Ordine degli avvocati. Sovente di leggono delle note, ignorate dai media, come questa: Le Camere penali di Basilicata, di Matera e la Camera penale "Alfredo Marsico" di Lagonegro (Potenza) "hanno deciso di non partecipare alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario" in programma domani, 24 gennaio, a Potenza, "raccogliendo l'invito dell'Unione Camere penali italiane di disertare una cerimonia ancora autoritaria e appariscente che non consente un concreto dibattito sui problemi della giustizia".
Il rito stantio delle toghe rossocerimonia, dell'anno giudiziario, è un rito destinato alla liturgica dei monologhi autoreferenziali e dell’elencazione dei problemi della Giustizia da addebitare agli altri.
Excusatio non petita, accusatio manifesta è una locuzione latina di origine medievale. La sua traduzione letterale è "Scusa non richiesta, accusa manifesta", forma proverbiale in italiano insieme all'equivalente "Chi si scusa, si accusa".
Il senso di questa locuzione è: se non hai niente di cui giustificarti, non scusarti. Affannarsi a giustificare il proprio operato senza che sia richiesto può infatti essere considerato un indizio del fatto che si abbia qualcosa da nascondere, anche se si è realmente innocenti. Liturgia inutile, i magistrati si autoassolvono.
E così, è andata anche quest’anno. L’Italia, pur sede del Vaticano – specialista in coreografie religiose dalle quali emerge comunque la presenza dello Spirito – si segnala per una particolare tenacia nella ripetizione ad oltranza di liturgie laiche (che è, si badi, una inutile ripetizione, poiché liturgia altro non significa se non “opera del popolo”) tanto ostinate quanto inutili, scrive Vincenzo Vitale su “Il Garantista”.
Per i magistrati il malfunzionamento della Giustizia va ricondotto alla Prescrizione.
LITURGIA AUTORITARIA
C’è un passaggio della solenne cerimonia del 2015 che traccia un bilancio crudo, amaro. Giorgio Santacroce, primo presidente della Cassazione, parla a un certo punto di «parabola discendente». Si riferisce ai suoi colleghi magistrati, scrive Errico Novi su “Il Garantista”. E se pure parte dalla «campagna irresponsabile di discredito» condotta «per anni» contro le toghe, e dà così la colpa anche alla politica, poi fa una diagnosi assai brutale: siamo davanti a «una situazione di crescente disaffezione verso la magistratura, dopo l’alto consenso dei tempi di Mani pulite è iniziata», appunto, «una parabola discendente».soprattutto, «i magistrati appaiono, anche quando non lo sono, conservatori dell’esistente e portatori di interessi corporativi». Di più: devono superare i loro «arroccamenti », e il richiamo pronunciato «davanti al Csm dal presidente Giorgio Napolitano» deve costituire per loro «un monito perché non ostacolino il rinnovamento, ma anzi si rinnovino essi stessi».
Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario le toghe finiscono dunque sul banco degli imputati, quanto meno al pari della politica. Le parole di Santacroce sono nette, ancora di più quando parla delle «tensioni» e delle «cadute di stile» che si registrano soprattutto fra i pm. Non è da meno il pg di Cassazione Gianfranco Ciani, che una mezz’ora più tardi interviene a sua volta nell’aula magna del Palazzaccio romano e si scaglia contro quei pm «troppo deboli alle lusinghe della politica». Due relazioni (di cui riportiamo ampi stralci nelle due pagine successive, ndr) che lasciano almeno intravedere una svolta. I riferimenti dei due più alti magistrati della Suprema Corte alle mancanze dei colleghi, ai limiti e alle storture del Csm, al vizio del correntismo in toga, sono numerosissimi.
Si sentono stretti nella morsa. E reagiscono, scrive “Il Garantista”. Dopo le scudisciate della cerimonia in Cassazione, i magistrati delle Corti d’Appello di tutta Italia tentano di replicare ai massimi vertici della Suprema Corte. Venerdì il primo presidente Giorgio Santacroce e il procuratore generale Gianfranco Ciani avevano parlato di toghe arroccate nel corporativismo, di pm cedevoli alle lusinghe dei media, di sacche d’inefficienza che il Csm spesso non riconosce. Insomma l’avevano fatta nera. E così nel day after, cioè nella giornata di ieri dominata dalle cerimonie inaugurali nei singoli distretti giudiziari, si è sentito di tutto. Non su Santacroce e Ciani, ma contro l’altro polo del potere: la politica. Si va dalla riforma di Renzi giudicata «ben misera cosa» a Milano al presidente di Reggio Calabria Macrì secondo cui «l’assenza di iniziative legislative di vasta portata» farà affondare «la giustizia nella palude». E poi si contano gli anatemi contro la corruzione che soffoca Roma da parte del presidente capitolino Antonio Marini, il quadro apocalittico delle collusioni tra camorra e e malapolitica di Antonio Buonajuto a Napoli, e insomma una batteria di denunce che stavolta si spostano dai vizi di giudici e pm a quelli delle altre, corrotte istituzioni.
Da Torino è partita la bordata più pesante, scrive “La Stampa”. Il procuratore generale Marcello Maddalena usa l’arma del sarcasmo per affrontare uno dei temi più controversi del piano del governo: «Il presidente del Consiglio non ha trovato niente di meglio che ispirarsi al personaggio di Napoleone della Fattoria degli animali di orwelliana memoria, che aveva scoperto il grande rimedio per tutti i problemi della vita: far lavorare gli altri fino a farli crepare dalla fatica, come il cavallo Gondrano».
Dottor Maddalena, perché questo affondo rivolto al presidente del Consiglio?
«Adottare un decreto di quel tipo, ammissibile solo in casi di necessità e urgenza, significa additare un’intera categoria di fronte all’opinione pubblica considerandola responsabile del cattivo funzionamento della Giustizia. Sono convinto che ciascuno possa dare di più, ma in questo caso i contenuti sono discutibili. E il modo offende».
Eppure aumentano i processi che cadono in prescrizione.
«Appunto. In un panorama segnato da migliaia di processi finiti in prescrizione sostenere che i problemi da affrontare sono le ferie dei magistrati e la responsabilità civile mi pare difficilmente tollerabile».
Durissimo affondo da Maurizio Carbone, segretario nazionale dell'Anm: "Respingiamo fortemente questa idea demagogica che il problema della giustizia siamo noi magistrati e non di chi intasca le tangenti". La proposta di riforma dell’Anm è quella sulla prescrizione. "Non ci possiamo più permettere una prescrizione, soprattutto per i reati di corruzione, che parta dal momento in cui si commette il fatto per tutti e tre i gradi di giudizio. Questo significa non avere una risposta di giustizia. Noi chiediamo - ha concluso Carbone - che i termini di prescrizione vengano sospesi con l’inizio del processo di primo grado o almeno dopo la sentenza di primo grado".
PER I MAGISTRATI IL CITTADINO DEVE ASPETTARE I LORO COMODI!!
Eppure, secondo lo studio fatto da Dimitri Buffa su “L’Opinione” i procedimenti prescritti sono dimezzati.
Prescrizioni penali rilevate in un decennio
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
219.146 |
189.588 |
159.703 |
164.115 |
154.671 |
158.335 |
141.851 |
128.891 |
113.057 |
123.078 |
Per Sabelli "il tema della responsabilità civile è sempre fondamentale ma - conclude - non può essere mortificato attraverso soluzioni che non tengono conto della giurisdizione e della compatibilità con il principio di indipendenza e autonomia dei magistrati".
«Basta con lo strapotere delle correnti della magistratura - dice il Premier Matteo Renzi -Oggi di nuovo le contestazioni di alcuni magistrati che sfruttano iniziative istituzionali (anno giudiziario) per polemizzare contro il governo e mi dispiace molto perché penso che la grande maggioranza dei giudici italiani siano persone per bene, che dedicano la vita a un grande ideale e lo fanno con passione. Ma trovo ridicolo - e lo dico, senza giri di parole - che se hai un mese e mezzo di ferie e ti viene chiesto di rinunciare a qualche giorno, la reazione sia: “Il premier ci vuol far CREPARE di lavoro”. Noi vogliamo solo sentenze rapide, giuste. Vogliamo che i colpevoli di tangenti paghino davvero e finalmente con il carcere ma servono le sentenze, non le indiscrezioni sui giornali. L’Italia che è la patria del diritto prima che la patria delle ferie, merita un sistema migliore di giustizia. La memoria dei magistrati che sono morti uccisi dal terrorismo o dalla mafia ci impone di essere seri e rigorosi. A chi mi dice: ma sei matto a dire questa cose? Non hai paura delle vendette? Rispondo dicendo che in Italia nessun cittadino onesto deve avere paura dei magistrati».
Dopo il botta e risposta tra l’Associazione nazionale magistrati e il premier Matteo Renzi, una sferzata ai giudici e al loro protagonismo è arrivata anche da Giorgio Napolitano. Il presidente della Repubblica, intervenuto al Consiglio superiore della magistratura, ha ribadito che politica e giustizia devono restare separati e che i giudici devo evitare comportamenti «impropriamente protagonistici».
«I Tribunali non sono proprietà dei giudici», scrive Errico Novi su “Il Garantista”. Vogliono rovinare la “festa”. Oggi sarebbe la giornata della giustizia, proclamata dall’Anm per protestare contro la riforma del ministro Orlando e in particolare contro il taglio delle ferie. I penalisti intervengono con una certa, brutale franchezza e mettono in discussione i dati che oggi i magistrati proporranno ai cittadini, per l’occasione liberi di entrare nei Palazzi di giustizia. Intanto, dice il presidente dell’Unione Camere penali Beniamino Migliucci, l’iniziativa del sindacato delle toghe è «la dimostrazione, come se ce ne fosse bisogno, di una concezione proprietaria della giustizia e dei luoghi in cui essa si celebra, da parte dei magistrati». I cittadini, dice, «non hanno bisogno di alcun invito per accedere al Tribunale, luogo sacro in cui si svolgono i processi in nome del popolo italiano». Dopodiché «i numeri forniti dall’Associazione magistrati rischiano di offrire una visione autoreferenziale e alterata della situazione in cui versa la giustizia italiana, nella quale si enfatizza la loro efficienza a tutto discapito di una realtà che ci vede fra i primi paesi in Europa per numero di condanne dalla Corte di Strasburgo». I numeri sono altri, secondo il presidente dei penalisti, «a cominciare dalla sostanziale inattuazione del sistema di controllo sulla responsabilità dei magistrati, dalle frequentissime sentenze di riforma dei giudizi di primo grado, per passare al cospicuo importo dei risarcimenti che lo Stato è costretto ogni anno a pagare per indennizzare le vittime degli errori giudiziari, all’inevitabile ricorso, da parte della magistratura togata, all’ausilio di magistrati onorari, il cui apporto è determinante per il raggiungimento di quegli obiettivi di produttività che la Anm enfatizza». Su una delle “contro-statistiche” proposte da Migliucci interviene anche il cahier de doleance del viceministro della Giustizia Enrico Costa, che dà notizia del boom di risarcimenti per ingiusta detenzione ed errori giudiziari pagati dallo Stato nel 2014. «L’incremento rispetto all’anno precedente è del 41,3%: 995 domande liquidate per un totale di 35 milioni e 255mila euro». Dal 1992, osserva Costa, «l’ammontare delle riparazioni raggiunge così i 580 milioni: sono numeri che devono far riflettere, si tratta di persone che si sono viste private della libertà personale ingiustamente e per le quali lo Stato ha riconosciuto l’errore. Dietro c’è una storia personale, ci sono trepidazioni, ansie, che un assegno, anche di migliaia di euro, non può cancellare». Le contromisure di Parlamento e governo sono note: da una parte la legge sulla custodia cautelare, che naviga ancora in acque incerte, dall’altra quella sulla responsabilità civile dei giudici, prossima all’approvazione della Camera. Sui problemi più generali del processo penale è ora all’esame della commissione Giustizia di Montecitorio l’atteso ddl del governo, che si accoda al testo base adottato proprio ieri dai deputati sulla prescrizione. «Sono soddisfatta, abbiamo avviato tutti e due i provvedimenti, coerenti tra loro», dice la presidente Donatella Ferranti. Su un altro capitolo della riforma, la soppressione di alcuni Tribunali, arriva dalla Consulta la bocciatura del referendum con cui alcune regioni avevano impugnato le chiusure. Tra queste, c’erano anche le sedi delle zone terremotate dell’Abruzzo.
Eppure c’è ancora un’altra verità che si tace nella liturgia laica giudiziaria.
Sono Procure o nidi di vipere? Si chiede Piero Sansonetti su “Il Garantista”. In un giorno solo tre casi che dovrebbero scuotere la credibilità della magistratura (ma in Italia è difficile scuoterla…). Il più clamoroso è l’atto di accusa dell’architetto Sarno, che è il testimone chiave del processo contro l’ex presidente della Provincia Filippo Penati (Pd). Sarno ha dichiarato: «Lo ho accusato, ingiustamente, perché la Procura mi ha fatto capire che se non lo accusavo non uscivo più di cella». Il secondo caso viene dalla Calabria: una Pm (la dottoressa Ronchi) accusata di abuso di ufficio e falso ideologico per avere provato a incastrare un collega (Alberto Cisterna, all’epoca numero due dell’antimafia nazionale). Il terzo caso è quello del sostituto Procuratore di Milano, Robledo, intercettato (abusivamente?) e affondato giornali se ne occupano poco di queste cose, cioè delle lotte di potere, violentissime, che scuotono la magistratura italiana e lasciano molte vittime sul terreno. Se ne occupano poco non perché le notizie non abbiano un buon interesse giornalistico, semplicemente perché il patto tra giornali e magistratura, che vige da molti anni, ha creato un sistema di assoluta omertà. Vediamo: un sindaco indagato per abuso di ufficio fa un bello scandalo, e sulla base delle leggi vigenti – se condannato in primo grado – porta pressoché automaticamente alla rimozione del sindaco stesso e a elezioni anticipate.
I capi della Cassazione sgridano (un po’) i Pm, scrive Errico Novi su “Il Garantista”. C’è un passaggio della solenne cerimonia che traccia un bilancio crudo, amaro. Giorgio Santacroce, primo presidente della Cassazione, parla a un certo punto di «parabola discendente». Si riferisce ai suoi colleghi magistrati. E se pure parte dalla «campagna irresponsabile di discredito» condotta «per anni» contro le toghe, e dà così la colpa anche alla politica, poi fa una diagnosi assai brutale: siamo davanti a «una situazione di crescente disaffezione verso la magistratura, dopo l’alto consenso dei tempi di Mani pulite è iniziata», appunto, «una parabola discendente».soprattutto, «i magistrati appaiono, anche quando non lo sono, conservatori dell’esistente e portatori di interessi corporativi». Di più: devono superare i loro «arroccamenti », e il richiamo pronunciato «davanti al Csm dal presidente Giorgio Napolitano» deve costituire per loro «un monito perché non ostacolino il rinnovamento, ma anzi si rinnovino essi stessi». Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario le toghe finiscono dunque sul banco degli imputati, quanto meno al pari della politica. Le parole di Santacroce sono nette, ancora di più quando parla delle «tensioni» e delle «cadute di stile» che si registrano soprattutto fra i pm. Non è da meno il pg di Cassazione Gianfranco Ciani, che una mezz’ora più tardi interviene a sua volta nell’aula magna del Palazzaccio romano e si scaglia contro quei pm «troppo deboli alle lusinghe della politica». Due relazioni (di cui riportiamo ampi stralci nelle due pagine successive, ndr) che lasciano almeno intravedere una svolta. I riferimenti dei due più alti magistrati della Suprema Corte alle mancanze dei colleghi, ai limiti e alle storture del Csm, al vizio del correntismo in toga, sono numerosissimi. Più che in altre occasioni l’inaugurazione dell’anno giudiziario vede la magistratura indicata tra le componenti responsabili della crisi della giustizia. Alla fine, mentre il primo presidente Santacroce e il pg Ciani sono piuttosto severi con i colleghi, deve provvedere il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, che è un politico e non un giudice, a una difesa d’ufficio delle toghe. Dice che «una magistratura compressa dalle inefficienze del sistema, suo malgrado non viene percepita come autorevole». Certo, dopo di lui, e su bito prima di Ciani, ci prova anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando a sussurrare qualche parola dolce. Oltre a definire i giudici «protagonisti del cambiamento» promette loro una mano un po’ più delicata sulla spinosa questione dei pensionamenti: «Il governo si riserva un’ulteriore riflessione sull’applicazione della nuova disciplina» che abbassa a 70 anni l’età pensionabile dei magistrati, spiega il Guardasigilli. Ma cambia poco. Continuerà a percepirsi assai più l’eco delle parole di Ciani a proposito della «magistratura requirente» che «nell’anno appena decorso», in taluni dei suoi appartenenti, ha dimostrato «un eccesso di debolezza nei confronti delle lusinghe dell’immagine, della popolarità, e soprattutto della politica ». E qui per giunta arriva un’altra stoccatina allo stesso Csm: sulla questione, dice ancora il procuratore generale della Cassazione, «è necessario un tempestivo intervento del legislatore per una più adeguata regolamentazione della materia: quella secondaria del Consiglio superiore si è rivelata insufficiente». Viceversa sia il pg che il primo presidente Santacroce promuovono seppur con riserva la riforma di Orlando. Plaudono soprattutto ad alcuni degli interventi sul civile, in particolare alla negoziazione assistita che dovrebbe aiutare ad alleggerire il carico dei tribunali. Un motivo di sollievo, per il ministro della Giustizia, in una fase in cui sul suo ruolo si allunga l’ombra di Nicola Gratteri, che pochi giorni fa ha annunciato la ”sua” riforma del processo penale. Ma l’altro tema forte nel Palazzo di giustizia capitolino è quello delle carceri, e della condizione dei detenuti in particolare. «C’è ancora molto da fare», avverte Santacroce, «le misure prese vanno senz’altro nella direzione giusta ma non sono risolutive. Anche se il numero dei detenuti tende a diminuire, l’emergenza sovraffollamento, suicidi e tensioni nelle strutture penitenziarie non è ancora rientrata e non può protrarsi ulteriormente». Bisogna assicurare, ricorda il primo presidente della Suprema Corte, «il rispetto della dignità della persona nella fase dell’esecuzione della pena: le carceri sono lo specchio della civiltà di un Paese, sono la carta di identità dello Stato costituzionale di diritto. Se è legittimo toglier a un uomo la libertà, non è legittimo togliergli la dignità». Persino qui non mancano critiche alla magistratura: «Il problema dell’eccesso di carcerazione chiama in causa anche i giudici, che non possono limitarsi a sollecitare sempre e comunque l’intervento della politica e del legislatore », avverte Santacroce, «è necessario che assumano anche su di loro la responsabilità di rendere effettivo il principio del minimo sacrificio possibile, che deve governare ogni intervento, specie giurisdizionale, in tema di libertà personale». Un passaggio che riscuote il plauso dell’associazione Antigone («Santacroce ha totalmente ragione, anche sull’illegittimità della pena per chi non se l’è ancora vista rideterminare dopo la bocciatura della Fini-Giovanardi da parte della Consulta») e dell’Unione Camere penali. «Siamo d’accordo sulla visione delle sanzioni penali e del carcere come extrema ratio» e sul «richiamo ad approvare il reato di tortura», dice il presidente Beniamino Migliucci. Una svolta c’è. Almeno sui limiti della magistratura e sul tema delle carceri. E un po’ di merito, su questo, a Napolitano andrà dato.
«Quella riforma mai». Lo stop dei magistrati, scrive “Il Garantista”. Si sentono stretti nella morsa. E reagiscono. Dopo le scudisciate della cerimonia in Cassazione, i magistrati delle Corti d’Appello di tutta Italia tentano di replicare ai massimi vertici della Suprema Corte. Venerdì il primo presidente Giorgio Santacroce e il procuratore generale Gianfranco Ciani avevano parlato di toghe arroccate nel corporativismo, di pm cedevoli alle lusinghe dei media, di sacche d’inefficienza che il Csm spesso non riconosce. Insomma l’avevano fatta nera. E così nel day after, cioè nella giornata di ieri dominata dalle cerimonie inaugurali nei singoli distretti giudiziari, si è sentito di tutto. Non su Santacroce e Ciani, ma contro l’altro polo del potere: la politica. Si va dalla riforma di Renzi giudicata «ben misera cosa» a Milano al presidente di Reggio Calabria Macrì secondo cui «l’assenza di iniziative legislative di vasta portata» farà affondare «la giustizia nella palude». E poi si contano gli anatemi contro la corruzione che soffoca Roma da parte del presidente capitolino Antonio Marini, il quadro apocalittico delle collusioni tra camorra e e malapolitica di Antonio Buonajuto a Napoli, e insomma una batteria di denunce che stavolta si spostano dai vizi di giudici e pm a quelli delle altre, corrotte istituzioni. Palermo, le scorte e i giudici scoperti. Prevedibile. Ma non privo di incidenti. C’è n’è uno spiacevole a Palermo, dove il procuratore generale facente funzioni Ivan Marino esclama «pausa caffè», s’incammina sul tappeto rosso, inciampa, batte la testa e riprende la cerimonia con un cerottone sul volto. Dopodiché, nella sua relazione, si concede un passaggio destinato ad alimentare polemiche. Alla sala gremita in cui spicca l’assenza dei pm della “Trattativa” (marcano visita tutti, dall’aggiunto Vittorio Teresi ai pm Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia) Marino dice: «Non si può sottacere che la indubitabile, contingente e pericolosissima esposizione a rischio in determinati processi di taluno dei magistrati della requirente», ovvero Di Matteo, «con conseguente adozione di dispositivi di protezione mai visti prima, finisca per isolare e scoprire sempre di più i magistrati della giudicante titolari degli stessi processi». Come a dire: per proteggerne uno, particolarmente in vista, lasciano alla mer-cè di ritorsioni e proiettili noialtri. Obiezioni che ricordano tanto quelle rivolte a Giovanni Falcone venticinque anni fa. E’ proprio d’altronde Marino a dirlo: «Si sta verificando la stessa identica situazione degli anni ’80, allorché la protezione era garantita per lo più, se non esclusivamente, ai magistrati facenti parte dei pool antimafia dell’ufficio Istruzione e della Procura della Repubblica, con indifferenza verso la situazione della giudicante». «Il problema non siamo noi» Si avverte un certo nervosismo, tra le toghe. Contro quelle palermitane arriva la stoccata del presidente della corte d’Appello di Milano Giovanni Canzio, secondo il quale «la dura prova dell’audizione al Quirinale » poteva essere risparmiata «al Capo dello stato, alla magistratura e alla Repubblica» (un ampio estratto della relazione di Canzio è pubblicato nella pagina a fianco, ndr). Ma a dare l’dea della sindrome da accerchiamento di giudici e pm sono soprattutto le polemiche montate dall’Associazione magistrati. Il sindacato delle toghe organizza conferenze stampa per criticare la riforma della Giustizia. A Milano con il segretario Rodolfo Sabelli e a Bari con il presidente Maurizio Carbone, che sbotta: «Respingiamo fortemente questa idea demagogica secondo cui il problema della giustizia siamo noi magistrati e non chi intasca le tangenti». E ancora: «Vediamo riforme banalizzate con slogan, che ci mettono al centro del problema attribuendoci colpe che non sono nostre per nascondere l’inadeguatezza di queste riforme». A Milano si registrano anche le critiche durissime dell’avvocato generale Laura Bertolè Viale, indirizzate a Renzi e anche al nemico storico, Silvio Berlusconi: intanto liquida le riforme come un «pacchetto» che è «ben misera cosa rispetto a i progetti elaborati prima: non poche norme peccano di distonia, cioè sono irragionevoli ». Prima fra tutte la cosiddetta salva-Berlusconi che non rispetterebbe «quei criteri di progressività in materia tributaria sanciti dalla stessa Costituzione. Inoltre da questo pacchetto è stato escluso il reato di falso in bilancio». In realtà è stato da poco riproposto al Senato nel ddl Grasso. In sala, il viceministro Costa appare perplesso. Sempre nel Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo si assiste alla sfilata del procuratore capo Bruti Liberati con tutti i suoi aggiunti, escluso Robledo che non si fa vedere. Nel coro di rivendicazioni e critiche ce n’è qualcuna non scontata come quella del pg di Torino Marcello Maddalena, che boccia l’idea di una «nuova Procura nazionale antiterrorismo». Il presidente della Corte d’Appello di Roma Marini accenna a una generica commistione tra malavita e ultras, con il ripescaggio del caso di Genny ’a carogna. Lo dice in un’aula disertata dalla Camera penale: «L’inaugurazione dell’anno giudiziario, ancor più nelle sedi locali, è un rito anacronistico, asimmetrico e vuoto», dice il presidente Francesco Tagliaferri. Vuoto o meno che sia, di sicuro c’è molto nervosismo.
Giustizia, scontro aperto tra Renzi e i magistrati, scrive “La Stampa”. Il pg di Torino Maddalena: vuole farci crepare di fatica. Il premier: «Polemiche ridicole, quelle toghe hanno perso il contatto con gli italiani che lavorano». Scontro rovente tra i magistrati e Matteo Renzi nella settimana già calda del Quirinale. Dimenticati i fasti della Merkel, il premier è stato improvvisamente riportato alle vicende di casa nostra dai molteplici attacchi piovuti dai magistrati durante l’inaugurazione 2015 dell’anno giudiziario. Da Torino è partita la bordata più pesante. Il procuratore generale Marcello Maddalena usa l’arma del sarcasmo per affrontare uno dei temi più controversi del piano del governo: «Il presidente del Consiglio non ha trovato niente di meglio che ispirarsi al personaggio di Napoleone della Fattoria degli animali di orwelliana memoria, che aveva scoperto il grande rimedio per tutti i problemi della vita: far lavorare gli altri fino a farli crepare dalla fatica, come il cavallo Gondrano». Parole feroci. Renzi, dopo averle lette, in serata si è rivolto amareggiato ai suoi più stretti collaboratori: «Accusarci di voler far “crepare” i magistrati per una settimana di ferie in meno significa che hanno un disegno o più semplicemente che hanno perso il contatto con gli italiani che lavorano». E oggi su Facebook rincara la dose: «Sono contestazioni ridicole. Non vogliamo far “crepare di lavoro” nessuno, ma vogliamo un sistema della giustizia più veloce e più semplice. E, polemiche o non polemiche, passo dopo passo, ci arriveremo». «Bisogna valorizzare i giudici bravi, dicendo basta allo strapotere delle correnti che oggi sono più forti in magistratura che non nei partiti», rilancia Renzi. Stop quindi ai magistrati «che sfruttano iniziative istituzionali (anno giudiziario) per polemizzare contro il Governo». «E mi dispiace molto - aggiunge il premier - perché penso che la grande maggioranza dei giudici italiani siano persone per bene, che dedicano la vita a un grande ideale e lo fanno con passione. Ma trovo ridicolo che se hai un mese e mezzo di ferie e ti viene chiesto di rinunciare a qualche giorno, la reazione sia: “Il premier ci vuol far crepare di lavoro”». Facile prevedere strascichi. Anche perché le critiche piovute dai magistrati durante le cerimonie che si sono svolte in tutta Italia investono svariati aspetti della riforma del governo. A Milano, Laura Bertolè Viale, avvocato generale dello Stato, si scaglia contro il decreto fiscale e la clausola di non punibilità: «Chiamata giornalisticamente anche “licenza a delinquere”, introduce una clausola espressa in termini solo percentuali che crea una sostanziale differenza di trattamento tra i contribuenti di minori e maggiori dimensioni». A Bari, Maurizio Carbone, segretario nazionale dell’Anm, è molto critico per la storia delle ferie tagliate: «Respingiamo questa idea demagogica che il problema della giustizia siamo noi magistrati e non di chi intasca le tangenti». A Bologna, il presidente della Corte di Appello, Giuliano Lucentini, parla del pericolo che l’Italia corre se i suoi giudici sono delegittimati: «Pensavo, finito un certo periodo, che le cose potessero cambiare». Il riferimento è ovviamente a Berlusconi. E proprio il sostanziale parallelismo sulla questione giustizia rischia di rinvigorirei critici del premier.
“Quello di Renzi è un attacco alla categoria, piuttosto agisca per limitare le prescrizioni”. Intervista di Andrea Rossi su “La Stampa” al procuratore generale di Torino dopo le polemiche all’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Dottor Maddalena, perché questo affondo rivolto al presidente del Consiglio?
«Adottare un decreto di quel tipo, ammissibile solo in casi di necessità e urgenza, significa additare un’intera categoria di fronte all’opinione pubblica considerandola responsabile del cattivo funzionamento della Giustizia. Sono convinto che ciascuno possa dare di più, ma in questo caso i contenuti sono discutibili. E il modo offende».
Al di là dei modi, esiste un problema di produttività?
«Le faccio un esempio. La Corte d’Appello di Torino nel 2014 ha esaurito 5735 provvedimenti contro i 4490 del 2013».
Eppure aumentano i processi che cadono in prescrizione.
«Appunto. In un panorama segnato da migliaia di processi finiti in prescrizione sostenere che i problemi da affrontare sono le ferie dei magistrati e la responsabilità civile mi pare difficilmente tollerabile».
È questa - la prescrizione - la vera emergenza dunque?
«L’amministrazione della giustizia non può permettersi di lavorare a vuoto, a maggior ragione quando la prescrizione interviene durante l’appello: significa che nelle fasi precedenti giudici, pubblici ministeri, gip, gup e tutto il personale amministrativo hanno lavorato per niente, svolgendo inconsapevolmente il ruolo di Penelope, con la differenza che Penelope lo faceva apposta».
Esistono soluzioni in grado di arginare il problema?
«I rimedi non mancano: assegnare ai procedimenti criteri di priorità, archiviare i casi minimali e soprattutto, ovviamente, modificare la prescrizione».
Come?
«Suggerisco due ipotesi. Far decorrere la prescrizione dal momento dell’iscrizione nel registro degli indagati, perché è in quel frangente che scatta l’interesse della persona (e dello Stato) a risolvere al più presto la sua posizione. In secondo luogo, interrompere la prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado. In questo modo, tra l’altro, si scoraggerebbero molti imputati dal fare ricorso con la sola speranza di dilatare i tempi per arrivare alla prescrizione».
Il rito stantìo dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, scrive Dimitri Buffa su “L’Opinione”.
Prescrizioni penali rilevate in un decennio.
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
219.146 |
189.588 |
159.703 |
164.115 |
154.671 |
158.335 |
141.851 |
128.891 |
113.057 |
123.078 |
La magistratura dopo Mani pulite ha iniziato “una parabola discendente”, con la “disaffezione” dei cittadini per le “credenziali mortificanti” che esibisce, come i processi lumaca e il degrado delle carceri, ma a questa crisi di fiducia concorrono anche le “frequenti tensioni e polemiche” soprattutto tra pubblici ministeri con “forme di protagonismo, cadute di stile e improprie esposizioni mediatiche”. Giorgio Santacroce, primo presidente della Corte di Cassazione, e umana dimostrazione di come con la Legge Breganze - che fa avanzare automaticamente le carriere dei magistrati - anche un pm che negli anni Settanta non era noto alle cronache per l’iperattivismo giudiziario (fu requirente nello scandalo Italcasse che grosso modo finì tutto a tarallucci e vino, tranne modeste condanne a Giuseppe Arcaini e soci nel 1989) possa arrivare ai vertici della magistratura, ce l’ha messa tutta per colorire la propria relazione di inizio anno giudiziario tenutasi a Roma nella mattinata di ieri nella consueta aula magna del “Palazzaccio”. Ma certo non ha sottolineato quei dati, come quelli sulle prescrizioni forniti un mese fa dal vice ministro Enrico Costa senza dire niente a nessuno nel governo, che dimostrano come la lentezza dei processi penali e il fatto che un milione e mezzo di loro finiscano in vacca ogni dieci anni è al 74 per cento imputabile al non lavoro dei pm e dei gip, non certo alla “melina” degli avvocati. Così come Santacroce non ha di certo rievocato i dati scoperti dal sito errorigiudiziari.com di Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi che parlano mai smentiti di un dossier nascosto sugli errori giudiziari in Italia dal 1989 al 2013: 50mila in 25 anni, pari a duemila l’anno. Una percentuale da Terzo Mondo. Sempre ascrivibile agli errori di pm e gip che aprono inchieste su qualsiasi cosa si muova sulla terra ma spesso con risultati disastrosi. Certo, è difficile chiedere all’“oste” di smentire la qualità del vino. E i magistrati ormai sono definiti persino nei saggi dei giornalisti de “L’Espresso” come Stefano Livadiotti come l’“ultra casta”. Ma oramai che il re in toga sia nudo è sotto gli occhi di tutti. I dati di Costa ad esempio sono disarmanti: “Su poco più di un milione e mezzo di casi in dieci anni... i numeri indicano che nell’ultimo decennio i decreti di archiviazione per prescrizione emessi dai gip sono stati 1.134.259: il 73 per cento del totale. A questi si aggiungono le 63.892 sentenze di avvenuta prescrizione emesse dai Gup. La quota restante è spalmata tra Tribunali (209.576), Corti d’appello (131.856), Cassazione (3.293) e Giudici di pace (9.559)”. Se questi dati nelle inaugurazioni degli anni giudiziari vengono tenuti quasi nascosti, o con poco rilievo, ogni dibattito sulla giustizia parte male in termini di onestà intellettuale. Questo grazie anche ai giornalisti che militano nel partito della forca: il convegno in cui Costa distribuì anche la tabella dei dati ministeriali in questione, sebbene trasmesso da Radio radicale, è stato bellamente ignorato dai quotidiani cartacei e anche on-line ha avuto un rilievo pari a zero. Proprio Costa in quell’occasione disse che “oltre il 70% delle prescrizioni si determina in fase di indagini preliminari. Un’anomalia che non può essere ricondotta ad azioni dilatorie della difesa, ma spesso è legata a un dribbling non dichiarato dell’obbligatorietà dell’azione penale che si traduce in una selezione dei casi da prendere in carico”. Parole che ieri non si sono sentite da parte di Santacroce, che ormai aspetta solo di andare in pensione con il massimo dell’anzianità prevista (ex Legge Breganze di cui sopra). Chi oggi vorrebbe abolire l’appello o allungare a dismisura i termini della prescrizione con quale buona fede chiede queste misure e ignora i dati di via Arenula? Va detto che già nel 2007 una ricerca dell’Eurispes commissionata sempre dalle Camere penali allora presiedute da Giuseppe Frigo (la ricerca fu condotta sotto la supervisione di Valerio Spigarelli che poi sarebbe succeduto a Frigo in quella carica) aveva avuto analoghi risultati. Stesso discorso sugli errori giudiziari strettamente legati alla vexata quaestio della mancata responsabilizzazione civile per colpa grave dei magistrati. Sapere che ci sono 2mila errori giudiziari l’anno, che diviso per 365 giorni è come dire che ogni 24 ore sei persone finiscono in carcere innocenti, lascia del tutto indifferenti Anm e quotidiani nazionali che vendono al volgo che i veri problemi dell’Italia sono “la corruzione e l’evasione fiscale”. E che invocano sceriffi e leggi speciali per qualunque cosa e con qualsivoglia pretesto. Con questo dialogo tra sordi che ormai continua da almeno vent’anni quel che è chiaro è che il Paese che ritiene di essere la culla del diritto oggi come oggi rischia di diventarne la bara. E all’estero questo problema viene visto in un’ottica meno moralista e più pragmatica. Cosa che spiega gli investimenti con il contagocce delle imprese straniere in Italia. Più che paura della corruzione c’è il terrore di finire in qualche tritacarne mediatico giudiziario con un pm di provincia in cerca di notorietà per fare carriera. Allora sì che son dolori...
Nuovo anno giudiziario. L'Anm la butta in rissa contro i politici corrotti. IL segretario Anm: "Respingiamo tesi che il problema della giustizia siamo noi magistrati e non di chi intasca le tangenti". Il ministro Orlando: "La giustizia inefficiente rallenta la crescita", scrive Raffaello Binelli su “Il Giornale”. Come ogni anno l'inaugurazione dell'anno giudiziario fornisce uno spaccato sullo stato di salute della giustizia in Italia. "La crisi sociale e l’indebolimento della struttura statale - afferma il ministro della Giustizia Andrea Orlando - rende quest’ultima sempre più fragile di fronte agli interessi particolari che la condizionano e ai poteri illegali che la insidiano. In un Paese come il nostro - ha proseguito Orlando - caratterizzato dalla storica presenza di potenti organizzazioni criminali, la prostrazione dei corpi intermedi e delle istituzioni apre spazi crescenti ai fenomeni criminali in ambito economico, sociale e politico". Orlando ha poi sottolineato che "questi poteri in termini assoluti, non sono più forti di prima, ma piuttosto è più debole l’organismo che attaccano. La criminalità organizzata - ha detto - non ha più le forme tradizionali e la tradizionale collocazione geografica circoscritta ad alcune regioni del sud Italia. Si è espansa, ha cambiato forme e metodi mimetizzandosi nei contesti in cui si sviluppa. Si confonde e si sovrappone alle reti collusive che avvolgono le pubbliche amministrazioni". Durissimo affondo da Maurizio Carbone, segretario nazionale dell'Anm: "Respingiamo fortemente questa idea demagogica che il problema della giustizia siamo noi magistrati e non di chi intasca le tangenti", ha detto a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Bari. In una conferenza stampa convocata nell’ambito della mobilitazione permanente contro la riforma della giustizia che prevede la responsabilità civile dei magistrati, Carbone ha parlato di «riforme banalizzate con slogan che ancora una volta hanno messo al centro del problema noi magistrati, attribuendoci colpe che non sono nostre per nascondere l’inadeguatezza di queste riforme». I magistrati esprimono "assoluta insoddisfazione". "Le risposte noi con le sentenze e con le indagini le stiamo dando - ha continuato Carbone - siamo primi in Europa per produttività nel settore nella giustizia penale e secondi per smaltimento di cause civili, ma abbiamo il dovere di dire che alcune riforme non sono all’altezza della situazione". La proposta di riforma dell’Anm è quella sulla prescrizione. "Non ci possiamo più permettere una prescrizione, soprattutto per i reati di corruzione, che parta dal momento in cui si commette il fatto per tutti e tre i gradi di giudizio. Questo significa non avere una risposta di giustizia. Noi chiediamo - ha concluso Carbone - che i termini di prescrizione vengano sospesi con l’inizio del processo di primo grado o almeno dopo la sentenza di primo grado". E da Milano il presidente dell’Anm, Rodolfo Sabelli, rincara la dose: "Siamo i primi a volere le riforme ma ci vuole coerenza, agli annunci devono corrispondere i fatti". Sabelli non esita a sottolineare come "il dibattito sulla giustizia è ancora troppo pieno di pregiudizi". I magistrati "non si chiudono in una forma corporativa e non rifuggono dal principio di responsabilità ma l’approccio del governo non è stato sufficientemente meditato". Se il testo sulla responsabilità civile "è stato purificato da aspetti che avrebbero leso il principio di indipendenza della magistratura", restano ancora degli aspetti di "un approccio non attento", in particolare contro "l’eliminazione del filtro di ammissibilità e l’introduzione della categoria del travisamento del fatto e delle prove". Per Sabelli "il tema della responsabilità civile è sempre fondamentale ma - conclude - non può essere mortificato attraverso soluzioni che non tengono conto della giurisdizione e della compatibilità con il principio di indipendenza e autonomia dei magistrati". ll procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino, Marcello Maddalena, si sofferma sulle misure anti-terrorismo di cui si parla da giorni, dopo gli attentati di Parigi. "Più lo Stato possiede dati certi meglio è. Parlo anche di quelli relativi al Dna e alle impronte digitali". E prosegue: "Se questi dati li posseggo correttamente, non capisco perché non li possa utilizzare. Invocare la privacy mi pare del tutto fuori luogo in generale, invocarla poi in questo momento mi sembra privo di ogni ragionevolezza e di ogni senso dello Stato". Il presidente della Corte d’Appello di Milano, Giovanni Canzio, dedica un ampio capitolo del suo intervento alla penetrazione della ’ndrangheta in Lombardia, sottolineando come vi sia, da parte della mafia una "interazione-occupazione". "La forma di penetrazione e la veloce diffusione del potere della ’ndrangheta all’interno dei diversi gangli della società lombarda - ha detto Canzio - può paragonarsi all’opera distruttiva delle metastasi di un cancro". Quanto all'Expo Canzio osserva che lo Stato è vigile. "Nel distretto milanese e in vista di Expo 2015, lo Stato è presente e contrasta con tutte le istituzioni l’urto sopraffattorio della criminalità mafiosa, garantendo - nonostante la denunciata carenza di risorse nel settore giudiziario - la legalità dell’agire e del vivere civile con coerenza e rigore". Ma l’esercizio della giurisdizione, prosegue Canzio, "non può essere frutto di accelerazioni o improvvisazioni, dettate, di volta in volta, da frammentarie emergenze, senza una chiara visione dei diritti e degli interessi in gioco". Poi denuncia il rischio che "dal pensiero corto alla sentenza tweet o al verdetto immotivato il passo è breve. Ma - si chiede- che ne resterebbe della cultura democratica della giurisdizione?". A margine dell'inaugurazione Canzio commenta la notizia dello smarrimento e danneggiamento dei faldoni degli atti di alcuni processi che la Corte d’Appello ha spedito via posta nell’ultimo mese alla Cassazione (atti che, secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, non sono mai arrivati a Roma): "Si tratta di un fatto indegno di uno Stato moderno, che non deve succedere". Il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, sottolinea che "mentre sul fronte della normativa antimafia si prevedono provvidenze e sostegni economici per gli imprenditori che denunciano gli estorsori mafiosi rompendo il vincolo di omertà, all’opposto sul fronte della corruzione si minacciano sanzioni penali a chi denuncia gli estorsori in guanti gialli, rafforzando così il vincolo di omertà. Neanche l’incessante susseguirsi di scandali nazionali attestante il dilagare irrefrenabile della corruzione - dice - sembra a tutt’oggi sufficiente per una riforma legislativa di svolta che incida sui nodi cruciali per restituire efficacia dissuasiva all’azione repressiva". Nella sua relazione il procuratore generale della Corte d’appello di Roma, Antonio Marini, evidenzia che "i procedimenti di prostituzione minorile sono stati ben 190 a fronte dei 35 iscritti nel precedente anno giudiziario, quindi si deve prendere atto di un incremento nelle nuove notizie di reato del 442%". Violenze sessuali, maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori (stalking). Nel distretto di Roma e Lazio, nel periodo che va dal primo luglio 2013 al 30 giugno 2014, si è registrato un vero e proprio "boom" di reati contro la libertà sessuale. Per Marini da tempo diversi gruppi criminali hanno scelto Roma e il Lazio per poter mettere in piedi i loro affari, sfruttando così la vastità del territorio, la presenza di tantissimi esercizi commerciali, attività imprenditoriali, società finanziarie e di intermediazione e immobili. Ed evitano di farsi la guerra per non dare nell’occhio. Nella relazione del procuratore generale c’è un lungo capitolo dedicato ai "gruppi criminali, compresi quelli dediti al narcotraffico», nel mirino dei magistrati della Dda. "Dalle indagini - ha evidenziato Marini - emerge che c’è un patto esplicito per evitare che questi contrasti, che pure ci sono, degenerino in atti criminali eclatanti che rischierebbero di attirare l’attenzione degli inquirenti e dei media. Meglio trovare un compromesso e continuare a fare affari".
Renzi replica ai magistrati: "Italia patria del diritto, non delle ferie". Su Facebook parole dure del premier dopo le inaugurazioni (e le polemiche) dell'anno giudiziario. Risposta a Maddalena: sulle vacanze critiche ridicole, scrive “La Repubblica”. L'Italia "che è la patria del diritto prima che la patria delle ferie, merita un sistema migliore. La memoria dei magistrati che sono morti uccisi dal terrorismo o dalla mafia ci impone di essere seri e rigorosi. Non vogliamo far 'crepare di lavoro' nessuno, ma vogliamo un sistema della giustizia più veloce e più semplice. E, polemiche o non polemiche, passo dopo passo, ci arriveremo". E' dura la replica di Matteo Renzi alle polemiche sollevate ieri durante le inaugurazioni dell'anno giudiziario. In particolare in risposta alle parole del procuratore generale di Torino Maddalena. Sono "ridicole" le "contestazioni" di alcuni magistrati contro il taglio delle ferie, dice Renzi su Facebook. Che poi lancia un altro affondo: "Bisogna anche valorizzare i giudici bravi, dicendo basta allo strapotere delle correnti che oggi sono più forti in magistratura che non nei partiti". "Oggi di nuovo le contestazioni di alcuni magistrati che sfruttano iniziative istituzionali (anno giudiziario) per polemizzare contro il Governo. E mi dispiace molto perchè penso che la grande maggioranza dei giudici italiani siano persone per bene, che dedicano la vita a un grande ideale e lo fanno con passione. Ma trovo ridicolo, e lo dico, senza giri di parole, che se hai un mese e mezzo di ferie e ti viene chiesto di rinunciare a qualche giorno, la reazione sia il premier ci vuol far crepare di lavoro". "Noi - chiarisce Renzi - vogliamo solo sentenze rapide, giuste. Un Paese civile deve avere una sistema veloce, giusto, imparziale. Per arrivare rapidamente a sentenza, bisogna semplificare, accelerare, eliminare inutili passaggi burocratici, andare come stiamo facendo noi sul processo telematico, così nessuno perde più i faldoni del procedimento come accaduto anche la settimana scorsa". "Bisogna anche valorizzare i giudici bravi, dicendo basta - torna a dire - allo strapotere delle correnti che oggi - accusa - sono più forti in magistratura che non nei partiti". "A chi mi dice 'ma sei matto a dire questa cose? non hai paura delle vendette?' rispondo dicendo che in Italia nessun cittadino onesto deve avere paura dei magistrati. E i nostri giudici devono sapere che il Governo, nel rispetto dell'indipendenza della magistratura, è pronto a dare una mano. Noi ci siamo. L'Italia che è la patria del diritto prima che - rimarca - la patria delle ferie, merita un sistema migliore. La memoria dei magistrati che sono morti uccisi dal terrorismo o dalla mafia ci impone di essere seri e rigorosi. Non vogliamo far crepare di lavoro nessuno, ma - puntualizza Renzi - vogliamo un sistema della giustizia più veloce e più semplice. E, polemiche o non polemiche, passo dopo passo, ci arriveremo".
Renzi: «Basta con lo strapotere delle correnti della magistratura». Il premier replica alle toghe: «Oggi di nuovo le contestazioni di alcuni magistrati che sfruttano iniziative istituzionali (anno giudiziario) per polemizzare contro il governo», “il Corriere della Sera”. «Basta con lo strapotere delle correnti della magistratura». Non usa mezzi termini il premier Matteo Renzi e attacca duramente i magistrati che a loro volta, come nel caso di Torino, avevano contestato alcuni presunti provvedimenti del governo nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. «Bisogna valorizzare i giudici bravi, dicendo basta allo strapotere delle correnti che oggi sono più forti in magistratura che non nei partiti» spiega Renzi su Facebook. «Oggi di nuovo le contestazioni di alcuni magistrati che sfruttano iniziative istituzionali (anno giudiziario) per polemizzare contro il governo» scrive ancora Renzi sul celebre social network. «E mi dispiace molto perché penso che la grande maggioranza dei giudici italiani siano persone per bene, che dedicano la vita a un grande ideale e lo fanno con passione. Ma trovo ridicolo - e lo dico, senza giri di parole - che se hai un mese e mezzo di ferie e ti viene chiesto di rinunciare a qualche giorno, la reazione sia: “Il premier ci vuol far CREPARE di lavoro”». «Noi vogliamo solo sentenze rapide, giuste. Vogliamo che i colpevoli di tangenti paghino davvero e finalmente con il carcere ma servono le sentenze, non le indiscrezioni sui giornali», sottolinea Renzi. «L’Italia che è la patria del diritto prima che la patria delle ferie, merita un sistema migliore di giustizia. La memoria dei magistrati che sono morti uccisi dal terrorismo o dalla mafia ci impone di essere seri e rigorosi», sottolinea ancora il premier. «A chi mi dice: ma sei matto a dire questa cose? Non hai paura delle vendette? Rispondo dicendo che in Italia nessun cittadino onesto deve avere paura dei magistrati. E i nostri giudici - aggiunge ancora su Facebook - devono sapere che il Governo (nel rispetto dell’indipendenza della magistratura) è pronto a dare una mano. Noi ci siamo». La replica dell’Associazione nazionale magistrati alle parole di Renzi non si faceva attendere. «Il problema non sono i magistrati, ma le promesse mancate, la timidezza in materia di prescrizione e corruzione, la proposta, alla vigilia di Natale, di depenalizzare l’evasione fiscale fino al 3%» scrive l’Anm in un post pubblicato su Facebook. Per l’associazione: «Le critiche che vengono dai magistrati sono dettate dalla delusione: noi riponevamo e vorremmo riporre fiducia nella volontà di fare le buone riforme, ma chiediamo coerenza tra parole e fatti. Renzi vuole un sistema più veloce e più semplice? Blocchi la prescrizione almeno dopo la sentenza di primo grado, introduca sconti di pena ai corrotti che collaborano con la giustizia, estenda alla corruzione gli strumenti della lotta alla mafia: i casi di corruzione clamorosi più recenti e più noti non sono indiscrezioni». L’Anm rileva: «Il Governo trovi le risorse per coprire le oltre 8.000 scoperture nell’organico del personale amministrativo. Accanto alla messa alla prova, alla non punibilità per tenuità del fatto, al processo civile telematico, sono troppe le riforme timide o assenti. Quanto alle correnti, riaffermiamo il valore delle diverse sensibilità che costituiscono una risorsa dell’associazionismo, da sempre respingiamo ogni degenerazione ispirata a logiche di potere. Non si può non trovare di cattivo gusto - conclude il post - il richiamo ai magistrati uccisi. Noi stessi siamo molto cauti nel richiamarci al ricordo dei colleghi caduti per il loro servizio: lo facciamo solo per onorare la loro memoria e il loro sacrificio, non per accreditare la nostra serietà». In serata sul tema è intervenuto anche il ministro della Giustizia, Andrea Orlando: «Le critiche delle ultime ore al progetto organico di riforma sono ingenerose. Dispiace che l'Anm non colga il passaggio solenne dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per recuperare obiettività».
Napolitano contro i giudici: «Basta protagonismi», scrive Virginia Spada su “Il Garantista”. Dopo il botta e risposta tra l’Associazione nazionale magistrati e il premier Matteo Renzi, una sferzata ai giudici e al loro protagonismo è arrivata anche da Giorgio Napolitano. Il presidente della Repubblica, che ieri è intervenuto al Consiglio superiore della magistratura, ha ribadito che politica e giustizia devono restare separati e che i giudici devo evitare comportamenti «impropriamente protagonistici». «Lo Stato di tensione – ha detto – e le contrapposizioni polemiche che per anni hanno caratterizzato i rapporti tra politica e magistratura, determinando un paralizzante conflitto tra maggioranza e opposizione in Parlamento sui temi della giustizia e sulla sua riforma, non hanno giovato né alla qualità della politica, né all’immagine della magistratura». Il capo dello Stato, che per tutto il mandato non ha mai smesso di criticare le esternazioni dei magistrati, ieri si è sentito in dovere di rincarare la dose e le critiche, dopo le proteste dell’Anm contro la legge sulla corruzione (considerata troppo debole) e soprattutto contro la riforma della giustizia. Se a via Arenula, si chiede ai magistrati di occuparsi delle sentenze e non delle scelte del governo, il Quirinale non è da meno: «Ho ripetutamente richiamato l’esigenza che tutti facessero prevalere il senso della misura e della comune responsabilità istituzionale. La credibilità delle istituzioni e la salvezza dei principi democratici si fondano sulla divisione dei poteri e sul pieno e reciproco rispetto delle funzioni di ciascuno». Al capo dello Stato, con le valigie ormai pronte per lasciare il posto al suo successore, premono le riforme. Tra cui quella della giustizia. Non si tratta di una questione per lui secondaria. Più e più volte ha rilanciato la questione dell’indulto e dell’amnistia, ma dal Parlamento le sue parole non sono state accolte. Ora si aspetta che la macchina-giustizia migliori. «È indubbio – ha continuato davanti al Csm – che ciò cui occorre mirare è un recupero di funzionalità, efficienza e trasparenza del sistema della giustizia». Ma per Napolitano questo non può avvenire se i magistrati continuano a sovrapporsi alle scelte che spettano al Parlamento e al governo. L’Associazione nazionale magistrati ha annunciato una mobilitazione in vista dell’inaugurazione anno giudiziario. Ma il messaggio del Quirinale è chiaro e irrevocabile: sono da evitare «i comportamenti impropri e altamente protagonistici e iniziative di dubbia sostenibilità assunte nel corso degli anni da alcuni magistrati della pubblica accusa».
Liturgia inutile, i magistrati si autoassolvono, scrive Vincenzo Vitale su “Il Garantista”. E così, è andata anche quest’anno. L’Italia, pur sede del Vaticano – specialista in coreografie religiose dalle quali emerge comunque la presenza dello Spirito – si segnala per una particolare tenacia nella ripetizione ad oltranza di liturgie laiche (che è, si badi, una inutile ripetizione, poiché liturgia altro non significa se non “opera del popolo”) tanto ostinate quanto inutili. Infatti, mentre la liturgia religiosa si offre quale mediazione necessaria con il divino, quella laica, consumata anche ieri per l’ennesima inaugurazione dell’anno giudiziario, si presenta del tutto priva di senso e perciò completamente autoreferenziale. Prova ne sia un esame anche superficiale delle argomentazioni svolte sia da Giovanni Legnini, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, sia da Giorgio Santacroce, presidente della Corte di Cassazione. Il primo, probabilmente per esigenze legate al ruolo ricoperto, ha svolto argomenti del tutto allineati con le prospettive tipiche delle correnti della magistratura, mettendo in primo piano l’esigenza di tutelare ed accrescere il prestigio della stessa magistratura, oltre che dei singoli magistrati, messa così, la cosa ha dell’incredibile. Ma davvero, per Legnini e per i suoi colleghi del Csm, oltre che naturalmente per i magistrati italiani – o meglio per le loro correnti (in quanto, grazie a Dio, c’è una bella differenza fra le persone concrete che esercitano la giurisdizione e le correnti in cui si organizzano) – ciò che occorre garantire in sommo grado sarebbe il prestigio dei magistrati e della magistratura nel suo complesso? Si trattasse solo di questo, sarebbe facilissimo ottenere lo scopo desiderato: basterebbe – che so? – nominare tutti i magistrati italiani cavalieri della Repubblica o, in alternativa, accademici della Crusca ad honorem. In questo modo, il prestigio sarebbe assicurato una volta per tutte e saremmo tutti contenti. Evidentemente, non passa per la testa di Legnini e dei suoi colleghi che il vero prestigio, anzi l’unico prestigio, lo si conquista sul campo; ed è quello di cui un magistrato giunge a godere dopo aver dato ad avvocati, colleghi e cittadini, ripetuta prova, negli anni, di possedere, equilibrio, buon senso e senso del diritto, coefficienti indispensabili per rendere giustizia. A ben guardare – e bisogna annotarlo con crescente preoccupazione – è proprio questa, la giustizia, ad essere tragicamente assente dalla discussione pubblica di queste liturgie laiche : nessuno se ne interessa, nemmeno per accennarvi, e credo il termine medesimo neppure compaia. La giustizia insomma scompare anche come concetto da pensare, sostituita da altri concetti oggi assai di moda, quali efficienza, tempestività, utilità: semplici sciocchezze, incidenti del pensiero, ma oggi tenuti in gran conto, perché non si capisce che se si fosse in grado di rendere giustizia, lo si farebbe celermente e che invece i deprecabili ritardi son dovuti alla reale incapacità di renderla come si dovrebbe. Accertato dunque ciò che Legnini ed i suoi colleghi non sanno, cioè che il prestigio dei magistrati è solo un traguardo (faticoso ed impegnativo) e non mai un punto di partenza, è il caso di prestare attenzione agli argomenti svolti da Santacroce. Il presidente della Cassazione ha mostrato certo maggior senso della realtà allorché ha invitato i pubblici ministeri a non litigare fra loro (con l’occhio rivolto alle recenti vicende che hanno contrapposto Robledo a Bruti Liberati) e ad evitare sovraesposizioni mediatiche, ma è incappato pure lui in uno scandalo (nel senso evangelico di “inciampo”) del discorso, allorché ha esordito notando che dopo mani pulite la magistratura avrebbe dato inizio ad “una parabola discendente”. Saremmo davvero curiosi di sapere di cosa si tratti e se per caso la parabola attuale – che si dice appunto discendente – possa mai sperare di tornare ad “ascendere”. Forse si vuole alludere al consenso che i magistrati di mani pulite – con Di Pietro in testa – incontravano in quel periodo fra la gente. Meglio si farebbe allora ad affermare che i magistrati non debbono godere di alcun consenso perché non sono politici di professione e che fu invece proprio in forza di quel consenso anche mediatico (ma del tutto sprovvisto di elementari principi di diritto) che una modifica della custodia cautelare, che la vedeva limitata ai soli casi di delitti “di sangue,” naufragò in poche ore: fu sufficiente che Di Pietro arringasse le folle dagli schermi riuniti di Rai e Mediaset per ottenere lo scopo desiderato, tanto che il governo di allora barcollò, per cadere dopo poche settimane. Come volevasi dimostrare: fra due forze politiche, una per natura – il governo – ed una contro- natura – la magistratura – a prevalere fu questa. Non basta. Santacroce si è anche addentrato nel merito di varie proposte di legge in tema di appello, ricorso per cassazione, ed altri simili intenti riformatori: è appena il caso di ricordare che chi è chiamato ad applicare la legge, cioè il giudice, farebbe bene ad evitare di concorrere direttamente o indirettamente alla sua formazione. O no? Se qualcosa è cambiato, che qualcuno me lo dica. La triste verità è che l’unica domanda che varrebbe davvero la pena di porsi – in modo martellante ed ostinatissimo, perché è la domanda dell’intera vita – viene accuratamente taciuta in queste liturgie. La domanda suona: noi tutti giudici italiani, con tutto l’ambaradàn di risorse, personale, organizzazioni e polemiche di vario genere, siamo riusciti, in questo ultimo anno, ad assicurare agli italiani che hanno fatto ricorso alla nostra opera non dico tanto, ma almeno un tasso di giustizia pari al 20% di quello richiesto? E se non ci siamo riusciti, perché ciò è accaduto? E, se è accaduto, cosa fare per rimediare? Invece, nulla: silenzio assoluto. Della giustizia e del tasso di giustizia che ogni sentenza sia in grado di assicurare (o non assicurare) ai nostri simili non importa a nessuno, neppure al vicepresidente del Csm o al presidente della Cassazione. Ma non crediate sia una novità. Si va avanti così da decenni, e non sorprende perciò che le cose vadano di male in peggio: si parla del nulla e si tace l’essenziale. Da qui l’inutilità. Avanzo perciò una irriverente proposta: il prossimo anno, diamo da leggere a presidenti e vicepresidenti una relazione redatta tre, sei, dieci, vent’anni or sono. Scommetto che nessuno se ne accorgerebbe, nemmeno i giornalisti, tanto essa conterrebbe, più o meno, la medesima litania di geremiadi sulla mancanza di denaro, di personale, di mezzi e così via: come se a saldare il conto della giustizia fossero il denaro, il personale, i mezzi e non il senso di giustizia dei giudici, il loro esercitato equilibrio, il loro essere e mostrarsi esperti d’umanità. Preoccupati, come dev’essere, non solo di sbagliare il meno possibile: ma anche di saper rimediare agli errori commessi. Ma mi rendo conto: di questo è meglio tacere.
COME TI GABBO IL POPOLINO. RIFORMA FARLOCCA DELLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.
Un passo avanti nel nulla. Però, più del nulla assoluto di Silvio Berlusconi, che ci ha messo 20 anni per non metterci mano. Renzi ed il partito dei giudici, invece, ci mettono mano e gridano alla riforma per trasformare il niente. Non è stata nemmeno l’incompetenza giuridica del Ministro della Giustizia, che per altro non è nemmeno laureato, a partorire una nefandezza del genere, ma solo la voglia di far apparire importante una cosa inconsistente. La riforma di facciata attinente una legge esistente che a dire del viceministro alla Giustizia Enrico Costa “ha portato a risarcimento un numero di cause bassissimo, stimato tra 4 e 7, non di più". Per darvi un'idea: tra 1988 e 2014 tale è stata la fiducia degli italiani nella Legge Vassalli che sono state presentate in tutto 410 domande, davvero poche. Quelle ritenute "ammissibili" sono state appena 35, nemmeno una su dieci, e di queste soltanto sette alla fine sono state accolte (per l'esattezza 2 a Perugia e una a testa a Brescia, Caltanissetta, Messina, Roma, Trento). E tale numero rimane agli annali. I magistrati sghignazzano divertiti dietro un’apparente disappunto. Tutto ciò si denota dalle blande contestazioni, che nascondono una malcelata soddisfazione dell’ennesima vittoria delle toghe. Sul punto è abbastanza d’accordo Giuseppe Di Federico, uno dei primi giuristi italiani (è docente emerito di diritto penale a Bologna ed ex membro del Csm), che nel 1987 fu tra i promotori del vittorioso referendum radicale sulla responsabilità civile, poi rintuzzato dalla Legge Vassalli. "Non mi attendo uno tsunami di ricorsi" dice a Panorama.it "perché mi domando quanti avvocati saranno disposti a esporsi in casi di questo genere. E comunque prevedo un estremo rigore da parte dei tribunali".
Responsabilità civile dei magistrati: 7 casi accertati in 26 anni. Ecco i dati dell'avvocatura generale dello Stato, aggiornati al febbraio 2014. Dimostrano che il sistema sanzionatorio non funziona, scrive Maurizio Tortorella su “Panorama”. Da anni si parla di introdurre una più realistica responsabilità civile per i magistrati italiani. Ma qual è la situazione effettiva? Quanti sono stati i giudici raggiunti da un’azione civile? Panorama.it, finalmente, è in grado di pubblicare dati ufficiali dell’Avvocatura generale dello Stato: e sono anche dati aggiornatissimi, visto che risalgono al 7 febbraio 2014. Dal 1988, quando entrò in vigore la legge Vassalli che (in teoria) avrebbe dovuto sistematizzare la normativa alla luce di quanto i cittadini avevano richiesto a gran voce con il referendum abrogativo dell’anno precedente, sono state proposte in tutto 410 cause civili nei confronti di altrettanti magistrati, ritenuti «responsabili» di una qualche colpa grave da cittadini incorsi in un procedimento giudiziario. Le domande sono di per sé pochissime: poco più di 16 all'anno. Il motivo di una così rarefatta richiesta di giustizia da parte delle presunte vittime di malagiustizia, che invece stando alle cronache sono tantissime, sta nella complessità della procedura, ma anche nella scarsa fiducia nella capacità di ottenere effettivamente giustizia, e in certi casi forse anche nel timore di aggredire legalmente un magistrato. Del resto, fra tutti i ricorsi presentati, solamente 266 sono stati ritenuti inammissibili, mentre 71 sono ancora in attesa di ottenere la complicatissima patente di «ammissibilità» da parte di un tribunale. Altri 25 procedimenti già cassati sono stati ri-presentati con un'impugnazione da parte della presunta vittima di ingiustizia. In totale, insomma, le richieste presentate e ammesse al vaglio di un tribunale sono state 35 in un quarto di secolo: sono appena l'8,5% del totale. Mentre altre 44 sono ancora pendenti (generalmente dopo lunghi anni dalla presentazione). E come sono terminati i giudizi? Malissimo per i ricorrenti: perché anche alla fine del tormentatissimo iter legale, quasi metà delle richieste di accertamento della responsabilità civile di un magistrato sono state respinte: ben 17. E soltanto 7 sono state accolte. Sette in totale, sulle 410 avviate: ovverosia l'1,7%. A guidare la classifica dei giudizi negativi per i magistrati è il tribunale di Perugia, con 2 casi. Un caso a testa riguarda invece le avvocature di Brescia, Caltanissetta, Lecce, Reggio Calabria e Trento. Al momento, dei 44 ricorsi pendenti, 10 riguardano l'avvocatura di Messina, al primo posto; altri 7 sono a Salerno, altri 4 a Roma e altrettanti a Trento. Tre casi si segnalano a Potenza e ad Ancona. Due a testa sono pendenti davanti alle avvocature di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova. Una riguarda Napoli, un'altra Brescia, l'ultima Venezia. I dati, se mai ce ne fosse stato bisogno, dimostrano che il sistema sanzionatorio varato 26 anni fa non funziona affatto.
La responsabilità soggettiva dell’errore giudiziario è troppo estesa, per renderne effettivo il risarcimento del danno causato, addebitandolo ai singoli. Sono troppi i gradi intermedi e troppi i livelli di verifica e di sindacato per prevenire il danno e se ciò non avviene è perché il sistema si conforma a se stesso. Quindi allo stato dei fatti è impossibile indicare il responsabile, se non coinvolgerli tutti. Accusare tutti significa condannare nessuno.
La responsabilità dell’evento dannoso è spalmata ed estesa tra troppi magistrati per poter rendere effettiva la pretesa di giustizia. E lasciare in mano loro l’efficacia della giusta applicazione delle norme di un equo e fattivo risarcimento del danno per responsabilità civile delle toghe sembra una utopia.
Il disegno di legge n. 1626/2014 sulla riforma della disciplina della Responsabilità civile dei Magistrati, presentato il 24 settembre 2014 dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, è strutturato in cinque articoli e interviene sulla legge 13 aprile 1988, n. 117, con la tecnica della novella.
Un escamotage per far procedere un testo che investe una materia su cui pendeva una procedura d'infrazione in sede Europea per mancata applicazione del diritto comunitario e per la quale l'Italia rischiava di pagare una multa stimata in 37 milioni di euro. Il Governo ha dato parere negativo a tutti gli emendamenti. Il testo con proposta di legge A.C. 2738 trasmessa dal Senato, il 24 febbraio 2015, è passato alla Camera in via definitiva, dopo il sì del Senato, con 265 sì, 51 no e 63 astenuti. Astenuti Lega, Fi, Sel, Fdi e Alternativa Libera. M5S ha votato contro. Il M5S ha votato contro il nulla e quello che è grave è che non se ne rendono conto. La legge – dice il deputato M5S Alfonso Bonafede - è "una intimidazione ai magistrati". "Rifiuto l'argomento dell'intimidazione", ha risposto in Aula il ministro. "A chi parla del travisamento dei fatti e delle prove come di un'estensione impropria, dico che questa è un'indicazione europea, e non produce un automatismo sul magistrato, che può essere chiamato in causa solo in caso di negligenza inescusabile". Di fatto nella relazione che accompagna il testo sono stati inseriti "dei correttivi, degli elementi di chiarificazione - ha spiegato la presidente della Commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti - che sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, esplicitano che il danno c'è solo nel caso in cui il travisamento sia macroscopico e evidente ".
In questa prospettiva, l'intervento normativo interviene sul sistema sino ad oggi disciplinato dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, che regola il risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati. Disciplina adottata all'esito del referendum abrogativo degli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987.
L'articolo 1 reca modifiche alla disciplina sui presupposti della responsabilità modificando l'articolo 2 della legge Vassalli.
Il comma 1 del richiamato articolo 2 della legge n. 117 del 1988 è riformulato richiamando espressamente la responsabilità dello Stato anche per le condotte dei magistrati onorari (fermo quanto si dirà sui giudici popolari) ed eliminando la superabile limitazione del danno risarcibile ai danni non patrimoniali prevista per la sola ipotesi di provvedimento cha abbia determinato la privazione della libertà personale (lettera a)).
La lettera b) dell'articolo 1 riscrive il comma 2 dell'articolo 2 della legge Vassalli, prevedendo che l'attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove non determina responsabilità se non nel caso di dolo del magistrato e laddove l'interpretazione si risolve in una violazione manifesta della legge o la valutazione dei fatti e delle prove in un travisamento degli stessi.
La lettera c) riscrive il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 individuando, quale ipotesi di colpa grave predeterminata per legge, la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.
Va rilevato che, andando oltre alle esigenze di compatibilità col diritto dell'Unione, viene esteso l'ambito di operatività della responsabilità dei magistrati all'ipotesi di violazione manifesta anche del diritto interno da parte di organi giurisdizionali anche non di ultimo grado. Un’eventuale distinta considerazione, sotto questo profilo, del diritto dell'Unione europea e del diritto interno avrebbe potuto essere considerata del tutto improponibile sotto il profilo della razionalità e della ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e sotto l'ulteriore profilo, per quanto riguarda l'attività dei giudici, dell'osservanza della Costituzione e delle leggi (ovviamente anche interne) come sancita dall'articolo 54 della Costituzione.
Dalla lettera d) dell'articolo illustrato è aggiunto il comma 3-bis all'impianto originario dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988. Vengono individuati, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, una serie di criteri volti a determinare i casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea.
Per la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione i criteri predetti sono il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza. In particolare per la violazione manifesta del diritto dell'Unione europea deve inoltre tenersi conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'articolo 2 del provvedimento illustrato prevede l'abrogazione del procedimento di ammissibilità della domanda (il cosiddetto filtro all'azione di responsabilità) in chiave di semplificazione e maggiore effettività della tutela riparatoria accordata al danneggiato.
L'articolo 3 reca modifiche all'azione di rivalsa come disciplinata dagli articoli 7 e 8 della legge n. 117 del 1988, in particolare nel senso:
di mantenere il presupposto soggettivo di questa azione civile in termini di negligenza inescusabile;
di elevare a tre anni il termine entro cui lo Stato esercita l'azione nei confronti del magistrato;
di rendere espressamente obbligatoria l'azione di rivalsa stessa;
di razionalizzare il regime della rivalsa nei confronti dei magistrati onorari, ancorandola ai presupposti comuni di dolo e negligenza inescusabile, in tutti i casi diversi da quelli dei giudici popolari che resteranno responsabili solo per dolo (sul punto si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 18 dell’11 gennaio 1989).
Modificando l'articolo 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, la misura della rivalsa viene elevata da un terzo alla metà di una annualità dello stipendio del magistrato responsabile. Analogamente viene elevata ad un terzo la rata mensile dello stipendio del magistrato la quota espropriabile con esecuzione forzata.
Sostituendo l'articolo 9 si stabilisce (mutuando una previsione dell'abrogato articolo 5 sul cosiddetto filtro di ammissibilità) che il tribunale adito per il giudizio di rivalsa ordina in ogni caso la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti sarà trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.
Resta ferma l'immutata autonomia del giudizio disciplinare (attivabile anche prima e a prescindere da quello civile) rispetto al processo civile anche in sede di rivalsa.
Le modifiche apportate all'azione di rivalsa intercettano anche un generale consenso parlamentare, evidenziato da iniziative attualmente in discussione nelle due Camere.
L'articolo 4 reca disposizione finanziaria con norma di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge. È prevista l'effettuazione del monitoraggio degli oneri ai sensi della legge n. 196 del 2009.
Il testo si chiude con la norma sull'efficacia della normativa (articolo 5), che è previsto che si applichi ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.
Più che un intervento legislativo a tutela dei cittadini è la tacitazione dell’opprimente e vessatoria ingerenza dell’Unione Europea negli interessi italiani.
Va rilevato che la sentenza Traghetti del Mediterraneo e la successiva Commissione/Repubblica italiana sono sulla stessa linea della legge n. 117 del 1988 sia sul punto che è lo Stato a dover rispondere degli errori dei giudici, sia sul punto che la responsabilità dello Stato per gli errori dei giudici si concretizza solo a seguito di una violazione «imputabile a un organo giudiziario di ultimo grado».
Piuttosto -- secondo le due sentenze della Corte di Lussemburgo -- ciò che urta contro il diritto dell’Unione europea, dei precetti contenuti nel vecchio articolo 2 della legge n. 117 del 1988, è che il danno risarcibile provocato da un giudice non possa derivare anche da interpretazioni di norme di diritto o da valutazioni di fatti e prove (comma 2); e che, in casi diversi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, possano essere imposti, per la concretizzazione della responsabilità dei giudici, «requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di una manifesta violazione del diritto vigente» (comma 1).
Con l'intervento regolatorio che si è approvato, che conserva il sistema misto di responsabilità civile dei magistrati della legge Vassalli, strutturato cioè sulla responsabilità diretta dello Stato (in funzione compensativo-satisfattoria) e su quella, in sede di rivalsa, del magistrato (in funzione preventivo-punitiva), si intendono soddisfare le esigenze di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea:
modulando lo spettro della responsabilità dello Stato sulla violazione del diritto ovvero sul travisamento del fatto e delle prove, purché manifesti, quali ipotesi paradigmatiche di colpa grave che qualifica l'illecito riferibile a tutte le magistrature, anche quella onoraria;
adeguando di conseguenza la cosiddetta clausola di salvaguardia per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove nel senso di non prevederne l’operatività in caso di dolo del magistrato e laddove l'interpretazione si risolva in una violazione manifesta della legge e la valutazione dei fatti e delle prove in un travisamento degli uni e delle altre.
Ancora, l'intervento normativo incontra l'esigenza di rendere più immediata ed effettiva la responsabilità del magistrato, in specie per il recupero di quanto pagato dallo Stato, attraverso:
l'eliminazione del filtro oggi posto all'azione di risarcimento costituito da un procedimento di ammissibilità della domanda giudiziale;
la modifica della disciplina dell'azione di rivalsa che lo Stato responsabile è chiamato a promuovere nei confronti del magistrato autore della condotta illecita, per negligenza inescusabile, in tre direzioni:
chiarire la natura obbligatoria dell'azione che lo Stato promuove nei confronti del magistrato per il recupero di quanto pagato al danneggiato;
aumento del tempo utile per proporre la domanda di rivalsa da parte dello Stato;
congruo incremento della misura della rivalsa stessa, fino alla metà dell'annualità dello stipendio del magistrato;
la precisazione in senso rafforzativo dei rapporti tra responsabilità civile e disciplinare.
Ma ai neofiti del diritto prospettiamo l’applicazione esemplare e pratica della norma e quindi la sua inefficacia.
La responsabilità civile del magistrato consegue ad un danno riconducibile a colpa grave o dolo: si desume, quindi, che l’evento dannoso sia conclamato se non al grado definitivo. Ad un attenta analisi ci si accorge, però, che ci sono troppi gradi intermedi e troppi livelli di verifica e di sindacato per prevenire il danno e se ciò non avviene è perché il sistema si conforma a se stesso. Quindi allo stato dei fatti è impossibile indicare il responsabile, se non coinvolgerli tutti. Accusare tutti significa condannare nessuno.
L’indennizzo per questioni oggettive già c’è:
per le lungaggini del processo c’è la legge Pinto, anche se con le novelle intervenute è stata resa inefficace;
per la illecita detenzione c’è la soddisfazione monetaria da parte della Stato.
Ma se si va a pretendere il risarcimento soggettivo al singolo magistrato per il maggior danno dovuto ad errore giudiziario ecco che alzano le scuri a difesa della categoria togata.
Prendiamo per esempio un evento dannoso nel processo penale per un imputato risultato innocente per assoluzione o per revisione, ma che nelle trame del processo ha perso tutto: chi è il responsabile?
E’ il Pubblico Ministero che si è prodigato a sostenere un'accusa inconsistente fondata su teoremi farlocchi?
E’ il GIP che ha convalidato il suo operato?
E’ il GUP che ha confermato la sua accusa?
E’ il giudice monocratico o i giudici di Corte di Assise che hanno approvato la tesi accusatoria?
E’ il giudice d’appello o i giudici di Corte di Assise di Appello che hanno avvalorato la condanna?
Sono gli ermellini di Cassazione che hanno accreditato l'operato sottostante?
La responsabilità dell’evento dannoso è spalmata ed estesa tra troppi magistrati per poter rendere effettiva la pretesa di giustizia. E lasciare in mano loro l’efficacia della giusta applicazione delle norme di un equo e fattivo risarcimento del danno per responsabilità civile delle toghe sembra una utopia.
Cosa diversa sarebbe stata se si fosse prevista una autorità sanzionatoria slegata alla categoria delle toghe, come per esempio il difensore civico giudiziario, o almeno che fosse mista: magistratura, avvocatura, politica: Non sarebbe cambiato nulla, comunque, ma almeno una parvenza di imparzialità ci sarebbe stata.
Naturalmente legge vera di tutela del cittadino sarebbe stata adottata, se essa avesse preveduto la responsabilità civile dei magistrati per colpa semplice o dolo, partendo dall'effettivo dato oggettivo come è quello dell'evento dannoso, e da lì partire con la quantificazione monetaria dello stesso, da soddisfare con la polizza assicurativa che i magistrati già hanno e che dovrebbero pagare di tasca propria.
LA STORIA
Il Partito Radicale, il Partito liberale italiano e il Partito socialista italiano, presentavano nel 1987 la richiesta di tre referendum per ottenere la responsabilità civile dei magistrati, come risposta ai sempre più frequenti problemi della giustizia.
Tra i principali protagonisti che in quegli anni si battevano per la riforma della giustizia vi era Enzo Tortora, conduttore televisivo accusato sulla base di alcune dichiarazioni di pentiti di essere colluso con la camorra e il traffico di stupefacenti, rivelatesi successivamente false. La lunga detenzione del conduttore, e la successiva elezione nelle liste Radicali che sosteneva le sue battaglie politiche, contribuiva ad alimentare la discussione pubblica nel paese e nei mezzi di comunicazione circa la situazione della giustizia italiana.
L'appello radicale per la riforma della giustizia veniva sottoscritto anche da molti magistrati: «L’otto novembre gli italiani sono chiamati ad esprimersi su due aspetti particolarmente rilevanti della crisi della giustizia. Di fronte a insensibilità politiche e a resistenza corporative, i referendum sulla giustizia rappresentano un’occasione unica offerta ai cittadini per riaffermare fondamentali principi dello stato di diritto, abolire anacronistici privilegi e irresponsabilità e rivendicare improrogabili riforme. Lo strumento referendario restituisce così la parola ai cittadini. Non è più accettabile che i magistrati che, per colpa grave, abbiano danneggiato un cittadino non siano chiamati a risponderne dinnanzi ad un loro collega. Introducendo la responsabilità civile dei magistrati per colpa grave (grave negligenza, grave imperizia, gravi omissioni) non si intacca ma si riafferma la loro autonomia ed indipendenza. Abrogando i poteri istruttori della commissione inquirente per i reati dei ministri si eliminano inammissibili impunità. Noi voteremo SI ed invitiamo a votare SI perché anche politici e magistrati rispondano, come ogni cittadino, di fronte alla legge».
I referendum abrogativi dell'8 novembre 1987 si conclusero con una netta affermazione dei «si».
Dopo la scelta degli italiani circa la responsabilità civile dei giudici, il Parlamento approvava la cosiddetta «legge Vassalli» (votata da Pci, Psi, Dc), che, secondo i Radicali, si allontanava decisamente dalla decisione presa dagli italiani nel referendum, facendo ricadere la responsabilità di eventuali errori non sul magistrato ma sullo Stato, che successivamente poteva rivalersi sullo stesso, ma solo entro il limite di un terzo di annualità dello stipendio.
scritti alle liste: 45 870 931
Votanti: 9 866 249 - 65,10%
Voti validi: 25 896 355 - 86,70%
Voti nulli o schede bianche: 3 969 894 - 13,30%
RISPOSTA AFFERMATIVA SÌ 20 770 334 - 80,20%
RISPOSTA NEGATIVA NO 5 126 021 - 19,00%
LA LEGGE
"Art. 11 C.P.P. (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso é venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, é competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1".
"Art. 30-bis C.P.C. (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati). Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
Se nel distretto determinato ai sensi del primo
comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente
alla sua chiamata in giudizio, é competente il giudice che ha sede nel capoluogo
del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11
del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione".
"Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato
assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di
persona offesa o danneggiata dal reato.
|
Tabella A |
|
|
Dal distretto di |
Al distretto di |
|
ROMA |
PERUGIA |
|
PERUGIA |
FIRENZE |
|
FIRENZE |
GENOVA |
|
GENOVA |
TORINO |
|
TORINO |
MILANO |
|
MILANO |
BRESCIA |
|
BRESCIA |
VENEZIA |
|
VENEZIA |
TRENTO |
|
TRENTO |
TRIESTE |
|
TRIESTE |
BOLOGNA |
|
BOLOGNA |
ANCONA |
|
ANCONA |
L'AQUILA |
|
L'AQUILA |
CAMPOBASSO |
|
CAMPOBASSO |
BARI |
|
BARI |
LECCE |
|
LECCE |
POTENZA |
|
POTENZA |
CATANZARO |
|
CAGLIARI |
ROMA |
|
PALERMO |
CALTANISSETTA |
|
CALTANISSETTA |
CATANIA |
|
CATANIA |
MESSINA |
|
MESSINA |
REGGIO CALABRIA |
|
REGGIO CALABRIA |
CATANZARO |
|
CATANZARO |
SALERNO |
|
SALERNO |
NAPOLI |
|
NAPOLI |
ROMA |
Il testo vigente dell'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, recante: "Risarcimento di danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", come modificato dalla legge 420/98 , é il seguente: "Art. 4 (Competenza e termini).
1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente é il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si é verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione é esperibile.
3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si é concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si é verificato.
4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio non abbia avuto conoscenza del fatto".
Il testo vigente dell'art. 8 della citata legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla legge 420/98, é il seguente: "Art. 8 (Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).
1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento é proposta, anche se dal fatto é derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa é calcolata In rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa é calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento é proposta".
LA POLIZZA ASSICURATIVA DI 145, 50 EURO ANNUE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - Roma
Dichiarazione da sottoscrivere da parte di chi aderisce all'assicurazione
Responsabilità Civile e Tutela Legale
(si prega di scrivere in stampatello)
Il sottoscritto_________________________________________________________________________________
Nato a __________________________ il _________________ Residente in ______________________________
Prov._______ Via __________________________________________________ n° ________ C.a.p. __________
Eventuale recapito per l'invio della corrispondenza, se diverso dalla residenza:
Città ____________________________________________________ Prov. __________ C.a.p. _______________
Via _____________________________________________________________________ Numero Civ. ________
Nota: si raccomanda di aggiornare ad ogni variazione sia la residenza sia il recapito della corrispondenza
Lo scrivente, dichiara di aderire ai contratti di assicurazione unici e collettivi stipulati dalla A.N.M. per la Responsabilità Civile del Magistrato (Legge 117/88), per la Responsabilità Amministrativa e Contabile e per la Legge 24/03/01 n° 89 e per la Legge 626/94, nonché per la Tutela Legale e si impegna a corrispondere i relativi premi annuali:
a) quanto al periodo intercorrente dalla data del versamento alla prima scadenza anniversario di polizza, prende atto che la stessa scadrà il 15/04 di ogni anno. Dichiara che ha provveduto a versare il relativo premio a mezzo di c/c postale n° xxxxxxxx intestato all'Associazione Nazionale Magistrati – Gestione Assicurazione Responsabilità Civile - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour – Roma.
Nota: il premio viene stabilito in Euro 145,50= complessivi (polizza di Responsabilità Civile e polizza di Tutela Legale -non è possibile sottoscrivere le polizze separatamente) per le adesioni che avverranno nel periodo 15/04-15/10 di ogni anno, mentre è pari ad Euro 72,75= per le adesioni che avverranno nel periodo 16/10-14/04 di ogni anno. La Copertura assicurativa decorre dalla data del versamento.
b) quanto alle annualità successive corrisponderà il premio il cui importo e le cui modalità di versamento verranno comunicati ad ogni scadenza anniversaria.
Il Sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto il testo delle condizioni tutte di assicurazione e di accettare il contenuto delle medesime.
_______________________ , li _____________________ ______________________________ firma
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: I MAGISTRATI RESPONSABILI ANCHE PER COLPA SEMPLICE
Sussiste la responsabilità dei magistrati per colpa semplice secondo la Corte di Giustizia europea.
Il rapporto tra i cittadini e tra i cittadini e gli organi dello Stato è regolato dalla legge.
L’art. 3 della Costituzione esplicita che tutti hanno pari obblighi e diritti di fronte alla legge, senza che vi siano immunità ed impunità per nessuno. Solo al Presidente della Repubblica è riconosciuta la mancata responsabilità dei suoi atti.
Analizzando l’ambito del rapporto di prestazione di servizi manuali o intellettuali si denota che il lavoratore subordinato, che con colpa reca danno a qualcuno, è sottoposto alla legge penale, civile e disciplinare. Lo stesso dicasi per il lavoratore autonomo o il professionista. Il medico che sbaglia diagnosi o cura, risponde di omicidio o lesioni colpose e ne paga le conseguenze civili e deontologiche. L’ingegnere, l’architetto, il geometra, che per colpa sbaglia i progetti e causa dei crolli, risponde di omicidio o lesioni o disastro colposo e ne paga le conseguenze civili, ecc. ecc.
L’avvocato, il commercialista, il notaio, l’assicuratore ecc, che per colpa reca danno al suo cliente, paga le conseguenze civili e deontologiche.
Al dirigente pubblico, o al funzionario pubblico, o all'amministratore pubblico, o addirittura al Presidente del Consiglio dei Ministri, o ai singoli Ministri e sottosegretari, che per colpa recano danno ai cittadini, la Corte dei Conti chiede la rivalsa per il risarcimento del danno riconosciuto.
Da quanto detto pare che la legge sia uguale per tutti. Ad una attenta analisi della realtà ci si accorge, però, che la legge è uguale per tutti, meno che per i magistrati.
I magistrati sono liberi di incarcerare i cittadini innocenti, tanto c’è l’indennizzo per ingiusta detenzione, pagato dallo Stato, ma a carico dei cittadini, salvo rivalsa, ma non sono perseguiti per sequestro di persona.
I magistrati sono liberi di condannare i cittadini innocenti, tanto c’è l’indennizzo per l’errore giudiziario, pagato dallo Stato, ma a carico dei cittadini, salvo rivalsa, ma non sono perseguiti per calunnia e diffamazione.
Al cittadino, che per anni ha subito ingiustamente e per accanimento un procedimento penale che lo ha visto prosciolto, ovvero da vittima del reato ha visto il reato prescritto per inerzia, non c’è risarcimento riconosciuto, ne vi è abuso od omissione d’atti d’ufficio a carico dei magistrati. Lo stesso dicasi per il cittadino che è impedito alla giustizia civile per l’annosità dei processi.
C’è stato un referendum, approvato dalla quasi totalità dei cittadini italiani, che formalmente ha stabilito la responsabilità civile dei magistrati. Ossia: i magistrati che sbagliano devono risarcire i danni.
Invece, il rappresentante eletto dal popolo, ma lontano dagli interessi dei cittadini, con l’art. 2 della legge n. 117/88 ha previsto:
«1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
b) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
c) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, prima frase, della legge n. 117/88, costituisce peraltro un diniego di giustizia «il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria».
Ad una lettura attenta della norma si palesa la volontà di non perseguire alcun Magistrato, specie se a decidere sul comportamento del singolo è la stessa corporazione di cui esso fa parte.
Se, come da molti è considerato, il magistrato è dio in terra, infallibile e perfetto nelle sue azioni, mai incorrerà nel dolo o colpa grave, tanto meno sarà ammissibile la semplice colpa, dalla legge esclusa, così come è per i comuni mortali. Secondo la conformità del pensiero dominante, l’appello accolto o il ricorso cassato non sono frutto di errori giudiziari penali risarcibili, ma oneri a carico dell’innocente, perseguito ingiustamente.
Per il diniego di giustizia, poi, secondo il modo di pensare conforme di gente codarda e collusa, l'impedimento è oggettivo. Non è responsabilità di chi amministra la giustizia, ma è colpa dello Stato, quindi del cittadino, che fa mancare all’apparato la sussistenza economica, ovvero è colpa degli utenti, che in massa, si rivolgono alla magistratura per chiedere giustizia.
I magistrati devono meritarlo il rispetto e non pretenderlo. L’art. 3 della costituzione non prevede cittadini unti dal signore, al di sopra della legge. Non è certo l’azione di rivalsa del Presidente del Consiglio dei Ministri, non superiore ad un terzo dello stipendio del responsabile, di cui all’art 13 della stessa legge, ad equilibrare gli interessi in campo.
L’azione di rivalsa opera solo in caso di indennizzo per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, casi in cui rientra l’operatività della legge. Per tutto il resto non opera l’indennizzabilità dello Stato e ricade sulle spalle del cittadino.
La Corte di giustizia Europea censura la disciplina italiana della responsabilità dei magistrati, e, con essa, il mancato utilizzo dell’art. 234 CE, attraverso la SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) del 13 giugno 2006:
«Responsabilità extracontrattuale degli Stati membri – Danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado – Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice – Esclusione di ogni responsabilità connessa all’interpretazione delle norme giuridiche e alla valutazione degli elementi di fatto e di prova compiute nell’ambito dell’esercizio dell’attività giurisdizionale»
Nel procedimento C-173/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Genova con ordinanza 20 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2003, nella causa
Traghetti del Mediterraneo SpA, in liquidazione, contro Repubblica italiana.
La sentenza, di seguito acclusa, si inquadra in un risalente filone nell’ambito del quale il giudice comunitario da decenni ribadisce la responsabilità degli Stati per mancato rispetto del diritto comunitario da parte di tutte le loro istituzioni, in qualsiasi forma perpetrata. In questo caso la Cassazione italiana aveva dato torto alla società Traghetti del Mediterraneo, ricorrente per il risarcimento nei confronti della Tirrenia, non avendo tenuto conto della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato. Nel fare ciò la Cassazione aveva inoltre rifiutato di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 234. Ed è questo forse un punto rilevantissimo nella sentenza pur densa di motivi interessanti (tra cui quello del colpo inferto alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
<Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.
Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler>
A questo punto non si può pretendere che il cittadino, già tartassato, debba subire e tacere. Almeno che ci rimanga il diritto di lamentarci, se non, addirittura, di ribellarci.
LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE E CIVILE DEI MAGISTRATI
LA SENTENZA 13 GIUGNO 2006 DELLA GRANDE SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL LUSSEMBURGO: LA LEGGE 117/88 VIOLA I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO, NELLA PARTE IN CUI LIMITA ARBITRARIAMENTE L'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI.
CONVINTA ADESIONE DEI PRIMI AUTORI DELLA DOTTRINA.
La più autorevole, fra le conferme alle nostre tesi, non può che provenire dalla recentissima Sentenza 13 giugno 2006 resa dalla più alta magistratura esistente nell'ordinamento comunitario europeo, vale a dire dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia U.E. del Lussemburgo.
La pronunzia, integralmente pubblicata su www.aziendalex.kataweb.it/, oltre che (sempre integralmente) sui settimanali giuridici ""Diritto e Giustizia"" fasc. 29/2006, pagg. 105 segg., e ""Guida al Diritto"", fasc. nr. 4 / 2006 <>, pagg.30 - 39, si caratterizza per l'affermazione, netta e categorica, dei seguenti principi di diritto, assolutamente dirimenti a favore della dimostrazione della fondatezza delle tesi qui sostenute:
I. Gli Stati membri dell'U.E. rispondono a titolo extracontrattuale del danno patito dai singoli, in conseguenza di violazioni manifeste del diritto comunitario compiute dagli organi giurisdizionali, quand'anche tali violazioni derivino dall'attività di interpretazione delle norme o di valutazione dei fatti e delle prove;
II. Per stabilire quando una violazione del diritto comunitario debba ritenersi manifesta "" si valuta, in particolare, alla luce di un certo numero di criteri quali il grado di chiarezza e precisione della norma violata, il carattere scusabile o inescusabile dell'errore di diritto commesso, o la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art.234, terzo comma, del Trattato C.E., ed è presunta, in ogni caso, quando la decisione interessata interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in materia "" (così il punto 43. della sentenza 13 giugno 2006); su questo punto, inoltre, il massimo giudice europeo conferma le precedenti sue statuizioni, rese a partire dalla sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C - 6 / 90 e C - 9 / 90 ricorrenti ""Francovich ed altri"", e poi dalla sentenza 5 marzo 1996 cause riunite C - 46 / 93 e C - 48 / 93, e in ultimo dalla la sentenza 30 settembre 2003 causa C - / 224 / 01 ricorrente ""Kobler"";
III. Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave ""inescusabile"" del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto comunitario.
I primi commenti della dottrina si registrano in termini di grande interesse ed enfasi.
Chi sbaglia paghi: anche i giudici si adeguino, scrive Marco Ventura su “Panorama”. In tutti i settori della vita pubblica occorre una nuova rivoluzione che metta al centro il principio della responsabilità e il contrappeso dei poteri. Chi controlla i controllori? Gli arresti e le inchieste ai vertici della Guardia di Finanza offrono una risposta semplice: la magistratura. Ma chi controlla i magistrati? Qui la risposta diventa più complessa, perché non è risolutivo che a controllare i magistrati siano altri magistrati. Le toghe formano una casta o corporazione che dietro lo scudo dell’indipendenza nasconde una struttura e meccanismi di potere politico-correntizio che con l’esercizio della “giustizia” hanno poco a che vedere. Intanto, infuria la polemica per l’inaspettato “sì” a un emendamento leghista alla Camera dei deputati che introduce la responsabilità civile dei magistrati, equiparandoli a tutti gli altri cittadini nell’obbligo di risarcire le vittime degli errori commessi , nel loro caso per “violazione manifesta del diritto” oppure con dolo o colpa grave. Una norma che sarebbe di civiltà, e in linea con un’esplicita e grave condanna europea nonché col referendum che nel 1987 consegnò alle urne la volontà dell’80.2 per cento di italiani favorevoli al principio che “chi sbaglia paga” anche per i giudici, e se non cadesse in coda alla ventennale polemica sull’uso strumentale, politico, della giustizia. Che il dibattito sia inquinato dall’attualità dello scontro politico è provato non soltanto dalla ormai pluridecennale querelle berlusconiana, ma dall’imbarazzo di Matteo Renzi che il 27 ottobre 2013 lanciò la riforma della giustizia portando a esempio “la storia di Silvio”. Che non era Silvio Berlusconi ma Silvio Scaglia, patron di Fastweb che noleggiò un aereo privato per rientrare in Italia e spiegare la propria posizione ai giudici che lo indagavano, ma finì in carcere innocente per 3 mesi, più 9 ai domiciliari. Oggi Renzi dissente dalla responsabilità civile per i magistrati, dall’Asia fa sapere che la norma sarà ribaltata al Senato. Cioè, la riforma può aspettare. L’eguaglianza fra i cittadini anche. Ma il problema è più vasto di quello che può sembrare.
Chi controlla i controllori? Questo è il punto. Interrogativo che si pone per qualsiasi posizione “di controllo”. La parola chiave è proprio “controllo”. Nelle società di cultura anglosassone il metodo applicato alla formazione delle istituzioni e alla giurisdizione è quello che risale a Montesquieu e va sotto il nome di “checks and balances”, ossia “controlli e contrappesi”. È il principio per cui il sistema non riserva a alcun potere una licenza assoluta, incontrollabile e incontrollata. Il succo della democrazia, in paesi come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, sta proprio nel contrappeso tra poteri che si controllano a vicenda. In Italia lo sbilanciamento è sotto gli occhi di tutti e insieme allo strapotere della magistratura (che giudica e sanziona se stessa in termini di carriera e procedimenti disciplinari), emerge il problema della effettiva indipendenza e credibilità. Non basta che un magistrato che ha esagerato nel disprezzo delle regole sia sottoposto a vaglio disciplinare. Occorre che i controllori siano anch’essi controllati e al di sopra di ogni sospetto. La politica deve riconquistare dignità e autorevolezza. Vanno superati dogmi inattuali e smentiti dai fatti (in ultimo dall’inchiesta sul Mose che ha coinvolto il sindaco Pd di Venezia) riguardo a una supposta e inesistente “superiorità morale della sinistra”. Bisogna che accanto a un’effettiva applicazione del principio del “checks and balances” si affermi un altro principio, quello dell’“accountability”. Cioè della verifica. I controllori sono gli insegnanti nelle scuole o professori nelle Università? Bene, chi li valuta? Chi ne controlla i risultati? Chi tiene l’inventario dei risultati concreti e misurabili? Per esempio, qual è il numero di laureati di quella Università che trovano lavoro e ottengono un successo? Qual è il numero di diplomati di un certo istituto che ha conseguito la laurea, e la specializzazione, e il dottorato? E se i controllori sono i super manager di aziende pubbliche, potrà mai esserci una relazione diretta tra la carriera e i risultati anche nel loro caso, o conferme e siluramenti dipenderanno ancora una volta dalla rete di amicizie e dai clan politici? Nella pubblica amministrazione, quando si passerà dal concetto dei premi come parte integrante e automatica dello stipendio, a quello di “premio” realmente selettivo e ponderato, fondato sul conseguimento di obiettivi verificati? In tutto il mondo, specialmente nelle compagnie private, vige il principio dei risultati da conseguire. Si fissano gli obiettivi, a posteriori si valuta se siano stati centrati. Altrimenti non si viene pagati, o addirittura si viene “fired”, licenziati. Non rinnovati. Forse appartiene a questa mentalità anche la sanzione che peserebbe di più sui pubblici funzionari infedeli: la perdita del diritto alla pensione. Se mai il processo sancirà che un reato è stato commesso, perché i pubblici funzionari dovrebbero conservare il diritto alla pensione visto che loro per primi hanno tradito il loro ruolo? Controlli e contrappesi. Verifica dei risultati. Premi e sanzioni. A quando la rivoluzione culturale? Gli italiani favorevoli alla responsabilità civile dei giudici.
Un sondaggio rivela come l'87% vuole che i magistrati paghino per i propri errori, scrive Arnaldo Ferrari Nasi su “Panorama”. Il governo è stato battuto a favore di un emendamento che modifica l'articolo 2 della legge 117/88 sul risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Cos'è la 177/88? E' la cosiddetta Legge Vassalli sul "risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati". Comporta che, al pari di altre professioni, i magistrati possano rispondere risarcendo il danno qualora compiano un atto con dolo o colpa grave, parificando la loro responsabilità a tutti gli impiegati civili dello Stato. In caso di colpa semplice o errore è lo Stato a risarcire le vittime. Una legge che, quando promulgata, venne giudicata troppo morbida da diverse parti e, soprattutto, che travisava i risultati del referendum dell'anno precedente. Referendum che stravinse con l'80% dei "Sì". Referendum presentato dai Radicali allo scopo di abrogare le opportune norme per stabilire che ci esistesse una responsabilità civile anche per i giudici. Del resto, dopo oltre venticinque anni, i casi di risarcimento effettivo da parte di magistrati si possono contare sulla punta delle dita. Invece, i cittadini sono oggi della stessa opinione di venticinque anni fa. Sia quelli che sono nel frattempo invecchiati, sia quelli che nel 1987 non erano ancora nati. Più precisamente il nostro ultimo dato a rilevato lo scorso anno ci dice che l'87% degli italiani maggiorenni è d'accordo con l'affermazione: “un magistrato che sbaglia dovrebbe essere responsabile della propria azione”. Il dato è perfettamente concorde con la nostra rilevazione precedente del 2010, i cui risultati davano 86%. Sul tema, dunque, il pensiero degli italiani è chiaro e non muta almeno da un quarto di secolo. Ma non ce l'anno fatta vincendo un referendum e non ce l'anno fatta con un Berlusconi fortissimo. Ci riusciranno oggi?
Sbatti l'azienda in prima pagina. Troppo spesso la magistratura è entrata a gamba tesa nella vita delle imprese, lanciando inchieste che poi si sono sgonfiate. Lo dimostrano le accuse della Procura di Parma sul caso Lactalis-Parmalat. Un copione che potrebbe ripetersi su Unipol-Sai e Ilva. Come ha chiesto Giorgio Squinzi, è un problema che va finalmente affrontato, scrive Oscar Giannino su “Panorama”. In nessun paese avanzato asset industriali restano per anni sotto il pieno controllo della magistratura. Il tema è stato seccamente posto da Giorgio Squinzi, all’ultima assemblea annuale di Confindustria. Poiché l’Italia ha tra i suoi numerosi nervi scoperti quello della legalità, i più hanno finto di non sentire. Ma è un errore di ipocrisia. Il tema andrebbe invece affrontato. Seriamente. Non è solo una questione di principio, visto che per dato di fatto i magistrati non hanno la competenza adeguata per giudicare piani aziendali, esaminati invece da periti delle Procure "attenti", come ogni perito di parte, ai fini del committente. Basta esaminare tre casi eclatanti in corso da anni, per capire che il problema esiste. Parmalat, Ilva e Unipol-Sai. In Parmalat, società quotata e dal luglio 2011 controllata dalla multinazionale francese Lactalis, solo il 26 maggio la Corte d’Appello di Bologna ha posto fine a un anno e mezzo di reiterate pronunzie della Procura di Parma volte alla revoca del cda e del consiglio sindacale, a seguito delle indagini civili e penali per l’acquisto di Lactalis America nel 2012. I procedimenti civili sono ora estinti, quelli penali no. A fine 2013 il cda si è dimesso, ad aprile in assemblea ne è stato eletto uno nuovo. Ma nell’anno e mezzo di scontro giudiziario nessun peso sembravano avere i risultati che Parmalat accumulava: nuove acquisizioni in Australia e Brasile, 24 prodotti nuovi nei 31 paesi in cui il gruppo opera, crescita del fatturato a parità di perimetro dai 4,4 miliardi del 2011 ai 5,7 nel 2013, aumento del margine operativo lordo da 374 a 493 milioni. Per l’Ilva, a luglio saranno due anni dall’arresto dei Riva. Da allora, una sfilza di provvedimenti giudiziari e molti divergenti nel merito, due decreti ad hoc dei governi Monti e Letta. Ma siamo al punto che il commissario straordinario Enrico Bondi ha un piano industriale che non convince né i privati né il pubblico, visto che il premier Matteo Renzi ha detto "così non va", promettendo novità a breve. La sopravvivenza delle produzioni è più che mai in gioco, le bonifiche e i relativi capitali ancora da vedersi. Per le indagini aperte dalla Procura di Milano sui concambi tra Unipol e Fonsai, è stato il senatore pd Massimo Mucchetti, di certo non sospettabile di pregiudizi avversi ai pm e favorevoli alla Consob di Giuseppe Vegas, a scrivere su Repubblica tutti i suoi dubbi, sul fatto che il magistrato possa far sicura questione di diritto partendo da opinabili valutazioni sulle analisi quantitative dei prezzi. Servirebbero interventi di legge. Volti a porre argini a una deriva cominciata con la legge 231 del 2011, che estende all’impresa, ai suoi manager e controllanti responsabilità amministrative e penali per reati compiuti da dipendenti. E che poi via via, con ordinanze e decreti ad hoc sui singoli casi aziendali, ha esteso le facoltà della magistratura di nominare commissari giudiziali che diventano capiazienda, e di inibire cda regolarmente nominati. La magistratura deve fare il suo dovere, non sostituirsi a proprietà e manager. Eppure in Italia c’è sempre chi, per ideologia o per timore di ritorsioni, è genuflesso alle toghe. Ue, il governo delle toghe battuto alla Camera sulla responsabilità civile toghe toghe. Norme più dure per gli errori dei giudici
Insorgono Anm e Csm: "A rischio la nostra indipendenza". Duro scontro Pd-5S. Renzi: "Correggeremo in Senato", scrive “La Repubblica”. Il governo e la maggioranza sono stati battuti, in un voto a scrutinio segreto, nell'esame sulla legge europea 2013-bis alla Camera sulla responsabilità civile delle toghe. E' infatti passato un emendamento della Lega, a prima firma di Gianluca Pini, e a cui governo e relatore avevano dato parere contrario. Riscrive l'articolo 26 sulla responsabilità civile dei magistrati, inasprendo di fatto le pene nei confronti dei giudici. I voti favorevoli sono stati 187, mentre 180 i contrari. Sette voti di differenza che pesano, visto che alla Camera governo e maggioranza contano su un ampio sostegno. L'emendamento modifica l'articolo 2 della legge dell'88 sul risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati. Una questione sulla quale il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ricorda che l'indipendenza dei giudici non è un privilegio. Il premier Matteo Renzi però, parlando con i suoi da Pechino, del voto con il quale la maggioranza è stata battuta, minimizza:"E' una tempesta in un bicchiere d'acqua, il voto segreto è occasione di trappoloni, ma le reazioni che vedo sono esagerate", dice il premier per il quale la norma sarà modificata a scrutinio palese al Senato.
Sabelli (Anm): "Fatto grave". Dura la reazione dell'Associazione nazionale magistrati che ha definito il voto "un fatto grave". Il presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli, ha detto che : "in un momento che vede la magistratura fortemente impegnata sul fronte del contrasto alla corruzione nelle istituzioni pubbliche, questa norma costituisce un grave indebolimento della giurisdizione". Con l'emendamento votato oggi "si vorrebbe reintrodurre ciò che non si riuscì ad approvare nel 2012 - sottolinea Sabelli - cioè un'introduzione dell'azione diretta di responsabilità civile che non ha eguale in nessun ordinamento occidentale e che presenta evidenti profili di incostituzionalità". Parte all'attacco anche il vice presidente del Csm, Michele Vietti che dice: "E' in gioco non un privilegio, ma l'indipendenza di giudizio del magistrato". Mentre, secondo l'Associazione magistrati della Corte dei conti "l'emendamento all'art. 26 della legge comunitaria, che prevede l'azione diretta di responsabilità civile nei confronti del magistrato, rileva come la stessa, oltre ad essere non in linea con la legislazione della maggior parte degli Stati membri dell'Ue, costituisce un gravissimo vulnus all'autonomia e all'indipendenza dei giudici". Critico anche il legale Gianluigi Pellegrino. "Si crea un cortocircuito che può bloccare ogni giudizio. Se è giusto, come chiede l'Europa prevedere sistemi più efficaci di ristoro per gli errori giudiziari, è assurdo e tribale prevederlo con azioni dirette della parte contro i giudici e peraltro anche per mero errore di diritto - spiega l'avvocato Pellegrino - . Piuttosto bisogna proporre un ulteriore rafforzamento del controllo disciplinare per tutte le giurisdizioni e nel rispetto dei principi di autogoverno". Nell'emendamento approvato dall'assemblea si legge, che "chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto". "La norma è passata con almeno 80 voti del Pd, quindi prima di sfidare la volontà popolare invito i democratici a sfidarsi internamente, mettendo d'accordo la parte destra del cervello con quella sinistra, per poi formulare una proposta alternativa sul tema", ha detto Pini, dopo il voto. Prova a gettare acqua sul fuoco il Pd: il provvedimento deve "ancora passare al Senato e lì modificheremo la norma", garantisce in Aula Ettore Rosato. Mentre Roberto Speranza, presidente dei deputati Pd parla di "un vero e proprio colpo di mano del centrodestra con la complicità del M5S". "In parlamento esistono proposte sulla responsabilità civile dei magistrati e ritengo siano maturi i tempi affinchè la questione venga affrontata in modo serio e rigoroso - aggiunge Speranza - . Penso sia oltremodo sbagliato trattare tale tema in modo frettoloso, attraverso un emendamento alla legge comunitaria". Forza Italia, come del resto la Lega, esulta. "Quando il centrodestra trova i contenuti batte il parlamento e batte anche Renzi", dice la deputata azzurra Daniela Santanchè, che aggiunge: "Al bando dunque le poltrone e gli organigrammi della sinistra, la forza delle nostre idee riflette fedelmente la volontà degli italiani. D'altro canto, l'astensione del M5S è del tutto vergognosa e ribadisce la natura giustizialista dei grillini". Anche i 5 Stelle mostrano soddisfazione: "La nostra decisione di astenerci ha tirato fuori tutta l'ipocrisia del Pd", dice il grillino Andrea Colletti.
A fine aprile era stato bocciato il disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati, voluto dal centrodestra. I senatori del Pd, i parlamentari grillini e gli ex 5 Stelle avevano approvato, in commissione Giustizia del Senato, l'emendamento del M5S che cancella l'art.1, cioè il cuore del testo. Giudici, Giachetti (Pd): "Ho votato sì perché norma non colpisce magistrati perbene". "Pensiamo ai casi di Tortora e Scaglia", dice il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti, Pd, che oggi ha contribuito con il suo voto (palese) a far passare l'emendamento leghista sulla responsabilità civile dei giudici e qiundi a battere il governo, 187 a 180. "Il tempo per una scelta è maturo anche nel Partito democratico", aggiunge, "non so perché nel gruppo non ci sia stato un dibattito. Nessuno scambio con il centrodestra".
E comunque in ogni giornalista c'è il comunista che è in sè, ed in queste occasioni esce fuori. Camera, passa la responsabilità civile dei Pm. Il "messaggio" della politica alle inchieste. La responsabilità civile dei magistrati, contro il parere del Governo, passa a Montecitorio con 187 sì e le decisive astensioni di M5S e Sel. Il centrodestra esulta, il Pd annuncia cambiamenti al Senato. Ma già nel 2012, con la maggioranza di centrodestra, l'emendamento era stato approvato, scrive Susanna Turco su “L’Espresso””. L’Anm parla di fatto grave, il centrodestra esulta, il Pd piuttosto imbarazzato fa sapere che al guasto si riparerà al Senato, senz’altro, mentre il senatore Maurizio Gasparri promette di combattere “strenuamente” per tenerlo così come è. Pare una giornata d’altra epoca, alla Camera. Proprio mentre la giunta per le Autorizzazioni, presieduta da Ignazio La Russa, apre il faldone relativo alla richiesta di arrestare Giancarlo Galan (e dal sì all’arresto di Francantonio Genovese è passato meno di un mese) in Aula, contro il parere del governo, i deputati approvano una norma che introduce la responsabilità diretta dei magistrati. Il principio, cioè, secondo cui se un magistrato sbaglia ci si può rivalere direttamente su di lui, invece che sullo Stato come accade ora secondo la procedura (peraltro complessa) della legge Vassalli. Il magistrato che ha sbagliato paghi: è uno dei caposaldi classici del berlusconismo che fu, mentre i democratici - pur concordando sulla necessità di rinnovare la norma del 1988 - hanno tutta un’altra idea su come farlo. A presentare il testo incriminato, come emendamento alla legge comunitaria in discussione a Montecitorio, è il leghista Gianluca Pini. Ma la sua approvazione in Aula, con 187 sì contro 180 no, e l’astensione dichiarata dei Cinque stelle, suona almeno in parte come una risposta della politica all’accanirsi della magistratura con inchieste di ogni ordine e grado, dall’Expo e Mose in avanti. “In questo momento, questa norma costituisce un grave indebolimento della giurisdizione”, dice il presidente Anm Rodolfo Sabelli. “Un vero e proprio atto intimidatorio”, aggiunge il presidente Pd in commissione Giustizia Donatella Ferranti, puntando l`indice contro chi, “proprio ora, cerca di intimorire i magistrati che con coraggio hanno aperto vari fronti di indagine sui fenomeni corruttivi dilaganti negli appalti pubblici”. Interpretazione, questa, valida fino a un certo punto. E’ tragicamente vero, infatti, che lo stesso testo sulla responsabilità dei magistrati, sempre firmato da Gianluca Pini, sempre come emendamento alla legge comunitaria, era stato presentato ed approvato poco più di due anni fa. Era il 2 febbraio 2012, a Palazzo Chigi regnava Monti, e l’Aula di Montecitorio dava il via libera al testo Pini con 264 sì e 211 no (un solo astenuto). Allora come ora il voto era segreto. Ma il rapporto di forze tra centrosinistra e centrodestra era invertito. E i Cinque Stelle, in Parlamento, nemmeno ci stavano. Dunque se è vero che si tratta di un segnale ai magistrati, è un segnale più trasversale e meno legato al momento di quanto non paia sulle prime. Tanto più che, mentre la responsabile giustizia del Pd Alessia Morani giura che oggi il gruppo è stato compatto nel votare contro, è pur vero che il vicepresidente democratico della Camera Roberto Giachetti rivendica il suo sì (quella sulla responsabilità civile è una antica battaglia radicale), e soprattutto che i deputati del centrodestra presenti in Aula, secondo i calcoli del forzista Simone Baldelli che è uno preciso, non sono più di ottanta. Per arrivare a 187 mancano, dunque, un centinaio di voti all’appello: e anche mettendo un punto interrogativo sui vari gruppi minori, i conti non tornano. La crepa, comunque, sarà sanata. Al Senato la norma verrà cancellata dalla legge comunitaria, in attesa che il tema sia affrontato a parte. I numeri ci dovrebbero essere perché anche i Cinque stelle, tutti contenti per il blitz che ha “permesso di svelare l’ipocrisia del Pd”, dicono che al Senato torneranno a votare no alla responsabilità civile diretta dei magistrati, come hanno fatto a fine aprile a Palazzo Madama, in asse col Pd e contro il centrodestra. Finirà insomma come due anni fa: anche allora la norma Pini fu cancellata dall’altro ramo del Parlamento. Resta da capire quando è che Renzi si deciderà a dare il via libera alla riforma di questo come di altri punti dolenti del capitolo giustizia. Proprio a fine aprile, a Porta a porta, il premier - pur favorevole a cambiare la Vassalli - spiegò che “finché c’è un clima da derby” e “finché ci sarà chi dice che la magistratura è il cancro dello Stato”, “non ci potrà essere nessun intervento sulla giustizia”. Ecco, insomma, un altro punto sul quale il rapporto con Berlusconi contiene una pericolosa ambivalenza.
I sinistroidi vogliono tutelare i magistrati incapaci ed in malafede.
Truffa Carige, indagati per abuso d'ufficio i magistrati liguri coinvolti. Indaga la procura di Torino sulle presunte interferenze di pm e giudici di Savona e La Spezia. Il fascicolo è stato trasmesso dai colleghi genovesi titolari dell'inchiesta, scrive Ottavia Giustetti su “La Repubblica”. L'ex presidente di Banca Carige, Giovanni Berneschi (ansa)Sono indagati per abuso d'ufficio e violazione del segreto i tre magistrati liguri coinvolti nell'inchiesta sulla maxi inchiesta per truffa a Banca Carige. Maurizio Caporuscio, pm a La Spezia, Pasqualina Fortunato, giudice del lavoro a La Spezia, Francantonio Granero procuratore capo di Savona. Sulle presunte interferenze dei magistrati liguri indaga la procura di Torino che ha ricevuto il fascicolo dai colleghi genovesi titolari dell'inchiesta su Carige. Lunedì il pm torinese Marco Gianoglio è stato a Genova per partecipare a una riunione organizzativa. Da lì era partito un paio di settimane fa il fascicolo sulle presunte rivelazioni e le interferenze. Già in Liguria la procura aveva iscritto i tre magistrati accusandoli di abuso e violazione del segreto. Caporuscio è nei guai per una telefonata tra l'avvocato spezzino Andrea Baldini, ex componente del Cda di Banca Carige, e Berneschi. Parlando Baldini racconta che il magistrato fece in modo che fosse fornita al banchiere la copia di una denuncia 'riservata' che l'imprenditore spezzino Gianfranco Poli aveva presentato contro l'ex numero uno di Carige per truffa. E sempre le dichiarazioni di Baldini accusano la moglie, Pasqualina Fortunato. L'avvocato ha spiegato infatti a Berneschi che grazie all'interesse di Lilly (per gli inquirenti è la moglie) sarebbe stata chiesta l'archiviazione del fascicolo. Berneschi, discutendo con il manager di Carige Antonio Cipollina di un interrogatorio che doveva affrontare nell'autunno scorso a Savona, dove è indagato per la bancarotta del costruttore Andrea Nucera, dice che il procuratore Ganero gli ha suggerito di non rispondere e ribadisce di aver parlato con lui del figlio Gianluigi, membro del cda di Cassa di risparmio di Savona, controllata da Carige e uomo di spicco delle cooperative. Granero aveva detto "Tutto falso, presenterò querela". E gli inquirenti sospettano che le frasi di Berneschi siano state pronunciate per comprometterlo. Non sono stati inviati invece a Torino gli atti che chiamano in causa il procuratore aggiunto di Genova Vincenzo Scolastico. Il suo nome, dedotto da alcune conversazioni telefoniche ma mai citato espressamente, era stato chiamato in causa come un possibile altro sospettato di aver favorito il gruppo che faceva riferimento a Berneschi. Ferdinando Menconi, ex manager di Carige Vita Nuova, ne descriveva la figura e diceva presumibilmente di lui "... carissimo amico con cui prendo il caffè ogni sabato". Ma sul suo conto non sarebbero stati riscontrati comportamenti scorretti e dunque è caduto nei suoi confronti ogni sospetto.
Responsabilità dei giudici. «Vogliono tenerci sotto schiaffo», scrive Mimmo Mazza su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. I mali della giustizia sono tanti e tali che non si risolvono con un singolo provvedimento, nè tantomeno con i 140 caratteri contenuti da un tweet. Eppure con la modifica della responsabilità civile dei giudici, d’incanto sembrano svaniti tutti i problemi. Ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto al giudice Martino Rosati, presidente della sezione di Taranto dell’Associazione Nazionale Magistrati. Taranto rappresenta una città di frontiera per la giustizia, essendo suo malgrado ormai da anni al centro dell’at t e n z i o n e mediatica per il caso Scazzi - di cui peraltro il dottor Rosati si è occupato come giudice per le indagini preliminari - e per la vicenda Ilva. «Pochi slogan come «chi sbaglia paga» si prestano così bene - dice alla Gazzetta il giudice Rosati - a guadagnarsi il favore dei cittadini, e potenziali elettori, quando si parla di giustizia e magistratura. Il magistrato infatti altro non fa che decidere delle lite tra due o più parti e non potendo dare ragione a tutti, inevitabilmente ne scontenterà almeno, e sottolineo almeno, una: per la quale, quindi, quella decisione è appunto sbagliata».
Ma i giudici non sbagliano mai?
«Noi interveniamo sempre in situazioni controverse e perciò più o meno discutibili. È sbagliato il paragone tra l’attività del magistrato e quella del medico, dell’ingegnere e di tutti gli altri professionisti. Tutti costoro, infatti, producono cose, oggetti o quanto meno risultati empirici. Il diritto, invece, non è aritmetica: non necessariamente, ossia, la soluzione di una questione giudiziaria può essere una ed una sola. Del resto, per nessun'altra professione è previsto per legge che l'attività di un operatore possa essere sottoposta al controllo di uno o più suoi colleghi. Il sistema delle impugnazioni, consentendo che ad occuparsi della controversia siano più persone, rappresenta comunque l'unico strumento per contenere le possibilità di errore connesse alla naturale e non eliminabile fallacia della conoscenza e dei giudizi del l'uomo sull'uomo. In vent'anni di attività almeno su un paio di questioni di grande importanza in materia di mafia e di libertà personale ho consapevolmente ritenuto, argomentando criticamente, di discostarmi dall’interpretazione di alcune norme allora sostenuta dalla Cassazione; e, se in quei singoli procedimenti le mie decisioni sono state impugnate dagli interessati ed annullate dalla Cassazione, negli anni seguenti è stata quest'ultima che, sulla spinta di tante altre decisioni come la mia da parte di altri giudici e tribunali ha mutato opinione, condividendo quanto io ed altri colleghi avevamo sostenuto. Se allora fosse stata in vigore questa legge sulla responsabilità civile dei magistrati, dunque, io sarei stato probabilmente chiamato a pagare i danni ad un delinquente per aver deciso bene».
Eppure, dicono che la nuova legge sia stata chiesta dall’Europa.
«Non è vero. L'Unione Europea si era limitata a minacciare una sanzione all'Italia, se non avesse predisposto degli strumenti di risarcimento da parte dello Stato, e senza alcuna necessità di rivalsa sul magistrato, in caso di mancata osservanza esclusivamente del diritto comunitario e soltanto da parte della Corte di Cassazione».
Cosa replica a chi parla, invece, della fine di un intollerabile privilegio di casta? «Le garanzie di cui gode il magistrato non costituiscono un privilegio di casta ma sono uno strumento posto dagli ordinamenti democratici a tutela dei cittadini e della loro eguaglianza. Il compito del magistrato, ridotto alla sostanza, è quello di porre rimedio a dei torti secondo la legge. Ma chi è più esposto a subire dei torti? Il ricco e potente, oppure il povero e disagiato? La possibilità di rivolgersi ad un giudice imparziale e non suscettibile di condizionamenti, dunque, rappresenta una opportunità per le frange più basse della gerarchia sociale, piuttosto che per i più abbienti ed attrezzati».
Eppure il presidente del Consiglio ha detto che i giudici non hanno nulla da temere.
«Allora, a parte il fatto che tutti quelli a cui Renzi e i suoi giannizzeri hanno detto di “stare sereni” non mi pare, poi, che abbiano avuto modo per esserlo davvero, sollevo alcuni dubbi. Perché se quella era l’effettiva volontà del Parlamento, l’attributo “macroscopico”, riferito all’errore che obbliga il giudice a pagare, l’hanno inserito nella relazione alla legge e non invece direttamente nel testo? Che bisogno c'era di fare una nuova legge dal momento che l'errore macroscopico, quello, ossia, chiaramente evidente, indiscutibile, clamoroso e perció inevitabilmente rarissimo era sicuramente sanzionato anche dalla legge finora in vigore? Se cosi è, chi stanno prendendo in giro i riformatori 2.0? I magistrati (nemmeno degni di un tweet “statesereni”, che cattiveria...)? Oppure i cittadini-elettori, a cui conviene far credere che il disservizio giustizia sia addebitabile esclusivamente ai magistrati. ed ai quali si vuol presentare come storica e rivoluzionaria (tanto da farsi fotografare mentre si firma il relativo testo di legge) una riforma che, invece, lascerebbe tutto come prima?».
Allora qual è il reale obiettivo del Governo?
«Renzi ed i suoi hanno completato un formidabile triplete ai danni della magistratura, dopo la riduzione degli stipendi e l'amputazione delle ferie. L'obiettivo non è quello, per seguito da alcuni suoi illustri predecessori in modi però grossolani e perciò fastidiosi a molti, di colpire la magistratura: quanto, piuttosto, di tenerci sotto schiaffo. L'altra sera, in tv, ho sentito dire da un'altissima figura istituzionale, quale è un vice-presidente della Camera dei Deputati (Roberto Giachetti, ndr), che, voce dal sen fuggita, la legge sulla responsabilità civile dei magistrati è uno strumento per ristabilire il primato della politica. Mi permetterei di ricordare a quell'elevato organo dello Stato il quale probabilmente non ha avuto tutto il tempo che ho avuto io, facendo il giudice in provincia da 22 anni per comprendere cosa significhi servire lo Stato ed i cittadini, che in un ordinamento democratico, nessuno dei tre poteri può rivendicare un primato su ciascuno degli altri due».
Cosa cambierà praticamente per i magistrati?
«Io faccio il gip, il giudice, per capirci, che dispone i sequestri ed applica la custodia cautelare. Ossia, come direbbe l'uomo comune, mette le persone in galera. Quando, già oggi, mi arriva una richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero, io, senza che nessuno mi possa dire niente, e senza quindi correre alcun rischio, potrei limitarmi a scrivere: visto, si rigetta, non ricorrendo i presupposti di legge per l'adozione della misure. Trenta secondi di impegno e punto. Oppure, come è giusto e doveroso che sia, studio, scrivo decine di pagine, lavoro per ore e ore, quasi sempre anche di sabato e la domenica (senza che cambi la mia retribuzione), e, alla fine, ordino che qualcuno sia posto in carcere o che un'azienda sia sequestrata e smetta di lavorare. Fino ad oggi, tutto ciò potevo farlo senza temere di rimetterci di tasca mia, o anche soltanto di essere citato in giudizio dall’imputato: da domani, probabilmente, non più. Non bisogna essere particolarmente acuti, allora, per capire che, in un simile contesto, è concreto il rischio che il magistrato preferisca adottare in due righe e trenta secondi una decisione favorevole all’indagato o all’azienda, tanto più quando si tratti del sindaco, del mafioso o del facoltoso industriale o della grande fabbrica da lui gestita, piuttosto che studiare, faticare e trascurare affetti e vita privata, per arrestare costoro o disporre il sequestro dei loro beni, con il rischio di doversi poi difendere in un giudizio risarcitorio. Anche i magistrati, non suoni strano, hanno figli da mantenere, mutui da pagare ed affetti da coltivare».
Ci sta dicendo che la classe politica vuole paralizzare i giudici?
«È sicuramente la sua aspirazione inconfessabile, che le consentirebbe di ristabilire il suo primato: il quale non vorrei che fosse inteso, come purtroppo la cronaca tristemente insegna, come l’op - portunità di avere le mani il più possibile libere. Del resto, non credo di sbagliare se affermo che il ceto politico del nostro Paese, a tutti i livelli, non sia noto per la qualità delle sue leggi e dei suoi provvedimenti, quanto piuttosto per l'endemica diffusione della corruzione. Su questo aspetto, però, non mi sembra che il Governo ed il Parlamento avvertano l’urg enza di provvedere: a giudicare dalla loro agenda, infatti, parrebbe che il problema dello Stato italiano, quello per cui siamo noti al mondo, o almeno uno dei più drammatici ed urgenti, sia la dittatura dei giudici irresponsabili, e non invece la corruzione della politica e della pubblica amministrazione. Viene veramente difficile, allora, dissentire dall'amara considerazione che ho sentito in questi giorni da qualcuno: il quale, chiosando l'ennesimo tweet autocelebrativo del presidente del Consiglio, secondo cui la responsabilità civile dei magistrati è legge ha aggiunto: grazie al voto di tanti con responsabilità penale».
La trappola che impedisce di incastrare le toghe sulla responsabilità civile. I tre anni per il risarcimento si calcolano dall'arresto: così richieste impossibili, scrive Stefano Zurlo su "Il Giornale". Una legge sbandierata dal governo Renzi come una pagina di civiltà. Ma una dose di robusto scetticismo è d'obbligo dopo aver letto gli articoli della nuova norma sulla responsabilità civile dei magistrati, appena approvata dopo interminabili polemiche dentro e fuori il Palazzo. Scintille, scenari apocalittici, previsioni nefaste sul futuro delle toghe italiane. E invece trabocchetti e trappole ci sono ancora. Una in particolare: il termine entro cui si può fare causa è ancora troppo stretto per chi sia finito negli ingranaggi di una giustizia ingiusta. Il termine infatti aumenta, e questo è meritorio, da due a tre anni. Ma il triennio viene calcolato nello stesso modo in cui si conteggiava con la legge Vassalli: in pratica a partire dalla fase cautelare, delle manette. E non dopo il verdetto di assoluzione. Dunque, troppo presto, in una fase delicata e drammatica del procedimento in cui la causa al magistrato che abbia sbagliato è l'ultimo pensiero per l'inquisito che sta combattendo. E vuole solo dimostrare la propria innocenza: di conseguenza tiene un profilo basso, immaginando che una controdenuncia contro chi lo accusa possa diventare un boomerang. L'articolo chiave è il 4: «L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimento cautelari o sommari». Qualche riga dopo il legislatore aggiunge: «la domanda dev'essere effettuata a pena di decadenza entro tre anni». Eccoci al punto infiammato. È vero, gli anni non sono più due ma tre, e però l'ostacolo, che nessuno pare aver visto in Parlamento, è lì a bloccare il passaggio: il countdown comincia quando l'inchiesta è ancora in pieno svolgimento. Quando l'inquisito è ancora in carcere o ai domiciliari e magari dev'essere ancora rinviato a giudizio. Il linguaggio è tecnico e poco comprensibile per il profano, ma il senso è chiaro: il conto alla rovescia inizia nel momento in cui il provvedimento cautelare si cristallizza. Che vuol dire? Poniamo che l'indagato sia in carcere e continui a professarsi innocente. L'avvocato ha giocato la carta della scarcerazione prima al tribunale del riesame, poi in Cassazione. Ecco, la linea di partenza viene stabilita sul calendario il giorno in cui la suprema corte si è pronunciata su quel punto. Prima dell'eventuale condanna di primo grado. E dei successivi gradi di giudizio. Tutte queste fasi arriveranno nel tempo ma sappiamo come sia lenta, a volte quasi immobile, la nostra giustizia. E allora il legislatore, vecchio o nuovo fa poca differenza, detta una partitura che pare essere obiettivamente poco realistica. Perché costringe a venire allo scoperto nel momento meno opportuno. Spiega l'avvocato Francesco Murgia, storico difensore di Vittorio Emanuele di Savoia: «Ma io come faccio a iniziare un'azione di responsabilità civile contro un magistrato se sono ancora sotto scacco? Se il mio procedimento è ancora in corso e le accuse non sono cadute?». Un'osservazione semplice, di buonsenso, che però pare essere sparita nelle curve di un dibattimento appassionato. La nuova legge ha abolito, e non è poco, il filtro che prima bloccava gran parte dei procedimenti, e ha ritoccato alcuni punti, ma ha trascurato questo elemento. Prosegue Murgia: «Per intraprendere la causa contro il pm Henry John Woodcock e il gip Alberto Iannuzzi abbiamo dovuto attendere che il principale capo d'imputazione, l'associazione a delinquere, si afflosciasse. Purtroppo abbiamo dovuto pazientare a lungo, per anni e anni». Il testo in carta bollata è stato presentato il 9 dicembre 2011. Troppo tardi. Puntuale come un orologio svizzero è scattata la ghigliottina: «L'azione - scrivono i giudici di Catanzaro - è inammissibile perché non tempestiva con riguardo alla richiesta di applicazione della misura emanata da Woodcock il 29 maggio 2006 e all'ordinanza emanata dal gip Iannuzzi il 15 giugno 2006. Il termine biennale decorre quando non sia più possibile la rimozione dell'ordinanza del gip che ha disposto la misura cautelare». Oggi il termine è triennale ma il nocciolo del problema è ancora lì. La giustizia va di corsa. E non aspetta. Il principe dovrà accontentarsi dei 39mila euro incassati dopo la vittoria in un altro processo: quello per l'ingiusta detenzione. La responsabilità civile rischia di restare nel cassetto in cui è chiusa da quasi trent'anni.
Giustizia un pochino al chilo. Il caso di Vittorio Emanuele di Savoia e la finta riforma della giustizia che non è quello che appare, scrive Giorgio Mulè su Panorama. Ma quanto si erano divertiti giornali e televisioni con Vittorio Emanuele di Savoia! Fu una bisboccia editoriale fin da subito, da quando il comitato di accoglienza di telecamere e fotografi s’era schierato dall’una di notte davanti al carcere di Potenza. Lui era arrivato in Basilicata da Lecco dopo un viaggio di 13 ore poco prima che facesse alba e la scena fu piuttosto surreale: Sua Altezza stava stretto stretto sul sedile posteriore di una Punto argento con i giornali attaccati ai vetri. Era il giugno 2006. Le accuse erano di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al falso, associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Quattro giudici, tra Como e Roma, hanno assolto in altrettanti processi Vittorio Emanuele "perché il fatto non sussiste". Ora, dopo quasi dieci anni, lo Stato lo risarcirà con 40 mila euro per i giorni in cella da innocente. Ovviamente, come scrissero i cronisti, nel "corposo ordine di custodia cautelare" (sono sempre corposi gli ordini di arresto, fateci caso, mai anoressici) c’era qualche chilo abbondante di intercettazioni telefoniche. Decine di migliaia. Di ogni genere e tipo, piccanti al punto giusto. Sputtananti di sicuro. E poi volete mettere il gusto di mettere alla gogna un Savoia goffo, antipatico, sprezzante, saccente? Andò esattamente così. Ora che sappiamo che non un solo fatto tra quelli contestati sussisteva, che cosa capiterà ai magistrati che misero in piedi questo - è il caso di dire - gigantesco bordello? Nulla. Non pagheranno un centesimo e la loro carriera proseguirà senza macchia. E continuerà a essere così con la finta riforma della giustizia che il governo sta per varare all’insegna di quella consueta mancanza di coraggio che lo contraddistingue. Con le nuove regole sulla responsabilità civile (che dovrebbe consentire di rivalersi, seppur in minima parte, sui magistrati che sbagliano) Vittorio Emanuele dovrebbe dimostrare che da parte dei suoi persecutori ci fu "dolo o negligenza inescusabile", che fu cioè deliberatamente deciso dai pubblici ministeri di provocare un danno alla sua persona; che la stessa condotta l’ebbe il giudice che accolse la richiesta di custodia cautelare; che il medesimo spirito albergava tra i giudici del tribunale del riesame che gli negarono di espatriare. State ridendo? E fate bene. Anche perché chi dovrebbe decidere di accogliere la richiesta di risarcimento? Ma un giudice, che domande! Fa quasi tenerezza il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Perché è così naïf da avventurarsi nella spericolata dimostrazione del teorema secondo il quale si può essere incinta anche solo un pochetto. Il campo è quello delle correnti dei magistrati, che non sono equivalenti ai partiti ma molto, molto peggio. Queste correnti - cito Luciano Violante, a scanso di equivoci - "sono diventate luoghi in cui si costruiscono le carriere". Il ministro che cosa intende fare? "Diluire il peso, sterilizzare il sistema di lottizzazione al Csm in base alla corrente (ma allora è vero!!, ndr), e non al merito, ma non abolire le correnti del tutto". Ma come? "Eliminare le correnti è un errore. L’idea del giudice privo di convinzioni personali e culturali è un’idea positivistica o un’ipocrisia: ogni magistrato ha delle sue idee; e io credo" dice Orlando "che sia giusto che l’appartenenza a quelle idee sia esplicita e non nascosta, purché non formino pregiudizi". In lontananza s’ode il capo dello Stato affermare: "L’ordinamento della Repubblica esige che il magistrato sappia coniugare equità e imparzialità". Lo spieghi al ministro della Giustizia, per favore. Altrimenti saremo rovinati.
Pintor li chiamava «i mostri…», scrive “Il Garantista”. La corporazione dei magistrati italiani, impegnata oggi a divincolarsi dai lacci di una pur flebile futura responsabilità per le proprie azioni, è decisamente sopravvalutata. Da buon marxista che aveva in odio la giustizia di classe, la ipervalutava Luigi Pintor, che nel famoso corsivo “I Mostri” qualche decennio fa la dipingeva come «l’immagine stessa del privilegio e dell’arbitrio», la casta degli “intoccabili”. E le dava la dignità di soggetto politico (pur da rimettere al suo posto), il presidente Francesco Cossiga, il primo a capire quel che stava succedendo nei primi anni Novanta in Italia: la progressiva trasformazione dell’ordine giudiziario in potere. Un potere con la pretesa di svolgere una funzione morale, salvifica dell’intera società. Ma meritano i magistrati l’immagine che di loro si è costruita negli ultimi decenni? Sono un esercito “in lotta” contro le mafie e i delitti, o semplicemente una categoria di burocrati che troppo spesso si comportano come piccoli impiegati preoccupati per il proprio status? Oggi è chiaro che la corporazione è stata sopravvalutata. Non tanto per una sua intrinseca reale forza, quanto per la debolezza del potere politico, che prima si è suicidato abolendo l’immunità parlamentare (unico contrappeso all’autonomia e indipendenza della magistratura), poi ha sottovalutato la potenza del tintinnar di manette. Perché i magistrati, come scrisse allora Pintor, «dispongono del più illecito dei poteri, quello sulla libertà altrui». E quelli di loro che più l’hanno usato a piene mani, si sono in seguito fiondati nell’agone politico, pensando di poter continuare a svolgere lo stesso ruolo, senza capire che, privati del potere di manette, il potere non l’avevano più. Basterebbero gli esempi dei vari Di Pietro, Ingroia, De Magistris per capire quale sia la dimensione reale, il peso specifico, intellettuale e professionale, della corporazione. Ma quel che è successo nell’ultimo anno, con un premier che, pur non mostrando grande coraggio sul piano delle riforme, ha avuto comunque la spavalderia di dire “brr che paura” davanti allo spettro di uno sciopero delle toghe, è l’impietosa fotografia di una categoria più concentrata su se stessa che sulle grandi questioni della legalità. Sono tre le immagini su cui finalmente il “re” è apparso nudo, in vera crisi di nervi. Le vacanze, prima di tutto. Ogni cittadino sa che se ha l’occasione di entrare in un qualunque palazzo di giustizia dopo le tre del pomeriggio, lo trova pressoché deserto. Ma forse i cittadini non sapevano che i magistrati godono di 51 giorni di ferie ogni anno. E, in un’epoca gonfia di moralismi e invidie sociali come l’attuale, la notizia ha destato scandalo, e ancor di più ha infastidito l’opinione pubblica la caciara che le toghe hanno messo in piedi contro la riduzione delle loro vacanze ipotizzata dal governo Renzi. Gli “intoccabili” si sono ribellati come se fossero stati morsi dalla tarantola. E non osiamo pensare alla reazione che avrebbero se qualcuno ipotizzasse di ritoccare i loro stipendi. Ma a questo rimedierebbe, come ha già fatto per le alte cariche, la Corte Costituzionale. Non a caso composta di magistrati. Se sulle ferie abbiamo assistito a una battaglia alquanto singolare, perché pareva la rivendicazione di un gruppo impiegatizio che però protestava con il tono di un soggetto abituato al comando, la situazione si è fatta ancor più paradossale quando, come in questi giorni, qualcuno ha detto “chi rompe paga”. Nessun governo, nessun parlamento è riuscito finora ad applicare realmente il risultato di quel referendum sulla responsabilità civile dei magistrati che nel 1987 fu approvato con il 90% dei sì. Non c’è riuscito un bravo ministro come Vassalli, che ha ceduto subito sull’ipotesi di responsabilità diretta (paga lo Stato) e su quel filtro di ammissibilità del ricorso del cittadino che ha reso l’intera legge inutile. La corporazione vorrebbe oggi che le cose restassero così, cioè vorrebbe non pagare mai per i propri errori. Piace ad esempio che tutte le toghe le quali, in veste di accusatori o di giudici, hanno creato il “caso Tortora” e mille altri, non solo non paghino l’errore e le malefatte, ma che abbiano placidamente scalato per via burocratica i vertici della categoria. Carriere intoccabili e intoccate. Per la verità la riforma di oggi sulla responsabilità civile è di una timidezza da far arrossire. Ma la corporazione dei sopravvalutati si mostra ugualmente disperata. Proviamo a rimbalzare una loro abituale obiezione: se non avete magagne da nascondere, che paura avete? Se fate il vostro dovere, perché temete che chi sbaglia paghi? La terza foglia di fico dietro la quale si nasconde la debolezza della corporazione è il tema della prescrizione dei reati. Un altro punto di rivendicazione sempre attuale. È ovvio che un processo non può durare in eterno, è questione di rispetto per la vittima come per l’imputato. Ma i magistrati – in questo dimostrandosi veramente piccoli piccoli – non vorrebbero termini. Preferiscono prendersela comoda. E quando 200.000 reati all’anno non hanno un responsabile perché è scattata la prescrizione, i magistrati si affrettano a dire che è colpa di qualcun altro. E che quindi bisogna allungare i termini. Ma i cittadini lo sanno che il 70% dei reati si prescrive nel corso delle indagini preliminari, cioè quando il Pm e il Gip sono i domini dell’inchiesta e gli unici responsabili del ritardo? Vogliamo fare un referendum? Questi sono i temi che scaldano i cuori della corporazione dei sopravvalutati: la carriera, le vacanze, lo stipendio, la produttività del loro lavoro. E il presidente Mattarella dice che non devono essere burocrati? Ma quella è la loro pelle…
La caduta (parziale) degli Dei, scrive Piero Sansonetti su “Il Garantista”. Il segretario dell’Anm, il dottor Maurizio Carbone, dice che la riforma delle norme sulla responsabilità civile dei magistrati, approvata l’altro ieri dal Parlamento, «è un tentativo di normalizzare la magistratura». Lo ha dichiarato ieri, durante la conferenza stampa dell’ Anm, che è su tutte le furie per questa piccola riforma. Già: «normalizzare». Cioè rendere normale. Oggi la magistratura non è normale: è l’unica istituzione dello Stato ad essere al di sopra dello Stato, della legge, ad essere – nell’esercizio delle sue funzioni – immune dalla legge, e insindacabile, e non dipendente dallo Stato ma sovraordinata allo Stato. «Normalizzare» la magistratura, cioè toglierle la sua caratteristica di ”deità” (che non è la ”terzietà” di cui spesso l’Anm parla) non sarebbe una cosa cattiva. Libererebbe forse l’Italia da un sovrappeso ”feudale” che ancora ne condiziona profondamente la struttura democratica, e che probabilmente è in contrasto con lo spirito della Costituzione, che è una Costituzione Repubblicana e che prevede l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Alcuni magistrati dicono: ma noi siamo magistrati, non cittadini. E su questa base pretendono di non dover sottostare alla legge. Ritengono – temo in buona fede – che la saldezza di una società, e la sua moralità, e il suo essere ”società etica” (successivamente si passa all’idea dello ”Stato Etico”) non possono che essere affidati ad una entità e ad un gruppo di persone migliori degli altri (”aristoi”) i quali siano in grado di ”sapere” la vita degli altri, valutarla, giudicarla, punirla. Non è questa una funzione – pensano – che possa essere affidata alla democrazia, o al libero svolgimento delle relazioni umane e sociali, perché la democrazia è un buon sistema di governo ma è viziato da corruzione. E l’eccesso della libertà, della deregolamentazione, sono pericolose per la collettività. La democrazia deve essere ” corretta” , o comunque controllata, e anche la società, da qualcosa di superiore e di ”certamente morale” : e cioè da i giudici. Contestare questa funzione dei giudici vuol dire contestare la loro indipendenza. E mettere in discussione l’indipendenza dei giudici vuol dire correre il rischio che la magistratura finisca per non essere più autonoma dalla politica. L’autonomia dalla politica non è vista come una condizione di funzionamento della magistratura, o come un elemento necessario nell’equilibrio dei poteri, ma come un valore assoluto al quale una società ”morale” deve sottomettersi, e in assenza del quale la società diventa ”immorale” e la democrazia, e le istituzioni, scendono in una condizione di subalternità alla politica. La politica è ”il male” , la giustizia (lo dice la parola stessa) è il bene, e il bene può governare il male, e può redimerlo, correggerlo, sottometterlo. Il male non solo non può governare il bene, ma non può aspirare ad essere alla pari col bene. Ecco, questo ragionamento è alla base delle molte dichiarazioni rilasciate ieri dal dottor Carbone, e anche dal presidente dell’Anm Sabelli. Il quale ha rimproverato al governo di avere promesso una riforma della Giustizia in 12 punti, e di avere realizzato invece l’unico punto che non va bene, e cioè la riforma della responsabilità dei giudici. I magistrati invece – ha spiegato – vogliono cose diverse: per esempio la riduzione della prescrizione, l’estensione dei poteri speciali ”antimafia” anche ad altri reati, il processo telematico (cioè la cancellazione del diritto dell’imputato ad essere presente al suo processo), la riduzione dei gradi di giudizio, eccetera. In sostanza, la proposta dell’Anm (che più o meno è stata organicamente strutturata nella proposta di riforma del dottor Nicola Gratteri) è quella di escludere norme che riportino alla normalità la magistratura, ristabilendo la legittimità dello Stato liberale e dell’equilibrio dei poteri, ma, viceversa, decidere un forte aumento dei poteri della magistratura, un ridimensionamento drastico dei diritti dell’imputato, e un rafforzamento della condizione di preminenza e di insindacabilità dei pubblici ministeri. Sabelli ha anche annunciato che l’Anm ha chiesto un incontro al Presidente della Repubblica. Per dirgli cosa? Per esprimere le proprie rimostranze contro il Parlamento. Già nella richiesta dell’incontro c’è un elemento di scavalcamento dell’idea (puramente platonica in Italia) dell’indipendenza dei poteri. La magistratura ritiene che il suo compito non sia quello semplicemente di applicare le leggi, ma di condizionarne il progetto e la realizzazione. L’associazione magistrati chiede al Presidente della Repubblica di frenare, o condizionare, o rimproverare il Parlamento. E vuole discutere nel merito delle leggi. La magistratura considera inviolabile la propria indipendenza dagli altri poteri, e inaccettabile la pretesa di indipendenza degli altri poteri dalla magistratura. Devo dire che la passione con la quale i magistrati hanno reagito alla miniriforma della responsabilità civile mi ha colpito soprattutto per una ragione: questa riforma è quasi esclusivamente simbolica. La responsabilità dei giudici resta limitatissima. L’unica vera novità è la rimozione del filtro che in questi vent’anni aveva permesso solo a 4 cittadini di ottenere un risarcimento per la mala-giustizia (nello stesso periodo sono stati processati e condannati 600.000 medici). Tutte le altre barriere restano. I magistrati saranno giudicati solo in caso che sia accertata una colpa grave, o addirittura un dolo nel loro comportamento, saranno giudicati non da una autorità esterna ma dai loro colleghi (visto che oltretutto non esiste una divisione delle carriere) e se alla fine saranno ritenuti colpevoli pagheranno con una sanzione che in nessun caso potrà superare la metà dell’ammontare di un anno di stipendio. Voi conoscete qualche altra categoria professionale protetta fino a questo punto? La probabilità di essere condannati per i magistrati è così bassa, e l’esiguità della pena così forte, che chiunque può mettersi al riparo pagando una assicurazione con poche decine di euro. Cosa che non vale per i medici, o gli ingegneri (non parliamo dei giornalisti) che essendo espostissimi al rischio di condanna (anche senza dolo e senza colpa grave) se vogliono sottoscrivere una assicurazione devono pagare migliaia e migliaia di euro. Diciamo che il privilegio non è affatto toccato da questa riformetta. Appena appena scalfito. E allora? Il fatto è che comunque la riforma ha un valore ideale, è una specie di metafora. Il Parlamento, per una volta, non si è inginocchiato davanti alla magistratura. E’ questa la novità che ha messo in allarme i settori più corporativi della magistratura. Il timore è che davvero possa cambiare il clima politico e possa essere aperta una via alle riforme vere, e al ridimensionamento della ”Divina Giustizia”. No, la riforma non comporterà la caduta degli Dei. Solo che gli Dei non sopportano gli oltraggi. Sono permalosi. E’ sempre stato così, dai tempi di Omero. E questa legge è uno sberleffo inaccettabile, anche se innocuo.
POTENTE UGUALE IMPUNITO.
In Italia potente è uguale a impunito. Solo undici persone sono in carcere per corruzione. Perché le inchieste vengono cancellate in massa dalla prescrizione. E così i colletti bianchi non pagano mai per i reati che commettono, scrivono Lirio Abbate e Paolo Biondani su “L’Espresso”. Gong, tempo scaduto: il reato c’è, l’imputato lo ha commesso, ma il processo è durato troppo, per cui il colpevole ha diritto di restare impunito. Nel gergo dei tribunali si chiama prescrizione. È il termine massimo concesso dalla legge per condannare chi ha commesso un reato. In teoria è una nobile garanzia: serve a evitare che uno Stato autoritario possa riesumare accuse del lontano passato e perseguitare i cittadini con processi infiniti. Il guaio è che in tutti i Paesi civili la prescrizione è un evento eccezionale, mentre in Italia è diventata la regola per intere categorie di reati. Una scappatoia legale che premia soprattutto gli imputati eccellenti e la criminalità dei colletti bianchi. E nega giustizia al popolo delle vittime dei reati. E provoca pure danni alle casse dello Stato: le somme, in molti casi si parla di decine di milioni di euro, sequestrati agli imputati in fase di indagine perché ritenute provento della corruzione o concussione, una volta dichiarato prescritto il reato devono essere restituite agli “illegittimi” proprietari. E così, grazie alle leggi-vergogna sulla prescrizione, le tante caste, cricche, logge o lobby della politica e dell’economia possono continuare a rubare. Mentre restano senza giustizia i cittadini danneggiati da truffe, raggiri finanziari, evasioni fiscali o previdenziali, corruzioni, appalti truccati, scandali sanitari, omicidi colposi, traffici di rifiuti pericolosi, disastri ambientali, morti sul lavoro, violenze in famiglia, perfino abusi sui bambini. «L’Italia è l’unico Paese del mondo in cui la prescrizione continua a decorrere per tutti e tre i gradi di giudizio», è la diagnosi tecnica di Piercamillo Davigo, l’ex pm di Mani Pulite che oggi è giudice di Cassazione: «All’estero di regola il conteggio si ferma con il rinvio a giudizio o al massimo con la sentenza di primo grado, dopo di che non si prescrive più niente. Da noi invece il colpevole può farla franca anche se è già stato condannato in primo e secondo grado e perfino se è l’unico a fare ricorso, quindi è proprio lui ad allungare la durata del processo. Quando proviamo a spiegarlo ai magistrati stranieri, non riescono a capacitarsene: “Che senso ha?”». Il senso di questa anomalia italiana è una massiccia impunità: solo nell’ultimo anno giudiziario, come ha detto il primo presidente della Cassazione invocando una «riforma delle riforme», sono stati annientati dalla prescrizione ben 128 mila processi penali. Come dire che in Italia, ogni giorno, evitano la condanna almeno 350 colpevoli di altrettanti reati. La prescrizione facile è da decenni un vizio nazionale: basti pensare che i processi di Mani Pulite, nati dalle storiche indagini milanesi del 1992-1994, si erano chiusi con un bilancio finale di 1.233 condanne, 429 assoluzioni e ben 423 prescrizioni. Già ai tempi di Tangentopoli, insomma, il 20 per cento dei colpevoli riusciva a beffare la giustizia. Invece di risolvere il problema, le cosiddette riforme dell’ultimo ventennio lo hanno aggravato. Il tasso di impunità è salito alle stelle, in particolare, con la legge ex Cirielli, approvata nel 2005 dal centrodestra berlusconiano, che ha reso ancora più breve la via della prescrizione: termini dimezzati, applicazione automatica, obbligo per i giudici di concederla per ogni singolo reato, anche se il colpevole ha continuato a commetterne altri. E così, mentre la crisi economica spinge molti Stati occidentali a punire severamente i reati finanziari e il malaffare politico, in Italia i più ricchi e potenti riescono quasi sempre a sfuggire alla condanna. A documentarlo sono i dati del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria (aggiornati al novembre 2013), raccolti in esclusiva da “l’Espresso”: sugli oltre 60 mila detenuti si contano soltanto 11 accusati per corruzione, 26 per concussione, 46 per peculato (cioè per furto di denaro pubblico), 27 per abuso d’ufficio aggravato. In Germania per reati economici finanziari vi sono in cella 8.600 detenuti. Di fronte all’enormità di un’evasione stimata nel nostro Paese di 180 miliardi di euro all’anno, in cella per frode fiscale ci sono soltanto 168 persone e appena tre arrestati per reati societari o falso in bilancio. La prescrizione all’italiana ha salvato centinaia di imputati eccellenti. L’elenco è interminabile, ma il re delle prescrizioni è sicuramente Silvio Berlusconi, che i giudici hanno dovuto dichiarare «non più punibile» prima per le tangenti a Bettino Craxi, per la corruzione giudiziaria della Mondadori (danni accertati per 494 milioni di euro) e per i colossali falsi in bilancio della Fininvest (caso All Iberian, fondi neri per 1.550 miliardi di lire) e poi, proprio grazie alla legge ex Cirielli approvata dalla sua maggioranza, per le mazzette da 600 mila dollari versate al testimone inglese David Mills, in cambio del silenzio sui conti offshore del Cavaliere. Che ora attende che si prescriva in appello anche la condanna per il caso dell’intercettazione trafugata nel dicembre 2005 per screditare il suo avversario politico Piero Fassino. Persino la prima condanna definitiva di Berlusconi per frode fiscale, quella che gli è costata il seggio in parlamento, è stata ridimensionata dalla prescrizione: le sentenze considerano pienamente provata un’evasione da 368 milioni di dollari, ma la ex Cirielli ha lasciato sopravvivere solo l’ultimo pezzetto di reato, per cui l’ex premier ora deve versare all’Agenzia delle Entrate solo dieci milioni. A sinistra, il miracolato più in vista è Filippo Penati, ex capo della segreteria del Pd: accusato di aver intascato tangenti per oltre due milioni di euro, aveva detto di voler rinunciare alla prescrizione, ma poi non l’ha fatto, e ora resta sotto processo solo per le accuse più recenti e difficili da dimostrare. Tra i big della finanza, autostrade e costruzioni, spicca il caso di Fabrizio Palenzona, che si è visto annullare l’accusa di aver intascato almeno un milione di euro su una rete di conti di famiglia tra Svizzera e Montecarlo, mai dichiarati al fisco e scoperti grazie alle indagini sulle scalate bancarie del 2005. Nel mondo della sanità, la sparizione dei primi reati, provocata dalla solita ex Cirielli, ha fatto tornare in libertà perfino il chirurgo della “clinica degli orrori” Pierpaolo Brega Massone, nonostante la condanna a 15 anni e mezzo. Nel pianeta giustizia, la prescrizione ha salvato l’ex giudice romano arrestato per tangenti Renato Squillante e altri magistrati con i conti all’estero. Tra i casi più recenti c’è la prescrizione ottenuta dal costruttore della “cricca” Diego Anemone per i famosi finanziamenti illeciti versati all’insaputa dell’ex ministro Claudio Scajola, che a sua volta è stato assolto nonostante siano stati usati per l’acquisto della sua casa romana. Mentre l’ex governatore del Molise, Michele Iorio, si è visto cancellare solo in Cassazione la condanna a 18 mesi per abuso d’ufficio e ora può tornare a fare politica nella sua regione. Verso la prescrizione si avviano molti altri scandali come le frodi milionarie di “Lady Asl” alla sanità laziale, le grandi truffe sui farmaci, i danni subiti da migliaia di risparmiatori con i famigerati bond-spazzatura della Cirio. La prescrizione facile, in sostanza, costringe la giustizia italiana, già rallentata da mille cavilli e inefficienze, a una corsa contro il tempo che per molti reati è perduta in partenza. E a truccare l’orologio a favore dei colpevoli sono proprio leggi come la ex Cirielli. Per capire quanto siano ingiusti e spesso drammatici gli effetti della prescrizione all’italiana, basterebbe che i politici legislatori non ascoltassero solo gli avvocati-deputati degli inquisiti, ma anche le vittime dei reati. «Mi chiamo Roberto Bicego, ho 66 anni, sono il primo paziente veneto a cui il luminare della cardiochirurgia Dino Casarotto aveva impiantato, nel novembre del 2000, una valvola-killer brasiliana, così chiamata perché scoppiava nel cuore dei pazienti. Quando si è saputo che aveva preso le tangenti dalle aziende fornitrici, il professore è stato arrestato e condannato in primo grado, ma non ha mai confessato niente, non ha chiesto scusa a noi malati, non ha risarcito nulla e in appello ha ottenuto la prescrizione. Io ho perso il lavoro, la salute, la tranquillità, ancora oggi ho dolori al torace. Il tribunale aveva accolto le richieste dei nostri legali, Giovanni e Jacopo Barcati, e ci aveva concesso un risarcimento provvisorio di 50 mila euro. Ma dopo la sentenza d’appello la direzione dell’ospedale di Padova ci ha intimato di restituirli con gli interessi. Adesso siamo noi a dover pagare i danni: roba da matti». «Sono Giovanni Tomasi, figlio di Clara Agusti, che ha 74 anni e non può muoversi da casa. I medici dicono che mia madre ha subito troppe operazioni, per cui non può più sostituire le sue due valvole cardiache, anche se una è difettosa. Facendosi corrompere, è come se il chirurgo l’avesse condannata a morte. Eppure anche lei ha ricevuto questo decreto ingiuntivo che le impone di risarcire l’ospedale. Ma che giustizia è questa?». Condanna a morte non è un modo di dire: dei 29 malati di cuore che si erano costituiti parte civile nel processo di Padova, solo uno aveva rifiutato di rioperarsi: «È morto durante il processo, il giorno dopo una visita di controllo. Gli hanno trovato pezzi della valvola-killer in tutto il corpo». «Sono Emanuela Varini, la moglie di Annuario Santi, che era un po’ il simbolo delle tante vittime di quelle valvole perché era rimasto paralizzato e seguiva tutte le udienze in carrozzella. Mio marito è morto nel 2008, non ha fatto in tempo a vedere che è finito tutto in prescrizione. Anche a Torino erano stati corrotti due chirurghi, ma hanno confessato e sono stati condannati: il professor Di Summa, quando ha visto mio marito in tribunale, è scoppiato a piangere e gli ha chiesto perdono. Il chirurgo di Padova invece non ha risarcito nessuno e dopo la prescrizione siamo ancora in causa con l’ospedale». A Roma sono cadute in prescrizione tutte le appropriazioni indebite che hanno svuotato le casse di 29 cooperative edilizie che hanno lasciato senza casa circa 2.500 famiglie. L’ex dominus del “Consorzio Casa Lazio” e i suoi presunti complici restano sotto accusa soltanto per bancarotta, ma il processo, lungo e complicato come per tutti i fallimenti a catena, è ancora in primo grado e i risarcimenti restano un sogno. «Le vittime sono migliaia di poveracci che hanno pagato gli anticipi e sono rimasti senza casa», spiega un avvocato di parte civile, Fabio Belloni: «Ci sono molte giovani coppie che avevano impegnato la liquidazione dei genitori, operai e impiegati che hanno perso tutti i risparmi: il Comune ha dovuto aiutare gli sfrattati che erano finiti a dormire per strada. Centinaia di famiglie, dopo aver versato più di centomila euro ciascuna, ora hanno solo la proprietà di un prato in periferia, neppure edificabile». A Milano è ancora fermo in appello, dopo le prime condanne e molte prescrizioni, il processo per le massicce attività di spionaggio illegale compiute dalla divisione sicurezza del gruppo Pirelli-Telecom tra il 2001 e il 2007, con la complicità di ufficiali corrotti anche dei servizi segreti: almeno 550 operazioni di dossieraggio che hanno colpito 4200 persone e decine di società private o enti pubblici. Lo scandalo aveva spinto il Parlamento a imporre per legge la distruzione dei dossier ricattatori: obiettivo raggiunto per i politici spiati, ma non per la massa di lavoratori e cittadini che avevano già subito i danni. E così, la prima vittima conclamata della banda dei super-spioni, il signor D.T., ex dirigente licenziato ingiustamente dalla filiale italiana di una multinazionale americana, non ha mai avuto giustizia, anche se l’intera maxi-inchiesta era partita proprio dal suo caso: «Sono stato spiato per mesi da una squadra di poliziotti corrotti, che per screditarmi non hanno esitato a inventarsi una falsa inchiesta per pedofilia», ricorda D.T. con voce disperata. «Sono stato mobbizzato, perseguitato per due lunghissimi anni: il manager che aveva pagato quel dossier 65 mila euro, ha diffuso quelle calunnie in tutta l’azienda, quindi i colleghi che mi erano amici hanno cominciato a chiamarmi “anormale”, a farmi passare per folle... È stato un inferno, ho avuto un gravissimo esaurimento nervoso, da allora non ho più una vita normale. Ho saputo di essere stato spiato illegalmente solo quando il pm Fabio Napoleone ha trovato la mia pratica: ero il dossier numero 323. Dopo l’arresto, le spie hanno confessato tutto, ma i poliziotti corrotti non sono stati nemmeno processati: era tutto prescritto già all’udienza preliminare. Ho perso il lavoro, la fiducia in me stesso, la serenità familiare e nessuno mi ha risarcito». La legge ex Cirielli favorisce anche i colpevoli di reati odiosi come le violenze contro i bambini. A Roma sono già caduti in prescrizione tre dei quattro processi aperti contro R.P., un padre degenere accusato di aver maltrattato e picchiato la moglie, arrivando a cacciarla da casa di notte con una neonata, in un drammatico quadro di abusi sessuali sulla figlia minorenne che lei aveva avuto nel precedente matrimonio. Condannato per tre volte in primo grado, l’uomo ha sempre ottenuto la prescrizione in appello. Nel quarto processo, il più grave, ora è imputato di violenza sessuale sulla ragazzina, nonché di averla sequestrata, alla vigilia della deposizione, per costringerla a ritrattare: tribunale e corte d’appello lo hanno condannato a quattro anni e otto mesi, ma l’udienza finale in Cassazione è stata rinviata per un difetto di notifica al prossimo marzo, quando rischia di essere tutto prescritto. «Al di là dei risarcimenti, le vittime dei reati hanno soprattutto un desiderio di giustizia che si vedono negare», spiega l’avvocata Cristina Michetelli. La ex Cirielli sta cancellando anche reati ambientali che minacciano intere comunità e compromettono la filiera alimentare. Della prescrizione facile hanno potuto beneficiare, tra gli altri, i diciannove inquisiti nella maxi-inchiesta sulle campagne avvelenate in Toscana e Lazio: sono imprenditori dello smaltimento, procacciatori d’affari e autotrasportatori che raccoglievano masse di rifiuti pericolosi, truccavano le carte, li riversavano negli impianti di compostaggio (rovinandoli) e poi li rivendevano come concimi da spargere nei terreni agricoli, che ora sono contaminati. In primo grado avevano subito condanne fino a quattro anni, con interdizione dalla professione, ma in appello la prescrizione ha cancellato anche i reati superstiti: ora sono tutti liberi e risultano incensurati, per cui possono tornare a fare il loro lavoro nel ciclo dei rifiuti. A completare il quadro dell’impunità, oltre alla prescrizione facile, sono le lacune normative che impongono di assolvere l’imputato che abbia commesso fatti considerati illeciti dai trattati internazionali, ma non dalle leggi in vigore in Italia. Un esempio per tutti: Francesco Corallo, il re delle slot machine del gruppo B-Plus-Atlantis, è riuscito a far cadere l’accusa, che lo aveva costretto alla latitanza, di aver pagato tangenti a un banchiere, Massimo Ponzellini, in cambio di prestiti per 148 milioni di euro: la Popolare di Milano infatti ha ritirato la querela, rendendo così impossibile processare entrambi per quella «corruzione privata». Anche i grandi evasori che nascondono montagne di soldi all’estero non vengono quasi mai perseguiti dall’Agenzia delle Entrate, perché le prove raccolte con le indagini penali fuori dai confini nazionali non possono essere utilizzate dal fisco italiano: tra i beneficiari di questo divieto, spiccano l’ex ministro Cesare Previti e i suoi colleghi avvocati condannati per corruzione di giudici. E fino a quando non diventerà reato l’auto-riciclaggio, non sarà possibile punire neppure i boss mafiosi che hanno nascosto o reinvestito le ricchezze ricavate con il racket delle estorsioni o i traffici di droga: il codice attuale infatti permette di incriminare solo eventuali complici esterni, ma non direttamente i padroni dei tesori criminali. Benvenuti in Italia, il Paese dell’impunità per i ricchi e potenti.
IL GIORNALISTA, SICURAMENTE FILO TOGHE, OMETTE DI DIRE CHE LA RESPONSABILITA' DEI TEMPI LUNGHI E' DELLE TOGHE.
E poi, il cittadino, quanto deve aspettare per avere giustizia e vedersi riconosciuta l'innocenza, sotto la mannaia perdurante della gogna aizzata da tesi giudiziarie strampalate?
E poi di chi ci dobbiamo fidare?!?
FIDARSI DELLE ISTITUZIONI. I CITTADINI: NO GRAZIE!! CHI CONTROLLA I CONTROLLORI?
Corruzione Gdf, Pm: «Nella Finanza sistema di tangenti», scrive “Il Messaggero”. Una macchina perfetta lubrificata dalle mazzette e messa in moto dagli ufficiali della Finanza. L’inchiesta della procura di Napoli, che due giorni fa ha portato all’arresto del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, Fabio Massimo Mendella, e all’iscrizione sul registro degli indagati del vicecomandante generale Vito Bardi, non riguarda un solo episodio di corruzione. E’ sul sistema che lavorano i pm, «sull’abitudine» con caratteristiche di «professionalità nel reato»: imprenditori disposti a pagare e militari, a tutti i livelli e senza soluzione di continuità, propensi a incassare. Da Emilio Spaziante, comandante in seconda del corpo arrestato per il Mose di Venezia, al suo successore, Vito Bardi. E a confermarlo ai pm sono anche alcuni alti ufficiali della Finanza. L’indagine è ancora ”coperta”: agli atti non ci sono soltanto le testimonianze dei fratelli Pizzicato, che hanno raccontato di avere pagato Mendella 15mila euro al mese (poi diventati 30) per evitare che gli accertamenti avessero conseguenze. Altri, come loro, hanno deciso di parlare. All’esame c’è anche la posizione di Achille D’Avanzo, il proprietario degli immobili adibiti a caserme, che ogni mese incassava il massimo dei canoni. La struttura del sistema, del quale Bardi avrebbe fatto parte, emerge con chiarezza dal decreto di perquisizione a carico di Bardi firmato dai pm Henry John Woodcock e Vincenzo Piscitelli. Si legge nel decreto che ieri ha portato proprio gli uomini della Finanza a perquisire gli uffici del capo: «Dalle indagini finora svolte è emerso lo stretto legame di ordine personale intercorso tra il colonnello Mendella, percettore di somme, illecitamente richieste asseritamente per sé e altri, e il generale Vito Bardi, attuale comandante in seconda della Guardia di Finanza. Diverse fonti testimoniali - di cui si omette allo stato il riferimento nominativo per ragioni di cautela processuale, potendo le stesse in ragione del ruolo rivestito da Bardi essere oggetto di iniziative inquinanti - hanno riferito sia dei rapporti di stretta vicinanza tra Mendella e Bardi, sia dei rapporti di familiarità di quest’ultimo con imprenditori partenopei (e non) a loro volta oggetto delle presenti e più ampie investigazioni». E ancora: «Tali ultime circostanze sono state riferite anche da appartenenti alla stessa Guardia di Finanza collocati ad alti livelli gerarchici sentiti come persone informate (di cui parimenti si omette il riferimento nominativo allo stato per le medesime ragioni in precedenza esposte). Altri soggetti hanno riferito di rapporti ispirati a richieste di favori di rilievo economico riguardanti Bardi, oggetto delle presenti investigazioni». All’esame dei pm sono finiti anche i canoni d’affitto pagati alla Solido Property dell’imprenditore napoletano Achille D’Avanzo, per alcuni immobili adibiti a caserme. In base alle risultanze, l’Ufficio tecnico erariale aveva fissato i canoni più bassi nelle tabelle di locazione ma, proprio Bardi, contrariamente alle indicazioni dell’Ute, avrebbe dato l’autorizzazione per pagare il prezzo massimo previsto. Inoltre, la sede della società di D’Avanzo, esattamente come quella dei fratelli Pizzicato, sarebbe stata spostata da Napoli a Roma in coincidenza con il trasferimento di Mendella. Gli avvocati dell’imprenditore, Roberto Guida, Luigi Petrillo e Luigi Pezzullo, precisano che «le società del gruppo di Achille D'Avanzo hanno sede in Roma dal settembre del 2004, epoca antecedente al trasferimento dell'ufficiale, che sarebbe avvenuto solo nel 2012». E aggiungono che la vicenda degli affitti era già stata oggetto di un’indagine chiusa con un’archiviazione. In realtà, l’inchiesta del 2012, poi archiviata, riguardava alcuni immobili che la società di D’avanzo aveva venduto a prezzi fuori mercato ai familiari dell'ex capo del Sismi Niccolò Pollari e del generale della Finanza Walter Cretella Lombardo.
Fiamme Gialle travolte dagli arresti ai vertici. Riemerge il caso: chi controlla i controllori? Alti ufficiali della Guardia di Finanza fermati, perquisiti e indagati che gettano ombre sull'impegno dei militari onesti. E, come venti anni fa, si ripropone il problema della prevenzione: come impedire che i funzionari corrotti facciano carriera, scrive Gianluca Di Feo su “L’Espresso”. Chi controlla i controllori? Per la seconda volta in pochi giorni, le istruttoria coinvolgono ufficiali di alto livello della Guardia di Finanza. Ieri è stato arrestato per corruzione il colonnello Fabio Massimo Mendella, attualmente comandante delle Fiamme Gialle a Livorno, ma soprattutto è stato perquisito l'ufficio del numero due del Corpo, il generale Vito Bardi, anche lui indagato. Non era mai successo prima. Il comando generale della Finanza non era stato perquisito nemmeno nella tempesta del 1994, quando Mani Pulite coinvolse decine di graduati e ufficiali che in Lombardia avevano alimentato un sistema di bustarelle. La scorsa settimana, la piena del Mose aveva investito con violenza l'istituzione. L'ex generale Emilio Spaziante è stato arrestato, con un'accusa ancora più grave delle bustarelle per chiudere un occhio sulle verifiche fiscali: secondo i magistrati avrebbe ottenuto oltre due milioni di euro per garantire alla macchina di quattrini veneziana la protezione dalle inchieste penali. Una circostanza mai accaduta durante la vecchia Tangentopoli. Con lui sono stati perquisiti Mario Forchetti, ex generale a tre stelle nominato garante per la trasparenza degli appalti Expo, e il colonnello Walter Manzon, ex comandante di Venezia: entrambi non risultano indagati. Spaziante è stata fino a pochi mesi fa una figura di primissimo piano, arrivata fino alla carica di capo di stato maggiore e comandante dell'Italia Centrale. Un ufficiale a dir poco discusso. Le intercettazioni del faccendiere Valter Lavitola avevano rivelato le pressioni nel 2009 su Silvio Berlusconi per farlo arrivare al vertice del Corpo. «No, non per fare il numero uno. Per fare una mediazione e lui fare il numero due», diceva Lavitola al premier: «La mediazione la sta facendo il ministro (dell'Economia Giulio Tremonti, ndr) ed è quasi fatta. Lei mi autorizzò a parlargliene. Lui mi ha detto che teneva tutto fermo fino a quando lei non si muoveva e noi si rischia il caso che da persone proprio amiche amiche amiche rischiamo insomma quanto meno che gli diventiamo antipatici». Il generale Vito Bardi, comandante in seconda della Guardia di finanza indagato per corruzione, intervistato a Bari nel 2012 spiega i principi del finanziere modello: ''Un cittadino non avulso dal contesto che lo circonda, di sani principi e pronto ad affrontare le difficoltà'' (immagini da AntennaSud). Nonostante questo, Spaziante è riuscito nel 2013 ad arrivare alla poltrona caldeggiata da Lavitola, grazie agli automatismi che regolano le carriere. Poco dopo è esplosa un'altra inchiesta, questa volta della procura antimafia di Roma, che ha registrato gli interventi sull'ufficiale di un'industriale di Ostia per ottenere un documento, con cui realizzare un falso e farsi assegnare un bene demaniale. Una vicenda in cui compariva anche un ruolo dello studio professionale di Giulio Tremonti, chiamato a mediare su un finanziamento da 100 milioni di euro che doveva essere stanziato da Unipol. Guarda caso, la stessa società da cui pochi mesi fa Spaziante ha ottenuto una consulenza dopo avere lasciato l'uniforme. Adesso l'ex generale è agli arresti. Secondo gli accertamenti, condotti dalle stesse Fiamme Gialle, Spaziante e la sua convivente hanno complessivamente dichiarato entrate per poco più di 2 milioni di euro, mentre sono state scoperte uscite pari a quasi 3,8 milioni. Scrivono i pm: «In questo caso emerge inequivocabile l’elevatissimo tenore di vita. Dalla scheda patrimoniale risultano auto sportive, barche di lusso, villa con piscina, prestigiosi immobili, nonché la frequentazione di costosissimi alberghi per i suoi spostamenti in Italia. Soggiorni settimanali a Milano in hotel da mille euro a notte». E durante le perquisizioni nella residenza della sua convivente, gli investigatori hanno trovato 200 mila euro con banconote sporche di terra che sembravano essere state appena dissepolte. La correttezza dell'istituzione non viene messa in discussione. Sono i militari delle Fiamme Gialle a condurre le istruttorie più delicate del momento. Ed è stato proprio un ufficiale, il colonnello Renato Nisi, a impedire che Spaziante venisse a conoscenza della rete di microspie che hanno smascherato la ragnatela di tangenti dell'Expo. Anche il procuratore capo di Napoli, Giovanni Colangelo, che ha ordinato la perquisizione nel comando generale, ha detto: «Confermiamo l'assoluta fiducia nel lavoro della Guardia di Finanza, ovviamente a partire dai suoi vertici». Gli ultimi sviluppi mostrano però con chiarezza l'esistenza di un problema di prevenzione, che riguarda tutta la pubblica amministrazione. Quali strumenti esistono per impedire che la corruzione dilaghi? La questione era stata posta venti anni fa, quando Mani Pulite aveva fatto finire in carcere decine di militari e di funzionari degli uffici fiscali. Allora erano stati proposti organismi di controllo, banche dati sui beni e altre iniziative, rimaste lettera morta. E adesso tutto si ripropone. Uno dei punti chiave, che anche in questo caso riguarda l'intera pubblica amministrazione, è l'assenza di efficaci meccanismi disciplinari per valutare il comportamento dei funzionari. Prima delle sentenza definitiva, non vengono quasi mai presi provvedimenti. Ma il verdetto della Cassazione arriva dopo parecchi anni e la prescrizione cancella quasi sempre le ipotesi di reato per i colletti bianchi. Come ha evidenziato due mesi fa un'inchiesta de “l'Espresso”, in Italia l'impunità per la corruzione è praticamente garantita. E nel frattempo le carriere proseguono, fino ai piani più alti delle istituzioni. Figure come Spaziante o come Bardi erano già state segnalate a vario titolo in diverse istruttorie: nell'estate 2011 entrambi erano citati nelle intercettazioni sulla cosiddetta P4. All'epoca i pm avevano ricostruito una fuga di notizie sulle indagini, che aveva permesso di mettere in guardia Gianni Bisignani, uomo chiave del potere romano. Ma non c'erano state ripercussioni. Così come nulla è stato fatto per arginare le frequentazioni molto interessate tra ufficiali e politici, in quella commistione tra affari e nomine che è diventata il pilastro della nuova Tangentopoli, da Milano a Venezia. Ora è necessario che questa nuova lezione si trasformi in misure concrete, per evitare che accada ancora. E per impedire che la corruzione di pochi getti ombre sull'attività di centinaia di militari delle Fiamme Gialle, che tutti i giorni si impegnano con rigore e onestà per difendere quel che resta della legalità nel nostro Paese.
Gdf, indagato per corruzione il comandante in seconda Bardi. L’inchiesta della Procura di Napoli ha portato anche all’arresto del comandante di Livorno Mendella per presunte verifiche fiscali «pilotate» nel capoluogo partenopeo, scrive Fiorenza Sarzanini su “Il Corriere della Sera”. Indagato per corruzione il generale Vito Bardi, comandante in seconda della Guardia di Finanza. Si tratta dell’ultimo sviluppo dell’inchiesta che ha portato - nella mattinata di mercoledì- anche all’arresto del colonnello Fabio Massimo Mendella, comandante della Guardia di Finanza di Livorno accusato di aver percepito un milione di euro per «pilotare» verifiche fiscali favorendo alcune società di imprenditori «amici» quando era in servizio a Napoli. Bardi è sospettato di aver ricevuto parte di quella somma oltre ad alcuni regali e favori. Nell’ambito dell’inchiesta i pm di Napoli Piscitelli e Woodcock hanno disposto una perquisizione degli uffici di Bardinella sede del Comando generale della Gdf in viale XXI Aprile a Roma. Il colonnello Mendella - comandante provinciale della guardia di finanza di Livorno - è finito in carcere insieme a un commercialista napoletano Pietro de Riu. I reati ipotizzati dalla Procura di Napoli sono concorso in concussione per induzione e rivelazione del segreto d’ufficio. In particolare De Riu avrebbe incassato per conto di Mendella, responsabile del settore verifiche del Comando provinciale di Napoli dal 2006 al 2012, oltre un milione di euro per evitare verifiche ed accertamenti fiscali.
Bufera giudiziaria sulla Finanza. Arrestato per concussione il comandante Gdf di Livorno: tangenti in cambio di verifiche fiscali addomesticate. Indagato il generale Bardi. Il provvedimento a carico di Fabio Massimo Mendella nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli. Fermato anche il commercialista napoletano De Riu. Perquisiti gli uffici romani del numero due della Guardia di Finanza che risulterebbe sotto inchiesta per corruzione in vicende collaterali, scrivono Dario Del Porto e Conchita Sannino su “La Repubblica”. Tangenti in cambio di verifiche fiscali addomesticate. Finiscono in carcere l'attuale comandante provinciale della Finanza di Livorno, colonnello Fabio Massimo Mendella e il commercialista napoletano Pietro De Riu. Nell'inchiesta risulta indagato il generale Vito Bardi, numero due della Guardia di Finanza: i suoi uffici romani sono stati perquisiti. I pm Vincenzo Piscitelli ed Henry John Woodcock ipotizzano per gli arrestati il reato di concorso in concussione per induzione e di rivelazione del segreto d'ufficio. Per l'accusa, l'importo delle dazioni di denaro e di varie utilità incassate dagli indagati ammonta, in totale, ad un milione di euro. Somme che, è scritto in una nota della Procura di Napoli, sarebbero state "asseritamente richieste ed incassate da De Riu per conto di Mendella". I fatti, stando alle indagini condotte dalla Digos napoletana con la direzione centrale della polizia criminale e dai finanzieri del Comando provinciale partenopeo e della Tributaria di Roma, si riferiscono a rapporti intercorsi negli anni tra il 2006 e il 2012, quando Mendella era responsabile del settore Verifiche al comando provinciale di Napoli, e successivamente trasferito a Roma. A beneficiare dei presunti favori della Finanza sarebbero stati due fratelli imprenditori napoletani della società Gotha. Secondo la tesi accusatoria, il legame tra quel colonnello e quella società, saldata attraverso l'opera del commercialista, era così forte che quando il colonnello fu trasferito nella capitale, anche la Gotha cambiò sede, pur di continuare ad usufruire di quei vantaggi illeciti. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati perquisiti gli uffici del comandante in seconda della Guardia di Finanza, generale Vito Bardi, che risulterebbe indagato per corruzione in vicende collaterali. Il generale di corpo d'armata, in pratica il numero due del corpo, è subentrato al generale Emilio Spaziante che è andato in pensione ed è stato arrestato con l'accusa corruzione nell'ambito della maxi inchiesta sulle tangenti del Mose. Bardi, 63 anni, è originario di Potenza. Ha ricoperto, tra l'altro, l'incarico di comandante interregionale dell'Italia meridionale. Il procuratore capo di Napoli, Giovanni Colangelo, dopo una lunga telefonata con il comandante generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo, tiene a ribadire: "Confermiamo l'assoluta fiducia nel lavoro della Guardia di Finanza, ovviamente a partire dai suoi vertici, tanto che abbiamo affidato congiuntamente ad essa e alla Digos l'esecuzione delle misure, e l'attività integrativa continua ad essere svolta dalle Fiamme Gialle insieme all'ufficio della Digos". Tra gli episodi della vicenda giudiziaria viene riportata anche una festa in barca con Vip per Mendella. Il colonnello, nell'estate del 2006 partecipò alla festa di compleanno dell'imprenditore Paolo Graziano assieme ai calciatori Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro (i tre sono del tutto estranei alla vicenda; il solo Graziano è stato sentito come persona informata sui fatti). La festa si svolse sulla barca di Graziano, attuale presidente dell'Unione industriali di Napoli. La circostanza viene riferita dal gip Dario Gallo solo come elemento di riscontro delle dichiarazioni accusatorie dell'imprenditore Giovanni Pizzicato, che sarebbe stato indotto da Mendella a pagare somme di denaro per evitare verifiche ed accertamenti fiscali. Nell'estate del 2007, invece, sia Mendella, accompagnato dalla fidanzata, sia il commercialista De Riu avrebbero trascorso le vacanze in Sardegna a spese di Pizzicato. Trasferito da Napoli a Roma, il colonnello Mendella - dice l'inchiesta - suggerì agli imprenditori Giovanni e Francesco Pizzicato di trasferire nella capitale anche la loro società Gotha spa. Dopo appena due giorni dal trasferimento della società, l'ufficiale propose ai suoi superiori una nuova verifica fiscale, che necessitava di una specifica autorizzazione a derogare dagli ordinari criteri di competenza. L'autorizzazione giunse 24 ore dopo. La tempistica dell'operazione, sottolinea il gip, è un decisivo elemento di conferma dell'ipotesi accusatoria: in quella circostanza spuntò il coinvolgimento di "due generali". Anche le modalità di concessione della deroga appaiono sospette, dal momento che non fu interessato il comando generale della Guardia di Finanza ma solo quello provinciale, mentre nè nella richiesta nè nell'autorizzazione erano specificate le circostanze eccezionali per derogare dai criteri di competenza. Nella sua denuncia, l'imprenditore Giovanni Pizzicato ha riferito di avere appreso dal commercialista Pietro De Riu, anche lui arrestato oggi, che la verifica "aveva richiesto una speciale autorizzazione da parte di due generali, uno dei quali mi fu detto essere il generale Spaziante". In quella circostanza, De Riu chiese a Pizzicato 150.000 euro "perchè a suo dire erano stati coinvolti, data la natura straordinaria dell'iniziativa, i generali". Il generale della Gdf Emilio Spaziante, oggi in pensione, è stato arrestato la settimana scorsa nell'ambito dell'inchiesta sul Mose.
Terremoto Gdf: arresti, perquisizioni ed incredulità. Arrestato il comandante della Finanza di Livorno, Mendella, con l'accusa di concussione ed indagato il comandante in seconda Bardi a Roma per corruzione. Lo sgomento delle fiamme gialle, scrive Nadia Francalacci su “Panorama”. "...è davvero impossibile". Diverse telefonate, identico però il tono e quel filo di voce di chi davvero ha preso un pugno nello stomaco. Sono le reazioni (anonime) dei militari delle Fiamme gialle di Livorno dopo l'arresto del comandante provinciale della Guardia di Finanza Fabio Massimo Mendella, accusato di concorso in concussione nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli. Il colpo è davvero tremendo: in caserma, nella città di Livorno e anche a Roma. In pochi hanno voglia di parlare. Mendella era arrivato al comando provinciale livornese neanche un anno fa, nel luglio del 2013, guadagnandosi immediatamente la stima del personale. Anche alti ufficiali della Finanza, raggiunti telefonicamente da Panorama.it, manifestano stupore ed incredulità. Oltre ad una profonda tristezza e smarrimento: E' impossibile per Mendella e ancora di più per il generale Bardi. Sembra quasi una voglia di colpire il Corpo.. cosa pensano di trovare all'interno di un ufficio di un comandante in seconda che cambia continuamente..” Poi qualcuno prosegue: "Mai una voce su Mendella..non è mai stato un collega chiacchierato come a volte ci può essere". Infatti, mentre la Digos di Napoli stava arrestando il comandante di Livorno, la procura di Napoli stava effettuando una perquisizione, sempre nell’ambito della stessa indagine che ha portato all’arresto del colonnello, nell’ufficio del generale Vito Bardi, comandante in seconda della Guardia di Finanza presso il Comando generale in viale XXI Aprile a Roma. Il generale Bardi, al momento, risulterebbe indagato per corruzione. Ma perché il colonnello Mendella sarebbe finito in carcere? E perché perquisire le stanze del Comando Generale di Roma? Secondo i pm napoletani, Piscitelli e Woodcock, gli imprenditori partenopei avrebbero versato oltre un milione di euro tra il 2006 ed il 2012 al commercialista Pietro De Riu, anche lui finito in manette questa mattina, che faceva da tramite con il responsabile verifiche ed accertamenti del Comando provinciale Guardia di Finanza di Napoli, ovvero il colonnello Fabio Massimo Mendella. Mendella, dopo sei anni nel capoluogo campano, fu trasferito dal Comando di Napoli a Roma. E in concomitanza con il suo trasferimento anche la holding "Gotha s.p.a.", oggetto di una verifica pilotata eseguita dall'ufficio coordinato dal colonnello, avrebbe trasferito la propria sede legale nella Capitale. Se l’arresto del comandante di Livorno ha destato non poco stupore, meno “impatto”, tra alcuni finanzieri, ha avuto la notizia della perquisizione a carico del generale. Il generale Vito Bardi, infatti, non è nuovo alle vicende giudiziarie. Nel 2011 era stato indagato con le accuse di favoreggiamento e rivelazione di segreto nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta P4. L'anno successivo, tuttavia, la sua posizione fu archiviata dal gip su richiesta dello stesso pm Henry John Woodcock. Al centro dell'inchiesta era l'ex deputato del Pdl Alfonso Papa, per il quale ora e' in corso il processo. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'ex parlamentare riceveva notizie coperte da segreto su indagini in corso e se ne serviva per ricattare alcuni imprenditori dai quali riceveva cosi' denaro o altre utilita'. Nell'inchiesta era coinvolto anche l'uomo d'affari Luigi Bisignani che ha patteggiato la pena. Ma la tristezza di moltissimi alti ufficiali della Finanza è dettata anche dal susseguirsi, di accuse verso gli appartenenti al Corpo o graduati ormai in pensione. E’ il caso del generale Emilio Spaziante rientrato nella maxi inchiesta, pochi giorni fa, sulle tangenti del Mose, a Venezia. Emilio Spaziante, in qualità "di Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza" è stato arrestato perché "influiva in senso favorevole sulle verifiche fiscali e sui procedimenti penali aperti nei confronti del Consorzio Venezia Nuova" e avrebbe ricevuto dal presidente del Consorzio Giovanni Mazzacurati, in cambio, la promessa di 2 milioni e 500 mila euro. E' quanto stato scritto nell'ordinanza del gip dove si precisa anche che la somma versata fu poi di 500 mila euro divisa anche con Milanese e Meneguzzo. Le indagini della Procura di Napoli che hanno portato all'arresto di Mendella, sono state condotte dalla Digos partenopea con il contributo della Direzione centrale di Polizia criminale e anche del Comando Provinciale e del nucleo di Polizia tributaria della stessa Guardia di Finanza di Roma.
Ci sono imprenditori che collaborano, ma a parlare sono soprattutto ufficiali e sottufficiali, scrive Fiorenza Sarzanini su “Il Corriere della Sera”. Uomini della Guardia di Finanza che accusano i loro superiori di aver preso tangenti. E svelano al procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli e al sostituto Henry John Woodcock l’esistenza di un «sistema» di corruzione che ha già fatto finire in carcere il colonnello Fabio Massimo Mendella, mentre sono indagati il comandante in seconda Vito Bardi e il suo predecessore Emilio Spaziante, tuttora agli arresti per lo scandalo del Mose di Venezia. Non sono gli unici. Ci sono nomi ancora coperti, componenti di quella «rete» che avrebbe preteso soldi, vacanze, favori e forse, ma su questo i controlli sono tuttora in corso, appuntamenti con alcune escort. È l’ordine di perquisizione notificato ieri al generale a svelare gli elementi raccolti dai pubblici ministeri facendo emergere un quadro di testimonianze incrociate: «Dalle indagini finora svolte è emerso lo stretto legame di ordine personale intercorso tra il colonnello Mendella, percettore di somme illecitamente richieste asseritamente per sé ed altri, ed il generale Vito Bardi, attuale comandante in seconda della Guardia di Finanza. Diverse fonti testimoniali - di cui si omette allo stato il riferimento nominativo per ragioni di cautela processuale, potendo le stesse in ragione del ruolo rivestito da Bardi essere oggetto di iniziative inquinanti - hanno riferito sia dei rapporti di stretta vicinanza tra Mendella e Bardi, sia dei rapporti di familiarità di quest’ultimo con imprenditori partenopei (e non) a loro volta oggetto delle presenti e più ampie investigazioni. Tali ultime circostanze sono state riferite anche da appartenenti alla stessa Guardia di Finanza collocati ad alti livelli gerarchici sentiti come persone informate (di cui parimenti si omette il riferimento nominativo allo stato per le medesime ragioni in precedenza esposte). Altri soggetti hanno riferito di rapporti ispirati a richieste di favori di rilievo economico riguardanti Bardi, oggetto delle presenti investigazioni». Tra gli imprenditori interrogati c’è Achille D’Avanzo, in passato legato al generale Nicolò Pollari e poi molto vicino a Bardi. Sono soprattutto due le circostanze emerse dagli accertamenti affidati agli investigatori della Digos. Il primo riguarda l’affitto della caserma di Napoli dove ha sede il Comando provinciale delle Fiamme Gialle e altri stabili che l’immobiliarista avrebbe concesso proprio ai finanzieri. I canoni vengono fissati dall’Ufficio tecnico erariale, ma per questo caso si è deciso di fare un’eccezione. E dunque Bardi avrebbe stabilito di concedere all’amico il massimo possibile ottenendo una contropartita che sarebbe già stata svelata e sulla quale sarebbero tuttora in corso le verifiche. Ma a destare sospetto è anche la decisione presa dallo stesso D’Avanzo di spostare la sede di una delle sue società da Napoli a Roma proprio in seguito al trasferimento di Mendella nella capitale. Esattamente come accaduto per la «Gotha spa» dei fratelli Pizzicato che collaborano con i magistrati e hanno raccontato di aver ricevuto il suggerimento proprio dal colonnello. I difensori dell’imprenditore mettono le mani avanti sostenendo che «le società del gruppo hanno sede nella capitale sin dal 2004». Al fascicolo di inchiesta è stato allegato il verbale dell’imprenditore Mauro Velocci, già coinvolto insieme ad Angelo Capriotti nell’inchiesta sugli appalti all’estero gestiti dal faccendiere Valter Lavitola. Il 23 luglio scorso l’uomo viene interrogato da Woodcock e dichiara: «Mi chiedete se Capriotti mi abbia mai riferito di rapporti con ufficiali della Guardia di Finanza e di eventuali richieste avanzate da questi ultimi. Posso dire che intorno al 2006 Capriotti mi mandò negli uffici del generale Bardi per consegnargli un esposto denuncia. Ricordo che io e Capriotti andammo una prima volta insieme dal generale Bardi nel suo ufficio di Napoli e poi Capriotti mi mandò da solo sempre negli uffici del Comando regionale. In questa occasione prese una copia del mio esposto e mi disse che avrebbe seguito lui direttamente la vicenda, tuttavia non abbiamo saputo più nulla. Credo un anno dopo Capriotti mi disse che il generale Bardi gli aveva fatto delle richieste “strane” ovvero richieste di utilità, se non sbaglio riferite all’acquisto o alla locazione di un posto barca ad Ostia». L’8 marzo scorso viene intercettata una telefonata tra Mendella e un amico avvocato, Marco Campora. Il colonnello dovrebbe aver appreso di avere i telefoni sotto controllo e dunque usa il legale come tramite per incontrare il commercialista Pietro De Riu. Per questo i pubblici ministeri vogliono adesso accertare se l’incontro con la donna sia effettivamente avvenuto o se invece fosse una «finta» per mascherare invece un appuntamento.
Mendella : ué Marco! Ti chiamo dopo
Campora : no, no Fabio! Perché ti stavano aspettando
Mendella : ma chi?
Campora : no là ... quella ragazza che ti volevo presentare a piazza dei Martiri là, quindi ti aspetto un quarto d’ora
Mendella : no e non ce la faccio a venire. Oggi non ce la faccio
Campora : eh ... ma scusa questo ti ... cioè qua sta figa qua, ti sta aspettando Fabio
Mendella : non ce la faccio!
Campora : ... una figura di merda. Sta amica di Cristiana qua devi
Mendella : ma non ce la faccio dai, sto al Vomero!
Campora : e devi venire per forza, che cazzo! Cioè
Mendella : dai, non ce la posso fare. C’ho pure ... adesso è arrivata pure Catia
Campora : eh no e Fabio dai, vieni, vieni! Fammi sta cortesia perché ... vieni, vieni capisci... Perché questo mò ti vo
... ti voleva sc.. mò, qua ... se ti dico vieni è perché devi venire, insomma, capito? Sennò mica ti dicevo cazzate ... hai capito?
I soldi in contanti gli sarebbero stati consegnati nelle scatole dei telefonini cellulari, continua la Sarzanini. Ma evidentemente quei 30 mila euro al mese non bastavano. E allora il colonnello della Guardia di Finanza Fabio Massimo Mendella si faceva pagare anche le vacanze in Sardegna, oppure le gite in barca a Capri con i calciatori del Napoli. Atteggiamento spregiudicato che i magistrati di Napoli inseriscono in un vero e proprio «sistema» di corruzione che avrebbe avuto tra i referenti il generale Vito Bardi, comandante in seconda della Guardia di Finanza. Il sospetto degli inquirenti è che proprio a lui possa essere finita una parte dei soldi versati dai fratelli Pizzicato, amministratori della «Gotha spa» che si occupa di metalli e gestori di alcuni locali notturni napoletani per evitare le verifiche fiscali. Non è l’unico. Anche altri alti ufficiali tuttora in servizio - oltre all’ex numero due delle Fiamme Gialle Emilio Spaziante - potrebbero aver partecipato alla spartizione delle «mazzette» pagate dagli imprenditori. Un dubbio alimentato da quanto raccontato al procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli e al sostituto Henry John Woodcock proprio da Giovanni Pizzicato che sostiene di aver ricevuto anche notizie sulle indagini in corso, compresa la decisione «di mettere sotto controllo 42 utenze». «Fondi in Romania e Lituania». È il 14 novembre scorso quando l’imprenditore decide di collaborare. E dichiara: «Nel 2005 venni avvicinato da un mio collega Pietro Luigi De Riu e mi disse che sarebbe stato bene che per la mia attività incontrassi un suo amico, il maggiore Fabio Massimo Mendella, con il quale fu organizzata una cena presso uno dei locali che all’epoca gestivamo, “La Scalinatella” di Napoli... De Riu ci propose di trovare un accordo economico con Mendella, in misura proporzionale al volume d’affari della società. Mi fu detto che con 15 mila euro al mese avremmo potuto star tranquilli... Cominciai quindi a pagare, ma poi nel tempo i versamenti sono cresciuti a 20 mila e poi fino a 30 mila euro. Non abbiamo avuto mai alcun controllo generale o comunque mirato dalla Guardia di Finanza. Complessivamente avrò versato oltre l milione di euro. Questi versamenti sono stati tutti quanti effettuati a Napoli... in qualche circostanza io avevo messo i soldi contanti in una confezione di un cellulare richiedendo alle mie segretarie di consegnarli al dottor De Riu. L’ultimo dei pagamenti è avvenuto a settembre, ottobre del 2012. Il contante lo abbiamo ritirato in banca in Italia fino al 2011 più o meno, poi ho utilizzato somme che venivano prelevate dai conti presenti in Lituania e Bulgaria». «Soldi ai due generali». Fila tutto liscio, poi Mendella viene trasferito a Roma. Ma lì avrebbe trovato la soluzione: trasferire nella capitale la sede della «Gotha spa» in modo da poter far partire una verifica «pilotata». Racconta Pizzicato: «De Riu mi aveva detto che questa verifica per poter essere autorizzata, in quanto di competenza territoriale di altro Comando, aveva richiesto una speciale autorizzazione concessa da due generali, uno dei quali mi fu detto essere il generale Spaziante. De Riu mi disse anche che successivamente c’era stata una segnalazione da parte del colonnello Baldassari di Napoli. Quest’ultimo, poi trasferito anche lui a Roma, aveva segnalato questa anomalia richiedendo spiegazioni al Comando generale sul perché la verifica era stata aperta dal Comando di Roma. In proposito devo aggiungere che il De Riu, in relazione a questa verifica mi aveva richiesto la somma di euro 150 mila perché a suo dire erano stati coinvolti, data la natura straordinaria dell’iniziativa, i generali che avevano autorizzato la stessa. Io anche in questa occasione ritenni di dover pagare». In barca con i calciatori. Ci sono le «mazzette», ma anche gli svaghi. L’imprenditore ha svelato di aver «pagato nel 2007 una settimana di soggiorno al residence “Smeraldina” di Porto Rotondo dove alloggiarono sia il De Riu che il Mendella, che era con la sua compagna, e io, che ero presente, pagai tutte le cene della settimana». Ma anche di aver organizzato nel 2006 una gita «a Capri con il presidente degli industriali napoletani, Paolo Graziano, amico di Mendella, che festeggiava a bordo della sua barca il suo compleanno. La barca di Graziano era un Mangusta e a bordo della stessa c’era l’ex calciatore del Napoli Ciro Ferrara con la famiglia di Fabio Cannavaro, quest’ultimo a bordo della sua barca. La barca del Graziano fu da noi raggiunta con un gommone che era di proprietà di mio cugino, Sergio Reale. Noi partimmo da Ischia dove io ero con la mia barca, a bordo della quale c’era Mendella con la sua compagna, oltre De Riu con la sua fidanzata dell’epoca». Nell’ordinanza il giudice elenca gli elementi di riscontro ai viaggi. E poi allega le intercettazioni di conversazioni durante le quali il colonnello Mendella fa finta di incontrare «belle donne» quando invece vede il commercialista De Riu per farsi consegnare le tangenti.
AMMINISTRATORI SOTTO ATTACCO.
Criminalità: ogni giorno vengono minacciati tre amministratori locali. I dati inquietanti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni. La regioni più colpita è la Sicilia. 132 omicidi di politici locali dal 1974 ad oggi, scrive Raffaello Binelli su “Il Giornale”. Ogni giorno tre amministratori vengono minacciati. Tra bombe, auto incendiate, aggressioni e minacce, più o meno pesanti, gli atti intimidatori contro sindaci, consiglieri e candidati sono stati 870 solo nel 2013. La situazione è peggiorata nei primi quattro mesi del 2014, con 395 casi, per un totale di 1.265, 80 al mese, quasi tre al giorno. Soltanto in 182 casi si è potuto risalire agli autori. Questi dati, insieme a molti altri, sono stati diffusi dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Il bilancio complessivo parla di 132 omicidi di politici locali dal 1974 ad oggi, più altri 11 che, a vario titolo, possono entrare in questo lungo elenco. Una vera e propria guerra strisciante. La regioni più colpita è la Sicilia, seguita da Puglia, Calabria e Sardegna. Sud ed Isole rappresentano il 63% di tutti i casi nazionali. Colpisce al nord il dato di Torino, 4,4% nella provincia, così come quello nell’area di Roma, 4%; in quella di Napoli il 5,3% dei casi. Quali sono le ragioni principali di questa criminalità? Non solo la mafia o motivi economici, nel nord-ovest sono prevalenti rispetto al resto dell’Italia le segnalazioni di possibili motivazioni legati al movimento antagonista, no Tav, no terzo valico, ecc. (76% dei casi) con il Piemonte che fa registrare il 56% degli episodi di questi tipi. "Il ruolo di amministratore nel Sud e nelle Isole comporta certamente maggiori pericoli che nel resto del paese anche se non bisogna dimenticare che le ultime due vittime in ordine di tempo erano amministratori di realtà del nord Italia, Laura Prati, sindaco di Cardano al Campo in provincia di Varese e Alberto Musy consigliere comunale di Torino", viene sottolineato nella relazione finale, approvata all’unanimità, che verrà presentato domani in Senato. L’obiettivo prevalente nelle azioni intimidatorie sono i sindaci, cui sono rivolte il 35% del totale degli episodi (446 casi). Dai dati forniti alla Commissione del Senato dalle prefetture, emerge che il 48% degli episodi si è verificato in Comuni di oltre 15 mila abitanti mentre un episodio su quattro in un piccolo comune (meno di 5.000 abitanti). Sardegna e Calabria sono le regioni dove sono più i casi in Comuni piccolissimi (meno di mille abitanti). La maggiore concentrazione di intimidazioni più gravi si è avuta in Puglia, dove si sono registrati i più numerosi episodi di auto incendiate (23%), incendi di beni privati (22%), il 38% dei casi con utilizzo di armi da fuoco e il 55% di utilizzo di ordigni esplosivi. In Sicilia si sono verificati il 25% dei casi di danneggiamento mentre la Campania ha il primato per le aggressioni (21%). La Commissione evidenzia inoltre «la vera cifra oscura del fenomeno, quello delle dimissioni, che con maggiore facilità sfuggono ad un accertamento cristallizzato: le dimissioni come effetto delle intimidazioni, del condizionamento pieno dell'attività politica ed amministrativa, e al riguardo non ci sono dati certi: ciò che è possibile acquisire con certezza è il dato medio annuo dei Comuni italiani disciolti anticipatamente a partire dal 1993 che è intorno al 2,5% con le punte massime che riguardano la Puglia (7,4%), la Campania (6,3%) e la Calabria (5,1%).
Amministratori e criminalità organizzata: 132 omicidi in 40 anni. Il rapporto della Commissione parlamentare d’Inchiesta: ma il fenomeno è più ampio di quanto denunciato e cresce, con la crisi la paura dei “lupi solitari”, scrive Dino Martirano su “Il Corriere della Sera”. Milleduecentosessantacinque atti intimidatori nei confronti di amministratori locali segnalati dalle 106 prefetture nel periodo gennaio 2013/ aprile 2014. 254 decreti di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose dal 1991 a oggi. 132 omicidi consumati negli ultimi 40 anni in danno di amministratori locali i carica e/o candidati alle elezioni amministrative. 70 casi emersi di dimissioni individuali o collettive di amministratori rassegnate negli ultimi 40 anni a seguito di atti di intimidazioni. 341 misure di protezione (scorte e tutele) nei confronti di amministratori locali minacciati. E ora, oltre alla guerra dichiarata dalla criminalità organizzata soprattutto nelle regioni del Sud, il fronte dei sindaci e degli assessori deve fare i conti anche con le minacce dei singoli che si scagliano contro i municipi a causa della crisi economica e del taglio della spesa per i servizi erogati ai cittadini. Ecco i numeri contenuti nella relazione approvata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali presieduta dalla senatrice del Partito democratico Doris Lo Moro. Il documento – 205 pagine – accende i riflettori sulla frontiera dei piccoli comuni italiani i cui amministratori sono oggetto di una crescente onda d’urto dai risvolti criminali ma, negli ultimi anni, legati anche alle crescenti difficoltà di bilancio in cui si trovano gli enti territoriali di tutti i livelli. Può succedere, dunque, che un sindaco riceva una lettera anonima accompagnata da un proiettile e chi indaga non riesca poi a decifrare la vera matrice della minaccia: criminalità organizzata, magari interessata agli appalti o al piano regolatore, oppure un “lupo solitario” deciso a farsi giustizia da solo perché convinto di avere subito un torto magari per un servizio non più erogato? La commissione presieduta dalla senatrice Lo Moro si è trovata di fronte anche “alla vera cifra oscura del fenomeno, quello delle dimissioni di tanti amministratori locali, che con maggiore facilità sfugge ad un accertamento cristallizzato: le dimissioni come effetto delle intimidazioni, del condizionamento pieno dell’attività politica ed amministrativa”. In realtà, in questo segmento del fenomeno, “non ci sono dati certi perché i motivi delle dimissioni possono essere mascherati da una cortina sufficientemente vasta e vaga sia quando sono personali che quando sono collettive. Difficile nascondere l’incendio di un bene, colpi d’arma da fuoco contro cose o persone, danneggiamenti, aggressioni. Forse è più semplice occultare una lettera minatoria, tacere di un dialogo o di una telefonata, dissimulare su una scritta murale”. Ma le dimissioni di sindaci, assessori e consiglieri messi sotto pressione possono essere “motivate come fatti personali, divergenze, politiche, persino come necessità di un ricambio di discontinuità”. I casi recenti più emblematici – legati a improvvise dimissioni dall’incarico di amministratori locali – hanno riguardato il sindaco di Sant’Agata di Esaro, dell’assessore alle Finanze del Comune di Aprilia, del vice sindaco di Rodi Garganico, del sindaco di Cerva, di amministratori locali di Cicciano e di San Lorenzo del Vallo, Il prefetto di Foggia, Latella, ha riferito i casi del comune di Orta Nova e di San Giovanni Rotondo. La commissione ha acquisito gli atti giudiziari dell’inchiesta “Deus” della procura di Reggio Calabria contro la cosca Rea di Rizziconi, riferita ai fatti verificatisi nel 2011 che, grazie alla testimonianza dell’ex sindaco Antonio Bartuccio, ha ricostruito come attraverso minacce e intimidazioni la cosca fosse riuscita a provocare le dimissioni dei consiglieri comunali e il conseguente scioglimento degli organi municipali. Il procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho , che ha definito un “eroe” l’ex sindaco Bartuccio, ha detto davanti alla commissione che “quella di Rizziconi “sono le manifestazioni effettive della situazione degli amministratori locali”. Elisabetta Tripodi, sindaca di Rosarno, ha poi spiegato un’altra modalità molto in voga in Calabria per spingere nell’angolo l’amministratore locale poco malleabile: “Hanno cercato di togliermi la maggioranza perché si può agire non solo con le intimidazioni ma anche dall’esterno, creando il vuoto all’interno dell’attività”. Il dato medio annuo dei comuni italiani sciolti per mafia a partire dal 1993 si attesta intorno al 2,5% mentre con punte massime che riguardano la Puglia (7,4%), la Campania (6,3%) e la Calabria (5,1%). Poco si sa invece sui cosnsigli e le giunte che cadono a causa delle dimissioni forzate a causa delle intimidazioni contro gli amministratori locali (il dato non viene scorporato dalle procure rispetto alle minacce subite da tutti gli altri cittadini). Per questo al commissione del Senato presieduta da Doris Lo Moro ha proposto nella sua relazione finale approvata il 26 febbraio scorso - che verrà presentata oggi a Palazzo Madama - propone l’istituzione di una banca dati presso il ministero dell’Interno e un monitoraggio costante sul fenomeno delle dimissioni individuali e collettive di sindaci e assessori in tutte le Regioni d’Italia.
Amministratori locali minacciati: quasi tre denunce al giorno. I dati forniti dalla Commissione d'inchiesta del Senato rivelano un fenomeno in costante crescita che non riguarda soltanto le regioni del Sud ma tutto il Paese. E smontano il pregiudizio generalizzato secondo cui "sono tutti collusi, implicati, compromessi". Aggressioni e intimidazioni non vengono più soltanto dalla criminalità organizzata, scrive invece Giuseppe Baldessarro su “La Repubblica”. Sparano contro il portone delle loro case, danno fuoco alle loro macchine, spediscono pallottole e messaggi di morte, li aspettano agli angoli delle strade per pestarli a sangue, minacciano le loro mogli e i figli. A volte li ammazzano. Nel 2013 si sono contati 870 diversi episodi, e il fenomeno è in crescita costante. Nei primi quattro mesi del 2014, infatti, gli amministratori locali finiti del mirino sono stati 395. In soli sedici mesi ci sono stati complessivamente 1.265 atti intimidatori nei confronti di sindaci, assessori, consiglieri comunali e dipendenti pubblici. Una media di 2,6 denunce al giorno. Sono questi i numeri messi assieme in dieci mesi di lavoro dalla Commissione d'inchiesta straordinaria del Senato sul "Fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali". Dati messi nero su bianco in una relazione che è stata approvata all'unanimità nei giorni scorsi, anticipata da Repubblica.it, che sarà illustrata ufficialmente dalla presidente Doris Lo Moro. Poco più di 200 pagine che analizzano segnalazioni, inchieste, denunce, o che sono il frutto di decine di audizioni nelle quali sono stati sentiti prefetti, magistrati, esponenti delle forze dell'ordine e le stesse vittime. Alla fine ne è emerso un quadro allarmante che non riguarda soltanto le regioni del Sud, ma che più in generale si va diffondendo a macchia d'olio in tutto il Paese. Ad essere interessati ben l'8% dei Comuni italiani, non soltanto piccoli municipi ma anche grandi città. L'Italia, secondo quanto emerge dalla relazione, dovrebbe essere più attenta rispetto a un fenomeno poco conosciuto. Scrive infatti la Commissione: "C'è un'altra storia dell'Italia. Una storia che attende ancora di essere scritta. Una storia sommersa fatta di nomi, di luoghi, di sofferenze, che ci appartiene per intero e che è giusto conoscere. E' quella delle centinaia di amministratori locali uccisi, feriti, intimiditi, minacciati, costretti a vivere sotto tutela oppure ad arrendersi di fronte a pressioni insostenibili". Il 35% delle minacce arriva ai sindaci, il 17% agli assessori, un altro 17% ai consiglieri comunali e poi, via via, tutti gli altri. Fino ai dirigenti delle municipalizzate o anche ai semplici dipendenti degli uffici. E', quella delle amministrazioni locali, una vera e propria frontiera, una trincea nella quale si combatte ogni giorno. Analizzando i dati si è scoperto che se è vero che in molti casi gli amministratori sono collusi, corrotti o complici, in moltissimi altri si dimostrano dei veri baluardi di legalità. "Il coraggio e l'integrità di molti amministratori - si legge nella relazione - sono stati offuscati da connivenze e complicità di altri, facendo prevalere un pregiudizio spesso generalizzato: tutti collusi, implicati, compromessi". In realtà esiste una bella politica, sia al Sud che al Nord, trasversale ai singoli partiti, fatta di uomini e donne che amministrano con coraggio e spesso in situazioni difficilissime. Non sono solo i Comuni del Sud ad essere sotto assedio. Alle tradizionali Sicilia, Calabria e Campania, si aggiungono i numeri inquietanti di Puglia, Sardegna, Lazio e, negli ultimi anni, il fenomeno è in forte espansione in Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte. Le regioni immuni sono solo tre (Friuli, Trentino, Molise). Per il resto è uno stillicidio. La relazione della Commissione d'inchiesta tiene conto solo di amministratori ed esclude, ad esempio, i politici di tutti i partiti che pure risultano essere nel mirino in più di una realtà. Tra l'altro si tratta soltanto dei casi denunciati, mentre il timore è che molti siano stati costretti, per paura, al silenzio. Non è un caso, dicono i commissari, che succeda di assistere a dimissioni di amministratori, o interi consigli comunali, senza apparenti ragioni. Inoltre, un tempo le aggressioni arrivavano quasi esclusivamente dalla criminalità organizzata. Ora invece, nel periodo di tempo preso in esame, è affiorato che solo il 13,7% dei casi sono chiaramente riconducibili al fenomeno mafioso. E il resto? Il resto delle aggressioni e delle intimidazioni sono figlie della volontà di "condizionare l'attività amministrativa" in termini più generali. Gli aggressori sono a volte disperati, bisognosi, gente che protesta e che vuole risposte immediate. E' insomma un fenomeno sociale complesso. E', in altri termini, la rabbia che esplode, improvvisa e violenta. Rabbia che viene indirizzato a chi lo Stato lo rappresenta sul territorio.
SINDACI IN TRINCEA. Un sindaco, Matteo Renzi, alla presidenza del Consiglio. Al suo fianco altri ex primi cittadini come Graziano Delrio e Maria Carmela Lanzetta. Il "governo dei sindaci" riaccende i riflettori sulla figura dell'amministratore locale, primo punto di riferimento per i cittadini ormai esasperati dalla crisi e dalla burocrazia. Non c'è solo la criminalità organizzata a minacciare i municipi, sono ormai centinaia gli episodi di violenza commessi da persone comuni. E ora c'è chi chiede che il Parlamento vari una Commissione d'inchiesta sul fenomeno. Dieci testimonianze di chi vive la politica in prima linea, scrive Anna Maria De Luca su “La Repubblica”. Non più "solo" nel mirino dei clan. Non più solo mafiosi a caccia di concessioni edilizie, di modifiche a piani regolatori, di appalti sui rifiuti. C'è chi entra nei Comuni armato di coltello o di acido, chi minaccia botte e ritorsioni: sindaci ed amministratori locali sono ora "sotto tiro" su molteplici fronti, sono diventati il potere più prossimo sul quale scaricare tensioni e rabbia. A Villaricca, in provincia di Napoli, dopo aver inveito contro il sindaco Francesco Gaudieri per la bolletta Tares, un uomo ha minacciato di buttarsi nel vuoto. A Lampedusa un disoccupato senza una gamba si è incatenato all'auto del sindaco e si è gettato addosso una tanica di benzina. In provincia di Macerata al sindaco di Colmurano, Ornella Formica, è arrivata una lettera con scritto: "Ti faccio tirare l'acido"; stessa minaccia in provincia di Ferrara per il sindaco di Jolanda di Savoia, Elisa Trombin. Nel bolognese, a Casalecchio un uomo con moglie e due figli a carico si è presentato in Comune con un accendino ed una tanica di benzina. E a Ceglie , il 2 gennaio un 52enne è salito sul tetto del Comune con in mano un estintore, minacciando di buttarsi giù perché voleva lavoro e una casa. La regione dove è più pericoloso fare il sindaco è sempre stata la Calabria che, da sola, rappresenta il 31% dei casi a livello nazionale, con una forte concentrazione a Reggio e a Crotone. Quest’anno però, per la prima volta, la Calabria cede il suo triste primato alla Puglia (è l’ultimo risultato dei dati che sta elaborando in questi giorni Avviso Pubblico, la rete di enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie). E' un fenomeno che dilaga in tutto il Paese. Così, se il 12 gennaio è toccato al sindaco di Cetraro (Cosenza), Giuseppe Aieta, trovarsi a casa due proiettili ed una seria minaccia, il 22 gennaio è stata la moglie del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, a trovarsi alla porta due sconosciuti con un messaggio ben preciso ("Dica a suo marito che vogliamo una casa e non le deve dare ai Rom"). Si calcolano circa 23 atti intimidatori al mese, uno ogni trentaquattro ore. E poi ci sono gli atti intimidatori indiretti cioè che colpiscono scuole, magazzini, mezzi ed altre strutture comunali (il 14% a livello nazionale). Ad Aprilia un assessore, Antonio Chiusolo, si è dimesso in seguito alle pesanti minacce e un consigliere comunale appena uscito dal Comune è stato preso a sprangate. “Ad agosto”, racconta a Repubblica l’ex assessore Chiusolo “hanno incendiato, davanti casa, la mia auto e quella di mio cognato che è referente provinciale di Libera; ad ottobre hanno minacciato di morte me e la mia famiglia; il 19 dicembre mi hanno fatto trovare, tra il cancello di casa e il portoncino, dieci pallottole calibro 9. A quel punto ho fatto la scelta, sofferta, di salvaguardare la mia famiglia e la mia persona e mi sono dimesso”. E che dire di Benestare, ancora in Calabria, dove al sindaco Rosario Rocca hanno bruciato l'auto? O del vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, che rifiuta le misure di tutela nonostante sia uno dei sindaci più pesantemente minacciati nel 2013? O, ancora, di Gianni Speranza, a Lamezia Terme, che vive costantemente a rischio?
Hanno ucciso il mestiere più bello, scrive Concita De Gregorio su “La Repubblica”. C’è stato un tempo, incredibilmente recente, in cui si diceva che fare il sindaco fosse il mestiere più bello del mondo, ed era vero. E' successo così pochi anni fa che se ci sforziamo ce lo ricordiamo ancora. Nelle piccole città, per esempio, nei paesi: nei luoghi dove eravamo nati e dove certe domeniche tornavamo. C’era qualcuno che era stato a scuola con noi, in un’altra sezione di un altro anno, o che era stato vent’anni fa fidanzato/a con qualcun altro che conoscevamo bene, o che era il figlio dell’Amelia la collega di nostra madre, ti ricordi l’Amelia?, e questo qualcuno adesso era il sindaco. Lo si incontrava per strada la mattina, buongiorno sindaco, si sorrideva con allegra ironia come a dire “sindaco, chi l’avrebbe detto…”, e lei o lui sempre, sempre passava mezz’ora a rispondere non puoi capire la bellezza di questo mestiere, il contatto con la realtà, la prossimità con le persone, la soddisfazione di essere utile, la certezza di poter davvero cambiare le cose, guarda la politica alla fine non c’entra, è un’altra storia questa, se ti ci metti davvero puoi fare, cambiare i destini. Fare bene, il bene. In buona fede, provando e magari sbagliando, ma fare. Qualcuno se lo ricorda? Io sì. Mi ricordo anche che era vero. Che un sindaco, il sindaco di una piccola o media o persino grande città, poteva davvero rovesciare il guanto e cambiare la storia. Potrei fare esempi, nomi. Quello che assegnò le case popolari. Quello che salvò la fabbrica dalla chiusura. Quello che fece il parco. Quello che si inventò il lungomare che non c’era. Quello che si gemellò con Chernobyl. Quella che riscattò le terre alla mafia. Ma sono storie di ieri, l’altro ieri. Qui parliamo di adesso. Adesso, oggi, in un lasso di tempo infinitesimale, fare il sindaco è diventata una condanna. Una sciagura. Sono passati gli anni, siamo cresciuti e poi invecchiati: non sono più i figli degli amici, ora. Sono gli amici. Sono loro ad aver affrontato campagne elettorali a dispetto dei partiti e averle vinte. Sono gente della nostra generazione, della nostra età che chiama e dice: è un inferno. Hanno scommesso tutto, hanno sgominato la diffidenza e il disincanto, hanno vinto. Bene, no? Malissimo, invece. Vi racconto un segreto. Ho un’amica cara, carissima, che quando le hanno chiesto – come a molti di noi nei paesi è successo – ti candidi? Ha detto sì, va bene provo. Ma guarda che c’è il ras della camorra (o delle tessere, degli affari, della massoneria, fate voi) ha detto va bene, provo. Ha vinto a dispetto di ogni previsione, perché la capacità delle persone di sperare ancora è illimitata e per meraviglia irragionevole. E' stata felice, ha fatto una grande festa, si è messa al lavoro. Due mesi dopo le hanno messo sotto sequestro i mutui bancari. Un importante leader politico da Roma l’ha chiamata per consigliarle di cercare un accordo con i mafiosi. Non l’ha fatto. Hanno minacciato suo figlio, a scuola: lo hanno isolato e deriso. Non l’ha fatto comunque. Hanno licenziato suo marito con l’occasione degli esuberi. Ha resistito ancora. Hanno fatto chiudere il negozio di suo padre triplicando l’affitto dei locali. Pazienza. Poi l’hanno messa nelle condizioni di non poter spendere un euro, perché per avere libertà di investire in nuovi progetti devi avere una disponibilità economica e se non hai il credito da Roma – dunque se non hai i favori di quel leader che ti consigliava come fare con la mafia – la spending review ti impedisce di fare la mensa all’asilo. Di conseguenza: rivolta dei genitori. Ti impedisce di sbloccare un pignoramento. Di conseguenza: rivolta degli abitanti del quartiere. Non puoi assumere chi merita. Di conseguenza: rivolta dei precari. Non puoi mettere a norma gli alloggi. Di conseguenza: rivolta di popolo. A sei mesi dalle elezioni, vinte a maggioranza assoluta, le hanno recapitato – i concittadini che, chissà, l’avevano votata – una busta piena di sterco. Le lettere anonime di minaccia arrivano ogni giorno a casa. Chiede: cosa rispondo, come reagisco. E' una trappola: ci mettono a fare qualcosa che poi ci impediscono di fare. E' un orribile inganno. E' vero, è così. E' questa l’origine ultima del disincanto verso la politica. Chiunque vada al governo, oggi, deve ricominciare da qui: i sindaci sono il primo bersaglio, il più prossimo, dei cittadini. Fare il sindaco non è solo un trampolino di lancio per la politica grande, non per tutti. Fare il sindaco è stare alla pari fra pari. Se non date loro i mezzi, voi che avete le mani sul quadro di comando, se vi approfittate della loro credibilità per avere voti e poi chiudete l’ossigeno state uccidendo la fiducia – l’ultima – nella politica. E' questo che state facendo? E poi cosa? Attenti, scherzate con l’ultimo fuoco.
Giochi e Scommesse. Giochi, Commissione intimidazioni amministratori locali sollecita legge organica, scrive “Il Velino”. È quanto emerso da Relazione approvata in Senato. "Settore attrattivo per organizzazioni criminali". Con riguardo alle problematicità emerse sul "gioco d’azzardo", si sollecita “un intervento legislativo coerente ed organico in materia”, che, oltre “alla implementazione delle misure per il contrasto delle ludopatie, attraverso forme di assistenza anche sanitaria delle persone affette, preveda pure meccanismi premiali per gli esercizi commerciali che rinunciano all'installazione di slot machines”. È quanto si legge in una delle osservazioni conclusive della Relazione approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali del Senato. Nell’ampia relazione della Commissione un capitolo è stato dedicato proprio al “mondo del gioco e il ruolo dell'ente locale”. “Nel corso delle audizioni e delle missioni svolte dalla Commissione è emerso che uno dei possibili moventi degli atti di intimidazione ai danni degli amministratori locali – si legge - può essere ravvisato nelle dinamiche e nelle richieste di autorizzazioni che si rendono necessarie per l’apertura di sale da gioco sul territorio e per l’installazione di apparecchi all’interno di esercizi commerciali pubblici. L’ordinamento vigente, nonostante i moniti della Corte costituzionale, non prevede una disciplina organica relativa al settore del gioco. La legislazione vigente – che, tra l’altro, assegna all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la gestione del comparto del gioco pubblico e la verifica degli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e tutti gli operatori legittimati ad operare – ha consentito sul territorio nazionale un crescente aumento della offerta di gioco d’azzardo, attraverso, da un lato, l’apertura di sale da gioco o di agenzie di scommesse e, dall’altro l’installazione di slot machines e di sistemi di videolottery all’interno degli esercizi commerciali. A questo, si aggiunge lo sviluppo del cosiddetto gioco d’azzardo on line, realizzato mediante l’attivazione di specifici siti internet, spesso collegati a server posizionati in paesi esteri la cui normativa tende a tutelare al massimo la privacy dei proprietari, rendendo in tal modo complesso il lavoro investigativo e di accertamento”. “La lucratività del mercato del gioco d’azzardo e la possibilità di utilizzare tali attività per il riciclaggio di denaro hanno reso tale settore evidentemente attrattivo per le organizzazioni criminali di stampo mafioso e in particolare della camorra e della ‘ndrangheta – si sottolinea nella relazione -. L’espansione del mercato del gioco d’azzardo ha poi determinato l’aumento dei casi di persone riconosciute affette da una nuova forma di dipendenza, denominata "Gioco d’azzardo patologico" (Gap). Di fronte a questo preoccupante scenario, aggravato dalla segnalata assenza di una legge nazionale organica in materia di regolamentazione del gioco d’azzardo, gli enti locali, privati di qualsiasi potestà di intervento diretto sul tema ma, allo stesso tempo, responsabili di una serie di atti amministrativi finalizzati alla concessione della licenza di apertura delle sale gioco, hanno cercato di far fronte alla situazione descritta intervenendo con delle misure di tipo amministrativo che, in diversi casi, sono state successivamente annullate dalla giustizia amministrativa. Emerge chiaramente, dunque, il consistente squilibrio tra le responsabilità formali in materia – dovute in buona misura alla competenza ad emanare una serie di atti endo-procedimentali – da una parte, e le competenze sostanziali che non permettono di decidere effettivamente sugli esiti dei vari procedimenti”. “In tale situazione, com’è intuibile, gli amministratori locali sono particolarmente esposti a pressioni e, altresì, a possibili intimidazioni e minacce, considerato che alcune loro decisioni vanno ad intaccare interessi finanziari, e non solo, particolarmente ingenti e delicati. Con riguardo alla attività di inchiesta il problema del gioco è emerso per la prima volta nel corso dell’audizione del Ministro per gli affari regionali, la quale, anche alla luce della sua diretta esperienza di sindaco, ha evidenziato come spesso l’amministratore locale venga minacciato a causa delle proprie scelte amministrative che possono consistere anche nel fare "la lotta alla lobby delle slot machine". Il ministro, inoltre, ha segnalato alla Commissione la situazione emblematica del comune di Pavia, dove al perseguimento da parte dell’amministrazione di politiche di contrasto al gioco d’azzardo, hanno fatto seguito gravi e reiterati episodi intimidatori ai danni degli amministratori. Successivamente nel corso del sopralluogo a Portici (NA), l’assessore al turismo e allo sviluppo, nel riferire in ordine alle possibili ragioni degli atti intimidatori subiti, ha segnalato le recenti iniziative portate avanti dal suo assessorato in Consiglio comunale e volte a contrastare il gioco d'azzardo. Ulteriori elementi per l’inquadramento del fenomeno sono stati acquisiti nel corso della missione svolta a Cardano al Campo (VA). In quella occasione, il sindaco di Corsico, nel dare conto delle numerose misure intraprese dal Comune - fra cui l’apposizione di ostacoli all’apertura, l’effettuazione di reiterati controlli e la chiusura di esercizi commerciali- per "impedire l'installazione di nuove sale giochi", ha sottolineato come proprio a tali interventi si ricolleghino gli atti minatori e le campagne diffamatorie subiti. L’audita, quindi, nel denunciare i costi in termini sociali connessi alle ludopatie, ha riferito del numero sempre più crescente di persone anziane e socialmente fragili che, impoverite dalla pratica del gioco d’azzardo, si rivolgono ai servizi sociali. Il sindaco poi ha rappresentato alla Commissione l’iniziativa intrapresa con le associazioni Legautonomie e a "Terre di Mezzo", che ha portato alla redazione del ""Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo". Documento questo, sottoscritto da più di 150 Comuni, con il quale gli amministratori chiedono di avere più poteri di programmazione, controllo e ordinanza per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo e limitare le conseguenze sociali sui territori che amministrano. Insieme al Manifesto, ha sottolineato l’audita, è stata lanciata anche una petizione finalizzata a chiedere al Parlamento l’approvazione di una legge quadro nazionale di iniziativa popolare sul gioco d’azzardo. Sempre nel corso della stessa missione, un’ulteriore preoccupazione, riguardante soprattutto la diffusione delle slot machine, è stata manifestata dall’assessore del Comune di Novara. L’ente ha emanato un’ordinanza che, a differenza di altre, ha superato il vaglio della giustizia amministrativa, con la quale sono state stabilite le distanze e gli orari di accensione delle macchinette da gioco. L’audita ha poi segnalato che il Comune, attraverso l’impiego degli agenti della polizia municipale e del personale dell’ufficio commercio, ha iniziato una mappatura delle slot machine presenti sul territorio svolgendo, contemporaneamente, dei controlli all’interno di alcuni esercizi pubblici insieme alla Guardia di Finanza. Inoltre, in collaborazione con l’ASL locale, ha riferito l’assessore, il Comune di Novara ha attivato un servizio di assistenza e un numero telefonico gratuito, funzionante durante il fine settimana, e specificamente dedicato alle persone malate, o che rischiano di ammalarsi, di ludopatie”. “Infine nell’ambito del sopralluogo in Emilia-Romagna, il questore di Bologna ha affermato che il gioco è il settore verso il quale si stanno spostando sempre di più gli interessi della criminalità organizzata. Inoltre, dalle testimonianze riportate dal questore di Piacenza, Calogero Germanà e dal questore vicario di Ravenna è emerso che nell’attività legata alla gestione del gioco d’azzardo vi sono fenomeni di infiltrazione mafiosa e l’organizzazione criminale più attiva è la ‘ndrangheta calabrese, la quale mette in campo una serie di attività di schermatura, tra le quali si rammentano l’utilizzo di prestanome dalla fedina penale pulita e il collocamento della sede fiscale dell’impresa in una provincia, mentre la successiva attività operativa si svolge nel territorio di una provincia limitrofa. I citati questori hanno altresì denunciato la difficoltà di comprendere il vissuto delle persone che si presentano negli uffici comunali e delle questure per chiedere le autorizzazioni necessarie per poter operare nel campo del gioco d’azzardo. Il responsabile dell'Area ricerca progettazione e valutazione su progetti sicurezza urbana e prevenzioni criminalità del Servizio politiche della sicurezza e della polizia locale della Regione Emilia-Romagna ha, infine, segnalato che, per cercare di ovviare alle problematicità connesse al gioco, una legge regionale del 5 luglio 2014 ha previsto l’istituzione - ad oggi non ancora realizzata - di un Osservatorio per il monitoraggio del fenomeno”.
DETENUTO SUICIDA IN CARCERE? UNO DI MENO!!!
"Uno in meno". Bufera per insulti su Fb. Capo Dap sospende 16 agenti, scrive “L’Ansa”. I commenti choc sono stati ospitati e poi cancellati sul profilo Facebook di un sindacato minore di polizia penitenziaria. "Un rumeno di meno" o ancora "Speriamo abbia sofferto". Sono i commenti shock al suicidio, l'ennesimo, in carcere di un detenuto in ergastolo, pubblicati (e poi cancellati) sulla pagina Facebook dell'Alsippe, un sindacato minore della polizia penitenziaria. Una vicenda che ha scatenato una bufera con una dura presa di posizione del ministro della Giustizia Andrea Orlando che ha parlato di "atti intollerabili" e ha convocato il capo del Dap. Il detenuto in questione, Ioan Gabriel Barbuta si è tolto la vita nel carcere milanese di Opera, dove si trovava in seguito a una condanna in appello all'ergastolo da parte della Corte d'assise di Venezia per aver ucciso, nel giugno del 2013, un vicino di casa durante una rapina finita male. Il capo del Dap, Santi Consolo, ha comunque immediatamente preso le distanze sottolineando di considerare i post "un'offesa al lavoro di tutti gli agenti che tutti i giorni sono impegnati a salvaguardare le persone che hanno in custodia". E dopo un colloquio con il ministro della Giustizia Orlando sospende alcuni agenti. "Ho firmato 16 provvedimenti cautelari di sospensione e ho concordato con il direttore del personale l'avvio del procedimento disciplinare" - ha annunciato -. Il capo del Dap non è entrato nel dettaglio delle possibili sanzioni per gli agenti, decisione che non compete a lui, perché come ha spiegato "sarà un organo terzo a decidere sulle sanzioni disciplinari". "Non si tratta - ha aggiunto il ministro della Giustizia Orlando, che insieme a Consolo ha tenuto una conferenza stampa - di un organo ad hoc, ma di una commissione disciplinare che interviene nel caso di rilievi". Consolo ha inoltre annunciato d'aver trasmesso gli atti alla procura: "Ho trasmesso un rapporto corposo predisposto dal nucleo investigativo centrale all'autorità giudiziaria perché faccia le sue valutazioni: se ci sono reati questa amministrazione si costituirà parte civile per danno all'immagine". Rispetto alla possibilità che nei comportamenti degli agenti possa esserci un rilievo penale e che possa essere contestato il reato di istigazione al suicidio, Consolo si è limitato a specificare che queste sono valutazioni che spettano ai magistrati. Quanto al fatto che tra i 16 agenti per cui è partito il provvedimento di sospensione ci siano anche appartenenti a organizzazioni sindacali del Corpo, Consolo ha precisato che gli accertamenti in questo senso sono appena iniziati e ancora in corso. L'organismo del Ministero da cui dipende la Polizia penitenziaria ha già avviato un'inchiesta interna per accertare che gli autori degli insulti siano davvero dei poliziotti e assicura che, in caso positivo, scatteranno le dovute sanzioni dal momento che la faccenda è ritenuta una "follia intollerabile". Prende le parti degli agenti il leader leghista Matteo Salvini: "conoscendo quali sono le condizioni in cui lavorano gli agenti della Polizia Penitenziaria non dico che giustifico ma capisco". Chiedono, invece, di fare luce sulla vicenda il Pd e Sel, mentre Patrizio Gonnella di 'Antigone' invita il Dap a chiudere ogni rapporto con l'Aslippe se sarà dimostrato che sono tesserati di questo sindacato quelli che hanno scritto "le frasi volgari e offensive". "Se è vero - dice Gonnella - che si tratta di agenti penitenziari questi hanno contravvenuto a un dovere di lealtà e legalità, tradendo la loro missione e il loro impegno istituzionale". Dura condanna arriva anche da uno dei principali sindacati degli agenti, il Sappe che, nel dare la notizia del suicidio di Barbuta, aveva spiegato: "Purtroppo, nonostante il prezioso e costante lavoro svolto dalla Polizia Penitenziaria, pur con le criticità che l'affliggono, non si è riusciti ad evitare tempestivamente ciò che il detenuto ha posto in essere nella propria cella". Il segretario del Sappe, Donato Capece attacca inoltre i presunti colleghi "esultare per la morte di un detenuto - dice - è cosa ignobile e vergognosa".
Suicida: capo Dap firma 16 provvedimenti sospensione, scrive invece “La Repubblica”. Prime misure per la vicenda, rivelata da Repubblica.it, delle offese pubblicate da agenti sulla pagina Facebook di un sindacato di polizia penitenziaria. Il ministro Orlando: "Assumeremo iniziative congrue". "Sedici provvedimenti cautelari di sospensione" per la vicenda degli insulti via Facebook a un detenuto suicida da parte di agenti della polizia penitenziaria. Li ha firmati il capo del Dap Santi Consolo, che ha annunciato di aver anche "concordato con il direttore del personale l'avvio del procedimento disciplinare". "Ho trasmesso un rapporto corposo predisposto dal nucleo investigativo centrale all'autorità giudiziaria perché faccia le sue valutazioni: se ci sono reati questa amministrazione si costituirà parte civile per danno all'immagine", ha aggiunto Consolo. Durissimo anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando: "Assumeremo i provvedimenti del caso", ha detto a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle commissioni tributarie, assicurando che verranno portate avanti "iniziative congrue". Il comportamento degli agenti penitenziari, ha ribadito il Guardasigilli, "è inammissibile, tanto più in un momento di grandi tensioni come questo è importante che nelle carceri venga assicurato il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e della vita umana". Però, ha tenuto a precisare Orlando, "va anche detto che gli agenti della polizia penitenziaria sono di norma quelli che sventano i suicidi non quelli che esultano quando ne avviene uno". Sulla questione intervengono anche gli avvocati che aderiscono alla Camera penale di Milano che definiscono le frasi pronunciate dagli alcuni agenti di polizia penitenziaria come parole che "fanno rabbrividire", perché "ogni suicidio in carcere è di per sé inaccettabile", è "il segno del fallimento di un sistema penitenziario che dovrebbe avviare le persone alla revisione di scelte devianti ed accompagnarle di nuovo nel mondo".
Suicidio in carcere, atroci commenti di agenti su Fb: "Uno di meno". Interviene Orlando. Le frasi sono apparse sulla pagina del sindacato di polizia penitenziaria Alsippe, che poi ha deciso di rimuoverle. Il Dap avvia un'inchiesta interna. Il ministro della Giustizia convoca i vertici dell'amministrazione, scrivono Giuliano Foschini e Marco Mensurati su “La Repubblica”. Un uomo si suicida nel carcere di Opera. E gli agenti di Polizia penitenziaria - come rivela Repubblica.it - si esibiscono in un diluvio di commenti di questo genere: "Meno uno". "Un rumeno in meno", "mi chiedo cosa aspettino gli altri a seguirne l'esempio". L'ultima vergogna italiana è qui, in un gruppo Facebook di un sindacato di agenti, l'Alsippe, dove nelle ultime ore si è scatenata una caccia all'uomo che rischia di avere gravi conseguenze. Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha convocato il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, per chiarimenti su commenti definiti "intollerabili". L'incontro servirà, tra l'altro, per acquisire "elementi sull'inchiesta interna avviata e per valutare i provvedimenti da adottare". Il ministro convocherà nei prossimi giorni anche le sigle sindacali della polizia penitenziaria per discutere dell'accaduto e "di come evitare che simili inqualificabili comportamenti possano ripetersi". Il sindacato Alsippe ha deciso di cancellare i commenti incriminati dalla propria pagina Facebook sottolineando di non condividerli. "Non è nostra abitudine censurare i commenti dei nostri followers pubblicati sul nostro profilo di Facebook", si legge sulla pagina social del sindacato, dove si spiega che la decisione è maturata considerando che le frasi "hanno ingenerato una strumentalizzazione tale da comportare un possibile danno di immagine al Corpo di Polizia penitenziaria". Il caso nasce tre giorni fa, con la notizia del suicidio dell'uomo: 39 anni, Ioan Gabriel Barbuta, romeno, era detenuto nel carcere di Opera dopo essere stato condannato all'ergastolo nel giugno del 2013 per l'omicidio di un vicino di casa. Una storiaccia emblematica anche perché documenta per l'ennesima volta la barbarie delle condizioni delle carceri in Italia, sia per i detenuti sia per chi ci lavora. "Noi poliziotti penitenziari - diceva non a caso nell'articolo un sindacalista del Sappe - siamo attenti alle difficoltà di tutti i detenuti, indipendentemente dalle condizioni sociali o dalla gravità del reato commesso". Il problema è però evidentemente come si declinano questa "attenzione e sensibilità". Perché i commenti a corredo del post che sono apparsi sulla pagina Facebook dell'Alsippe, uno dei sindacati della Polizia penitenziaria, sono stupefacenti: "Meno uno". "A me dispiace per i colleghi che si suicidano per soggetti come questo. Per lui no!", e ancora "chi se ne frega?", "uno de meno che lo stato non ha da magna..." e a chi faceva notare che i commenti erano fuori luogo la risposta era chiara: "Lavora all'interno di un istituto. Sono solo extracomunitari. Per fare questo mestiere devi avere il core nero". E la cosa incredibile è che la maggior parte di queste persone arrivavano non soltanto da agenti ma anche da chi ha responsabilità sindacali. Insomma, rappresentanti della categoria. Questa storia probabilmente però non finirà qui. Perché grazie all'intelligenza e alla sensibilità di qualcuno che lo ha denunciato sui social, è finita all'attenzione del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha immediatamente avviato un'inchiesta interna. "E' un'offesa - spiegano al Dap - al lavoro di tutti gli agenti impegnati a salvaguardare le persone che hanno in custodia". Profonda irritazione è stata espressa anche da altre sigle sindacali. Tre senatori del Pd (Roberto Cociancich, Laura Cantini ed Andrea Marcucci) e Sel hanno preannunciato un'interrogazione al Guardasigilli sul caso. Per Daniele Farina, capogruppo Sel in Commissione Giustizia a Montecitorio, si tratta di "commenti inqualificabili che vanno stigmatizzati", sottolineando la necessità di arrivare all'istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulle morti in carcere. Matteo Salvini, segretario della Lega nord, parla di "commento che a mente fredda uno non avrebbe fatto" e poi spiega: "Conoscendo quali sono le condizioni in cui lavorano gli agenti della Polizia Penitenziaria non dico che giustifico ma capisco".
Suicida in cella. Silenzio diventa notizia solo se…, scrive Giuseppe Candido su “Il Garantista”. Suicidio al carcere di Opera, a Milano. Il Sappe lancia l’allarme per le condizioni inumane dei penitenziari, ma per Repubblica.it la notizia diviene un’altra. La versione online del quotidiano diretto da Ezio Mauro, mercoledì 18 febbraio, pubblica un articolo a firma di Giuliano Foschini e Marco Mensurati, col titolo in bella evidenza su alcuni commenti usciti sulla pagina Facebook di un sindacato di polizia penitenziaria: “Suicidio in carcere, atroci commenti di alcuni agenti su Fb: Uno di meno ”. «Un uomo si suicida nel carcere di Opera», scrivono i due giornalisti. Ma aggiungono subito dopo: «gli agenti di Polizia penitenziaria – come rivela Repubblica. it – si esibiscono in un diluvio di commenti di questo genere: ”Meno uno”. ”Un rumeno in meno”, ”mi chiedo cosa aspettino gli altri a seguirne l’esempio”». Nessuno cenno alla condizione ancora disumana e degradante delle carceri che nell’ottobre 2013 ha indotto il presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano a inviare – secondo l’articolo 87 della Costituzione – un messaggio alle Camere per chiedere di «riconsiderare le ostilità a un provvedimento di amnistia e indulto». Un messaggio ancora tragicamente attuale e che come Radicali, proprio perché rimasto inascoltato dal Parlamento cui era rivolto, abbiamo deciso di mettere al centro della nostra iniziativa politica. Per ottenere qualche condivisione in più sui social, i giornalisti aggiungono la frase ad effetto: «L’ultima vergogna italiana è qui, in un gruppo Facebook di un sindacato di agenti, dove nelle ultime ore si è scatenata una caccia all’uomo che rischia di avere gravi conseguenze». Trattandosi di un articolo online uno si aspetterebbe di trovare almeno il collegamento che conduce alla pagina incriminata dove, secondo gli autori, sono apparsi questi commenti che consentono di dire: è Repubblica ad aver “rivelato” la notizia. Invece niente, c’è solo una immagine di alcuni commenti su Facebook senza che si capisca nemmeno su quale pagina siano. Poi si scopre che questi commenti sono stati fatti sulla pagina di un piccolo sindacato di polizia, l’Al.Si.Ppe., che tra l’altro ha subito rimosso i commenti incriminati scusandosi: «Non è nostra abitudine censurare i commenti dei nostri followers pubblicati sul nostro profilo di Facebook, ma visto il contenuto e fermo restanti le responsabilità personali per quanto si afferma scrivendo su Facebook alcune frasi riportate, hanno ingenerato una strumentalizzazione tale da comportare un possibile danno di immagine al Corpo di Polizia penitenziaria. Oltre a non essere assolutamente condivisibili da parte del nostro sindacato, pertanto abbiamo ritenuto opportuno cancellarli». Meglio tardi che mai, verrebbe da commentare. Ma allora la domanda è un’altra: quale è la notizia per Repubblica? Quella delle carceri sulle quali il giornale vuol far notare di essere attenta, o piuttosto quella che sono apparsi commenti indecenti relativamente al suicidio del cittadino rumeno? Per gli autori dell’articolo evidentemente la seconda. E in realtà Repubblica non rivela proprio un bel niente perché – ad onor del vero – a dare la notizia dell’ennesimo suicidio nelle patrie galere, il sesto del 2015, è stato direttamente il Sappe Lombardia, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, con un comunicato diramato dal segretario Donato Capece che aveva posto al centro quello che definiva «un’emergenza purtroppo ancora sottovalutata, anche dall’Amministrazione penitenziaria». Un comunicato che era stato ripreso dalla carta stampata de Il Giornale, nelle pagine di Milano, il giorno 15 febbraio e, successivamente, dalle Cronache del Garantista, quotidiano molto attento alla tematica delle carceri, con un bell’articolo di Damiano Aliprandi pubblicato sulla versione cartacea martedì 17 e che, a differenza di Repubblica, si occupava dell’”uomo”, del cittadino rumeno che non c’è più, di una persona che ha preferito togliersi la vita in carcere. Si trattava lì di voler documentare una condizione vergognosa, quella sì, di carceri in cui anche agenti, operatori sanitari e direttori, sono spesso vittime di uno stato che non rispetta più la sua stessa legge né quella internazionale e continua a trattare in modo inumano e degradante i detenuti e, con loro, tutto il personale che in quelle condizioni lavorano ogni giorno. La cosa strana è che sia la notizia dei commenti su Fb apparsa sul sito di Repubblica.it solo il 18 febbraio, sia quella sullo stesso sito ma relativa al “fatto” che porta la data del 14 febbraio, non sono mai stati pubblicate su carta, ma solo nella versione digitale.
A Opera si continua a morire: ecco il sesto suicidio del 2015, scrive Damiano Aliprandi su Il Garantista il 17-02-2015. Si è tolto la vita impiccandosi all’interno della sua cella del carcere di Opera, alla periferia di Milano. Parliamo dell’ennesimo suicidio all’interno delle nostre patrie galere e questa volta è toccato ad un detenuto romeno di 39 anni, condannato dalla Corte di assise d’appello di Venezia all’ergastolo per omicidio. La sua è stata una controversa vicenda giudiziaria. Il detenuto suicidato era accusato dell’omicidio dell’agricoltore sessantenne di Due Carrare, trovato senza vita, semicarbonizzato, nella sua abitazione il 6 giugno del 2007. Barbuta – l’ergastolano suicidato – era stato sempre assolto nei primi due gradi di giudizio, prima dall’Assise di Padova, quindi dall’Assise d’Appello di Venezia. I giudici avevano sempre condiviso l’impostazione della difesa. Secondo l’avvocato Chiarion non vi sarebbe stata alcuna prova decisiva a carico di Barbuta. I due verdetti erano stati però impugnati in Cassazione dalla Procura generale e dall’ex moglie della vittima. La Suprema Corte aveva annullato la sentenza assolutoria rinviando il processo ad un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello. Il 26 giugno 2013 i giudici veneziani gli avevano inflitto l’ergastolo, con isolamento diurno per sei mesi. Barbuta era stato arrestato un paio di mesi dopo dalla polizia romena nella città di Miroslava, nel distretto di Ieiu, ed estradato in Italia. Inizialmente la morte di Guerrino Bissacco era stata attribuita a un incendio accidentale o addirittura ad un suicidio. Le lesioni rilevate sul corpo dell’agricoltore durante l’autopsia avevano rapidamente portato i carabinieri della compagnia di Abano ad orientarsi verso l’omicidio. Secondo l’accusa, Barbuta, che abitava a pochi chilometri dall’abitazione della vittima in via Bassan, si sarebbe introdotto in casa di Bissacco per rubare la targa della sua auto, da montare successivamente sulla propria vettura. Avrebbe avuto infatti bisogno di una targa ”pulita” per rapire la fidanzata e riportarla in Romania. Scoperto dall’agricoltore, lo avrebbe ucciso provocando poi un incendio per far sparire ogni traccia del delitto. A rendere noto il suicidio del detenuto è stato il sindacato della Polizia penitenziaria (Sappe) secondo il quale, nonostante l’intervento degli agenti, non c’è stato nulla da fare. «Purtroppo, nonostante il prezioso e costante lavoro svolto dalla polizia penitenziaria, pur con le criticità che l’affliggono, non si è riusciti ad evitare tempestivamente ciò che il detenuto ha posto in essere nella propria cella», osserva il segretario generale del Sappe, Donato Capece. «Quel che mi preme mettere in luce – aggiunge Capece – è la professionalità, la competenza e l’umanità che ogni giorno contraddistinguono l’operato delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria di Milano Opera con tutti i detenuti per garantire una carcerazione umana ed attenta pur in presenza ormai da anni di oggettive difficoltà operative come le gravi carenze di organico di poliziotti e le strutture spesso inadeguate. Siamo attenti e sensibili, noi poliziotti penitenziari, alle difficoltà di tutti i detenuti, indipendentemente dalle condizioni sociali o dalla gravità del reato commesso». Poi Capece sottolinea i problemi del carcere di Milano stesso: «Nei dodici mesi del 2014 nel carcere di Milano Opera si sono contati purtroppo il suicidio di un detenuto e la morte, per cause naturali, di un altro. Quattro sono stati i tentati suicidi evitati in tempo dai poliziotti penitenziari; 35 gli episodi di autolesionismo, 24 le colluttazioni e 7 i ferimenti». Sempre Capece conclude: «Numeri su numeri che raccontano un’emergenza purtroppo ancora sottovalutata, anche dall’Amministrazione penitenziaria che pensa alla vigilanza dinamica come unica soluzione all’invivibilità della vita nelle celle senza però far lavorare i detenuti o impiegarli in attività socialmente utili». Resta il fatto che il sistema penitenziario continua a produrre morte. Dall’inizio dell’anno siamo arrivati a sei suicidi, con un totale di 12 morti.
RepTv News, Ceccarelli: "Carceri, il
silenzio della politica. Paura o repulsione?". Dopo
l'ultimo suicidio in cella e gli insulti on web nessuna voce si è levata dai
politici sul sovraffollamento, le condizioni pietose delle prigioni e i morti in
carcere, detenuti e guardie. Forse qualcuno teme "di finirci dentro". Molti di
certo hanno paura di "perdere voti"
La gabbia, scrive Massimo Gramellini su “La Stampa”.
Un ergastolano si suicida in prigione e sulla pagina Facebook di un sindacato di
polizia penitenziaria compaiono commenti di tenebra: «un rumeno di meno», «mi
chiedo cosa aspettino gli altri a seguirne l’esempio». Stupore, scandalo,
indignazione. E il solito carico insopportabile di ipocrisia. Come se molti
secondini non avessero mai formulato questi pensieri anche prima che la
tecnologia permettesse loro di farli conoscere a tutti. Come se, oltre a
pensarli, non li avessero già espressi fin troppe volte in pestaggi e torture.
Ma, soprattutto, come se si trattasse di qualche malapianta cresciuta in un
giardino di rose anziché dell’ovvia conseguenza di un sistema in cui carcerieri
e carcerati condividono le stesse brutture e combattono l’ennesima guerra tra
poveri. La galera in Italia non è un centro di recupero, ma una soffitta orrenda
dove stipare rifiuti umani che almeno metà della popolazione vorrebbe vedere
sparire per sempre, non fosse altro perché teme che qualche garbuglio legale
riesca a rimetterli in libertà molto prima del meritato e del dovuto. Le
statistiche urlano che il carcere riesce a cambiare soltanto chi lavora,
possibilmente in un luogo sano. Eppure nella pratica comune i condannati vivono
da parassiti e la pena viene espiata in ambienti fetidi e brutali, tranne per
chi è abbastanza ricco e mafioso da potersi permettere un trattamento
privilegiato. Rendere civili le carceri e dare un senso alla galera non porta
voti, quindi è considerato uno spreco. La politica ci risparmi almeno la sua
indignazione per la beceraggine di certi immondi carcerieri. È lei ad averli
disegnati così.
Quelli che… dagli, dagli all’assassino! Scrive Angela Azzaro su “Il Garantista”. Prima di sapere come andava a finire, finalmente Schettino ha pianto. Finalmente non perché pensiamo che dovesse piangere, che si dovesse battere il petto per chiedere perdono, come molti volevano. Finalmente perché ha detto tutto quello che ha passato. Non solo il dolore per le persone che sono morte, ma anche il fatto che in questi anni è stato «sotto il tritacarne mediatico». Sì, questi tre anni, dal naufragio della Concordia, gli italiani hanno vissuto sonni tranquilli, perché tanto il Colpevole, l’Assassino era lui. Sul processo e sulla sentenza, pesa questo sentimento che fin da subito ha colpito il comandante. Non erano passate neanche poche ore che già agli occhi dell’opinione pubblica mondiale era diventato lui l’unico responsabile del naufragio, il comandante vile che ha lasciato morire trentadue persone. È bastato davvero poco perché la sentenza fosse emessa, perché non ci fosse nessuna attenuante. La telefonata del comandante De Falco che gli grida di tornare a bordo – a quanto pare fatta uscire appositamente per delegittimare ancora di più Schettino – ha fatto il resto. Ma la gogna pubblica, messa in piedi da tv e giornali, è andata oltre. Ha fatto qualcosa di ancora più grave. Non solo ha condizionato pesantemente l’esito del processo, la condanna che ieri è stata trasmessa come se fosse una fiction, ma ha anche creato il Mostro. Schettino il vile, il comandante poco coraggioso, è diventato il personaggio perfetto per costruire il capro espiatorio, il responsabile di tutti i mali, l’esempio da stigmatizzare di quell’Italia che si merita di andare a fondo. In questi anni, senza nessuna pietà, Schettino è stato additato, offeso, perseguitato. Questo non significa che lui non abbia responsabilità, ma che queste responsabilità si sono mescolate con un sentimento di odio e di gogna che poco c’entra con la giustizia e con la verifica puntuale di tutte le responsabilità. Dall’opinione pubblica, o meglio dal pubblico di questo osceno spettacolo, si è passati all’aula di giustizia, dove il pm – che aveva chiesto per Schettino 26 anni, reputandolo l’unico colpevole – sono arrivate parole inaccettabili in un tribunale. Lo ha chiamato «abile idiota». Non una prova, ma un giudizio morale. Non la frase di un pubblico ministero, ma l’urlo della folla inferocita. Schettino, allora, ci racconta anche di noi. Di come siamo diventati e di come è diventata la giustizia in questo Paese. Noi, questa società, è diventata più barbara. Siamo sempre pronti a mandare qualcuno al patibolo, pensando che siamo migliori. Non esercitiamo il dubbio, non proviamo pietà, siamo solo capaci di affermare verità, la nostra verità. Una verità che ci scagiona e accusa l’altro. Da questo punto di vista il comandante Schettino è stato perfetto, il migliore obiettivo che ci si potesse dare in pasto. E noi lo abbiamo accolto, mangiato e sputato come qualcosa di spurio, come colui che corrompe il tessuto sociale e va fatto fuori. La giustizia, quella andata in scena non in un tribunale, ma in un teatro di Livorno, ne esce altrettanto male. La scelta anche del luogo dove celebrare il processo ci racconta di un rapporto morboso tra media e giudici. L’obiettività è stata sostituita dalla spettacolarizzazione, lo stato di diritto dalla condanna in diretta. Molti godranno della pena inflitta a Schettino, anzi si lamenteranno che gli anni non sono stati abbastanza, noi no. E non solo per il suo bene.
BENI CONFISCATI ALLA MAFIA: FACCIAMO CHIAREZZA! NON E’ COSA LORO!
“Cose nostre: per un uso sociale dei beni confiscati alla mafia” recita il titolo di un convegno tenuto il 12 febbraio 2015 a Manduria nel tarantino e promosso dai Verdi e dal movimento Giovani per Manduria. A relazionare sul tema son venuti da Mesagne, nel brindisino, quelli di “Libera” ed erano presenti soggetti istituzionali di Manduria e di Mesagne.
“Cose nostre” si affermava nel titolo del convegno, mutuata dallo spot nazionale di “Libera” come se di una espropriazione proletaria si trattasse.
La Gazzetta del Mezzogiorno e Manduria Oggi ha dato ampio risalto all’evento.
Già nel marzo 2010 si leggeva su La voce di Manduria che "Il comune bandirà una gara per l'affidamento alle associazioni di tutti i 25 beni (terreni ed immobili) confiscati alle due famiglie mafiose Stranieri e Cinieri di Manduria. I primi tre lotti riguardano l'ex ristorante Tutti Frutti ed altre due villette a San Pietro in Bevagna. L'associazione contro le mafie, Libera, coordinerà i progetti finanziati dalla Regione Puglia.
Già da allora “Libera” voleva mettere le mani sui beni manduriani, non riuscendoci.
Si legge su Manduria Oggi del 3 dicembre 2014 «Quando la Regione Puglia, nel 2010 varò il progetto “Libera il Bene”, una iniziativa che promuoveva, con finanziamenti, il recupero e il riuso dei beni confiscati, nessun ente locale della provincia di Taranto partecipò, perdendo così una occasione preziosa» ricorda Anna Maria De Tomaso Bonifazi, referente per la provincia dell’associazione “Libera”. «Più volte “Libera”, fin dal 2004, ha chiesto di conoscere lo stato degli immobili confiscati sia al Comune di Taranto che a quello di Manduria, ricevendo risposte evasive. Eppure proprio a Manduria, in un periodo di commissariamento del Comune, il Prefetto di Taranto e i referenti nazionali di “Libera” riuscirono finalmente a mettere a bando i beni confiscati. Ma ci accorgemmo ben presto che si trattò di una vittoria di Pirro, perché, con l’elezione del nuovo Consiglio Comunale, il sindaco che si insediò annullò tutto e, di fronte alle rimostranze di “Libera”, non seppe fornire spiegazione alcuna, se non rifacendosi ad una decisione del segretario generale del Comune».
Vorrei, se possibile, come presidente nazionale della “Associazione Contro Tutte le Mafie”, associazione antiracket ed antiusura riconosciuta dal Ministero dell’Interno, in quanto iscritta presso la prefettura di Taranto dal 2006, ma non facente parte della sfera di Libera, contribuire a far chiarezza su un dato, tenuto conto che nei convegni si devono sentire tutte le campane e fare compendio, specialmente se in quel convegno di diritto si avrebbe avuto interesse a prendere la parola. Non foss’altro per spirito territoriale, avente la sede legale a 10 km da Manduria. E non è per spirito polemico, ma per ragioni di verità, per non far passare dei principi non esatti ma ritenuti come tali, in virtù dell’ampia visibilità che a “Libera” si dà. Opinioni secondo scienza e coscienza forte delle mansioni nazionali che ricopro.
Si spera che la mia precisazione abbia lo stesso risalto che si è dedicato ai presenti al convegno.
Descrizione del Fenomeno, si legge sul sito della Commissione Nazionale Antimafia. Uno degli elementi fondamentali per sconfiggere le mafie è procedere al loro impoverimento confiscando loro tutti i beni e i patrimoni acquisiti mediante l'impiego di denaro frutto di attività illecite. Si tratta di un principio fondamentale che Pio La Torre, segretario regionale del partito comunista in Sicilia e parlamentare della Commissione antimafia, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982, capì in modo molto chiaro. Infatti, la legge che successivamente introdurrà nel codice penale italiano l'articolo 416-bis e altre norme, denominate misure patrimoniali, che consentono la confisca dei capitali mafiosi, porta il suo nome insieme a quello dell'allora Ministro dell'Interno, Virginio Rognoni. I beni dei quali sia stata accertata la proprietà da parte di soggetti appartenenti alle organizzazioni mafiose vengono confiscati, vale a dire sottratti definitivamente a coloro che ne risultano proprietari. Questi beni sono rappresentati da immobili (case, terreni, appartamenti, box, ecc.), da beni mobili (denaro contante e titoli) e da aziende. Secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, una legge di iniziativa popolare sostenuta dalla raccolta di un milione di firme da parte dell'associazione Libera, i beni immobili possono essere usati per finalità di carattere sociale. Questo significa che essi possono essere concessi dai comuni, a titolo gratuito, a comunità, associazioni di volontariato, cooperative sociali e possono diventare scuole, comunità di recupero per tossicodipendenti, case per anziani, ecc. Nelle regioni meridionali, ad esempio, sono sorte delle Cooperative sociali di giovani che coltivano terreni confiscati alle organizzazioni mafiose producendo pasta, vino e olio. In base alle previsioni della legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 201-202) i beni confiscati possono essere assegnati anche a Province e Regioni. I beni immobili non assegnati ai comuni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e vengono utilizzati per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile. I beni mobili vengono trasformati in denaro contante, il quale viene successivamente depositato in un apposito fondo prefettizio. Le aziende vengono vendute, date in affitto o messe in liquidazione. Il ricavato viene versato nel fondo prefettizio. La Cancelleria dell'Ufficio giudiziario provvede a comunicare il provvedimento definitivo di confisca ai seguenti soggetti: l'Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, il Prefetto, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. L'Ufficio del territorio una volta stimato il valore del bene da assegnare sente il Prefetto, il Sindaco, l'Amministrazione ed entro novanta giorni formula una proposta finalizzata all'assegnazione del bene. È il Direttore Centrale del Demanio che entro trenta giorni emette il provvedimento di assegnazione.
Bene. Su tutti i territori italiani operano delle associazioni distribuite per competenza provinciale ed iscritte presso le rispettive Prefetture. Dichiarazione, relazione e documentazione comprovante l’attualità dei requisiti e delle condizioni prescritte di cui agli artt. 1 e 3 del regolamento (DM 220 del 24/10/2007) recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall’art. 13, comma 2, L. 44/99 e dall’art. 15, comma 4, L. 108/96.
Associazioni antimafia che operano per assistere le vittime di estorsione ed usura, molte delle quali non fanno capo a Libera, che, spesso, presso la CGIL fa eleggere domicilio alle delegazioni locali.
Quindi sfatiamo un fatto: i beni confiscati non sono roba loro, ossia di “Libera”.
Un’altra cosa. I beni già sequestrati in odor di mafia, si confiscano solo a sentenza di condanna definitiva. In caso contrario tornano ai legittimi proprietari. Ma di altre questioni nei convegni di cui si parla ci si dovrebbe occupare: Ossia denunciare pubblicamente quello che la gente non sa circa gli interessi economici e politici che ruotano intorno ai beni sequestrati, prima, ed eventualmente confiscati, poi...
Che fine ha fatto la “robba” dei boss? L’ Antimafia al lavoro sui dossier. «Da più parti riceviamo denunce che rivelano la persistenza di molte ombre nella gestione dei beni confiscati alla mafia», ha spiegato Nello Musumeci, presidente della commissione regionale (siciliana ndr), che sta analizzando l’utilizzo delle ricchezze sottratte a Cosa nostra, scrive Giuseppe Pipitone su “L’Ora Quotidiano”. «Dopo avere completato le trascrizioni – annuncia il presidente dell’Antimafia – provvederemo a trasmettere il documento anche all’autorità giudiziaria. Abbiamo riferito al prefetto (Postiglione ndr) che in un anno e mezzo la commissione ha raccolto il grido di allarme di giornalisti, amministratori, imprenditori e rappresentanti dei lavoratori che denunciano la persistenza di molte ombre nella gestione dei beni tolti alla mafia». «In alcuni casi – ha spiegato Musumeci – si tratta di denunce di vere e proprie incompatibilità, situazioni preoccupanti. In altri casi abbiamo riscontrato la concentrazione di molti incarichi nelle mani di un unico amministratore e tentativi di favorire società e studi professionali». Palermo è la capitale della ”robba” dei boss. Il quaranta per cento di tutti i beni confiscati a Cosa Nostra, infatti, si trova nel capoluogo siciliano. Ed è proprio da Palermo che arriverà il primo dossier con le anomalie sulla gestione degli immobili confiscati alla mafia. Un patrimonio imponente: più di diecimila immobili, mille e cinquecento aziende, più di tremila beni mobili. Numeri che fanno dell’Agenzia per i beni confiscati, creata nel 2009 per gestire “la robba dei boss”, la prima holding del mattone d’Italia. E probabilmente anche la più ricca: il valore dei beni confiscati alle mafie, infatti, si aggira intorno ai 25 miliardi di euro. Un vero tesoro, che però spesso non riesce ad essere restituito alla collettività. A Palermo, per esempio, sono solo 1.300 i beni assegnati su un totale di 3.478. “Da più parti riceviamo, in audizione, denunce che rivelano la persistenza di molte ombre nella gestione dei beni confiscati alla mafia. Denunce che, dopo le trascrizioni, trasmetteremo alla magistratura e al ministero dell’Interno per le necessarie verifiche”, ha spiegato ieri Nello Musumeci, presidente della commissione regionale Antimafia, che sta lavorando ad un dossier sulla gestione dei beni confiscati. Proprio ieri la commissione Antimafia ha ascoltato la deposizione del prefetto Umberto Postiglione, che ha sostituito Giuseppe Caruso alla guida dell’Agenzia. “Insieme alla commissione Lavoro dell’Assemblea regionale siciliana – ha continuato Musumeci – stiamo elaborando una proposta di modifica della legge nazionale vigente ponendo particolare attenzione due problemi: la tutela dei dipendenti di quelle aziende che spesso chiudono dopo la confisca; il patrimonio di edilizia abitativa da destinare, a nostro avviso, alle famiglie indigenti e alle Forze dell’ordine piuttosto che restare inutilizzato e in completo abbandono”. L’emergenza principale è forse rappresentata dai dipendenti delle aziende sottratte a Cosa Nostra. La maggior parte delle società confiscate, infatti, finisce per fallire, e i dipendenti rimangono senza lavoro. Questo perché il codice antimafia recentemente approvato, che ha preso il nome del ministro Angelino Alfano, prevede la liquidazione di tutti i crediti non appena l’amministratore giudiziario prende possesso della società. “Significa che se questa norma venisse intesa in senso rigido, il tribunale deve procedere a liquidare il 70 per cento dell’impresa per pagare tutti i crediti: e quindi non resterebbe alcuna risorsa per continuare a far vivere l’azienda”, spiega il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Gaetano Paci. Con il risultato che dopo la confisca gli ex dipendenti delle aziende di Cosa Nostra rimangono senza lavoro. “Con la mafia si lavora, con lo Stato no” gridavano negli anni ’80 gli operai delle prime aziende confiscate a Cosa Nostra. Oggi la situazione non sembra particolarmente migliorata. Un segnale poco incoraggiante, pericolosissimo in una terra come la Sicilia che di segnali vive e si alimenta. Questo vale per la Sicilia, così come vale per tutta l'Italia.
Spero di aver dato un contributo costruttivo al dibattito.
IL BUSINESS DEI BEI SEQUESTRATI E CONFISCATI.
La mafia dell’antimafia. Il business dei beni sequestrati e confiscati. Come si vampirizzano le aziende sane. «L’antimafia è un’entità composita con finalità politiche e speculative. Se la mafia è quella che ci propinano, allora la mafia non esiste. La mafia siamo noi tutti: i politici che mentono o colludono, le istituzioni che abusano, i media che tacciono, i cittadini che emulano. Se questo siamo noi, quindi mai nulla cambierà.»
Il 3 febbraio 2015, nel suo primo discorso di insediamento da Capo dello Stato, Sergio Mattarella ha parlato di lotta alla criminalità organizzata e di corruzione. "La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute", ha detto nel suo discorso di insediamento. "La corruzione - ha aggiunto - ha raggiunto un livello inaccettabile, divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini, impedisce la corretta espressione delle regole del mercato, favorisce le consorterie e danneggia i meritevoli e i capaci". Il capo dello stato ha citato le "parole severe" di Papa Francesco contro i corrotti, "uomini di buone maniere ma di cattive abitudini". Ed ha sottolineato quanto sia "allarmante la diffusione delle mafie in regioni storicamente immuni. La mafia è un cancro pervasivo, distrugge speranze, calpesta diritti". A giudizio del presidente Mattarella occorre "incoraggiare l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine, che spesso a rischio della vita si battono per contrastare la criminalità organizzata. Nella lotta alle mafie - ha ricordato cedendo per un attimo alla commozione - abbiamo avuto molti eroi, penso a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Per sconfiggere la mafia occorre una moltitudine di persone oneste competenti tenaci e una dirigenza politica e amministrativa capace di compiere il proprio dovere verso la comunità". Ad ascoltare Mattarella a Montecitorio c'erano il presidente della Regione Rosario Crocetta e il sindaco Leoluca Orlando, che proprio di Falcone era acerrimo nemico.
Molti altri lo hanno ascoltato a Montecitorio: persone oneste e meno oneste. Tra le persone oneste folta schiera è nel centro sinistra: quasi tutti o tutti. Fiancheggiatori della giustizia e della legalità o vittime o parenti di vittime della mafia. Se non lo sono, vale lo stesso. Nel centro destra, poi, son tutti mafiosi (a prescindere). Certo è questo quel che si vuol far intendere. Ma a destra non se ne curano. Basta loro adoperarsi per gli interessi del loro capo. I magistrati, poi, sono gli innominati di manzoniana memoria. Loro sì onesti per davvero, perchè la gente comune non lo sa, ma i magistrati non hanno nulla da spartire con i comuni mortali, perchè loro, i magistrati, vengon da Marte.
Dopo l'elezione di Sergio Mattarella a Capo dello Stato, su Facebook la politica si scatena nei commenti, scrive “Libero Quotidiano” ed “Il Giornale”. Qualcuno non condivide l'elezione come fa Matteo Salvini, ma qualcun altro tra i grillini (che hanno votato Imposimato), ha attaccato il neo-presidente in modo duro. A farlo è Riccardo Nuti che afferma: "Lodare Mattarella come antimafia perché il fratello fu ucciso dalla mafia è falso e ipocrita perché allora bisognerebbe dire anche che il padre era vicino alla mafia". Lo scrive su Facebook il deputato M5s, che aggiunge: "Ma se è vero che gli errori dei genitori non possono ricadere sui figli, allora non possono essere utilizzate altre vicende dei parenti in base alla propria convenienza. L'uccisione di un parente da parte della mafia (i motivi possono essere tanti e diversi fra loro) non da nessun bollino di garanzia di lotta alla mafia". Un commento che di certo farà discutere.
L’antimafia è un’entità composita con finalità politiche e speculative. Se la mafia è quella che ci propinano, allora la mafia non esiste. La mafia siamo noi tutti: i politici che mentono o colludono, le istituzioni che abusano, i media che tacciono, i cittadini che emulano. Se questo siamo noi, quindi mai nulla cambierà.» Non lo dice Don Ciotti, presidente nazionale di “Libera”, anche perché non oserebbe mai, ci vorrebbe pure. Lo afferma categoricamente il dr Antonio Giangrande, noto scrittore e sociologo storico e fine conoscitore del fenomeno della Mafia, della Massoneria e delle Lobbies e della Caste, oltreché presidente nazionale della “Associazione Contro Tutte le Mafie”. Ed è tutto dire. Io sono il presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte le Mafie. Sodalizio antiracket ed antiusura riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Associazione iscritta presso la Prefettura di Taranto. Per le problematiche sociali affrontate, siamo l’associazione madre di tutte le associazioni tematiche e territoriali, così come riporta il nostro sito web. Se qualcuno ha un problema me lo segnala. Non ho il potere di risolverlo, (nessuno può) ma di elevarlo agli onori della cronaca, sì. Io sono il Don Ciotti della mia associazione, per intenderci. Però abbiamo un difetto. Io ho un difetto: non sono comunista e non santifico i magistrati. Per questo i media ci ignorano. Ma non i cittadini. Prova a mettere su google il mio nome e vedrai quanti parlano di me. Ho pochi amici su Facebook e sul gruppo associazione contro tutte le mafie, perché dopo un po’ di tempo cancello gli amici o gli iscritti, quando verifico che hanno sbagliato amico o gruppo. Noi siamo diversi e ce ne vantiamo. Ogniqualvolta mi hanno interpellato, le vittime hanno preteso la soluzione. Mai una volta che abbiano offerto il loro appoggio, il loro sostegno. Non ho potere, ne sono sostenuto da alcuno e pure i coglioni mi dicono: che ci stò a fare. A prendere le ritorsioni dei magistrati che tentano in ogni modo di tacitarmi. Ogni volta che qualcuno si è confrontato con me per forza di cose voleva alzare la sua bandiera ed il suo nome, per un interesse personale. Gli onori a lui, le rogne a me. Le lotte si portano avanti insieme e non per la propria guerra. E’ un tallone di Achille parlare di sé. Si sarà sempre additati di mitomania o pazzia o di interesse personale. Pensi che qualcuno abbia pensato a me per competenza, capacità, esperienza e coraggio per portare avanti in Parlamento le aspettative del popolo. No. Pur incapaci son tutti pronti ad ante mettersi. Io parlare di voi o di altri e come se parlassi per me. Ma parlo di voi e ne sono contento. Perché è come se fossi uno di voi. Quest’ultima inchiesta è pubblicata su 500 siti web di portali di informazione a me collegati in tutta Italia. Pensi che ciò non basti a dare spazio alla tua storia, che non è la tua: è di mille come te? Pensi che lo abbia fatto per un interesse personale e che abbia chiesto a qualcuno un compenso? Quindi non serve avere una associazione in più, ma basta avere la consapevolezza di avere una guida o di avere uno strumento che porti ad un risultato. E mi dispiace dirlo, sarà solo quello di aver fatto conoscere la propria storia e non sarà quello di avere giustizia in questa Italia e con questi italiani. Segui me, vediamo fin dove arriviamo, perché il mio cammino è iniziato 20 anni fa. Io son Antonio Giangrande e basta questo basta. Pensa a Berlusconi: se è successo a lui, e non è stato capace di difendersi, figuriamoci ai poveri cristi. C'è qualcosa da fare: far conoscere la verità a tutti ed in tutti i modi. Solo quello ci rimane da fare. I miei siti web. I miei canali youtube. La mia tv web. I miei libri. Sono tutti strumenti di divulgazione che fanno male al sistema e ciò serve a cambiarlo. Come azione politica noi combattiamo, oltre che per cambiare il sistema, anche per una proposta concreta: il difensore civico giudiziario a tutela del cittadino che abbia i poteri del magistrato ma che non sia uno di essi: corporativo ed amicale. Questo sì che cambierebbe le cose in fatto di garanzia per le vittime di giustizia.
L’antimafia non combatte i mafiosi. Il suo intento è osannare i magistrati (i Pubblici Ministeri in particolare) per asservirli ai loro fini. Ossia: eliminare i rivali politici (avete mai visto qualcuno di sinistra condannato per mafia o per il reato inventato dai magistrati quale l’associazione o la partecipazione esterna alla mafia?) e sfruttare economicamente i beni sequestrati ed espropriati, spesso ingiustamente.
L’Antimafia: o si è con loro, o si è contro di loro. Ti chiami Giangrande o Sciascia uguale è. E’ inutile rivolgersi ai parlamentari per ottenere giustizia. Molti sono genuflessi alla magistratura, qualcuno è colluso, tanti sono ricattati o sono ignavi. La poltrona vale qualsiasi lotta di civiltà. Per questo nessuno di loro merita il voto degli italiani veri.
Ecco allora che nasce impettito il fenomeno mediatico dell’invasione virulenta della mafia in tutta Italia. L’Italia all’estero è una nazione ormai infetta. Non è più la Sicilia martoriata da Cosa Nostra o dalla Stidda, con vittime illustri uccise dai boss (dello Stato), o non è più la Calabria martirizzata dalla ‘Ndrangheta, o non è più la Campania tormentata dalla Camorra. Oggi l’Italia per i magistrati è tutta una mafia. E gli intellettuali di sinistra ci marciano. Ed all’estero ringraziano per il degrado del Made in Italy. Fa niente se prima l'illegalità diffusa si chiamava tangentopoli e guarda caso i comunisti non son stati colpiti. Oggi nel fenomeno criminogeno (sempre di destra, sia mai) ci sono di mezzo siciliani, napoletani e calabresi: allora è mafia!
L’antimafia per creare consenso e proselitismo monta campagne stampa di sensibilizzazione che incitano le vittime a denunciare. “DENUNCIA IL RACKET. TI CONVIENE.” A questo punto sembra più una minaccia che un invito.
Le vittime, diventate testimoni di giustizia, successivamente sono abbandonate al loro destino, che porta questi a pentirsi ed a rinnegare quanto fin lì fatto. Esemplari sono le testimonianze da tutta Italia tra i tanti di: FRANCESCO DIPALO. LUIGI ORSINO. PINO MASCIARI. COSIMO MAGGIORE. LUIGI COPPOLA. LUIGI LEONARDI. TIBERIO BENTIVOGLIO. IGNAZIO CUTRO'.
A cosa porta per davvero l'interesse dell'Antimafia se non tutelare le vittime dell'estorsione e dell'usura, così come propinata?
Il fenomeno taciuto è la gestione dei beni sequestrati, prima, e confiscati, poi. Per capire bene il fenomeno di cui si crede di essere unica vittima bisogna andare al di là di quello che si conosce.
I beni di sospetta leicità sono sequestrati con un provvedimento giudiziario come misura di prevenzione ed eventualmente confiscati con successiva pena accessoria in sentenza, che spesso non arriva. Questi beni sotto sequestro vengono affidati a un amministratore giudiziario scelto dal giudice del caso, che dovrebbe gestirlo mantenendolo in attività e tenerlo agli stessi livelli che precedevano il sequestro. Ma no è così.
I beni sotto tutela sono appetibili da tutti coloro che agiscono all’interno del sistema. Apparato non accessibile a tutti.
Firma l'appello: "Niente regali alle mafie, i beni confiscati sono cosa nostra", si legge sul sito web di "Libera". "Cosa nostra"? Mi sembra di aver già sentito da altri lidi questa affermazione. "Cosa vostra"? Con quale diritto?
"Attorno ai beni confiscati e all’assegnazione di essi si può sviluppare l’unica vera opportunità per coinvolgere attivamente la società civile nella lotta alle mafie, portandola al suo esito più elevato: quello di estirpare culturalmente il fenomeno mafioso sul territorio a cominciare dal riuso di beni confiscati che devono essere effettivamente restituiti alla collettività", si legge su vari siti web di associazioni e comitati fiancheggiatori di "Libera" e della CGIL.
Una espropriazione proletaria nel nome dell’antimafia? Una buona trovata.
Rock e sociale incrociano le loro strade in Il silenzio è dolo. Il brano è di Marco Ligabue e si intitola "Il silenzio è dolo". Marco Ligabue l'ha scritta quando ha scoperto la storia del contestato sorteggio con cui sono stati "selezionati" gli scrutatori per le recenti elezioni europee nei seggi di Villabate, in Sicilia. L'iniziativa è stata presentata a Montecitorio e ha riscosso l'appoggio del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Nino Di Matteo, convinto che "la mafia ha sempre prosperato nel silenzio, i mafiosi vogliono che di mafia non si parli". Della selezione e dell'operato degli scrutatori e dei presidenti di seggio, uguale in tutta Italia, sorvoliamo, anche perché è cosa di sinistra, ma attenzioniamo un fatto. I Parlamentari e l'associazione Nazionale Magistrati non hanno posto uguale attenzione all'appello di Pino Maniaci. Ed i media neppure.
«Mafia dell’Antimafia: l'inchiesta di Telejato audita in Parlamento - scrive Pino Maniaci - C’è ancora un business di cui non si parla, un business di milioni di euro. Il business dell’Antimafia. Quattro mesi dopo il brutale assassinio di Pio La Torre, nel 1982, viene approvata la legge Rognoni-La Torre, che consentiva il sequestro e la confisca di quei beni macchiati di sangue. Finalmente, lo Stato aveva le armi per attaccare gli ingenti patrimoni mafiosi. Nel ’96 grazie a Libera nasce la legge 109 che disponeva l’uso sociale dei beni confiscati alla mafia, e finalmente terreni, case, immobili tornano alla comunità. Tutto bellissimo. Nella teoria. Qualcosa però non funziona. Questi beni, sequestrati, confiscati, falliscono l'uno dopo l’altro. Il 90% di imprese, aziende, immobili, finisce in malora spesso prima ancora di arrivare a confisca. A non essere rispettata e ad aver bisogno di una riforma strutturale è la Legislazione Antimafia - Vittime della mafia e relativo Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Parliamo di aziende e imprese sequestrate perché di dubbia legalità: aziende che forse furono acquistate con proventi mafiosi, o che svolgono attività illecito-mafiose, e che per chiarire questo dubbio vengono poste sotto sequestro ed affidate alla sezione delle misure di prevenzione del Tribunale competente. In questo caso, parliamo del Tribunale di Palermo, che amministra la grande maggioranza dei beni in Sicilia. I beni confiscati sono circa 12.000 in Italia; di questi più di 5000 sono in Sicilia, circa il 40%. La maggior parte nella provincia di Palermo. Si parla di un business di circa 30 miliardi di euro, solo qui a Palermo. Questi beni sotto sequestro vengono affidati a un amministratore giudiziario scelto dal giudice del caso, che dovrebbe gestirlo mantenendolo in attività e tenerlo agli stessi livelli che precedevano il sequestro. Questa fase di sequestro secondo la legge modificata nel 2011 non deve superare i 6 mesi, rinnovabile al massimo di altri 6, periodo in cui vengono svolte le dovute indagini e si decide il destino del bene stesso: se dichiarato legato ad attività mafiose esso viene confiscato e destinato al riutilizzo sociale; se il bene è pulito viene restituito al precedente proprietario. Purtroppo la legge non viene applicata: il bene non viene mantenuto nello stato in cui viene consegnato alle autorità, né vengono rispettate le tempistiche. In media il bene resta sotto sequestro per 5-6 anni, ma ci sono casi in cui il tempo si prolunga fino ad arrivare a 16 anni. L’albo degli amministratori competenti che è stato costituito nel gennaio 2014 per legge dovrebbe essere la fonte da cui vengono scelti questi soggetti: in base alle competenze e alle capacità. Ma la scelta è arbitraria, effettuata dai giudici della sezione delle misure di prevenzione. Ritroviamo molto spesso la solita trentina di nomi, che amministrano decine di aziende e imprese. E non per capacità, perché la maggior parte di quei beni falliscono durante la fase di sequestro. Anche se poi vengono dichiarati esterni alla vicenda e gli imputati assolti da tutte le accuse. Telejato, la piccola emittente televisiva comunitaria siciliana che gestisco dal 1999 e che da allora non ha mai smesso di denunciare e lottare contro la mafia, ha sede a Partinico e copre un bacino d’utenza caratterizzato storicamente da una forte presenza mafiosa. La dichiarazione di fallimento e la messa in liquidazione dei beni confiscati è la strada più facile per gli amministratori, perché li esonera dall’obbligo della rendicontazione e consente loro di “svendere” mezzi, attrezzature, materiali, anche con fatturazioni non conformi al valore reale dei beni, girando spesso gli stessi beni ad aziende collaterali legate agli amministratori giudiziari. La pratica di vendere parti delle aziende stesse mentre sono ancora sotto sequestro, è abbastanza consolidata, e ci si ritrova con aziende svuotate e distrutte ancor prima del giudizio definitivo, che sia di confisca o di dissequestro. Questi sono solo alcuni esempi, alcune storture del sistema; ma molti sono i casi che riflettono un problema strutturale: una legge limitata, da aggiornare, che non permette gli adeguati controlli e conduce troppo spesso al fallimento dei beni per le - forse volute - incapacità del sistema. Posso fare nomi, esempi, citare numeri e casi. Chiedo alla Commissione Antimafia di essere audito per esporre questa inchiesta che stiamo portando avanti a Telejato, con notevole fatica, perchè non abbiamo nessuno al nostro fianco».
Il business dell'Antimafia. Conoscete Cavallari, il re mida della sanità? A bari si son fottuto tutto di questo signore. Tutte le sue cliniche private. Per i magistrati era mafioso perchè era associato con sè stesso. E poi come si dice, alla mano alla mano…Ossia conoscere altre storie similari ma non riuscire a cambiare le cose?!? Perché ognuno pensa per sé. Una voce è una voce; tante voci sono un boato che scuote. Peccato che ognuno pensa per sé e non c’è boato. Basterebbe unirsi e fare forza.
Si prosegue con Matteo Viviani, che raccoglie la testimonianza di una famiglia siciliana di imprenditori: Mafia, antimafia e aziende che affondano. I Cavallotti hanno subito estorsioni dal braccio destro di Provenzano, irruzioni armate in casa, finendo poi in galera per aver pagato il pizzo. Erano glia anni di Cosa Nostra, spiegano, e tutti pagavano il pizzo. Nonostante dopo anni di processo sia stato appurato che i Cavallotti non siano mafiosi, continuano a non poter gestire la loro azienda. L'amministratore che se ne sarebbe dovuto occupare infatti, ha effettuato operazioni di vendita poco chiare di cui, alla fine, ha beneficiato economicamente. Viviani lo raggiunge, ma lui non dà risposte. Il 29 gennaio 2015 è andato in onda Italia Uno, nel corso della trasmissione “Le Iene” un lungo e documentato servizio sui fratelli Cavallotti, su come chi dovrebbe rappresentare lo Stato abbia distrutto un’azienda florida che dava lavoro a circa 200 dipendenti e su come questa vicenda, che ormai si protrae da 16 anni, malgrado le assoluzioni del tribunale e la riconosciuta estraneità dei fratelli Cavallotti a qualsiasi forma di collusione mafiosa, per decisione dell’ineffabile magistrato che dirige l’Ufficio Misure di Prevenzione di Palermo, ancora continua, scrive Salvo Vitale. I dati e i contatti con l’azienda sono stati forniti in gran parte da Telejato. Vista la complessità dell’inchiesta che l’emittente conduce da tempo, lo staff delle Iene ha deciso, per il momento di affrontare solo un’impresa, quella dei Cavallotti, ma riservandosi di portare all’attenzione le altre malversazioni che, su questo campo, sono consumate in nome e con l’avallo dello Stato. Davvero meschina e al di là di ogni umano senso di dignità la figura dell’ ex amministratore giudiziario, che non ha saputo dare spiegazioni delle sue malversazioni e delle false fatturazioni girate a un’azienda del fratello. In pratica abbiamo assistito in diretta alle prove dimostrate di come si commette un reato, con l’avallo dei magistrati delle misure di prevenzione e come, chi dovrebbe rappresentare lo Stato e tenere in piedi le aziende che gli sono state affidate, fa di tutto per distruggerle ai fini di un utile personale. Le riprese di un’azienda con i mezzi di lavoro arrugginiti, abbandonati, con i capannoni spogli, non possono che generare tristezza. Come succede in Italia, non succede niente, anzi, se succede qualcosa, succede per danneggiare chi chiede giustizia. Come nel caso dell’ultimo recentissimo sequestro operato ai figli dei Cavallotti, che cercavano di raccogliere i cocci dell’azienda. Questo è quello che la redazione di Telejato vorrebbe andare a dire alla Commissione Antimafia, se questa si decidesse di tenere conto della richiesta di ascoltarla, già sottoscritta da 40 mila cittadini.
Ma per la Commissione Antimafia la mafia è tutt’altra cosa…
La differenza tutta politica tra il 1992 e adesso sta nei numeri che ho dato prima. Il sistema politico è esangue. E neppure il grillismo è riuscito a trasfondervi qualcosa. Il sistema politico è stretto nella tenaglia tra il renzismo (che, va ricordato, non ha mai avuto alcun suffragio elettorale) e l’astensionismo ormai dilagante. Paragonate l’affluenza in Emilia Romagna nel 1992 (per la Camera, Circoscrizione Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì: 94,44 per cento; Circoscrizione Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia: 92, 99 per cento) con il misero 37,7 per cento delle regionali del 2014, e si capisce di cosa stia parlando. Gli italiani, soliti ignavi, non lo dicono, ma dimostrano il loro odio e disprezzo, o comunque il loro distacco dalla politica contemporanea che viene da lontano con l’astensionismo od altre forme di protesta. La politica interessa solo a 3 italiani su 10 e magari. Secondo Renato Mannheimer su “Il Corriere della Sera” la politica interessa solo a 3 italiani su 10 e magari, dico io, proprio perché interessati dai favori richiesti e ricevuti. I risultati delle ultime amministrative hanno dato una scossa violenta alla vita dei partiti. L'elevato tasso di astensione, il gran numero di schede bianche e nulle (di cui troppo poco si è parlato) e il successo di un movimento antipartitico come la lista 5 stelle hanno mostrato tutta la debolezza delle forze politiche tradizionali nell'opinione pubblica italiana. D'altra parte, questo scarso appeal dei partiti era già stato indicato dalle ricerche che mostravano il decrescere progressivo del grado di fiducia nei loro confronti. La sfiducia verso i partiti si inquadra in un più generale trend di disaffezione da tutte le principali istituzioni politiche, anch'esso accentuatasi negli ultimi anni. L'indice sintetico di fiducia per le istituzioni politiche elaborato da Ispo (che misura, attraverso un algoritmo statistico, il consenso verso diverse istituzioni, dall'Ue al Parlamento, al Governo, fino al presidente della Repubblica) mostra al riguardo un calo drastico al valore del 25,5 di oggi. Quello che i politici oggi hanno perso è la credibilità: chi a torto attacca i magistrati; chi a torto li difende a spada tratta; chi a torto cerca l’intervento referendario inutile in tema di giustizia, fa sì che quel 50 % di astensione elettorale aumenti. Proprio perché, la gente, è stufa di farsi prendere in giro. Oltremodo adesso che siete tutti al Governo delle larghe intese per fottere il popolo. Quel popolo che mai si chiede: ma che cazzo di fine fanno i nostri soldi, che non bastano mai? E questo modo di fare informazione e spettacolo della stampa e della tv, certamente, alimenta il ribrezzo contro l'odierno sistema di potere. Per fare un sillogismo. Se l’Italia è la Costa Concordia, e come tale è affondata, la colpa non è dello Schettino di turno, ma dell’equipaggio approssimativo di cui si è circondato. E se la Costa Crociere ha la sua Flotta e l’Italia ha la sua amministrazione centrale e periferica, quanti Schettino e relativi equipaggi ci sono in giro a navigare? E quante vittime i loro naufragi provocano? Si dice che l’Italia, come la Costa Concordia, è riemersa dall’affondamento? Sì, ma come? Tutta ammaccata e da rottamare!!! E gli italioti lì a belare……
Ma non solo la politica paga fio. Non si fidano della magistratura 2 italiani su 3, scrive Errico Novi su "Il Garantista". E’ un crollo. Il tasso di fiducia nei magistrati passa dal 41,4% di un anno fa ad appena il 28,8%. Lo dice il Rapporto 2015 dell’Eurispes, presentato ieri a Roma dal presidente dell’istituto Gian Maria Fara. Che definisce il dato su giudici e pm «preoccupante e inatteso». Di fatto quello della magistratura è il potere che perde maggiori consensi: più del 30% di quelli che già aveva. Il governo è messo male, il dato della fiducia è al 18,9%, eppure è in lieve crescita rispetto a un anno fa. Il che autorizza a credere che nella lite tra le toghe e l’esecutivo sul taglio delle ferie, i cittadini parteggino decisamente per quest’ultimo. I dati rischiano di galvanizzare Renzi. Soprattutto nella sua guerra a distanza con i magistrati. Secondo il Rapporto Italia 2015 dell’Eurispes la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni tende al ribasso. Ma se si va nel dettaglio, le cose si mettono davvero malissimo per la magistratura, che ha un tasso di consenso ridotto ormai al 28,8% e diminuito nel giro di un anno di ben 12,6 punti percentuali (nel 2014 era dunque al 41,4%, tutta un’altra cosa). Il governo come istituzione nel suo complesso ha un punteggio da incubo, sta al 18,9%. Ma seppur di qualche decimale, e in un clima di generale scoramento, è in salita. Non che ci sia da festeggiare visti i numeri, ma insomma il presidente del Consiglio potrebbe dedurne che gli italiani parteggiano più per lui che per le toghe, nella contesa sul taglio delle ferie. Interpretazioni a parte, le statistiche presentate ieri alla Biblioteca Nazionale di Roma da Gian Maria Fara, che dell’Eurispes è presidente, fanno impressione. Il giudizio degli italiani nei confronti delle istituzioni resta complessivamente negativo, il 69,4% dice di riporvi minore fiducia che in passato. E questo in un quadro complessivo di certezze sempre più scarse, di valutazioni molto critiche nei confronti dell’Unione europea e della moneta unica e in un generale clima di oppressione percepita nei confronti di fisco e burocrazia. Nulla di sorprendente, però. Tranne il dato sui magistrati. Che tracollano in modo davvero verticale – di fatto perdono oltre il 30% dei consensi che avevano – nonostante il grande impatto mediatico di inchieste come quella su Mafia Capitale. E’ la pietra tombale sul ricordo stesso della stagione di Mani pulite. Un cambio di paradigma che tra l’altro è stato ampiamente rappresentato pochi giorni fa all’inaugurazione dell’anno giudiziario dal primo presidente della Cassazione, Giorgio Santacroce, proprio con il riferimento alla golden age di Tangentopoli. Nella sua esposizione pubblica Fara non si dilunga granché sul dato. Si limita a definirlo «preoccupante e inatteso». E a proporlo anche in versione capovolta: «La quota di cittadini che non ripongono fiducia nella magistratura è passata dal 54,8% del Rapporto 2014 al 68,6% dell’ultimo rilevamento». Il clima del Paese non è certo colorato di rosa, dice lo studio presentato. Gli aspetti patologici da rimuovere in fretta sarebbero la pervasività della burocrazia e le tasse asfissianti. Soprattutto il primo elemento potrebbe indurre il sospetto che il crollo della magistratura nell’indice di gradimento degli italiani sia parte di una più generale ripulsa nei confronti di tutto ciò che è apparato e potere pubblico. E invece non è così. Niente da fare, le toghe non possono aggrapparsi neppure a questo. Perché nonostante l’analisi del presidente Fara parta da quello che lui chiama il «Grande Fardello» degli adempimenti infiniti e del fisco, la fiducia nei confronti della pubblica amministrazione non è in calo, anzi: è in clamorosa ascesa, fa registrare un +18,1% e si risolleva così da un dato precedente molto basso, fino a raggiungere il 39,1%. Meglio i travet e gli impiegati, meglio i ministeriali di giudici e pm. Chi l’avrebbe mai detto. Persino i partiti si riprendono un po’ (arrivano al 15.1% con un significativo +8,6% rispetto a un an anno fa), addirittura i vituperatissimi sindacati hanno consensi più che doppi rispetto alle forze politiche (tasso di fiducia al 33,9%, con un +14,7). La magistratura niente, è così penalizzata dalla ricerca dell’Eurispes da far pensare a un rancore profondo, diffuso, quasi a una voglia di fargliela pagare. Figurarsi se davvero insisteranno con il piagnisteo per quei 15 giorni su 45 di vacanza in meno.
Tutto il potere alle toghe. Dai la parola all’imputato? Favoreggiamento, scrive Guido Scarpino su "Il Garantista". Da 17 anni scrivo sui giornali e denuncio la mafia. Mi hanno anche bruciato la macchina e minacciato. Mi è capitato poi di dare diritto di replica agli imputati. Per esempio a un certo Serpa. Perché lo ho fatto? Perchè vivo – o così credo – in uno stato di diritto. Non è che se uno è accusato di un reato mafioso perde il dirtto a difendersi, no?. E invece un Pm, durante la requisitoria, se l’è presa con quei giornalisti che danno la parola ai boss e di conseguenza «favoreggiano la mafia…» Il diritto di replica può essere concesso anche ad un boss di ‘ndrangheta in semilibertà o ad un presunto “capoclan” a piede libero? E’ una domanda, a mio avviso superflua - soprattutto se posta dal cronista di un giornale che si chiama il Garantista – che pongo a me stesso dopo aver udito la requisitoria di un pubblico ministero antimafia, svoltasi a Paola, in provincia di Cosenza, che, bontà sua, ha distribuito bacchettate a destra e a manca: ai politici, ai parlamentari e finanche – mi chiedo cosa ci sia dietro – al “solito articolista”, che avrebbe condotto una “attività di favoreggiamento” per aver offerto il diritto di replica. In un clima di omertà e condizionamento denunciato dal pm, mi sarei atteso, dallo stesso pm, quanto meno nomi e cognomi. Tuttavia, ciò non è accaduto, ed il quesito di cui sopra lo pongo a me stesso, anche perché il sottoscritto, in diciassette anni di professione in cui ha documentato quasi quotidianamente le attività delittuose delle cosche tirreniche, nonostante le auto bruciate (la sua auto) e le tante minacce mafiose subite (“spedizioni punitive” sotto casa e proiettili inclusi), ha avuto il buon senso di far parlare, in replica, il boss della cosca Serpa, a quel tempo in semilibertà. Mario Serpa ha infatti contattato, anni addietro, il cronista perché voleva replicare a chi, come il sottoscritto, lo accusava d’aver mandato alcuni parenti – che incutevano terrore facendo il suo nome – a taglieggiare gli esercenti commerciali; anticipava telefonicamente, al giornalista, l’invio di una lettera a sua firma, concordata con l’avvocato Gino Perrotta, che il giornale pubblicò sulle pagine regionali a corredo di un altro pezzo, a dir poco “cattivo”, sempre a firma del sottoscritto, in cui si riportava il curriculum criminale dello stesso boss di Paola. Quella missiva (che non è stata sequestrata, come erroneamente riferito) è stata consegnata, dal sottoscritto, ai carabinieri, dopo essere stata pubblicata. In diciassette anni di attività, dunque, ho fatto parlare Mario Serpa e non credo d’aver “favorito” nessuno. Era un suo diritto parlare, in uno Stato di diritto e dopo centinaia di batoste a mezzo stampa. Peraltro era stato promesso dal detenuto in semilibertà, sempre al sottoscritto, l’invio di un corposo “dossier-confessione” a sua firma, da trattare – era questo l’intento – in una serie di articoli o attraverso la stesura di un libro. Una inchiesta giornalistica che mi avrebbe consentito di raccogliere una importante “verità di parte” da mettere in contrapposizione ai fatti storici ed ai fatti processuali della mala nella provincia di Cosenza. Poi Mario Serpa venne arrestato e quel dossier venne trovato in carcere e finì – questo sì – sotto sequestro. Ho fatto parlare, poi, Nella Serpa, cugina di Mario e presunta “reggente” della cosca di Paola. Mi ha inviato delle lettere dal carcere che ho pubblicato (due, di cui una in ricordo del suo avvocato, il noto compianto penalista Enzo Lo Giudice), mentre altre tre/quattro missive (credo anche telegrammi), contenenti dure accuse e velate minacce al sottoscritto, non le ho rese note – ma consegnate (e non sequestrate) ai carabinieri quando mi è stata bruciata l’auto – solo perché di scarso interesse pubblico. Ricordo ancora, quando lavoravo a Calabria Ora, di essere stato contattato da un “gancio” per una intervista al boss di Cetraro, Franco Muto, che poi, nonostante la mia piena disponibilità a recarmi in quel di Cetraro, dove sono sempre stato odiato per le innumerevoli pagine da me stilate contro la cosca, non venne mai rilasciata. Ricordo ancora, diversi anni or sono, di essere stato convocato dai carabinieri, su richiesta dello stesso pm, per aver ospitato sulle mie pagine la denuncia di un avvocato penalista (Gino Perrotta) a discolpa di un suo assistito, un aspirante pentito prelevato dal carcere senza autorizzazione per indurlo a contattare telefonicamente i suoi “compari” al fine di raccogliere indizi nell’ambito di indagini antimafia. In questo caso, il magistrato perse mezz’ora del suo prezioso tempo solo per pormi una domanda: “Ma lei con chi sta? Con noi o con loro?”. Io risposi: “Io sto con me stesso. Faccio il giornalista”. Una risposta che mi portò, poco dopo ad un’altra convocazione, questa volta in caserma a San Lucido – pare sempre su richiesta dello stesso pm - per rispondere sulla fonte di una notizia di cronaca nera apparsa sul mio giornale ed a mia firma. Chiaramente mi rifiutai di fare nomi, ma fornii ai carabinieri (me l’ero portato dietro, perché avevo previsto la mossa del “nemico”) copia di un articolo apparso il giorno prima su un giornale concorrente in cui il giornalista intimo amico di quel pm, pubblicò la stessa notizia, precedendomi, ma lui – il collega – non venne convocato da nessuno. Dunque, dopo migliaia di articoli contro le cosche del Tirreno (ospitando anche tante veline dei “buoni”), dare spazio in replica, con tre articoli, ai “cattivi”, può anche non fare piacere a tutti, ma a me interessa poco proprio perché opinione “interessata”. Mi sono sempre guardato le spalle dalla ‘ndrangheta e dalla malapolitica ed ho imparato ad essere guardingo anche verso “padroni” in cerca di “servi” e verso quei pochissimi pm che vivono di visibilità ad ogni costo. Dopotutto, se un giornalista che fa parlare un mafioso è accusato – verbalmente, e non certo sulla carta – di essere un “favoreggiatore” (opinione personale non condivisa), un magistrato che acquista consapevolmente una villa abusiva (è la motivazione di un giudice), è uno che non rispetta le regole e non è in condizioni di dare lezioni a nessuno. P.S.: Oggi sono in vena di consigli: non dimenticate di chiedere al neo pentito Adolfo Foggetti chi è il mandante e chi l’esecutore dell’incendio della mia auto. Poi confrontate i nomi con quelli da me forniti al magistrato di Paola.
Ma questi magistrati non sono coerenti.
L'ex pm antimafia Ingroia difende un boss pluriomicida. È il legale del camorrista La Torre, accusato di 40 delitti. Di lui Saviano disse: "È solo uno smargiasso ambiguo", scrive Gianpaolo Iacobini su "Il Giornale". Antonio Ingroia, l'ex pm antimafia che difende un camorrista. Più d'uno è saltato sulla sedia quando il nome del magistrato che dava la caccia ai capi di Cosa Nostra è risuonato nelle aule del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere insieme a quello di Augusto La Torre, fino ai giorni dell'arresto - e pure oltre - boss del clan dei Chiuovi di Mondragone, alleato dei Casalesi ed egemone nell'alto Casertano, nel basso Lazio e lungo la costa domizia tra il 1980 e gli inizi dei Duemila. Davanti ai giudici sammaritani La Torre - che dietro le sbarre s'è laureato in Psicologia - è comparso da testimone nel processo a carico di Mario Landolfi, imputato di corruzione e truffa aggravata dal metodo mafioso per la vicenda d'un consigliere comunale dimessosi, secondo la Procura, in cambio dell'assunzione trimestrale della moglie in una società di servizi. L'ex ministro s'è sempre detto innocente e La Torre, in videoconferenza, ha smentito avesse contatti col clan, ma a far notizia è stata la nomina del nuovo legale del boss psicologo, poi confermata dal portavoce dell'ex procuratore aggiunto. Quello che, all'indomani del giuramento da avvocato, assicurava: «Per coerenza con la mia storia non difenderò né mafiosi né corrotti». E invece alla fine s'è ritrovato al fianco d'un barone del crimine organizzato, condannato in via definitiva a 22 anni per associazione camorristica e ad altri 9 per estorsione aggravata ed a tutt'oggi sotto processo anche per omicidio. La replica: «Nessuna contraddizione: è un collaboratore di giustizia». Insomma, un conto sarebbe difendere i mammasantissima tutti d'un pezzo, un altro assistere mafiosi contriti, anche quando, confidando nell'impunità, confessano i peggiori misfatti. Come La Torre, autoaccusatosi di una quarantina di omicidi, con le vittime crivellate di colpi, gettate nei pozzi di campagna e dilaniate con le bombe a mano, per smembrarne i corpi e lasciarli a marcire sotto acqua e terra. Di sicuro, c'è collaboratore e collaboratore: l'imperatore di Mondragone, detenuto dal 1996, saltò il fosso nel 2003, ma poco dopo la protezione gli fu revocata per un'estorsione. E i Tribunali hanno fin qui preso con le molle le sue dichiarazioni, negandogli sconti di pena, mentre proprio uno degli Ingroia-boys, lo scrittore Roberto Saviano, nel luglio del 2012 ne stroncava l'attendibilità, definendolo su Facebook «un pentito pieno di lati ambigui: smargiasso e feroce, è arrivato a far pentire l'intero clan per ricevere sconti di pena, in cambio della possibilità di uscire tutti dal carcere dopo una manciata di anni e conservare un potere economico legale, avendo ormai demandato il potere militare ad altri. Il boss, pur se pentito, dal carcere dell'Aquila tempo fa chiedeva anche danaro: aggirando i controlli scriveva lettere di ordini e richieste». Avesse ragione Saviano, che a sentire gli ingroiani ha ragione per definizione, è questo il nuovo cliente di Antonio Ingroia, un avvocato che non difende né mafiosi né corrotti. Ipse dixit.
Chi sono le istituzioni che aiuteranno chi denuncia?
Usura ed estorsioni, in manette il figlio del prefetto Sessa, scrive “Il Mattino”. Daniele Sessa, 31 anni, figlio del prefetto di Avellino, Carlo, è stato arrestato ieri dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Sessa è finito in carcere all’alba insieme a Cosimo De Pasquale. I due, entrambi tarantini, sono dietro le sbarre con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione. Nel corso delle indagini della Guardia di Finanza, eseguite anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, è emerso che Sessa e De Pasquale, gestivano nel capoluogo ionico un giro di usura nei confronti di numerosi commercianti, con il supporto anche di altre tre persone, delle quali due legate da vincoli di parentela. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre Daniele Sessa si occupava principalmente di procurare i capitali e di gestire la parte contabile, Cosimo De Pasquale, sfruttando la sua fama di uomo violento, si assicurava con continue minacce e intimidazioni fisiche e psicologiche, il rispetto delle scadenze da parte delle vittime finite nel giro di usura.
Gli altri tre componenti dell’associazione a delinquere, denunciati a piede libero, fungevano, a loro volta, da collettori insospettabili per la raccolta delle rate usurarie, mettendosi a disposizione come supporto logistico dell'associazione malavitosa. Ai due arrestati, su disposizione del pubblico ministero della Procura tarantina, sono stati sequestrati i conti correnti bancari, a titolo preventivo d'urgenza. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, è stata denominata «Ultima chanche». Le indagini delle Fiamme Gialle di Taranto sono andate avanti per circa un anno. I finanzieri sono entrati in azione dopo la denuncia di alcuni commercianti finiti nella rete degli strozzini. Secondo quanto accertato dagl inquirenti, Sessa e De Pasquale imponevano agli esercenti del rione Italia, che avevano chiesto piccole somme di denaro in prestito, tassi usurai che si aggiravano tra il 150-180 per cento.
Assistente sociale e usuraio. Nel blitz coinvolto Daniele Sessa, figlio di un Prefetto. Disponeva di macchine costose e con l’hobby delle competizioni motociclistiche, scrive “Taranto Buonasera”. Uno dei due presunti usurai, arrestati ieri dalla Guardia di Finanza, lavorava anche come assistente sociale. Daniele Sessa, 31 anni, incensurato e figlio di Prefetto, ufficialmente aiutava i bisognosi e, così come emerge dalle indagini delle Fiamme Gialle “ricavava redditi nell’ordine soltanto di poche centinaia di euro mensili, tanto da non presentare neppure le relative dichiarazione fiscali”. Di Daniele Sessa, che è attualmente in carcere con le pesanti accuse di associazione a delinquere e usura, gli investigatori del nucleo di polizia tributaria nel corso delle indagini hanno tracciato un preciso identikit. “Tra il 2011 e il 2013 era ancora a carico dei genitori, e tuttavia ciò non gli ha impedito di disporre di macchine costose, due Audi A6 e di coltivare l’hobby delle competizioni motociclistiche, anch’esso notoriamente piuttosto impegnativo dal lato finanziario”. Arrestato nella operazione “Ultima chance” anche il 46enne Cosimo De Pasquale che secondo l’accusa avrebbe a curato con continue minacce il “rispetto” delle scadenze da parte delle vittime. Altri tre, tra cui zio e nipote, tutti commercianti, sono indagati a piede libero. E’ emerso che fungevano da collettori insospettabili per la raccolta delle rate usurarie, mettendosi a disposizione come supporto logistico dell’organizzazione. I due arrestati sono attualmente detenuti nella casa circondariale di largo Magli, a disposizione del giudice delle indagini preliminari che li interrogherà lunedì prossimo. Nei confronti di De Pasquale e Sessa, su ordine del pm Lucia Isceri è stato operato anche il sequestro preventivo d’urgenza dei conti correnti bancari. Nel corso delle indagini, durate oltre un anno e condotte anche con intercettazioni telefoniche, è emerso che De Pasquale e il suo amico Sessa avrebbero gestito nel capoluogo jonico il giro di usura. Tra le vittime una decina di titolari di esercizi commerciali e di laboratori artigianali. Avrebbero pagato tassi usurari che arrivavano fino al 180% annui, titolari di ristoranti, di negozi di abbigliamento e imprenditori. Secondo l’accusa le vittime sarebbero state minacciate anche in casa o nei luoghi di lavoro. In alcune circostanze Sessa avrebbe proceduto anche personalmente a richiedere i pagamenti degli interessi usurari. Avrebbe comunque ricoperto il ruolo di mandante delle azioni estorsive che avrebbe, invece, messo in atto, il suo amico Cosimo De Pasquale.
La Guardia di Finanza di Taranto ha arrestato ieri due tarantini con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’usura e all’estorsione. Si tratta del 46enne Cosimo De Pasquale e del 31enne Daniele Sessa, scrive “La Voce di Manduria”. Quest’ultimo è figlio di Carlo Sessa, attuale prefetto di Avellino, già prefetto della neo costituita Prefettura della Provincia Bat e commissario prefettizio del comune di Manduria dove possiede ancora un’antica villa nelle campagne tra Manduria e Sava. Secondo l’accusa, i due arrestati, con la complicità di altri tre indagati a piede libero, avrebbero gestito un giro di attività usuraia nei confronti di numerosi commercianti ai quali praticavano interessi sino al 180% annui. L’inchiesta delle fiamme gialle assume particolare spessore proprio grazie alla presenza, tra gli indiziati di reato, del figlio del prefetto Sessa. Il giudice delle indagini preliminari, Martino Rosati, nella sua ordinanza, descrive il giovane come «vocato alla violenza». Seppure ancora a carico dei genitori – scrive il gip -, dichiarava redditi per poche centinaia di euro mensili, disponeva di autovetture costose e coltivava l’hobby altrettanto costoso delle competizioni motociclistiche.
Da un fatto ad un all'altro.
Il Prefetto (poco perfetto) del Bunga Bunga. Guarda un po’: il prefetto Carlo Ferrigno, uno dei testi chiave dell’atto di accusa di "papponaggio" a Berlusconi (“A casa di Berlusconi c’era pure la Minetti, col seno da fuori, che baciava Berlusconi in continuazione. Che puttanaio…”), è un esperto della materia: risulta iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale da sette donne: ricattate in cambio di pompini…, scrive “Dagospia”.
1 - IL PREFETTO SOTTO INCHIESTA PER VIOLENZA SESSUALE...Franco Bechis per "Libero". Uno dei testi chiave dell'atto di accusa a Silvio Berlusconi, il prefetto Carlo Ferrigno, è stato intercettato non su ordine di Ilda Boccassini e dei pm di Milano che stavano indagando sui festini di Arcore, ma del pm Stefano Civardi, che lo ha iscritto nel registro degli indagati per ipotesi di reato gravissime, fra cui la violenza sessuale. Il clamoroso particolare filtra con discrezione dal palazzo di Giustizia di Milano, e fa leggere sotto altra luce l'inchiesta principale. Ferrigno infatti è protagonista delle 389 pagine di intercettazioni telefoniche che Milano ha inviato in parlamento per inchiodare Berlusconi. Lo è perché Ferrigno è prefetto della Repubblica, e fra il 2003 e il 2006 è stato anche commissario anti-racket nominato dal governo Berlusconi. È attraverso le sue parole intercettate in tre telefonate che gli inquirenti e la stampa hanno disegnato il quadro delle feste di Arcore. Ferrigno non ha avuto mezze parole. È stato lui a definirle «un puttanaio» e a dare questo quadro alla stampa nelle prime ore. Lui a giudicare - alla luce dei festini - «un uomo di merda» il presidente del Consiglio, raccontando: «[...] tutte ragazze che poi alla fine erano senza reggipetto, solo le mutandine, quelle strette [...], capito? Bella roba, tutta la sera [...], pensa un po', che fa questo signore [...], ma che schifo quell'uomo». Trattandosi di un prefetto, di «un servitore dello Stato», quel giudizio è stato la chiave di lettura di quelle carte. Nessuno degli inquirenti però, inviandole a Montecitorio, si è premurato di fare sapere i guai giudiziari in cui il prefetto che si scandalizzava è incappato, e per cui il suo telefonino era sotto controllo del pm. Ferrigno è stato denunciato nel febbraio scorso dal presidente di Sos usura, Frediano Manzi, e dal presidente della Associazione Sos Italia Libera, Paolo Bocedi. Alla denuncia erano allegate sette testimonianze di donne che raccontavano ricatti e violenze sessuali subìte dal prefetto per sbloccare i loro mutui dal fondo anti-usura. Fatti avvenuti anche dopo l'abbandono dell'incarico di commissario, perché a loro dire il prefetto Ferrigno sosteneva di avere ancora in mano il commissariato. Le sette donne sono state convocate in procura e hanno confermato parola per parola i fatti. Una vittima dell'usura aveva consentito di filmare la sua denuncia, chiedendo di oscurare il volto. Il filmato è visionabile sul nostro sito www.libero-news.it. In procura sono arrivate altre due testi di accusa nei confronti di Ferrigno che hanno raccontato episodi di violenza sessuale svoltisi negli uffici o nelle abitazioni di Torino, di Milano e di Roma in cui si trovava il prefetto. Tutti e nove i verbali sono stati segretati dalla procura che ancora ha indagini in corso. Le accuse delle testi - lo capisce bene chi può visionare il video - sono gravissime. I presunti ricatti subiti sono di incredibile e odiosa violenza, le parole crude. Ferrigno - secondo il racconto - imponeva rapporti sessuali completi e talvolta orali in cambio dello sblocco dei mutui. E minacciava le malcapitate di non fare denuncia, perché tanto lui aveva relazioni con molti pm e molte procure e non le avrebbero mai prese sul serio. Il pubblico ministero Civardi invece le ha prese molto sul serio e così è nata l'inchiesta. Quando sono emerse le prime notizie, Ferrigno ha negato ogni responsabilità, sostenendo che le signore si erano inventate tutto. Sfortuna vuole che pochi giorni dopo, in tutt'altra procura - quella di Fermo - ma per episodi non dissimili si sia presentato un imprenditore, G.G., denunciando di avere subito analoghi ricatti dal prefetto per sbloccare la somma da lui attesa dal fondo anti-usura. Ha raccontato di avere dovuto pagare 5 mila euro per una serata che Ferrigno voleva trascorrere con alcune ragazze di un night club della riviera marchigiana. Il prefetto anche in questo caso è stato iscritto nel registro degli indagati, non per reati sessuali ma per corruzione. Entrambe le indagini sono ancora in corso, e per Ferrigno vale naturalmente la presunzione di innocenza. Anche se sembra singolare la sua inclinazione allo scandalo per le feste di Berlusconi. È curioso però come i verbali di intercettazione di Ferrigno siano finiti dentro un altro faldone che poco aveva a che vedere con il prefetto. Ferrigno infatti ha solo sfiorato le feste di Arcore, grazie a un suo rapporto assai stretto con una ballerina marocchina, Maria Makdoum, che la sera del 13 luglio ballò ad Arcore e nel cuore della notte telefonò a Ferrigno per un resoconto. Di quella telefonata ci sono solo i tabulati. Ma è citata come fosse avvenuta il giorno precedente in altre due telefonate, contenute in un brogliaccio di intercettazioni relative a telefonate che il prefetto ha fatto a un amico e al figlio il 22 e il 29 settembre 2010, a due mesi e mezzo dai fatti. Un giallo ulteriore che dovrà essere chiarito.
2 - LE INTERCETTAZIONI...Da "Libero". Che uomo di merda (...) Praticamente questo sai che faceva? Facevano le orge lì dentro, non con droga, non mi risulta, capito? E facevano quel lavoro lì. Bevevano tutte mezze discinte, e poi lui è rimasto con due o tre di queste (...) tutte ragazze che poi alla fine erano senza reggipetto, solo le mutandine quelle strette (...) capito? Bella roba, tutta la sera (...) pensa un po\', che fa questo signore (...) ma che schifo quell'uomo.
La testimone X.Y su Ferrigno....Sua Eccellenza il prefetto Carlo Ferrigno mi chiamò a Roma per vedere la mia pratica perché diceva che c'erano novità. Mi mandò a prendere da Tonino, il suo autista. Suonai. Mi venne ad aprire Sua Eccellenza e io ero un po' imbarazzata perché lo vidi in accappatoio. (...) La situazione era imbarazzante perché era nudo. Lui lasciava aperto l'accappatoio e quindi si vedevano i genitali. Cominciò con dei convenevoli (...) mi chiese di toccarlo. Mi disse proprio "Mi fai il favore di toccarmi?". Dissi che non ci pensavo proprio. Lui reagì sostenendo che non avevo capito, non dovevo pensare male... Mi prese per mano e mi portò in camera da letto... (...) Mi prese le mani e le mise sui suoi genitali... Io mi ritrassi. Lui disse che non avevo capito niente, (...) ma che ero abbastanza intelligente per capire che questa situazione mi avrebbe portato dei benefici. Lui (il prefetto Carlo Ferrigno) chiuse la porta dietro di me a chiave. Mi sono sentita sicuramente in trappola (...). Mi disse che non pretendeva tanto, che gli bastava anche un rapporto orale. Gli dissi che non se ne parlava proprio. Lui mi spinse sul letto e mi infilò la mano nei calzoni. Nel frattempo si era slacciato i suoi e aveva fuori il pene e i testicoli (...) Mi disse che le pratiche potevano restare ferme fino alla prescrizione, che lui aveva tanti amici nelle procure e anche fra i giudici e che la mia denuncia sarebbe finita in niente... Mi portò nei sotterranei... Mi prese la mano, la portò sui calzoni. Si slacciò la cerniera e in quella occasione mi disse che era la soluzione a tutti i miei problemi... se non vuoi avere un rapporto con me possiamo avere almeno un rapporto orale. Chiaramente mi rifiutai e lui mi disse che avevo deciso comunque la mia fine...
Ferrigno su Berlusconi. A casa di Berlusconi c'era pure la Minetti, col seno da fuori, che baciava Berlusconi in continuazione, insomma, senti, proprio un puttanaio eh? Quella Minetti lì, dice che poi non è nemmeno tanto bella, quella sera che c'erano tutte donne, Emilio Fede, Lele e lei, c'era anche la Minetti (...) quella mi chiamava, pur essendo lei una puttanella è rimasta esterrefatta quando stavano tutte discinte con le mutande, mezze ubriache, in braccio a Berlusconi e se le baciava tutte, le toccava tutte....
Si allarga la “tangentopoli” della Marina. Il Tribunale del Riesame di Taranto ha deciso di concedere i domiciliari ad alcuni ufficiali finiti in carcere a gennaio. Ma nelle prossime settimane altri potrebbero finire agli arresti, scrive Guido Ruotolo su “La Stampa”. Dopo gli arresti del 7 gennaio scorso di diversi alti ufficiali della Marina militare, per concussione, perché gli imprenditori erano stati costretti a versare una tangente del 10% (su tutti gli appalti e forniture), il Tribunale del Riesame di Taranto ha deciso di concedere gli arresti domiciliari ad alcuni ufficiali finiti in carcere. Ma negli atti depositati ai giudici, il pm Maurizio Carbone ha scritto che diversi imprenditori hanno chiamato in causa altri ufficiali della Marina militare di Taranto. Il pm ha glissato i nomi di questi ufficiali che sono stati anche loro iscritti sul registro degli indagati. Scrive nella sua memoria il pm Carbone: «I verbali delle sommarie informazioni degli imprenditori ascoltati contengono numerosi “omissis” nelle parti concernenti il coinvolgimento di altri ufficiali che sempre all’interno del Commissariato della Marina (Maricommi) di Taranto avrebbero preteso tangenti dagli imprenditori anche per gli altri reparti, sempre con la regia della direzione di Maricommi». Insomma, la Marina di Taranto rischia di essere affondata dalla inchiesta della Procura di Taranto, che sta svelando le tante falle di un «sistema» di corruzione che si tramandava da generazioni di ufficiali. E che non riguardava solo «il quinto reparto», ma anche gli altri. Dagli atti delle indagini risulta addirittura che dopo il primo fermo in flagranza di reato di un ufficiale della Marina che intascava le mazzette, e questo avveniva nel marzo scorso, le tangenti hanno continuato a essere pagate dagli imprenditori. «Si è rotto il muro dell’omertà», scrive il pm Carbone nella sua memoria. Ed ė facile ipotizzare che nelle prossime settimane altri ufficiali della base di Taranto finiranno agli arresti. Una falla. Enorme, continua Ruotolo. Cinque ufficiali e un sottufficiale della Marina militare in carcere per concussione. Le tangenti arrivavano anche a Roma, allo Stato Maggiore della Marina. Il 10% su tutti gli appalti. Ma il quadro potrebbe aggravarsi ancora di più. Ci sono altri indagati e gli arresti potrebbero scattare per altri ufficiali se quelli finiti in carcere stanotte dovessero decidere di collaborare, di ammettere, di confermare le ipotesi del pm Maurizio Carbone. Uno schizzo di fango, anzi peggio sulla Marina militare. Mare nostrum, il salvataggio di decine di migliaia di profughi è alle spalle. L’inchiesta della Procura di Taranto apre uno scenario inedito. Non si tratta di semplici «mele marce». È un sistema di corruzione radicato in quella che è la base aeronavale della nostra Marina. È stato un imprenditore che si è ribellato nel marzo scorso a svelare il sistema, facendo arrestare in flagranza di reato un capitano di Fregata, Roberto La Gioia, mentre intascava una busta con 2.000 euro. I carabinieri sequestrarono una pen drive e un appunto nella cassaforte dell’ufficiale che documentavano appalti, percentuali, spartizioni delle tangenti. Decine e decine di migliaia di euro finiti nelle tasche di diversi ufficiali. La Gioia ha ammesso che il suo predecessore gli fece le consegne. Insomma, ereditò il «sistema». Adesso c’è solo da aspettare, per vedere quanto esteso sia il marcio, alla Marina militare.
Appalti e mazzette, nuovo terremoto per la Marina a Taranto, scrive Francesco Casula su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Si allarga anche agli altri reparti di Maricommi l’inchiesta sul sistema di tangenti imposto agli imprenditori. È quanto emerge dalla memoria presentata ieri mattina dinanzi al tribunale del riesame dal sostituto procuratore Maurizio Carbone con la quale aveva chiesto la conferma del carcere per i quattro indagati che avevano appellato l’ordinanza emesso lo scorso 13 gennaio dal gip Pompeo Carriere e che invece il collegio di magistrati ha scarcerato. Si tratta del capitano di vascello Attilio Vecchi, assistito dall’avvocato Susanna Carraro, del capitano di fregata Riccardo Di Donna, del capitano di fregata Marco Boccadamo, difeso dai legali Raffaele Errico e Rocco Maggi, e del maresciallo Antonio Summa difeso dagli avvocati Raffaele Errico e Alessandra Semeraro. Il pubblico ministero Carbone ha depositato diverse testimonianze di imprenditori raccolte negli ultimi giorni nelle quali gli stessi avrebbero raccontato agli inquirenti che le tangenti venivano pagate anche ad altri ufficiali di altri reparti della Direzione di commissariato della Marina militare di Taranto. L’inchiesta sulla tangentopoli in divisa, quindi, non si ferma. Anzi. L’indagine ora sembra mettere sotto la lente di ingrandimento anche gli altri reparti di Maricommi. Dalle poche notizie trapelate, infatti, i verbali di interrogatorio depositati dal pm Carbone sarebbero in diverse parti coperti da «omissis» per nascondere i nomi di altri ufficiali che, secondo quanto raccontato negli ultimi giorni da una serie di imprenditori, avrebbero intascato mazzette. Tra i diversi indagati, al momento, la posizione più delicata è quella di Marco Boccadamo, l’ex vice direttore di Maricommi a cui il riesame ha concesso i domiciliari. Contro di lui, infatti, hanno testimoniato diversi imprenditori sostenendo di aver pagato mazzette all’ufficiale sia quando ricopriva l’incarico di comandante del V Reparto che di vice direttore. Inoltre dopo le prime dichiarazioni di La Gioia che avrebbe raccontato di aver suddiviso le mazzette con Boccadamo, ora si sarebbero aggiunti anche altri due imprenditori che al pubblico ministero avrebbero ammesso di aver versato tangenti all’ex vice direttore per ottenere appalti anche negli altri reparti. Conferme non da poco, quindi, che per gli inquirenti possono significare solo che gli elementi raccolti finora rappresentano solo una parte di quello che avviene all’interno del comando militare. Elementi raccolti, secondo il pm Carbone, grazie agli arresti effettuati che hanno consentito agli imprenditori di abbattere il muro di omertà che per anni ha garantito la sopravvivenza del sistema concussivo. Infine contro Boccadamo pesano anche le dichiarazioni del suo pari grado Giovanni Cusmano avrebbe ammesso di aver ereditato direttamente da lui «la prassi» del 10 percento e di aver diviso con lui almeno in una occasione una tangente da 4mila euro versata dall’imprenditore tarantino che per primo ha dato il via a questo terremoto giudiziario. Cusmano ha spiegato al pm Carbone e al gip Carriere di essere arrivato al comando del V Reparto quasi consapevole che avveniva qualcosa di sospetto: «Che Boccadamo facesse queste cose, si sapeva all’interno».
"Pizzo come i malavitosi", 7 arresti per le tangenti su appalti della Marina militare. Secondo l'accusa, da più di 10 anni, gli imprenditori erano tenuti a pagare il 10 per cento del valore delle commesse per aggiudicarsi i lavori. In manette cinque ufficiali, un sottufficiale e un dipendente civile, scrive Vittorio Ricapito su “La Repubblica”. Scandalo in Marina Militare. Per la procura di Taranto ufficiali e responsabili degli uffici imponevano il pizzo alle aziende fornitrici e dell'appalto. Un sistema di tangenti a percentuale fissa, il dieci per cento sull'importo di ogni appalto o fornitura, sotto minaccia di rallentare o ostacolare i pagamenti. "Come la malavita organizzata", il pizzo veniva imposto "in modo rigido e con brutale e talora sfacciata protervia", scrive il gip Pompeo Carriere nell'ordinanza di custodia cautelare, causando danni notevoli sia alle singole imprese che all'intera economia locale. Con l'aggravante che il giro di tangenti era imposto da dipendenti dello Stato, per la maggior parte militari, "che hanno giurato fedeltà alla Repubblica e all'osservanza delle regole, innanzitutto deontologiche, dell'ordinamento di appartenenza". Secondo gli investigatori, il "sistema del 10 per cento" andava avanti da almeno dieci anni, una prassi illecita che tacitamente si trasferiva da un comandante all'altro, come un passaggio di consegne. All'alba di questa mattina sono scattate le manette. I carabinieri del comando provinciale di Taranto guidati dal colonnello Giovanni Tamborrino hanno portato in carcere l'attuale e due ex vice direttori del commissariato militare marittimo di Taranto (Maricommi), un ex capo reparto, un sottufficiale capo deposito, un dipendente civile addetto alla contabilità del reparto e un capo ufficio del settore logistico dello Stato Maggiore della Marina militare, tutti accusati di concussione. Gli arresti sono stati eseguiti a Roma, Napoli e Taranto. In carcere sono finiti il capitano di vascello Attilio Vecchi, di 54 anni (in servizio al Comando Logistico di Napoli); il capitano di fregata Riccardo Di Donna, di 45 anni (Stato Maggiore della Difesa-Roma); il capitano di fregata Marco Boccadamo, di 50 anni (Stato Maggiore Difesa-Roma); il capitano di fregata Giovanni Cusmano, di 47 anni (Maricentadd Taranto); il capitano di fregata Giuseppe Coroneo, di 46 anni (vice direttore Maricommi Taranto); il luogotenente Antonio Summa, di 53 anni (V reparto Maricommi Taranto); e Leandro De Benedectis, di 55 anni (dipendente civile di Maricommi Taranto). Secondo gli investigatori le tangenti venivano riscosse dall'ufficiale alla guida del quinto reparto e poi divise in percentuali a seconda degli accordi con chi aveva seguito l'iter amministrativo della pratica. C'era da oliare diversi ingranaggi: chi dal comando di vertice assicurava la copertura finanziaria sui relativi capitoli di bilancio, chi autorizzava l'atto di spesa, chi sottoscriveva l'atto dispositivo, chi materialmente contabilizzava assegni e provviste ed infine chi si interfacciava direttamente con la vittima del sistema. Il tutto naturalmente suddiviso in percentuali formulate in base all'importanza che rivestiva nel procedimento ogni singolo attore. L'inchiesta del sostituto procuratore Maurizio Carbone è decollata il 13 marzo del 2014 quando i carabinieri arrestarono in flagranza di reato il capitano di fregata Roberto La Gioia, 45 anni, comandante del 5° reparto di Maricommi, fermato nel suo ufficio subito dopo aver intascato una tangente di 2mila euro da un imprenditore. Questo aveva già denunciato tutto ai carabinieri sostenendo di aver subìto per anni il "sistema del 10 per cento" e versato tangenti per circa 150 mila euro per mantenere l'appalto dello smaltimento delle acque di sentina delle navi militari. Fra casa ed ufficio del militare, gli investigatori trovarono circa 44mila euro ma soprattutto alcune pen drive su cui era annotata la contabilità occulta e la lista delle imprese che pagavano tangenti. Il 5° reparto di Maricommi, guidato da La Gioia fino al suo arresto, è quello che si occupa dell'approvvigionamento, stoccaggio e rifornimento di combustibili e lubrificanti delle unità navali della Marina Militare e dei mezzi aeromobili, assicurando rifornimenti h24 e 365 giorni all'anno. Nei successivi nove mesi gli investigatori si sono concentrati sulle dichiarazioni dell'ufficiale arrestato, hanno ascoltato i titolari delle imprese che lavorano con la Marina militare, messo sotto controllo telefoni e sequestrato documenti, computer e buoni carburanti, portando alla luce un giro di pizzo di notevoli dimensioni. La Marina militare, si legge in una nota, "ribadendo il proprio pieno sostegno all'azione della magistratura, ha incrementato al proprio interno le attività ispettive e di controllo finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, a salvaguardia del personale che presta quotidianamente servizio con spirito di sacrificio e senso dello stato, compiendo il proprio dovere anche a rischio della vita".
Marina Militare e appalti, 7 arresti per concussione, scrive “la Gazzetta del Mezzogiorno”. Un “vero e proprio pizzo imposto in modo rigido e con brutale e talora sfacciata protervia, e che ha causato nel complesso danni notevoli sia alle singole imprese che all’intera economia locale, sostanzialmente alla stregua dell’agire della malavita organizzata”. Lo scrive il gip di Taranto Pompeo Carriere nell’ordinanza di custodia cautelare, richiesta dal pm Maurizio Carbone, notificata a 7 indagati, tra militari e civili, nell’ambito di una inchiesta sugli appalti gestiti dalla Marina militare. La tangente imposta era pari al 10% dei profitti. I carabinieri del comando provinciale di Taranto hanno arrestato il vice direttore di Maricommi, due ex vice direttori, un ex capo reparto, un sottufficiale capo deposito, un dipendente civile addetto alla contabilità del reparto e un capo ufficio del settore logistico dello Stato Maggiore della Marina Militare per concussione. In concorso tra loro – secondo l'accusa – abusando delle loro qualità e dei loro poteri, con la minaccia di ostacolare la regolare emissione dei mandati di pagamento per la esecuzione dei lavori di manutenzione e forniture di servizi e materiale loro affidati per conto della Marina militare, gli indagati hanno costretto “vari imprenditori a versare materialmente al capo del V Reparto di Maricommi, in tempi diversi, più somme di denaro non dovute per importi variabili e altre utilità, per un valore complessivamente comunque equivalente al 10% circa dei profitti derivanti dai servizi svolti”. Somme che il capo reparto, precisa una nota dei carabinieri, “provvedeva a distribuire successivamente in diverse parti percentuali secondo gli accordi tra loro intervenuti”.
Gip: imponevano «pizzo» come malavitosi, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”. E' in corso, nelle provincie di Taranto, Roma e Napoli, l’esecuzione, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, di sette ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le misure restrittive e contestuali perquisizioni vedono fra i destinatari appartenenti della Marina Militare fra i quali Ufficiali, Sottufficiali e personale civile, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di concussione nell’ambito di appalti in favore dell’ente. L'inchiesta, avviata dopo la denuncia presentata da un imprenditore che sosteneva di aver pagato tangenti in relazione ad un appalto, sfociò il 12 marzo 2014 nell’arresto del capitano di fregata Roberto La Gioia, di 46 anni, comandante del quinto reparto di Maricommi, che si occupava di contratti e appalti. L'ufficiale fu bloccato dopo aver ricevuto una busta con 2mila euro dall’imprenditore, che rappresentava – secondo l'accusa – una tranche di una tangente imposta per emettere i mandati di pagamento nei confronti della sua azienda. Il sospetto degli investigatori è che il militare abbia chiesto una tangente del 10 per cento. I carabinieri successivamente perquisirono l’appartamento e l’ufficio di La Gioia trovando altro denaro ritenuto frutto della concussione. Furono sequestrate anche due pen drive dell’arrestato, in cui furono scoperti file con un elenco di imprese. Accanto a ognuna di esse era riportato il valore dell’appalto aggiudicato e il pagamento di tangenti. Sono cinque ufficiali in servizio a Napoli, Roma e Taranto, un sottufficiale e un impiegato, entrambi in servizio a Taranto, le sette persone portate in carcere dai carabinieri nell’ambito dell’indagine sulle tangenti imposte sugli appalti della Marina Militare. In carcere sono finiti il capitano di vascello Attilio Vecchi, di 54 anni (in servizio al Comando Logistico di Napoli); il capitano di fregata Riccardo Di Donna, di 45 anni (Stato Maggiore della Difesa-Roma); il capitano di fregata Marco Boccadamo, di 50 anni (Stato Maggiore Difesa-Roma); il capitano di fregata Giovanni Cusmano, di 47 anni (Maricentadd Taranto); il capitano di fregata Giuseppe Coroneo, di 46 anni (vice direttore Maricommi Taranto); il luogotenente Antonio Summa, di 53 anni (V reparto Maricommi Taranto); e Leandro De Benedectis, di 55 anni (dipendente civile di Maricommi Taranto). Sono tutti indagati in concorso con il capitano di fregata Roberto La Gioia, di 46 anni, ex responsabile di Maricommi, arrestato il 12 marzo del 2104 ed attualmente e sottoposto all’obbligo di firma. L’ufficiale fu indagato per concussione nei confronti di una serie di imprenditori locali, assegnatari di servizi per conto della Pubblica Amministrazione nell’ambito degli appalti gestiti dalla direzione di Commissariato per la Marina Militare di Taranto. Al graduato fu sequestrata una somma di denaro contante, suddivisa in singole mazzette, per un ammontare complessivo pari a 44mila euro. Il gip scrive nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi che il sistema ideato dagli indagati faceva sì che gli imprenditori concussi fossero vittime di una “vera e propria prassi illecita che si trasferisce da un comandante all’altro, in un ideale passaggio di consegne, più o meno tacito”.
Ma non è la prima volta.
Un provvedimento di interdizione dagli incarichi è stato chiesto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto Vincenzo Petrocelli nei confronti di quattro ufficiali della Marina Militare, coinvolti in un’inchiesta su appalti assegnati dalla Marina Militare per lavori nell’Arsenale di Taranto, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”. La richiesta è stata accolta dal gip del tribunale di Taranto Michele Ancona: trattandosi tuttavia di personale militare è necessario prima procedere agli interrogatori di garanzia, già fissati per il 28 e il 31 marzo 2008. Per i quattro ufficiali era stato chiesto l’arresto, ma il gip ha respinto la richiesta di misura cautelare. In tutto sono nove gli indagati. I quattro destinatari del provvedimento interdittivo sono l’ammiraglio Giulio Cobolli, attuale comandante dell’Arsenale militare, l’ammiraglio ispettore Alberto Gauzolino, ex direttore dell’Arsenale di Taranto, trasferito a Roma; Pietro Covino, in servizio a La Spezia, e Nicola Giustino, contrammiraglio in servizio a Taranto. Si ipotizzano anche i reati di truffa e turbativa d’asta perché alle gare di appalto avrebbero partecipato ditte che non avevano requisiti. L'inchiesta sfociò, il 9 novembre 2005, nel sequestro preventivo e probatorio di un’area di circa 18.000 metri quadrati all’interno dell’Arsenale della Marina Militare, nella quale lavorano numerose ditte appaltatrici, e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione delle navi. Successivamente fu notificato il provvedimento di sequestro preventivo ai titolari delle ditte, alcune delle quali avrebbero la sede legale in un bar o in campagna. All’ammiraglio ispettore Alberto Gauzolino fu affidata la custodia giudiziale dell’area interessata dal sequestro. Le indagini dei carabinieri del Nil e dei funzionari dell’Ispettorato del lavoro facevano riferimento a presunte violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Durante le ispezioni, sarebbe emersa la mancanza dei requisiti utili per poter partecipare alle gare di appalto espletate dalla Marina militare. Per altre aziende, invece, furono avviati accertamenti sulle modalità con le quali era stato ottenuto il certificato Nato necessario per compiere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle navi militari.
Lecce, confessano altri due poliziotti della Stradale, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno. Altri due poliziotti della Stradale confessano. E’ accaduto ieri mattina nel corso dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame. Stef ano Simonetto, 42 anni, e Luigi De Vincenzo, di 55, entrambi di Nardò, hanno ammesso di essersi «adeguati un andazzo che era generalizzato» fra gli agenti in servizio nella sezione di Polizia stradale di Lecce. I due sono in carcere dal 12 maggio scorso sulla scorta di u n’ordinanza di custodia cautelare in cui si contestano i reati di associazione per delinquere e concussione. Gli agenti sono accusati di aver preteso mazzette e regali da commercianti ed imprenditori. In cambio furgoni e camion delle aziende «compiacenti » non sarebbero stati multati. Il sistema delle «regalie» e delle mazzette è già stato illustrato da altri due agenti: l’ispettore capo Fr ancesco Reggio di Lecce e l’assistente Anna Maria Petrelli di Lizz anello. Ieri sono arrivate le dichiarazioni degli altri due agenti che hanno ammesso di aver ricevuto i regali e di aver fatto qualche «giro» fra gli imprenditori per ottenere buoni benzina. Simonetto e Di Vincenzo sono difesi dagli avvocati Giuseppe Bonsegna e Donato Mellone. Nel corso dell’udienza il pubblico ministero Guglielmo Cataldi ha depositato anche nuovi verbali con le dichiarazioni di altri imprenditori i cui nomi compaiono nella lista di coloro che avrebbero versato «mazzette» e fatto regali agli agenti della Stradale. I titolari di alcune aziende sono già stati sentiti. Ed hanno confermato di aver consegnato denaro, regali e buoni benzina ai poliziotti per evitare il rischio di essere multati. Ieri davanti al collegio del Tribunale del Riesame sono arrivate le posizioni di altre cinque agenti raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si tratta di Leonardo Impero Delle Donne 45 anni, di Caprarica; di Franco Carlà, 58, di Lizzanello; di Maurizio Scarofo n e , di Lecce; Giuse ppe Piccinno, 51, di Aradeo; di Giuseppe Amenini, 46, di Maglie. Fra di loro c’è stato chi ha preferito rinunciare al ricorso al Riesame. Gli agenti sono assistiti dagli avvocati Giancarlo Dei Lazzaretti, Luigi Rella, Luigi Greco, Pantaleo Cannoletta, e Laura Minosi. Intanto continuano da parte degli ufficiali della sezione di pg della Polizia di Stato gli ascolti degli imprenditori come persone informate sui fatti.
Rossana di Bello, fa fallire Taranto e si prende un vitalizio a 58 anni, scrive di Franco Bechis su “Libero Quotidiano”. La domanda l’ha fatta all’inizio di settembre, ed è bastata una sola seduta dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Puglia per esaudirla, perfino in modo retroattivo. Dal primo settembre scorso c’è un ex politico in più a prendere quel vitalizio che da anni ci raccontano falsamente di avere abolito: è Rossana di Bello, una delle pioniere di Forza Italia. Ci sono non poche anomalie in quel vitalizio che era stato abolito e continua a correre come un fiume. La prima anomalia è quella di uno Stato che premia per tutta la vita un politico che non ha particolarmente brillato: la Di Bello è stata sindaco di Taranto per lunghi anni e con lei la città è stata fra i pochi comuni italiani a fallire, con un dissesto finanziario per oltre 900 milioni di euro (è stata anche sotto inchiesta penale, ma in secondo grado l’hanno assolta dando la colpa ai suoi collaboratori. La Corte dei Conti però ce l’ha ancora nel mirino per danno erariale). La seconda anomalia è che la Di Bello con soli cinque anni lavorati prende da settembre e prenderà fino all’ultimo suo giorno (con possibilità di rendere reversibile ai suoi cari) un assegno mensile da 3.862,27 euro lordi. La terza anomalia riguarda l’età pensionabile della fortunata politica: ha compiuto 58 anni il 28 agosto scorso. La legge Fornero vale dunque per tutti, ma non per i politici italiani, che con soli 58 anni e per avere lavorato solo 5 anni hanno diritto a una pensione reversibile che è quasi il triplo della pensione media degli italiani che hanno lavorato 40 anni. Quarta anomalia, chi sul lavoro combina un disastro come è evidente nella storia di Taranto, alla fine ci rimedia un bel premio.
Lecce, aumentano processi a magistrati, 12 indagati, 92 parti offese. L'inaugurazione dell'anno giudiziario a Lecce con competenza su Taranto: tra i temi caldi l'ambiente, con l'Ilva, il fotovoltaico, gli abusi edilizi e i rifiuti interrati. In crescita durata media procedimenti civili, in lieve calo quella dei processi di primo grado, scrive Chiara Spagnolo su “La Repubblica” L’Ilva, i parchi fotovoltaici, i rifiuti interrati e poi le colate di cemento sulle aree protette, vittime di “reati perpetrati oltre che da privati spesso anche dal pubblico”. È stato l’ambiente uno dei settori più impegnativi per la magistratura salentina, come emerge dalla relazione fatta per l’inaugurazione dell’anno giudiziario dal presidente vicario della Corte d’appello di Lecce, Mario Fiorella: “In tutto il Salento è grave la situazione del traffico di rifiuti pericolosi di varia provenienza, spesso sparsi in discariche abusive o anche interrati con danni per i terreni e le falde acquifere”. Relazione sintetica, quest’anno, perché racconta il lavoro fatto sotto la presidenza di Mario Buffa, da due settimane in pensione, al quale è stato rivolto un plauso unanime. L’anno appena trascorso - nei tribunali di Lecce, Brindisi e Taranto – è stato caratterizzato da difficoltà legate alla perdurante carenza di organico, sia dei magistrati che del personale amministrativo, a cui si è reagito con un impegno che ha consentito “di mantenere inalterato il trend relativo alla durata dei processi”, ha detto il presidente. I numeri, a quanto pare, descrivono una situazione sotto controllo: aumenta la durata media dei processi civili, ma solo in fase d’appello (891 giorni contro gli 806 dell’anno precedente), ma aumenta anche il contenzioso, che non viene alleggerito dalla mediazione civile “che non ha dato effetti positivi”, con solo 63 procedimenti iscritti nel 2013. Risulta addirittura leggermente diminuita, invece, la durata media dei processi di primo grado a Lecce e Brindisi (663 giorni a Lecce e 419 a Brindisi rispetto ai 675 e 442 dell’anno precedente) mentre è leggermente aumentata a Taranto (619 giorni a fronte dei 580 del 2012). I processi d’Appello invece sono risultati più veloci in entrambe le sedi (560 giorni a Lecce e 733 a Taranto, contro i 674 e gli 823 dell’anno precedente). E se le lungaggini della giustizia pongono il 2013 in perfetta linea con gli anni passati, risulta invece in crescita il numero di processi a carico di magistrati: ben 113 sono stati infatti quelli iscritti nel registro degli indagati, comprendendo sia quelli in servizio nel Distretto di Lecce (inchieste poi trasferite per competenza a Potenza) sia quelli in servizio a Bari, mentre 92 sono i magistrati che risultano parti offese. La relazione sull’andamento della giustizia ha preso poi in esame il lavoro effettuato dalle Procure, scavando anche nelle metodologie di indagine utilizzate ed evidenziando, per esempio in materia di intercettazioni telefoniche, come la Procura di Brindisi sia quella che ne ha fatto un maggiore utilizzo (con 647 utenze controllate a fronte delle 437 di Lecce e 641 di Taranto), mentre 1.267 sono i telefoni intercettati dalla Dda nell’ambito del controllo delle organizzazioni criminali. Proprio in tema di mafia, è stata sottolineata dal presidente Fiorella la diminuzione degli omicidi (2 a Taranto e 2 a Lecce) “dettato dall’esigenza di non richiamare l’attenzione di polizia e magistratura con azioni eclatanti”. Usura ed estorsioni, invece, continuano ad essere terreno privilegiato d’azione dei clan ma molto spesso “non vengono denunciate dalle vittime per paura di ritorsioni”, confermando l’appellativo di “reati sommersi”, che danno infatti origine a pochi procedimenti giudiziari: 40 per usura e 182 per estorsione nelle tre province.
E poi....
Denuncia un concorso ma l'Ateneo la accusa: «Collezionava incarichi», scrive Luca Barile su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Un assegno di ricerca, pagato dall’Ateneo dal 2007 al 2011, entra a gamba tesa in un processo non ancora incominciato, ma che sta già facendo discutere. Dalla procura di Taranto, è notizia dell’altro ieri, il pubblico ministero Remo Epifani ottiene il rinvio a giudizio per una decina di professori universitari, accusati a vario titolo di aver favorito, nella fase di valutazione dei titoli, il candidato risultato vincitore di un concorso per ricercatore, bandito nel dicembre del 2009. Ma dalla direzione generale dell’Ateneo, nel frattempo, era partita una lettera, datata 12 dicembre 2014 scorso, indirizzata all’avvocatura dello Stato. Nella missiva si chiede un parere su come comportarsi nei confronti di Monica Bruno, titolare dell’assegno di ricerca. Da una verifica interna parrebbe che la signora, moglie del magistrato tarantino Ciro Fiore, possa aver percepito quella borsa senza averne avuto diritto. E quindi l’Università è pronta a pretenderne la restituzione. Quello che non è chiaro, ed ecco perché il parere richiesto all’avvocatura, è se si possa anche annullare il contratto che, a suo tempo, l’assegnista Bruno firmò con l’Ateneo. Questione non da poco (senza contratto, niente titolo) considerando che la signora è l’autrice dell’esposto dal quale è partita l’indagine sul concorso da ricercatore, un posto nel settore del diritto commerciale nella sede distaccata, a Taranto, dell’ateneo barese. Perché il titolo di assegnista ha il suo valore in una procedura di valutazione comparata. Tanto più che proprio sui titoli, Bruno sta giocando la sua partita contro Giuseppe Sanseverino, vincitore del concorso. La tesi, accolta da una sentenza del 2013 del Consiglio di Stato, è che i commissari valutarono positivamente alcuni titoli presentati da Sanseverino, in particolare delle esperienze scientifiche all’estero, senza accertarne la veridicità. Il Consiglio di Stato ordinò all’Università di ripetere la comparazione dei titoli, per i due concorrenti in causa ed il rettore, Antonio Uricchio, annullò il precedente decreto di nomina di Sanseverino, con cui questi era stato dichiarato vincitore. Inoltre, ha messo in moto la procedura per formare una nuova commissione. Della vecchia, sono indagati alcuni docenti baresi e non, compreso il professor Gianvito Giannelli, noto per aver svolto l’incarico di curatore fallimentare del Bari Calcio. È indagato anche il professor Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante, anche se non faceva parte della commissione. Sanseverino, però, ha denunciato all’Ateneo che la sua concorrente avrebbe ottenuto incarichi, come amministratore giudiziario, curatore e revisore dei conti durante il periodo dell’assegno di ricerca. La cosa è incompatibile con l’esclusivo impegno richiesto ad un assegnista. E' stata fissata per il 13 febbraio 2015 prossimo l’udienza preliminare, dinanzi al gup del tribunale di Taranto Vilma Gilli, a carico di 11 persone per un presunto concorso truccato per un posto di ricercatore in diritto commerciale alla sede tarantina della Facoltà di Economia dell’università di Bari.
Concorso Università a Bari: 11 indagati tra cui 4 professori, scrive Massimiliano Scagliarini “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Una dottoranda con il registratore sempre acceso in tasca e un concorso da ricercatore in Diritto commerciale annullato dal Consiglio di Stato. Un calderone di vita universitaria che ha scatenato una guerra tra Procure, coinvolgendo 11 persone (tra cui 4 docenti) che oggi si ritrovano indagati con l’accusa di aver truccato non solo le selezioni, ma persino l’assegnazione degli incarichi gratuiti di supplenza. Il punto è che la dottoranda Monica Bruno, che dal 2009 ha inviato diverse denunce sulla questione, è moglie di un magistrato di Taranto, Ciro Fiore, all’epoca dei fatti gip nel Tribunale jonico ed oggi trasferito al Minorile. A febbraio il procuratore aggiunto di Bari, Lino Giorgio Bruno, aveva chiesto e ottenuto l’archiviazione delle accuse per una parte dei fatti, ma a inizio giugno il pm di Taranto, Remo Epifani, ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini ad 11 persone: oltre ai commissari del concorso annullato, nell’elenco ci sono il vincitore, Giuseppe Sanseverino, 46 anni, di Massafra, ed i docenti baresi Gianvito Giannelli, 54 anni, e Ugo Patroni Griffi, 48 anni. Ce n’è abbastanza per parlare di liti in famiglia. Anche perché Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante, della Bruno è stato non solo tutor ma anche testimone di nozze. E Giannelli, ultimamente molto noto alle cronache per l’incarico di curatore fallimentare del Bari calcio, è a sua volta sposato con un sostituto procuratore. Ma quando la commissione che doveva nominare un ricercatore in Diritto commerciale ha prescelto Sanseverino rispetto agli altri tre partecipanti (tra cui c’erano il figlio del professor Giorgio Costantino e la figlia della professoressa Eda Lofoco), la dottoressa Bruno ha preso carta e penna e con l’avvocato Carlo Raffo ha denunciato una serie di presunte irregolarità, arrivando a formulare persino i capi di imputazione: nell’avviso di conclusione delle indagini la procura di Taranto li ha ripresi quasi tutti, e quasi parola per parola. In particolare, la Bruno ha denunciato quello che lei stessa chiama il «metodo del cappello» per l’assegnazione delle supplenze: il professor Patroni Griffi (che per questo è accusato di truffa e falso ideologico) avrebbe presentato domanda salvo poi ritirarla all’ultimo momento, avvantaggiando così - questa è la tesi - il dottor Sanseverino. Un punto su cui la procura di Bari, chiedendo l’archiviazione, aveva però espresso un’opinione contraria: semplicemente perché anche in quei casi Sanseverino poteva comunque vantare i titoli migliori dell’unica altra candidata. Il concorso per ricercatore del 2009, che a breve dovrà essere ripetuto con una nuova commissione e presumibilmente vedrà di nuovo la Bruno ai blocchi di partenza, è stato annullato sulla base di una decisione della giustizia amministrativa sulla valutazione comparativa dei titoli. Per questo la procura di Taranto accusa di abuso d’ufficio sia Sanseverino sia i commissari, tra cui oltre a Giannelli ci sono il bolognese Filippo Paolucci e il campano Ermanno Bocchini. Ma soprattutto, nei guai dopo le denunce (e le registrazioni) della Bruno sono finiti alcuni suoi ex colleghi dottorandi, accusati di favoreggiamento aggravato per aver negato ciò che probabilmente hanno detto a proposito del concorso mentre non sapevano di essere intercettati. Al di là dei docenti di ruolo, il vero beffato di tutta questa storia finora è proprio Sanseverino, che oltre a non aver ottenuto il posto è accusato anche di aver «barato» nel curriculum. Sanseverino ha depositato in procura una lunga memoria, in cui esamina in dettaglio i propri titoli accademici, si toglie qualche sassolino dalla scarpa, ma passa anche al contrattacco nei confronti della Bruno: ha infatti documentato che la collega, mentre percepiva l’assegno di dottorato da parte dell’Università di Bari, continuava a svolgere l’attività professionale di revisore dei conti. Nel frattempo il dossier di Sanseverino è finito alla Corte dei Conti: questa storia non finirà mai...
Concorso all'Università, 11 indagati illustri. "Truccarono le carte". La selezione per il posto di ricercatore in diritto commerciale internazionale, la procura di Bari archivia, Taranto verso il giudizio. Il Consiglio di Stato annulla la prova, scrive Giuliano Foschini su “La Repubblica”. Un concorso universitario. Undici indagati illustri. Un dibattito tra due procure, quella di Taranto e quella di Bari, che sullo stesso fatto hanno opinioni diverse: a Bari archiviano, nel capoluogo jonico sono pronti ad andare a giudizio. La storia è quella del concorso da ricercatore in diritto commerciale internazionale bandito dall'università di Bari per la sede di Taranto. La selezione viene vinta dal professor Giuseppe Sanseverino. Ma una delle partecipanti, Monica Bruno, non ci sta e presenta il ricorso amministrativo: il Tar le dà torto mentre il Consiglio di Stato ribalta la sentenza e di fatto annulla la prova che infatti si sta rifacendo in queste settimane. Non è chiaro, dicono i giudici amministrativi, in una sentenza in cui parlano tra le altre cose di "eccesso di potere", quali criteri abbia utilizzato la commissione per "sovvertire il diverso peso dei titoli di ricerca esibiti da ciascun candidato", dunque è tutto da rifare. Il giudizio amministrativo però rappresenta soltanto una fetta di questa storia. La Bruno ha presentato un corposissimo esposto in procura, preparando persino i capi di imputazione. In un primo momento Taranto ha inviato gli atti a Bari, iscrivendo nel registro degli indagati ventinove persone, cioè tutto il consiglio di dipartimento. Con un provvedimento del 26 febbraio del 2014 firmato dal sostituto Luciana Silvestris e dall'aggiunto Giorgio Lino Bruno, Bari però archivia il reato di falso inizialmente ipotizzato. E rimanda le carte a Taranto per ulteriori valutazioni. Nei giorni scorsi la doccia fredda: il pm di Taranto Remo Epifani ha fatto notificare a undici persone un avviso di garanzia. E' indagata l'intera commissione di esame composta dai professori Gianvito Giannelli, Luigi Paolucci ed Ermanno Bocchino. L'accusa è di falso e abuso di ufficio perché "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, procuravano intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale al candidato Sanseverino in concorso con il quale agivano, consentendogli il positivo superamento della procedura di valutazione contributiva. Cagionano così un danno ingiusto alla candidata Bruno". Non solo: dice il pm che ci sono anche dei falsi compiuti per "riconoscere al Sanserverino titoli preferenziali inesistenti" per "formulare giudizi favorevoli su pubblicazioni che non potevano essere valutate", il tutto chiaramente per consentire al professore di vincere la prova a scapito della Santoro. Nell'inchiesta è indagato anche il professor Ugo Patroni Griffi che però non faceva parte della commissione ma che è accusato dalla Santoro e dalla procura di aver favorito Sanseverino, perché suo allievo. Agli atti sono state depositate alcune intercettazioni fatte dalla stessa Santoro nella quale altri docenti, ora iscritti nel registro degli indagati (gli altri sono i professori Ermanno Bocchini, Luigi Paolucci, Anna Zaccaria, Francesco Sporta Caputi, Laura Tafaro, Giuditta Lagonigro, Rosa Calderazzi e Francesco Costantino) raccontavano alla collega di sapere che Sanseverino avrebbe dovuto vincere il concorso perché "aveva dei titoli fortissimi". Sanseverino a sua volta è passato al contrattacco depositando una memoria contro la Bruno (moglie del magistrato Ciro Fiore scrive nella memoria) nella quale fa notare tra le altre cose che la collega avrebbe ricevuto un assegno di ricerca mentre svolgeva altri ruoli, tra i quali “perizie contabili e societarie, curatele fallimentari e procedimenti penali” presso gli uffici giudiziari tarantini. Eppure al titolare dell'assegno è "inibito lo svolgimento - dice Sanseverino - in modo continuativo di rapporti di lavoro nonché l'esercizio di attività libero professionali". Oltre questo c'è poi la questione amministrativa. Come detto il Consiglio di Stato ha annullato il concorso perché la commissione avrebbe favorito Sanseverino a scapito della Bruno. 'Confrontando le relative attività di ricerca - si legge infatti nella sentenza emerge, in termini oggettivi, un dato di prevalenza per la dottoressa Bruno". Dopo la decisione dei giudici amministrativi è stata formata una nuova commissione che però ha interrotto i lavori. La Santoro ha mandato loro una diffida, spiegando che avrebbero dovuto rivalutare soltanto i suoi titoli e quelli di Sanseverino e non quelli di tutti gli altri candidati. Una teoria che non ha convinto però il rettore, Antonio Uricchio, che infatti ha chiesto un parere al Consiglio di Stato per capire come comportarsi ed è in attesa di ricevere una risposta. Per il momento il concorso è bloccato. Intanto però l'avviso è diventato un caso in ambito accademico. Anche se tutte le persone coinvolte si dicono serenissime. Se da una parte il legale di Patroni Griffi, Ugo Paliero, si dice sicurissimo di chiarire tutto in tempi stretti anche vista la "posizione marginale" del suo assistito, il difensore del professor Giannelli, Vito Mormando spiega: "I rilievi che gli vengono mossi fanno riferimento a presunte e opinabili irregolarità amministrative, tra l'altro già travolte dalla sentenza del Tar e dal decreto di approvazione degli atti da parte del rettore. Comunque un dato è pacifico: il concorso si è svolto presso l'università di Bari. La competenza non è tarantina".
USURA ED ESTORSIONE: CONVIENE DENUNCIARE? RISPONDONO LORO. ANTONIO GIANGRANDE. PINO MANIACI E MATTEO VIVIANI DE LE IENE PER I FRATELLI CAVALLOTTI E L'ITALGAS. FRANCESCO DIPALO. LUIGI ORSINO. PINO MASCIARI. COSIMO MAGGIORE. LUIGI COPPOLA. LUIGI LEONARDI. TIBERIO BENTIVOGLIO. IGNAZIO CUTRO'.
ANTONIO GIANGRANDE. Alla domanda rispondo come dr. Antonio Giangrande, presidente nazionale della “Associazione Contro Tutte le Mafie”, iscritta presso la Prefettura di Taranto e per gli effetti riconosciuta dal Ministero Dell’Interno.
Per dare una risposta un po’ lunghina, ma estremamente esauriente ed esaustiva, bisogna partire dalla concezione che si ha dei mafiosi in Italia. Nel calcio, così come nella politica, specie a sinistra, vige il concetto che se si vince e si ha successo, si vale, se si perde, gli altri han rubato. Ergo: tu sei ricco e di successo, allora sei un mafioso. Così come molte associazioni antiracket ed antiusura, che non sono di sinistra o riconducibili alla CGIL, la mia associazione non è inserita nel sistema precostituito dell’antimafia Grasso-Ciotti-ANM/MD e per gli effetti vedo e denuncio le storture di una struttura mediatico-giudiziaria. Non ho il megafono dei media di sinistra col paraocchi ideologico, né tantomeno di quelli di destra, occupati ad osannare Berlusconi. Per questo non mi rimane che testimoniare il presente nei miei libri. In particolare: “Mafiopoli” e “Usuropoli e fallimentopoli”. Tornando alla domanda. La risposta la danno gli stessi protagonisti più noti della cronaca dimenticata. Mi astengo dal dilungarmi sulla mia storia. Un ristorante bruciato e dalla burocrazia mai risarcito, né fatto ricostruire. Dal 1998 al 2014 non mi hanno abilitato alla professione di avvocato in un esame di Stato, che come tutti i concorsi pubblici ho provato, con le mie ricerche ed i miei libri, essere tutti truccati. A Taranto, tra i tanti processi farsa per tacitarmi sulle malefatte dei magistrati, uno si è chiuso, con sentenza del Tribunale n. 147/2014, con l’assoluzione perché il fatto non sussiste e per non doversi procedere. Bene: per lo stesso fatto si è riaperto un nuovo procedimento ed è stato emesso un decreto penale di condanna con decreto del Gip. n. 1090/2014: ossia una condanna senza processo. Tentativo stoppato dall’opposizione.
Comunque in regime di sottomissione ideologica l’establishment ha altre cose da pensare rispetto a quello che il popolo anela.
PINO MANIACI. Beni sequestrati, Maniaci: “Gli dei delle misure di prevenzione”. Il direttore di Telejato è stato ascoltato in Commissione regionale antimafia. In quella sede ha presentato il suo dossier sui curatori dei patrimoni sottratti ai boss di Cosa nostra: “Sono sempre gli stessi e gestiscono patrimoni immensi. A volte con problemi di incompatibilità”, scrive Riccardo Campolo su “L’Ora Quotidiano”. “A fronte di quattromila richieste per fare l’amministratore giudiziario, vengono nominati sempre i soliti noti: Dara, Modica de Mohac, Benanti e soprattutto Cappellano Seminara. Quest’ultimo, tutt’ora, continua a gestire capitali immensi, nonostante qualche problema di incompatibilità”. Pino Maniaci, direttore di Telejato, ricostruisce per loraquotidiano.it le denunce portate davanti alla Commissione regionale antimafia durante la sua audizione dello scorso 17 dicembre. Secondo quanto riferito da Maniaci, il sistema delle misure di prevenzione farebbe acqua da tutte le parti, non rispettando il principio ispiratore della legge Rognoni-La Torre. “Non sono riuscito a scalfire con le mie denunce – ha spiegato – il sistema delle assegnazioni degli incarichi a pochi privilegiati. Quando ho riferito ciò che sapevo, mi sono reso conto che la politica era consapevole di ciò che stava succedendo. Forse i parlamentari non sono nelle condizioni di intervenire, al massimo hanno il potere legislativo per correggere”. Nessuno ha preso provvedimenti nei confronti delle persone denunciate dal direttore di Telejato? ”Non funziona così, funziona così per le persone normali, ma non per gli dei delle misure di prevenzione”. “Un lungo e intenso confronto in Commissione Antimafia regionale. Abbiamo appena finito di ascoltare Pino Maniaci, direttore di Telejato. Pino dipinge un quadro a tinte fosche, tante ombre e poche luci, ci fornisce spunti interessanti, soprattutto sulla gestione dei beni confiscati, e nei prossimi giorni ci consegnerà un dossier dettagliato che studieremo con attenzione. Gli ho detto, salutandolo, che non è solo e che deve continuare a fare il suo lavoro, il giornalista, come sempre ha fatto: con la schiena dritta e la testa alta”. Lo scrive sui social network il vicepresidente della Commissione regionale Antimafia, Fabrizio Ferrandelli. a conclusione dell’audizione del direttore della Tv di Partinico al centro di continue intimidazioni.
LE IENE. Le Iene e Mafia, antimafia e aziende che affondano. Nella puntata di giovedì 29 gennaio 2015, de Le Iene Show uno dei servizi proposti ha toccato il tema della mafia e l’inviato Matteo Viviani ha voluto raccontare la storia della famiglia Cavallotti ed ambientata a pochi chilometri da Palermo. Una vita, quella dei fratelli Salvatore, Vincenzo, Giovanni, Gaetano, dedicata a svolgere il proprio lavoro, con passione e dedizione con l’intento di lasciare ai figli un modo migliore in cui vivere, salvo poi trovarsi, da un giorno all’altro, senza nulla a causa dello stato che sottrae tutto in nome della legalità. In poco tempo vedere i frutti di anni di lavoro, mandati in fumo da qualcun’altro che è stato messo a gestire il tutto al posto di proprio dallo stato. I fratelli raccontano la loro storia sin dagli inizi: dalle idee geniali che frutta una grande molo di lavoro, all’infiltrazione della mafia che spinge per riscuotere il pizzo, fino ad arrivare ad una situazione insostenibile fatta di arresti assurdi e condanne per associazione a delinquere. Il resto ve lo facciamo vedere senza svelarvi altro, per farvi gustare a pieno quanta assurda è questa storia.
A Le Iene Show nella puntata andata in giovedì 29 gennaio 2015, Matteo Viviani racconta la storia di un’azienda di famiglia siciliana affondata dalla mafia e dal mancato sostegno dello Stato. Siamo a pochi chilometri da Palermo, nella ditta familiare gestita dai fratelli Salvatore, Vincenzo, Giovanni e Gaetano Cavallotti. Tutti e quattro hanno dedicato anima e corpo a questo lavoro per sperare di poter lasciare qualcosa ai rispettivi figli. Ma neppure la loro realtà imprenditoriale in crescita è passata inosservata alla mafia locale che ha bussato alla loro porta pretendendo il pagamento del pizzo. Da qui è iniziato un calvario in cui l’intervento dello Stato non ha fatto che peggiorare le cose. Nel 98 i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni e arrestato le vittime della vicenda, ovvero proprio loro che erano “costretti” a pagare il pizzo. Chi ha pagato viene trattato alla stregua di complice: le banche prendono le distanze e l’attività inizia a dare segni di cedimento. A capo delle aziende sono state messe persone terze (amministratori delegati) e ai proprietari originari non resta che assistere inermi al graduale fallimento, alla distruzione inesorabile del frutto di anni di sacrifici. I contratti già in essere decadono e passano ad altre società. Ma c’è di peggio: il patrimonio di famiglia viene sequestrato in via preventiva fino a quando, sostengono le autorità, “non riusciranno a dimostrare la provenienza lecita dei beni”. La “giustizia” arriva dopo 12 anni e 4 gradi di giudizio: i Cavallotti vengono dichiarati innocenti, estranei alla Mafia. Viviani ha intervistato l’amministratore delegato per capire se veramente ha sempre agito a favore dell’azienda vittima del sequestro. Spunta una differenza sospetta di un milione di euro circa di cui i Cavallotti non hanno visto un centesimo. Se volete vedere il servizio completo su questa assurda vicenda di in-giustizia italiana cliccate nel link sotto.
Le Iene parlano dei Cavallotti, scrive Salvo Vitale su “Peppino Impastato”. Ieri sera è andato in onda Italia Uno, nel corso della trasmissione “Le Iene” un lungo e documentato servizio sui fratelli Cavallotti, su come chi dovrebbe rappresentare lo stato abbia distrutto un’azienda florida che dava lavoro a circa 200 dipendenti e su come questa vicenda, che ormai si protrae da 16 anni, malgrado le assoluzioni del tribunale e la riconosciuta estraneità dei fratelli Cavallotti a qualsiasi forma di collusione mafiosa, per decisione dell’ineffabile dottoressa Saguto, il magistrato che dirige l’Ufficio Misure di Prevenzione di Palermo ancora continua . I dati e i contatti con l’azienda sono stati forniti in gran parte da Telejato Vista la complessità dell’inchiesta che l’emittente conduce da tempo, lo staff delle Iene ha deciso, per il momento di affrontare solo un’impresa, quella dei Cavallotti, ma riservandosi di portare all’attenzione le altre malversazioni che, su questo campo, sono consumate in nome e con l’avallo dello stato. Davvero meschina e al di là di ogni umano senso di dignità la figura dell’ ex amministratore giudiziario Modica de Moach, che non ha saputo dare spiegazioni delle sue malversazioni e delle false fatturazioni girate a un’azienda del fratello. In pratica abbiamo assistito in diretta alle prove dimostrate di come si commette un reato, con l’avallo dei magistrati delle misure di prevenzione e come, chi dovrebbe rappresentare lo stato e tenere in piedi le aziende che gli sono state affidate, fa di tutto per distruggerle ai fini di un utile personale. Le riprese di un’azienda con i mezzi di lavoro arrugginiti, abbandonati, con i capannoni spogli, non possono che generare tristezza. Come succede in Italia, non succede niente, anzi, se succede qualcosa, succede per danneggiare chi chiede giustizia. Come nel caso dell’ultimo recentissimo sequestro operato ai figli dei Cavallotti, che cercavano di raccogliere i cocci dell’azienda. Questo è quello che la redazione di Telejato vorrebbe andare a dire alla Commissione Antimafia, se questa si decidesse di tenere conto della richiesta di ascoltarla, già sottoscritta da 40 mila cittadini.
La storia allucinante dei fratelli Cavallotti di Belmonte Mezzagno, estratto da I Siciliani Giovani aprile 2014 n°19: Beni Confiscati: così non funziona di Salvo Vitale, Pino Maniaci, Christian Nasi e pubblicato su “La Nuova Belmonte”.
La Comest. Quella dei fratelli Cavallotti di Belmonte Mezzagno è una storia allucinante. Sono cinque fratelli che, negli anni ‘90 cominciano a lavorare per alcune aziende legate al nascente affare della metanizzazione in Sicilia. Fiutano che c’è in ballo un fiume di miliardi in arrivo, si parla di 400 miliardi delle vecchie lire, specialmente da parte della Comunità Europea, che li affida alla Regione e decidono di mettersi in proprio, ognuno con una propria azienda relativa a uno specifico settore. E’ tutto in ordine, partecipano ai bandi della Regione, hanno i requisiti richiesti, cominciano ad avere numerosi appalti, specie nelle Madonie, con la clausola del possesso di una gestione trentennale, per poi tornare tutto all’Ente Committente, cioè ai comuni. Sul mercato nasce, a far concorrenza a loro l’Azienda Gas spa, per iniziativa di un impiegato regionale, di nome Brancato, il quale chiede, per fondare la società, i soldi a Vito Ciancimino, allora all’apice della carriera politica: Ciancimino si serve di un suo commercialista, Lapis, legato ai più discussi politici siciliani, da Cintola a Vizzini: viene stipulato, con l’avallo, a Mezzoiuso, dell’allora Presidente della Commissione Antimafia Lumia, un protocollo di legalità e si aprono le porte per gli appalti: unico ostacolo la Comest e le altre aziende dei fratelli Cavallotti, ma si fa presto a metterli fuori gioco: Belmonte è la patria di Benedetto Spera, uno dei più temuti mafiosi legati a Bernardo Provenzano: attraverso il collaboratore di giustizia Ilardo, infiltrato appositamente, viene trovato un “pizzino” nel quale, con riferimento a un appalto ottenuto ad Agire, è scritto: “Cavallotti due milioni”. Si fa presto a incriminare i Cavallotti, che, come tanti pagavano il pizzo, per associazione mafiosa, e a far disporre il sequestro di tutti i loro beni. Siamo nel 1998, allorchè Vito Cavallotti viene arrestato per reati legati al 416 bis, da cui, nel 2001 viene assolto. Dopo che nel 2002 la Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza con una condanna e dopo una serie di vicende processuali, nel 2011 Vito Cavallotti è assolto definitivamente e prosciolto da ogni accusa, ma, qualche mese dopo, nei suoi confronti scattano altre misure di prevenzione personale e patrimoniale, sino ad arrivare al 22.10.2013, allorchè il PG Cristodaro Florestano propone il dissequestro dei beni e la sospensione delle misure di prevenzione nei confronti di tre dei fratelli Cavallotti: ad oggi le motivazioni della sentenza non sono state ancora depositate. All’atto della prima denuncia viene nominato come amministratore giudiziario un certo Andrea Modìca di Moach, il quale già dispone di altre nomine da parte del tribunale , oltre che essere il terminale di altre aziende, tipo la TOSA, di cui si serve per complesse partite di giro, sino ad arrivare all’Enel gas. L’ammontare dei beni confiscati è di circa 30 milioni di euro , ma ben più alto è il valore di quello che i Cavallotti avrebbero potuto incassare nei lavori di metanizzazione dei comuni, mal’azienda non è stata ancora dissequestrata, malgrado siano passati quasi tre anni, anzi, per, viene confiscata una nuova azienda di uno dei fratelli, che si è spostato a Milazzo e nel dicembre 2013 estrema beffa, viene disposto un nuovo sequestro ad un’azienda creata dal figlio, nel tentativo di risollevare la testa, la Euroimpianti plus, e l’amministrazione giudiziaria, revocata al Modìca, viene affidata a un certo Aiello, che si rifiuta di far lavorare in qualsiasi modo, il ragazzo titolare, la cui sola colpa è di essere figlio di uno che è stato indagato, condannato e poi prosciolto dall’accusa di associazione mafiosa. Gli ultimissimi sequestri riguardano un complesso di aziende edili di Vito Cavallotti, figlio di Salvatore, la Energy clima, la Sicoged la Tecnomet e la Ereka CM, una parafarmacia già chiusa dal 2013. La prima seduta svoltasi il 30.1.2014 è stata rinviata nientemeno che al 22.5 per ritardo di notifica. Tutto ciò malgrado la proclamata innocenza dei Cavallotti. Per non parlare della rovina nella quale si sono trovate circa 300 famiglie che ruotavano attorno alle aziende. Rimane ancora senza risposta la domanda di questa gente: perché questo accanimento? E il motivo è forse da ricercare nell’ingente somma che il tribunale dovrebbe pagare per risarcire queste imprese che sono state smantellate da amministratori giudiziari voraci e spregiudicati.
Questo sistema non guarda in faccia a nessuno.
ITALGAS. Italgas: il colosso commissariato dall’antimafia. A dicembre 2014 ascoltati anche i vertici Snam in commissione parlamentare, scrive Luca Rinaldi su “L’Inkiesta”. Commissariata per sei mesi dal 9 luglio 2014 da parte della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, e commissariamento prorogato di altri sei mesi lo scorso dicembre. È l’attuale situazione della società Italgas, controllata al 100% da Snam, i cui principali azionisti di Snam sono Cassa Depositi e Prestiti Reti, Cassa Depositi e Prestiti e per un altro 49% altri investitori istituzionali. È la prima volta che una società quotata subisce una misura del genere. Italgas conta 1.500 concessioni, una rete di distribuzione di 53mila chilometri e 6 milioni di utenze a cui fornisce gas per quasi 7,5 miliardi di metri cubi. Un colosso che per gli inquirenti ha però trovato tra i suoi affari anche quelli di alcune società riconducibili a cosa nostra. E il gas storicamente attrae gli interessi della mafia siciliana da Mattei ai giorni nostri. Così capita che il cane a sei zampe si trovi tra le società cui appalta la metanizzazione del Sud Italia strutture in mano a soggetti destinatari di misure di prevenzione patrimoniali in passato accusati (ma poi assolti) di concorso esterno in associazione mafiosa e altre società su cui le procure antimafia hanno messo la lente d’ingrandimento. I pm di Palermo hanno richiesto e ottenuto per Italgas il commissariamento in seguito a una inchiesta partita sulla società Gas spa, società riconducibile a Vito Ciancimino e invece gestita formalmente dall’imprenditore Ezio Brancato. La stessa Gas nei primi anni duemila risulta però essere sotto il controllo di del figlio di don Vito, Massimo, che tramite due legali, la cede alla spagnola Endesa. Nel maggio del 2013 tre società del gruppo Gas finiscono in amministrazione giudiziaria e l’inchiesta della procura di Palermo, coordinata dai pm Petralia e Scaletta prosegue. Si arriva così ai fratelli Cavallotti di Belmonte Mezzagno, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, e poi assolti. Tuttavia i due sono destinatari di alcune misure di prevenzione patrimoniale. Vengono sequestrati ai due beni per il valore di circa otto milioni di euro nel dicembre 2013, e nell’inchiesta fanno capolino due società, la Imet e la Comest. Quest’ultima, che già compariva in un pizzino di Bernardo Provenzano e un’altra, la Euroimpianti, mettono nei guai Italgas. Proprio la Comest fa parte di un pacchetto di acquisizioni di Italgas, che ne prende il controllo successivamente all’amministrazione giudiziaria nel 2009. Ma la società che segna un punto di svolta per la vicenda è la EuroImpianti, che secondo la procura di Palermo sarebbe sempre riconducibile ai fratelli Cavallotti. EuroImpianti vince l’affidamento di alcuni appalti in Sicilia e Liguria e si occupa della manutezione di altre strutture controllate da Eni. Il 22 dicembre 2011 Euroimpianti entra in amministrazione giudiziaria in seguito alle inchieste della procura di Palermo, e nel luglio 2014 è il turno di Italgas, che secondo i giudici «aveva sicuramente cognizione del fatto che la Euroimpianti pur se formalmente intestata ai giovanissimi figli di Cavallotti Vincenzo e Cavallotti Gaetano, era di fatto gestita dai predetti imprenditori». Per il tribunale di Palermo ci sono sospetti di infiltrazioni mafiose all'interno di Italgas, che è anche quotata in Borsa: ora si trova affidata a un amministratore giudiziario. Sullo sfondo della vicenda una interdittiva antimafia atipica nei confronti della Euroimpianti arriva il 2 novembre del 2011 dalla procura di Messina. L’interdittiva atipica, presente nell’ordinamento italiano e ora non più in vigore dopo l’approvazione del codice antimafia del 2013, faceva accendere una spia nei confronti di un’azienda che prendeva parte a un appalto, ma senza effetti immediati: l’appaltatore può discrezionalmente valutare se interrompere o meno il rapporto. Per il tribunale di Palermo ci sono sospetti di infiltrazioni mafiose all'interno di Italgas, che è anche quotata in Borsa: ora si trova affidata a un amministratore giudiziario. A ricostruire la vicenda è Luca Schieppati, per tre mesi amministratore delegato di Italgas prima del commissariamento, in audizione alla Commissione Parlamentare Antimafia. L’11 novembre del 2014 Schieppati si siede davanti alla commissione parlamentare antimafia per riferire sulla vicenda Italgas. Esordisce specificando che «il racconto di questa sera è quello di una persona che, fino al 10 aprile 2014, era direttore generale operations di SNAM Rete Gas, dopodiché dall'11 aprile è stato in Italgas, dove in questi tre mesi esatti, dall'11 aprile 2014 all'11 luglio 2014, non ha mai saputo di questa vicenda». Fatto sta che dopo la sospensione EuroImpianti viene riabilitata nell’ottobre del 2012: per 14 mesi la società non ha partecipato a gare di Italgas, poi riprende il servizio. Arriva il commissariamento anche per Italgas nel luglio 2014. «misura - dice Schieppati in audizione - che ha colto Italgas di sorpresa, perché non ci era mai pervenuta, prima di quella data, nessuna richiesta né alcuna informazione relativamente ai fatti». Viene sentito anche Leonardo Rinaldi, Ex amministratore delegato di Gas Natural Distribuzione Italia SpA, altra società che ha portato le indagini dei pm su Italgas, ma la sua audizione in commissione è rimasta secretata. A dicembre vengono sentiti in commissione anche Paolo Mosa, amministratore delegato di Snam Rete Gas e Carlo Malacarne, Amministratore delegato di Snam, i quali ricalcano le parole di Schieppati sulla sorpresa del provvedimento di commissariamento, e indicano che la società ha già avviato un monitoraggio interno per la selezione delle ditte che partecipano agli appalti. Malacarne, amministratore delegato di Snam: «Non solo non ne ero al corrente, ma non è nel mio compito normale essere al corrente di un rapporto fra la società che ha l'indipendenza operativa e i suoi appaltatori». «Mi sento di dire - ha riferito Malacarne ai commissari - che ci sono state delle carenze, sicuramente, a livello locale, localizzate. Queste carenze vanno comunque individuate». E ancora «Il discorso di Eurimpianti Plus e Cavallotti l'ho letto nella notifica. Non solo non ne ero al corrente, ma non è nel mio compito normale essere al corrente di un rapporto fra la società che ha l'indipendenza operativa e i suoi appaltatori. Io non ne ero al corrente non solo nel 2009, ma neanche nel 2014. Questo discorso di Cavallotti l'ho letto, ma non ne ero assolutamente al corrente. Lo dico molto sinceramente». Uno scarico di responsabilità che forse chiarisce ancora poco i rapporti tra le società in gioco, cioè Italgas e quelle dei Cavallotti. Dopo sei mesi, dal giugno al dicembre 2014 i commissari di Italgas e i giudici sembrano non vederci ancora chiaro e, come riporta La Stampa, in Italgas permangono «condizioni di potenziale agevolazione degli interessi di soggetti collegati alla criminalità organizzata» mentre il pm «ha rappresentato di aver in corso il completamento di ulteriori attività investigative». È uno dei passaggi del provvedimento, secondo quanto riferito da chi ha visionato i documenti, con il quale il tribunale di Palermo ha prorogato per altri sei mesi il commissariamento della società controllata da Snam Rete Gas. In sostanza le indagini della procura di Palermo non si sono fermate, e si è in cerca di altri elementi utili, in particolare su negligenze nella gestione del sistema informatico degli appalti. Letta dunque la relazione degli amministratori giudiziari (Sergio Caramazza, Luigi Giovanni Saporito, Marco Frey, Andrea Aiello), depositata lo scorso 18 dicembre e fatta propria dai giudici nel provvedimento del 24, avrebbe fatto emergere in particolare una serie di carenze nel sistema di concessione degli appalti per i lavori sulla rete. I commissari: in Italgas permangono «condizioni di potenziale agevolazione degli interessi di soggetti collegati alla criminalità organizzata». Carenze, scrive ancora La Stampa, in grado di avere impatti negativi sul budget e sui conti della società. Proprio alla luce di queste carenze, i pm avevano chiesto e ottenuto nel novembre scorso il sequestro dei dati storici del sistema che gestisce gli appalti dell’intero gruppo Snam, al fine di «estrarre» i contratti relativi a Italgas. A poco è servito, secondo il giudice, l’attività posta in essere da Snam , che lo scorso 13 dicembre aveva a sua volta proposto una serie di misure per eliminare i problemi riscontrati dagli amministratori. Insomma, il rischio che Italgas rientri tra gli appetiti di cosa nostra è ancora alto e i giudici dicono che i commissari nella stessa Italgas che genera un terzo dei ricavi del gruppo Snam, pari a 1,3 miliardi di euro, devono restarci almeno fino al prossimo luglio.
«Ringrazio Riccardo Spagnoli e Matteo Viviani per avere, per la prima volta, portato a conoscenza degli italiani una verità che ancora oggi nei media, nelle aule di Tribunale, financo in Commissione Nazionale Antimafia si tenta di mistificare. Ringrazio anche il dott. Antonio Giangrande per avere ora - come in passato - trattato in maniera imparziale e professionale la storia della mia famiglia. Un ringraziamento particolare va a Pino Maniaci per avere per primo dato ascolto alla richiesta di aiuto della mia famiglia - scrive sul suo profilo Facebook Pietro Cavallotti - Ciò che più dà fastidio non è tanto il costatare che i sacrifici di due generazioni sono andati in fumo perché non siamo mai stati attaccati ai beni materiali; non è tanto vedere che un amministratore giudiziario si è impunemente arricchito sulle tue spalle con l'avallo - non so se consapevole o meno - del giudice che lo ha nominato, che ne avrebbe dovuto controllare l'operato e al quale avevamo a tempo debito segnalato le irregolarità compiute da questo signore amministratore. La cosa che più ci mortifica è continuare ad essere accostati alla mafia nonostante una sentenza di assoluzione passata in giudicato. Per chi ha subito le vessazioni della mafia nell'attività di impresa, financo nella vita privata non c'è nulla di peggio che essere accostati alla criminalità mafiosa. La mafia ci fa schifo! Noi siamo assolutamente lontani dalla logica mafiosa della prepotenza e della prevaricazione. Noi giovani abbiamo vissuto la nostra infanzia tra aule di Tribunale e case circondariali. Ma non abbiamo mai perduto la speranza nella giustizia. Pensavamo che l'assoluzione dei nostri padri ci avesse restituito la dignità che il fango di quelle infamanti accuse ci aveva tolto. Ci siamo messi in gioco e, ispirandoci ai valori che ci sono stati trasmessi dai nostri padri - l'amore per lavoro, il senso della legalità, il rispetto per il lavoratore che abbiamo sempre anteposto al bene personale - abbiamo costituito con le nostre mani una società che con impegno e sacrificio siamo riusciti a far crescere producendo il benessere per le famiglie dei nostri collaboratori e una aspettativa di vita migliore per noi stessi. Pensavamo di avere recuperato quello che la cattiva giustizia aveva tolto a noi e ai nostri padri. Avevamo per un attimo accarezzato il pensiero di vivere in un Paese civile. Ma evidentemente ci sbagliavamo. Nel 2012, infatti, viene sequestrata la nostra azienda. Sapete perché? Perché l'amministratore giudiziario che si vede nel video ha fatto una segnalazione al Tribunale dicendo che la nostra società faceva concorrenza alla Comest. Nel provvedimento di sequestro si continua a ripetere che i nostri padri sono vicini alla mafia. Ma come si può dire una cosa del genere a fronte di una sentenza ampiamente assolutoria? Ed ecco che proprio quando pensi di esserti rimesso in carreggiata, precipiti di nuovo in basso. Ti ritrovi isolato, emarginato dai media e da qualcuno che fino a poco prima ritenevi essere amico, tutto intorno terra bruciata. Siamo letteralmente impossibilitati nella ricerca di trovare un lavoro. Nessuno è disposto ad assumerci per paura di ripercussioni giudiziarie. Sono addirittura stati capaci di porre in amministrazione giudiziaria la Italgas perché questa ha avuto dei regolari rapporti commerciali con la nostra società che, secondo l'accusa, sarebbe riconducibile ai fratelli Cavallotti "vicini ad esponenti di spicco della criminalità organizzata". Questo ci ferisce e ci sconforta. Con la massima - e forse ingenua - fiducia nelle istituzioni, mandiamo una lettera alla Commissione Nazionale antimafia chiedendo di essere ascoltati per chiarire la vicenda giudiziaria della nostra famiglia e i rapporti che ci sono stati tra la nostra società e la Italgas, esprimiamo la più ampia disponibilità a collaborare per l'accertamento della verità. Ad oggi non ci è stata data alcuna risposta. Qualcuno potrebbe dire <<le colpe dei padri non devono ricadere sui figli>>. Ma talvolta nello sconforto ci chiediamo: quale sarebbe la colpa dei nostri padri? La loro colpa è forse quella di essere innocenti? Quella di avere subito le minacce della mafia in un periodo storico in cui opporvisi significava sottoscrivere la propria condanna a morte? Noi siamo orgogliosi di tutto quello che i nostri padri hanno fatto, di tutto quello che ci hanno insegnato. Ci dicono che noi siamo i prestanome dei nostri padri. Cosa falsa. Noi portiamo con orgoglio il loro nome e non lo prestiamo! E se la conseguenza dell'amore che noi proviamo nei loro confronti deve essere quella di portare insieme a loro questa croce noi siamo disposti a farlo, mai abbandonando la fiducia nella giustizia che siamo certi, prima o dopo, arriverà. L'auspicio è che giornalisti seri come Antonio Giangrande, Pino Maniaci, Marco Salfi, le stesse Iene, tutti gli altri protagonisti della antimafia vera (come Salvo Vitale), tutti i protagonisti della lotta contro tutte le mafie - per dirla con il dott. Giangrande -, tutti gli uomini liberi non asserviti al potere e non inclini a fare aprioristicamente da eco alla voce delle procure, possano ancora impegnarsi per far luce sul malaffare che ruota attorno al sistema criminale delle misure di prevenzione, dietro il quale spesso si nasconde e si arricchisce impunemente sotto il manto della legalità la criminalità meglio organizzata».
La Mafia dell’Antimafia: l'inchiesta di Telejato audita in Parlamento, scrive Pino Maniaci su “Change”. C’è ancora un business di cui non si parla, un business di milioni di euro. Il business dell’Antimafia. Quattro mesi dopo il brutale assassinio di Pio La Torre, nel 1982, viene approvata la legge Rognoni-La Torre, che consentiva il sequestro e la confisca di quei beni macchiati di sangue. Finalmente, lo Stato aveva le armi per attaccare gli ingenti patrimoni mafiosi. Nel ’96 grazie a Libera nasce la legge 109 che disponeva l’uso sociale dei beni confiscati alla mafia, e finalmente terreni, case, immobili tornano alla comunità. Tutto bellissimo. Nella teoria. Qualcosa però non funziona. Questi beni, sequestrati, confiscati, falliscono l'uno dopo l’altro. Il 90% di imprese, aziende, immobili, finisce in malora spesso prima ancora di arrivare a confisca. A non essere rispettata e ad aver bisogno di una riforma strutturale è la Legislazione Antimafia - Vittime della mafia e relativo Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Parliamo di aziende e imprese sequestrate perché di dubbia legalità: aziende che forse furono acquistate con proventi mafiosi, o che svolgono attività illecito-mafiose, e che per chiarire questo dubbio vengono poste sotto sequestro ed affidate alla sezione delle misure di prevenzione del Tribunale competente. In questo caso, parliamo del Tribunale di Palermo, che amministra la grande maggioranza dei beni in Sicilia. I beni confiscati sono circa 12.000 in Italia; di questi più di 5000 sono in Sicilia, circa il 40%. La maggior parte nella provincia di Palermo. Si parla di un business di circa 30 miliardi di euro, solo qui a Palermo. Questi beni sotto sequestro vengono affidati a un amministratore giudiziario scelto dal giudice del caso, che dovrebbe gestirlo mantenendolo in attività e tenerlo agli stessi livelli che precedevano il sequestro. Questa fase di sequestro secondo la legge modificata nel 2011 non deve superare i 6 mesi, rinnovabile al massimo di altri 6, periodo in cui vengono svolte le dovute indagini e si decide il destino del bene stesso: se dichiarato legato ad attività mafiose esso viene confiscato e destinato al riutilizzo sociale; se il bene è pulito viene restituito al precedente proprietario. Purtroppo la legge non viene applicata: il bene non viene mantenuto nello stato in cui viene consegnato alle autorità, né vengono rispettate le tempistiche. In media il bene resta sotto sequestro per 5-6 anni, ma ci sono casi in cui il tempo si prolunga fino ad arrivare a 16 anni. L’albo degli amministratori competenti che è stato costituito nel gennaio 2014 per legge dovrebbe essere la fonte da cui vengono scelti questi soggetti: in base alle competenze e alle capacità. Ma la scelta è arbitraria, effettuata dai giudici della sezione delle misure di prevenzione. Ritroviamo molto spesso la solita trentina di nomi, che amministrano decine di aziende e imprese. E non per capacità, perché la maggior parte di quei beni falliscono durante la fase di sequestro. Anche se poi vengono dichiarati esterni alla vicenda e gli imputati assolti da tutte le accuse. Telejato, la piccola emittente televisiva comunitaria siciliana che gestisco dal 1999 e che da allora non ha mai smesso di denunciare e lottare contro la mafia, ha sede a Partinico e copre un bacino d’utenza caratterizzato storicamente da una forte presenza mafiosa. La dichiarazione di fallimento e la messa in liquidazione dei beni confiscati è la strada più facile per gli amministratori, perché li esonera dall’obbligo della rendicontazione e consente loro di “svendere” mezzi, attrezzature, materiali, anche con fatturazioni non conformi al valore reale dei beni, girando spesso gli stessi beni ad aziende collaterali legate agli amministratori giudiziari. La pratica di vendere parti delle aziende stesse mentre sono ancora sotto sequestro, è abbastanza consolidata, e ci si ritrova con aziende svuotate e distrutte ancor prima del giudizio definitivo, che sia di confisca o di dissequestro. Questi sono solo alcuni esempi, alcune storture del sistema; ma molti sono i casi che riflettono un problema strutturale: una legge limitata, da aggiornare, che non permette gli adeguati controlli e conduce troppo spesso al fallimento dei beni per le - forse volute - incapacità del sistema. Posso fare nomi, esempi, citare numeri e casi. Chiedo alla Commissione Antimafia di essere audito per esporre questa inchiesta che stiamo portando avanti a Telejato, con notevole fatica, perchè non abbiamo nessuno al nostro fianco.
La famiglia Cavallotti è solo la punta dell'iceberg, scrive Pino Maniaci su “Change”. I fratelli Cavallotti, sono stati assolti con sentenza definitiva dalla infamante accusa di concorso esterno in associazione mafiosa con la formula "perchè il fatto non sussiste". In riferimento all’assoluzione dei fratelli Cavallotti il dott. De Lucia ha dichiarato che tale pronuncia giudiziale “come tutte le sentenze di assoluzione, però, deve essere letta. Una serie di dati processuali lì non hanno trovato, per una serie di questioni di natura formale, soddisfazione”. Ebbene, i fratelli Cavallotti sono stati assolti non per “questioni di natura formale”, ma perchè, a seguito di un lungo e complesso procedimento penale, sono stati ritenuti vittime e non complici della mafia per i motivi di cui adesso si dirà. Gli elementi da cui è scaturito il processo penale sono gli stessi su cui si basano le misure di prevenzione avverso le quali pende ricorso in Cassazione. Si tratta di una serie di pizzini e di dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che, se interpretate correttamente, dimostrano come le imprese dei fratelli Cavallotti, piuttosto che essere state avvantaggiate illecitamente dalla mafia, alla stregua di tutte le imprese operanti in Sicilia negli anni '80 e '90 - periodo della massima recrudescenza del fenomeno mafioso - sono state costrette a pagare il pizzo e a subire furti e danneggiamenti nei propri cantieri, tutti denunciati alle autorità competenti. I Cavallotti non hanno mai partecipato al sistema di spartizione illecita degli appalti (c.d. "Accordo Provincia") ideato dal Siino; ciò è dimostrato in maniera irrefutabile dall'elenco dei lavori che il gruppo Cavallotti ha svolto dalla data della costituzione della prima società di capitali alla data del sequestro, dal quale si evince che mai alcuna impresa riconducibile al gruppo Cavallotti si è aggiudicata lavori di importo superiore ad un Miliardo di lire indetti dall'Anas o dalla Provincia tra la seconda metà degli anni ottanta e il 1991 - periodo della riferita operatività dell'accordo suddetto avente ad oggetto, come spiegato dallo stesso Siino, la spartizione dei lavori indetti da Anas e Provincia di valore superiore ad un Miliardo di Lire . Quanto poi alla non meglio precisata - e perciò suggestiva - “documentazione riferibile a Bernardo Provenzano, che parla di appalti all'epoca di natura miliardaria, che riguardavano il gruppo Cavallotti” cui ha fatto cenno il dott. De Lucia secondo il quale tale documentazione avrebbe avuto “una valorizzazione diversa in sede processuale, ma questo non toglie che quel materiale trova nuovo utilizzo nella misura di prevenzione attualmente pendente”, può essere di aiuto alla comprensione della vicenda processuale ricordare che si tratta di missive dattiloscritte inviate dal Provenzano all’Ilardo e da questi consegnate al Colonnello Riccio. In queste missive si fa cenno, da una parte, ai lavori di metanizzazione dei comuni di Agira e Centuripe, eseguiti dalle società dei fratelli Cavallotti, dall’altra, alla Cooperativa “Il Progresso”, di cui a breve si dirà. Il carteggio in parola va letto - ed è stato valorizzato dai giudici del processo penale - come pagamento del pizzo, e ciò per le seguenti ragioni. Le gare per i lavori per la metanizzazione dei comuni di Agira e Centuripe sono state indette e aggiudicate a Palermo dalla Siciliana Gas. Queste missive sono del seguente tenore:
1- "Ti prego se puoi mettere a posto questi tre bigliettini che ti mando che cadono tutti e tre nella Provincia di Enna dammi risposta di quello che fai".
2- "Imp. Coop. Il Progresso deve fare un lavoro a Piazza Armerina - devono fare il consolidamento Pile sul Fiume Gela sotto il viadotto Fontanelle al km 48 strada Statale 117 bis importo 500 m circa questo lo cominceranno verso fine Febbraio 95. Imp. Cavallotti. Lavoro Gas Agira dopo Leonforte Provincia di Enna. Imp. 4 ml. Imp. Cavallotti. Lavoro Gas Centuripe Provincia di Enna Imp. 4 ml. Dammi risposta se li raccomandi o nò".
Va precisato che nel gergo mafioso con l'espressione "raccomandazione", come affermato incidentalmente nella sentenza che ha assolto dalla accusa di turbativa d’asta il sig. Pavone, titolare della Cooperativa “Il Progresso” menzionata nello stesso bigliettino, si intende fare riferimento alla messa a posto. Pur non contenendo una datazione, tali missive vengono fatte erroneamente risalire all'Ottobre del 1994 così da essere collocate, nella prospettazione accusatoria, in epoca antecedente alla aggiudicazione dei lavori (Dicembre 1994). Inoltre, la Cassazione ha stabilito che le dichiarazioni dell’Ilardo e le sintesi delle stesse contenute nella relazione del Riccio (dove si fa cenno al dato temporale) sono inutilizzabili perché ritenute prove formate in violazione di legge in assenza del contradditorio. Ma non è tutto. Sulla base di una nota "regola di mafia", se Provenzano avesse voluto favorire l'aggiudicazione dei lavori ai Cavallotti, avrebbe dovuto rivolgersi al referente locale della consorteria mafiosa competente su Palermo - luogo, nel quale vengono indette e aggiudicate le gare - e non di certo all'Ilardo, referente della famiglia mafiosa di Caltanissetta ed Enna. Viceversa, l'indirizzamento delle missive all'Ilardo dimostra, in verità, ancora una volta, che Provenzano faceva riferimento alla messa a posto. E ciò risulta compatibile con una ulteriore "regola di mafia" secondo la quale la riscossione del pizzo compete alla famiglia del luogo in cui i lavori vengono eseguiti. Alcune delle concessioni ottenute con regolare procedura dai Cavallotti, dopo il loro arresto avvenuto nel 1998, sono state sottratte alla Comest, già in amministrazione giudiziaria, e affidate, senza alcuna gara con il c.d. "patto di legalità" siglato dall'allora prefetto Profili, proprio alla Gas s.p.a., in corrispondenza dello stanziamento dei fondi europei per la metanizzazione della Sicilia al fine di, come si legge nell’atto prefettizio, “prevenire e reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazione della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli appalti e negli investimenti, nonchè nello svolgimento dei lavori presso i cantieri e nell’esercizio delle attività produttive”. Con riferimento a questa operazione è di interesse, inoltre, riportare le dichiarazioni rese da Massimo Ciancimino presso il Tribunale di Palermo alla presenza dei magistrati dott. Ingroia e dott. Di Matteo il 09/07/2008: "si erano occupati insieme anche di fare levare l'aggiudicazione della, dei lavori dell'impresa quella dei Cavallotti per farla aggiudicare sempre all'impresa Brancato - Lapis". L'allora Presidente della Commissione Antimafia Giuseppe Lumia in data 17/06/2000 partecipava a Mezzojuso alla inaugurazione dei lavori di metanizzazione eseguiti dalla Gas s.p.a. spiegando al suo uditorio la necessità di coniugare lo “sviluppo con la legalità”. Nel processo di appello del processo di prevenzione il Procuratore Generale, Florestano Cristodaro, ha chiesto la revoca delle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali ritenendo ancora una volta i Cavallotti "vittime della mafia" ed invitando i giudici a "leggere serenamente le carte processuali". Ora, se un Procuratore della Repubblica italiana, ha chiesto di revocare le misure di prevenzione, ciò significa, che con riferimento alla vicenda dei Cavallotti non è ravvisabile neppure l'indizio della loro vicinanza alla mafia; E se questo dato così significativo viene letto insieme alla sentenza di assoluzione definitiva la conseguenza non può che essere una: i Cavallotti non hanno mai avuto nulla a che fare con la mafia! Veniamo adesso all'audizione della commissione Nazionale Antimafia nella quale sul sequestro Italgas sono stato audito il dott. Dario Scaletta “Belmonte Mezzagno è un paesino della provincia di Palermo, per chi non lo conoscesse, ed è il paese di Benedetto Spera, un noto esponente mafioso assicurato alle patrie galere”) del dott. De Lucia (DE LUCIA: “(a) Belmonte Mezzagno, un paese di poche migliaia di anime, (i Cavallotti) sono ben noti sia per le capacità imprenditoriali sia per il tipo di rapporti che hanno con la criminalità mafiosa in quel territorio, che è stata per anni rappresentata dal braccio destro di Bernardo Provenzano, Benedetto Spera”), dell’On.le Lumia (LUMIA: “Belmonte Mezzagno, un comune dove agiva un boss mafioso del calibro di Benedetto Spera, che stava nel Gotha mafioso insieme a Provenzano e a Giuffrè”). Sembra quasi che le imprese gestite da cittadini belmontesi siano per ciò stesso dotate, in chiave indiziaria, di un marchio registrato che ne certifica l’origne criminale. Questo modo di argomentare che segue il noto detto di “fare di tutt’erba un fascio” è inamissibile oltre che offensivo nei confronti di una intera comunità cittadina. Vale la pena di ricordare che Belmonte Mezzagno non è soltanto il paese che ha dato i natali a Benedetto Spera, ma il paese in cui vivono e da cui provengono centinaia di lavori infaticabili e imprenditori onesti che lottano tra mille difficoltà a fianco dei propri collaboratori non soltanto contro la crisi economica ma anche contro un pregiudizio che talvolta fa più male della crisi. Belmonte Mezzagno, “per chi non lo conoscesse”, è il paese di artisti, di musicisti e sportivi di fama internazionale, dei migliori studenti dell’Università di Palermo. Continueremo con la Nostra battaglia e vi preghiamo di sostenere la petizione.
FRANCESCO DIPALO. Imprenditore di Altamura, testimone di giustizia, minaccia di darsi fuoco, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Un testimone di giustizia, Francesco Di Palo, ha minacciato di darsi fuoco nella serata di ieri davanti alla Prefettura di Monza, procurandosi comunque delle ustioni alle mani con liquido infiammabile. Francesco Di Palo è un imprenditore di Altamura, diventato testimone di giustizia e recentemente uscito dal programma di protezione. Tuttavia lui e la sua famiglia continuano a sentirsi in pericolo. Di Palo era il titolare della 'Venere srl' di Matera, società che produceva vasche idromassaggio, dichiarata fallita un anno prima che l’imprenditore decidesse di denunciare alla magistratura barese i soprusi subiti dalla mala altamurana e il presunto intreccio tra mafia, politica e Forze dell’Ordine. A causa delle ristrettezze economiche derivanti dal suo status di testimone di giustizia, l’uomo ha più volte protestato pubblicamente contro il ministero dell’Interno e la procura di Bari. Nell’ottobre 2011 chiese di uscire dal programma di protezione perchè – disse ai giornalisti – il Viminale non gli pagava più l’affitto della casa nella località protetta in cui viveva: per questo, il 27 ottobre 2011, protestò con un megafono davanti al tribunale di Bari dove era giunto in treno ("senza pagare il biglietto") e senza scorta. Raccontò che anche i suoi tre figli erano tornati a casa, ad Altamura. «Ero disposto a tutto per la giustizia, ma sono stato buttato al vento come un pezzo di carta. Protesto – disse in quell'occasione ai cronisti – per dire a questa procura che i testimoni di giustizia sono trattati come pezze per pulire le scarpe».
Altamura: nuove minacce per i fratelli Di Palo Scritte intimidatorie contro il giornalista ed il testimone di giustizia, scrive Savino Percoco su “Antimafia Duemila”. Lo scorso dicembre 2014, all’indomani di alcune denunce, testimoniate in diretta radiofonica ai microfoni di Radio Regio Stereo, Alessio e Francesco Di Palo, sono stati destinatari di minacciose frasi intimidatorie scritte su alcuni muri della città di Altamura. Non è la prima volta che i due fratelli, entrambi molto attivi nella lotta contro la criminalità organizzata, sono destinatari di inquietanti messaggi o minacce. In passato sono stati vittime anche di violente aggressioni fisiche e verbali ed hanno subito danni anche su alcuni beni mobili. Alessio è giornalista e conduttore radiofonico e nei suoi programmi denuncia senza timore il malaffare mafioso e le sue connessioni. Francesco invece è un ex imprenditore e titolare della Venere S.r.l. di Matera, produttrice di vasche idromassaggio, divenuto testimone di giustizia dopo aver coraggiosamente denunciato i suoi estorsori. Dal dicembre 2009 su richiesta del pm antimafia Desirèe Digeronimo, oggi consigliere comunale di Bari, è entrato nel programma di protezione, iniziando così la dura vita dei testimoni di giustizia in località protetta fatta di segretezza, difficoltà economiche e limitazioni di movimenti e spostamenti. Nonostante ciò nei loro confronti regna un certo silenzio. Nessuno, tra i media, ha dato risalto alle intimidazioni subite ed anche tra le istituzioni sono latitanti nell'esprimere vicinanza verso questi due uomini che a distanza di anni, continuano il duro commino in nome della giustizia e della legalità. Francesco Di Palo, assieme al fratello, qualche mese fa ha presentato una serie di esposti alla Procura della Repubblica di Bari, denunciando continue estorsioni ai danni di imprenditori, commercianti ed artigiani altamurani. Nella sua denuncia Di Palo ha spiegato come, a suo parere, vi sia una nuova famiglia criminale che sta prendendo il controllo sulle attività estorsive un tempo condotte dal boss Bartolomeo Dambrosio, trucidato da 50 colpi di arma da fuoco nelle campagne altamurane il 6 settembre del 2010. “Inoltre sono stati inviati esposti - aggiunge Francesco - con i quali abbiamo denunciato fatti gravi e penalmente rilevanti che vedono coinvolti imprenditori deviati di Altamura, affiliati al clan Dambrosio e ad un clan di Bari. Non abbiamo più avuto notizie. Mai in nessuna Procura d’Italia un Testimone di Giustizia non è stato convocato dai Magistrati dopo aver denunciato fatti gravi e penalmente rilevanti. Mai in nessuna Procura della Repubblica d’Italia un soggetto che denuncia una organizzazione criminale per estorsioni, non è convocato dai magistrati per confermare le denunce rese e/o approfondire i fatti oggetto delle stesse denunce”. Alla luce di ciò, qualche settimana fa i due fratelli lanciarono un appello dagli studi di Radio Regio Stereo indirizzato al Prefetto di Bari, chiedendo non solo un intervento a riguardo ma anche spiegazioni per il mancato scioglimento del Consiglio Comunale di Altamura per condizionamento mafioso.Su quest’ultio punto, l’ex imprenditore ricorda importanti deposizioni rilasciate agli inquirenti dalla vedova del boss Bartolomeo Dambrosio (oggi testimone di giustizia) riguardo presunti coinvolgimenti tra mafia, imprenditoria e politica altamurana. Nello specifico, risalta i punti e afferma “che il Sindaco di Altamura Mario Stacca chiedeva al boss supporto per le sue campagne elettorali … il Presidente del Consiglio Comunale di Altamura, si recava a casa del boss per chiedere sostegno per la sue candidature a consigliere comunale di Altamura … e che gli amministratori e politici Altamurani erano quasi tutti nel libro paga del Columella”.
A tutela delle sue accuse, il testimone di giustizia fa riferimento anche ad alcune intercettazioni telefoniche apparse sui giornali, tra il figlio di Carlo Dante Columella (patron della discarica di Altamura) e il Presidente del Consiglio comunale di Altamura Nico Dambrosio, quando “parlavano delle presunte mazzette che i Columella pagavano al segretario del sindaco tanto che quest’ ultimo era definito dagli intercettati, mani viola (dal colore delle banconote da 500 euro. Nelle stesse intercettazioni si faceva riferimento a presunte mazzette che andavano anche al Sindaco Stacca”. Il senso di solitudine da parte del testimone di giustizia si manifesta anche dopo un ulteriore atto intimidatorio nei suoi confronti, avvenuto negli ultimi tempi. “Uno dei principali indagati per Mafia murgiana, recentemente raggiunto da nuova ordinanza di custodia cautelare per reati di mafia - spiega Francesco - ha persino lanciato, tramite una rete televisiva privata, una sorta di petizione per non farmi mettere più piede ad Altamura. Tutto questo nella più assoluta indifferenza delle Autorità Giudiziarie. Io ho sacrificato la mia famiglia, le mie aziende, il futuro dei miei figli perché ho creduto nella Giustizia e la Procura di Bari non risponde alle mie missive: ma lo Stato con chi sta?”.
Francesco Dipalo: "Io, testimone di giustizia contro la Mafia Murgiana". La lettera dell’imprenditore: “Entrati nel programma di protezione, un incubo senza fine". Pubblichiamo di seguito la lettera inviata al direttore Giorgio Bongiovanni di “Antimafia duemila” da Francesco Dipalo, testimone di giustizia di Altamura che ha denunciato i clan della Mafia Murgiana.
«Egregio Direttore, chi Le scrive è un Imprenditore di Altamura che alcuni anni fa denunciò una organizzazione criminale denominata Mafia Murgiana che imponeva il pizzo al sottoscritto e ad una intera classe imprenditoriale. A seguito delle mie dichiarazioni rilasciate alla DDA di Bari e dopo sei anni di indagini, la dottoressa Desirèe Digeronimo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, e il dott. Roberto Pennisi Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, applicato alla DDA di Bari, chiesero ed ottennero dal GIP di Bari il rinvio a giudizio di numerosi soggetti tra i quali figuravano, affiliati al clan Dambrosio di Altamura, imprenditori deviati, esponenti delle forze dell’ordine, professionisti, politici ed amministratori pubblici accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidi, occultamento di cadavere, detenzione illegale di armi da guerra e relative munizioni, estorsione, usura, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, rapimento (per avere rapito un imprenditore di Altamura rilasciato per aver pagato un riscatto) ecc. Sempre dalle mie denunce si svilupparono altri filoni di indagini che consentirono al Tribunale di Lecce (competente su quello di Bari), di rinviare a giudizio una ventina di soggetti tra i quali figuravano magistrati togati, giudici di pace, avvocati ecc. tutti accusati di aver pilotato sentenze in favore del boss Bartolomeo Dambrosio e dei suoi affiliati. Sempre dalle mie denunce si sono sviluppati altri filoni di indagini tra i quali vi sono quello della sanità pugliese, e delle escort. Il mio vero dramma ha inizio quando, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Direzione Nazionale Antimafia, io e la mia famiglia, esattamente 5 anni fa fummo inseriti nello speciale programma di protezione e condotti in località segreta. Da allora per tutta la mia famiglia ha avuto inizio un incubo senza fine. Siamo stati umiliati, derisi, vessati, maltrattati e ci siamo sentiti dire anche che rompevamo i coglioni quando contestavamo comportamenti irresponsabili, ingiustificati ed ingiusti messi in atto da funzionari del Ministero dell’Interno nei confronti di soggetti che in questa maledetta storia sono solo vittime. È stato distrutto il futuro affettivo dei miei figli che hanno dovuto lasciare amici e parenti per essere destinati all’isolamento più totale. Una delle mie figlie solo dopo pochi mesi non sopportava più lo stato di solitudine e di sofferenza a cui era sottoposta e tornò a casa ad Altamura. Come se tutto ciò non bastasse, da quando sono stato sottoposto allo speciale programma di protezione, il Servizio Centrale di Protezione non ha provveduto a notificarmi gli atti giudiziari. Nel frattempo alcuni dei soggetti arrestati e/o rinviati a giudizio, mi avevano querelato per diffamazione e/o reati simili. A seguito delle predette querele, sono stato rinviato a giudizio, processato e condannato in contumacia dai giudici di pace di Altamura mentre io ero all’ oscuro di tutto. Io non sapevo neanche di essere stato querelato. Ovviamente gli imputati hanno utilizzato le condanne inflitte in contumacia al sottoscritto dal giudice di pace di Altamura per tentare di screditarmi nei processi nei quali erano imputati. Ad un testimone di giustizia sotto protezione in una località segreta, lo Stato non gli ha notificato gli atti giudiziari. Mi è stato impedito di esercitare il diritto di difesa nei processi. Con gli atti e i documenti in mio possesso, avrei potuto dimostrare ai giudici di pace che le querele sporte nei miei confronti dagli affiliati al clan Dambrosio erano pretestuose e facevano parte di una strategia difensiva finalizzata a screditarmi. Ma vi è di più: lo Stato non mi ha concesso di presenziare nei processi nei quali sono persona offesa e mi sono costituito parte civile contro i miei estorsori, contro soggetti accusati di reati gravi come omicidi, ecc. Mi è stato impedito di puntare il dito contro i miei estorsori. Inoltre mi è stato impedito di poter raggiungere altre procure per acquisire atti a mia firma di procedimenti penali a carico di altri soggetti da me denunciati, e che erano strettamente attinenti ai procedimenti penali in corso a Bari. Il risultato è che i colletti bianchi della mafia murgiana sono stati assolti. Uno dei principali imputati assolti, solo poche settimane dopo la sentenza di assoluzione è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare per reati simili. Lo Stato mi ha impedito di esercitare il diritto di difesa nei processi ed ha agevolato le posizioni processuali di soggetti legati ad una potente organizzazione criminale che da oltre un decennio ha condizionato la vita sociale ed economica di una intera comunità. Ora sono tornati a delinquere più forti di prima grazie alla inerzia dello Stato. Ovviamente il sottoscritto ha provveduto ad inviare al Ministro dell’Interno, oltre che al vice Ministro, una serie di esposti con i quali denunciavo tutto quello che si stava verificando e che stavano inclinando i processi a beneficio degli imputati. Nessuno mi ha mai risposto. Si sta per volgere al termine il processo in Corte di Assise a Bari nei confronti di tutti gli altri affiliati al clan e al sottoscritto non è stato concesso di presenziare ad una sola udienza. Si continua ad impedire ad un testimone di giustizia di presenziare alle udienze. Ma nonostante le decine di esposti che ho inviato a mezzo raccomanda a/r al Ministro Alfano, mai nessuna risposta mi è pervenuta e nessun provvedimento e stato adottato per consentirmi di avere giustizia. Ho anche denunciato al Ministro Alfano con decine di missive, che nonostante i processi in corso, nonostante le indagini tuttora in corso, il Servizio Centrale di Protezione ha reso pubblica la mia residenza nella località dove attualmente vivo e nessuna tutela è stata predisposta per la mia famiglia ed in particolare nei confronti di mia figlia che vive ad Altamura. Non mi ha mai risposto. Ora tutti sanno che vivo a Monza. Ho scritto decine di missive ai Prefetti di Bari e di Monza e Brianza con le quali ho chiesto se sono in state attuate misure di tutela idonee a garantire la incolumità dalla mia famiglia. Nessuno mi ha mai risposto. Si continua a favorire le posizioni processuali di esponenti della mafia murgiana e il Ministro Alfano non risponde. Egregio direttore, in questo Paese per garantire la incolumità dei propri cari che rischiano di essere lasciati nelle mani dei carnefici, bisogna ricorrere ad atti estremi. Questo è lo Stato. Cordialità. Francesco Dipalo»
LUIGI ORSINO. Vittime di camorra abbandonate dallo Stato – L’invito a denunciare il racket è una trappola? Scrive “Pensare Liberi”. Ci ritroviamo a parlare di malagiustizia, ma questa volta la protagonista indiscussa è la camorra. Abbiamo raccolto la testimonianza di un nostro concittadino napoletano che riporteremo integralmente nel presente articolo. Questa vuole essere una denuncia nei confronti della politica, delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine e nei confronti di quei cittadini collusi e quindi omertosi. Sappiamo tutto, i vari “stacci tu qua e poi vediamo se fai l’eroe!” Bene, la storia che portiamo oggi alla luce parla proprio di un caso eroico, di chi ha detto no alla camorra, di chi ne ha pagato pesantissime conseguenze, di chi non trova dalla sua parte nemmeno l’opinione pubblica, i media, o famosi giornalisti o scrittori. Perchè quando si fanno i nomi, quando dal generico si passa al pratico, allora le cose si fanno davvero serie. Questo articolo non diverrà un best-seller, ma bisogna avere il coraggio di denunciare soprattutto i casi reali e stringersi intorno a questi. Tutti devono sapere cosa accade a un nostro concittadino nel momento in cui cade in questo vortice di violenza e disumana realtà. Belle parole? Vediamo se siamo bravi anche con i fatti? Ci incontriamo per strada a parlarne da uomini? Questa storia, come tante altre, dimostra come lo Stato sia completamente assente nel momento in cui bisogna difendere i cittadini che hanno avuto il coraggio di denunciare il racket. Politicamente scorretto dirlo? Denunciare il racket è un dovere? Solo così si può sconfiggere la camorra? L’omertà… di chi? Slogan di un certo effetto, di quelli che suscitano gli applausi delle platee… peccato che spesso questo invito a denunciare il racket si riveli solo una ingegnosa, quanto sospettosamente premeditata, trappola mortale. I fatti parlano in questi termini. Lo Stato? Assente ingiustificato…Veniamo al coraggioso e disperato racconto del protagonista cittadino Luigi Orsino e della sua famiglia. «La nostra attività imprenditoriale (mia e di mia moglie Esposito Giuseppina) inizia nel 1979, all’epoca eravamo studenti, con l’apertura di un piccolo negozio di mobili in Portici (Na). Nel tempo la nostra attività si ingrandì e arrivammo a possedere 2 aziende, una ditta individuale ed una S.r.l., proprietarie di 3 negozi di abbigliamento in Portici, di un grosso negozio di arredamenti sempre in Portici e di un ancor più grande negozio di arredamenti in Sant’Anastasia. Ovviamente avevamo molti dipendenti ed eravamo divenuti benestanti. Comperammo una villa al mare in Calabria, due proprietà a S. Sebastiano al Vesuvio (villa con giardino e dependance con giardino), un appartamento di lusso ad Ercolano e due appartamenti in pieno centro di Roccaraso ( circa 130 mq + 60 mq), un locale commerciale in Portici. Ad un certo punto entrammo nelle mire del clan Vollaro che pretese cifre sempre più consistenti per farci lavorare in pace, ovviamente ad ogni nostra resistenza corrispondevano minacce, atti intimidatori e attentati. L’esosità degli estorsori ci costrinse a ricorrere all’aiuto finanziario di una persona, che credevamo essere nostro amico e con cui effettivamente intrattenevamo rapporti di amicizia a livello familiare, tale individuo si offerse di prestarci il denaro per poter tacitare le richieste estorsive dei camorristi. In seguito questa persona, noto professionista napoletano, si rivelò essere un avido usuraio che in complicità con altri svolgeva questa ignobile attività. In seguito l’usuraio si rivelò essere un personaggio molto pericoloso ed aggressivo, arrivando a minacciarmi con una pistola ed a vantarsi dei suoi stretti legami con il feroce clan camorristico dei Vollaro. Quest’individuo arrivò a pretendere interessi che, fatti i dovuti calcoli e grazie ad un perverso meccanismo, arrivano a raggiungere finanche il 400%. Sempre questo viscido personaggio, quando non potei onorare prontamente i prestiti, si appropriò con minacce ed atti violenti delle mie proprietà di Ercolano e di Roccaraso, una vera e propria estorsione perpetrata usando la violenza per vincere la mia riottosità. L’eccessiva avidità dei camorristi e del loro affiliato, e forse una sopravvalutazione delle mie disponibilità finanziarie, causarono il tracollo economico delle mie aziende ed il loro conseguente fallimento. Ovviamente tutti i miei beni furono pignorati a favore dei creditori, tra cui per altro avevano avuto la sfacciataggine d’inserirsi anche gli usurai. Il Giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Nola si rifiutò di voler considerare il caso nel suo insieme e ritenne che non era sua competenza valutare i risvolti penali (intanto avevo denunciato il tutto alla Procura della Repubblica), in tal modo equiparava il mio caso, di fatto, ad un fallimento doloso, quanto in realtà era sempre stato, e tale riconosciuto dallo stesso tribunale fallimentare, fallimento semplice non fraudolento. E’ pur vero che il giudice è tenuto a salvaguardare i diritti dei creditori ma è altrettanto vero che egli è tenuto a verificare la validità dei crediti vantati. Tra i miei creditori vi sono gli usurai e banche che si sono comportate come usurai e continuano a farlo tutt’ora. Le banche hanno applicato l’anatocisma finchè la legge non ha comparato tale pratica all’usura, ora applicano comunque pratiche che fungono da moltiplicatore del debito, va, inoltre considerato che le stesse banche hanno commesso atti illegali, dimostrati, ma su cui il Giudice civile non ha mai indagato. Il G.E. Si è limitato a dichiararsi incompetente a ripartire tra i creditori il ricavato delle vendita all’asta dei miei beni, compreso la casa in cui abito con la famiglia. Veniamo al risvolto penale della vicenda: Nel 2004 presentammo denuncia alla Procura della Repubblica contro usurai ed estorsori, tale denuncia, su consiglio pro bono di un giovane legale, tracciava per grandi linee la vicenda perché ci aspettavamo di essere convocati da un magistrato per poter scendere nei particolari. La denuncia fu presentata alla Procura e non alle locali forze dell’ordine perché negli anni precedenti si erano verificati episodi di collusione tra tali organismi e la malavita organizzata, i fatti ebbero grande rilevanza e furono promosse azioni giudiziarie, inoltre noi stessi avemmo a costatare strani comportamenti. Ascoltati dai CC di San Sebastiano rendemmo dettagliata deposizione circa i fatti riguardanti l’usura ma fummo più vaghi sugli estorsori, per le ragioni già dette. Dal 2004 al 2010 nessuno ci ha ascoltato, ad eccezione dei CC 2 volte, in ogni caso mai nessun giudice, ed anzi la procedura è stata divisa in due tronconi, uno per l’usura ed uno per l’estorsione, nonostante noi avessimo dimostrato che i reati erano contigui e perpetrati da personaggi in complicità tra loro, Proc. N° 52969/05 e 11335/10. A giugno del 2010 il Giudice che si occupava delle indagini sull’usura ha archiviato la procedura senza neanche avvertirci, privandoci del nostro diritto di fare opposizione. Inoltre non si spiega come mai lo stesso magistrato, su nostra richiesta ci abbia concesso i benefici previsti dall’art. 20 della legge 44/1999 (il 25/11/2010) che prevede la sospensione dei termini esecutivi per le vittime della criminalità organizzata, riconoscendoci, dunque, tale status, e poi poco dopo (comunque prima dello scadere dei canonici 300 gg) archivia il tutto, bloccando in tal modo la nostra richiesta di poter accedere ai fondi di solidarietà destinati alle vittime di camorra. Veramente la spiegazione è che il Signor Giudice in 5 anni non ha fatto indagini ma ha tenuto la pratica a raccogliere polvere, dopo di che dovendo rispondere della sua ignavia si è cavato d’impaccio archiviando. La motivazione dell’archiviazione “ perché non eravamo credibili in quanto esistevano rapporti antecedenti con gli usurai” è una vera beffa. Tali rapporti li avevamo già riferiti noi nella nostra denuncia, specificandone la natura e furono proprio tali rapporti a far conoscere agli usurai la nostra florida situazione finanziaria, (l’usuraio era il nostro commercialista sin dal lontano 1979, mai avevamo prima sospettato la sua vera attività). Ancora maggiormente inspiegabile è l’archiviazione della procedura contro gli usurai se si considera il fatto che abbiamo prodotto prove non solo testimoniali (testimonianza mia e di mia moglie) ma anche prove documentali incisive e verificabili. Resta in piedi la procedura contro gli estorsori, ma l’archiviazione della procedura contro gli usurai non fa ben sperare. Nel frattempo tutti i miei beni sono stati venduti forzosamente dal Tribunale, la casa in cui abitiamo è stata anch’essa venduta e il 07 settembre u.s. l’Ufficiale Giudiziario , con l’appoggio della forza pubblica, mi voleva gettare materialmente per strada, solo le mie precarie condizioni di salute lo hanno costretto a rinviare al 19 ottobre 2011, quando interverrà un’ambulanza per sgomberarmi senza correre il rischio di essere denunciati per tentato omicidio. In quale modo noi si possa sopravvivere senza più una casa, senza un lavoro, nell’indigenza più assoluta, io gravemente cardiopatico, con tre by-pass, e mia moglie malata anch’essa, nessuno mi ha mai spiegato. Tutti gli sforzi fatti in questi anni per rientrare nel tessuto produttivo (vari tentativi di iniziare una nuova attività) sono stati vanificati dall’aggressività dei criminali che mi hanno perseguitato e continuano ancor oggi. Nel tempo abbiamo subito minacce, intimidazioni ed attentati di ogni genere: spari contro i nostri esercizi (molte volte), furti di automezzi carichi di merce, spari conto la mia casa e la mia vettura, furti negli esercizi, rapimento di mio figlio (durato pochi minuti per fortuna), auto con mia moglie a bordo spinta fuori strada, percosse a me e a mia moglie, uccisione del nostro amato cane a colpi d’arma da fuoco. E ultime in ordine di tempo atti vandalici contro la mia vettura (settembre 2010), un ordigno incendiario gettato nel cortile di casa (07/12/2010) che ha causato un principio d’incendio da me domato con un estintore, dopo di che sono intervenuti i CC. Il 3 gennaio 2011 un messaggio anonimo contenente una minaccia, scritto su un biglietto d’auguri, è stato lasciato nella buca delle lettere. Il 17 gennaio 2011 un individuo introdottosi nel giardino di casa ha aggredito mia moglie,verso le ore 19, picchiandola e poi spingendola per le scale interne al giardino stesso. Evidentemente i malavitosi vogliono mantenere costante la pressione su di noi ed anzi rincarano vieppiù la dose. Il 21/03/2011 un individuo aggredì in giardino mia moglie ponendo in essere un tentativo di strangolamento. Lo stato economico attuale è disastroso, viviamo della carità del Comune (ogni tanto ci paga qualche bolletta) e della Chiesa di San Sebastiano al Vesuvio che ci fornisce pacchi alimentari. Faccio notare che per volere del comitato per l’ordine e la sicurezza siamo sottoposti a protezione di tipo 4, cioè i Carabinieri della locale caserma passano più volte al giorno a controllare che non vi siano pericoli incombenti. Sicuramente la costanza e la tenacia del Comandante la stazione di San Sebastiano al Vesuvio e dei militi ai suoi ordini ha evitato che nuove e, forse più gravi, violenze fossero commesse a nostro danno. Ci risulta incomprensibile come sia possibile proteggerci se saremo in ridotti a vivere in strada (realmente, non retoricamente). Come è incomprensibile che la polizia si mobiliti in otto, dico otto, agenti, alcuni della DIGOS per sfrattarci mentre contemporaneamente il Comandante dei CC e il suo vice erano presenti per garantirci la protezione. Una assurda ed incomprensibile contraddizione. Il prossimo 19 ottobre l’ufficiale giudiziario accompagnato probabilmente da un plotone di poliziotti, con l’ambulanza pronta nel caso mi dovesse venire un altro infarto mi butteranno in strada, con la famiglia, a calci nel di dietro. Se fossi stato il boss Provenzano forse mi avrebbero trattato meglio. E’ molto facile fare i forti con i deboli, salvo poi a farsi deboli con i forti. Luigi Orsino»
“DENUNCIA IL RACHET. TI CONVIENE.” A questo punto sembra più una minaccia che un invito. Vogliamo fare luce su un particolare che ci ha colpito molto e che, a nostro avviso, rappresenta la chiave del “problema camorra” e nello stesso tempo la sua vera forza. La collusione tra questa e le istituzioni, ma soprattutto, la collusione tra camorra e cittadini. Chiunque, inaspettatamente, può rivelarsi un camorrista, anche il più insospettato e insospettabile amico di famiglia. In questo caso è venuta fuori la figura di un commercialista il cui vero lavoro è quello di segnalare alla camorra le aziende che fatturano bene e che vanno a gonfie vele, arrotondando con attività di estorsione, mentre il lavoro contabile è soltanto una copertura. Che questo principio entri bene nelle nostre teste. Il nemico non è soltanto fuori.
PINO MASCIARI: «Costretto a sparire e autoproteggermi perché abbandonato dalla scorta in Calabria», scrive Roberto Galullo su “Il Sole 24Ore”. Il suo telefono cellulare torna raggiungibile 19 minuti dopo la mezzanotte ma il Sole-24 Ore riesce a mettersi in contatto con Pino Masciari – il testimone di giustizia calabrese che per oltre 36 ore era scomparso a Cosenza – solo alle 9.31 di oggi. Ha la barba lunga e sta poco al telefono. «La scorta mi ha detto che non mi avrebbe riportato a casa. Mi ha girato le spalle e se ne è andata. A quel punto ho dovuto tutelarmi e sono stato costretto a fare tutto da solo senza dare notizie a nessuno, neppure a mia moglie. Mi sono mosso da solo e non nascondo che nel primo tratto di strada mi hanno riconosciuto e sono stato preso dal panico. Con mezzi di fortuna mi sono messo all'opera per tornare a casa, a Torino, dove sono giunto ieri sera tardi». In altre parole, come lui stesso scrive sul sito, «mi sono sentito costretto ad auto-proteggermi e a tornare a casa, non ritenendo giusto di esporre i civili che mi stavano accompagnando in quanto versavo, per l'ennesima volta, privo di protezione in terra di Calabria». Da quel momento ha staccato il cellulare perché, dice, «sarebbe stato possibile essere rintracciato da chiunque». A casa l'aspettavano moglie e figli che – a quanto dichiara al Sole-24 Ore lo stesso Masciari - nulla sapevano. E che per 36 ore hanno cercato di avere notizie. E che per 36 ore nulla hanno intuito se è vero che la coniuge di Pino ha cercato di averne in ogni modo e che ancora nel pomeriggio di ieri aveva un rappresentante del servizio scorte di Torino accanto a lei in casa. Notizie sulla sua scomparsa che - a quanto si apprende solo questa mattina nel momento in cui è stato pubblicato il comunicato stampa nel sito di Pino Masciari – la prefettura (di Torino? Di Cosenza?, non è dato sapere visto che manca l'intestazione) sapeva. E lo Stato (qualunque fosse la prefettura) non le ha comunicate alla moglie? A quanto sembra no anche se è umanamente difficile da credere. Alle ore 9 di ieri mattina la prefettura ha infatti ricevuto questo comunicato spedito via fax dallo stesso Masciari: «Oggetto: Urgente Comunicazione Giuseppe Masciari. La presente, quale documento ufficiale, è per comunicare che in questo momento sono a Cosenza, Calabria, e sono stato " abbandonato" dal personale di scorta, con la conseguenza che sto provvedendo di rientrare a Torino con mezzi pubblici o di fortuna. Vani sono stati i tentativi di contattare il personale di scorta di riferimento di ………… . Pertanto mi rivolgo a Lei per un intervento immediato che tuteli la mia persona e per denunciare il susseguirsi di mancate condizioni di sicurezza che avvengono, in particolar modo in Calabria, e che mi espongono a serio rischio. Reputo le autorità preposte responsabili se dovesse accadere qualcosa alla mia persona. Cordialità» . Questa la nuda cronaca (conclusiva o dovremo aspettarci la versione dello Stato, attraverso le spiegazioni del Viminale?) di due giornate delle quali non si sentiva francamente il bisogno.
Chi è Giuseppe Masciari?
Il mio nome è Giuseppe Masciari, un imprenditore edile calabrese, nato a Catanzaro nel 1959. Sono stato sottoposto a programma speciale di protezione dal 18 ottobre 1997, insieme a mia moglie (medico odontoiatra) e ai miei due bambini. Dal 2010, fuoriuscito dal Programma Speciale di Protezione, vivo sotto scorta. Ho denunciato la ‘ndrangheta e le sue collusioni con il mondo della politica. La criminalità organizzata ha distrutto le mie imprese di costruzioni edili, bloccandone le attività sia nelle opere pubbliche che nel settore privato, rallentando le pratiche nella pubblica amministrazione dove essa è infiltrata, intralciando i rapporti con le banche con cui operavo. Non ho accettato le pressioni mafiose dei politici e del racket della ‘ndrangheta. Il sei per cento ai politici e il tre per cento ai mafiosi, ma anche angherie, assunzioni pilotate, forniture di materiali e di manodopera imposta da qualche capo-cosca o da qualche amministratore, pretese di regali di appartamenti e costruzioni gratuite, finanche acquisto di autovetture: questo fu il prezzo che mi rifiutai di pagare. Fummo allontanati dalla nostra terra per l’imminente pericolo di vita in cui ci siamo trovati esposti, insieme alla mia famiglia. Da quando operavo nella mia attività con le mie aziende, non mi sono arreso mai ai soprusi della ‘ndrangheta, mi ribella, riferisco tutto all’Autorità Giudiziaria e denuncio; tanto fu ferma la mia scelta di non cedere ai ricatti che arrivai al punto di dover chiudere tutte le mie imprese licenziando nel settembre 1994 gli ultimi 58 operai rimasti.
Ingresso nel Programma Speciale di Protezione. Il 18 Ottobre 1997 io, mia moglie Marisa e i miei due figli appena nati entrammo nel programma speciale di protezione e scompariamo dalla notte al giorno: niente più famiglia, lavoro, affetti, niente più Calabria. Testimonio nei principali processi contro la ‘ndrangheta e il sistema di collusione, quale parte offesa costituendomi come parte civile. Divento “il principale testimone di giustizia italiano”, così definito dal procuratore generale Pier Luigi Vigna. Inizia il CALVARIO: accompagnamenti con veicoli non blindati, con la targa della località protetta, fatto sedere in mezzo ai numerosi imputati denunciati, intimidito, lasciato senza scorta in diverse occasioni relative ai processi in Calabria, registrato negli alberghi con il mio vero nome e cognome, senza documenti di copertura. Troppi episodi svelano le falle del sistema di protezione che dovrebbe garantire sicurezza per me e la mia famiglia.
Lo Stato istituisce la figura del testimone di giustizia. 2001. Con la legge 45/2001 si istituisce la figura del testimone di giustizia, cittadino esemplare che sente il senso civico di testimoniare quale servizio allo Stato e alla Società. Il 28 Luglio 2004, la Commissione Centrale del Ministero degli Interni mi notifica che “sussistono gravi ed attuali profili di rischio, che non consentono di poter autorizzare il ritorno del Masciari e del suo nucleo familiare nella località di origine. Ritenuto che il rientro non autorizzato nella località di origine potrebbe configurare violazione suscettibile di revoca del programma speciale di protezione”.
Revoca del programma speciale di protezione. Il 27 Ottobre 2004, tre mesi dopo, la stessa Commissione Centrale del Ministero degli Interni mi notifica il temine del programma speciale di protezione. Tra le motivazioni si indica che i processi erano terminati. Cosa non vera: i processi erano in corso e la D.D.A. di Catanzaro emetteva in data , 6 febbraio 2006 successiva alla delibera, attestato che i processi era in corso di trattazione.
Ricorso contro la revoca. 19 Gennaio 2005, faccio ricorso al TAR del Lazio contro la revoca, azione che mi permette di rimanere sotto programma di protezione in attesa di sentenza.
Il programma cessa in ogni caso. 1 Febbraio 2005, senza tenere conto del ricorso già in atto, la Commissione Centrale del Ministero dell’Interno delibera ancora una volta di “ invitare il testimone di giustizia Masciari Giuseppe ad esprimere la formale accettazione della precedente delibera ricordando che alla mancata accettazione da parte del Masciari, seguirà comunque la cessazione del programma speciale di protezione”.
Non posso testimoniare ai processi. Il 19 Maggio 2006, il mio legale invia una nota alle Autorità competenti per segnalare che i Tribunali erano stati notiziati “della fuoriuscita del Masciari dal programma di protezione” e che pertanto non risultavo essere più soggetto a scorta per accompagnamento nelle sedi di Giustizia. Mi sono recato ugualmente nei processi con senso di DOVERE, accompagnato dalla società civile.
Sentenza del TAR: diritto alla sicurezza. Gennaio 2009, dopo 50 mesi a fronte dei 6 mesi stabiliti dalla legge 45/2001 art.10 comma 2 sexies-, il TAR del Lazio pronuncia la sentenza riguardo il ricorso e stabilisce l’inalienabilità del diritto alla sicurezza, l’impossibilità di sistemi di protezione o programmi a scadenza temporale predeterminata e ordina al Ministero di attuare le delibere su sicurezza, reinserimento sociale, lavorativo, risarcimento dei danni. Per tramite del mio legale faccio richiesta formale dell’ottemperanza della sentenza.
Sciopero della fame e della sete. Aprile 2009 Non avendo ricevuto nessuna risposta dalla Commissione Centrale del Ministero dell’Interno, annuncio la volontà di cominciare il 7 aprile lo sciopero della fame e della sete, fintanto che non vedrò rispettati i diritti della mia famiglia ancor prima che i miei. Lo sciopero della fame è l’ultima risorsa, supportata dlla società civile e dagli “Amici di Pino Masciari” vista l’urgente necessità di tornare a vivere che dichiarano: «Grazie a Pino Masciari abbiamo imparato ad amare lo STATO. Dodici anni di sofferenza e esilio sono un prezzo altissimo che i Masciari hanno pagato con dignità, senza mai rinnegare la scelta fatta. E’ ora che questo STATO riconosca loro quanto dovuto. Noi, Società Civile, non possiamo accettare questa scelta senza lottare fino all’ultimo istante al fine di evitare l’ennesimo estremo sacrificio della famiglia Masciari. Basta una firma, e la volontà di apporla. Per i cittadini, lo STATO e la Costituzione. Per la Famiglia Masciari.» Il 14 maggio termina lo sciopero della fame e della sete a seguito dell’impegno preso dalla Presidenza della Repubblica attraverso la nota del 12 maggio, che da quel momento mi assegna scorta e tutela adeguata e ulteriori vetture di staffetta, che mi hanno accompagnato.
Due eventi preoccupanti. Il 21 luglio 2009, sul davanzale della mia ex sede della ditta di costruzioni (attualmente ufficio legale di mio fratello), a Vibo Valentia, è stato ritrovato un ordigno inesploso. Il 19 agosto l’abitazione in località segreta nella quale risiedo con la mia famiglia, è stata violata. In questo caso si è trattato probabilmente di ladri comuni (cosa comunque gravissima, a riprova della vulnerabilità cui siamo soggetti), nel precedente è stata invece la ‘ndrangheta, che ricorda di non avere fretta, non dimentica.
L’uscita dal Programma speciale di protezione. Nel 2010 ho concordato la conclusione del Programma Speciale di Protezione in comune sintonia con il Ministero dell’Interno, dando cosi inizio ad una nuova fase della mia vita e quella della mia famiglia, con le Istituzioni e la società civile al mio fianco. Oggi vivo alla luce del sole, pur rimanendo “sotto scorta”.
L’inizio di una nuova vita. «”Quando istituzioni e società civile si assumono le proprie responsabilità lo Stato vince. In questo credo e continuo a credere ed è per questo che sono certo che la mia vicenda si concluderà con la giusta reintroduzione sia in ambito lavorativo che sociale ed umano“.» In questi anni ho girato l’Italia, ho solidarizzato con i familiari delle vittime di mafia ed altre associazioni, persino oltre confine, sono stato a raccontare la mia storia in numerosissimi istituti scolastici e incontri organizzati dalla società civile. Inoltre ho ottenuto la cittadinanza onoraria di molte città. E infine, si è deciso – insieme a mia moglie – di raccontare la nostra storia in un libro. Si intitola “Organizzare il coraggio. La nostra vita contro la ‘ndrangheta”, lo ha pubblicato la casa editrice torinese “Add”.
COSIMO MAGGIORE. L’ultimatum del testimone di giustizia Cosimo Maggiore: “Mi hanno lasciato solo”, scrive Paolo de Chiara il 14 gennaio 2015 su “19 luglio 1992”. “Nella mia azienda non entrerà nessuno. Io non sono come loro, sono una persona perbene. Ho ricevuto una proposta indecente: fare un accordo con la mafia. Cosa devo fare per uscire da questa drammatica situazione? Devo rivolgermi ad un usuraio? Devo fare il gioco dei mafiosi che ho denunciato? Devo vendere la mia anima al diavolo, alla Sacra Corona Unita? Non ho ritirato le mie denunce, neanche dopo le innumerevoli pressioni. Ho mandato in galera i miei estorsori. Continuerò su questa strada, sino alla fine. Sino alla morte”. Cosimo Maggiore, il testimone di giustizia che ha sfidato la mafia pugliese, è determinato, fermo sulle sue posizioni. “Meglio la morte, che perdere la dignità”. Non vuole e non cerca compromessi. Abbiamo già raccontato la sua drammatica storia (Il Testimone di giustizia abbandonato dallo Stato, restoalsud.it), ma nulla è cambiato. Cosimo è un imprenditore (si occupava di infissi), vive a San Pancrazio, in provincia di Brindisi, dove risiede la figlia del capo di Cosa Nostra, Totò Riina. Ha avuto il coraggio di dire no nel suo territorio, stretto da una morsa mortale, quella della Sacra Corona Unita, la mafia sotterranea, di cui pochi si occupano. Una delle mafie più pericolose presenti in Italia, che opera nel silenzio e nel disinteresse generale. Maggiore ha rotto questo muro di omertà, ha denunciato, ha testimoniato. Ha indicato con il dito i suoi aguzzini, ha fatto i nomi e i cognomi. Ha permesso allo Stato di condannare questi pericolosi delinquenti, assassini senza scrupoli. “Grazie alle mie dichiarazioni lo Stato si è imposto con la legge, con la legalità. Ora lo stesso Stato mi ha lasciato solo. Oggi (lunedì 12 gennaio 2015, ndr) entreranno nel mio capannone, messo all’asta per il mancato rispetto di una legge dello Stato (legge 44 del 1999, ‘Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura’), ma io non rinuncerò a lottare. Dovranno prima uccidermi”. Dopo le denunce è iniziato il suo percorso ad ostacoli. “Sto combattendo la mia battaglia anche contro le Istituzioni”. Poco attente, distratte e insensibili, soprattutto nei confronti dei testimoni di giustizia, che non hanno nulla a che fare con i collaboratori. Due figure diverse: i primi, semplici cittadini che hanno fatto il proprio dovere attraverso la denuncia; i secondi, già appartenenti a consorterie mafiose (definiti anche ‘pentiti’) e con dei reati sulle spalle. “Ho scritto al presidente della Repubblica, al Ministro degli Interni, al Presidente del Tribunale di Brindisi, al Generale dei Carabinieri. L’Arma è l’unica Istituzione che mi è stata vicina. Gli altri non hanno risposto ai miei appelli, al mio grido di aiuto”. Ma perché il capannone di Maggiore è andato all’asta? Non è riuscito a pagare i suoi creditori, “nemmeno il giudice civile ha accettato la sospensione (articolo 20, legge 44 del ’99)”. L’asta è stata vinta da un unico partecipante “legato alla criminalità. Ho chiesto informazioni, un mio amico mi ha riferito dei legami di sangue con Roberto Maci, fratello di Vito, appartenente alla delinquenza locale. Sono stanco di combattere inutilmente, la mia scelta è stata fallimentare. Ogni volta che rilascio un’intervista devo subire anche le pressioni di alcuni soggetti. Mi arrivano anche continui messaggi per le cose che scrivo quotidianamente su Facebook. Ho tutti contro, maledetto il giorno che ho denunciato”. Cosimo ha tentato anche la strada del dialogo con il “prestanome”. Tutto inutile. “Ho visto l’ufficiale giudiziario salire sulla macchina del boss della Scu, denunciato da me e condannato a due anni di carcere. Non mi sento più un testimone di giustizia, ma una vittima dello Stato”. Il testimone di giustizia pugliese è sconfortato, ha perso fiducia. Il dovere di ogni cittadino è denunciare, sempre e comunque. Costi quel che costi. L’unica arma è allearsi con lo Stato, almeno per mettere i bastoni tra le ruote a questi ripugnanti delinquenti. Cosimo Maggiore è pentito della sua scelta, porta avanti da solo la sua battaglia. “Per entrare dovranno chiamare un fabbro. La mia reazione dipenderà dalle loro azioni. Mi farò ammazzare, meglio morto che senza dignità”.
Si barrica nella sua azienda venduta all’asta e tenta il suicidio, l’imprenditore che denunciò il racket: “Vaffanculo Stato”. L’intervista realizzata da Maristella De Michele su “Brindisi Oggi”. Ha perso tutto, ora anche la sua azienda venduta all’asta. Questa mattina i nuovi proprietari hanno cambiato il lucchetto e si sono appropriati dell’azienda di Cosimo Maggiore, l’imprenditore di San Pancrazio Salentino che nel 2008 denunciò i suoi estorsori, ritenuti elementi di spicco della Sacra Corona unita di Torre Santa Susanna. Maggiore è stato riconosciuto testimone di giustizia, ma come la maggior parte dei testimoni è stato abbandonato dallo Stato. In un paese dove i collaboratori di giustizia vengono tutelati meglio dei testimoni, gente che non ha commesso alcun reato ma che ha deciso di denunciare il racket e il malaffare. Una volta raccolte le testimonianze poi vengono lasciati al loro destino, senza alcuna garanzia. La legge che riconosce lo status di testimoni di giustizia è la stessa che garantisce tutele per i pentiti. Ma questi ultimi servono, e quindi vengono protetti. I testimoni, come molti di loro raccontano “vengono usati e poi mandati via… per loro siamo solo dei rompiglioni” Questa è una delle frasi più volte lette nel libro del giornalista Paolo De Chiara che in “Testimoni di giustizia” riporta la storia e le interviste ad molti di coloro che hanno denunciato e si sono opposti alle organizzazioni criminali. La storia di Cosimo Maggiore ve l’abbiamo già raccontata in un nostro reportage. Alla sua triste vicenda oggi si aggiunge un nuovo tassello. Lui non solo non ha più un lavoro, pochissime tutele, una vita di stenti ma la sua azienda è stata venduta all’asta perché non è stata riconosciuta la legge prevista in questi casi per la sospensione del pagamento delle varie contribuzioni. Oggi è sfiorato nella sua mente il pensiero di farla finita, di saltare in aria in quel capannone che è stata la sua vita. Ma non ce l’ha fatta, ha guardato la foto dei suoi e ha deciso di continuare a vivere. Arrabbiato, amareggiato, deluso, con la dignità calpestata si lascia sfuggire in questa intervista: “vaffanculo allo Stato”.
Azienda va all’asta e imprenditore tenta il suicidio, scrive A.P. su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. «Vaff... allo Stato». Sono le ultime durissime e sofferte parole dell’imprenditore Cosimo Maggiore, che nel 2008 denunciò i suoi estorsori, ritenuti elementi di spicco della Sacra Corona unita di Torre Santa Susanna. Maggiore è stato riconosciuto testimone di giustizia, ma è stato abbandonato dallo Stato. Uno schiaffo in un paese dove i collaboratori di giustizia vengono tutelati meglio dei testimoni, gente che non ha commesso alcun reato ma che ha deciso di denunciare il racket. Ma una volta raccolte le testimonianze persone come Maggiore vengono abbandonate al loro destino, senza alcuna garanzia. La legge che riconosce lo status di testimoni di giustizia è la stessa che garantisce tutele per i pentiti. Al termine di una mattinata convulsa l’imprenditore si è barricato in azienda tentando di farla finita. L’ultimo disperato grido d’allarme dopo che alla fine di una vicenda che va avanti da quasi 7 anni, la sua attività è stata venduta all’asta. Maggiore non solo non ha più un lavoro, pochissime tutele, una vita di stenti, ma ha finito anche col perdere la sua azienda che è stata venduta all’asta perché non è stata riconosciuta la legge prevista in questi casi per la sospensione del pagamento delle varie contribuzioni. E ieri mattina quando ha visto che i lucchetti all’ingresso della sua attività erano stati sostituiti ha pensato di compiere un insano gesto vedendo che tutte le battaglie sostenute negli ultimi anni erano perse. Amaro il suo sfogo: «È finita oltre che la mia vita si sono presi anche la mia azienda. Fanno bene a non denunciare. Non denunciate il racket. Ecco cosa succede, sbattuto fuori da casa mia! La mia banca la Popolare pugliese non ha accettato l’art. 20 della legge 44/99, la legge che tutela chi è colpito dal racket. Grazie Stato». Con la voce rotta dall’amarezza spiega perchè non ha portato a termine il suo gesto: «Mi sono barricato nel capannone perchè avevo deciso di farla finita. C’era già tutto pronto anche le bombole di propano. Poi... ho guardato le foto dei miei figli... e... non ce l’ho fatta». Poi conclude: «Vaff... allo Stato!».
L’azienda del testimone di giustizia finisce all’asta. “Pronto a barricarmi dentro”, scrive Paolo De Chiara su “Resto al Sud”. “Nella mia azienda non entrerà nessuno. Io non sono come loro, sono una persona perbene. Ho ricevuto una proposta indecente: fare un accordo con la mafia. Cosa devo fare per uscire da questa drammatica situazione? Devo rivolgermi ad un usuraio? Devo fare il gioco dei mafiosi che ho denunciato? Devo vendere la mia anima al diavolo, alla Sacra Corona Unita? Non ho ritirato le mie denunce, neanche dopo le innumerevoli pressioni. Ho mandato in galera i miei estorsori. Continuerò su questa strada, sino alla fine. Sino alla morte”. Cosimo Maggiore, il testimone di giustizia che ha sfidato la mafia pugliese, è determinato, fermo sulle sue posizioni. “Meglio la morte, che perdere la dignità”. Non vuole e non cerca compromessi. Abbiamo già raccontato la sua drammatica storia (Il Testimone di giustizia abbandonato dallo Stato, restoalsud.it), ma nulla è cambiato. Cosimo è un imprenditore (si occupava di infissi), vive a San Pancrazio, in provincia di Brindisi, dove risiede la figlia del capo di Cosa Nostra, Totò Riina. Ha avuto il coraggio di dire no nel suo territorio, stretto da una morsa mortale, quella della Sacra Corona Unita, la mafia sotterranea, di cui pochi si occupano. Una delle mafie più pericolose presenti in Italia, che opera nel silenzio e nel disinteresse generale. Maggiore ha rotto questo muro di omertà, ha denunciato, ha testimoniato. Ha indicato con il dito i suoi aguzzini, ha fatto i nomi e i cognomi. Ha permesso allo Stato di condannare questi pericolosi delinquenti, assassini senza scrupoli. “Grazie alle mie dichiarazioni lo Stato si è imposto con la legge, con la legalità. Ora lo stesso Stato mi ha lasciato solo. Oggi (lunedì 12 gennaio 2015, ndr) entreranno nel mio capannone, messo all’asta per il mancato rispetto di una legge dello Stato (legge 44 del 1999, Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), ma io non rinuncerò a lottare. Dovranno prima uccidermi”. Dopo le denunce è iniziato il suo percorso ad ostacoli. “Sto combattendo la mia battaglia anche contro le Istituzioni”. Poco attente, distratte e insensibili, soprattutto nei confronti dei testimoni di giustizia, che non hanno nulla a che fare con i collaboratori. Due figure diverse: i primi, semplici cittadini che hanno fatto il proprio dovere attraverso la denuncia; i secondi, già appartenenti a consorterie mafiose (definiti anche pentiti) e con dei reati sulle spalle. “Ho scritto al presidente della Repubblica, al Ministro degli Interni, al Presidente del Tribunale di Brindisi, al Generale dei Carabinieri. L’Arma è l’unica Istituzione che mi è stata vicina. Gli altri non hanno risposto ai miei appelli, al mio grido di aiuto”. Ma perché il capannone di Maggiore è andato all’asta? Non è riuscito a pagare i suoi creditori, “nemmeno il giudice civile ha accettato la sospensione (articolo 20, legge 44 del ’99)”. L’asta è stata vinta da un unico partecipante “legato alla criminalità. Ho chiesto informazioni, un mio amico mi ha riferito dei legami di sangue con Roberto Maci, fratello di Vito, appartenente alla delinquenza locale. Sono stanco di combattere inutilmente, la mia scelta è stata fallimentare. Ogni volta che rilascio un’intervista devo subire anche le pressioni di alcuni soggetti. Mi arrivano anche continui messaggi per le cose che scrivo quotidianamente su Facebook. Ho tutti contro, maledetto il giorno che ho denunciato”. Cosimo ha tentato anche la strada del dialogo con il “prestanome”. Tutto inutile. “Ho visto l’ufficiale giudiziario salire sulla macchina del boss della Scu, denunciato da me e condannato a due anni di carcere. Non mi sento più un testimone di giustizia, ma una vittima dello Stato”. Il testimone di giustizia pugliese è sconfortato, ha perso fiducia. Il dovere di ogni cittadino è denunciare, sempre e comunque. Costi quel che costi. L’unica arma è allearsi con lo Stato, almeno per mettere i bastoni tra le ruote a questi ripugnanti delinquenti. Cosimo Maggiore è pentito della sua scelta, porta avanti da solo la sua battaglia. “Per entrare dovranno chiamare un fabbro. La mia reazione dipenderà dalle loro azioni. Mi farò ammazzare, meglio morto che senza dignità”.
Il testimone di giustizia abbandonato dallo Stato. “Maledetto il giorno che ho denunciato, maledico questo Stato e le persone che mi hanno convinto a denunciare e che mi hanno lasciato solo”. È l’imprenditore Cosimo Maggiore che parla, un testimone di giustizia di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. La stessa località che ospita la figlia del capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina. Cosimo è stanco, è abbattuto. Ha denunciato i suoi estorsori, uomini della Sacra Corona Unita, finiti in galera e condannati grazie al suo senso civico. Alla sua onestà di cittadino perbene. Vittima di estorsione e di minacce da parte dei mafiosi del posto. La mafia pugliese, sanguinaria e violenta, che sembra quasi dimenticata. Lo stesso ‘trattamento’ riservato alla ‘ndrangheta, sino a qualche tempo fa. Ha perduto la sua azienda e la speranza. “Oggi non lavoro più, cazzeggio tutto il giorno su facebook, la mia valvola di sfogo. Il mio capannone è stato messo all’asta. Mi hanno fatto terra bruciata intorno. Sono solo, con la mia famiglia. Sai chi ha acquistato all’asta il mio capannone? Un prestanome delle persone che ho denunciato. Ma nessuno entrerà nella mia struttura, a costo di farmi saltare in aria”. Cosimo ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Napolitano, al ministro Alfano, al Prefetto, al Generale dei Carabinieri. “Non ho ricevuto risposta da nessuno. L’unica cosa che hanno fatto è stato il ritiro delle armi, legalmente detenute. Le ho regalate ai miei amici dell’Arma”. Cosimo Maggiore ha una scorta, due carabinieri (“tutto ciò che mi resta, due angeli custodi”) che lo seguono ovunque. “Ho ricevuto premi come imprenditore coraggio, tutti mi dicono sei coraggioso, hai le palle, servono persone come te. Sono uno scemo, mi sento solo e abbandonato”. Ma quando inizia la sua storia di testimone di giustizia? “Otto anni fa, nel 2006, quando vennero da me dei soggetti per una proposta”. Una ‘assicurazione’, un’estorsione di 500euro al mese, da destinare alle famiglie dei carcerati. “Non accettai la proposta”. Cosimo pensa a lavorare, ha diversi cantieri aperti, costruzioni da ultimare. Si occupa di infissi. Va avanti per la sua strada, a testa alta. Ma i delinquenti non mollano la presa. Si rifanno vivi dopo qualche mese. “Vengo convocato in un appartamento, dove trovo una bella sorpresa. Non c’erano lavori da effettuare, ma una nuova proposta da accettare. Pretendevano anche gli interessi arretrati, circa 2mila euro al mese”. Nella stanza erano “presenti Occhineri Antonio e Musardo Mario”, entrambi detenuti. Cosimo continua a subire pressioni, strani sguardi, avvertimenti. Racconta la sua drammatica storia a un ispettore della squadra mobile e denuncia nel 2007. “Ho avuto paura, questa è brutta gente. Hanno collegamenti con le forze dell’ordine e non solo”. Sino ad oggi ha collezionato 32 denunce, “è stato tutto inutile”. Le pressioni continuano senza soste. “Un mio compare, vicino a questa organizzazione criminale, mi avvicina diverse volte. Pretendono che ritiri la querela, mi incontrano”. È presente anche Bruno Andrea, capo indiscusso della zona, oggi in carcere con una trentina d’anni da scontare. Fratello di Ciro, capo storico della Scu, già condannato all’ergastolo. “Mi fanno parlare con un avvocato, che a tavolino, mi spiega cosa devo fare”. Il ‘compare’ continua la sua azione, “non potevo immaginare che anche lui potesse appartenere all’organizzazione. Gli dissi che non doveva farsi più vedere, ricordo una sua frase, non potrò mai più dimenticarla: ‘fai attenzione, non sai chi hai sfidato. Sono gli stessi criminali che, tempo fa, hanno ammazzato e seppellito sotto un terreno due giovani”. Cosimo Maggiore è una brava persona, non la ritira la denuncia. Si posiziona dalla parte dello Stato (che in molte circostanze non si dimostra tale e con la ‘S’ maiuscola), vuole e cerca giustizia. La sua dettagliata testimonianza manda in galera sette soggetti. Diventa quasi un eroe. Nel 2007 a San Pancrazio il Presidente della Provincia convoca un consiglio monotematico, coinvolgendo tutti i sindaci (di Brindisi e provincia), i politici, la Camera di Commercio e le autorità locali. Tutti insieme per celebrare “l’imprenditore coraggioso, tutti volevano aiutarmi. Ad oggi non ho mai visto nessuno. Dopo la denuncia è cominciato il mio calvario”. Nel 2008 i riconoscimenti pubblici: il premio 112 dell’Arma dei Carabinieri e il premio imprenditore coraggio. Iniziano i problemi anche con la sua attività. “Mano a mano comincio a perdere i lavori”. ‘Non possiamo saltare anche noi in aria’ – le parole ripetute all’infinito – potevi pensarci prima. Te la sei cercata. Perde tutti i lavori. “Ed iniziano altri problemi, le ingiunzioni. Mi avevano avvisato, me lo avevano detto chiaramente: ‘te la faremo pagare. Rimarrai da solo come un cane’. Si è avverato tutto”. Il testimone di giustizia non si dà pace. “Il mio capannone è stato messo all’asta, nessuno ha applicato l’articolo 20 della legge 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura). La banca non ha mai accettato questa legge, nessuna sospensione. Solo una presa per il culo”. Si legge nell’interrogazione dell’aprile 2014, a firma del senatore Iurlaro: “Chi denuncia il racket dovrebbe essere tutelato ai sensi di quanto stabilito dalla legge del 1999. Chi è vittima dell’estorsione e denuncia il racket, si rivolge alle associazioni anti racket proprio perché ne presume l’adeguata esperienza assistenziale, invece, nel territorio brindisino, il signor Maggiore ha ricevuto solo danni per inadeguata assistenza. È stato persino danneggiato pesantemente, per il mancato interessamento volto alla sospensione dei termini di 300 giorni ex art.20, come era suo diritto e come, da prassi, ottiene la vittima di estorsione e/o usura che abbia denunciato ed abbia presentato domanda di accesso al Fondo”. Cosimo ha 47 anni, una moglie e due figli. Ma come vive la famiglia Maggiore questa assurda situazione? “Preferisco non parlarne. Con me hanno vinto loro, i mafiosi. Siamo rimasti soli, tremendamente soli. Vado sempre in giro con una lettera intestata alla mia famiglia. Mi resta soltanto una strada: il suicidio”.
Un ex imprenditore chiede aiuto: “La SCU ha mantenuto la sua promessa: Io non vivo più”, scrive Maristella De Michele su “Brindisi Oggi” “Se non paghi finirai di lavorare”; “Se denunci avrai finito di vivere”; “Se ti fai parte civile, muori”. Firmato La Scu (Sacra corona unita). Questo e molto altro lo ha vissuto – e continua a vivere – sulla sua pelle Cosimo Maggiore, oggi 47enne, ex imprenditore di San Pancrazio Salentino, piccolo paese in provincia di Brindisi. ‘Ex’ perché oggi Maggiore si ritrova senza un lavoro e senza la sua azienda. Perché? Perché un bel giorno mentre nel Salento stava per sbocciare la Primavera al cancello della sua azienda di infissi si è presentato il pizzo. Una macchia nera che avvolge e distrugge tutto: il lavoro, la libertà, la serenità, la vita. L’imprenditore, che si è piegato pochissime volte ai ricatti della criminalità organizzata, è stato costretto al pagamento attraverso intimidazioni e minacce, ma poi aggrappandosi alle sue forti spalle ha deciso di recarsi dalle forze dell’ordine e denunciare. Dal 2006 ad oggi per Cosimo Maggiore e la sua famiglia, sono stati anni di lotte, minacce, denunce, arresti, paure. L’imprenditore da otto anni vive sotto protezione. Al suo fianco ci sono sempre due carabinieri – definiti da lui gli angeli custodi – che non lo perdono di vista. Una vita che oramai non si può più definire vita. Un’azienda ereditata dal padre che dopo venti anni di duro lavoro si è sgretolata, ma non a causa della crisi o della mancanza di lavoro, ma a causa del giro del racket. Cosimo Maggiore non si è inginocchiato ai piedi della Scu e ha denunciato, non una sola volta, ma più volte fino a far arrestare anche il boss della frangia torrese della Sacra corona unita, Andrea Bruno insieme ai suoi compari. Oggi però dopo anni di inferno, Cosimo Maggiore – considerato dallo Stato un Testimone di giustizia e vittima del racket – sostiene che a sbattergli le porte in faccia sia stato proprio lo Stato e le associazioni Antiracket e sostiene, ancora, che a vincere sia stata la Scu. Il suo capannone, infatti, lo Stato lo ha venduto all’asta. Una parte, quindi, della sua ex azienda è stata acquistata da terze persone. L’imprenditore di San Pancrazio Salentino lo scorso settembre ha presentato un’ennesima denuncia presso l’Arma dei carabinieri. In quella querela Maggiore dichiara a chiare lettere che il suo capannone sarebbe stato acquistato da un prestanome. Già in passato Maggiore aveva rilasciato qualche dichiarazione, ma oggi per la prima volta ha accettato di parlare in una video-intervista.
LUIGI COPPOLA. Sono disposto a darmi fuoco. Parla il testimone di giustizia Luigi Coppola. Abbandonato dallo Stato, scrive Paolo De Chiara sul suo blog. “La camorra ha iniziato, ma le Istituzioni stanno continuando il lavoro”. Non usa mezzi termini il testimone di giustizia Luigi Coppola per spiegare la sua situazione. Difficile e drammatica per lui e per la sua famiglia. La famiglia Coppola, per una scelta coraggiosa e dignitosa, è costretta ad elemosinare un posto per dormire. Tutto è cominciato nel 2001. Luigi era un commerciante di auto a Boscoreale, in provincia di Napoli. Stanco delle vessazioni della camorra, denuncia le estorsioni e l’usura. Grazie alle sue denunce si aprono le porte del carcere per alcuni esponenti camorristici locali. Oggi la famiglia Coppola è stata abbandonata dallo Stato. Ritornati nella loro terra, dopo aver girato il Paese, hanno toccato con mano la diffidenza della gente comune. “Un giorno sono entrato insieme alla mia scorta in un noto ristorante di Pompei. A me e mia moglie è stato impedito di sederci a tavola”. Nel gennaio del 2010 il Viminale ha revocato la scorta e la vigilanza fissa. Per lo Stato l’imprenditore Coppola non rischia nulla. Solo per un ricorso al Tar viene risparmiata la scorta. Non è facile, nel BelPaese, la vita dei testimoni di giustizia. Per l’europarlamentare Sonia Alfano: “le loro storie, purtroppo, sono tutte uguali: eroi civili che hanno denunciato i fatti criminosi che hanno subito o di cui sono venuti a conoscenza e che, dopo i processi (le cui sentenze quasi sempre si soffermano sulla nobiltà del loro gesto) sono stati abbandonati dallo Stato, estromessi dai programmi di protezione, lasciati senza sicurezza e senza mezzi di sostentamento”. Luigi Coppola, membro della consulta anticamorra del comune di Boscoreale e coordinatore di uno sportello antiracket, continua la sua solitaria battaglia. “Sono anche disposto a darmi fuoco davanti al Viminale. E’ un mese che ho lasciato l’albergo per motivi economici e nessuno si è curato di noi”.
Coppola, a chi si riferisce?
“Allo Stato”.
Cosa chiede allo Stato?
“Di essere ricevuto e di cercare una soluzione al mio grosso problema. Nel momento in cui lo Stato mi abbandona definitivamente sotto il profilo della sicurezza la camorra metterà in atto il proprio atto criminale”.
Ha ricevuto altre minacce?
“Sto vivendo temporaneamente presso l’abitazione di mio fratello. Ultimamente si sono registrati degli sgradevoli episodi. Qualcuno, scambiando mio fratello per me, gli ha dato del cornuto. C’è stata una regolare denuncia fatta da mio fratello”.
Esiste una petizione promossa dal comitato per la tutela dei testimoni di giustizia, tra i firmatari Salvatore Borsellino, Sonia Alfano, Angela Napoli, Giuseppe Lumia, Elio Veltri. A che punto siamo?
“Non ricordo bene se siamo a 1300 o 1400 adesioni. C’è l’intenzione, entro questo mese, di portarla all’attenzione del Capo dello Stato per vedere se almeno lui ci riceva”.
Nel luglio scorso Sonia Alfano ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica per illustrare la situazione dei testimoni di giustizia. Siete stati ricevuti dal Capo dello Stato?
“No, l’incontro non c’è mai stato. A parte la lettera dell’onorevole Alfano, mi ci sono recato personalmente al Quirinale. Insieme a mia moglie abbiamo fatto lo sciopero della fame, ma in tre giorni e tre notti nessuno si è visto. Ho avuto una sola risposta dal Quirinale. In quei giorni sono scesi dei funzionari che mi hanno comunicato che il Capo dello Stato non può interferire in decisioni che devono essere prese da altri organi dello Stato”.
Il neo ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, ha dichiarato che “si interesserà al caso”.
“Il ministro ancora non si è interessato. L’altro giorno sono stato ricevuto dal senatore Giuseppe Lumia e prima dell’incontro sono riuscito ad ascoltare le dichiarazioni della Cancellieri alla Camera dei Deputati, un’interrogazione a risposta immediata sull’altro caso del testimone di giustizia Cutrò. Il ministro ha risposto anche sugli altri testimoni, affermando che il Viminale si è sempre preso cura dei testimoni e nulla sarebbe stato lasciato al caso. Io sono la prova che tutto ciò è falso e sfido la Cancellieri a smentirmi”.
Lei era un rivenditore di automobili a Boscoreale. Nel 2001 denuncia l’estorsione e l’usura della camorra…
“E viene decapitato definitivamente il clan Pisacane di Boscoreale, vengono tratti in arresto un reggente del clan Cesarano, più due suoi cognati. In più vengono arrestati appartenenti al clan Gionta di Torre Annunziata e numerose persone che avevano fatto usura nei miei confronti. In totale 30 persone. Per pagare la camorra fui costretto ad acquisire denaro a tassi usurai. Grazie alle mie dichiarazioni è stato anche sciolto il Comune di Boscoreale per infiltrazioni camorristiche”.
Nel 2002 venite inseriti nel programma di protezione per i testimoni di giustizia…
“Grazie al sostituto procuratore Giuseppe Borrelli, che lavora attualmente presso la Procura di Catanzaro. Prima stava alla Dda di Napoli. Prima di lui, chi aveva preso la situazione in mano non aveva ritenuto opportuno attivare nessuna misura di sicurezza. In quel periodo ho subito due aggressioni e ci sono i referti ospedalieri che lo provano”.
Nel 2007 la famiglia Coppola rientra in Campania, precisamente a Pompei.
“Avevamo scelto Pompei perché ritenuta tranquilla”.
E come siete stati accolti dalle Istituzioni, dalla gente?
“Peggio della camorra. Al sindaco sono state portate delle petizioni che sono state girate alla Direzione Distrettuale Antimafia e all’ex prefetto di Napoli. Il sindaco non ha mai dimostrato sensibilità nei nostri confronti, anche quando siamo stati costretti a vivere nelle auto blindate”.
Come spiega la frase “a voi non si loca e non si vende…”.
“Mi auguro che sia solo un fattore di paura, ma non credo che il Comune di Pompei possa avere paura. Questa è discriminazione”.
Dopo i vari gradi di giudizio, nel 2009, i processi aperti grazie alla sua testimonianza arrivano in Cassazione.
“Ventitre di loro vengono definitivamente condannati per associazione di stampo mafioso. Da un mesetto è uscito il reggente, il braccio destro del clan Pisacane. Stiamo parlando di un clan che fino ad oggi non ha prodotto pentiti e che ha tutta la voglia di rimettersi in piedi, di riprendersi il territorio per continuare con la droga, con le estorsioni e con l’usura”.
Per lo Stato la famiglia Coppola non rischia nulla. Viene revocata la vigilanza fissa e la scorta.
“Alla revoca mi oppongo con un ricorso al Tar. La scorta viene mantenuta, ma la vigilanza non viene rimessa. La camorra dà il proprio segno di apprezzamento con proiettili inesplosi e una bottiglia incendiaria. Attualmente ho ancora la scorta, ma so che stanno operando per eliminarla”.
Oggi come vive la famiglia Coppola?
“A carico di mio fratello e di mia madre, senza un centesimo. Il 24 gennaio le banche mi iscriveranno al recupero crediti e sarà per me la morte civile. E se tutto questo avverrà mi darò fuoco davanti al Viminale”.
Lei ha due figlie.
“Frequentano il liceo”.
A scuola come vengono trattate?
“Non bene. Vengono viste come degli appestati dai loro amici, sicuramente condizionati dai genitori”.
L’ex sottosegretario Mantovano le disse: “cerchiamo di non prenderci il dito, la mano e il braccio”.
“Ho presentato regolare denuncia alla Procura di Roma”.
Esiste lo Stato nei suoi territori?
“Stato è una parola troppo grossa. La camorra ha preso il posto dello Stato”.
L'IMPRENDITORE LUIGI COPPOLA, PERSEGUITATO DALLA CAMORRA E ABBANDONATO DALLO STATO. Inizia nel lontano 1993 la triste storia di Luigi Coppola , 47enne sposato, con 2 figlie, scrive E. Lampitella su “Globuli Azzurri”. Da venditore d’auto a perseguitato dalla Camorra. Coppola è uno dei tanti che denunciano i propri aguzzini ma rimangono sotto traccia. Grazie alle sue deposizioni, nel 2001 sono state arrestate più di 34 persone di 4 Clan diversi, tra cui il Boss Pesacane. L’imprenditore è rimasto vittima delle attenzioni di tre clan diversi. Colpa, la sua, vendere auto in un trivio che è sotto la “giurisdizione” di 3 clan diversi, tra Bosco Reale, Boscotrecase e Torre Annunziata, che lo vedevano come potenziale riciclatore. Rappresentava un boccone prelibato per il loro malaffare . E’ così entrato in una vera e propria spirale del terrore, a causa dei rifiuti alle pesanti richieste di estorsione e riciclaggio di più esponenti malavitosi che si palleggiavano il cittadino onesto di turno. Ma La storia di luigi Coppola non si ferma qui, dopo aver collaborato con la giustizia alla fine di 10 anni passati in mano ad usurai per pagare il pizzo ai camorristi, Coppola è rimasto solo. Abbandonato dallo stato e ridotto alla fame, costretto a dormire in auto con la scorta. Un’ordinanza del Viminale, che fa seguito alle richieste avanzate da Coppola, nega al collaboratore di giustizia il programma di protezione. Luigi Coppola stasera racconterà la sua storia a Globuli Azzurri, programma di Samuele Ciambriello, sempre sensibile a queste tematiche.
LUIGI LEONARDI. Camorra, denunciò chi gli chiedeva il pizzo: abbandonato dallo Stato e dalla famiglia, scrive Giovanni Gaudenzi su Theblazonedpress.it. Luigi Leonardi ha 39 anni, ed è stato per molti anni uno degli imprenditori più ricchi di Napoli. Guadagnava anche 250 mila euro a settimana, con la sua attività di fabbricazione d’impianti d’illuminazione e 4 negozi sparsi per la provincia partenopea. Oggi non guadagna praticamente nulla, e le sue imprese non esistono più. Perchè ha osato denunciare i taglieggiatori mandati dalla camorra, che gli chiedevano oltre 24 mila euro al mese per garantirgli la loro protezione. Lui, invece di sottostare al vile ricatto dei clan, ha scelto di ribellarsi, presentando 18 denunce negli ultimi 12 anni. Sulle sue dichiarazioni sono basati 2 processi, il primo dei quali ha portato a 63 condanne in primo grado. Per il commerciante nessuna protezione, nessuna misura precauzionale come quelle previste per i pentiti. Perché Leonardi, con i camorristi, non ha mai voluto avere nulla da spartire. E’ stato aggredito a sprangate, nel 2009, ed è finito in ospedale con una diagnosi di cecità temporanea all’occhio sinistro. L’uomo è stato anche sequestrato per 24 ore, a Secondigliano. Ma non si è arreso, sfidando la mala e perdendo tutto quello che aveva, negozi compresi. Ora chiede solo che lo Stato provveda a proteggerlo e che gli venga riconosciuto lo status di testimone di giustizia, insieme al risarcimento dei danni subiti. “Rifarei tutto- spiega- Con la camorra non ho mai voluto compromettermi.” Il cugino del padre, Antonio Leonardi, è sospettato di essere affiliato alla famiglia mafiosa dei Di Lauro. Ed è questa la ragione per la quale la sua famiglia lo ha abbandonato, lasciandolo solo a combattere la sua battaglia: “Se mi fossi rivolto a lui- dice- avrebbe risolto immediatamente la questione. Ma ho scelto di stare dalla parte della legalità. Adesso, alla mia situazione, deve pensarci lo Stato.”
Camorra, denunciò i clan. La famiglia lo lascia solo, lo Stato non lo risarcisce. Luigi Leonardi, a causa delle estorsioni, ha perso due fabbriche di impianti di illuminazione, i negozi e la casa. Negli anni ha subito minacce ed è stato sequestrato. Le sue dichiarazioni hanno portato a due processi, per questo la famiglia, sospettata di essere vicina ai Di Lauro, non gli rivolge più la parola da 5 anni. Adesso l'imprenditore chiede che gli venga riconosciuto lo status di testimone di giustizia e un risarcimento, scrive Antonella Beccaria su “Il Fatto Quotidiano”. Ha 39 anni e da 5 non riceve dalla sua famiglia un messaggio, nemmeno un augurio per Natale. Ma fino a qualche anno fa le feste comandate, però, gliele ricordavano gli “esattori” della camorra, gli stessi che gli chiedevano il pizzo e che per l’occasione, oltre ai 6 mila euro a settimana, gli volevano imporre un’integrazione di 1500 euro. Luigi Leonardi, nato a Napoli nel 1974 e oggi riparato in una località in provincia di Salerno, a causa del racket ha perso le sue due fabbriche di impianti di illuminazione e i relativi negozi, distribuiti tra Cardito, Nola, Giugliano e Melito, nel Napoletano. Ed è accaduto nonostante si sia ribellato al “sistema” che cercava di stritolarlo presentando 18 denunce nell’arco di 12 anni. Denunce che hanno portato a due processi, il primo celebrato davanti al tribunale di Nola e giunto a sentenza di primo grado il 31 maggio 2010 con condanne per 63 persone e periodi di reclusione che vanno tra 5 ai 17 anni. Il secondo processo, invece, è ancora in corso a Napoli. Partito a rilento con udienze rinviate per 5 volte a causa di difetti di notifica, sta entrando nel pieno e il 22 ottobre Luigi Leonardi racconterà davanti al collegio giudicante la sua vicenda che ha ricostruito in due incontri con ilfattoquotidiano.it, il primo a Sasso Marconi, in provincia di Bologna, e il secondo a Firenze, nella sede dell’Associazione stampa Toscana. Qui esordisce affermando che, rispetto ai testimoni di giustizia, “i pentiti hanno più voce in capitolo. Chi invece non ha mai voluto avere a che fare con i clan, avrebbe diritto almeno allo stesso tipo di protezione offerto ai collaboratori”. L’affermazione trova ragione nel fatto che l’imprenditore napoletano, nel corso degli anni, ha subito diversi atti di violenza. Oltre alle intimidazioni dei clan napoletani di Secondigliano, Melito, Marano e Ottaviano, ognuno dei quali pretendenva la propria fetta sul fatturato di Leonardi, poi si è passati alle vie di fatto. Prima c’è stata l’auto dell’imprenditore sbalzata fuori strada al termine di un inseguimento. Poi un’aggressione, a metà 2009, a suon di spranghe di ferro che l’hanno fatto finire in ospedale con una diagnosi di cecità temporanea all’occhio sinistro. E ancora, nel settembre dello stesso anno, l’uomo è stato sequestrato e tenuto per 24 ore prigioniero nelle Case Celesti di Secondigliano, un rione ad alto degrado soprannominato “terzo mondo”. “In quelle ore”, racconta Leonardi, “mi hanno puntato contro una pistola e mi hanno fatto vedere cambiali per un valore di 26 mila euro che ovviamente non erano mie. Ma pretendevano che le pagassi e per assicurarsi che lo facessi, nonostante li avessi già denunciati, mi hanno preso l’automobile e la moto, che secondo loro valevano la metà dell’importo che mi chiedevano”. Poi lo hanno rilasciato pensando di averlo “ammorbidito”. Invece l’imprenditore è andato avanti, presentandosi a carabinieri, polizia e sostituti procuratori ogni volta che lo convocavano per stendere un nuovo verbale. “Così, alla fine, mi hanno bruciato l’ultimo negozio che mi era rimasto, quello di Melito: in due ore se n’è andato in fumo l’ultimo pezzo della mia attività commerciale”. Oggi le fabbriche non esistono più e nemmeno i punti vendita. Erano stati aperti a partire dal 1997. Allora Luigi Leonardi, giovanissimo, aveva investito il denaro che con la madre era riuscito a mettere da parte, circa 75 milioni di vecchie lire. Con lui c’erano i fratelli e per i primi due anni tutto era sembrato andare per il meglio tanto che nel 1999 le imprese di famiglia erano riuscite ad accedere a un finanziamento regionale di 5 miliardi di lire per costruire un capannone industriale a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. Con la prima tranche da 1 miliardo e 200 milioni erano stati eseguiti i lavori edili e i contratti con i fornitori dei macchinari erano stati firmati. Ma a quel punto erano iniziati i problemi con i riscossori dei clan. Problemi che sono l’inizio della fine e che portano alla rinuncia dell’importo restante del finanziamento, a una denuncia penale contro lo stesso Leonardi, accusato – e poi prosciolto – di essersi appropriato di denaro pubblico senza aver concluso il progetto presentato e al tentativo di contenere le richieste dei clan. Ai quali tuttavia non sono bastati gli oltre 70 mila euro che, in un primo tempo, l’imprenditore paga nell’arco di 11 mesi. “A un certo punto mi sono ribellato, ho deciso che di soldi, a loro, non gliene avrei più dati”, spiega. “Fare impresa vuol dire essere liberi, la ‘protezione’ che i camorristi invece offrono è esattamente il contrario della libertà d’impresa. Non si può accettare di finire in quella spirale, ogni cittadino dovrebbe denunciare, malgrado il prezzo da pagare”. Il prezzo, per Luigi Leonardi, è stato elevatissimo. Con l’entrata in funzione del capannone del beneventano, contava di portare da 20 a 30 i suoi dipendenti, che invece hanno dovuto essere licenziati. Dai 250 mila euro a settimana che fatturava versando regolamente tasse e contributi, è passato a dover farsi bastare 200 euro al mese. Sfrattato dalla casa dove abitava, per un periodo ha occupato un appartamento sopra il negozio di Melito e ha trascorso anche un periodo dormendo in macchina. E ora che ha cambiato città e ha ripreso da libero professionista la sua attività, chiede solo che gli venga riconosciuto lo status di testimone di giustizia e la protezione dello Stato. “Nel processo in corso a Napoli proveranno a farmi passare per un mafioso”, dice. Il cugino di suo padre, infatti, è Antonio Leonardi, arrestato a fine 2012 e sospettato di essere affiliato al clan Di Lauro. “Con la camorra, però, non ci ho mai avuto a che fare. Il paradosso di questa situazione è che so che se mi fossi rivolto a lui, i miei problemi si sarebbero risolti in un attimo, ma la mia scelta è stata quella di mettermi dalla parte della legalità”. Per questo la famiglia lo ha cancellato. “Ti stavi zitto e non succedeva niente”, gli hanno detto. Invece lui ha parlato, prima con i carabinieri del nucleo operativo di Castello di Cisterna e poi con gli agenti della squadra mobile di Napoli venendo sentito in un primo tempo dal sostituto Luigi Alberto Cannavale e in seguito dal collega Francesco De Falco, che oggi rappresenta l’accusa contro i boss che Leonardi accusa. “Se rifarei tutto?”, afferma alla fine. “Sì, non mi pento di aver parlato, starei solo più attento a conservare meglio le carte”. Si riferisce alle fatture e ai documenti bruciati nel negozio di Melito, quelli che oggi gli impediscono di essere risarcito a causa di un altro muro che si è trovato davanti, la burocrazia. “Mi hanno detto che non avendo più alcuna pezza d’appoggio non posso dimostrare l’entità del danno che ho subito. E allora, per fare qualcosa, sto pagando di tasca mia perizie che accertino quest’altro sopruso. Anche a queste assurdità lo Stato dovrebbe pensare”.
TIBERIO BENTIVOGLIO. Tiberio Bentivoglio, imprenditore antimafia: «Ho denunciato, Equitalia mi porta via la casa». Rompe il muro di omertà contro la 'ndrangheta, ma resta solo. Così, tra silenzi, lentezze burocratiche e casa ipotecata, si umilia il coraggio di chi denuncia le cosche di Reggio Calabria, scrive Gelsomino Del Guercio su “L’Espresso”. «Sto perdendo casa e lavoro, ho già perso la serenità familiare. Allora oggi mi chiedo: conviene denunciare i propri aguzzini come ho fatto io?». E' il grido di un uomo disperato quello che affida a "l'Espresso" Tiberio Bentivoglio, imprenditore reggino 61enne sotto scorta e testimone di giustizia dal 1992, cioè da quando si è ribellato ai suoi estorsori. Da allora per Tiberio è iniziato un lungo calvario. Gli hanno voltato le spalle gran parte dei suoi concittadini di Condera, la frazione di Reggio Calabria dove abita e dal 1979 è titolare di un negozio, la "Sanitaria S.Elia" che vende prodotti elettro medicali e articoli per la prima infanzia. Perché da quelle parti sfidare i boss è un sacrilegio. Ma sopratutto gli hanno voltato le spalle le istituzioni, che lo hanno abbandonato a se stesso nonostante gli appelli al consiglio regionale della Calabria, alla Commissione Parlamentare Antimafia , al ministro dell'Interno Angelino Alfano e persino a papa Francesco. In questi giorni la parabola di Tiberio è giunta al capolinea. Sommerso dai debiti, con un fatturato crollato negli ultimi nove anni del 75% (cioè 2 milioni e mezzo di euro in meno) e un conseguente danno per mancato guadagno che si aggira ad oltre 800 mila euro, l'imprenditore è sull'orlo del crac e dirà addio al suo negozio e non solo. Il colpo finale è arrivato tra le fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Equitalia gli ha inviato l'avviso di vendita all'asta della sua abitazione, già ipotecata da oltre un anno per 991mila euro. L'iter prima dello sfratto durerà circa sei mesi. L'ipoteca di Equitalia era arrivata perché da nove anni non paga più i contributi all'Inps dei propri dipendenti (ora rimasti in due, prima erano in cinque) ai quali fino all'anno scorso riusciva a versare a mala pena gli assegni con gli stipendi. «Ho sempre pagato tutto regolarmente ai lavoratori fin quando ho potuto», sottolinea l'imprenditore. Per il danno erariale relativo ai contributi Inps, sua moglie (la loro è un'azienda familiare) ha subito due condanne in primo grado dal tribunale di Reggio Calabria per appropriazione indebita (pena sospesa): la prima un anno fa, la seconda una settimana fa. «Il paradosso è che adesso diventiamo noi i "pregiudicati"…», afferma sconsolato Tiberio. Come se non bastasse, da qualche settimana si è fatto incalzante il pressing delle banche, che dopo l'ipoteca sull'abitazione hanno ritirato gli affidamenti: non concedono più alcuna forma di credito, mutui e prestiti a Bentivoglio. Sono stati ridotti i carnet degli assegni a lui destinati perché sui suoi conti correnti non c'è abbastanza denaro per pagare i fornitori del negozio (circa 150). Il risultato è che le banche, come da legge, hanno inoltrato gli assegni scoperti ai notai - il cosiddetto "protesto" - e per l'imprenditore si prospettano nuove sanzioni amministrative (che comunque non riuscirà a pagare). L'ennesima batosta è arrivata sabato 4 ottobre quando ha ricevuto il preavviso di sfratto dai proprietari del negozio, perché, ormai da un anno, non ha i soldi per pagare l'affitto. Invece il 10 dicembre 2014 il tribunale di Reggio stabilirà se Tiberio dovrà abbandonate il deposito annesso al negozio perché anche in quel caso è "forzatamente" moroso nei confronti del proprietario. Ma perché un uomo libero, un imprenditore coraggioso, un testimone di giustizia, fondatore peraltro di "Reggio Libera Reggio", iniziativa anti racket nata in città il 20 aprile 2010, si è ritrovato in una condizione così assurda, al punto da ritenere che sia stata una cosa sconveniente, un errore, denunciare la 'ndrangheta? E' giusto che in un Paese civile si debba pagare tacitamente il pizzo per non ridursi in questo stato di disperazione? Quest'ultima domanda, tanto più in queste ore, se la stanno ponendo Tiberio, la moglie e sopratutto i suoi figli, «psicologicamente devastati da questa vicenda», dice lui. Nelle sue parole traspare un rimorso rabbioso per quella battaglia iniziata 20 anni fa. «Mi sono rifiutato di riconoscere il loro sistema criminale e sono stato costretto a subire una serie di punizioni e perfino un tentato omicidio che si verificò dopo la condanna di alcuni malavitosi da me nominati nelle denunce». Episodi agghiaccianti, sette in totale. Il primo nel 1992 (furto al negozio), altri due nel 1998 (furto e attentato). Quindi un attentato dinamitardo al negozio nell’aprile 2003 e un incendio nel 2005. Nel giugno 2008 va a fuoco il capannone-deposito. Nel febbraio 2011 gli sparano mentre sta andando nel suo frutteto, alle 6 del mattino. «Solo il caso ha voluto che il proiettile, probabilmente quello fatale, si fermasse nel marsupio di cuoio, che quel giorno portavo a tracolla sulle spalle. Gli autori del tentato omicidio a oggi restano ignoti, mentre io continuo a trascinarmi su una sola gamba in quanto l’altra ha riportato lesioni permanenti causati dai proiettili». Da quel momento a Bentivoglio è stata potenziata la scorta, ora di "terzo livello", cioè assegnata ad una persona "ad alto rischio". Questa serie di intimidazioni ha scatenato un primo, ma graduale allontanamento della clientela dal negozio. E' lunga la lista degli amici che hanno cominciato a far finta di non vederlo, a non salutarlo in strada, a schivarlo. Peggio ancora dopo che il testimone di giustizia, nel 2007, ha denunciato la presunta connivenza del parroco locale don Nuccio Cannizzaro con Santo Crucitti, presunto boss di Condera-Pietrastorta. Il reato di favoreggiamento di cui era accusato il sacerdote è stato prescritto a luglio 2014 e a Condera, dopo la pronuncia del Tribunale di Reggio, si è festeggiato con caroselli d'auto e fuochi d'artificio. «Don Nuccio da queste parti è molto temuto, ma sta di fatto che in Italia la giustizia è lentissima», ammonisce Bentivoglio. Non solo la giustizia, ma lo è anche la burocrazia, che ha scagliato il colpo di grazia contro la "Sanitaria S.Elia". C'è una legge, la 44 del 1999, che prevede aiuti alle vittime di mafia. «Per l'attentato al negozio del 2003 ho ricevuto 3400 euro a fronte di 120mila euro di danni. Per l'incendio del 2005 ho avuto circa 300mila euro in tre anni, e per l'incendio al capannone del 2008 circa 400mila euro, tanto quanto il valore della merce bruciata, ma sempre dopo tre anni». In teoria la normativa stabilisce che lo Stato ripaghi la vittima entro 60 giorni dal fatto. «In realtà la media di attesa è molto più lunga - sentenzia Bentivoglio - intanto, ogni volta che ho subito un agguato, in attesa di ricevere quei soldi sono rimasto anni ed anni con il mio negozio e il deposito distrutti». I clienti in fuga, la liquidità che viene a mancare, le difficoltà nel pagare i fornitori, un mix micidiale, «che mi è costato 2 milioni e mezzo di euro in nove anni, a tanto ammonta il calo del mio fatturato e 800mila di mancato guadagno che è alla base del mio indebitamento verso Stato, fornitori, locatari. In confronto a ciò gli indennizzi ricevuti in tre anni, non compensano praticamente nulla». Sempre per la legge 44/99, gli è valso 16mila euro il tentato omicidio del 2011 (soldi ricevuti nel 2014), e poiché quella norma sospende i provvedimenti esecutivi per 10 mesi, è rimasto tutelato dall'avviso di sfratto del proprietario del deposito fino a settembre 2013. «Non ho mai trovato gente disponibile ad affittare un locale ad una persona come me, che ha già subito una serie di attentati». Eppure l'imprenditore-coraggio non vuol rassegnarsi ad un epilogo che sembra scritto. «Griderò fino all’ultimo giorno di vita - chiosa Bentivoglio - non voglio e non posso finire così. Io ho fatto il mio dovere ma sto perdendo tutto. Se non avessi una famiglia mi sarei già suicidato».
IGNAZIO CUTRO'. L'imprenditore Ignazio Cutrò chiude per mafia "Lo Stato mi ha lasciato solo". Aveva denunciato il racket: “Tante parole al vento perchè alla fine sono stato abbandonato. Mi chiedo quale sia oggi il posto della lotta alla mafia nell’agenda del governo”, scrivono Piero Messina e Maurizio Zoppi su “L’Espresso”. Chiuso per mafia: è il titolo adatto per l’ultimo capitolo della storia imprenditoriale di Ignazio Cutrò. Ultimo, perché l’imprenditore in prima linea contro Cosa Nostra, pronto a denunciare i suoi estortori, alla fine si è arreso e ha chiuso la sua azienda. La procedura è stata avviata al registro delle Imprese di Agrigento. Così, l’azienda che aveva detto no al racket, nei fatti, oggi non esiste più. A Cutrò resta solo una montagna di debiti col fisco e le banche per evitare il fallimento. “Che dire? Un bel segnale per tutti gli imprenditori che sono assaliti dalla mafia e dagli estortori – è il commento caustico di Cutrò – da oggi per tutti è chiaro quale sia la fine delle aziende che si oppongono alla mafia”. Ma come si è arrivati al default? Dopo aver denunciato i suoi estortori, accusandoli pubblicamente e contribuendo all’attività di magistrati e investigatori, l’imprenditore di Bivona, un piccolo comune della provincia di Agrigento, s’era trovato letteralmente solo. Lo Stato all’inizio, sembrava volesse prendere a cuore la causa dell’imprenditore, sul cui operato – nella sentenza che seppelliva il sistema del racket mafioso agrigentino – i giudici esprimevano ben 19 pagine di riflessioni. Cutrò e la sua famiglia finiranno sotto scorta per le continue minacce. A quel punto, l’imprenditore si trova di fronte al classico bivio: scegliere di essere trasferito in località protetta ed essere stipendiato dallo Stato o rinunciare ai sussidi e tentare di far ripartire la sua attività. “ In quel momento ho scelto di restare – ricorda Cutrò – perché ho tentato di essere coerente fino in fondo. Che lotta alla mafia è quella che costringe gli imprenditori ad abbandonare la propria terra e la propria attività?”. Non mancano le stille di curaro: “io sono tra i pochi imprenditori che ha iniziato a collaborare senza versare un centesimo agli esattori della mafia. Non tutti erano nella mia stessa condizione. Molti hanno saltato il fosso soltanto dopo che gli investigatori avevano scoperto e accertato il loro soggiacere alle richieste economiche della mafia”. Che Cutrò credesse fino in fondo alla scelta di restare in Sicilia lo dimostra l’utilizzo dei fondi ricevuti dallo Stato come danno biologico. “A me ed ai miei familiari – spiega – è stato riconosciuto un risarcimento di circa 100 mila euro. Quei soldi avrei potuto metterli da parte, invece li ho usati per pagare tasse e contributi. Insomma, volevo il Durc a posto (durc è l’acronimo di documento unico di regolarità contabile, necessario per lavorare nel settore pubblico, ndr) per poter essere chiamato a lavorare. Forse ho sbagliato”. Ogni tentativo di far ripartire l’azienda sarà inutile. Cutrò e la sua azienda verranno isolati. L’imprenditore tenterà persino di mettere in vendita tutti i mezzi della sua azienda, camion, macchine scavatrici, bulldozer e utensili. Non si è presentato nessuno. “Messaggio chiaro – dice – messaggio non detto che vale più di mille parole: le cose di Cutrò non si toccano”. L’ultimo tentativo è dell’estate scorsa, quando Cutrò viene chiamato a lavorare dal general contractor dell’impianto fotovoltaico di Gela. Missione fallita, di quel sogno declinato nel segno dell’energia verde resta solo una collina rasa al suolo e tante imprese, come quella dell’ormai ex imprenditore antimafia, che non vedranno mai il risultato del lavoro svolto. Eppure sarebbe bastato poco per salvare quella piccola impresa edile in prima linea nella lotta alla mafia, bastavano solamente 38.500 euro. A tanto ammontavano i debiti fiscali che Cutrò avrebbe dovuto pagare per restare con il Durc pulito. Ma lo Stato ha erogato soltanto 20 mila euro, il resto non è mai arrivato. Cutrò sostiene di avere sperato sino all’ultimo nell’intervento del Viminale: “Resta solo l’amarezza – ricorda – per decine e decine di riunioni, tempo perso e parole al vento. Perchè alla fine sono stato abbandonato. Mi chiedo quale sia oggi il posto della lotta alla mafia nell’agenda del governo. A parte le vetrine della legalità, mi sembra tutto fermo e tutto inutile. Non vorrei fare polemica, ma non ritengo giusto che uno Stato in grado di pagare un riscatto di 12 milioni di euro per salvare la vita di due ragazze italiane prese in ostaggio dai terroristi, non trovi le risorse, o molto più probabilmente la voglia, di trovare quei 18 mila euro che rappresentavano la mia salvezza” . “Ora – conclude Cutrò – non mi resta che prendere atto di aver fallito, di avere distrutto la mia vita e quella dei miei figli. Ma in fondo dal Viminale mi avevano avvertito, me l’avevano detto che non avrei più potuto lavorare nella mia terra”.
MAI DIRE MAFIA. FRANCESCO CAVALLARI E LA SFIDUCIA NEI MAGISTRATI.
L’irresistibile ascesa di Cicci e le mille luci della città che pensava in grande. Il rappresentante di farmaci che divenne il re Mida della sanità privata. Nella sua villa cenò Liza Minnelli, scrive Angelo Rossano su “Il Corriere del Mezzogiorno”. È un’alba livida e umida. E’ l’alba di martedì 28 marzo 1995. Se, alla fine, questa storia diventerà davvero la trama per un film, ebbene, la prima scena non potrà che essere questo momento in questa città: Bari. I blitz vengono fatti sempre all’alba, sia che si tratti di criminalità comune, organizzata o di colletti bianchi. Sia che si tratti di sicari di malavita o del sindaco o del direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. L’appuntamento con le manette è a quell’ora lì. E lo fu anche quel giorno. Quando 35 persone finirono coinvolte in un’inchiesta sulla sanità privata. Una storia di tangenti, giri miliardari e rapporti mafiosi. Così si disse e si scrisse. Il Corriere della Sera titolò il pezzo: «Tangenti, in manette i padroni di Bari». E poi finirono tutti assolti. Quell’inchiesta era iniziata qualche tempo prima: il 3 maggio del 1994, un altro martedì. Francesco Cavallari finì in manette con alcuni suoi collaboratori per una storia di ricoveri poco chiara. Da lì, alle sue agendine, ai racconti e alle testimonianze sui suoi rapporti con la politica e con i pezzi che contavano nella società barese, il passo fu breve. E’ l’operazione «Speranza» coordinata dall’allora procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia Alberto Maritati (poi divenne parlamentare prima dei Ds e poi del Pd e anche sottosegretario). Al centro di tutto c’è lui: Francesco Cavallari, detto Ciccio solo da chi voleva far credere di conoscerlo bene, mentre il suo vero nomignolo era «Cicci». E con lui finirono nell’inchiesta e agli arresti domiciliari gli ex ministri Vito Lattanzio (Dc) e Rino Formica (Psi), accusati di corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Furono pesantemente coinvolti l’allora sindaco di Bari, Giovanni Memola (Psi), accusato di corruzione, l’ex sindaco Franco De Lucia (Psi), ma ancora un ex presidente della Regione, Michele Bellomo (Dc), ex assessori regionali come Franco Borgia (Psi) e Nicola Di Cagno (liberale), il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Franco Russo. E anche appartenenti alle forze dell’ordine, capiclan, magistrati. In vent’anni sono stati tutti assolti. Tutti, tranne uno: Cicci. Lui aveva patteggiato. Ma l’altro ieri (che giorno era? il 6 maggio, un altro martedì) la Cassazione - proprio in occasione del suo compleanno - ha stabilito di fatto che Francesco Cavallari, l’ex «re Mida» della sanità privata barese, non è mafioso. I giudici hanno disposto un nuovo procedimento per la rideterminazione della pena. Assistito dagli avvocati Franco Coppi e Mario Malcangi, Cavallari nel 1995 patteggiò una condanna a 22 mesi di reclusione per associazione mafiosa e corruzione e gli fu confiscata gran parte del patrimonio, circa 350 miliardi di lire. Chiariamo: la corruzione resta, ma la pena andrà rideterminata. Il patrimonio? Si vedrà. Un vero tesoro accumulato a partire dalla fine degli anni ’70, grazie alla legge che istituì il servizio sanitario nazionale e che prevedeva le convenzioni con i privati. Il rappresentante di medicinali Cavallari compie il grande passo: «Rileva le quote di una società che possedeva la clinica Santa Rita, in via Bottalico, a Bari», racconta Antonio Perruggini, che fu suo stretto collaboratore ed è l’autore del libro Il botto finale, sottotitolo: «Morì un giudice, un imprenditore finì in esilio. Storia dello scandalo giudiziario più clamoroso di Bari e delle sue inaspettate fortune» (Wip edizioni, 10 euro). Fu quella la porta che Cavallari attraversò per entrare negli anni Ottanta da protagonista. Era la Bari da bere, la Bari governata dall’asse socialisti-democristiani. Nelle elezioni del 1981 per la prima volta in città il Psi superò il Pci. Era la Bari del giro vorticoso di soldi e favori, di affari e carriere, di rapporti opachi con il malaffare e la malavita, di assistenza medica privata in cliniche che sembravano alberghi a 5 stelle e posti di lavoro da chiedere e da garantire. Una città dove tutto si teneva insieme. Ma era soprattutto una città che aspirava al ruolo di capitale e poggiava le sue ambizioni su quattro pilastri: la sanità privata, la cultura, la finanza, la tecnologia. Erano le Ccr (le Case di cura riunite), il Petruzzelli, la Cassa di risparmio di Puglia e Tecnopolis. Era quindi anche la città del Petruzzelli e di Ferdinando Pinto, un altro socialista. Un lustro per la città che toccò l’espressione più alta con la produzione dell’Aida in Egitto, tra le vere Piramidi. Altri tempi, si dirà: rubinetti della spesa pubblica sempre aperti e politica compiacente. Certo, ma anche altre ambizioni, altre visioni, altra borghesia. Com’è finita lo ricordano tutti. Teatro in fiamme e a Pinto ci sono voluti dieci anni per dimostrare di essere innocente. Erano anche gli anni delle cene a casa Cavallari: villa su corso Alcide De Gasperi, lato destro andando verso Carbonara, con due piscine (una era coperta e l’altra scoperta), interni progettati dallo studio barese dell’ingegnere Dino Sibilano. Una volta, lì cenò Liza Minnelli, ma c’è chi ricorda anche Umberto Veronesi e Renato Dulbecco. Nulla di strano, in fondo nel frattempo Cavallari era diventato il capo di un’azienda, le Case di Cura Riunite, «cui facevano capo - ricorda Perruggini - 11 strutture a Bari e provincia specializzate in cardiochirurgia, dialisi, cardiologia, chirurgia, geriatria: è stata fino alla metà degli anni ’90 la prima azienda sanitaria privata di Italia con un fatturato prossimo ai 300 miliardi di lire annui e oltre 4mila dipendenti. All’epoca le Case di Cura Riunite erano per dimensioni seconde solo all’Ilva di Taranto». Bari era diventata l’eldorado della medicina convenzionata. Antonio Gaglione cardiochirurgo, già deputato, senatore e sottosegretario, ricorda ancora quell’8 maggio del 1992, oggi sono esattamente 22 anni, era il giorno che i baresi dedicano a San Nicola: a Villa Bianca (clinica Ccr) eseguì per la prima volta in Puglia un’angioplastica su un malato di cuore. Non era un paziente qualunque: si trattava di quel Nicola Di Cagno, politico e docente universitario, che tre anni dopo sarebbe finito coinvolto nell’inchiesta. E se la sera, dopo il teatro, si andava a cena da «Cicci» e dalla moglie, la signora Grazia Biallo, la mattina si facevano affari anche grazie al ruolo che aveva assunto la Cassa di Risparmio di Puglia, presidente Franco Passaro, socialista, docente universitario. Sotto la presidenza Passaro (dal 1981 al 1994) la Cassa diventa banca leader della Puglia assieme al Banco di Napoli. Com’è finita? L’ex presidente ha raccontato nel 2010 la sua versione in un libro La Resa. Piccola storia di una banca e di un processo. Infine, la quarta gamba di questa sorta di «primavera tecnocratica» barese anni ’80. Tecnopolis, il primo parco scientifico e tecnologico d’Italia, nasce alle porte di Bari da un’intuizione del professore di fisica Aldo Romano (prima socialista, poi vicino ai democristiani), allievo di Michelangelo Merlin che era a capo di un dipartimento di fisica, quello barese, dove ci fu la prima laurea d’informatica del Sud, seconda in Italia. Tecnopolis viene inaugurato nel 1984, per l’occasione arriva anche il vice governatore della California e assiste al convegno di battesimo intitolato «Finanza, tecnologia e imprenditorialità». L’Università di Bari, la Banca d’Italia, la Cassa per il Mezzogiorno e il Formez erano insieme nell’incubatore che consentirà la nascita del parco. Il modello del parco scientifico e tecnologico fu esportato in tutta Italia. Anche su Tecnopolis fu aperta un’inchiesta giudiziaria. Romano lasciò la presidenza del parco e andò a insegnare a Roma. Dall’inchiesta, alla fine, non emerse nulla. Nel 1982, intanto, la Regione Puglia, presidente Antonio Quarta varò il «Piano regionale di Sviluppo centrato sull’innovazione». Era l’82 e alla Regione si parlava di innovazione. Oggi Tecnopolis di fatto è InnovaPuglia, società della Regione che progetta e gestisce programmi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione ed è anche una società per la promozione, gestione e sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico. Forse si farà davvero un film su un pezzo di questa storia. E se la scena iniziale sarà quella dell’alba sul lungomare di Bari, quella finale non potrà che essere il tramonto di Santo Domingo, dove adesso Francesco Cavallari, detto Cicci, gestisce una gelateria.
Francesco Cavallari, ex «re Mida» della sanità privata barese, non è mafioso. Lui lo aveva sempre sostenuto, ma le sue dichiarazioni dinanzi a pubblici ministeri e giudici erano rimaste inascoltate. E vent'anni dopo arriva la clamorosa decisione della Cassazione: è stata annullata la sentenza con la quale la corte di appello di Lecce aveva respinto l'istanza di revisione del processo al termine del quale nel gennaio 2013 era stato condannato per associazione mafiosa. I giudici della Suprema corte hanno disposto un nuovo procedimento per la rideterminazione della pena. Lo aveva sempre sostenuto e la Cassazione gli ha dato ragione: Francesco Cavallari non è mafioso. La Suprema Corte ha annullato la sentenza con la quale la corte d’Appello di Lecce nel gennaio 2013 aveva detto «no» all’istanza di revisione del processo avanzata dai suoi difensori, sulla base di un principio, in fondo, semplice semplice: un’associazione mafiosa con se stesso non può esistere. Cavallari è stato assistito dagli avvocati Franco Coppi e Mario Malcangi. Bari. Tutti assolti: con questo verdetto, 14 anni dopo gli arresti, si è concluso il processo d’appello per trentuno imputati coinvolti nell’operazione Speranza, in cui la procura di Bari ipotizzava un intreccio tra mafia, politica e affari. E così l’unico colpevole è rimasto Francesco Cavallari, noto come Cicci, per lungo tempo il re Mida della sanità privata pugliese e italiana: l’imprenditore, infatti, dopo essere stato arrestato, patteggiò una pena a ventidue mesi di reclusione per associazione mafiosa e corruzione subendo un sequestro patrimoniale di circa 350 miliardi di vecchie lire. A questo punto, però, visto che tutti i presunti componenti di quella organizzazione criminale sono stati scagionati nei vari processi relativi all’inchiesta che si sono susseguiti nel corso degli anni, Cavallari di fatto risulta associato con se stesso: proprio per questa ragione l’imprenditore, un tempo ex presidente delle Case di Cura Riunite e adesso gestore di una gelateria a Santo Domingo, ha chiesto la revisione del processo. L’inchiesta sul presunto intreccio tra politica, affari e criminalità organizzata nella gestione delle case di Cura Riunite di Bari, denominata speranza, fu diretta dall’allora pm Alberto Maritati, successivamente parlamentare del partito democratico e più volte sottosegretario, e coinvolse politici, magistrati e giornalisti. Tutti, naturalmente, non toccati dalla vicenda. Il vicenda giudiziaria che travolse Bari nel 1995 vide coinvolti oltre all’imprenditore esponenti politici di primo piano (tra i quali gli ex ministri Lattanzio e Formica poi assolti) amministratori regionali e infine esponenti della criminalità organizzata barese. Cavallari da anni vive a Santo Domingo dove gestisce una gelateria.
Lo aveva sempre sostenuto e la Cassazione gli ha dato ragione: Francesco Cavallari non è mafioso, scrive Giovanni Longo su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. La Suprema Corte ha annullato la sentenza con la quale la corte d’Appello di Lecce nel gennaio 2013 aveva detto «no» all’istanza di revisione del processo avanzata dai suoi difensori, sulla base di un principio, in fondo, semplice semplice: un’associazione mafiosa con se stesso non può esistere. Le carte, adesso, torneranno a una diversa sezione della Corte d’Appello salentina che dovrà rideterminare la pena che Cavallari aveva patteggiato: corruzione sì, falso in bilancio anche, ma mafia davvero «no». Così ha stabilito la Suprema Corte che ha accolto la richiesta della stessa Procura generale, oltre che quella dei difensori dell’ex «Re Mida» della sanità privata pugliese. «Sono contento che sia stata ristabilita la verità storica su quello che abbiamo sempre sostenuto da molto tempo», ha commentato l’avvocato Mario Malcangi, difensore di Cavallari, insieme con il principe del foro, il professor Franco Coppi. Si chiude così, dopo qua-si vent’anni, non solo la vicenda privata di Cavallari, ma anche quella della imponente operazione denominata «Speranza». Gli inquirenti teorizzarono la sussistenza, nel territorio barese, di u n’associazione a delinquere di stampo mafioso nata da un ben preciso accordo criminoso intervenuto tra Cavallari, maggior azionista e presidente del consiglio d’amministrazione della società «Case di Cura Riunite» s.r.l. e titolare effettivo della Geoservice s.r.l. - e i principali capi clan baresi. Nel mirino degli inquirenti «il controllo di attività economiche e servizi di pubblico interesse » anche «attraverso la manipolazione del consenso elettorale a beneficio di candidati compiacenti». L’operazione rappresentò un «cataclisma» per il sistema politico e imprenditoriale locale. Il primo vero scandalo nella gestione della sanità privata. Pesanti accuse che non hanno retto al vaglio della magistratura giudicante. Personaggi del calibro di Antonio, Sabino, Mario e Giuseppe Capriati, tra gli altri sono stati strada facendo assolti in via definitiva. Era il 1995 quando il gup del Tribunale di Bari aveva ratificato il patteggiamento a una pena (sospesa) di 22 mesi anche per l’accusa di associazione mafiosa per Cavallari. Un patteggiamento criticato dalla stessa sentenza con cui il Tribunale di Bari assolse alcuni suoi computati. Il re della sanità privata, che oggi vive a Santo Domingo dove gestisce una gelateria, non poteva essere considerato credibile quando ammise «di avere posto in essere molteplici e gravi condotte di corruzione di pubblici amministratori e di reati finanziari, e una serie di assunzioni di malavitosi» e non attendibile quando «pur riconoscendo di avere intrattenuto rapporti di connivenza con alcuni boss della malavita» negò «di avere stipulato un rapporto con i clan » . Nel corso del tempo tutti gli altri imputati erano stati assolti in via definitiva dalla stessa accusa. Di qui la richiesta di revoca della sentenza con proscioglimento «dal menzionato delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione della pena inflitta ». La Corte d’Appello di Lecce aveva detto «no». Di diverso avviso la Cassazione. Dalle sentenze di merito è persino emerso come «Cicci» «sia stato sottoposto ad atti di intimidazione da parte dei clan». A seguito del patteggiamento, i giudici confiscarono numerosi beni tra i quali ville, appartamenti e terreni. Tra questi, anche la villa di corso De Gasperi a Bari e l’appartamento in via Putignani, nel centro del capoluogo, ora in uso alle forze dell’ordine. Un sequestro disposto ai sensi del codice antimafia. Adesso il rischio è che potrebbero ritornare nelle mani di Cavallari. Con tante scuse.
«Anzitutto, devo precisare che sono stato difeso da prof. Franco Coppi, ma anche dall’avv. Mario Malcangi di Bari, che mi ha seguito in questa vicenda. Qual è la mia prima reazione? Sono molto, molto felice, perché è tornata serenità e pace in famiglia e, finalmente, penso che potrò ritornare con un bel rapporto con mia moglie, perché purtroppo all’epoca non resse a tutto quel tam tam che ci fu tra carabinieri, guardia di finanza, ecc. Tanto che arrivammo al divorzio. Adesso, penso che lei si sia definitivamente convinta che in casa non ha mai avuto un Totò Riina o un Bernardo Provenzano. Quindi sono molto felice. Anche se in questa grande gioia che provo in questo momento c’è grande dolore per come sono ridotte le mie strutture, che erano un gioiello all’epoca. Non lo dico io, lo dicevano tutti. E soprattutto per le migliaia di dipendenti che hanno perso il posto di lavoro. Io non sono d’accordo con chi dice, con chi ha sempre detto che mi hanno tolto i magistrati, Maritati, Scelsi, 20 anni di vita. Io ho guadagnato 20 anni di vita in questo periodo. Perché se fossi rimasto a Bari, con quelle ansie, preoccupazioni, anni di dolore che ho provato, sarei crepato. Ecco perché io non sono crepato a Bari, ma finalmente, posso dire oggi, che loro mi hanno regalato 20 anni di vita. Quindi, sembrerà un paradosso. Sono grato a quei provvedimenti, che all’epoca presero per la mia libertà personale, che mi consentì, dopo tanti anni, di fare degli accertamenti diagnostici. Da qui venne fuori che ero un cardiopatico. Sto aspettando la mia famiglia, che mi raggiungerà in questi giorni, proprio per chiarire alcune situazioni tra di noi, di famiglia, e, quindi, penso di ritornare al momento debito. Perché adesso voglio completare tutto l’iter giudiziario. Certamente ritornare a Bari. Vedere quello strazio. Quelle condizioni in cui versano le mie strutture. Io penso che eviterò di passare da via Fanelli. Eviterò di passare da via Salandra, da via Ciro Petroni. Ecco quindi cercherò di non frequentare quei posti, per non rivivere certi momenti che ho vissuto. Molto belli. Ho maturato in me una grande decisione, che mi fa piacere, in primis, riportare attraverso Telenorba. Io creerò una fondazione per assistere coloro i quali sono senza difesa, perché non hanno la possibilità di permettersi un avvocato, ed anche un assistenza a parenti di persone che sono incarcerate».
Cavallari fu arrestato nel ’94 e patteggiò la pena di 22 mesi per associazione mafiosa ed alcuni episodi di corruzione. Dalle sue dichiarazioni racconta, rimasero coinvolti una sessantina di politici e tra loro l’ex assessore regionale Alberto Tedesco, che però, non venne indagato. Cavallari affermò di aver dato 20 milioni di lire anche a Massimo D’Alema, ma i pm baresi chiesero ed ottennero l’archiviazione dell’accusa per finanziamento illecito ai partiti. Ha riferito anche che alla fine degli anni 80 un amico gli segnalò per un’assunzione Patrizia D’Addario, ma non se ne fece nulla.
Sanità, Politia ed Affari. E’ già successo a Bari nei primi anni 90, dice Antonio Procacci in un suo servizio su Telenorba. Fu un vero terremoto. Un’ottantina le persone indagate e una trentina gli arrestati. Alla fine ha pagato solo uno: Francesco Cavallari. Il re delle cliniche private. Fu arrestato nel maggio ’94 e scarcerato a novembre, quando cominciò a svuotare il sacco. Fece i nomi, e che nomi: da i ministri Lattanzio e Formica al sottosegretario Lenoci; dall’ex presidente della giunta regionale Michele Bellomo all’ex senatore Alberto Tedesco, a cui, secondo il racconto fatto all’allora pm Alberto Maritati, oggi compagno di partito dell’ex assessore, diede un contributo di 40 milioni di lire per la campagna elettorale di Lenoci, pochi mesi prima del sui arresto. E poi parlò di magistrati, funzionari pubblici, direttori generali di ASL e persino di giornalisti. Partito come informatore scientifico, Cavallari ha costruito un impero. Il più grande della sanità italiana ed europea. Con 10 cliniche private e 4000 dipendenti: pagando mazzette finanziano campagne elettorali ed assumendo centinaia di dipendenti sponsorizzati dai politici e dalla malavita locale. Tutto annotato in agende e sul computer in un file denominato, non a caso, mala.doc. “Sono l’unico imprenditore che non si è potuto sottrarre ai ricatti dei politici, malavita organizzata, magistrati e forze dell’ordine” ha sempre sostenuto e dichiarato Cicci Cavallari, che era solito favorire l’acquisto di materiale sanitario da fornitori che li venivano segnalati dai politici. Nulla di nuovo nella successiva inchiesta “Tarantini”. All’epoca non c’era la droga e neanche le escort, anche se una giovanissima Patrizia D’Addario fu presentata pure a Cavallari, ma con l’intento di fargli eseguire giochi di prestigio in alcune serate nelle sue cliniche. C’erano già, invece, i viaggi regalati, però, non ai medici, bensì ad alcuni giudici e funzionari regionali. La grande differenza di ieri, rispetto ad oggi, la fanno, però, soprattutto i soldi. Davvero tanti: 4,5 miliardi di vecchie lire, secondo le ultime stime che l'ex re delle CCR avrebbe pagato a tutti: dal PCI, come ammesso da Massimo D’Alema, fino all’MSI. Chi più, chi meno, un po’ tutti confermarono di aver intascato mazzette da Cavallari, anche se alla fine, gogna mediatica a parte, nessuno, o quasi, ha pagato. Anzi, è la Regione Puglia che deve pagare a Cavallari 63 milioni di euro per TAC, risonanze magnetiche e ricoveri in esubero non saldati ai tempi dello scandalo. Fu proprio Tedesco, all’epoca assessore alla Sanità, a stoppare i pagamento alle CCR, come ha ricordato recentemente il re Mida della Sanità. Per non parlare delle parcelle degli avvocati, che hanno difeso molti di quei politici e rigorosamente a carico dello Stato. Alcuni di essi si sono ritirati dalla scena, altri invece, sono ancora sugli scudi.
Guardia di finanza in azione: finiti in prigione anche l'ex assessore regionale Marroccoli e un consigliere comunale di Bari. TITOLO: Puglia, manette alla sanità privata. Tra le accuse più pesanti: truffa aggravata, falso e corruzione. Ricoveri mai effettuati, pagati dall'Usl 600 mila lire al giorno. Coinvolti anche i vertici di "Apulia Salus" e "Santa Maria". Ventisei arresti, il carcere attende Francesco Cavallari padrone di dieci cliniche, scriveva Piraino Giancarlo su “Il Corriere della Sera” il 4 maggio 1994. Per qualche ora s'è temuto che, avvertito in tempo, fosse riuscito a riparare all'estero. Poi, a metà pomeriggio, è giunta notizia che stava tornando da Milano per costituirsi ai giudici baresi. Francesco Cavallari, "re" della sanità privata in Puglia, era stato infatti raggiunto da due ordinanze di custodia cautelare. Al mattino era già finito in cella Paolo Biallo, suo cognato e braccio destro nella gestione delle Case di cura riunite (10 cliniche, 4 mila dipendenti, 250 miliardi di fatturato all'anno), il direttore sanitario Nicola Simonetti (piantonato in ospedale), e altri quattro tra medici e dirigenti del gruppo. Sempre in mattinata erano stati arrestati l'ex assessore alla Sanità della Regione Puglia, Tommaso Marroccoli, e un consigliere comunale di Bari, Giuseppe Pellecchia. Il blitz della Guardia di finanza aveva raggiunto anche i vertici dei due gruppi concorrenti delle Case riunite: i fratelli Franco e Giuseppe Cacurri, proprietari dell'Apulia Salus (tre cliniche, più altre tre partecipate) e Vincenzo Traina, della Santa Maria. Coinvolti anche tre funzionari della Regione, Maria Grazia De Luca, Nicola Armenise e Lorenzo D'Armento. In tutto 34 ordinanze di custodia cautelare, che hanno interessato 27 persone (qualcuno ne ha ricevuta più d'una). Truffa aggravata, falso, reati contro la pubblica amministrazione e corruzione, i reati contestati dai giudici Giovanni Colangelo ed Annamaria Tosto. I provvedimenti sono stati firmati dal gip Maria Iacovone. In ballo i ricoveri in regime di convenzione e soprattutto quelli d'urgenza. Negli uffici dei funzionari regionali sono stati sequestrati documenti riguardanti il periodo 1990-93. Alle sole Case di cura riunite sarebbero stati versati 85 miliardi per ricoveri mai effettuati. Un soggiorno di degenza, alla Mater Dei o altra clinica del gruppo, costava sino a 600 mila lire. L'indagine sarebbe partita da una denuncia riguardante le risonanze magnetiche e le Tac. Differenziate le accuse: quella di corruzione riguarderebbe solo i vertici delle Case di cura riunite, l'ex assessore Marroccoli e i funzionari regionali. Marroccoli, i funzionari regionali e i vertici delle Case di cura sono finiti in carcere; per tutti gli altri, arresti domiciliari. Per Bari è un autentico terremoto. I personaggi sono tutti notissimi. Cavallari era nel mirino della magistratura da tempo. Il sostituto procuratore Nicola Magrone (ora deputato progressista) aveva accusato lui e il cognato Paolo Biallo d'assunzioni fatte negli ambienti della malavita. L'indagine gli era poi stata tolta, alla vigilia, pare, del coinvolgimento di alcuni personaggi politici. Magrone era stato anche deferito al Csm e poi completamente prosciolto. Di fronte al plenum del Csm era invece finito nel gennaio scorso il procuratore generale di Bari, Michele De Marinis. A lui erano stati contestati anche l'atteggiamento tenuto in quella vicenda e la sua supposta amicizia con Cavallari, ma nei suoi confronti non era poi stato assunto alcun provvedimento. La sanità privata pugliese è sempre stata al centro di polemiche politiche. Le opposizioni, di destra e di sinistra, alla giunta regionale hanno sempre contestato l'entità dei finanziamenti. Cifre imponenti: nel solo bilancio 1993 94, 310 miliardi, più altri 100 per la sola assistenza nelle malattie da tumore. Dei 310 miliardi i due terzi sarebbero finiti ai tre gruppi ora sotto indagine; i 100 miliardi per l'oncologia quasi tutti alla sola "Mater Dei", clinica di Cavallari in regime di convenzione con la Regione sino al 31 dicembre di quest' anno. Dopo quella data il governo della Puglia dovrebbe decidere se rinnovare la convenzione o acquistare la clinica. Ma in questo caso Cavallari aveva già pronta la soluzione di ricambio: proprio in questi giorni stava per varare l'Istituto oncologico del Mediterraneo, con i soldi dell'Isveimer e della Cassa di risparmio di Puglia; benchè il suo gruppo abbia con la Cassa barese un'esposizione di 65, qualcuno dice 100 miliardi.
Il giudice morto che turba un pm e un senatore Pd, scrive Gian Marco Chiocci su “Il Giornale”, Lun, 26/09/2011 con Massimo Malpica. Le inchieste sulla sanità pugliese, le accuse tra magistrati, gli esposti al Csm, le denunce in Procura. I veleni tra le toghe baresi di questi giorni, che vedono l'ex pm Scelsi contrapposto al capo dell'ufficio giudiziario del capoluogo, Laudati, ricalcano una storia oscura di 15 anni fa. Nel 1994 la Procura di Bari indaga su un re della sanità pugliese, Francesco Cavallari, presidente delle Case di cura riunite. Al lavoro ci sono quattro pm. Alberto Maritati (l'attuale senatore Pd che a detta di Scelsi, nel 2009, gli chiese notizie sull'affaire Tarantini per conto del dalemiano De Santis) e Corrado Lembo della Direzione nazionale antimafia, Giuseppe Chieco e Pino Scelsi (lo stesso che oggi accusa Laudati) della Dda locale. Procuratore capo facente funzioni è Angelo Bassi.
Bassi non è una toga rossa. Non ha colori. A dicembre '94 difende Antonio Di Pietro: «Si sono disfatti di un magistrato scomodo facendo disperdere intorno a lui il senso della giustizia», detta alle agenzie. Quando però il mese prima Silvio Berlusconi era stato raggiunto da un avviso di garanzia alla conferenza Onu sulle mafie, Bassi aveva apertamente parlato di «scempio». Non sui giornali, ma in ufficio sì. Tanto era bastato, racconta oggi la moglie, Luigina, per inquadrarlo come «non allineato». Di certo, da quel momento la sua vita prende una piega drammatica. Bassi, come tanti a Bari, conosce Cavallari, che è sotto intercettazione. Viene registrato un colloquio tra l'aggiunto e l'indagato. I due si danno del tu, si chiamano per nome. E poi, un giorno, a dicembre del 1994, Bassi va a casa di Cavallari per interrogarlo. «Essere andato a interrogare Cavallari, che intendeva collaborare, a casa sua (...) bastò a far decretare la mia fine», racconta lui stesso, a luglio del 1997, a Carlo Vulpio del Corriere della Sera. I «colleghi» che indagano su Cavallari lo denunciano alla procura di Potenza (allora competente per i magistrati baresi, ora è Lecce, come Laudati sa bene) e al Csm. Bassi si ritrova indagato: abuso di potere e omissione di atti d'ufficio le ipotesi di reato. Il Csm a settembre del 1995 lo trasferisce a Napoli: incompatibilità ambientale. E l'otto novembre '96 viene rinviato a giudizio dalla procura di Potenza. Proprio due dei suoi «accusatori», Scelsi e Chieco, in udienza confermano che Bassi «li raggiunse nel loro ufficio per informarli dell'incontro con Cavallari», nel corso del quale Bassi aveva raccolto una confidenza, utile per un'indagine che vedeva Maritati parte lesa a Potenza, subito trasmessa dagli stessi pm alla procura lucana. Non sembra un comportamento da favoreggiatore. Infatti il 14 marzo '97 Bassi viene assolto perché il fatto non sussiste. La motivazione della sentenza è devastante per gli accusatori dell'ex procuratore, e stigmatizza in particolare Maritati. Che, pur in conflitto di interessi, come inquirente e come parte lesa di quelle dichiarazioni, secondo il giudice «non ha avvertito la necessità di astenersi dal prendere parte a qualsiasi iniziativa del suo ufficio in relazione ad un fatto che lo riguardava personalmente, ed abbia anzi redatto unitamente ai colleghi Chieco e Scelsi la relazione inviata in data 23-12-94 al procuratore della Repubblica di Potenza». Bassi, assolto in tribunale, il giorno dopo la sentenza viene condannato in ospedale, dove gli viene diagnosticata una malattia in fase terminale. Morirà un anno dopo, non prima di aver denunciato i suoi accusatori Maritati, Scelsi, Chieco e Lembo che si ritrovarono sotto indagine a Potenza in un fascicolo. Archiviato. Come archiviata finì la denuncia degli stessi pm da parte di Cavallari, che nella maxi-inchiesta barese che aveva coinvolto anche big della politica come Massimo D'Alema (percettore per sua stessa ammissione di un finanziamento da Cavallari, ma il reato era prescritto) era stato, alla fine, l'unico condannato, patteggiando 22 mesi. Decisivo per chiudere l'indagine potentina in cui Cavallari denunciava «gravi violazioni» dei pm, fu il nastro di un colloquio in procura a Bari di Maritati e Chieco con lo stesso Cavallari, in cui l'imprenditore rivelava ai suoi interlocutori una sorta di «complotto» della politica contro di loro. Deja-vu? Fatto sta che Cavallari, di fatto, li scagiona mentre, a Potenza, li accusa. Tutto normale? Insomma. Maritati, come rimarcava in un'interrogazione del '97 l'allora senatore di An Ettore Bucciero, era «al contempo indagato (...) e magistrato inquirente che raccoglie e registra le dichiarazioni confidenziali del suo accusatore». Un delirio. Ma non è la sola stranezza. Quel verbale viene chiuso con Maritati che fa presente come alle «11.50 del giorno 12 febbraio 1996, Cavallari è uscito dalla nostra stanza», a Bari. Eppure lo stesso Cavallari quel giorno, secondo gli atti del procedimento della procura lucana, venne convocato e interrogato dai pm Nicola Balice ed Erminio Rinaldi. Alle 12: dieci minuti dopo, a 140 chilometri di distanza. E i due magistrati, ascoltando il nastro barese dell'ubiquo imprenditore, invece di stupirsi della strana coincidenza di date, chiesero (e ottennero) l'archiviazione per il futuro senatore Maritati e per i suoi colleghi. Chi tocca certi fili muore, come Bassi.
“Cavallari? Il male lo ha subito”. "In punta di piedi mi permetto di rivolgermi alla Sua persona in qualità di amico di Francesco Cavallari, dopo aver appreso dagli organi di informazione della consegna, anche alla Sua presenza, della villa di Rosa Marina in favore di una nobile causa sociale. Annoveri anche il buon Cavallari nelle preghiere che anche altri vescovi gli hanno sempre riservato". "In punta di piedi mi permetto di rivolgermi alla Sua persona in qualità di amico di Francesco Cavallari, dopo aver appreso dagli organi di informazione della consegna, anche alla Sua presenza, della villa di Rosa Marina in favore di una nobile causa sociale. Annoveri anche il buon Cavallari nelle preghiere che anche altri vescovi gli hanno sempre riservato". Una lettera aperta, (pubblicata da Nicola Quaranta su “Brindisi Report”) una difesa a tutto campo dell'imprenditore barese Francesco Cavallari. Antonio Perruggini, ex responsabile delle Pubbliche relazioni del Gruppo Case di Cura Riunite di Bari, all'indomani dell'inaugurazione, presso l'ex villa del Re delle Ccr di Bari, del Centro per l'autonomia, ripercorre le tappe della vicenda giudiziaria di Cicci Cavallari: fondatore delle "Case di Cura Riunite" di Bari, coinvolto negli anni Novanta nella tangentopoli barese. E lo fa rivolgendosi in prima persona al Vescovo di Brindisi e Ostuni, monsignor Rocco Talucci, che nel corso della cerimonia di benedizione ha sottolineato il senso e il valore dell'evento che ha sancito la consegna ai volontari del Centro per la riabilitazione dei disabili del patrimonio immobiliare a suo tempo confiscato: "Come nella Resurrezione, siamo a celebrare il passaggio dal male al bene". Queste le parole del vescovo. Ma chi, al fianco di Cavallari, ha lavorato per anni, vivendo la stagione fortunata delle Case di cura Riunite (all'epoca azienda leader in Europa nella Sanità Privata, con 250 miliardi di fatturato, undici presidi e oltre 4000 dipendenti), non ci sta: "Il Procuratore della Repubblica di Bari Angelo Bassi, il magistrato integerrimo che si permise di trattare Francesco Cavallari con umanità pur non avendo mai avuto alcun rapporto con lo stesso imprenditore imputato per mafia, mentre era in preda a atroci sofferenze, mi disse poco prima di morire che il caso Cavallari sarebbe terminato con un botto finale. E così è stato, anche se quello più fragoroso deve ancora arrivare. Non so se Cavallari assisterà a quell'esplosione, ma di sicuro il suo nome, la sua storia e quella dei suoi carnefici, ci saranno. In prima fila, ognuno con le proprie responsabilità e meriti. Proprio come diceva l'indimenticabile magistrato". La ragione dello sfogo: "Ancora oggi - scrive Perrugini - le cronache regalano pezzi di ingiustizia, così eclatante da far rabbrividire. Mi chiedo come si può non sapere che quell'uomo è innocente e ha subito ingiustamente un martirio durato 17 anni. Invece ancora oggi in pompa magna autorevolissimi esponenti della politica, dello Stato e della Chiesa partecipano all'affidamento di un bene di Cavallari, sequestrato perché lo stesso era accusato (mai condannato !) di ipotesi mafiose risultate penosamente infondate. Anzi infondatissime. E così l'azione devastante verso quell'uomo e l'azienda che aveva realizzato, ovvero di quelle cliniche che furono un vanto per il territorio pugliese e un esempio di eccellenza clinica per il meridione di Italia, pare non terminare mai, nonostante ben tre gradi di giudizio che hanno urlato la stessa parola finale: innocente. Dopo 17 anni". E la difesa continua: "Era il 17 dicembre del 2009 quando per l'ennesima volta un collegio giudicante di appello aveva sconfessato sonoramente tutta l'opera costata miliardi, contro Cavallari. Ma non bastò. Chi volle il suo sacrificio, quello della sua famiglia e dei suoi dipendenti, non si dette per vinto e in un ultimo disperato tentativo, tentò la strada della Cassazione, che con decisione ha consacrato quanto per anni e in tutte le lingue aveva riferito e avevano motivato i suoi legali. Non bastarono le testimonianze, i riscontri inesistenti, le rogatorie internazionali in mezzo mondo finite con un nulla di fatto, e la leale collaborazione dell'imprenditore a far ragionare i suoi accusatori". "Doveva sparire. E così avvenne. Ora è esiliato a Santo Domingo. Oggi è gravissimo e in certi versi sconvolgente, che la "signora con la spada" pronta a troncare ogni ingiustizia, non ottenga il giusto rispetto. E così mentre si scrive la parola fine "all'assalto alla diligenza", ora deve essere il tempo della presa d'atto di un fallimento e del riconoscimento morale e materiale di quanto è avvenuto in danno di un innocente. Di mafia si intende. Perché Francesco Cavallari è stato accusato di altri reati, che non potevano procurare l'attacco verso tutto il suo essere e consentire di entrare anche nei "buchi delle sue serrature" e incenerire anche la polvere che calpestava. Quindi l'affondo, nelle parole di Peruggini: "L'affare ciclopico c.c.r". ha sorpassato da tempo i limiti della decenza politico-economico - istituzionale e nonostante le urla di giustizia consacrate in coerenti sentenze penali e civili, non ha fatto muovere nulla e nulla è stato fatto, come se in una sorta di limbo imbalsamato e maledetto da un diabolico sortilegio, "la bestia" doveva restare vittima, in attesa della tanto adorata "bella". Quello che è stato più volte e chiaramente scritto "in nome del popolo italiano", evidentemente ha infastidito i pochi reduci della "lotta verso Cavallari" e così mentre viene consacrato che quanto ha subito è stato davvero troppo, attraverso le ipotesi di mafia e truffa naufragate insieme alle loro congetture, l'unica vittima di questo affare colossale, resta Cicci Cavallari che ha creato lavoro e sviluppo economico, restando completamente estraneo alle insussistenti accuse del naufragio annunciato". Ed in fine le conclusioni: parole rivolte direttamente a monsignor Talucci. "Mi aspetto che almeno un Vescovo, con il suo noto senso di Carità avverta la opportunità di condividere una atroce sofferenza, agevolmente da conoscere con un minimo cenno, al fine di poter annoverare anche il buon Cavallari nelle preghiere che anche altri vescovi gli hanno sempre riservato. Penso che qualsiasi uomo che sente il dovere della giustizia terrena e divina, debba avere la gioia di conoscere una storia, a maggior ragione quando questa è costellata da grandi sofferenze trasformate spesso in altre versioni lontane dalle sentenze e dai fatti per il tramite di articoli e menzogne riportate in centinaia di "cronache", e in libri pubblicati e venduti sulla pelle di Cavallari e di una azienda passata di mano senza troppe esitazioni". "La storia vera, che in tutta solitudine Cavallari, ormai stremato, ha invocato per anni e che non è stata mai ascoltata ha sostenuto invece varie fortune politiche, una drammatica disoccupazione e l'affermazione di un nuovo modello di gestione della sanità che viviamo ogni giorno. Basta ancora oggi alzare il telefono e chiedere la disponibilità di una Risonanza Magnetica o di una Tac per rendersene conto". La chiosa, in calce alla lettera indirizzata al vescovo: "Ringrazio il Signore - scrive Perruggini - per avermi donato la gioia di essermi rivolto alla Sua pregevole persona e di aver vissuto nel mio cuore un glorioso momento di giustizia, pregandoLa di perdonare il mio sfogo e di rivolgere la Sua preghiera e il Suo perdono anche verso chi a Cavallari volle così male". La storia giudiziaria di Cavallari, in sintesi: negli anni Novanta l'imprenditore barese finì in manette nell'ambito di un'operazione che portò la magistratura a scoperchiare un presunto intreccio affaristico, politico, criminale. Una vicenda giudiziaria che scosse nel capoluogo i palazzi del potere. Cavallari a suo tempo patteggiò la pena, quella di associazione per delinquere di stampo mafioso, e uscì dal carcere. Riacquistata la libertà, perse però i suoi averi. Quel patteggiamento, infatti, segnò la fine del suo impero economico e portò alla confisca di gran parte dei beni di famiglia, compresa la lussuosa villa nel residence più esclusivo del litorale ostunese. Nei mesi scorsi la Cassazione ha chiuso anche l'ultimo capitolo di quella vicenda giudiziaria, dichiarando inammissibile il ricorso che era stato presentato dalla Procura generale avverso la sentenza con la quale nel 2009 i giudici d'appello mandarono assolti, perché il fatto non sussiste, anche le dodici persone ritenute vicine ai clan baresi a cui, sempre secondo la Pubblica accusa, Cavallari aveva concesso una serie di aiuti, a partire dalle assunzioni presso le sue cliniche. Nel corso del tempo furono assolti anche gli altri personaggi eccellenti coinvolti in quella inchiesta: ex assessori e funzionari regionali, ex ministri, giornalisti. Cavallari, l'unico all'epoca a scegliere la strada del patteggiamento, risulta così anche l'unico colpevole.
Maritati & C.: “liberammo Bari”. Adesso chi ci libererà da loro? Si chiede Nicola Picenna su “Toghe Lucane”. L'inchiesta “Speranza” (31 imputati) e l'inchiesta “Toghe Lucane” (34 indagati) hanno molto in comune, oltre al numero degli indagati che quasi quasi coincide. Entrambe ipotizzano una vasta rete di corruttela fra imprenditori, politici, magistrati e delinquenza comune e non. Entrambe sembrano destinate a finire in un nulla di fatto. Tutti assolti in appello (tranne Francesco Cavallari che aveva scelto il patteggiamento) quelli di “Speranza”. Tutti in attesa che si pronunci il Gip sulla richiesta di archiviazione tombale, per “Toghe Lucane”. Uno dei PM che aveva condotto le indagini nell'inchiesta “Speranza”, Alberto Maritati, difende il suo operato: “può anche succedere che l'accusa venga rovesciata con una sentenza di assoluzione, ma non per questo si deve pensare che il pm sia stato un cieco persecutore”. Anche il Procuratore Capo, Giuseppe Chieco, difende l'operato della Procura di cui ha la responsabilità, criticando quello del dr Luigi de Magistris dopo che gli indagati da quest'ultimo – nel “filone” Marinagri, troncone rilevante del “Toghe Lucane, sono stati assolti. Nel processo “Speranza”, “non si deve pensare che il pm sia un cieco persecutore. I provvedimenti cautelari da noi richiesti sono passati al vaglio di tre giudici: il gip, il Tribunale del Riesame e la Cassazione”, così parla Alberto Maritati. Nel procedimento “Toghe Lucane-Marinagri” il provvedimento (cautelare) del sequestro del cantiere è stato confermato dal Gip, dal Riesame, dalla Cassazione e, per altre due volte, nuovamente dal Gip. Ma De Magistris viene dipinto come un “cattivo magistrato”. Nel procedimento penale “Toghe Lucane” il pensiero infamante è obbligatorio. “Di regola il pm che svolge le indagini è lo stesso che sostiene l'accusa anche nel dibattimento e, a certe condizioni, anche in appello. I pm non hanno seguito il procedimento fino alla conclusione... e il processo è stato spezzettato in tanti tronconi: questo secondo me ne ha decretato la fine”. Così parla Maritati del processo “Speranza” e non si sbaglia. Per “Toghe Lucane” è lo stesso. Il primo pm (Luigi de Magistris) viene sottratto all'inchiesta; gli subentra Vincenzo Capomolla che spezzetta “Toghe Lucane” in tanti tronconi. Nel momento topico del processo anche Capomolla evapora. Arriva Cianfrini che in pochi minuti valuta quintali di atti giudiziari e chiede l'assoluzione. Gabriella Reillo, Gup dalle indiscusse capacità valutative, assolve. “Quell'inchiesta ha liberato Bari da una cappa... Cavallari controllava la città. Così come ha detto egli stesso a noi e come ha detto a voi (Corriere del Mezzogiorno, ndr) nell'intervista conferma di aver distribuito 4 miliardi di lire ai politici e non solo”; sempre Maritati che parla apertis verbis. Anche per “Toghe Lucane” emergeva la “cappa” o, come scrisse De Magistris, “l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, alla truffa aggravata ai danni dello Stato ed al disastro doloso”. Che Bari si sia liberata da quella cappa, alla luce delle recenti inchieste sulla sanità pugliese, appare affatto certo. Come accade in Basilicata, dove gli indagati da De Magistris (in buona parte) occupano ancora i posti di comando e controllo. Se non che, a guardare tutto, si scopre che Giuseppe Chieco, oggi fra gli indagati in “Toghe Lucane” è stato fra i PM dell'inchiesta “Speranza” insieme con Maritati. Che Chieco e Maritati furono indagati per abuso d'ufficio in una inchiesta tenuta dalla Procura di Potenza da cui vennero prosciolti grazie alle improvvide dichiarazioni rese loro (che strano) proprio da Francesco Cavallari. Era il 12 febbraio 1996, in Procura a Bari, presenti Chieco, Maritati e Cavallari. Ma Cavallari nega e si scopre che in quello stesso giorno, a quella stessa ora, Cavallari Francesco veniva interrogato a Potenza. Carte false, Chieco e Maritati vennero salvati da carte false autoprodotte. “Liberammo Bari” dice Maritati, ma chi ci libererà da loro? p.s. Qualcuno chieda ad Alberto Maritati, perché la quota parte dei 4 miliardi finita nelle tasche di Massimo D'Alema finì con la prescrizione e come mai egli decise di candidarsi proprio nel partito di Max e come fu che, eletto alle suppletive, D'Alema lo volle immediatamente sottosegretario nel I e II governo di cui era Presidente del Consiglio. Qualcuno chieda a Maritati perché non indagò Alberto Tedesco, indicato fra i percettori di una quota consistente dei “soliti” 4 miliardi; come oggi risulta indagato per analoghe operazioni poste in essere da assessore della giunta “Vendola”. Qualcuno chieda a Maritati come fa a sostenere lo sguardo dei parenti di quel magistrato coperto da accuse infamanti ma poi assolto per non aver commesso il fatto. Qualcuno gli chieda perché, ancora oggi, non sente vergogna ogni qualvolta ne richiama la memoria, tradendolo anche da morto, come di un magistrato colpevole di inqualificabili (ma inesistenti) reati.
E POI PARLIAMO DELL'ILVA.
Il tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'Ilva di Taranto, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Come giudice delegato per la procedura stessa è stata nominata Caterina Macchi. Si apre quindi il capitolo finale per la tormentata azienda siderurgica, ormai destinata al fallimento. L'azienda "presenta un indebitamento complessivo pari a 2.913.282.000 euro", scrivono i giudici nella sentenza. Secondo i giudici l'Ilva "si trova in stato di insolvenza come adeguatamente illustrato nel ricorso" del commissario straordinario presentato lo scorso 21 gennaio e "comprovato dalle allegazioni documentali, risultando - si legge nel provvedimento - che la società presenta capitale circolante negativo per circa 866 milioni di euro, una posizione finanziaria netta negativa per 1583 milioni di euro, una progressiva riduzione del patrimonio netto contabile e una redditività negativa della gestione" sempre in riferimento al 30 novembre 2014. Mancano materie prime, stop alcuni impianti - Intanto a rendere ancora più complicata una situazione non facile, è arrivato l'annuncio dell'Ilva ai sindacati metalmeccanici di fermare alcuni impianti a causa del mancato rifornimento delle materie prime provocato anche dalla protesta degli autotrasportatori. "L'azienda - dice Vincenzo Castronuovo della Fim Cisl di Taranto - ha precisato che la situazione potrebbe cambiare in caso di ripartenza degli approvvigionamenti".
“Il futuro dell’Ilva è legato a filo doppio a quello di Taranto e a quello di un intero comparto, strategico per gli interessi nazionali. Per questo qualsiasi intervento inerente lo stabilimento va ben oltre l’ambito locale, e merita di essere affrontato in maniera approfondita e valutato in tutti i suoi possibili aspetti e in tutte le sue profonde ripercussioni, al netto da contrapposizioni demagogiche e pregiudiziali, cercando di alimentare e stimolare confronto e dialogo e non uno scontro sempre più esasperato” ha affermato Nuovo Centrodestra in Consiglio regionale, Domi Lanzilotta. “E la preoccupazione per il contesto ambientale e per la tutela dei posti di lavoro va ovviamente estesa anche al considerevole indotto: apportando quindi i dovuti correttivi al decreto che ha restituito allo Stato una necessaria centralità per evitare la svendita dell’impianto, ma al tempo stesso non chiedendo e auspicando ripensamenti e retromarce in palese contraddizione con le precedenti, dure e motivate critiche e preoccupazioni per la gestione -piena di ombre- dei privati. Il momento così critico deve indurre allora a stemperare la tensione e a una piena assunzione di responsabilità da parte delle parti chiamate in causa. Per la ricerca di un difficile equilibrio, alla luce delle numerose difficoltà e criticità emerse, ma che va trovato nelle sedi istituzionali, per non lasciare sprofondare Taranto in un nuovo incubo, dopo anni di buio e colpevole silenzio”.
Lospinuso: “Non può essere lo Stato a far fallire le imprese, si paghino subito i debiti indotto Ilva”. “Confindustria Taranto lancia un grido di allarme: il decreto per Taranto, anziché salvarla, rischia di affossare la città con una crisi occupazionale senza precedenti. Eppure, Forza Italia ha presentato emendamenti risolutori, proposti anche dal Senatore Amoruso, che rappresentano la strada maestra per garantire i crediti vantati dalle aziende dell’indotto, evitandone il fallimento”. Lo sostiene in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Pietro Lospinuso. “Oltre ai 3000 dipendenti delle aziende dell’indotto che rischiano il posto di lavoro – aggiunge – anche l’Ilva potrebbe mettere in cassa integrazione 5000 dipendenti. Ciò vuol dire che l’intera città di Taranto rischia il fallimento. Pensare che le aziende abbiano fornito materiali e prestazioni per l’Ilva in questi mesi, contando sull’affidabilità dello Stato che l’amministrava tramite i suoi commissari; e che oggi queste realtà economiche siano sul filo del rasoio, è veramente il colmo. Non può essere lo Stato a far fallire le imprese ed anzi, deve pagare i debiti pregressi del siderurgico: il senatore Amoruso propone una soluzione che ritengo condivisibile e concreta per la salvaguardia del sistema-impresa di Taranto. Come proposto negli emendamenti presentati, il governo potrebbe garantire i debiti al 100% presso le banche con la Cassa Depositi e Prestiti, e così gli istituti di credito presterebbero le somme necessarie. Agli imprenditori non resterebbe che pagare gli interessi alle banche per i prestiti ricevuti e per lo Stato sarebbe una manovra quasi a costo zero. In alternativa, potrebbe essere la stessa Cassa depositi a finanziare le imprese dell’indotto in forza dei crediti da riscuotere dall’Ilva. Il governo, inoltre, potrebbe prevedere, nel decreto in questione, la sospensione dei debiti delle imprese interessate verso Equitalia, come prima misura di sostegno per le realtà economiche che non vengono pagate ormai da mesi. Come pure si potrebbe immaginare un sistema di compensazione fiscale per le imprese interessate”. “Siamo aperti ad ogni altra alternativa – conclude Lospinuso – purché non sia una chiacchiera per perdere altro tempo. Taranto è una questione nazionale e adesso non c’è più tempo per scherzare”.
Come si fa a salvare l’Ilva senza la collaborazione della procura di Taranto? Si chiede Luigi Amicone su “Tempi”. Siamo stati facili profeti quando abbiamo ricostruito le pazzesche vicende di questo tipico caso di “catastrofe italiana” indotta per via giudiziaria. Eppure una via di uscita che non sia il fallimento o la statalizzazione si può ancora trovare due numeri a fotografare lo spartiacque tra cos’era prima della “cura” a cui è stata sottoposta dalla procura di Taranto e cos’è oggi, dopo tre anni di inchieste, arresti, sequestri, blitz della polizia giudiziaria, la più grande acciaieria d’Europa: da una media di utili annua che sfiorava i 100 milioni, Ilva è passata a perdite secche di 1 miliardo l’anno. Siamo stati facili profeti quando ricostruimmo le pazzesche vicende di questo tipico caso di “catastrofe italiana” indotta per via giudiziaria. Adesso, dopo che l’azienda è stata commissariata (e naturalmente indagato anche il commissario governativo Enrico Bondi, sostituito nel giugno scorso con Piero Gnudi dal governo Renzi) la fotografia è la seguente: permanendo il sequestro giudiziario su due terzi dello stabilimento, le banche hanno staccato un assegno di 125 milioni come seconda rata di un prestito che servirà a pagare stipendi di dicembre e tredicesime agli 11 mila dipendenti. Dopo di che, buio completo. Non si sa come verranno pagati gli stipendi a partire dal prossimo gennaio. E soprattutto non si sa chi salderà i circa 400 milioni di debiti scaduti con i fornitori. Non bastasse, quale investitore straniero può essere così matto da prendersi sul gobbo un’azienda condannata a intervenire con bonifiche ambientali per 1,8 miliardi di euro (pena il mancato dissequestro degli impianti) e sul cui capo pendono richieste di risarcimento danni per 35 miliardi? Essendo un caso tragico di zelo giudiziario, il genio della giustizia italiana si è inventato di tutto. Perfino il prelievo forzoso (e l’uso per ricapitalizzare l’acciaieria commissariata dallo Stato) degli 1,2 miliardi sequestrati ai Riva (tutt’ora, almeno per il diritto nazionale e internazionale, proprietari al 90 per cento delle acciaierie) nell’ambito di un’inchiesta milanese che li accusa di truffa ai danni dello Stato. Le banche e gli otto trust a cui i Riva hanno affidato il loro “tesoretto” (oltre che un ricorso pendente in Cassazione), hanno fatto sapere che, mancando una sentenza definitiva sulla partita giudiziaria (che nulla ha a che vedere con il caso Ilva) non se ne parla nemmeno di utilizzare quei soldi. Di qui l’impasse che lascia presagire il peggio. Ad oggi sono solo chiacchiere le notizie che circolano di aziende italiane ed estere che sarebbero disposte a entrare nell’“affare” Ilva. Corre ad esempio la leggenda secondo cui il più grande gruppo europeo dell’acciaio (gli anglo-indiani di Arcelor-Mittal, alleati con Marcegaglia) avrebbe presentato un’offerta. E si racconta che anche il lombardo Arvedi sarebbe disposto a entrare nella cordata. In realtà, vere e proprie offerte per l’Ilva non ce ne sono. Per questo si è dato inizialmente spago alla voce di un intervento dello Stato che consentisse di sfruttare anche per le acciaierie tarantine la legge Marzano. Uno schema che in pratica prevederebbe il fallimento pilotato dell’Ilva e la sua cessione. Ma è difficile immaginare un percorso per cui, prima si fa fallire un’azienda per via giudiziaria. Poi la si sottrae con un commissario governativo (esproprio) ai suoi legittimi proprietari. Infine il governo la rivende al migliore offerente. Ora, sebbene alla Fiom non dispiaccia questa via (tant’è che a Repubblica Landini dice «no, assolutamente no» a un piano di salvataggio dell’Ilva che coinvolga anche gli attuali proprietari), Renzi ha capito in fretta che non può essere questa la strada di un paese che sta in Europa e che vorrebbe ricominciare ad attrarre gli investitori stranieri piuttosto che gli avvoltoi. Dunque? «Dunque stiamo a vedere», dicono a Federacciai. «Renzi è intelligente. Capisce bene che l’Ilva non può fallire e non può mettere per strada 11 mila operai, più un centinaio di imprese che lavorano nell’indotto. Se lo Stato fa la sua parte e i Riva, come hanno fatto sapere, faranno la loro, una via d’uscita si trova». E magari una via d’uscita modello Alitalia. Con un bad company che si accolla le passività e la giungla di pendenze giudiziarie. E una new company che riparte grazie a un mix di ricapitalizzazione privata (banche, Riva, Arvedi, Arcelor-Mittal-Marcegaglia) e intervento statale (Cassa depositi e prestiti, attraverso il Fondo strategico). Certo, la condizione perché si possa ipotizzare una via d’uscita al disastro, è che la procura di Taranto molli la presa sui sequestri e consenta all’azienda di tornare sul mercato producendo e vendendo acciaio e non avvisi di garanzia. A questo proposito, conversando in pubblico con il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, si era da parte nostra avanzata la modesta proposta di dare al Pil italiano la possibilità di schizzare all’in su di un paio di punti grazie alla messa in mora (ad esempio con un anno sabbatico) di quei pubblici ministeri che, come ci ha detto l’ex capo procuratore di Napoli Lepore, fanno danni perché «si credono dei padreterni» . Quando funzionava a pieno regime l’Ilva valeva il 75 per cento del Pil tarantino e l’1 di quello italiano. Se invece di continuare a tenere sotto sequestro due terzi dello stabilimento la procura di Taranto si mostrasse meno intransigente, forse una via d’uscita per l’Ilva si troverebbe.
Il romanzone del caso Ilva, una catastrofe italiana. Ecco come abbiamo distrutto la più grande acciaieria d’Europa, scrive Luigi Amicone su "Tempi". Stanziamenti, tre leggi ad hoc, l’ingaggio di due governi, della Suprema Corte e della Corte Costituzionale. Niente da fare. L’Ilva chiude e riapre l’Iri. I magistrati sono scatenati, Enrico Letta è imbelle. Nei prossimi giorni il parlamento varerà una serie di provvedimenti per rilanciare la commissariata Ilva. La più grande acciaieria d’Europa. Almeno fino a due anni fa. Dopo di che, nel biennio di massimo protagonismo della Procura di Taranto, tra il 26 luglio 2012 (data del primo sequestro degli impianti) e il 20 dicembre 2013 (pronuncia della Cassazione contro il sequestro del patrimonio della famiglia Riva, maggiore azionista dell’azienda), l’Ilva ha perso un terzo della sua produzione di acciaio, ha dimezzato i ricavi e nel 2014 attuerà un massiccio piano di messa a “contratti di solidarietà” di 3.579 lavoratori. 26 luglio 2012. 20 dicembre 2013. Segnatevi queste due date. Corrispondono all’arco temporale durante il quale due magistrati, il procuratore capo Franco Sebastio e il giudice per le indagini preliminari Patrizia Todisco, impegnati a perseguire per “disastro ambientale” la proprietà e gli amministratori dell’Ilva, hanno di fatto determinato la politica ambientale e industriale di un pezzo importante del sistema Italia (prerogative che, per legge, spetterebbero al governo e alle amministrazioni pubbliche). Non solo. Questa coppia di magistrati è stata sufficiente a polverizzare ogni record in materia di conflitto tra funzione giudiziaria e gli altri poteri dello Stato. Anticipato in rapide sequenze da trailer, il film è il seguente. Dopo aver ordinato le due prime e pesantissime raffiche di arresti e di sequestri all’Ilva (26 luglio e 26 novembre 2012), prima la procura e il gip di Taranto si oppongono con ricorso alla Corte costituzionale a una legge dello Stato del 3 dicembre 2012. Poi, alla sentenza (9 aprile 2013) che dichiara “costituzionale” una legge dello Stato (la cosiddetta “salva Ilva”), la Procura attende un mese prima di predisporre il dissequestro, previsto per sentenza, di prodotti Ilva che la stessa Procura aveva impedito di commercializzare a partire dal 26 novembre 2012. Prodotti che in data 15 maggio 2013, giorno in cui il gip di Taranto firma il dissequestro, hanno perduto (per deperimento e caduta dei prezzi sul mercato dell’acciaio) oltre un terzo del loro valore di 1 miliardo di euro. Ancora. Il 25 maggio 2013, cioè dopo essere stati contraddetti dalla Corte costituzionale (sentenza del 9 aprile e deposito delle motivazioni del 10 maggio 2013), i magistrati di Taranto sequestrano altri 8,1 miliardi di patrimonio dei proprietari dell’Ilva e mantengono ferrignamente tale sequestro (col rischio di far collassare l’intera filiera aziendale dei Riva) fintanto che, sette mesi dopo, la Corte di Cassazione cancella senza rinvio tale provvedimento, dichiarandolo «abnorme» e «fuori dall’ordinamento». Infine, dopo l’incredibile braccio di ferro tra Procura e leggi dello Stato, dopo che i più gravi e importanti provvedimenti assunti dai magistrati nei confronti dell’Ilva sono stati demoliti da ben due sentenze delle massime Corti, invece che chiedere conto di quanto siano costati allo Stato (e a Taranto) l’intransigenza e gli errori della Procura, Enrico Letta riesce nell’impresa di rinunciare a esercitare le prerogative di un primo ministro e di un governo. Così, con l’alibi che nel giugno 2013 la proprietà Ilva (con tutto quello che aveva addosso) non era ancora riuscita a mettersi completamente a norma rispetto alle severe regole ambientali approvate nel decreto “salva Ilva”, il governo vara un ennesimo decreto legge che, a partire dall’agosto 2013, sancisce il “commissariamento straordinario” dell’Ilva. Azienda privata che viene in questo modo trasformata in azienda parastatale per almeno i prossimi 36 mesi. E ora, secondo le richieste del commissario Enrico Bondi, l’Ilva dovrebbe essere ricapitalizzata con i soldi (1,2 miliardi di euro) che i Riva si sono visti porre sotto “sequestro cautelativo” dalla Procura di Milano. Non per violazioni all’Ilva, ma su tutt’altra partita di una (ad oggi presunta) «maxi-evasione fiscale». E ora godiamoci il film (si fa per dire), distesamente. Il 27 novembre 2012, Stefano Saglia, vicepresidente della commissione Camera per le Attività produttive è ancora ottimista. Il giorno prima era scattata una seconda retata, dopo quella del 26 luglio con cui il gip di Taranto, Patrizia Todisco, aveva sequestrato sei impianti dell’area a caldo dell’Ilva, emesso otto mandati di arresto cautelare per manager dell’acciaieria (compreso l’allora 87enne Emilio Riva, ex patron dell’Ilva) e nominato quattro custodi giudiziari. Dunque, il 26 novembre 2012 una seconda ondata di arresti aveva portato in carcere altre sei persone e posto sotto sequestro 1,8 milioni di tonnellate di prodotti Ilva del valore commerciale di 1 miliardo di euro. Nonostante queste notizie, per Saglia l’acciaieria di Taranto resta «una grande realtà siderurgica di cui il paese non può privarsi. L’Ilva vale lo 0,5 per cento di Pil nazionale». E poi naturalmente ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro. Per la precisione: 11.611 impiegati nelle acciaierie di Taranto più gli addetti in società strettamente collegate all’Ilva. In totale, senza contare l’indotto del Nord, nel novembre 2012 Ilva occupa ancora 15.358 persone e il suo fatturato consolidato (oltre 6 miliardi di euro nel 2011) è in netta ripresa rispetto al biennio 2009-2010. Ed ecco una fotografia dell’azienda esattamente un anno dopo, dicembre 2013, quando il commissario straordinario Bondi scrive nella sua relazione che le vendite sono in picchiata, costi e perdite in paurosa ascesa. Colpisce il brusco calo di produzione. L’Ilva perde due milioni di tonnellate d’acciaio, un terzo della produzione, in un solo anno. Nel 2013 produce 6 milioni e 300 mila tonnellate, contro gli 8 milioni e 300 mila del 2012. Rispetto al 2011, quando a bilancio risultavano ricavi superiori a 6 miliardi di euro, in aumento del 30,4 per cento rispetto al 2010, la relazione di Bondi prevede per il 2013 ricavi quasi dimezzati, 3,65 miliardi, oltre il 40 per cento in meno rispetto al 2011, anno che precede gli interventi della Procura. Insomma, benché goda della speciale rete di protezione messa a disposizione dai governi Monti e Letta (che nell’ultimo biennio hanno approvato ben tre decreti legge ad hoc e cospicue risorse economiche per interventi emergenziali, a cominciare dai 336 milioni di euro resi disponibili fin dall’agosto 2012) l’Ilva è inchiodata. Si deve procedere alla sua ricapitalizzazione. «All’Ilva servono 3 miliardi», dichiara Bondi al vertice ministeriale del 9 gennaio scorso. E la legge sull’emergenza ambientale, la cosiddetta “Terra dei fuochi-Ilva” in corso di definitiva approvazione in Senato, dovrebbe servire a procurarli. Come? In parte utilizzando il miliardo e rotti di euro sequestrati ai Riva dal procuratore di Milano (e attualmente anche consulente di Palazzo Chigi) Francesco Greco. In parte provando a convincere banche e investitori a entrare nella partita Ilva. E veniamo al “disastro ambientale” di cui sono accusati imprenditori, manager, funzionari pubblici, che hanno gestito l’Ilva negli ultimi 15 anni. Prima, però, facciamo un bel passo indietro. Il 13 aprile 1972, in un elzeviro di pagina 3 sul Corriere della Sera, Antonio Cederna, fondatore di Italia Nostra, descrive così la Taranto dell’Ilva-Italsider a gestione statale: «Una città disastrata, una Manhattan del sottosviluppo e dell’abuso edilizio. Mille camion al giorno scaricano a mare il materiale sbancato a monte e i velenosi residui degli altiforni: un’enorme distesa di mare è già colmata e i lavori procedono senza tregua». Cederna annota sgomento: «Un’impresa industriale a partecipazione statale, con un investimento di quasi duemila miliardi, non ha ancora pensato alle elementari opere di difesa contro l’inquinamento e non ha nemmeno piantato un albero a difesa dei poveri abitanti dei quartieri popolari sottovento». Il riferimento è al quartiere Tamburi, quello che nel 2013 è stato segnalato per l’alta incidenza di tumori. A distanza di oltre quarant’anni, 3 febbraio 2014, è Adriano Sofri a raccontare la visita e il ritorno da Taranto con animo «desolato». La magnifica penna di Repubblica non si lascia tentare dagli sforzi compiuti da ben due governi, dalle istituzioni locali e dalla stessa Corte costituzionale che il 9 aprile 2013 aveva richiamato la necessità di contemperare le esigenze del lavoro, della salute e del rispetto dell’ambiente, spettando al governo e alla pubblica amministrazione, non alla magistratura, dettare indirizzi e scelte in questi ambiti. Si ha l’impressione che per giustizia Sofri intenda questo: «Poi, nella notte fra l’11 e il 12 gennaio i custodi giudiziari hanno compiuto un’ispezione a sorpresa senza preavviso nell’Ilva e hanno trovato gli impianti (quelli che dovrebbero funzionare a ritmo ridotto) “tirati al massimo”. Anomale accensioni delle torce dell’acciaieria…» e via di altre illegalità. Bene. Dai primi anni Settanta, quando Cederna descriveva lo sversamento e inquinamento a cielo aperto dell’Ilva statale, pare che non sia successo niente. Poi, dai primi mesi del 2012, per la procura, i suoi periti e, a seguire, ambientalisti e dipietristi 2.0, l’Ilva diventa “il mostro di Taranto”. E i Riva – che pure hanno documentato investimenti a Taranto per 3 miliardi in tecnologia e 1,5 miliardi per l’ambiente – gli emblemi di un capitalismo selvaggio, feroce sfruttatore dei lavoratori, dell’ambiente e della salute. In effetti, sussurrano i collaboratori degli (ex) patron dell’Ilva, i Riva hanno commesso due gravi errori. Primo: sono scesi a Taranto col piglio bauscia del “sciur parun” del Nord. Secondo: il 17 febbraio 2012 non si sono presentati all’incidente probatorio dove avrebbero potuto giocarsi una sentenza del Tar di Lecce che aveva dato loro ragione in tema di emissioni di diossina. Detto ciò, sembra veramente arduo che l’accusa riesca a dimostrare in sede processuale che «in 13 anni» (13 anni? E i precedenti 50?) l’Ilva dei Riva è stata l’unica ed esclusiva responsabile di “disastro ambientale”. Tanto più che, oltre alla siderurgia, il sito industriale di Taranto comprende una grande raffineria, una grande centrale elettrica, un grande cementificio, un grande arsenale militare pieno di amianto. Non solo. A complicare le cose a quelli che vedono nei Riva il diavolo e nell’Ilva l’inferno, c’è un particolare rivelato da Corrado Clini, ex ministro dell’Ambiente del governo Monti che conosce ogni piega del caso e se ne è occupato personalmente fino al passaggio di testimone al suo omologo ministro Orlando del governo Letta. Dice Clini: «Il 4 agosto 2011 è stata data l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per Ilva di Taranto, dopo un’istruttoria di 5 anni, con 462 prescrizioni. 5 anni è un tempo superiore 10 volte a quanto prevede la legge. E le 462 prescrizioni erano in gran parte in contraddizione tra loro e non applicabili, perché espressione di un compromesso “politico” tra la resistenza dell’impresa ad assumere impegni in linea con le migliori tecnologie disponibili e le istanze della Regione e degli enti locali in gran parte non sostenibili sul piano della fattibilità tecnica e giuridica. Ilva ricorre al Tar contro gran parte delle prescrizioni, ritenute in contrasto tra di loro e nei confronti delle norme vigenti. Il Tar riconosce la fondatezza del ricorso di Ilva e disapplica una parte rilevante delle prescrizioni. Nello stesso tempo, con valutazioni opposte a quelle del Tar, la procura della Repubblica di Taranto rileva che l’Aia non è adeguata per risolvere le molte problematiche ambientali e per la salute causate dallo stabilimento Ilva». Giusi Fasano, giornalista del Corriere della Sera, è a Taranto nei giorni dei sequestri e arresti che mettono a rischio quasi 12 mila posti di lavoro. Il 17 agosto 2012 l’inviato del Corriere segue il vertice che si svolge in città tra le istituzioni e le parti coinvolte nella crisi delle acciaierie. Il governo Monti è presente con due carichi da novanta, il ministro dell’Ambiente Corrado Clini e il ministro per lo Sviluppo economico e le infrastrutture Corrado Passera. Manca qualcuno? Sì. Manca il procuratore capo Franco Sebastio che pure è l’artefice, diciamo così, di tutto il can can. Giusi Fasano ha il suo cellulare, chiama, lasciamoli chiacchierare. «Sebastio risponde da Soverato, Calabria, “dove vengo in vacanza da 35 anni”, dice. Ma come? È a tre ore di distanza, arrivano i ministri a Taranto perché una sua inchiesta ha fatto dell’Ilva un caso nazionale e lei non torna nemmeno per una stretta di mano? “L’ho detto anche a loro in una telefonata, cordialissima: vedrete che non mancherà l’occasione”. Più che una promessa sembra una minaccia. “Non mancherà occasione nel senso che c’è sempre tempo per farlo. Presentarmi nell’incontro di venerdì non mi è sembrato opportuno. Lì c’era spazio per politici, amministratori, sindacalisti… che c’entrava un magistrato?”». Ecco, bisogna aggiungere altro? Sì, bisogna aggiungere che alla fine del 2012 il procuratore Sebastio metterà in un libro-intervista le sue riflessioni. «Quando arriva a Taranto con la toga sulle spalle? “Vengo trasferito nella mia città sempre da pretore nel ’76”. Che situazione trova? “Una situazione non certo facile. L’emergenza ambientale c’era tutta, ma non era agevole rendersene conto e, soprattutto, documentarla”. Ostacoli? “Diciamo che non mancavano ostacoli oggettivi”. In che senso? “Beh, in generale l’inquinamento ambientale non sempre provoca danni immediati. In alcuni casi, come per l’amianto, occorre aspettare anche decenni per rilevare le conseguenze sulla salute delle persone. E poi non c’era una sensibilità diffusa sulla qualità del lavoro e la tutela dell’ambiente. Naturalmente, anche la Giustizia soffriva della stessa miopia”». (Il mio Salento, la mia Puglia, dicembre 2012, edizione Affari Italiani). Dunque, alla fine del 2012 apprendiamo dal pm accusatore degli ultimi quindici anni di Ilva che dei 40 anni precedenti in cui lo stesso pm era a Taranto c’è ben poco da ricordare. Eppure, già all’inizio degli anni Settanta Antonio Cederna scriveva quel che scriveva sulla Iri-Italsider-Ilva di Stato. Ma certo, sono anni in cui «ostacoli oggettivi» non consentivano interventi come quelli odierni. E dal 1982 al 2012? Sempre in prima linea. Però «diciamo che la società civile non era consapevole del problema». La società civile? Ascoltiamo in proposito l’ex ministro Corrado Clini. «Nel marzo 2012, per superare le contraddizioni ed uscire dalla situazione di stallo che si era venuta a creare, sulla base di gran parte delle valutazioni della procura della Repubblica di Taranto ho disposto la revisione dell’Aia. Contestualmente al riesame dell’Aia, ho avviato una ricognizione sullo stato dell’ambiente nel territorio di Taranto. È stato messo in evidenza che molte iniziative strategiche per il risanamento ambientale di Taranto, programmate e finanziate a partire dalla fine degli anni ’90, non erano state avviate o completate. E straordinariamente, nessuno aveva avuto nulla da ridire. In particolare. Primo, il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, finanziato nel 1998 con 50 milioni euro, era stato in gran parte disatteso. Secondo, le risorse destinate al risanamento ambientale del Mar Piccolo nel 2005 (26 milioni euro) erano state successivamente destinate ad altri interventi nella regione Puglia. Terzo, le risorse stanziate per il risanamento del quartiere Tamburi di Taranto (49,4 milioni di euro) il 3 luglio 2007 erano state successivamente destinate ad altri progetti». E adesso occhio alle date. Clini spiega: «Il 26 ottobre 2012, dopo una procedura di sei mesi ho rilasciato la nuova Aia, con la prescrizione dell’adeguamento degli impianti agli standard europei più severi e avanzati e che impone investimenti per 3 miliardi di euro». È un’Aia draconiana. Impone all’Ilva standard che in Europa si devono adottare entro il 2016 (mentre i tedeschi hanno ottenuto un posticipo al 2018). L’Ilva deve adottarli entro il 2014. I primi due interventi prevedono la copertura di 65 ettari – l’equivalente di circa settanta campi di calcio di serie A – di parchi minerali. Il secondo, l’intubamento di novanta chilometri di nastri trasportatori. «Il 15 novembre 2012 – spiega Clini – Ilva accetta le prescrizioni e presenta il piano degli interventi per dare attuazione alla nuova Aia. Nello stesso tempo Ilva ritira tutti i contenziosi aperti nel 2011 e 2012 dall’azienda contro l’Amministrazione. Insomma, Ilva aveva finalmente deciso di allinearsi alle direttive europee, voltando pagina». Con la retata del 26 novembre, naturalmente tutto cambia. Si era creata una via d’uscita rispettosa di tutte le esigenze (salute, lavoro, ambiente) al dramma di Taranto. Ma “la legge è legge”. Stessa storia accade il 24 maggio 2013, dopo la sentenza del 9 aprile con cui la Corte Costituzionale aveva sbloccato i sequestri e confermato la legittimità del “salva Ilva” di Monti. Il gip di Taranto passa a sequestrare l’intero patrimonio dei Riva. È la mazzata finale. Vero che alla procura di Taranto non basterà il bel servizio di Report del 18 novembre scorso, completamente allineato con le tesi della Procura degli 8,1 miliardi sequestrati perché questa, dicono i periti del gip, «è la cifra da noi stimata delle risorse sottratte dai Riva al risanamento ambientale Ilva». Vero che, 7 mesi dopo il teorema della procura e dell’affetto sostenitore di Report, arriverà la sentenza della Cassazione che disintegra l’ordinanza del gip di Taranto e ordina la restituzione degli 8,1 miliardi di patrimonio sequestrati ai Riva. Ma ormai il danno è fatto, l’Ilva è a pezzi, l’aria che tira a Taranto è di scontro permanente, insormontabile. E il governo Letta che fa? Invece di affrontare di petto l’incredibile anomalia di una procura che ha sbagliato pesantemente e che è stata due volte sonoramente stroncata nei suoi atti dagli stessi vertici del potere togato (Corte costituzionale e Suprema corte), ecco, invece di affrontare due magistrati, il governo batte in ritirata e si inventa una legge di “commissariamento straordinario”. Il resto è storia di questi giorni. Le acciaierie di Taranto sono tornate sotto amministrazione parastatale. E forse, chissà, invece che Ilva domani si chiameranno Iri.
La saggezza di un Capo magistrato: «I pm non sono padreterni. Devono servire il cittadino», scrive Luigi Amicone su “Tempi”. Giovandomenico Lepore, l’ex numero uno della procura di Napoli, la più grande d’Italia, si confessa a Tempi. Separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati, poco garantismo o troppo garantismo. Per una volta non parliamo dei problemi della giustizia. Per una volta parliamo di un magistrato “vecchio stampo”. Che poi significa semplicemente funzionario dello Stato, piuttosto che vincitore di concorso che si dà arie di primo ballerino alla Scala. Bene, coadiuvato dal giornalista Nico Pirozzi, l’ex capo procuratore di Napoli Giovandomenico Lepore (foto a fianco) ha scritto un libro apolide rispetto alle correnti dell’Anm e controcorrente sul mestiere più delicato e terribile. Un libro di bilanci e di vicende giudiziarie narrate con precisione, gustosi aneddoti e statistiche. Un libro che per il fatto stesso di suggerire saggezza e ironia fin dal titolo pirandelliano – Chiamatela pure giustizia (se vi pare), Edizioni Cento Autori –, il rifiuto di sedurre il lettore con la sgamata tecnica dell’“indignazione”, rappresenta un buon viatico all’azione, non giudiziaria ma educativa e culturale, di contrasto alla proliferazione di cervelli all’ammasso che da un ventennio hanno messo in capo alla magistratura il vasto programma di creazione di un Mondo Nuovo. Giovandomenico Lepore, 78 anni, sposato, napoletano, uomo del buon umore e della lingua del popolo, cinquant’anni di vita trascorsi in magistratura. Dopo essere stato pretore, pm, aggiunto, sostituto, presidente della procura generale, ha diretto per sette anni (2004-2011) la procura di Napoli, la più grande e tormentata d’Italia. Il Csm lo scelse all’unanimità come capo degli uffici requirenti (per una volta trovando l’accordo il correntismo politico di destra e di sinistra), «perché alla procura generale stavo troppo tranquillo e sereno». Mentre occorreva che qualcuno di forte e autorevole mettesse fine allo scontro che, un po’ come succede oggi a Milano, spaccava la procura partenopea all’epoca della gestione di Agostino Cordova. Fu così che Lepore venne incardinato al vertice e in breve riportò ordine (e perfino una certa armonia) tra i centosedici pubblici ministeri della città delle emergenze per antonomasia. «Non ho fatto niente di particolare se non tenere la porta aperta, ascoltare, dialogare, assumere le mie responsabilità, decidere. E all’occorrenza anche correggere certe storture». È stato il regista di alcune delle inchieste più rumorose della Seconda Repubblica (le cosiddette Calciopoli, P4, escort a Palazzo Grazioli, emergenza rifiuti, bonifiche fantasma, mega truffe sulle invalidità civili, appalti al Comune) e ha stroncato il clan dei Casalesi. Cioè quel pezzo di potente camorra con a capo Michele Zagaria «che le forze dell’ordine mi arrestarono proprio qualche giorno prima di andare in pensione, fu per me un regalo quasi più bello della buonuscita». Tempi ha incontrato Lepore a Milano, tra una conferenza e l’altra organizzate nell’ambito dei corsi (obbligatori, legge del governo Monti) di aggiornamento professionale per i giornalisti. Conversazione all’Ata Hotel e aperitivo al bar dei cinesi.
Nei confronti dei magistrati di Prima Repubblica emerge talvolta, da parte dei colleghi della Seconda, l’accusa più o meno velata di “collusione col potere”. Certa attuale magistratura è così consapevole del potere e della centralità che ha assunto in un ventennio di scandali, che a quei pochi che eventualmente contestano loro certi metodi (tipo l’uso disinvolto della carcerazione preventiva), essi rispondono che «la legge è la legge». Il che sarebbe un’ovvietà se, di fatto, non fosse uno scaricare la coscienza personale dall’orizzonte del proprio operare. Che ne pensa?
«Penso che la legge vada sempre interpretata con buon senso e equilibrio. Lo lasci dire a uno che è stato per cinquant’anni al penale, tranne nei due anni che ho fatto il pretore a Genova, quando il pretore era un magistrato magnifico, stava nei piccoli centri ma era a contatto con la gente e, se era di buon senso, risolveva i problemi veramente secondo giustizia. Queste sono anche le finalità per cui ho scritto il libro. Proprio per dare indicazioni ai colleghi giovani. Infatti, durante i miei sette anni da capo procuratore a Napoli, mi sono accorto che arrivano in Procura giovani magistrati – magari hanno appena vinto il concorso – e ognuno di loro che va a ricoprire l’ufficio di pubblico ministero si crede un Padreterno, si crede al di sopra delle parti, e non si rende conto che invece è solo un servitore del cittadino. Perciò quando sento dire: “Ma io sono un magistrato!”, con quel tono sopracciglioso di chissà chi, a me scappa da ridere. Un magistrato? Beh, io non lo so fare, ma bisognerebbe fargli un bel pernacchio. Ma è così, sono duecento anni che in Italia la giustizia non funziona, rassegniamoci, non funzionerà per altri duecento…»
Eppure c’è una parte di magistratura che è convinta di avere una missione salvifica nella società…
«Guardi, io capisco che con la velocità dei nuovi mezzi di comunicazione e qualche ansia di protagonismo – la televisione, i titoli sui giornali, la gente che vuole “giustizia” – ci si esponga e si creda di rendere un buon servigio alla società. Il magistrato risponde alla legge. È vero. Ma risponde tanto meglio quanto più serve lo spirito e le finalità della legge: servire lo Stato e prima ancora i cittadini. Dunque, per essere dei buoni magistrati non occorre protagonismo per poi magari un giorno, sull’onda della notorietà, procacciarsi un posticino in politica. È anche a questo riguardo che la riforma del 2006 diede funzioni ordinatrice e coordinatrice al capo dell’ufficio. I pubblici ministeri non possono pretendere di godere della stessa indipendenza e autonomia del giudice. Sono parti e quindi devono in qualche modo rispondere al capo ufficio. Capisco le resistenze, ciascuno ha la propria testa ed è giusto che la utilizzi. Però il capo ha la responsabilità degli uffici e io non mi sono mai tirato indietro dal ricordarlo ai miei colleghi. Quando stralciai l’inchiesta su Bertolaso e due prefetti perché ritenevo che non vi fossero elementi che giustificassero provvedimenti restrittivi, l’ho fatto e non me ne sarei pentito, anche se poi li avessero condannati. Grazie a Dio ho avuto ragione, perché tutte e tre le posizioni vennero poi assolte. Per questo è di fondamentale importanza la valutazione attenta dei candidati prima di nominare i capi degli uffici requirenti. È il vertice dell’ufficio che dà l’impronta, in un verso o nell’altro, negativamente o positivamente, all’azione della procura».
Lei ci sta dicendo che la magistratura è l’ultimo posto in Italia dove si fa politica?
«Purtroppo non abbiamo ancora trovato un sistema che prescinda dalle correnti. Però, secondo la mia modesta opinione, il Csm dovrebbe essere composto solo da togati. Che ci stanno a fare i cosiddetti “membri laici”, spesso reduci o trombati della politica?»
Non mi riferivo ai politici in Csm, mi riferivo proprio al fatto che gli incarichi, così come i capi delle procure, vengono decisi nei negoziati tra le correnti dell’Anm e con criteri lottizzatori molto simili al tanto vituperato Cencelli della politica di Prima Repubblica. O sbaglio?
«Per me il problema è solo la eventuale malafede. Le correnti sono una realtà e non ci possiamo fare niente. E poi è normale che un magistrato abbia le sue idee politiche. L’importante è che non agisca in malafede. Vede, l’ho detto anche in conferenza qui a Milano. In un certo senso anche il delinquente ha una sua buona fede. E se tu magistrato sei corretto, stai tranquillo che le disgrazie non succedono. Ma se tu sei scorretto, ricorri ai trabocchetti, sei in malafede, è chiaro che raccogli quello che hai seminato. E poi non è vero che le nomine sono sempre lottizzate. Pensi al mio caso, ma ce ne sono anche molti altri. Ripeto, secondo me non sono le idee politiche, di destra o di sinistra che siano, a ostacolare la giustizia. L’ostacolo è il magistrato che si fa trascinare dalla sua ideologia e insiste, in malafede, a farsi trascinare».
L’ex procuratore di Bari Michele Emiliano ha lasciato la procura nel 2003, è stato eletto sindaco e poi segretario regionale Pd. Adesso dice che ritorna a fare il magistrato. Le pare possibile?
«Beh, sì, se la legge lo consente… Però, no. Dal mio punto di vista se un magistrato va in politica deve lasciare la magistratura. Come fa il cittadino ad avere fiducia? Quale garanzia di imparzialità può dare ai cittadini?»
Condivide lo zelo con cui certe procure “attenzionano” i pochi grandi asset che sono rimasti in Italia? Pensi al caso delle presunte tangenti che l’accusa era certa fossero state pagate da Finmeccanica per piazzare elicotteri italiani in India. È finito in nulla ma l’Italia ci ha perso un mercato da 75 miliardi di dollari e commesse da due-tre miliardi di euro. Non le sembra distruzione del sistema-paese, per di più in un contesto di recessione e disoccupazione di massa?
«Capisco. Una cosa sono le tangenti che rientrano in Italia come provviste al manager o al politico che ha procacciato l’affare. Un’altra è quando sui mercati dell’Est, o dell’estremo oriente, per non parlare dell’Africa, l’azienda italiana deve passare, diciamo così, dalle forche caudine di sistemi corrotti in loco. Non è certo bello a vedersi. Ma questo è il mondo. Che senso ha metter tanto zelo e indagare i rapporti tra aziende e soggetti esteri? Ripeto, mi riferisco al contesto ambientale di certi mercati, non alle eventuali bustarelle che rientrano in Italia al manager o al politico per un affare che, poniamo, l’azienda italiana ha fatto in Africa e che vanno senz’altro perseguite. Sto parlando di come il mondo funziona realisticamente in certe aree geografiche. Lei ha fatto il caso di Finmeccanica. Lì non c’è stata nessuna tangente dice il dispositivo assolutorio. Ma anche se ci fossero state provviste da parte di soggetti esteri per ottenere all’azienda italiana la possibilità di entrare in un mercato – d’accordo, non sarebbe un bel vedere e infatti non si deve proprio vedere – non capirei lo zelo investigativo. Mettetevi al posto del soggetto straniero, come pensate che prenda la nostra attività? “Sapete che c’è? La commessa che dovevo dare a voi italiani la giro al belga piuttosto che all’inglese”. Questo è il punto. Il buon magistrato deve sempre ricordare che la legge lo pone al servizio del cittadino non astrattamente, ma realisticamente e prudentemente, considerando tutti i fattori di contesto in cui è chiamato a operare. Altrimenti io cittadino posso anche pensare che qualche interesse indicibile ce l’hai pure tu. E magari non è di questo paese».
De Magistris ha fatto cadere Prodi…
«Veramente quello lo ha fatto cadere un collega che sta dalle parti di Santa Maria Capua a Vetere, se si riferisce al caso Mastella».
Al di là del caso Mastella, Luigi De Magistris, questo singolare personaggio che condannato in prima istanza e obbligato a dimettersi da sindaco di Napoli – così come tutti i politici (in primis Berlusconi) sono stati obbligati a dimettersi in ottemperanza alla legge Severino – è il solo caso di politico che ottiene una sospensiva (dal Tar della Campania) e torna sindaco. E quanti danni ha fatto, da magistrato, con i suoi flop?
«Conoscevo suo padre, era un magistrato straordinario, eccezionale, equilibrato, direi impeccabile. Adesso questo figlio, che è pure intelligente e, devo dire, assolutamente onesto, pecca un pochino di impulsività. Quanto alle sue inchieste finite in flop devo dire che il problema non è suo. Ha fatto indagini, si è appassionato al suo quadro probatorio. Insomma, ha fatto il mestiere del pubblico ministero. È vero, ha sbagliato a farsi trascinare in televisione e a farsi rappresentare come una Giovanna D’Arco che sta sulle barricate. Però, chi lo poteva o doveva fermare – se c’erano le ragioni per fermarlo – era il capo ufficio. Allora, o il capo è stato un pusillanime e non ha avuto il coraggio di fermare cose sbagliate. Oppure il capo ha condiviso l’inchiesta e un certo modo di procedere. Terzo non è dato».
Arresti cautelari. Non c’è un sistema giudiziario in Europa che come il nostro vi ricorra così disinvoltamente. Con la conseguenza che le carceri italiane sono piene di persone ancora in attesa di giudizio. Non è tortura questa?
«Guardi che sono tre le motivazioni per giustificare provvedimenti cautelari restrittivi. Tu devi provare che c’è rischio di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato. Il problema è che la pressione dei media e della cosiddetta “opinione pubblica” non aiutano. Vai a spiegare, poniamo nel caso di un omicidio per gelosia, con reo confesso e magari pure pentito, che ci sono tutti i presupposti per concedere la libertà provvisoria. Vai a spiegare che se non c’è pericolo di fuga e naturalmente non c’è pericolo di inquinamento delle prove essendo il reo confesso, il rischio di reiterazione è nullo, ovviamente, per la particolare fattispecie di reato (quello ha ucciso la moglie per gelosia, non è che adesso c’è il rischio che ammazzi il primo che passa). Se li immagina i titoli dei giornali? Ci vuole più coraggio a fare le cose bene che a farle strizzando l’occhio alla vox populi, o meglio, alla vox media».
Ma lei, quando i suoi sostituti chiesero l’arresto di Bertolaso e dei due prefetti, si mise di traverso.
«E perché avrei dovuto rovinare la vita a tre persone quando il quadro probatorio non mi sembrava giustificare gli arresti? Poi, come le ho detto, mi andò bene, furono tutti e tre assolti. Ma anche se fossero stati condannati io ero il capo e dovevo assumermi le mie responsabilità. Dopo di che, non vorrei sembrare un’anima bella: se ci sono elementi per giustificare un provvedimento di restrizione della libertà si deve provvedere. Bisogna anche capire, però, che un arresto cautelare non è una prova di colpevolezza, perché poi la prova si forma in dibattimento. È chiaro che, purtroppo, proprio per le ragioni del giornalismo alla velocità della luce poi succede che chi finisce agli arresti cautelari viene marchiato a vita, perde la reputazione, l’onore, il lavoro, a prescindere. Per questo bisogna ponderare con prudenza ed equilibrio ogni provvedimento di questo genere. Purtroppo l’opinione pubblica è stata abituata ad avere la certezza di colpevolezza già dall’avviso di garanzia. E questo non va bene».
Cosa pensa dello scontro in atto alla Procura di Milano tra il capo Bruti Liberati e l’aggiunto Alfredo Robledo?
«Il dissidio è forte. Ci penserà il Csm. Mi spiace soltanto che queste cose finiscano sui giornali. La gente cosa capisce della magistratura? E soprattutto, a che serve alla gente sapere che questo e quello stanno litigando? È tutto gossip che fa solo male alla giustizia».
Come disse una volta Luciano Violante, bisognerebbe separare le carriere dei magistrati da quelle dei giornalisti?
«Sì, bisognerebbe tagliare il cordone. Anche se io ho sempre avuto rapporti splendidi con i giornalisti. Se dicevo a uno di loro: “Guarda questa cosa che ti hanno spifferato è vera, ma non la scrivere sennò mi comprometti le indagini”, beh questi mi obbediva e non usciva niente. Poi è capitato qualcuno con l’ansia dello scoop che ha creduto di farmi fesso. Peggio per lui, l’ho messo nel libro nero e non s’è visto più. Così la pubblicazione delle intercettazioni, a mio parere non va bene. Però capisco la pressione che avete addosso voi giornalisti… Comunque è sempre una questione di persone. Con me non è potuto mai succedere. Chiaro che poi non è che puoi controllare tutti gli uffici. Come si vide con l’inchiesta Calciopoli, dove molti verbali vennero rubati e pubblicati in un vero e proprio volumetto e questo ci rovinò l’indagine».
Però, se il Csm funzionasse bene, sarebbe già una mezza riforma della giustizia, non crede?
«Credo che il Csm dovrebbe essere composto solo da magistrati. Che c’entra il cosiddetto “laico”? Il Csm svolge una funzione importantissima. Come le dicevo, l’ufficio del capo procuratore è decisivo per l’organizzazione e il coordinamento dell’attività requirente. Per questo il problema è come scegli e chi scegli ai vertici delle procure…»
Da quale corrente è stato portato all’ufficio di capo a Napoli?
«Da nessuna. Ho avuto la fortuna o la sfortuna, veda un po’ lei, di essere prescelto all’unanimità. Me ne stavo tranquillo e sereno in procura generale quando mi hanno chiesto di mettermi a disposizione per sanare un pesante conflitto che spaccava in due la procura. Non voglio parlare della situazione che trovai negli uffici, dico soltanto che grazie a un paziente lavoro di ascolto e di mediazione siamo riusciti a ricompattare la più grande procura d’Italia, con 116 procuratori. Le assicuro, non è stato uno scherzo».
Beh, i risultati insegnano…
«Ripeto, quando si devono scegliere i capi degli uffici requirenti bisogna ponderare bene le scelte. Fortunatamente io sono stato scelto sopra, sotto e oltre ogni corrente. E mi scusi se cambio argomento pensando alle correnti politiche in generale: che spettacolo è questo che non si riesce a eleggere due membri della Corte costituzionale perché, così si dice, la Corte ormai è un organismo politico? E allora aboliamola questa Corte invece di assistere a questo spettacolo indecoroso!»
In effetti Svizzera e Gran Bretagna, tanto per citare i primi due paesi che vengono in mente, non hanno la Corte costituzionale e non pare siano paesi incivili…
«Ma l’Italia ne ha bisogno, abbiamo una Costituzione che la prescrive, va interpretata, la Corte è indispensabile per dirimere i conflitti istituzionali».
Cosa pensa del moltiplicarsi delle leggi anti-corruzione, anti-riciclaggio, anti-autoriciclaggio e via discorrendo? Ormai si pensa che le leggi siano la bacchetta magica per risolvere tutto e non si risolve niente, anzi.
«È vero che il costume italiano è peggiore di altri. Però è anche vero che la corruzione c’è sempre stata. Che fai, fermi lo sviluppo perché prima dev’essere tutto pulito e moralizzato? Che fai, blocchi i cantieri perché c’è sempre qualcuno in “odore di mafia”? E poi che significa “in odore di mafia”? Che se c’è un tale, un operaio o un impiegato di una certa impresa che è legato a qualche cosca o ha la fedina penale macchiata, fermi tutto in nome della normativa antimafia? Adesso vedo che a Milano è arrivato Raffaele Cantone, un bravissimo collega, per vigilare sull’Expo. Ma che vuol dire “super magistrato”, “super procuratore”? E poi, in concreto, che vuole dire “vigilare”, che può fare? Non mi sembra che sia la via giusta quella di moltiplicare le authority e gli istituti cosiddetti “anticorruzione”. Cantone è bravissimo, per carità. Ma che può fare in concreto? Rischia di aggiungere carte a carte, burocrazia a burocrazia. Vede, si moltiplicano gli organismi e le autorità, ma ancora non si fa abbastanza per far comprendere che il problema della corruzione è di cultura e di educazione. È qui che devi intervenire. Non puoi ridurre la giustizia a feticcio e aspettarti dalla magistratura la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi. Il mestiere del magistrato non è quello di salvare il mondo. È quello di fare rispettare le leggi nell’interesse della giustizia, dello Stato e, prima di tutto, dei cittadini».
Chi sono le istituzioni che aiuteranno chi denuncia?
EQUITALIA. STROZZINI DI STATO.
Equitalia, strozzini di Stato: per 2.100 euro ne vogliono 3 mila, scrive di Franco Bechis su “Libero Quotidiano”. Avviene tutti i giorni in gran parte delle case degli italiani. A metà mattina suona il postino «Raccomandata!», apri e ti trovi fra le mani una missiva di Equitalia, che sono sempre dolori. Si tratta delle solite multe prese magari senza nemmeno accorgersene (soste, infrazioni al traffico, eccessi di velocità etc..) o di contestazioni della Agenzia delle Entrate per rilievi formali magari di poco conto sulle dichiarazioni dei redditi. Al signor Marco Rossi (il nome è di fantasia) proprio quest'ultima è arrivata: una cartella Equitalia con una contestazione per irregolarità formali da parte della Agenzia delle Entrate su una dichiarazione dei redditi di cinque anni prima. «Ma come? Sono lavoratore dipendente, l’unica cosa che aggiungo è qualche detrazione di spese mediche e per questo invio tutto al commercialista». Marco manda la cartella di Equitalia al commercialista, che allarga le braccia: «La cifra non è enorme. Bisogna pagarla». Marco sospira: «Per lei non saranno enormi 2.114,66 euro. Ma per me sono più di un mese di stipendio. Almeno si può pagare a rate?». Con l’aiuto del commercialista è subito pronta la lettera da spedire ad Equitalia: non c’è bisogno di allegare documentazione che comprovi le difficoltà del momento per cifre così basse. E infatti Equitalia tempo un mese risponde a Marco, che apre la lettera tutto felice: «Le abbiamo accordato la ripartizione del pagamento di tale documento in n.28 rate mensili». Rateizzare - Il piano di ammortamento - scrivono - è stato «formulato secondo il criterio alla francese, che prevede rate di importo costante con quota di capitale crescente e quota interessi decrescente». Il signor Rossi non ci capisce molto: qualcosa cresce, qualcosa altro decresce. Ma vede il conto totale a fine operazione: 3.076,44 euro. Rateizzare quel debito che nemmeno capisce gli costa insomma 950 euro più che pagare subito. Sono 20 giorni di stipendio che si involano un po’ salendo un po’ scendendo «alla francese» per finire in tasca ad Equitalia. Le varie colonne dicono «quota capitale», «quota interessi di mora», «quota interessi di dilazione», «quota compensi di riscossione». Si fa due calcoli e significa che in due anni e 4 mesi il suo debito aumenta del 45,2%. Se va da uno strozzino dal cuore buono finisce che per una cifra così i prestito riesce perfino a risparmiare rispetto a quanto gli chiede il fisco italiano. Equitalia vuole il 32,58% in interessi di mora, poi il 4% di interessi di dilazione e l’8,6% di compensi di riscossione. Avranno ragione? Naturalmente hanno ragione: sono le leggi e i regolamenti che prevedono questo lievitare del debito dei contribuenti. Ogni governo di questi ultimi anni ha fatto finta di addolcire la pillola, si è sgolato parlando di «fisco amico», di «sportello amico», di una Equitalia dal volto umano, magari ha anche allargato e allungato le possibilità di rateizzare il debito per cifre via via più consistenti e perfino in tempi più lunghi, per venire incontro alle difficoltà che la crisi economica crea nel bilancio familiare o aziendale di milioni di contribuenti. Ma al ruolo vocazionale di strozzinaggio lo Stato non ha mai rinunciato, in nessuno dei volti in cui si presenta. Tassi di interesse - Il primo gennaio 2014 scorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è stato pubblicato il nuovo tasso di interesse legale stabilito dal governo italiano: è l’uno per cento. Il contribuente non si deve attendere di più quando presta soldi o li dà in custodia a Stato o privati secondo le leggi vigenti. Ma se il percorso è quello contrario: è lo Stato che li deposita da te (ad esempio facendoti rateizzare il tuo debito con lui), quella regola non vale più, e sono dolori per il cittadino. Oltretutto non c’è solo Equitalia: quel debito potrebbe essere con l’ufficio tributi di un comune, o con un ufficio giudiziario, o con un altro ente pubblico. E ognuno applica il tasso che vuole. Ad esempio gli interessi sulle dilazioni sono diversissimi in ogni posto di Italia: si va da zero fino al 6 per cento. Ed è questione di fortuna: gli uffici giudiziari applicano il 4,5%. L'ufficio tributi del comune di Monza (e di pochi altri piccoli comuni) non chiede interessi (il tasso sulle dilazioni è 0%). Quello di Livorno vuole il 4,5%, quello di Perugia si accontenta dell'1% che sarebbe poi il tasso legale, quello di Pitigliano chiede il 3,5%. A Messina vogliono il 4%, a Torino il 5%, a Milano sulla tassa per i rifiuti viene applicato un interesse dilazionatorio del 2%, a Novara l'ufficio tributi chiede il 2,5%, in un posto vip come Courmayeur si accontentano dell’1,5% (a Cortina invece è 1%).
CONCORSI ED ESAMI. LE PROVE. TRUCCO CON I TEST; TRUCCO CON GLI ELABORATI.
Le Prove. La Prova scritta.
La prova scritta è in genere un tema o una griglia di test a risposta sintetica o una prova pratica. Solitamente è svolta in 1 o più giornate differenti su materie differenti, e può essere indifferentemente un giorno un tema ed il successivo una prova pratica, o una prova a risposta sintetica ed un tema ecc. ecc. Come nella prova preselettiva al candidato vengono consegnate due buste, una con il materiale d’esame e l’altra con il cartoncino su cui indicare il proprio nome, cognome e data di nascita. Lo scritto va fatto – brutta e bella – utilizzando esclusivamente i fogli messi a disposizione, che poi il candidato inserirà nella busta grande insieme alla busta piccola (chiusa) contenente il cartoncino con le generalità. Il bando dà indicazioni sui testi che è possibile portare con sé – normalmente il dizionario di italiano ed i codici senza commenti se la prova è di tipo giuridico. Attenzione, all’ingresso i testi possono venire aperti per un controllo e, se non rispondono per qualche ragione a quanto previsto, non vengono fatti entrare. Eliminate perciò fogli di appunti, temi, schemi ecc…Evitate per quanto possibile di portare fotocopie, che possono subire la stessa sorte. Se sono proprio necessarie, portatele ben rilegate. Tenete conto che le operazioni di controllo all’ingresso possono durare a lungo, specialmente nei concorsi con grande affluenza. E’ quindi molto frequente che dall’orario di convocazione – in genere le 9 del mattino – all’ora in cui ha effettivamente inizio la prova, possono passare 2,3,4 ore. Se aggiungete a queste le ore di durata effettiva della prova, capite quanto può essere importante avere con sé qualcosa da mangiare e da bere. Solitamente non è possibile alzarsi per le prime due ore.
Domande a risposta sintetica. Si tratta di un numero limitato di domande (di solito non più di sei) che hanno, oltre alla classica opzione della risposta multipla, anche alcune righe per la risposta sintetica. E’ un tipo di prova molto comune soprattutto sulle materie giuridiche ed è un tipo di scritto abbastanza ostico. Scrivere di diritto non è facile, essere sintetici ancora meno. Il testo scritto deve essere breve (tra le dieci e le venti righe), coinciso e il più possibile chiaro. Non deve semplicemente ripetere con altri termini la risposta già scelta tra le riposte fornite dal test, ma deve aggiungere qualcosa: la motivazione della risposta già data, il contesto, casi specifici ed eccezioni, ecc. Nell’allenarsi alla prova a risposte sintetiche, è sconsigliabile tentare di imparare quelle contenute nei testi di preparazione: quasi sempre niente ritorna alla memoria al momento opportuno, mentre è utilissimo allenarsi a scrivere testi brevi, utilizzando qualunque tipo di domanda a risposta multipla.
Prova pratica. E’ una prova pratica quella ispirata alla verifica delle reali capacità operative del candidato nel ruolo specifico che gli verrà affidato. Essendo diversa da mansione a mansione è quindi qui impossibile estrapolare degli esempi (la sua applicazione va dalla multa al caso clinico). Di solito quando un concorso prevede una prova di questo tipo, le editrici specializzate inseriscono uno schema all’interno dei testi di preparazione. Il suggerimento anche qui è di utilizzare il buon senso: la prova serve a verificare quanto il candidato riesca effettivamente ad utilizzare nella pratica le nozioni che ha acquisito, quindi va benissimo imparare schemi (moduli, procedure ecc), ma questi vanno utilizzati tenendo in debito conto del quesito proposto (che come sempre va letto molto attentamente) ed anche della nozioni teoriche sottese (implicate).
Tema. Il tema è una composizione scritta abbastanza lunga ed articolata – circa 3/5 facciate di foglio protocollo - ampiamente utilizzata nelle prove di concorso. Nei concorsi per diplomati, è più spesso di cultura generale, storia, italiano; si tratta quindi di uno scritto del tipo di quelli che si fanno alle scuole superiori. In questo caso quello che conta è che l’elaborato sia in italiano corretto e che sia chiaro e non contenga informazioni errate. Se invece il tema è di argomento giuridico la faccenda cambia. Il tema di diritto mette in difficoltà un po’ tutti, chi è laureato in materie giuridiche infatti è raramente abituato a scrivere, chi ha fatto altri percorsi di studio teme di non saper utilizzare adeguatamente il linguaggio giuridico. In tutti i casi, non c’è da perdersi d’animo: ci si riabitua a scrivere semplicemente allenandosi. Certo, specialmente chi non ha un background giuridico fa bene a seguire dei corsi, per affinare la terminologia in modo da non incorrere in errori concettuali gravi. Se chiarezza e completezza sono le carte vincenti, non vanno dimenticate la calligrafia – che deve essere il più possibile leggibile, e la lunghezza totale, che non deve essere eccessiva.
Diario di un commissario del concorso per magistrato: i trucchi per copiare, dal bagno alla nursery, scrive Lionello Mancini su “Il Sole 24ore”. Nelle ore immediatamente successive alla prova scritta per un posto da magistrato, uno dei 29 commissari, ha voluto riassumere in quattro paginette di appunti la sua esperienza al padiglione fieristico di Rho-Pero e aggiungere alcuni suggerimenti per rendere meno macchinosa, più corretta e trasparente la selezione dei togati. Ecco alcuni passi degli appunti del commissario, una probabile traccia per l'audizione davanti alla IX commissione del Csm. Durante i tre giorni delle prove scritte, a seguito di violazioni delle regole concorsuali, la commissione ha deciso diverse espulsioni, pare 70, anche se non conosco il numero esatto. Io stesso ho espulso un buon numero di candidati in poche ore. La maggior parte delle irregolarità consisteva nella detenzione di testi non consentiti. Ho sentito dire da più parti che con ogni evidenza il controllo dei codici non ha funzionato. Ma è proprio così? Per non drammatizzare inutilmente, basterebbe un semplice conteggio: ogni concorrente si presenta alla prova scritta con almeno 5 "pezzi" tra codici, raccolte di leggi, stampe da Internet ecc. Moltiplicando questa cifra (ottimistica) per 5.600 partecipanti, risulta che noi commissari abbiamo controllato non meno di 28mila testi. Se solo 2 su 1.000 sono sfuggiti al controllo – frazione senz'altro fisiologica se non virtuosa – possiamo concludere che una sessantina di casi sono apparentemente tanti, ma sono invece relativamente pochi. Esistono molte edizioni dei codici, quasi tutte volutamente ai limiti dell'ammissibilità e spesso con tanto di scritta in copertina che rassicura l'acquirente sul fatto che potrà usarlo durante la prova scritta. Ed è così: l'irregolarità non è per niente scontata e dipende dall'interpretazione della norma che esclude i testi con "note, commenti, annotazioni anche a mano". E allora perché tante edizioni border line? Alcuni di questi tomi sfruttano l'indice analitico che arriva così a occupare centinaia di pagine ed è talmente strutturato da poter fungere da tracce di elaborati; altri volumi recano abbondanza di richiami che non possono essere vietati perché riportati da tutte le edizioni, "Gazzetta Ufficiale" compresa. I candidati sono suddivisi per lettera in tante file e consegnano i testi ad altrettanti desk con un commissario che decide i casi dubbi. È ovvio che per evitare disparità di giudizi che finiscano in difformità sui criteri di sequestro, la soglia di ammissibilità è tenuta bassa. Anche perché, spesso si tratta di codici costosi, non pacificamente inammissibili, magari curati da colleghi magistrati, spesso recanti scritte rassicuranti e persino timbri di concorsi precedenti. Soprattutto, sequestrare i codici a Rho-Pero in prossimità della prova, significa di fatto lasciare il candidato senza testi da consultare perché, data la distanza dalla città, non è possibile andare in una libreria a Milano e tornare in tempo per l'esame. Oltre alle edizioni border line, è sempre più frequente che i candidati si presentino con pacchi di stampe dal computer: formati ammissibili, ma di difficile controllo. Ci sono poi i testi annotati a mano, non vietati automaticamente ma da valutare nel loro contenuto. Ci sono candidati disposti, per evitare il sequestro, a strappare o sigillare le parti vietate e rendere così utilizzabile un codice (sulla cui copertina resterà comunque scritto "commentato", cioè di fatto vietato). E va considerato che la legge di fatto incoraggia i tentativi di introdurre materiale illegale perché in sede di controllo pre-esame consente solo l'esclusione del testo e non anche del candidato: insomma, abbiamo dovuto vedere in aula candidati che il giorno prima avevano cercato di introdurre un vocabolario di italiano farcito con temi di diritto. È stato escluso il tomo, ma non il suo detentore. A parte i difficoltosi controlli dei giorni precedenti, anche il giorno della prova il materiale irregolare entra facilmente: la polizia penitenziaria esegue una perquisizione "leggera" all'ingresso, ma le piccole fotocopie nascoste sotto gli abiti ovviamente passano. I servizi igienici sono usati sia per scambiarsi parole veloci durante le code per entrare, sia per passare il materiale da una inaccessibile fodera a una comoda tasca. Da qui il divieto di andare al bagno prima di una certa ora, cui vengono opposte continue affermazioni di gravi problemi fisici, difficili da contestare in assenza di un commissario-medico. Ecco il motivo delle numerose deroghe al divieto, pur accompagnate da precauzioni aggiuntive come le perquisizioni prima e dopo, a meno che il candidato non accetti di lasciare la porta del bagno aperta, vigilato da un agente dello stesso sesso. Altro luogo "tentatore" è la nursery cui hanno diritto le candidate con infante da allattare. Ovviamente il bimbo è accudito da un parente, magari adatto a consultazioni o che si presta a "importare" materiale proibito.
Questo succede durante le prove scritte. Nessuno sa quello che succede dopo. La verità si scopre attraverso i ricorsi al Tar.
LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI. Quanto già indicato sono i trucchi che i candidati possono vedere ed eventualmente denunciare. Quanto avviene in sede di correzione è lì la madre di tutte le manomissioni. Proprio perchè nessuno vede. La norma prevede che la commissione d’esame (tutti i componenti) partecipi alle fasi di:
• apertura della busta grande contenente gli elaborati;
• lettura del tema da parte del relatore ed audizione degli altri membri;
• correzione degli errori di ortografia, sintassi e grammatica;
• richiesta di chiarimenti, valutazione dell’elaborato affinchè le prove d’esame del ricorrente evidenzino un contesto caratterizzato dalla correttezza formale della forma espressiva e dalla sicura padronanza del lessico giuridico, anche sotto il profilo più strettamente tecnico-giuridico, e che anche la soluzione delle problematiche giuridiche poste a base delle prove d’esame evidenzino un corretto approccio a problematiche complesse;
• consultazione collettiva, interpello e giudizio dei singoli commissari, giudizio numerico complessivo, motivazione, sottoscrizione;
• apertura della busta piccola contenete il nome del candidato da abbinare agli elaborati corretti;
• redazione del verbale.
Queste sono solo fandonie normative. Di fatto si apre prima la busta piccola, si legge il nome, se è un prescelto si dà agli elaborati un giudizio positivo, senza nemmeno leggerli. Quando i prescelti sono pochi rispetto al numero limite di idonei stabilito illegalmente, nonostante il numero aperto, si aggiungono altri idonei diventati tali “a fortuna”.
La riforma del 2003 ha cacciato gli avvocati e sbugiardato i magistrati e professori universitari (in qualità anch’essi di commissari d’esame) perché i compiti vengono letti presso altre sedi: tutto questo perché prima tutti hanno raccomandato a iosa ed abusato del proprio potere dichiarando altresì il falso nei loro giudizi abilitativi od osteggiativi. Spesso le commissioni d’esame sono mancanti delle componenti necessarie per la valutazione tecnica della materia d’esame. Le Commissioni d’esame hanno sempre e comunque interessi amicali, familistiche e clientelari. Seguendo una crescente letteratura negli ultimi anni abbiamo messo in relazione l’età di iscrizione all’albo degli avvocati con un indice di frequenza del cognome nello stesso albo. In particolare, per ogni avvocato abbiamo calcolato la frequenza del cognome nell’albo, ovvero il rapporto tra quante volte quel cognome vi appare sul totale degli iscritti, in relazione alla frequenza dello stesso cognome nella popolazione. In media, il cognome di un avvocato appare nell’albo 50 volte di più che nella popolazione. Chi ha un cognome sovra-rappresentato nell’albo della sua provincia diventa avvocato prima. Infine vi sono commissioni che, quando il concorso è a numero aperto, hanno tutto l’interesse a limitare il numero di idonei per limitare la concorrenza: a detta dell’economista Tito Boeri: «Nelle commissioni ci sono persone che hanno tutto da perderci dall’entrata di professionisti più bravi e più competenti».
Paola Severino incoraggia gli studenti e racconta: “Anch’io la prima volta fui bocciata all’esame per diventare avvocato”. Raccontare una propria disavventura per infondere coraggio alle nuove generazioni. Questa è la tecnica adottata dal Ministro della Giustizia Paola Severino con i ragazzi della «Summer School» promossa dalla Fondazione Magna Charta di Gaetano Quagliariello e Maurizio Gasparri. “Cari ragazzi, non dovete scoraggiarvi perché anch’io la prima volta fui bocciata all’esame per diventare avvocato… Quella volta ero con il mio futuro marito: lui fu promosso e io non ce la feci… Ma eccoci ancora qua. Siamo sposati da tanti anni” ha raccontato di fronte ai futuri avvocati puntando tutto sulla love story e omettendo che, nonostante quella bocciatura, sarà titolare fino a novembre di uno degli studi legali più importanti d’Italia (con cifre che si aggirano intorno ai 7 milioni di euro). Una piccola consolazione non solo per i laureati in legge, ma anche per tutte le future matricole che sosterranno i test di ammissione. In fondo anche Albert Einstein venne bocciato. E a quanto pare anche la Severino. Bisognerebbe, però, chiedere al ministro: gli amorosi l’aiuto se lo son dato vicendevolmente ed i compiti sicuramente erano simili, quindi perché un diverso giudizio?
In quei mesi di tormenti a cavallo tra il 2000 e il 2001 la Mariastella Gelmini si trova dunque a scegliere, spiegherà essa stessa a Flavia Amabile de “La Stampa.it”: «La mia famiglia non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi, mio padre era un agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo superare l'esame per ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La sensazione era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame. Per gli altri, nulla. C'era una logica di casta». E così, «insieme con altri 30-40 amici molto demotivati da questa situazione, abbiamo deciso di andare a fare l'esame a Reggio Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto, erano incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo calabrese c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il triplo che nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo che ad Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il 28% di Brescia, il 23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte e mezzo quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata, Trentino, Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la tentazione era forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e abbiamo deciso di farlo anche noi». E l'esame? Com'è stato l'esame? Quasi 57% di ammessi agli orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a Brescia. Dietro soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno.
Quello per giudici e pm resta uno dei concorsi più duri. Dopo la laurea occorrono oltre due anni di preparazione negli studi forensi. Oppure nelle scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali. Sui 3.193 candidati che nel novembre 2008 hanno consegnato i tre scritti di diritto amministrativo, penale e civile, la commissione ha mandato agli orali soltanto 309 aspiranti magistrati. Per poi promuoverne 253. Nonostante i quasi due anni di prove e correzioni e i soldi spesi, il ministero non è nemmeno riuscito a selezionare i 500 magistrati previsti dal concorso. E tanto attesi negli uffici giudiziari di tutta Italia. Se questi sono i risultati dei corsi di formazione post-laurea, il fallimento degli obiettivi è totale. Eppure almeno cinque tra i 28 commissari sono stati scelti dal ministro Alfano proprio tra quanti hanno insegnato nelle scuole di specializzazione per le professioni legali. "I componenti della commissione rispondono che il livello degli elaborati non ammessi era basso", dice l'avvocato Anna Sammassimo, dell'Unione giuristi cattolici: "Ma alla lettura degli elaborati dichiarati idonei si resta perplessi e molto. Tanto più che i curricula dei candidati esclusi destano ammirazione. Dal verbale da me visionato, il 227, risulta che la correzione dei tre elaborati di ciascun candidato ha impegnato la sottocommissione per circa 30 minuti: per leggere tre temi di tre materie, discuterne e deciderne il voto o la non idoneità sembra obiettivamente un po' poco". Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati.
Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio.
Di scandali per i compiti non corretti, ma ritenuti idonei, se ne è parlato.
Nel 2008 un consigliere del Tar trombato al concorso per entrare nel Consiglio di Stato, si è preso la briga di controllare gli atti del giorno in cui sono state corrette le sue prove, scoprendo che i cinque commissari avevano analizzato la bellezza di 690 pagine. "Senza considerare la pausa pranzo e quella della toilette, significa che hanno letto in media tre pagine e mezzo in 60 secondi. Un record da guinness, visto che la materia è complessa", ironizza Alessio Liberati. Che ha impugnato anche i concorsi del 2006 e del 2007: a suo parere i vincitori hanno proposto stranamente soluzioni completamente diverse per la stessa identica sentenza. Il magistrato, inoltre, ha sostenuto che uno dei vincitori, Roberto Giovagnoli, non aveva nemmeno i titoli per partecipare al concorso. L'esposto viene palleggiato da mesi tra lo stesso Consiglio di Stato e la presidenza del Consiglio dei ministri, ma i dubbi e "qualche perplessità" serpeggiano anche tra alcuni consiglieri. "Il bando sembra introdurre l'ulteriore requisito dell'anzianità quinquennale" ha messo a verbale uno di loro durante una sessione dell'organo di presidenza: "Giovagnoli era stato dirigente presso la Corte dei conti per circa 6 mesi (...) Il bando non sembra rispettato su questo punto". Per legge, a decidere se i concorsi siano stati o meno taroccati, saranno gli stessi membri del Consiglio. Vedremo.
In effetti, con migliaia di ricorsi al TAR si è dimostrato che i giudizi resi sono inaffidabili. La carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio negativo reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque la infondatezza dei giudizi assunti, tale da suffragare e giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta discrasia tra giudizio e contenuto degli elaborati, specie se la correzione degli elaborati è avvenuta in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio composito. Tempi risibili, tanto da offendere l’umana intelligenza. Dai Verbali si contano 1 o 2 minuti per effettuare tutte le fasi di correzione, quando il Tar di Milano ha dichiarato che ci vogliono almeno 6 minuti solo per leggere l’elaborato. La mancanza di correzione degli elaborati ha reso invalido il concorso in magistratura. Per altri concorsi, anche nella stessa magistratura, il ministero della Giustizia ha fatto lo gnorri e si è sanato tutto, alla faccia degli esclusi. Già nel 2005 candidati notai ammessi agli orali nonostante errori da somari, atti nulli che vengono premiati con buoni voti, mancata verbalizzazione delle domande, elaborati di figli di professionisti ed europarlamentari prima considerati “non idonei” e poi promossi agli orali. Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio. Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati. O ancora l’esame di ammissione all’albo dei giornalisti professionisti del 1991, audizione riscontrabile negli archivi di radio radicale, quando la presenza di un folto gruppo di raccomandati venne scoperta per caso da un computer lasciato acceso nella sala stampa del Senato proprio sul file nel quale il caposervizio di un’agenzia, commissario esaminatore, aveva preso nota delle prime righe dei temi di tutti quelli da promuovere. E ancora lo scandalo denunciato da un’inchiesta del 14 maggio 2009 apparsa su “La Stampa”. A finire sotto la lente d’ingrandimento del quotidiano torinese l’esito del concorso per allievi per il Corpo Forestale. Tra i 500 vincitori figli di comandanti, dirigenti, uomini di vertice. La casualità ha voluto, inoltre, che molti dei vincitori siano stati assegnati nelle stazioni dove comandano i loro genitori. Una singolare coincidenza che diventa ancor più strana nel momento in cui si butta un occhio ad alcuni “promemoria”, sotto forma di pizzini, ritrovati nei corridoi del Corpo forestale e in cui sono annotati nomi, cognomi, date di nascita e discendenze di alcuni candidati. «Per Alfonso, figlio di Rosetta», «Per Emidio, figlio di Cesarina di zio Antonio», «Per Maria, figlia di Raffaele di zia Maria». Piccole annotazioni, certo. Il destino, però, ha voluto che le tutte persone segnalate nei pizzini risultassero vincitrici al concorso.
GLI ESCLUSI, RIAMMESSI. Candidati che sono stati esclusi dalla prova per irregolarità, come è successo al concorso per Dirigenti scolastici, o giudicati non idonei, che poi si presentano regolarmente agli orali. L’incipit della confidenza di Elio Belcastro, parlamentare dell’Mpa di Raffaele Lombardo, pubblicata su “Il Giornale”. Belcastro ci fa subito capire, scandendo bene le parole, che Tonino non era nemmeno riuscito a prenderlo quel voto, minimo. «Tempo fa l’ex procuratore capo di Roma, Felice Filocamo, che di quella commissione d’esami era il segretario, mi ha raccontato che quando Carnevale si accorse che i vari componenti avevano bocciato Di Pietro, lo chiamò e si arrabbiò molto. Filocamo fu costretto a tornare in ufficio, a strappare il compito del futuro paladino di Mani pulite e a far sì che, non saprei dire come, ottenesse il passaggio agli orali, seppur con il minimo dei voti». Bocciato e ripescato? Magistrato per un falso? Possibile? Non è l’unico caso. Era già stato giudicato non idoneo, ma in una seconda fase sarebbero saltati fuori degli strani fogli aggiuntivi che prima non c’erano. Ecco come sarebbe sorto il sospetto che qualcuno li avesse inseriti per “salvare” il candidato già bocciato, in modo da giustificare una valutazione diversa oppure da consentire un successivo ricorso al TAR. I maggiori quotidiani nazionali e molti locali, ed anche tanti periodici, si sono occupati di tale gravissimo fatto, e che è stato individuato con nome e cognome il magistrato (una donna) in servizio a Napoli quale autore del broglio accertato. Per tale episodio il CSM ha deciso di sospendere tale magistrato dalle funzioni e dallo stipendio. In quella sessione a fronte di 350 candidati ammessi alle prove orali pare che oltre 120 siano napoletani, i quali sembrano avere particolari attitudini naturali verso le scienze giuridiche e che sembrano essere particolarmente facilitati nel loro cammino anche dalla numerosa presenza nella commissione di esami di magistrati e professori napoletani.
Medicina, storia del concorso delle
polemiche. "Test copiati, quiz rimossi e compiti modificati".
L'esame per l'accesso alle scuole di specializzazione dello
scorso novembre 2014 doveva eliminare il problema dei baronati. Ma dopo le
polemiche sulle domande sbagliate, l'Espresso ha visionato il ricorso presentato
dai candidati al Tar. E dentro viene denunciato davvero di tutto, scrive Martino
Villosio su “L’Espresso”. Doveva essere il concorso del merito, della
trasparenza, dei parametri standard di valutazione, immune finalmente da
localismi e al riparo dalle grinfie dei baroni. Tutti i candidati, dal Friuli
alla Sicilia, davanti a un pc, niente carta e penna, un salvataggio a fine
prova, un meccanismo di correzione costruito per essere impermeabile a qualunque
ipotetico sospetto di violazione dell'anonimato. A distanza di tre mesi, invece,
la lista completa di verbali, atti e documenti relativi al primo concorso
pubblico per l'accesso alle specializzazioni di medicina gestito a livello
nazionale con graduatoria unica svela il tracollo di premesse e promesse. Un
tradimento che ha già portato tanti giovani medici ad abbandonare l'Italia,
ancor prima di attendere le decisioni della giustizia amministrativa sommersa
dai ricorsi. Punteggi sbagliati, pc in rete. Sedi non idonee, controlli non
omogenei delle singole commissioni, router nascosti nei cappotti e pc collegati
in rete durante le prove in alcuni atenei, foto che mostrano chiaramente come in
certe aule i candidati fossero seduti a distanza ravvicinata tanto da
costringere il Miur a sferzare le commissioni con una circolare dopo il primo
giorno di test. E ancora singole aule in cui tutti i candidati hanno totalizzato
punteggi stellari e perfettamente combacianti, centinaia di black out e guasti
ai computer che hanno consentito ai più fortunati di veder raddoppiato il tempo
a disposizione per rispondere alle domande, "bachi" nel sistema informatico,
punteggi affissi in graduatoria diversi da quelli visualizzati dai candidati al
termine delle prove e ricorretti in fretta e furia solo grazie all'attenzione e
alle proteste degli interessati. Computer così vicini da permettere di copiare.
A suggello di tutto le mani non meglio identificate di chi, denunciano gli
avvocati dei ricorrenti, ha potuto incredibilmente entrare nelle prove di tutti
i candidati modificandole dall'interno in violazione dello stesso principio che
il nuovo concorso era nato per salvaguardare: proprio quello dell'anonimato.
Tutto questo viene oggi ad aggiungersi a quanto di clamoroso emerse a inizio
novembre, a concorso appena finito: il pasticcio dell'inversione dei quesiti di
due differenti aree del test (quella medica e quella dei servizi clinici) da
parte del consorzio Cineca incaricato di preparare le prove, il ministero
dell'Università e della Ricerca che prima annuncia la scelta di annullare quelle
oggetto dell'errore poi, dopo due giorni, fa marcia indietro e sentito il parere
dell'Avvocatura sceglie di abbonare quattro domande (in seguito diventate sei) a
tutti i candidati, dando loro il massimo punteggio a prescindere dalla maggiore
o minore correttezza delle risposte fornite.
Uno scandalo già rimosso. Un caso dai contorni surreali, l'ultimo pugno nello
stomaco di una generazione di aspiranti camici con la valigia in mano,
archiviato dai media e dal dibattito politico con molta più fretta di quanto ci
si sarebbe potuti aspettare nell'Italia che insegue la svolta all'insegna della
gioventù e della meritocrazia. L'Espresso ha potuto visionare in anteprima
questa galleria di irregolarità e superficialità, alla vigilia dell'udienza del
12 febbraio davanti al Tar del Lazio chiamato a prendere in esame parte dei
ricorsi presentati per l'annullamento delle graduatorie. Una lista contenuta
nella lunga memoria depositata lo scorso 26 gennaio dall'avvocato Michele
Bonetti, il legale che tra l'estate e l'autunno dello scorso anno ha già
ottenuto l'ammissione con riserva ai corsi di laurea delle facoltà di medicina
di tutta Italia di 5.000 studenti respinti ai test d'ingresso e che, insieme al
collega Santi Delia, ha curato anche i ricorsi degli aspiranti specializzandi.
Insomma un elenco fornito da una parte con precisi e concreti interessi nella
partita, ma puntellato da un corposo dossier di carte ufficiali finito
all'attenzione della magistratura in sede penale. Aule inidonee, punteggi
stellari. Il primo cardine su cui doveva poggiare il nuovo concorso, ovvero
l'omogeneità della selezione a livello nazionale, ha retto a stento davanti alle
carenze organizzative di alcune aule. L'articolo 2 comma 4 del bando disponeva
che almeno 20 giorni prima della prova di esame il Miur dovesse comunicare sedi
e orario di svolgimento. Le aule però sarebbero state reperite solo qualche
giorno prima dei test, non solo nelle università ma anche in centri di
formazione professionale e istituti privati. Come emerge da alcuni verbali e
dalle foto pervenute al sito de "l'Espresso", in alcune di esse i candidati
erano talmente vicini da consentire a tutti di poter leggere tranquillamente
dallo schermo del collega. Un monitor che, a differenza dei classici fogli A4
contenenti 4 o 5 domande, proiettava a visione intera un solo quesito alla volta
con la relativa risposta del candidato. Più piccole erano le aule, riporta
l'avvocato Bonetti nella sua memoria, più palese è stato il numero di
concorrenti con punteggi identici. Come a Catania, dove nell'aula 10 - durante
l'ultimo giorno di prova - su 12 partecipanti concorrenti per Anestesia, in 10
hanno avuto l'identico alto punteggio di 17,4 su 20. O a Bari, dove il 31
ottobre durante la prova dell'area dei servizi di fatto non di competenza dei
candidati (perché si scoprirà che le domande erano state invertite con quelle di
area medica) in un'aula 12 candidati su 14 ottengono lo stesso score: di nuovo
17,4 su 20. A Milano i candidati chiedono che sia messo a verbale che i pc sono
troppo vicini e corrono voci di "copiature frequenti e uso di cellulari presso
altre sedi". A Trieste è addirittura la stessa commissione ad alzare bandiera
bianca: "Risulta materialmente impossibile", recita il verbale del 30 ottobre
per l'aula F, "collocare tutti i candidati in modo alternato, si decide di far
prendere posto ai candidati seduti necessariamente vicini nelle posizioni di
massima visibilità". Black out, web libero e bug informatici. Sono centinaia i
casi a verbale di black out energetici in diverse sedi di concorso. In alcune i
candidati, dopo aver letto le domande e addirittura aver terminato la prova,
hanno potuto ripeterla visto che i pc si spegnevano o non rispondevano ai
comandi. Aule intere hanno subito la sospensione dell'energia dopo che erano
state lette le domande della prova. Durante le operazioni di ripristino, a
Chieti, i candidati hanno addirittura potuto riprendere i propri cellulari
collegati in rete. In altre sedi, come risulta a verbale, i pc erano invece
collegati via cavo alla rete LAN o avevano accesso alla rete wi-fi consentendo
la navigazione sul web attraverso router portatili lasciati dai candidati nei
cappotti. Uno di questi casi è documentato a Napoli, presso l'università Suor
Orsola Benincasa. Alla Seconda Università di Napoli, il 31 ottobre, dopo 16
episodi di malfunzionamento dei pc la prova viene interrotta e fatta ripetere ai
candidati. A Ferrara addirittura salta un'intera fila di computer, obbligando
ormai a fine prova a far rifare il test a tutti i candidati della fila.
Tragicomici, poi, alcuni degli episodi segnalati sempre a verbale: come a
Padova, dove durante la prova un candidato - ricontrollando i test - si rende
conto a un certo punto che in alcuni casi le risposte da lui date risultano
modificate. Colpa di un bug informatico che fa sì che il concorrente, anche
semplicemente muovendo il mouse sulla parte bianca dello schermo, intervenga
sull'opzione appena spuntata senza rendersene conto. Un'anomalia denunciata
anche a La Sapienza. Centinaia anche le segnalazioni di aspiranti specializzandi
che hanno trovato un punteggio affisso diverso da quello visualizzato dopo la
prova e regolarmente salvato. Come a Genova, dove lo score di una candidata era
stato prima salvato come 34,1 e poi - il giorno dopo - riverificato essere 33,8.
Se l'interessata non avesse chiesto di eseguire un controllo, essendo convinta
del suo risultato iniziale, l'accaduto non avrebbe mai potuto essere
ricostruito. Pipì nel cestino. Anche nella severità con cui le commissioni hanno
fatto rispettare i regolamenti emergono forti discrepanze. Nonostante il bando
del 4 agosto 2014 specifichi chiaramente che "il Ministero definisce ogni elenco
d'aula avendo cura di distribuire i candidati secondo l'ordine anagrafico", in
alcune sedi è stato concesso agli aspiranti specializzandi di scegliere
liberamente il posto. In un verbale dell'ateneo di Udine viene riferito
candidamente che "ciascun candidato si colloca a sua scelta in una delle
postazioni disponibili". A Palermo la commissione controbatte addirittura a un
candidato che, bando alla mano, chiedeva il rispetto dell'ordine alfabetico.
D'altro canto persino il video esplicativo sulla procedura di accesso alle aule
del Miur, disponibile sul sito , indicava la possibilità di scegliere
liberamente dove sedersi in piena contraddizione con il bando. Il video è stato
poi successivamente modificato a concorso concluso. Il rigore in ordine sparso
delle varie commissioni ha riguardato anche la possibilità di andare in bagno: a
Pisa e Pavia è stato consentito, a Firenze invece un candidato è stato costretto
a urinare nel cestino della carta. Le domande abbonate: nuovi interrogativi. Non
è la prima volta che il consorzio interuniversitario Cineca, incaricato di
somministrare i test nei concorsi, combina errori che impattano su vite e
carriere. Basti pensare al "famoso" concorso del 2012 per l'accesso ai TFA, i
tirocini formativi per l'abilitazione all'insegnamento, nel quale 25 domande su
60 furono annullate. Questa volta l'anomalia è avvenuta nella fase di
preparazione delle buste: le domande che avrebbero dovuto essere sottoposte ai
candidati per le scuole di area medica il 28 ottobre sono state invece
somministrate il 31 ottobre nella prova per l'area dei servizi clinici, e
viceversa. Il primo novembre il Miur annuncia con un comunicato stampa sul sito
che le prove in questione sono da ripetere. Due giorni dopo, al termine di una
riunione tra il ministro Stefania Giannini e la Commissione nazionale incaricata
di validare le domande dei quiz, sempre tramite nota stampa arriva il
contrordine: siccome l'inversione ha riguardato solo le 30 domande comuni a
ciascuna delle due aree, e non i 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di
scuola (cardiologia, necrologia, endocrinologia etc.), l'esito dei test si può
salvare "neutralizzando" le sole due domande per ciascuna area che sono state
giudicate non pertinenti dalla Commissione di esperti. In pratica a tutti i
candidati, a prescindere dalla maggiore o minore correttezza della risposta
fornita, viene assegnato per quelle domande il massimo punteggio. Da quel
momento, e dopo le dimissioni rassegnate dal presidente del Cineca Emilio
Ferrari, si chiude il sipario mediatico sulla vicenda. Adesso però, dai verbali
delle singole commissioni sparse per l'Italia, da quello della riunione del 3
novembre tra Miur e Commissione nazionale e da una perizia di parte del dottor
Gianluca Marella (docente a Tor Vergata e consulente tecnico della procura di
Roma) emergono elementi nuovi. Emerge chiaramente, ad esempio, come in diversi
casi gli stessi candidati abbiano riscontrato e segnalato ai commissari
l'inversione dei quiz già nel corso delle prove, che tuttavia non sono state
interrotte. Nel verbale della riunione di Roma del 3 novembre, inoltre, si legge
che "delle 30 domande contenute nella prova di area medica del 29 ottobre, 27
sono riconducibili ai 5 settori scientifici disciplinari comuni tra l'area
medica e quella dei servizi, 1 quesito è riferibile al settore scientifico
disciplinare della farmacologia". Tradotto: le domande non pertinenti all'area
medica, e quindi da abbonare, in base a quanto dichiarato dalla stessa
Commissione nazionale non sono due ma tre. Perché allora il quesito di
farmacologia non è stato abbonato? Non solo. Nel verbale del 3 novembre la
Commissione conclude che la scelta di invalidare le quattro domande di area non
influisce sulla validità complessiva dei test, perché le domande più importanti
- quelle relative alle scuole di specialità cui sono attribuiti il doppio dei
punti - non hanno determinato problematiche. Eppure, dopo la stesura dell'atto,
sulla base di un altro verbale, che conclude una riunione del 4 novembre cui
prendono parte solo il presidente della medesima Commissione nazionale e un
rappresentante della società Selexi, si provvederà ad abbonare altre due
domande: stavolta relative proprio ad altrettante scuole di specializzazione
(una di Cardiologia e un'altra di Endocrinolgia). Un totale di 6 quesiti
abbonati attraverso dei semplici verbali, senza l'intervento di un apposito
provvedimento ministeriale indispensabile - sostengono gli estensori dei ricorsi
- per modificare un bando di concorso approvato con decreto. Prove modificate
dall'interno. Alla scelta di abbonare le sei domande, accusano i legali dei
ricorrenti, è seguita una procedura inedita. Invece di limitarsi ad aggiungere
il punteggio delle domande in questione alla graduatoria finale, Cineca e Miur
sono entrati nei singoli compiti inserendo a livello informatico i codici
fiscali e hanno modificato dall'interno le risposte dei candidati, che non hanno
in questo modo neanche più la certezza di quali risposte abbiano fornito, visto
che le prove erano soltanto digitali. La decisione di intervenire sulle prove
già svolte è avvenuta dopo che i punteggi dei singoli candidati erano già
pubblici e le graduatorie già in mano al Cineca: cioè dopo che ad ogni compito
era stato dato un nome. E così, tra accessi non verbalizzati nei compiti e
interventi postumi sulle domande, lo scopo principale del nuovo concorso a
graduatoria nazionale, quello di garantire la segretezza e la trasparenza della
selezione e l'anonimato dei candidati, potrebbe essere stato compromesso.
Mancano i soldi. Davanti a questo nutrito elenco di contestazioni, l'Avvocatura
dello Stato ha messo le mani avanti. "Nella denegata ipotesi in cui i ricorsi
relativi al contenzioso venissero accolti", recita un documento redatto dal Miur
e da poco depositato davanti al Tar del Lazio, "una ammissione in sovrannumero
comporterebbe ripercussioni economiche considerevoli, in quanto imporrebbe allo
Stato il reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di
ulteriori contratti di formazione specialistica". "Anche l'ammissione di un solo
medico in più", prosegue minaccioso il documento, "comporterebbe l'onere di
reperire risorse aggiuntive da stanziare tramite appositi provvedimenti
legislativi (circa 125.000 euro in più per ogni specializzando)". Una mossa
legittima, anche se i giovani ricorrenti meriterebbero forse un giudizio -
decisivo per il loro futuro - capace di entrare nel merito delle irregolarità
denunciate senza fermarsi davanti allo spauracchio della spesa pubblica. Dal
Paese che li spinge in massa verso l'estero dopo anni di sacrifici sui libri,
meriterebbero maggiore considerazione e trasparenza.
Concorsi pubblici, tutti i casi sospetti. Il pasticciaccio delle scuole di specializzazione in medicina, per il quale i giovani medici manifestano a Roma, è l’ultimo episodio di un lungo elenco di irregolarità, favoritismi e trucchi. Dalla Farnesina alla Polizia penitenziaria nessuno è escluso. A partire dalle selezioni per insegnanti e ricercatori, scrive Michele Sasso su “L’Espresso”. Una manifestazione di specializzandi di medicina a Roma. Le prove, l’errore e il dietrofront. Dopo giorni di polemiche, il ministero dell’Istruzione cerca di mettere una pezza al pasticciaccio del concorsone per l’accesso alla scuole di specializzazione in medicina. Un test fondamentale per accedere alle oltre cinquemila borse di studio diventato tristemente famoso per l'annullamento che ha colpito più di 11mila candidati. Dopo avere rilevato una “grave anomalia” il ministro Stefania Giannini ci ripensa e annuncia: «Le prove per l’accesso del 29 e 31 ottobre non dovranno essere ripetute. Abbiamo trovato una soluzione che ci consente di salvare i test». Una pezza dopo l’annuncio di una valanga di ricorsi. Le dimissioni di Emilio Ferrari, il responsabile del Consorzio universitario che ha preparato il test di ingresso, non sono servite a stoppare la manifestazione davanti al Miur. In piazza i giovani medici che la settimana scorsa hanno partecipato alle selezioni. Non è la prima volta che un concorso pubblico finisce con una figuraccia e una protesta di piazza. Tra caos, ricorsi, graduatorie ritoccate e interventi della Magistratura non c’è settore della pubblica amministrazione immune all’aiutino. Il prestigioso posto di ambasciatore junior del ministero degli Esteri si è trasformato, secondo le critiche, in una corsia preferenziale per chi ha parentele famose. In ballo 35 posti per il gradino più basso della carriera alla Farnesina: la questione è finita con otto interrogazioni parlamentari e ombre pesanti sul ministero degli Esteri. Perfino alle prove per diventare poliziotti si scoprono bluff. Lo scorso maggio alla scuola di formazione della Polizia penitenziaria di Roma si aprono le porte ai concorrenti al concorso pubblico per 208 posti di agente. Test e prove attitudinali per andare a lavorare nelle carceri italiane. Durante gli scritti la commissione esaminatrice scopre tre aspiranti con in tasca le risposte esatte ai quiz di selezione. L’elenco delle valutazioni sballate, superficialità e grossolani errori per scegliere gli insegnanti della scuola italiana è lungo. Nel 2010 nel concorso per dirigente scolastico il Ministero mette online i temi delle prove e arrivano una valanga di segnalazioni. Tanti, troppi errori e un quiz su sei viene ritirato. Nonostante gli accorgimenti all‘apertura delle buste nei cento quiz c’erano ancora degli strafalcioni. Per i tirocini formativi attivi (Tfa) obbligatori per diventare insegnanti si replica con ancora quiz errati e si ottiene ammissione dei ricorrenti alle prove scritte. Per l’ultimo concorso a cattedra la Giannini è stata costretta a un decreto correttivo. «Ogni volta è la stessa storia», commenta Marcello Pacifico del sindacato Anief:«Non sono le dimissioni di un presidente ma la gestione delle prove selettive che non trova mai un responsabile. Non è possibile che proprio le domande e le risposte per accertare il merito contengano degli errori». Tra le maglie delle selezioni anche casi clamorosi di familismo amorale e concorsi truccati su misura. A Palermo la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex preside della facoltà di Medicina Giacomo De Leo e di Salvatore Novo, professore ordinario e direttore della scuola di specializzazione in Cardiologia dell'università locale insieme ad Alberto Balbarini, docente di malattie cardiovascolari a Pisa. Complici e menti (con l’accusa di truffa, soppressione di atto pubblico e falsità ideologica) di un presunto concorso truccato per un posto da ricercatore universitario nel loro dipartimento bandito nel lontano 2004. Il concorso, secondo gli inquirenti, venne truccato per consentire alla figlia di Novo, Giuseppina, l'aggiudicazione del posto. L'inchiesta parte da Bari, e indaga su una serie di concorsi truccati in diverse facoltà della Penisola. Secondo gli investigatori, ci sarebbe stato un vero e proprio accordo tra Novo e De Leo per far vincere il concorso alla figlia del cardiologo. A garantire il posto assegnato a tavolino doveva essere Mario Mariani, altro docente universitario di Pisa, nominato membro della commissione esaminatrice. All'ultimo momento, però, Mariani scopre di essere indagato dai pm baresi e fa un passo indietro. È allora che, secondo i magistrati, i due docenti distruggono il verbale con cui Mariani era stato designato commissario d'esame e lo sostituiscono con uno identico in cui mettono il nome di Balbarini. Quest'ultimo, vicino a Mariani, sarebbe stato al corrente di tutto. Dopo dieci anni la ricercatrice ha fatto carriera e oggi può vantare il titolo di docente alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia. L’ateneo? Quello di Palermo, naturalmente.
SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO.
Si stava meglio quando si stava peggio? Italia, declino inevitabile: dove andremo a finire?
A leggere i giornali od a seguire i Tele Giornali o i talk show in tv cerco di carpire qualche notizia che parli di me: di me cittadino. Cerco qualcuno che parli dei miei problemi.
La pagina politica parla delle solite promesse, dei soliti sprechi e dei soliti privilegi.
La pagina della giustizia parla dei soliti morti, dei soliti arresti e delle solite condanne, oltre che della solita mafia: una rassegna dei successi di magistrati e forze dell’ordine, insomma.
La pagina degli esteri parla delle solite guerre e dei soliti cattivi da eliminare.
La pagina finanziaria parla di default, tasse e soldi per lo Stato che non bastano mai e della ovvia evasione fiscale dei soliti ricchi.
Per lo spettacolo e lo sport la solita rassegna di pettegolezzi di star e starlette senza arte né parte.
A parer dei media sembra che la vita scorra monotona lungo questi binari, salvo qualche problema che, però, a parer dei lettori e telespettatori, appare colpire solo gli altri.
Ma non è così. A spulciare nelle notizie, c’è tutta una quotidianità di cui nessuno parla: la lotta alla sopravvivenza delle famiglie italiane nella assoluta solitudine e nel generale sottaciuto abbandono.
Chi ha qualche anno di vita, (chi troppi, chi pochi) ricorda che:
prima il potere era del popolo: oggi non più, il potere è delle mafie, delle caste, delle lobbies e delle massonerie deviate;
prima c’era meno illegalità, meno obblighi, meno sanzioni e c’erano meno leggi da rispettare, specie quelle a carattere emergenziale: oggi anche un giurista insigne pecca di ignoranza giuridica;
prima nel nome della legalità c’era meno illegalità ed iniquità: oggi l’ingiustizia abbonda e gli abusi di potere strabordano;
prima c’era più rispetto e credibilità negli anziani, nei magistrati e nelle istituzioni: oggi non ci sono più esempi degni da seguire e non abbiamo stima nemmeno per noi stessi;
prima pur con tangentopoli, c’era meno ladrocinio e le mafie non avevano invaso l’Italia: oggi la corruzione e l’abuso di potere è la normalità e la mafia è dappertutto;
prima l’usuraio era l’amico: oggi non più, usuraio è lo Stato o le banche;
prima si pagava un decimo di tributi rispetto ad oggi e si otteneva 10 volte tanto in termini di servizi;
prima nella disgrazia potevi parlare con il politico che votavi ed il minimo che succedeva era che ti ascoltava ed il favore lecito, spesso, ci scappava: oggi non è più così, perché i politici sono tutti degli emeriti sconosciuti e se ti rapporti con loro disattendono il loro mandato;
prima nell’errore speravi nella coscienza delle istituzioni e tutto si aggiustava secondo equità: oggi non è più così, perché più che il principiò di legalità vale l’interesse estremo a punire, per salvaguardia finanziaria del proprio status di sanzionatore;
prima c’era più Empatia, ci si metteva nei panni dell’altro, si condividevano sentimenti, emozioni e sofferenze: oggi non più, c’è più Dispatia, ovvero l'incapacità o il rifiuto di condividere i sentimenti o le sofferenze altrui, ovvero c’è più Alessitimia, ossia il disturbo specifico nelle funzioni affettive e simboliche che spesso rende sterile e incolore lo stile comunicativo delle persone;
prima nell’avversità c’era qualcuno che pubblicamente denunciava sui giornali la tua questione: oggi la notizia è omologata nella censura e se, al contrario, è resa pubblica, lo scandalo non produce effetti;
prima nell’avversità c’era una famiglia, spesso numerosa e con genitori pensionati, che ti sosteneva: oggi siamo soli nell’indifferenza, nell’indisponenza, nell’insofferenza e gli anziani non hanno più figli al capezzale ma solo badanti straniere;
prima si era più ricchi di affetti e di beni materiali: oggi amici non ne hai ed i parenti meglio non averli e se hai un bene materiale te lo toglie la criminalità o lo Stato;
prima nel bisogno il lavoro era tutelato e comunque si trovava, anche negli uffici di collocamento, o addirittura anche a nero o sottopagato: oggi non più assolutamente, nonostante i centri per l’impiego e le agenzie interinali;
prima a veder un clandestino era un’eccezione, oggi è la regola;
prima gli unici ad essere discriminati erano i meridionali: oggi si discrimina tutto e tutti e si uccide per questo (religione, razza, sesso, ideologia politica, tifo sportivo, gusti sessuali, ecc.);
prima si era più sinceri e diretti: oggi si è politicamente corretti, perbenisti e buonisti, ossia più demagoghi, utopistici, falsi e bugiardi;
prima nell’intraprendenza l’agricoltura, l’allevamento, la pesca, nonostante i disastri meteorologici, erano attività in cui si riusciva ad andare avanti: oggi le campagne sono abbandonate, troppi, cavilli, oneri e spese;
prima nel rischio le imprese, grandi o piccole, riuscivano a produrre reddito: oggi non più, perché sono vessate dallo Stato da controlli, oneri, cavilli e balzelli e tributi e comunque da questo Stato non tutelate dalla competitività estera, o taglieggiate dalla criminalità, o sequestrate e portate al fallimento dallo stesso Stato perché accusate di essere colluse con la criminalità, o, seppur operanti da decenni, chiuse ora perché inquinanti;
prima le professioni si potevano esercitare: oggi non più, perché hanno chiuso gli ospedali ed i tribunali ed impediscono di esercitare. Prendiamo per esempio la professione di avvocato. Hanno chiuso moltissimi tribunali. Hanno impedito la tutela legale per i sinistri stradali e le sanzioni amministrative. Settori utili per i neo professionisti. Non sono certo, però, diminuite, come promesso, le polizze assicurative. Hanno eliminato di fatto il gratuito patrocinio, con condanne inevitabili per gli indigenti, ed in generale il ricorso all’autorità giudiziaria, con il contributo unico unificato elevato. Tra Giudici onorari di Tribunale, Giudici di Pace, Conciliazione obbligatoria e Negoziazione assistita hanno eliminato quasi tutto il lavoro dei magistrati togati, impegnati come sono a fare esclusivamente politica, ma la lentezza della giustizia è rimasta. Hanno imposto ai giovani avvocati in tempo di crisi l’iscrizione alla Cassa Forense ed imposto in tempo di vacche magre l’esercizio della professione legale in maniera continuativa e prevalente. Ecco i punti fissati dal Governo:
a) la titolarità di una partita Iva;
b) l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in forma collettiva (associazione professionale, società professionale, associazione di studio con altri colleghi);
c) la trattazione di almeno 5 affari per ogni anno dei 3 presi in considerazione, anche se l’incarico è stato inizialmente conferito ad altro legale;
d) la titolarità di un indirizzo Pec comunicato al Consiglio dell’ordine;
e) l’avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo modalità e condizioni stabilite dal Cnf;
f)la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall’esercizio della professione;
g)la corresponsione dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’ordine;
h) il pagamento delle quote alla Cassa di previdenza forense.
Sig. direttore, lei, meglio di me, sa che prima si poteva criticare e protestare: oggi non più perché abbiamo un bavaglio. Tra la legge sulla privacy e lo spauracchio delle norme penali sulla diffamazione tutto ciò è impedito.
Oggi non puoi nemmeno recriminare con una imprecazione: “Italia di Merda” perchè segue una condanna certa.
Allora… si stava meglio quando si stava peggio? E dove andremo a finire? E comunque, per gli italiani perché non vale la teoria sull’evoluzione migliorativa naturale della specie?
Europa, i napoletani guadagnano meno dei polacchi. E in altre zone d'Italia non va meglio. Secondo i dati più recenti dell'istituto di statistica europeo il reddito medio in provincia di Napoli è ormai inferiore a quello medio della Polonia. Nei primi si ferma a 16.100 euro l'anno, mentre per i secondi è più alto di 300 euro, scrive Davide Mancino su “L’Espresso”. Se un amico di Napoli vi confida che vuole emigrare in Polonia, non chiedetegli se è diventato matto: per come vanno le cose l'idea potrebbe quasi avere senso. Secondo i dati dell' Istituto di statistica europeo , aggiornati al 2011, il reddito medio dei napoletani è ormai inferiore a quello dei polacchi. Nei primi si ferma a 16.100 euro l'anno, mentre per i secondi è più alto di 300 euro. L'area d'Europa con il PIL più alto è invece la parte occidentale di Londra, cuore finanziario della Gran Bretagna, dove la media supera i 150mila euro. Ma in Italia c'è chi è messo ancora peggio. Nella provincia di Medio Campidano, in Sardegna, il reddito è di 11.200 euro l'anno: poco meno che in Bulgaria. Seguono Caserta e Agrigento, intorno ai 13mila e qualche centinaio di euro in più rispetto a un abitante medio della Romania. Resta forte la divisione nord-sud, anche se in quest'ultimo spicca la provincia di Catanzaro che supera i 20mila euro l'anno – fatto praticamente unico nel meridione –, mentre al centro si distingue Rieti; chi vi abita ha in media un reddito più basso di quello dei vicini. Roma è un caso a parte. Essere il centro della burocrazia italiana, con il relativo carico di retribuzioni elevate, non può che portare a risultati maggiori: un elemento che in qualche misura sposta i redditi – ma non per forza quanto poi si produce davvero – verso l'alto. Al nord invece i milanesi hanno un reddito medio di 45.600 euro, quasi il doppio della media europea. Un valore senz'altro elevato, ma forse neppure troppo per quello che dovrebbe essere il centro della borghesia produttiva italiana. Senza neppure arrivare a Londra, in cui i tanti stranieri della City finanziaria renderebbero il confronto poco sensato, basta andare in Francia o in Germania – a Monaco, Parigi o Bonn – per trovare diverse aree in cui il reddito si aggira o supera i 60-70mila euro a persona. I dati non considerano solo quanto le persone producono, ma tengono in conto anche il diverso costo della vita. Affitti più alti e beni più economici, servizi a buon mercato o meno: tutti fattori che nella vita concreta contano almeno quanto lo stipendio che riceviamo. Si tratta del modo più accurato per capire qual è il reale tenore di vita delle persone in un regione piuttosto che in un'altra. Come succede di consueto quando si calcola il PIL, è inclusa anche una stima (più o meno accurata) dell'evasione fiscale. Eppure basta tornare qualche anno indietro per capire come i problemi italiani siano tutt'altro che nuovi. La crisi non ha fatto che pesare su un sistema già affaticato – in alcune zone più che in altre. Basilicata, Puglia e Calabria, per esempio, già prima della recessione del 2008 crescevano poco – meno dell'1% l'anno. Emilia Romagna, Marche e Lazio avevano invece un ritmo più elevato, intorno al 2%. Il motore pare inceppato da tempo: già intorno al 2002-2003 in diverse regioni il reddito ha fatto un salto indietro, per poi calare a picco dal 2008. In Molise la recessione ha fatto più danni: fino al 2011 l'economia è decresciuta in media del 2,9% l'anno; meno in Campania, con una caduta dell'1,8%. Seguono Calabria (-1,7%), Sicilia e Basilicata (-1,6%). Quando gli altri cadono – magra consolazione – anche restare fermi è un segnale positivo. È il caso di Lombardia e provincia di Bolzano, dove invece le cose sono rimaste stabili oppure la diminuzione è stata minima. Guardando a come vanno le cose provincia per provincia abbiamo un quadro più dettagliato, ma anche meno recente – per il momento i dati arrivano solo al 2011. Che napoletani e siciliani abbiano recuperato qualcosa, nel frattempo? L'unico modo per farsi un'idea è guardare a come sono andati i paesi nel loro complesso. Anche così, però, l'Italia resta quella che fa peggio. Non solo l'economia non recupera quanto aveva perso dall'inizio della recessione, ma continua a cadere ancora. Nel 2012 e 2013 la crescita media è stata molto negativa: la Spagna arretra ma meno, Francia e Germania crescono – molto poco – mentre nel Regno Unito va abbastanza meglio. Nulla di impressionante, certo, eppure nel regno dei ciechi l'orbo è re. Dunque è ancora vero che i napoletani guadagnano meno dei polacchi? Una cosa è certa: negli ultimi due anni questi ultimi sono andati avanti, mentre l'Italia è tornata ancora più indietro. Non solo il divario potrebbe essere rimasto, ma ci sono buone ragioni per pensare che sia aumentato. Chi più in fretta, chi trascinando i piedi, resta il fatto che diversi paesi stanno cominciando a uscire dalla crisi. Molti, ma non l'Italia. Chissà che l'amico napoletano non abbia tutti i torti.
Disoccupazione, i numeri fanno paura. Quella verità nascosta nelle statistiche. Fermarsi a leggere solo il dato generale di chi non ha un lavoro è un errore: i numeri in nostro possesso mostrano fenomeni meno noti, che interessano soprattutto donne e giovani. Mentre il titolo di studio sembra ancora l'unico antidoto al rimanere senza impiego. Naviga i nostri grafici interattivi, scrive Davide Mancino su “L’Espresso”. Una manifestazione del 2011 contro la disoccupazione giovanile Quando si parla di disoccupazione la cosa più semplice è elencare il solito numero - i soliti due numeri - e fermarsi lì. Sono quelli che sono stati ripetuti negli ultimi giorni: il tasso di disoccupazione generale è al 12,6 per cento, quello dei giovani fra 15 e 24 anni è al 43,3 per cento. Al crescere dell'età le cose migliorano, certo, ma restano tutt'altro che confortanti. Eppure la realtà è più complicata, e se si scava più a fondo nelle statistiche il quadro diventa forse ancora più buio: sicuramente più sfaccettato. Eurostat e Istat raccolgono informazioni sul lavoro anche a livello regionale, aggiornate al 2013; e sono dati che mostrano l'enorme differenza che esiste non solo fra paesi europei, ma anche all'interno degli stessi. Eppure, nel fare confronti fra paesi, i dati vanno guardati con prudenza. Il tasso di disoccupazione indica infatti quante sono le persone senza lavoro, ma solo fra quelle che un lavoro lo stanno cercando. Più di tre milioni, secondo le ultime stime: certo non un italiano su dieci o un giovane su due, come si sente dire ogni volta, ma comunque troppo. Il paragone naturale è con i vicini spagnoli. Ma proprio in Spagna, che nella mappa della disoccupazione risalta come una grande macchia rossa, secondo la Banca Mondiale la partecipazione al mercato del lavoro è più alta - in particolare per le donne e nelle aree più povere. In questi gruppi, ovvero, sono molti coloro che dichiarano di essere alla ricerca di un impiego. In Italia vale l'opposto: sono meno le persone che risultano alla ricerca di un lavoro e questo spinge il dato della disoccupazione verso il basso. D'altra parte in Italia e Spagna il numero di persone effettivamente occupate, rispetto al totale della popolazione, è più o meno lo stesso. Dunque la differenza, tutto sommato, è molto minore di quello che sembra. Non è il solo caso. In generale, prima di fare paragoni, bisogna fare attenzione a quei paesi in cui, per esempio, donne e giovani tendono a partecipare di più al mercato del lavoro. È il caso di Germania, Francia e - appunto - della stessa Spagna. Questo però non vuol dire che la situazione sia grave ovunque allo stesso modo; al contrario. Proprio in Italia considerare solo il tasso di disoccupazione generale nasconde le situazioni più diverse: soprattutto in alcune province, soprattutto per i giovani - e ancora di più per le donne. Tutti casi in cui la realtà è molto più difficile di quello che sembra. Prendiamo tre persone diverse: Luca, 40 anni, di Milano; Giulia, una trentenne romana; Sofia, appena diplomata a Napoli. Il primo è riuscito a trovare lavoro, e come lui diversi amici e amiche: a Milano essere uomo o donna non fa grande differenza. Giulia salta da un breve impiego all'altro, ma con la crisi le cose sono diventate più complicate. Trovare un nuovo lavoro è difficile, e non solo per lei: a Roma succede lo stesso a una donna su sei nelle sue condizioni. Sofia invece vorrebbe cominciare a lavorare subito dopo aver finito la scuola, ma non può. A Napoli per andare avanti ci vuole fortuna e bravura - o entrambe - quando tre ragazze su cinque come lei, pur cercandolo, un lavoro non lo trovano. Altrimenti la soluzione è la solita: emigrare. Anche qui però bisogna fare attenzione: fra i 15 e i 24 anni molti ragazzi studiano ancora, quindi non cercano lavoro né sono - tecnicamente - disoccupati. Un gruppo che rientra nella categoria degli “inattivi”, come li chiama l'Istat, composto da poco meno di quattro milioni e mezzo di persone. Il problema vero riguarda invece 685mila giovani di quell'età che, usciti da scuola, un lavoro lo vorrebbero ma non ce l'hanno. I dati smentiscono anche un altro luogo comune: che studiare non serve. Di nuovo, è vero l'opposto. Le persone con titoli di studio più elevati sono quelle meno esposte alle disoccupazione, e questo vale sia per gli uomini che per le donne. Una differenza che - soprattutto al sud - è enorme: le laureate calabresi, per esempio, hanno un tasso di disoccupazione di 8 punti percentuali più basso delle diplomate, mentre le campane arrivano a 10. Per gli uomini è lo stesso, basta guardare la differenza fra laureati e diplomati siciliani: fra questi ultimi, ai tempi della crisi, il tasso di disoccupazione è doppio. Altro che perdita di tempo: uno degli antidoti alla crisi, se mai ce ne fosse uno, sembra proprio lo studio.
USURA BANCARIA: I MAGISTRATI STANNO CON LE BANCHE.
Magistrati coraggiosi contro le banche cercasi, scrive Enzo Di Frenna su “Il Fatto Quotidiano”. C’è qualcosa di legale in questo meccanismo? A novembre 2011 il presidente della Banca centrale europea, l’italiano Mario Draghi, incontra i vertici di alcune grandi banche – tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays Capital– e dopo qualche settimana annuncia prestiti fino a tre anni per le banche europee con l’obiettivo di “ridare fiato all’economia” ed evitare il “credit crunch”, cioè la chiusura dei rubinetti monetari alle piccole e medie imprese. I soldi, in pratica, sono regalati (tasso 1%). Non si ha notizia che Draghi abbia fatto firmare alle banche un contratto che le costringesse ad usare quel denaro per sostenere gli imprenditori. Insomma, una roba del tipo: se li usi per speculare, il tasso passa al 15% e paghi anche una penale. È una soluzione elementare, non ci vuole una laurea in economia per usare una tale precauzione. Invece, cosa succede? Le banche succhiano un torrente di denaro alla Bce – cioè soldi dei cittadini europei – e li usano per speculare e acquistare titoli di Stato, sui cui guadagnano somme elevate. Ecco cosa è accaduto in Italia. Il 21 dicembre 2011 la Bce di Draghi mette a disposizione delle banche italiane 116 miliardi di euro lordi, ma – attenzione – l’incasso netto è intorno ai 60 miliardi. Nell’ultimo bollettino della Banca d’Italia si scopre che tra dicembre 2011 e gennaio 2012 le banche hanno speso 28 miliardi di euro per acquistare BTP e altri titoli: in soli trenta giorni la loro quota complessiva è passata da 209 a 237 miliardi. Altri 41 miliardi li hanno spesi per acquistare bond e il totale arriva a 69 miliardi di euro. Quindi hanno usato i soldi per speculare e arricchirsi, invece che “ridare fiato all’economia” e aiutare le imprese. Tra febbraio e marzo 2012 si suicidano diversi imprenditori, anche con metodi violenti come darsi alle fiamme. Poi scopriamo che 12 mila aziende hanno chiuso nell’ultimo anno e 50 mila lavoratori sono stati licenziati. Emergono storie di imprenditori a cui le banche hanno chiuso i rubinetti del credito. Michele Santoro a Servizio pubblico, la scorsa settimana ha intervistato Maria Teresa Carlucci, la moglie di un imprenditore suicida a cui la banca ha rifiutato un prestito di 500 euro. Posso aggiungervi che anche un paio di amici – titolari di piccole attività commerciali – mi hanno riferito che sono in gravi difficoltà a cause della stretta creditizia applicata improvvisamente dalle loro banche. Ecco invece un commento copiato dal mio profilo Facebook: “Vedo che la gente è spaventata, che tante attività chiudono o che stanno per chiudere. Negozi chiusi da tanti mesi che nessuno prende in affitto perché avviare qualsiasi attività è troppo rischioso. Sono molto preoccupata per il futuro. Tanto tanto preoccupata. Non capisco perché la crisi la devono risolvere le classi meno abbienti» (Antonella). Quindi abbiamo la seguente situazione: la Bce ha fallito il suo obiettivo. Le imprese sono strangolate nel “credit crunch” e altri padri di famiglia potrebbero decidere di uccidersi. Ci sono i presupposti per avviare un’inchiesta giudiziaria? Si possono sequestrare i contratti che Mario Draghi ha firmato con le banche italiane? Possiamo conoscere i nomi degli amministratori delegati di quelle banche che hanno preso i soldi della Bce per comprare titoli e speculare? Mi rivolgo dunque alla magistratura. E chiedo ad Antonio Di Pietro, ex magistrato, di farsi portavoce di questa istanza presso la categoria che ha rappresentato negli anni di Mani Pulite. È possibile trovare magistrati coraggiosi che possano indagare su questo meccanismo e – se saltano fuori le prove di illegalità – far scattare le manette a chi usa il denaro in modo così spregiudicato? È’ possibile vedere in galera qualche banchiere senza scrupoli, che non arrossisce neppure quando nega un prestito di 500 euro a un padre di famiglia e anzi – cosa atroce – usa gli spiccioli per fare profittto con manovre speculative? Avete presente Callisto Tanzi dimagrito e col sondino al naso? Avete presente il suo pentimento in tribunale per aver causato sofferenze ai suoi clienti truffati? «Non mi rendevo conto dell’esaltazione…», ha detto. Ecco, vorrei vedere decine banchieri in galera e poi cospargersi il capo di cenere per aver causato così tanta sofferenza. Vorrei vederli pentiti per l’ubriacatura finanziaria e rinchiusi al sicuro dietro le sbarre. I giornalisti con la schiena dritta hanno fatto il loro dovere denunciando queste anomalie. Ora tocca ai magistrati.
Il seguito è cosa scontata. Trasmettiamo di seguito un esposto del commerciante di Nardò, Luigi Stifanelli, sull'assoluzione di Luigi De Magistris e pubblicata su Agenparl.it.
"Luigi De Magistris è stato assolto perché il fatto non sussiste: è la sentenza del Tribunale di Salerno nel processo per omissione in atti d'ufficio all'eurodeputato, per fatti risalenti a quando era ancora magistrato. ''Era un'accusa ingiusta e infamante - ha commentato De Magistris - ma sono stato assolto difendendomi nel processo e non dal processo, senza usare l'immunità parlamentare nè il legittimo impedimento''. Per il leader dell'Idv Antonio Di Pietro ''giustizia è stata fatta''. Questa nota dell’Ansa tace la circostanza che il Giudice che ha assolto De Magistris è la Dr.ssa Maria Teresa Belmonte, moglie dell’avv. Giocondo Santoro, fratello del Santoro famoso conduttore di Annozero. Questo Giudice costituisce il simbolo della imparzialità quando deve giudicare De Magistris. Con tale Giudice il De Magistris ha fatto certamente un grande sforzo a difendersi “nel processo”!!! E’ notoria l’attività di sponsorizzazione dell’europarlamentare dell’Idv De Magistris da parte del Santoro televisivo su di una televisione pubblica. Nessuno ha prove per dire che la decisione dell’assoluzione sia stata presa davanti al focolare dei coniugi Santoro-Belmonte allargato al noto conduttore di Annozero; è innegabile, però è che il Santoro televisivo cognato della Belmonte è il padrino dell’europarlamentare. Ciò che è certo è che la sentenza, così come formulata, getta un’ombra lugubre sulla Giustizia, quella vera. Luigi De Magistris era imputato di un grave delitto. Egli, secondo l’accusa, “...indebitamente rifiutava di compiere un atto del suo ufficio..." quando era sostituto procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro ed aveva omesso di “procedere alle indagini ordinate…dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro” in un “procedimento…a carico dei magistrati di Potenza IANUARIO ROBERTA e IANNUZZI ALBERTO”, che si era aperto a loro carico su denuncia del sottoscritto per ipotesi delittuose di “associazione per delinquere, favoreggiamento, falsità, concorso in estorsione ed usura” a carico di “alcuni magistrati di Lecce e di Potenza”. Nel fascicolo del Giudice certamente ci sarà stata l’ordinanza del GIP di Catanzaro che ordinava al De Magistris P.M. di proseguire le indagini nei confronti di altri magistrati di Potenza e di Lecce. Nel fascicolo del Giudice certamente vi è carenza assoluta delle indagini svolte dal De Magistris. Ci si attendeva nella ipotesi più rosea per l’europarlamentare l’assoluzione con la formula che il fatto che un P.M si rifuti di eseguire un ordine del GIP non costituisca reato; invece, l’assoluzione è stata con la formula più ampia, cioè, che il fatto non sussiste, che sta a significare che non vi è stato mai ordine di alcun GIP. Invece, l’ordine del GIP rivolto al De Magistris di proseguire le indagini era ben preciso. L’assoluzione perchè il fatto non sussiste può significare anche che il De Magistris abbia compiuto uno straccio d’indagine; invece, no; è proprio egli stesso che sul suo blog ha scritto di essersi considerato il “dominus” e di non aver inteso indagare per non fare spendere denaro. Dunque, la sentenza che ha assolto il De Magistris è smaccatamente falsa. Ciò che colpisce in questo processo è la rapidità con cui si è concluso; certamente, era necessario sgomberare le ombre sul candidato sindaco di Napoli: tre udienze velocissime a distanza di pochi giorni l’una dall’altra; con la scelta mirata del giorno dell’udienza in cui vi era lo sciopero degli avvocati, e, quindi, svolta in assenza del difensore della parte civile. Ammirevole la velocità con cui il Giudice Belmonte ha concluso questo processo; sarebbe interessante sapere se questa velocità nel concludere il processo De Magistris, abbia penalizzato qualche altro imputato vero innocente, che attende prima di lui da anni la conclusione del suo processo. Eppure il reato ascritto al De Magistris riguarda il suo rifiuto di indagare, all’epoca in cui egli era P.M. a Catanzaro, sulle sistematiche archiviazioni da parte di magistrati di Lecce di procedimenti penali a carico di soggetti bancari che praticavano e praticano tuttora usura ed estorsione. Altro lato oscuro della vicenda è il fatto che non siano stati escussi i testi che avevo proposto al mio difensore, l’avv. Licia Polizio; infatti, avevo proposto come “testi i soggetti menzionati nell’opposizione alla richiesta di archiviazione”, che avrebbero dovuto riferire su sistematiche archiviazioni facili da parte di magistrati di Lecce nei confronti di banche che operano usura ed estorsione e, precisamente i seguenti soggetti: l’On. Nichi Vendola, il sig. Franco Carignani, l’Avv. Fedele Rigliaco, Il giornalista de "Il Mondo" che scrisse l’articolo dal titolo "Com'è stretta la Puglia" il12 giugno 1998 N. 24, l’ex Ministro della Giustizia, on. Diliberto, il Giudice di Lecce Dr. Pietro Baffa, l’ex P.M. Dr. Aldo Petrucci, il presidente dello SNARP, sindacato nazionale antiusura, dell’anno 1999, il Giudice Dr. Gaeta di Lecce, l’ex Gip Dr. Francesco Manzo, l’ex Gip Dr. Fersini il consulente del P.M. di Lecce, Dr. Daniele Garzia, che dovrà riferire sulla seguente circostanza: la tabella dove erano indicati i tassi praticati allo Stifanelli da parte della banca erano abbondantemente superiore a quelli consentiti dalla legge il Dr. Leonardo Rinella che è stato P.M. presso la Procura di Bari, il quale aveva accertato, per il tramite del suo consulente, che la banca aveva praticato ad un cliente interessi passivi su saldi attivi; il consulente della Procura di Bari, Dr. Egizio De Tullio, il quale aveva accertato che la banca aveva praticato ad un cliente interessi passivi su saldi attivi. Altro lato oscuro della vicenda è il fatto che non siano stati acquisiti dal Giudice del dibattimento alcuni fascicoli che avevo proposto al mio difensore come richieste istruttorie. Così, infatti, scrivevo al mio difensore avv. Licia Polizio: “E’ necessario chiedere al Giudice del dibattimento l’acquisizione di alcuni fascicoli che dimostrano l’attività di “protezione dell’usura nel Salento” da parte di alcuni magistrati e che sono raccolti tutti nel Dossier a firma del Sig. Franco Carignani: 3445/94 rgnr. Tribunale di Lecce, n. 8133/ 95 RGNR del Tribunale di Lecce (Capoti), n.15950/97 RGNR del Tribunale di Bari (Bisconti - Durante), n. 2011/G/96 Presso la Direzione Nazionale Antimafia, n. 508/97 RGNR del Tribunale di Lecce, n. 1885/96/21 RGNR del Tribunale di Bari, n. 800/96/21/96/21 RGNR del Tribunale di Bari, n. 6647/97/21 RGNR del Tribunale di Bari, n. 3926/96/21 RGNR del Tribunale di Bari, n. 9725/97/21 RGNR del Tribunale di Bari, n. 19797/97/21 RGNR”. Eppure il reato ascritto al De Magistris riguarda il rifiuto di indagare sulle altrettante sistematiche archiviazioni da parte di magistrati di Potenza di procedimenti penali a carico di quei magistrati di Lecce che consentono tali “facili” archiviazioni. La carenza delle suindicate indagini ha consentito ad alcuni magistrati criminali di Potenza e di Lecce di crearsi l’usbergo della immunità e, così, proseguire con la loro opera delinquenziale di copertura di gravi reati, come l’estorsione, il favoreggiamento, l’usura, la falsità, di Banche, di società di riscossione dei tributi e di personaggi importanti. Insomma, per De Magistris e per il Giudice cognato del Santoro di Annozero tutto questo è cosa da nulla; che i magistrati di Lecce o di Potenza consentano ad estortori o usurai bancari o ad esattori delle tasse usurai a proseguire nella loro attività criminale con conseguente distruzione di molte imprese, di molte famiglie e dell’economia salentina è una cosa di poco conto. Oggi, affrancato dal peso dell’accusa, il De Magistris - che aveva il dovere d’indagare e d’impedire la prosecuzione di questi reati - si appresta con estremo candore a governare la città di Napoli massacrata dall’usura bancaria. Con la sentenza della “Giudicessa” cognata del Santoro televisivo alcuni magistrati di Lecce possono proseguire impunemente a favorire l’usura e l’estorsione delle Banche e dell’esattore delle tasse in danno dei salentini; tali magistrati sanno che troveranno, prima o poi, una Dr.ssa Belmonte che scriverà una sentenza perché “il fatto non sussiste”. Eppure le archiviazioni di procedimenti penali a carico di soggetti che, con minacce di pregiudizi, riuscirono ad estorcere del denaro crearono disagio, malessere e sconcerto nella popolazione salentina. In particolar modo furono gl’imprenditori che esternarono - con esposti a tutte le Autorità ed a tutte le Istituzioni dello Stato, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Commissione antimafia, alle Cariche istituzionali più importanti dello Stato - il disagio per la mancata tutela penale della proprietà; nell’immaginario collettivo si ebbe a formare l’idea di una sorta di sodalizio fra magistrati, banchieri ed altri soggetti. A seguito di ciò in data 24/09/’98 l’on. Nichi Vendola, all’epoca vice-presidente della Commissione antimafia, ora Governatore della Puglia, pose il dito su questa piaga del Salento; e, con atto di sindacato ispettivo n. 4/19855 sollevò questioni riguardanti le numerose e facili archiviazioni da parte della Procura della Repubblica di Lecce dei procedimenti penali “per i reati di estorsione, usura, truffa ed altro commessi da rappresentanti delle banche a danno di imprenditori Salentini” per sapere come mai molti salentini non avevano avuto la tutela penale, nonostante che i magistrati della Procura di Lecce avessero constatato l’applicazione di alti tassi d’interesse da parte di Banche; la vicenda ebbe vasto clamore, scaturito dalla divulgazione delle notizie attraverso la stampa. Nel succitato atto l’onorevole interrogante faceva riferimento ad un articolo comparso sul settimanale “Il Mondo” del 12 giugno 1998, n. 49 che dettagliava numerosi casi di archiviazioni di procedimenti penali. Quell’interrogazione venne archiviata perché il Ministro della Giustizia dell’epoca, on. Diliberto, ebbe a fornire una risposta contenente notizie false che gli furono fornite dalle articolazioni ministeriali competenti. L'On.le Consiglio Superiore della Magistratura con le circolari nn° 8160/82 e 7600/85, 4° commissione, e con la delibera del plenum dell'11 dicembre 1996 ha esplicitato che "l'esigenza generale, consistente nella tutela dell'imparzialità e della libertà da condizionamenti che devono connotare anche nell'apparire, l'attività giudiziaria, si pone quale specificazione del principio di tutela del prestigio della Magistratura inteso come apprezzamento sociale della corretta amministrazione della Giustizia". Secondo la Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza del 03 aprile 1988, n. 2265 "La responsabilità disciplinare del Magistrato, per comportamento pregiudizievole al prestigio suo e dell'Ordine Giudiziario, può conseguire anche da atti non illegittimi, ma meramente inopportuni od avventati”. Questo esposto pubblico è rivolto alle autorità in indirizzo per quanto di loro competenza, in particolare al Presidente della Repubblica, per valutare se vi sono gli elementi per promuovere procedimento disciplinare nei confronti della Dr.ssa Belmonte se per accelerare il procedimento a carico del De Magistris abbia trascurato qualche altro procedimento che aveva delle priorità o per valutare se la decisione di assolvere il De Magistris con la formula “perché il fatto non sussiste” sia stata avventata in presenza di un’ordinanza ineseguita di un GIP."
Usura, un imprenditore accusa: «Ora a Milano i giudici stanno con le banche». Da qualche mese il Tribunale del capoluogo lombardo, dove hanno sede legale parecchi istituti di credito, ha iniziato a respingere le cause di usura bancaria. Motivando così la scelta: le perizie tecniche devono essere svolte secondo i criteri fissati dalla Banca d'Italia. I cui azionisti, però, sono gli stessi istituti, scrive Stefano Vergine “L’Espresso”. «Grazie all’azione di lobbying, le banche hanno fatto breccia nel Tribunale di Milano. Da qualche mese i giudici della corte lombarda stanno infatti rigettando le cause per usura che imprese come le mie stanno continuando a proporre, e questo è paradossale considerando che invece nel resto d’Italia le ragioni dei consumatori continuano a prevalere». A parlare è G.P., un imprenditore del settore immobiliare, titolare di due società e amministratore di altrettante imprese. Preferisce non rivelare il suo nome perché - dice – «ho ancora diverse cause in corso e questa intervista potrebbe danneggiarmi». Il suo è però un attacco diretto. Contro le banche, accusate di applicare tassi d’usura all’insaputa di imprese e cittadini. E contro l’orientamento prevalente nel Tribunale di Milano che, spiega l’imprenditore, «ultimamente ha iniziato ad accettare acriticamente la posizione sostenuta dagli istituti di credito». Sul tavolo c’è una questione spinosa come quella dell’usura. Non quella applicata dalla criminalità organizzata, ma l’usura bancaria. Un fenomeno difficile da quantificare con precisione. Le uniche cifre sono quella della Fondazione SDL, un centro studi basato a Brescia, di cui fanno parte avvocati, commercialisti e imprenditori come G.P. Analizzando circa 150 mila prodotti bancari, SDL dice di aver rilevato nel 71 per cento dei casi la presenza di usura oggettiva ai sensi del codice penale. E sulle 19 mila pratiche giudiziarie intentate finora contro le banche, afferma di aver ottenuto per i propri clienti, quasi sempre tramite transazioni, diverse decine di milioni di euro. «Tutte queste vittorie hanno costretto le banche a reagire», sostiene G.P., convinto che ora «la loro attività di lobbying abbia attecchito al Tribunale di Milano».
G.P., ci racconti in breve la sua storia personale.
«Nel 2012, grazie ad un amico che fa il perito per le banche, ho scoperto che sui conti correnti e sui mutui delle mie aziende venivano praticati tassi d’usura. Mi sono allora rivolto alla studio legale SDL, del professor Serafino Di Loreto, il quale mi ha spiegato come, in base alla legge 108 del 1996, mi veniva effettivamente praticata usura».
Ha fatto causa alle banche?
«Sì, ho fatto una decina di cause. Ovviamente per recuperare quanto pagato ingiustamente, ma anche per un senso di responsabilità civile: riflettendo su quanto mi stava accadendo, ho capito che dovevo farlo per non lasciare ai miei figli una società in cui la classe dirigente, in questo caso quella bancaria, esercita usura sulla piccola e media impresa e sulle famiglie».
Alla fine le cause le ha vinte?
«La prima l’ho vinta, a Milano: nel conto corrente di una mia azienda la perizia disposta dal tribunale ha rilevato usura penale per 50 mila euro. Le altre cause sono ancora in corso».
E cosa c’entra il Tribunale di Milano allora?
«Al Tribunale di Milano l’orientamento predominante è pro-banche, e questo è particolarmente importante visto che gran parte degli istituti ha la propria sede legale proprio nel capoluogo lombardo».
In che cosa consiste questo orientamento pro-banche di cui parla?
«Le cause per usura bancaria a Milano incontrano resistenze molto maggiori rispetto al resto d’Italia. Questo lo dico perché, da collaboratore di una fondazione che si occupa a livello nazionale di difendere i consumatori dall’usura bancaria (la fondazione SDL, ndr), ho avuto modo di notare la differenza di trattamento che ultimamente Milano sta riservando alle banche».
Concretamente, in che cosa consiste questo trattamento privilegiato?
«Tutto si gioca sulle perizie che il tribunale dispone per analizzare i conti correnti e ravvisare se vi è stata o meno usura. Nel resto d’Italia prevalgono le indicazioni di redigere la perizia sulla base dei criteri della legge 108 del 1996 e delle successive conferme della Cassazione. A Milano, invece, la linea predominante è quella di analizzare i conti correnti non sulla base della legge dello Stato, ma seguendo le istruzioni secondarie della Banca d’Italia».
E qual è il problema?
«Il problema è che le istruzioni della Banca d’Italia sono decisamente più vantaggiose per gli istituti. E non è un caso, visto che gli azionisti della Banca d’Italia sono le stesse banche. E’ un po’ come se, dopo un incidente d’auto provocato dallo scoppio di una gomma, il perito valutasse le cause dell’incidente seguendo le indicazioni della ditta costruttrice di pneumatici e non quelle previste dalla legge».
Lei però ha detto che a Milano una causa l’ha vinta, in realtà.
«Sì, è vero. L’ho vinta perché la banca aveva talmente esagerato che, nonostante siano stati applicati i criteri favorevoli della Banca d’Italia, il conto corrente è risultato essere comunque in usura».
Quindi alla fine le imprese che fanno causa alle banche continuano a vincere anche a Milano?
«La gravità della situazione è proprio questa. Ultimamente, sia personalmente che alla Fondazione SDL, risulta che l’orientamento prevalente del Tribunale di Milano sia quello di rigettare le cause per usura se la perizia con la quale si presenta il caso non è redatta sulla base delle istruzioni della Banca d’Italia. Questo mi sembra gravissimo perché le istruzioni di una società privata, seppur autorevole come la Banca d’Italia, disattendono diverse sentenze della Cassazione. Mi pare inoltre molto grave precludere la via del contenzioso a tutte quelle aziende piccole e medie che non hanno la forza economica per ricorrere in appello e cassazione, dove invece potrebbero ottenere ragione».
Adesso cosa farà?
«Continuerò a seguire le mie cause, che fortunatamente sono state presentate prima di questa ulteriore virata pro-banche del Tribunale di Milano. Di certo se subirò delle sentenze ingiuste ricorrerò, con il mio avvocato Biagio Riccio, in appello e in Cassazione, perché sono sicuro che alla fine otterrò giustizia. Al di là delle questioni personali, però, vorrei che questa intervista desse origine a un dibattito, aperto a tutte le parti in causa, perché sulla questione dell’usura bancaria e più in generale del credito alle imprese si gioca la ripresa italiana e il futuro dei nostri figli».
Banche, tassi usurai alle aziende. Una società di consulenza bresciana ha scoperto che i tassi applicati sui prestiti si sono alzati, al limite dello strozzinaggio. Ma pochi imprenditori denunciano e l'ABI e la Banca d'Italia non controllano. Cronaca di una nuova, pericolosa deriva, scrive Massimiliano Carbonaro su “L’Espresso”. Anche le banche, in Italia, prestano 'a strozzo', attraverso meccanismi complessi nel rilascio dei finanziamenti a favore delle imprese. Sono molti gli istituti di credito coinvolti in questa nuova e pericolosa deriva. Sul fenomeno non esistono cifre complessive esatte, così come non si conosce la quantità di questi prestiti a tassi usurai. Questo perché, nelle occasioni in cui finora il problema è emerso in sede giudiziale, le stesse banche attraverso accordi di conciliazione sono riuscite a non far diventare pubblica la questione. La stessa Banca di Italia, pur ammettendo di non avere il polso complessivo della situazione, ha annunciato che deve rivedere il sistema di rilevazione dei tassi bancari. Come è noto, il grosso del tessuto imprenditoriale italiano è fatto da piccole e medie imprese che non sono strutturate per affrontare problematiche di natura finanziaria. Solo quando i costi di gestione dei loro conti correnti diventano particolarmente alti, gli imprenditori cominciano a porsi domande: così i titolari delle aziende hanno cominciato a rivolgersi a consulenti esterni per cercare di capirci di più. Tra queste società di consulenza c'è la bresciana SDL Centro Studi. Si tratta di una società con una trentina di dipendenti, unica rispetto al panorama delle concorrenti perché offre gratuitamente il primo screening sui conti. Negli ultimi due anni e mezzo ha esaminato oltre 29mila conti correnti intestati ad aziende, scoprendo che il 90% è afflitto da questo problema. Tutto è cominciato nel 2010 quando l'avvocato bresciano Serafino di Loreto è stato coinvolto nel fallimento della società di un amico che per la disperazione si è tolto la vita. A una attenta analisi della situazione societaria della ditta fallita è emerso che i conti erano infettati da usura e soprattutto che la somma degli interessi non dovuti estorti dalle banche l'avrebbe salvata dal fallimento. Questa scoperta ha spinto Di Loreto a creare una società in grado di scandagliare in maniera rapida la situazione finanziaria di un'impresa evidenziandone le anomalie. L'accertamento della SDL sui conti aziendali procede secondo vari step. In primo luogo si verifica se il tasso applicato è inferiore o meno al tasso oltre il quale siamo davanti all'usura. Ogni tre mesi Banca di Italia segnala i tassi effettivi medi rilevati e segnala i tassi 'soglia' su base annua per ogni categoria di operazione e per differenti range di importo oltre cui si verifica l'usura. L'altro fronte su cui lavora la SDL riguarda l'anatocismo, ovvero l'applicazione di interessi sugli interessi maturati che fanno crescere esponenzialmente il debito. «Il risultato degli accertamenti è per molti versi inaspettato. Tendenzialmente non sei portato a credere che una banca possa fare una cosa simile» commenta l'avvocato Di Loreto, responsabile legale della SDL «ma la cosa impressionante è che in pratica sono coinvolte tutte le banche italiane. Si stanno accanendo sulle nostre aziende, infliggendo costi ben superiori a quanto dovuto». Nel dettaglio la SDL è entrata dentro le carte di 9845 imprese, prevalentemente dislocate tra il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e la Toscana: il 90% dei conti presentava usura e anatocismo. Secondo i calcoli, poi certificati da commercialisti esterni, quello che le banche non avevano diritto a percepire oscilla tra il 30% e il 70% di quanto prelevato dai conti: si varia molto in base agli istituti di credito e alle tipologie di conto. Non sono solo i conti correnti delle imprese ad essere attaccati: ciò che emerge è un sistema perverso in cui le banche colpiscono gli imprenditori stessi rivalendosi sul loro patrimonio con l'intento di riuscire a rientrare dei debiti contratti per portare avanti l'attività dell'azienda: spesso, però, una parte di questi è frutto di interessi illegittimi. Il quadro del fenomeno fatica a venir fuori perché quando un imprenditore si ribella, utilizzando le perizie fornite da Di Loreto, e cita la banca in tribunale, l'istituto di credito preferisce arrivare a una transazione amichevole e soprattutto segreta. E' molto chiaro in tal senso l'accordo raggiunto tra un'azienda bresciana cui SDL ha fatto da consulente e una banca (non si può rendere noto il nome dei soggetti coinvolti altrimenti l'intesa potrebbe saltare) in cui l'istituto di credito ha preferito rinunciare a 350 mila euro dei 650mila concessi come prestito all'azienda. Questo dopo che era intervenuta una sentenza relativa ad un decreto ingiuntivo in cui il giudice rilevava che 42mila euro di debiti dell'impresa con la banca erano frutto di usura e anatocismo. Secondo il panorama delle conciliazioni esaminate, nessun gruppo creditizio italiano sembra sfuggire a questa strategia. C.C., un imprenditore del milanese attivo nel settore dei servizi che preferisce rimanere anonimo, si è sentito dire da un direttore di banca: «Non siamo un ente di beneficenza». «Sono furente» commenta l'imprenditore «non solo per i soldi che mi hanno rubato, ma anche i mancati investimenti e la perdita di competitività in campo internazionale». L'analisi finanziaria dei suoi conti ha evidenziato una richiesta di interessi non dovuti per 200mila euro. «Fino a un anno fa, spiega Di Loreto, si trattava esclusivamente di un recupero crediti legittimo. Ora invece stiamo assistendo da parte delle banche a una vera caccia alle imprese per far rientrare a tutti i costi e in tempi rapidi i clienti dei crediti concessi». Uno scenario per G.P., un imprenditore edile che con il suo gruppo di società detiene un patrimonio di immobili da circa 30 milioni di euro, definisce drammatico: «Sono 40 anni» spiega «che lavoro con le banche, ma in una situazione simile non mi ero mai trovato. Tra l'altro questo attacco indiscriminato alle imprese farà sì che quando ci sarà la ripresa rimarremo bloccati. Il tessuto di piccole e medie aziende che sostengono l'economia italiana nel frattempo sarà stato distrutto». Manco a dirlo, l'analisi finanziaria dei suoi conti ha evidenziato crediti estorti dalle banche per 1,5 milioni di euro. L'aspetto più assurdo della vicenda è che gli istituti procedono pressoché impuniti e che l'Abi (Associazione bancaria italiana) non rilascia alcuna dichiarazione. Il motivo? Non sono tenuti a esercitare il controllo sui loro soci. Banca d'Italia, che invece questo controllo lo dovrebbe effettuare, sottolinea come «le numerose denunce per usura siano basate sull'impiego di criteri di calcolo difformi». A questo però aggiunge che «sta rivedendo le istruzioni in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali». Insomma, la situazione sembra priva di reale controllo.
I magistrati indagano i banchieri, poi ci vanno pure a scuola, scrive “Alètheia”. E pensare che ci stupivamo della telefonata fatta dal ministro della giustizia Cancellieri alla famiglia Ligresti. Le banche, tramite l’Abi (Associazione bancaria italiana), hanno sempre cercato di condizionare la giustizia, con protocolli di intesa (novembre 2006) con il Ministero della giustizia per progetti di formazione destinato a magistrati, cancellieri, ed altri operatori del settore giudiziario, per favorire la conoscenza e l’adozione degli strumenti del processo civile telematico, contribuire allo scambio di informazioni e best practice tra gli addetti ai lavori e agevolare la costruzione di una cultura italiana sulla giustizia telematica. Molti gli episodi di evidenti conflitti di interessi, come quella di alcune banche di finanziare i corsi dei magistrati, o la poco trasparente gestione delle esecuzioni immobiliari tra la società Asteimmobili di natura privatistica, chiamata a svolgere nei tribunali compiti di natura pubblicistica, nonché il palese conflitto di interessi sotteso alla decisione di assegnare all’Abi la gestione integrata di tutte le informazioni relative ai procedimenti giudiziari nei fallimenti ed esecuzioni immobiliari e l’invio informatico degli atti processuali. Lo scorso 4 luglio 2014 ed a seguito chiusura indagini per il reato di usura a carico di alcune banche e di ex dirigenti Bankitalia da parte del Pm di Trani Michele Ruggiero, la Scuola superiore della magistratura ha organizzato, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) i cui ex vice-presidenti sono stati indagati (Emilio Zanetti scandalo Ubi-Banca) o arrestati (Giovanni Berneschi, scandalo Banca Carige Genova), un corso interdisciplinare sul tema dell’usura, riservando 30 posti per magistrati addetti al settore civile e 40 posti per magistrati addetti al settore penale (funzioni giudicanti e requirenti). Come si può leggere dalla lettera, Prot.n. 1980/2014USSM; inviata alla Direzione Generale dei Magistrati, Ispettorato Generale, Al Presidente della Corte di Cassazione Dr. Giorgio Santacroce, Al Procuratore Generale della Corte di Cassazione Dr. Gianfranco Ciani, Ai Presidenti delle Corti d’Appello, Ai Procuratori Generali delle Corti d’Appello, con l’oggetto: incontro di studi ”L’Usura: profili civilistici e penalistici“ 14-15 luglio 2014 Roma; Piazza del Gesù n. 49 – Sala della Clemenza, Palazzo Altieri. Roma, 4 luglio 2014. Firmato: la Segreteria della Scuola Superiore della Magistratura. Essendo gravissimo questo ultimo tentativo di indottrinamento degli operatori della Giustizia ad interessi di parte, che si consumerà il 14 e 15 luglio a Roma, nella sede Abi di Palazzo Altieri, dove è stato convocato un incontro di studio organizzato in fretta e furia dalla SSM (Scuola Superiore della Magistratura) d’intesa con la Banca d’Italia e l’ABI, proprio sul tema dell’usura bancaria, dove sono stati ammessi 70 magistrati, che potrebbe avere la finalità di condizionare indagini penali in corso, che vedono tra gli indagati primari esponenti delle banche associate all’Abi, che annovera molti banchieri incriminati e perfino arrestati, con sede in Piazza del Gesù, 49, a Roma proprio a Palazzo Altieri, e la Sala della Clemenza è tra le più prestigiose sale dove vengono svolti incontri, dibattiti, convegni, conferenze. Adusbef e Federconsumatori hanno denunciato un aspetto ancor più grave, che vede l’ex ministro della Giustizia del Governo Monti, prof.ssa Paola Severino nella duplice funzione di docente e partecipante attiva al corso sull’usura somministrato ai magistrati nella tavola rotonda di apertura per disquisire, assieme ad altri illustri relatori, sui profili civili e penali della legislazione antiusura, ed allo stesso tempo nella veste di avvocato difensore e consulente legale di celebri indagati (probabilmente anche nel processo penale istruito dal Pm di Trani Michele Ruggiero), accusati di aver violato la legge 108/96 ed il reato sull’usura. Poiché tale palese commistione tra organi giudiziari come il SSM, che avrebbe finalità di offrire formazione oggettiva ai magistrati, con i rappresentanti di dirigenti indagati o arrestati come Abi e Banca d’Italia, fa sorgere il dubbio di una giustizia addomesticata a misura di potenti, al contrario di quanto sancito dalla Costituzione Repubblicana ancora vigente, configura insanabile vulnus per la necessaria terzietà materiale e sostanziale, con lo studio dell’usura “a casa” del principale indiziato di attività usuraria, analogamente a corsi di formazione sui reati di mafia organizzata a Corleone, a casa di Totò Rjina o Bernardo Provenzano, Adusbef e Federconsumatori hanno inviato un corposo esposto alle maggiori cariche istituzionali italiane ed alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, denunciando il grave pericolo per le garanzie Costituzionali ed i diritti delle persone, specie se correntisti e risparmiatori, da una giustizia molto spesso ingiusta per i comuni cittadini.
Corso anti-usura per pm. In cattedra le banche, scrive Giorgio Meletti su Il Fatto Quotidiano, 12/07/2014 pagina 10. Il problema è molto complesso. Da quando il codice penale è stato modificato e il reato di usura non è più tipico dello strozzino ma anche dei banchieri qualora applichino tassi esagerati, le nostre scienze giuridiche si arrovellano: quando si può considerare superato il tasso-soglia oltre il quale scatta il reato? Pare che dopo quasi vent'anni non siano " ancora sopiti i problemi interpretativi", e così il presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Valerio Onida, ex presidente della Corte costituzionale, ex candidato a sindaco di Milano ed ex saggio di Giorgio Napolitano, ha avuto un'idea notevole. Ha organizzato un corso di formazione per magistrati in collaborazione con l'Abi (associazione bancaria italiana) e con la Banca d'Italia. Gente che di usura se ne intende, ovviamente, ma con il difetto di essere potenzialmente nel mirino dei magistrati che sono chiamati a formare. I Presidenti di Adusbef e Federconsumatori, Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, hanno preso carta e penna per scrivere una lettera di protesta alle Nazioni Unite, alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, al presidente Napolitano, al premier Matteo Renzi e al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Chiedono che Onida sia severamente censurato, e lo fanno con parole forti: " Chi ha ordito questa turpe trovata merita di essere sollevato dagli incarichi. Tanto al fine di evitare che altri magistrati magari siano costretti in futuro a partecipare a corsi antimafia a Corleone, nelle ville di Totò Riina o Bernardo Provenzano". Il corso si tiene il 14 e il 15 luglio 2014 nella sede dell'Abi, gentilmente messa a disposizione dal presidente dell' Abi, Antonio Patuelli. Colpisce che settanta magistrati provenienti da tutta Italia vengano mandati a scuola di usura presso un' associazione che si è trovata in pochi giorni con un vicepresidente arrestato, Giovanni Berneschi ex presidente di Carige, e uno indagato, Emilio Zanetti, ex presidente di Ubi-Banca. Lo stesso Patuelli deve la nomina alle dimissioni del predecessore Giuseppe Mussari, travolto dallo scandalo Montepaschi e oggi rinviato a giudizio anche per usura. Competenza per competenza, non si capisce perché non abbiano invitato anche Mussari a spiegare ai magistrati in cerca di formazione professionale i segreti dell'usura. C'è però, tra i docenti, Paola Severino, ex ministro della Giustizia e penalista di primo piano. Prima di diventare Guardasigilli a novembre 2011, era impegnata nel processo sull'aeroporto di Ampugnano che coinvolgeva Mussari e altri esponenti del Monte dei Paschi. E proprio a causa della nomina dovette abbandonare la difesa di una banca accusata di usura. Non è dato sapere se le due giornate di aggiornamento professionale prevedano anche esercitazioni pratiche. Ci sarebbe un ottimo caso di scuola a disposizione, l'inchiesta per usura del pm di Trani Michele Ruggiero, che vede indagati, tutti insieme, il presidente della Rai Anna Maria Tarantola come ex capo della Vigilanza della Banca d'Italia, l'ex ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni in quanto ex direttore generale della Banca d'Italia, e poi i capi o ex capi di alcune della maggiori banche italiane: Luigi Abete e Fabio Gallia della Bnl, Alessandro Profumo di Unicredit e il suo successore Federico Ghizzoni, Mussari per il Montepaschi insieme all'ex vicepresidente Francesco Gaetano Caltagirone, di cui Severino è da sempre difensore di fiducia. Peccato solo che il pm Ruggiero non sia stato invitato al corso, poteva essere l'occasione per i vertici di Abi e Bankitalia, e per la stessa Severino, di spiegargli per le vie brevi l'eventuale esagerazione delle sue ipotesi investigative. Per Adusbef e Federconsumatori, che hanno sollevato il problema, in gioco c'è la separazione dei poteri, "il doveroso distacco tra Abi e Ordine Giudiziario il cui collante risalente nel tempo stride con un paese ad ordinamento costituzionale e democratico". Una questione antica. Nel 2010 Lannutti, da senatore, interrogò il ministro dell' Economia Giulio Tremonti e il Guardasigilli Angelino Alfano, per sapere come mai l'Abi, con il patrocinio del ministero della Giustizia, avesse "sviluppato un progetto di formazione e-learning destinato a magistrati, cancellieri, avvocati e a tutti gli operatori del settore giudiziario per favorire la conoscenza e l'adozione degli strumenti del processo civile telematico". E riproponendo il tema della società Asteimmobili, costituita dall'Abi per gestire l'esecuzione dei fallimenti. Un' altra invasione di campo.
Chi sono le istituzioni che aiuteranno chi denuncia?
CORRUZIONE NEL CUORE DELLO STATO.
Corruzione nel cuore dello Stato. Solo alla Difesa 130 dipendenti sotto accusa. Al Mef c'è chi si porta via pure i timbri. Nel giro di due anni hanno subito provvedimenti disciplinari per reati penali anche 800 dipendenti della Guardia di Finanza. Neppure la Presidenza del Consiglio e il Consiglio di Stato sono immuni. Ecco la radiografia degli illeciti nelle istituzioni che non avete mai letto. E l'Anac corre ai ripari: dipendenti onesti, segnalate a noi, scrive Thomas Mackinson su “Il Fatto Quotidiano”. Al Tesoro c’è chi si porta via pure i timbri. Se parlare di 60 miliardi l’anno quasi non impressiona più, si possono però citare i 130 dipendenti della Difesa per i quali nel giro di due anni l’amministrazione ha avviato procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti. Certo potevano essere anche di più, visto che l’amministrazione conta 31.589 dipendenti tra militari e civili. Fatto sta che tra il 2013 e il 2014 per 109 di loro è scattata la sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione, cinque sono stati licenziati in tronco. A cercare bene si scopre che neppure la Presidenza del Consiglio, coi suoi 3.382 dipendenti, è immune agli illeciti: negli ultimi due anni Palazzo Chigi ha dovuto vedersela con un dirigente accusato di peculato e sei procedimenti disciplinari legati a vicende penali, una delle quali per rivelazione di segreto d’ufficio. Nel frattempo al Ministero dell’Economia e Finanze si sono registrati 15 casi su 11.507 dipendenti, compreso quello che s’è portato a casa i timbri dell’ufficio, e vai a sapere per farne cosa.
La mappa anche le guardie fanno i ladri. Pillole da una casistica che disegna una inedita “mappa della corruzione” nelle amministrazioni che sono il cuore dello Stato. La si ottiene analizzando una per una le “relazioni annuali sull’attività anticorruzione” che i funzionari responsabili della prevenzione delle amministrazioni pubbliche devono predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno, così come previsto dalla legge Severino (n.190/2012), le norme in fatto pubblicità e trasparenza (decreto n. 33/2013) e le successive “disposizioni sulla condotta per i pubblici dipendenti” (n. 62/2013). Prescrizioni cui ha contribuito in maniera importante l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), fornendo le linee guida del Piano nazionale anticorruzione, elaborando schemi operativi e modelli organizzativi e operativi per le amministrazioni e predisposto formulari destinati alla raccolta, gestione e diffusione dei dati nei piani triennali delle singole PA. Un articolato sistema di prevenzione e contrasto che – visti i numeri – sembra ancora insufficiente a contenere un fenomeno che si consuma prevalentemente nelle amministrazioni statali. Il bubbone, infatti, è tutto lì, come certificano le 341 sentenze pronunciate negli ultimi 10 anni dalla Corte dei Conti per casi di corruzione e concussione: il 62% ha riguardato i dipendenti dello Stato, a pari merito col 12% quelli dei comuni, sanità, enti previdenziali e assistenziali. Residuali, al momento, i reati che riguardano province, regioni e università. Dunque il problema è nel cuore dello Stato. E la tendenza non sembra cambiare, anzi. Dai documenti aggiornati a dicembre si apprende anzi di amministrazioni che hanno visto raddoppiare gli episodi di illecito penale nel giro di un anno. Al Ministero per i Beni culturali ad esempio erano stati 12 nel 2013, nel 2014 sono stati 24. Altri rapporti fanno intravedere la penetrazione verticale dell’inquinamento corruttivo. Non fa gli argine, ad esempio, il Consiglio di Stato. Siamo in casa di giudici, non ci si aspetterebbe che ladri e corrotti avessero dimora. Invece su 869 dipendenti sono stati avviati 15 provvedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti, due sono terminati con il licenziamento. E che cosa succede, allora, a casa delle guardie? La Finanza reprime gli illeciti. Ma molto lavoro arriva direttamente dai suoi uffici, e su dimensioni di scala impressionanti. La Gdf conta 433 dirigenti, 2.477 ufficiali, 56mila tra ispettori, appuntati e finanzieri. Negli ultimi due anni le Fiamme Gialle hanno avviato ben 783 procedimenti disciplinari per fatti penali a carico dei propri dipendenti: 17 riguardano ufficiali, 766 personale non dirigente o direttivo. Con quali effetti e sanzioni? Una degradazione generale: 658 sanzioni disciplinari di corpo, 40 sospensioni disciplinari, 66 perdite di grado. Nota di colore: nel cortocircuito tra guardie e ladri spunta anche il finanziere “colluso con estranei per frodare la Finanza”. La via italiana all’anticorruzione, visti questi, sembra ancora in salita. La difficoltà è palese, avvertita e denunciata sia dall’interno degli uffici pubblici e sia all’esterno, come in più occasioni ha segnalato la stessa Anac. I responsabili della trasparenza lo dicono chiaramente: a due anni dalla legge che è il perno delle politiche di contrasto al fenomeno, le amministrazioni non hanno poteri effettivi, non ricevono risorse adeguate, devono muoversi in un quadro normativo sempre più complesso e farraginoso che affastella leggi su leggi. Solo gli obblighi di pubblicazione hanno raggiunto quota 270. “Un monitoraggio efficace è difficilmente attuabile”, ammette Luigi Ferrara, da sei mesi responsabile anticorruzione del Mef, “anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione non ha poteri d’indagine e che i terzi potenzialmente interessati sono molto numerosi”. E abbiamo visto quanto.
Una macchina senza benzina. Che non va avanti. Il dito è puntato sull’insufficienza di strumenti e risorse per debellare la natura pervasiva e sistemica della corruzione. Si è fatto un gran parlare dei fondi per l’authority, spesso centellinati in nome del risparmio. Per nulla di quelle che servono alle amministrazioni per utilizzare gli strumenti via via codificati dal legislatore per fare opera di prevenzione dall’interno. L’impressione, ammette un funzionario, è che si vuol fare la guerra a parole, a costo zero. E questo atteggiamento vanifica gli sforzi. Un esempio? Il personale individuato dalle amministrazioni per vigilare sui settori a maggior rischio si sarebbe dovuto formare “senza ulteriori oneri per lo Stato, nella Scuola superiore della pubblica amministrazione”. Questo dice la legge 190. Ma quasi mai succede. “Alcune misure e raccomandazioni, per lo più riferite alla Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, sono state superate a seguito della soppressione della Scuola medesima”, fa notare con sottile ironia il responsabile anticorruzione del Mef, Luigi Ferrara. L’Anac gli dà ragione, sottolineando come il legislatore avesse assegnato alla formazione un ruolo essenziale, ma a distanza di un anno era ancora “la tessera mancante del mosaico”. Tanto che le attività progettate dalla Scuola nazionale dell’amministrazione “non si può dire siano andate a regime”. A volte le carenze riguardano cose banali: “Mancano gli applicativi informatici ad hoc per il supporto dell’attività di monitoraggio e di attuazione delle misure anticorruzione”, mette a verbale il capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane del Miur, Sabrina Bono. Del resto, spiega, il nuovo complesso di norme che ha investito le amministrazioni si scontra con la mancanza di personale dedicato. Per far seguito agli impegni previsti dalla normativa anticorruzione la funzionaria si è avvalsa di un dirigente e di due funzionari che “hanno svolto tali funzioni congiuntamente ai compiti assegnati in ragione dell’ufficio d’appartenenza”. Uno modo delicato per dire che non c’è personale da dedicare alla missione, a fronte di un aumento esponenziale degli adempimenti. In questo quadro, l’invito a ciascuna amministrazione a disegnare una propria politica di prevenzione rischia di cadere nel vuoto.
L’authority chiama in causa la politica. Sono criticità ben note all’Anac che negli anni ha lanciato più volte l’allarme sul rischio che le iniziative assunte si traducano in un mero adempimento formale degli obblighi, senza effetti reali sul malcostume nella cosa pubblica. Già nel primo anno di applicazione della 190/2012 l’Autorità chiamava in causa la politica e inviava al Parlamento una durissima relazione: “Appare particolarmente problematica – si legge – la constatazione che il livello politico non abbia mostrato particolare determinazione e impegno”. La rampogna era diretta al legislatore che affastellava leggi su leggi per spegnere l’incendio della corruzione salvo dimenticarsi di aprire i rubinetti. Ma era rivolta anche ai vertici delle amministrazioni pubbliche che all’invito a render conto delle proprie attività, segnatamente in fatto di trasparenza, rispondevano alzando un muro di gomma. Dopo un anno, per dire, solo l’8% dei ministeri si era premurata di indicare un responsabile interno. Molte non trasmettevano i dati, altre non davano seguito agli obblighi in materia di pubblicazione. Con la beffa finale, segnalata direttamente da Cantone pochi mesi dopo, per cui – a fronte del quadro sopra descritto – “la quasi totalità dei dirigenti pubblici ha conseguito una valutazione non inferiore al 90% del livello massimo atteso”.
Quelle denunce mai fatte. Ecco l’ultima speranza. Il dato fa poi il paio con la scarsa propensione dei dipendenti degli “uffici” a denunciare “fatti penalmente rilevanti per i quali siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”. Doveva essere la mina che fa saltare il sistema dall’interno, il famoso whisteblowing di matrice anglosassone, tanto enfatizzato dai mezzi di informazione all’indomani dell’approvazione della legge Severino. E quanti “sussurrano”? Pochi, quasi nessuno. Le “Relazioni” dei responsabili anticorruzione confermano che le segnalazioni si contano sulle dita di una mano e che quasi mai arrivano da dentro gli uffici, nonostante la promessa protezione contro rappresaglie e discriminazioni. Se ci sono, quasi sempre arrivano da fuori. Esempi. La Difesa, con 30mila dipendenti, registra un solo caso che abbia comportato una misura di tutela del segnalante. Il Ministero dell’Istruzione ha 4.223 dipendenti in servizio. Il responsabile anticorruzione nel suo rapporto conferma che la procedura è attivata via mail. Quanti l’hanno usata in due anni? Nessuno. Segno che il timore e l’omertà tengono ancora banco negli “uffici”. E forse per questo lo scorso 9 gennaio l’Anac ha diramato una nota per segnalare la propria competenza a ricevere segnalazioni.
Consiglieri, commessi e segretari. Ecco il Parlamento dei parenti. La burocrazia più ricca di intrecci familiari d’Italia? È quella delle Camere. Legami L’ex tesoriere della Margherita Lusi aveva il fratello in Senato e il cognato alla Camera, scrive Sergio Rizzo “Il Corriere della Sera”. Chi guarda con apprensione alla fusione fra le amministrazioni di Camera e Senato, per possibili traumi o crisi di rigetto, si può tranquillizzare. Il ruolo unico è già stato realizzato, con reciproca soddisfazione, per via familiare. La recente nomina all’impegnativo incarico di segretario generale di Montecitorio di Lucia Pagano, figlia dell’ex consigliere della Camera Rodolfo Pagano e moglie del nuovo capo dell’informatica di Palazzo Madama, Mauro Fioroni, ne è la certificazione più limpida. In Italia non esiste burocrazia con intrecci parentali e dinastici così diffusi e profondi come in quella del Parlamento. A tutti i livelli: da quelli più bassi ai più elevati. E altri casi, oltre a quello di Lucia Pagano, rendono bene l’idea. Il suo vice Aurelio Speziale, per esempio, è sposato con Gloria Abagnale, consigliere del Senato. Giovanni Gifuni, consigliere della Camera, è figlio dell’ex potentissimo segretario generale di Palazzo Madama Gaetano Gifuni. Mentre l’ex vicesegretario generale della Camera Carlo Goracci è il papà di Alessandro Goracci, alto funzionario del Senato. E se il padre di Ugo Zampetti, fino a qualche giorno fa capo indiscusso della burocrazia di Montecitorio, era il responsabile della biblioteca di Palazzo Madama, quello dell’attuale segretario generale del Senato Elisabetta Serafin era solo un commesso. Commesso come anche il papà di Daniela D’Ottavio, consigliera d’Aula. A dimostrazione del fatto che l’ascensore sociale, fermo ormai ovunque, qui non è mai andato in manutenzione. «vietato» Anche se qualche volta s’inceppa. Figlio di un ex consigliere della Camera, Fabrizio Castaldi ne sarebbe diventato a 43 anni uno dei segretari generali più giovani di sempre se la sua candidatura non fosse naufragata in extremis. Come quella di Giacomo Lasorella, incidentalmente fratello della giornalista Rai Carmen Lasorella. E quella del possibile terzo incomodo Costantino Rizzuto Csaky, consorte di Maria Teresa Stella, consigliera della Camera al servizio biblioteca. Parentela, quest’ultima, che ci riporta a un illustre caso del passato. Fece scalpore, cinquant’anni orsono, il matrimonio fra Antonio Michela-Zucco, nipote dell’omonimo inventore della rivoluzionaria macchina di stenotipia, e Magda Sammartino. Erano entrambi stenografi del Senato e la cosa venne considerata causa di incompatibilità. Per rimuoverla fu deciso il trasferimento della moglie alla Camera. Dove Magda Sammartino fu protagonista di una splendida carriera arrivando, prima donna nella storia, all’incarico di vicesegretario generale. Ma erano altri tempi. i Oggi la presenza di coniugi nelle stanze dei bottoni della stessa amministrazione non scandalizza più davvero nessuno. Marito e moglie sono il capo servizio controllo parlamentare Carlo Lomaglio e la direttrice dell’ufficio pubblicazioni della Camera Consuelo Amato: figlia del magistrato ed ex capo dell’amministrazione penitenziaria Nicolò Amato. Marito e moglie sono Stefano Cicconetti, dirigente di Montecitorio ora in pensione, e la sua collega ancora in servizio Maria Teresa Calabrò: figlia del potentissimo ex presidente del Tar Lazio e dell’Agcom Corrado Calabrò. Marito e moglie sono Alessandro Palanza, ex vicesegretario generale della Camera e la funzionaria Martina Mazzariol. Attualmente vicepresidente della Fondazione Italiadecide di Luciano Violante, Palanza ha guidato a lungo un’amministrazione nella quale aveva un ruolo di rilievo anche sua sorella Maria Rita. Marito e moglie sono Pietro Calandra, alto dirigente del Senato poi finito all’autorità di vigilanza dei lavori pubblici su indicazione del Pd e la funzionaria di Palazzo Madama Stefania Boscaini. Ma si potrebbe andare avanti chissà quanto, notando come il gioco degli intrecci e delle parentele non sia limitato ai soli burocrati. Dice tutto quello intorno alla funzionaria della Camera Giuliana Coppi. Figlia del principe del Foro Franco Coppi, legale di Silvio Berlusconi, è sposata a sua volta con un altro avvocato. Non uno dei tanti. Il suo nome è Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia eletto al consiglio superiore della magistratura in quota al partito di Berlusconi. Si potrebbe anche ricordare come il vicesegretario della Camera Guido Letta sia il nipote di Gianni Letta e cugino di Enrico Letta. Oppure che il funzionario del Senato Luigi Ciaurro sia figlio dell’ex ministro liberale Gianfranco Ciaurro, scomparso ormai quindici anni fa. O che Valentina Loiero, figlia dell’ex governatore della Calabria Agazio Loiero, e Giulia Laganà, figlia dell’ex parlamentare del Pd Tana De Zulueta, facciano parte dello staff della presidente Laura Boldrini. La cui segreteria, peraltro, era stata per otto mesi guidata da Marco Cerase, genero di Alberto Asor Rosa, prima che venisse trasferito ad altro incarico per far posto all’astro emergente Castaldi. Come dimenticare poi che l’ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, ex senatore, aveva il fratello direttore del servizio del Senato, mentre suo cognato Francesco Petricone è funzionario della Camera? E che Cristiano Ceresani, un altro funzionario della Camera già vicecapo legislativo di Gaetano Quagliariello e oggi addirittura capo con il ministro Maria Elena Boschi, è il marito di Simona De Mita, quindi genero dell’ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco Ciriaco De Mita?
COSI' HANNO TRUFFATO DI BELLA.
Travaglio: Così hanno truffato Di Bella. Dosi sballate e farmaci scaduti, la sperimentazione della cura Di Bella sarebbe viziata da gravi irregolarità, scrive "La Fucina". A quindici anni dalla fine della sperimentazione il Metodo Di Bella sta tornando a far parlare. Migliaia di pazienti si stanno rivolgendo a Giuseppe Di Bella, che sta portando avanti la terapia inventata dal padre Luigi, per essere curati. Ci sono, inoltre, migliaia di casi di guarigione e i tribunali di diverse città hanno imposto alle ASL locali di rimborsare le cure ad alcuni malati. La sperimentazione di questa terapia alternativa era stata bocciata a fine anni ’90, ma da un’indagine del PM Raffaele Guariniello era emerso che c’erano stati gravi errori nella sperimentazione. È significativo un articolo di Marco Travaglio pubblicato su Repubblica nel settembre del 2000, in cui il giornalista raccontava i lati oscuri della vicenda. Lo riportiamo di seguito: “La sperimentazione della cura Di Bella sarebbe viziata da gravi irregolarità. Peggio: alcuni dei 386 malati di cancro che provarono la “multiterapia” (Mdb) del medico modenese sarebbero stati usati come cavie, trattati con farmaci “guasti e imperfetti”, non si sa con quali effetti sulla salute. E l’ Istituto superiore di Sanità, pur sapendolo, non avrebbe avvertito 50 dei 51 ospedali d’ Italia che sperimentavano i protocolli. Sono queste le conclusioni della lunga e minuzionsa indagine aperta due anni fa dal procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello, in seguito ad alcune denunce, sulla sperimentazione nei 4 “centri di riferimento” di Torino (Molinette, San Giovanni antica sede, Mauriziano e Sant’ Anna) e nei 4 della provincia (gli ospedali di Chivasso, Orbassano, Chieri e Cirè). Un’ indagine che non entra nel merito dell’ efficacia o meno della cura, ma si limita ad analizzare la regolarità della sperimentazione. Quattro gli accusati, tutti dirigenti dell’ Istituto superiore di sanità (Iss): Roberto Raschetti e Donato Greco, coordinatori della sperimentazione del 1998, Stefania Spila Alegiani, responsabile dei preparati galenici, ed Elena Ciranni, che curava i rapporti con i vari centri clinici. Grave l’ ipotesi di reato: “somministrazione di medicinali guasti o imperfetti” (punibile, secondo l’ articolo 443 del codice penale, con la reclusione fino a 3 anni). Il direttore Giuseppe Benagiano, a suo tempo indagato, è stato poi archiviato. Nessuna responsabilità per l’ ex ministro della Sanità Rosi Bindi, sentita come testimone in gran segreto, a Roma, all’ inizio dell’ anno. I 4 indagati hanno ricevuto l’ “avviso di chiusura indagini”. Una sorta di preannuncio di rinvio a giudizio, che poi però non è arrivato: grazie alla legge Carotti, i difensori hanno chiesto e ottenuto dal Pg della Cassazione Nino Abbate il trasferimento dell’ inchiesta a Firenze. Con la curiosa motivazione che i farmaci “incriminati” li produce l’ Istituto farmacologico militare fiorentino. Inutile l’ opposizione di Guariniello il quale, sentenze della Cassazione alla mano, ha ribattuto che il 443 non punisce la produzione o la detenzione, ma la somministrazione di farmaci guasti (avvenuta, appunto, a Torino). Spetterà dunque alla Procura di Firenze – che l’ anno scorso aveva già archiviato un’ altra inchiesta sui protocolli Di Bella – trarre le conclusioni: rinviare a giudizio o chiedere l’ archiviazione. Tutto dipenderà dall’ interpretazione delle irregolarità emerse a Torino: errori in buona fede o condotte dolose? Per Guariniello, la prova del dolo sarebbe in una lettera inviata nel ‘ 98 a un ospedale romano, che chiedeva lumi sulla conservazione e la composizione delle “soluzioni ai retinoidi” previste per i protocolli 1 e 9. Nella lettera i dirigenti dell’ Iss precisavano che quelle sostanze hanno una “validità” di soli 3 mesi, dopo di che “scadono” e vanno buttate. Peccato che la stessa direttiva non sia stata diramata agli altri 50 ospedali che sperimentavano la cura. E che infatti continuarono, ignari di tutto, a somministrare quelle soluzioni ampiamente scadute (addirittura vecchie di 4, 5, 9 mesi) e “deteriorate”. Non solo: un gravissimo errore tecnico avrebbe dimezzato il quantitativo di un componente, un principio attivo, fondamentale per l’ efficacia di quelle soluzioni: l’ “axeroftolo palmitato”. In pratica, per i due protocolli, quella sperimentata non era la multiterapia Di Bella, ma una “variazione sul tema” non dichiarata. Così com’ era emerso nel ‘ 98 per altri due protocolli, frettolosamente ritirati dopo che Guariniello vi aveva scoperto alcune sostanze mancanti e alcune altre (come il tamoxifene del professor Umberto Veronesi) aggiunte da una mano misteriosa. Ma quel capitolo è ancora aperto. A Torino.”
GIUDICI SENZA CONDIZIONAMENTI?
Cassazione su Ilva: «Giudici tarantini senza condizionamenti», scrive Mimmo Mazza su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Il processo sull’inquinamento provocato dall’Ilva si può tranquillamente e legittimamente fare a Taranto perché «non c’è una grave situazione locale tale da condizionarlo» e perché «l’esito non riguarderà il futuro produttivo dello stabilimento siderurgico e dunque anche quello economico-sociale di Taranto ma la condotta di singoli imputati». I provvedimenti adottati dai magistrati tarantini che finora si sono occupati della vicenda «non sono stati il frutto del condizionamento operato da una «grave situazione locale», ma rappresentano piuttosto l'espressione fisiologica dell'esercizio della funzione giudiziaria e non denotano in alcun modo mancanza di imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo». La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha depositato le 15 pagine di motivazioni con le quali lo scorso 7 ottobre ha respinto l’istanza di rimessione proposta da 15 dei 52 imputati del processo «Ambiente svenduto». Il collegio presieduto da Umberto Giordano (consigliere relatore Margherita Cassano) ha sostanzialmente accolta la tesi del sostituto procuratore generale Enrico Delehaye e della stessa Procura di Taranto che aveva sollecitato, inviando una memoria firmata dal procuratore capo Franco Sebastio e dagli aggiunti che si sono occupati dell’indagine, la permanenza del processo a Taranto. A rivolgersi alla suprema corte erano state le società Riva Fire (guidata da Claudio Riva) e Riva Forni Elettrici (presieduta da Cesare Riva), imputate ai sensi della norma che disciplina la responsabilità giuridica delle imprese; e le persone fisiche Fabio e Nicola Riva, figli del patron Emilio morto lo scorso 30 aprile, l’ex presidente dell’Ilva Bruno Ferrante, gli ex direttori del siderurgico Luigi Capogrosso e Adolfo Buffo, i dirigenti della fabbrica Ivan Dimaggio, Salvatore D’Alò, Salvatore De Felice, Angelo Cavallo, i fiduciari del gruppo Riva Lanfranco Legnani e Giuseppe Casartelli; l’ex responsabile dell’ufficio romana Caterina Vittoria Romeo; l’ex responsabile delle relazioni esterne Girolamo Archinà. A sorpresa, però, il giorno della discussione dell’istanza, aveva aderito alla richiesta di spostamento a Potenza del processo, tramite l’avvocato Luca Sirotti, anche il commissario dell’Ilva Piero Gnudi. L’azienda, sottoposta a commissariamento dal giugno del 2013, è imputata nel procedimento per i profili penali previsti dalla legge 231 del 2001 ma Enrico Bondi, primo commissario, non aveva firmato l’istanza di rimessione. Gnudi, nominato lo scorso giugno dal governo Renzi, aveva evidentemente deciso diversamente dal suo predecessore, dando mandato al suo legale di appoggiare la richiesta di spostamento del processo, con argomenti molto critici nei confronti del gip Patrizia Todisco e del gup Vilma Gilli. I giudici della Suprema Corte però hanno ritenute viziate le argomentazioni dei proponenti che «muovendo da indimostrate inferenze totalizzanti, valorizzano una logica presuntiva e dubita dell'imparzialità di un intero ufficio giudiziario non sulla base di fatti verificabili, ma di mere congetture che non trovano riscontro in circostanze obiettive». La Cassazione tornerà ad occuparsi di «Ambiente svenduto» il 4 febbraio, esaminando l’istanza di ricusazione del gup Vilma Gilli presentata dall’avvocato Michele Rossetti, legale dell’ex assessore provinciale Michele Conserva, uno dei 52 imputati.
A PROPOSITO DI RIMESSIONE DEL PROCESSO ILVA. ISTANZA RESPINTA: DOVE STA LA NOTIZIA?
Lo chiediamo al dr Antonio Giangrande, sociologo storico che sul tema ha scritto : “Malagiustiziopoli. Ingiustizia contro la collettività”, ovvero “Tutto su Taranto, quello che non si osa dire”.
«E’ da venti anni che studio il sistema Italia, a carattere locale come a livello nazionale. Da queste indagini ne sono scaturiti decine di saggi, raccolti in una collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo", letti in tutto il mondo, ma che mi sono valsi l’ostruzionismo dei media nazionali. Pennivendoli venduti all’economia ed alla politica. Book ed E-Book che si possono trovare su Amazon.it, Lulu.com, CreateSpace.com. Il processo all’Ilva resterà a Taranto e non sarà trasferito a Potenza: lo ha deciso la Corte di Cassazione la sera del 7 ottobre 2014. A presentare la richiesta di rimessione ad altra sede, per legittimo sospetto, erano stati i difensori di alcuni dei 52 imputati per disastro ambientale. I legali di Riva Fire, Ilva spa e di 13 imputati (tra i quali gli avvocati Franco Coppi, Francesco Mucciarelli, Adriano Raffaelli, Nerio Diodà, Stefano Goldstein e Marco De Luca) avevano depositato l’istanza il 5 giugno 2014. Il rigetto è avvenuto il 7 ottobre 2014. In poco meno di 200 pagine, i legali avevano cercato di far perno sull'articolo 45 del codice di procedura penale. Ovvero, come recita l’articolo, "la sicurezza o l'incolumità pubblica", o ancora "la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali" che possono turbare lo svolgimento del processo stesso e non sono neppure eliminabili. Ovvero per “legittimo sospetto”. Dopo l’annuncio i colpevolisti hanno festeggiato, pensando di trovare a Taranto un humus giudiziario favorevole per le loro aspettative. Ma quale è la notizia? Il rigetto scontato dell’istanza? Non ne era convinto del buon esito il buon Franco Coppi, che già ci aveva provato per Sabrina Misseri per il processo sul delitto di Sarah Scazzi. Ma ciò non gli ha impedito di presentare l’istanza insieme agli altri legali. Tarantini non lo sono e per questo hanno avuto il coraggio di presentare l’istanza di rimessione per legittimo sospetto che i magistrati del foro di Taranto non potessero essere sereni per il clima generato dalle campagne di stampa che hanno sobillato l’opinione pubblica. Quella stampa che prima era prona alla grande industria e come escort foraggiata. In attesa delle ovvie motivazioni degli ermellini, i giornalisti, degni di tale titolo facciano una ricerca approfondita dei precedenti ricorsi di Rimessione fatti in tutta Italia. Se non vi è capacità o volontà possono sempre attingere ai miei saggi di inchiesta: “Malagiustiziopoli. Ingiustizia contro la collettività”, ovvero “Tutto su Taranto, quello che non si osa dire”. Il tema è stato trattato e ci si accorgerà che la legge Cirami mai è stata applicata. Perché la legge si applica per i poveri cristi e si interpreta per i poteri forti, specie se corporativi. Una norma disapplicata in abuso di potere ed a spregio dei diritti di difesa.
“L’ipotesi della rimessione, il trasferimento, cioè, del processo ad altra sede giudiziaria, deroga, infatti, alle regole ordinarie di competenza e allo stesso principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione) - spiega Edmondo Bruti Liberati, già Presidente dell’Associazione nazionale magistrati. - E pertanto già la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che si tratta di un istituto che trova applicazione in casi del tutto eccezionali e che le norme sulla rimessione devono essere interpretate restrittivamente. Nella rinnovata attenzione sull’istituto della rimessione, determinata dalla discussione della proposte di modifica (2002, legge Cirami), numerosi commenti – comparsi sulla stampa – rischiano di aver indotto nell’opinione pubblica l’impressione che l’istituto del trasferimento dei processi trovi applicazione ampia e che dunque la magistratura italiana ricorrentemente non sia in grado di operare con serenità di giudizio. Vi fu una sola difficile stagione dei primi decenni della nostra Repubblica, in cui numerosi processi per fatti di mafia furono trasferiti dalle sedi giudiziarie siciliane in altre regioni: era il segno umiliante della fragilità delle istituzioni, di uno Stato incapace di assicurare serenità allo svolgimento del processo e di garantire protezione ai giudici popolari di fronte alle minacce. Era una stagione in cui i processi, pur trasferiti ad altra sede, si concludevano pressoché ineluttabilmente con le assoluzioni per insufficienza di prove. Superata questa fase, e pur sotto la vigenza della norma del Codice di procedura penale del 1930 – che prevedeva la formula del «legittimo sospetto» –, in un periodo di diversi decenni i casi di rimessione sono stati pochissimi: intendo dire poche unità. I casi più noti di accoglimento, di norma ad iniziativa degli uffici del Pm, determinarono polemiche e reazioni. (Ad esempio, i fatti di Genova del luglio 1960, la strage del Vajont, la strage di Piazza Fontana, l’appello sul ‘caso Zanzara’, il caso delle schedature alla Fiat). Avanzava tra i giuristi la tesi che fosse necessaria una più puntuale e rigorosa indicazione dei motivi suscettibili di determinare il trasferimento. Il Parlamento, dopo le polemiche per il trasferimento del processo per la strage di Piazza Fontana da Milano a Catanzaro, interveniva per dettare dei criteri stringenti per la designazione del nuovo giudice (legge 773/1972 e successivamente legge 879/1980, che introdusse il criterio automatico tuttora vigente). La lettura delle riviste giuridiche, dei saggi in materia e dei codici commentati ci presenta una serie lunghissima di casi, in cui si fa riferimento alle più disparate situazioni di fatto per concludere che la ipotesi di rimessione è stata esclusa dalla Corte di cassazione. Pochissimi sono dunque fino al 1989 stati i casi di accoglimento: l’ordine di grandezza è di una dozzina in tutto. Il dato che si può fornire con precisione – ed è estremamente significativo – riguarda il periodo dopo il 1989, con il nuovo Codice di procedura penale: le istanze di rimessione accolte sono state solo due.»
Di queste due istanze accolte, però, non ve ne si trova traccia per farne un attendibile riferimento.
Il collegio della prima sezione penale è stato presieduto da Umberto Giordano, consigliere relatore Margherita Cassano che entro trenta giorni, circa, depositerà i motivi del «no» al trasloco del processo Ilva. Senza successo, quindi, i difensori degli imputati - tra i quali il professor Franco Coppi - hanno sostenuto che i giudici tarantini non sarebbero sereni nell’affrontare una vicenda che coinvolge tanta popolazione della città pugliese dove sorgono gli insediamenti dell’acciaieria che riversa le sue polveri sui quartieri vicino agli stabilimenti.
Via libera al Gup Vilma Gilli, allora. Alla sbarra compaiono non solo i vertici Ilva, accusati di aver creato un’associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale della città, ma anche politici, amministratori, funzionari regionali e del ministero dell’Ambiente: dal presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, all’ex presidente della Provincia di Taranto, Gianni Florido, al sindaco della città, Ippazio Stefano, per arrivare ad avvocati (c'è anche un legale Ilva), un poliziotto, un carabiniere e un sacerdote.
Per i manettari: Tutti dentro!!
L’accusa è portata dalla Procura della Repubblica di Taranto, guidata da Franco Sebastio, al quale sono affiancati in questa inchiesta il procuratore aggiunto, Pietro Argentino, e quattro sostituti procuratori.
Da ricordare che mina la credibilità del pool d’accusa l’indagine della procura di Potenza a carico di Pietro Argentino per falsa testimonianza, come tutti sanno, per una deposizione resa a favore del’ex Pm di Taranto Matteo di Giorgio, condannato a 15 anni di carcere dal Tribunale di Potenza.
Come ne sono tutti a conoscenza del conflitto interpersonale tra Sebastio ed Argentino. Nel processo sulla malasanità di Bari compaiono intercettazioni telefoniche fra il dott. Sebastio e il consigliere regionale dell'area del P.D. ostile al sindaco di Bari Michele Emiliano, Michele Mazzarano, nel corso delle quali il dott. Sebastio esprimeva sfavore per la nomina a Procuratore Aggiunto del dott. Pietro Argentino.
Quindi un iter giudiziario travagliato che, data la mia esperienza, mi permette, così come ho fatto per il processo Sarah Scazzi, di prevederne il finale: condanna per tutti, salvo prescrizione».
In Italia si rileva che la Corte di Cassazione, sistematicamente, rigetta ogni istanza di rimessione da chiunque sia presentata e qualunque ne sia la motivazione. La Corte di Cassazione – Supremo Organo di Giustizia Italiana – rigetta sistematicamente ogni istanza di rimessione dei processi per legittimo sospetto e ogni richiesta di ricusazione presentata dall’imputato per grave inimicizia con il magistrato che lo giudica. La Corte di Cassazione non applica mai le norme per il giusto processo e, sistematicamente, non solleva mai dalla sua funzione il giudice naturale, anche quando questo non è sereno nel dare i suoi giudizi.
Sarah Scazzi: perché il processo resta a Taranto, scrive Diana De Martino su “Golem Informazione”. In più occasioni la Cassazione ha ricordato come non solo le campagne di stampa, ma anche le pressioni dell’opinione pubblica, non sono di per sé idonee a condizionare la libertà di determinazione del giudice. L’omicidio di Sarah Scazzi è uno di quegli eventi delittuosi che, per una serie di ragioni non tutte comprensibili, ha assunto una dimensione di enorme rilievo sugli organi di informazione, e di riflesso sull’opinione pubblica. Proprio tale abnorme interesse mediatico è stato posto alla base dell’istanza di rimessione presentata dalla difesa di Sabrina Misseri, come è noto imputata assieme alla madre Cosima Serrano, dell’omicidio della giovane Sarah. In sostanza i difensori hanno sostenuto che la campagna di stampa tuttora in corso, dai toni quanto mai accesi ed astiosi nei confronti delle imputate, nonché la pressione dell’opinione pubblica pesantemente schierata per la colpevolezza delle 2 donne, avevano determinato un oggettivo condizionamento nelle attività del Pubblico Ministero e nelle valutazioni del GIP nonché del Tribunale del Riesame di Taranto. A fondamento di tale prospettazione la difesa riepilogava una serie di anomalie riscontrate nell’attività della Procura quali la mancanza di vaglio critico degli interrogatori in cui Michele Misseri, modificando l’originaria versione, aveva accusato la figlia Sabrina; la mancata considerazione delle successive ritrattazioni di tali accuse; l’affidamento di ulteriori consulenze finalizzate ad allineare le conclusioni tecniche con le nuove prospettazioni accusatorie; le iniziative assunte nei confronti dei precedenti difensori di Sabrina Misseri, indagati per fatti inerenti all’esercizio del mandato difensivo; le limitazioni alla corrispondenza dei detenuti Michele e Sabrina Misseri nonché la perquisizione nella cella del Misseri e il sequestro di tutta la corrispondenza rinvenuta. L’attività inquirente era stata orientata, secondo la difesa, dal forte condizionamento che la Procura aveva subito di fronte ad un opinione pubblica ormai schierata contro Sabrina Misseri e sua madre Cosima. Ma tale inquinamento si era esteso agli uffici giudicanti cosicché, ad avviso della difesa, proprio tale pesante condizionamento spiegava la revoca della misura cautelare nei confronti di Michele Misseri, che pure in numerose interviste continuava a proclamarsi l’unico responsabile dell’omicidio di Sarah Scazzi. L’istanza di rimessione formulata sulla base di tali elementi è stata rigettata dalla Corte di Cassazione, con una motivazione a mio avviso del tutto condivisibile, che mette in luce i vari profili di infondatezza degli argomenti difensivi. Va premesso che l’istituto della rimessione, previsto dall’art. 45 del c.p.p., ha la finalità di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del giudice nonché l’inviolabilità del diritto di difesa. In pratica la norma stabilisce che quando, per gravi situazioni ambientali, si presenti come probabile un condizionamento dei giudici, che non potrebbero dunque determinarsi in piena libertà ed indipendenza, il procedimento debba essere trasferiti ad altra sede. Si tratta peraltro di uno strumento eccezionale, che non tollera interpretazioni estensive in quanto la conseguente “translatio iudicii” va a collidere con un altro principio costituzionale ovvero quello del giudice naturale. La prima osservazione che deve essere fatta è che le “gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo” devono anche essere “non altrimenti eliminabili”. Ciò vuol dire che vengono in rilievo non l’imparzialità o l’indipendenza del singolo giudice o dello specifico collegio, perché in tali ipotesi sono previsti gli abituali strumenti dell’incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione, tutti meccanismi destinati ad eliminare le situazioni che possono incidere sulla libertà di autodeterminazione e sull’indipendenza del singolo magistrato, senza incidere sul principio del “giudice naturale”. Perciò le “gravi situazioni locali” a cui fa riferimento la norma, e che legittimano il trasferimento del processo ad altra sede, devono essere tali da pregiudicare la libertà di determinazione del complessivo ufficio giudiziario. L’art. 45 c.p.p. dunque autorizza lo spostamento del processo nel caso in cui emerga che la grave situazione ambientale, alternativamente:
1) pregiudichi la libera determinazione delle persone che partecipano al processo;
2) metta in pericolo la sicurezza o l’incolumità pubblica;
3) determini motivi di legittimo sospetto.
Nella vicenda in esame si evidenzierebbero – secondo la prospettazione difensiva – le ipotesi di cui alle lettere a) e c). Al riguardo la giurisprudenza ha in più occasioni specificato che il pregiudizio alla libertà di determinazione degli attori del processo implica l’idea di una vera e propria coazione, fisica o psichica; mentre il legittimo sospetto coinvolge la probabilità, fondata su dati obiettivi e concreti, che risulti compromessa l’imparzialità di giudizio. In sostanza, poiché l’istituto della rimessione serve ad assicurare che il giudizio si svolga secondo gli irrinunciabili criteri di libertà e di indipendenza, esso può essere attivato soltanto in via eccezionale, quando, sulla base di elementi concreti, si possa ipotizzare che il giudice sia coartato fisicamente o psichicamente ad una determinata decisione ovvero vi sia il pericolo che possa essere condizionato.
Non sembra che tale situazione possa ravvisarsi a proposito del procedimento relativo all’omicidio di Sarah Scazzi per i seguenti motivi:
- in primo luogo la situazione che sarebbe alla base del sovvertimento del regolare svolgimento delle dinamiche processuali non è una situazione locale bensì nazionale. Proprio il clamore sulla stampa e sui mezzi televisivi - richiamato dalla difesa - ha evidentemente una ricaduta non sulla realtà del distretto di Taranto bensì su tutto il territorio nazionale: i talk show, i telegiornali, le interviste sui quotidiani, gli stessi social-network raggiungono ogni parte del territorio nazionale, cosicché lo spostamento del processo presso l’ufficio giudiziario di Bari (ai sensi dell’art. 11, richiamato dall’art. 45 c.p.p.) non risolverebbe in alcun modo la situazione di potenziale condizionamento.
- in secondo luogo, tale potenziale condizionamento dei magistrati di Taranto non è stato in alcun modo provato. Ed infatti gli argomenti evidenziati a tale proposito dalla difesa, da cui emergerebbe che l’attività inquirente è stata svolta con una sorta di accanimento o di “interpretazione meramente congetturale e illogica” delle emergenze, rappresentano in realtà - come la Cassazione ha riconosciuto - l’espletamento delle funzioni che l’ufficio di Procura è chiamato a condurre istituzionalmente. Analogamente i provvedimenti giurisdizionali indicati dalla difesa come “l’espressione di un pesante condizionamento ed inquinamento dell’attività giurisdizionale” non sono altro che le motivate e ponderate valutazioni dell’organo giudicante.
Si ha anzi l’impressione che la difesa tenti di ottenere – tramite l’istanza di rimessione – una nuova valutazione degli elementi posti alla base delle misure cautelari, in tale sede non consentita. È evidente che nel successivo corso processuale, il complessivo compendio probatorio dovrà essere sottoposto ad un vaglio particolarmente stringente in relazione alle varie ricostruzioni del delitto emerse nella fase di indagine, ma certo l’eventuale rivisitazione degli elementi emersi spetterà alla Corte d’Assise e non alla Cassazione, né può essere veicolata da un’istanza di rimessione.
Resta da aggiungere che in più occasioni la Cassazione ha ricordato come non solo le campagne di stampa, ma anche le pressioni dell’opinione pubblica, non sono di per sé idonee a condizionare la libertà di determinazione del giudice.
Ed infatti chi svolge funzioni giudiziarie è abituato a compiere scelte ed attività che sono oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica, e spesso di critica anche esasperata. Ma il giudice non per questo svolge le sue funzioni con un’indipendenza menomata o con un giudizio minato da imparzialità.
Sarah Scazzi. Mentre la Cassazione lascia il processo a Taranto in procura ci si interroga per capire qual è il sogno migliore, scrive Massimo Prati su “Volando Contro Vento”. Volevate il processo a Potenza? Per quale motivo visto che a Taranto, a parte il tribunale invivibile in estate (ma le udienze sono iniziate e siamo solo in autunno), si sta benissimo? E vero, a Potenza l'aria è fresca e si è meno ossessionati, ma vuoi mettere il gustarsi il mare in inverno? Quindi si resta a Taranto, tutti se ne facciano una ragione perché, come ha detto il procuratore Franco Sebastio, anche fosse cambiata la sede il quadro accusatorio sarebbe rimasto invariato. Per cui, dato che il quadro rimarrà invariato ed il processo si celebrerà nel luogo di origine, dobbiamo aspettarci prima una condanna a 30 anni e poi un'assoluzione in Appello (ultimamente capitano queste cose in Italia)? Può sembrare io vada controcorrente dato che tutti i giornalisti ieri e ieri l'altro hanno scritto di una nuova vittoria delle Misseri (tutti tranne il solito noto che ha scambiato i giudici di Cassazione con quelli di Assise). E questo perché nel Palazzaccio romano si è stabilito che le decisioni dei giudici di Taranto devono essere riviste in quanto fallaci in quasi ogni punto. Ed è vero, la Cassazione ha cassato per l'ennesima volta i giudici di Taranto e, per essere onesti, li ha pure bacchettati di brutto. Ma a guardare bene il tutto non sono io ad andare controcorrente in quanto nella stessa sentenza si accreditano un sogno, basta decidersi e dire quale dei tre portati dagli inquirenti ai giudici si ritiene giusto, le testimonianze ex novo di chi in prima ed in seconda battuta aveva dato orari differenti, ed un range cronologico all'interno del quale Sarah sarebbe morta. Per lo meno si accredita la formula ed il metodo usati dai giudici nell'accettarli. E non può essere che così dato che non è compito della Cassazione andare nel dettaglio e decidere se quanto portato dalla procura ha basi solide, e ci sarà tempo e modo per l'Accusa di ribadirle a processo, le testimonianze, e cercare di farle diventare verità definitive, e ci sarà tempo e modo per la Difesa di provare a tornare alla prima tesi. Ed io credo non sia così complicato, perché se non paiono fallaci quattro testimonianze che cambiano nel tempo, inizialmente concordanti in tutto e per tutto, anticipando o spostando gli orari in modo da tornare ad essere concordanti per affrancare una nuova ricostruzione, significa che il modo di fare chiarezza è ambiguo e non idoneo ad entrare in un processo. Significa che nessun alibi portato a discolpa potrà mai ritenersi valido. E non solo a Taranto ma ovunque ed in qualsiasi processo lo si porti. Significa che ai procuratori basterà convincere chi indirettamente l'alibi l'ha fornito, meglio ancora se assecondato da chi fa tele-disinformazione, specialmente nei più seguiti programmi pomeridiani (vanno bene sia la D'Urso con gli onnipresenti avetranesi, a partire da Anna Pisanò, sia la Venier coi suoi opinionisti e psicanalisti tascabili, buoni per tutte le occasioni, escluso il Marazzita), per poter disporre di una diversa ricostruzione dei fatti, per poter disporre di un maggiore spazio temporale e di un alleato in più. E questo non è ciò che voleva chi ha scritto le tavole della legge. Non lo voleva ma è quanto avviene in Italia, ed è già avvenuto, da quando le indagini sono seguite ossessivamente dai media. Tanto che pare quasi un fatto normale, nei giorni o nei mesi, il cambiare le testimonianze acquisite. E che i giudici credano che il tempo agevoli il ricordo a me pare una presa per i fondelli bella e buona. Come può la mia mente, fra due tre o quattro mesi, ricordare meglio ciò che ha visto ieri o una settimana fa? Come può la mia mente dopo essere stata il bersaglio continuo dei programmi televisivi pregiudizievoli, programmi in cui mi hanno detto e ripetuto che i magistrati "hanno una montagna di prove così" e che quella determinata persona è un'assassina, programmi che mi hanno fatto cambiare idea sull'uomo che inizialmente ritenevo un orco ed ora ritengo manipolato, perché ha "solo" gettato il corpo della nipote in una cisterna piena d'acqua (è stato costretto il poverino)... ripeto, come può la mia mente essere tranquilla e neutrale ad ogni interrogatorio in cui mi si dice che quanto ho dichiarato precedentemente non ci sta nel quadro accusatorio già sistemato e concordante? Come può la mia mente non credere di essersi sbagliata visto che il tam tam mediatico mi continua a dire che non è quello l'orario in cui ho visto e che per essere giusto deve spostarsi di, addirittura, 35/40 minuti? Ma i giudici di Cassazione, oltre ad aver concordato con quelli di Taranto che le procedure giuridiche adottate per anticipare o spostare gli orari erano nelle regole, in un certo senso hanno reso valido, anche se in modo del tutto particolare, uno dei sogni del fioraio. Certo è che in procura devono decidere quale sogno e quale ricostruzione vogliano portare al processo, visto che al momento ne stanno utilizzando tre, ed è ora che optino per la ricostruzione che ritengono migliore. Ma qual'è la migliore? Quella della coppia Cerra/Pisanò che parla di un sequestro avvenuto in via Deledda con Sarah presa per i capelli e trascinata in casa, racconto che si dice fatto dal fiorista alla Cerra poi da questa a sua madre e da quest'ultima ai magistrati? Oppure la migliore è quella delle sorelle Scredo? In questa si è parlato di un sogno dove si diceva ci fosse stato uno strangolamento avvenuto in auto da parte di un ombra robusta dai capelli neri chiamata Sabrina Misseri. Anche nel caso in questione il tutto è partito dalle parole del fiorista, stavolta però da quelle dette alla moglie, che passando di bocca in bocca sono arrivate alla Giuseppina Scredo e sono state scoperte dagli inquirenti, grazie alle intercettazioni telefoniche, mentre la stessa le riportava alla sorella Anna. Ma non sarà che dopo averlo tolto dagli imputati del processo principale, ed averlo messo in stand-by in attesa di decisioni, verrà accettata la ricostruzione dello stesso Buccolieri che, sempre in via onirica, ha semplicemente detto di aver visto la Serrano intimare alla nipote di salire in auto? Perché c'è una enorme differenza fra una testimonianza e l'altra, è innegabile, ed a mio modo di vedere pare che nei giorni, anzi nei mesi, il racconto del fioraio sia stato ripreso da più persone e sia stato, in base a chi lo ha ascoltato e ripetuto, modificato più volte e da più bocche (il solito telefono senza fili). Ma forse la mia è una mente troppo pessimista e condizionata da quanto visto e letto nel tempo, perché la sentenza è sostanzialmente davvero favorevole alle donne ora in carcere. I giudici di Cassazione hanno scoperto quali trucchi sono stati usati da chi continuamente metteva in scena nuovi giochi di prestigio. Hanno scoperto che sarebbe potuto accadere (ma il mio è uno scrivere per assurdo) che Sabrina Misseri fosse processata e condannata due volte, visto che ha due imputazioni diverse per la stessa accusa. Hanno scoperto che non ci sono indizi validi a pronosticare una certa condanna e che, quindi, la ragazza sta in carcere da un anno in base al nulla. Hanno scoperto che non si sa ancora quale sia il luogo in cui i magistrati di Taranto vogliano collocare l'omicidio, in auto, in casa, in garage, sotto il fico, in piazza, dal fiorista? Hanno scoperto che al tribunale di Taranto dal 1987 non amano aggiornarsi sulle Leggi che periodicamente entrano a far parte del Codice Penale italiano. Hanno scoperto che non si è dato spazio alla perizia della Difesa, quella sulla localizzazione dei cellulari, preferendo non aprirla neppure e continuare con la perizia che più li agevolava. Hanno scoperto che a Taranto ci si è dimenticati di ascoltare il Misseri quando ne ha fatto richiesta ed anche dopo, sia quando ha cambiato versione che quando si è inserito agli atti un suo soliloquio, dando di questo un'interpretazione parziale senza chiedere all'occultatore cosa volesse significare in realtà con quelle parole. Hanno scoperto che non si è cercato di capire cosa intendesse dire Sabrina Misseri quando "confessava" la sua colpevolezza ad Anna Pisanò, preferendo accettare le dichiarazioni di quest'ultima senza approfondirne il significato. Hanno scoperto che non esiste motivo alcuno, i giudici di Taranto non l'hanno scritto, che spieghi la carcerazione di Cosima Serrano. Hanno scoperto che i magistrati pugliesi non sanno se questa fosse a conoscenza dello "sfrenato amore" di sua figlia nei confronti di Ivano, non ci sono risultanze che lo provino, hanno scoperto che la si è inserita nel delitto, sia avvenuto in auto oppure in casa o in qualsiasi altra parte, senza giustificarne i motivi. Perché Cosima Serrano avrebbe dovuto aiutare sua figlia ad uccidere la nipote? Per "amore di mamma"? Ed inoltre a Roma hanno capito, salvo poi chiedere ai giudici tarantini di decidere quale ricostruzione accettare (come ho scritto sopra), che non si può ascrivere alle indagate il "sequestro di persona" in base a tre modus operandi onirici differenti e difficilmente provabili. Insomma, il caos continua in quel di Taranto. Però, seppure ora i magistrati debbano mettersi in riga, studiare ed aggiornarsi maggiormente, dopo la sentenza che li ha cassati all'80% nell'animo hanno qualche speranza di condanna in più. Una nasce dai cellulari delle due arpie che il giorno successivo la scomparsa non stavano, come detto dai loro difensori, alla ricerca della nipote ma stazionavano nei pressi di una cisterna. Questo la Cassazione non l'ha cassato, ma per renderlo credibile dovranno trovare il modo di restringere il raggio d'azione della cella che ha agganciato i cellulari, al momento di una ventina di chilometri. Un'altra nasce dal fatto che a Roma non si sono permessi di entrare nello specifico, guardando solo la forma e la scrittura, ed hanno lasciato passare liscia l'affermazione che vuole l'omicidio avvenuto fra le 14.00 e le 14.40. Ciò però non significa che il delitto si sia compiuto fra le 14.05 e le 14.15 (come ha scritto il patologo e come affermano i procuratori) perché potrebbe essere avvenuto anche 25 minuti dopo e restare ugualmente in questo lasso di tempo. Perciò il dire che si possono accettare le ricostruzioni degli orari accertati dalla procura, a riguardo di quanto fatto da Sarah prima della sua morte, anche se pare una forzatura per via delle testimonianze postume, in realtà non è sbagliato. Per capirlo basta fare un ragionamento logico (come ho scritto non toccava alla Cassazione farlo o spiegarlo ma lo si farà in Assise... chi lo spiega questo al giornalista pugliese?). Gli inquirenti tarantini danno credito al dottor Strada che in perizia scrive la morte essere giunta ad un'ora dall'aver mangiato il cordon bleu. E tutto andrebbe a posto se Sarah l'avesse mangiato alle 13.10. Ma le nuove testimonianze della madre e della badante vogliono che la ragazzina lo abbia mangiato alle 13.30, dopo aver ricevuto (a suo dire) il messaggio della cugina e poco prima di prepararsi per uscire di casa (l'orario è agli Atti). Ebbene, in base a questo è capibile da tutti che l'aggressione non può essere iniziata che attorno alle 14.30, e non fra le 14.05 e le 14.15 come si ipotizza nella ricostruzione della procura (che ha inserito appositamente un sms ed una telefonata dell'amica, a cui Sarah non ha risposto, per far credere che alle 14.18 fosse già cadavere). E se l'aggressione si posiziona sulle 14,30, e con quanto portato in Cassazione (pur non volendolo dire) lo dicono i Pm che prendono come base la perizia di Luigi Strada e non io, i minuti disponibili per l'omicidio, parlo di quelli necessari a Sabrina Misseri, tornano ad essere insufficienti per lei ma sufficienti per altri. O vogliamo credere che mentre la figlia spediva e riceveva messaggi la madre faceva il "lavoro sporco"? Perché o crediamo questo o siamo bloccati dalla ricostruzione della procura. Ed a meno che i Pm non tornino da Concetta Serrano e dalla badante romena per cercare un diverso orario del pasto grazie ad altri sforzi mnemonici...
LA RIMESSIONE DEI PROCESSI PER LEGITTIMO SOSPETTO (SUSPICIONE): UNA NORMA MAI APPLICATA. CONTRO LO STRAPOTERE DELLE TOGHE (MAGISTRATI ED AVVOCATI) DISPONETE L’ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO GIUDIZIARIO. PROPOSTA DI LEGGE IN CALCE.
PREMESSA
Il Popolo della libertà scende in piazza sabato 11 maggio 2013 a Brescia "in difesa di Silvio Berlusconi". Alle numerose esternazioni di esponenti del suo partito su un "uso politico della giustizia" segue quella dello stesso Berlusconi: "La sentenza di ieri è davvero una provocazione preparata dalla parte politicizzata della magistratura che da vent'anni cerca di eliminarmi come principale avversario della sinistra e il rinvio a giudizio di Napoli fa parte di questo uso politico della giustizia". Da una parte vi è Silvio Berlusconi che si presenta come vittima sacrificale della magistocrazia e dall’altra il solito Marco Pannella con i suoi scioperi della fame e della sete per denunciare la detenzione dei carcerati nei canili per umani. Puntano l’indice su aspetti marginali del problema giustizia. Eppure loro sono anche quei politici che da decenni presentano le loro facce in tv. Tutto fa pensare che non gliene fotte niente a nessuno se i magistrati sono quelli che sono, pur se questi, presentandosi e differenziandosi come coloro che vengono da Marte, sono santificati dalla sinistra come unti dall’infallibilità. Tutto fa pensare che se si continua a dire che Berlusconi è una vittima della giustizia (e solo lui) e che le celle sono troppo piccole per i detenuti, non si farà l’interesse di coloro che in carcere ci sono, sì, ma sono innocenti. Bene, Tutto questo fa pensare che dopo i proclami tutto rimarrà com’è. E tutto questo nell’imperante omertà dei media che si nascondo dietro il dito dell’ipocrisia. Volete un esempio di come un certo modo di fare comunicazione ed informazione inclini l’opinione pubblica a parlare di economia e solo di economia, come se altri problemi più importanti non attanagliassero gli italiani?
La mafia cos'è? La risposta in un aneddoto di Paolo Borsellino: «Sapete che cos'è la Mafia... faccia conto che ci sia un posto libero in tribunale..... e che si presentino 3 magistrati... il primo è bravissimo, il migliore, il più preparato.. un altro ha appoggi formidabili dalla politica... e il terzo è un fesso... sapete chi vincerà??? Il fesso. Ecco, mi disse il boss, questa è la MAFIA!»
«La vera mafia è lo Stato, alcuni magistrati che lo rappresentano si comportano da mafiosi. Il magistrato che mi racconta che Andreotti ha baciato Riina io lo voglio in galera». Così Vittorio Sgarbi il 6 maggio 2013 ad “Un Giorno Da Pecora su Radio 2.
«Da noi - ha dichiarato Silvio Berlusconi ai cronisti di una televisione greca il 23 febbraio 2013 - la magistratura è una mafia più pericolosa della mafia siciliana, e lo dico sapendo di dire una cosa grossa». «In Italia regna una "magistocrazia". Nella magistratura c'è una vera e propria associazione a delinquere» Lo ha detto Silvio Berlusconi il 28 marzo 2013 durante la riunione del gruppo Pdl a Montecitorio. Ed ancora Silvio Berlusconi all'attacco ai magistrati: «L'Anm è come la P2, non dice chi sono i loro associati». Il riferimento dell'ex premier è alle associazioni interne ai magistrati, come Magistratura Democratica. Il Cavaliere è a Udine il 18 aprile 2013 per un comizio.
Qui non si vuole criminalizzare una intera categoria. Basta, però, indicare a qualcuno che si ostina a difendere l’indifendibile che qualcosa bisogna fare. Anzi, prima di tutto, bisogna dire, specialmente sulla Rimessione dei processi.
Questa norma a vantaggio del cittadino è da sempre assolutamente disapplicata e non solo per Silvio Berlusconi. Prendiamo per esempio la norma sulla rimessione del processo prevista dall’art. 45 del codice di procedura penale. L'articolo 45 c.p.p. prevede che "in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
Tale istituto si pone a garanzia del corretto svolgimento del processo, dell'imparzialità del giudice e della libera attività difensiva delle parti. Si differenzia dalla ricusazione disciplinata dall'art. 37 c.p.p. in quanto derogando al principio costituzionale del giudice naturale (quello del locus commissi delicti) e quindi assumendo il connotato dell'eccezionalità, necessita per poter essere eccepito o rilevato di gravi situazioni esterne al processo nelle sole ipotesi in cui queste non siano altrimenti eliminabili. Inoltre mentre per la domanda di ricusazione è competente il giudice superiore, per decidere sull'ammissibilità della rimessione lo è solo la Corte di Cassazione.
«L’ipotesi della rimessione, il trasferimento, cioè, del processo ad altra sede giudiziaria, deroga, infatti, alle regole ordinarie di competenza e allo stesso principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione) - spiega Edmondo Bruti Liberati, già Presidente dell’Associazione nazionale magistrati. - E pertanto già la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che si tratta di un istituto che trova applicazione in casi del tutto eccezionali e che le norme sulla rimessione devono essere interpretate restrittivamente. Nella rinnovata attenzione sull’istituto della rimessione, determinata dalla discussione della proposte di modifica (2002, legge Cirami), numerosi commenti – comparsi sulla stampa – rischiano di aver indotto nell’opinione pubblica l’impressione che l’istituto del trasferimento dei processi trovi applicazione ampia e che dunque la magistratura italiana ricorrentemente non sia in grado di operare con serenità di giudizio. Vi fu una sola difficile stagione dei primi decenni della nostra Repubblica, in cui numerosi processi per fatti di mafia furono trasferiti dalle sedi giudiziarie siciliane in altre regioni: era il segno umiliante della fragilità delle istituzioni, di uno Stato incapace di assicurare serenità allo svolgimento del processo e di garantire protezione ai giudici popolari di fronte alle minacce. Era una stagione in cui i processi, pur trasferiti ad altra sede, si concludevano pressoché ineluttabilmente con le assoluzioni per insufficienza di prove. Superata questa fase, e pur sotto la vigenza della norma del Codice di procedura penale del 1930 – che prevedeva la formula del «legittimo sospetto» –, in un periodo di diversi decenni i casi di rimessione sono stati pochissimi: intendo dire poche unità. I casi più noti di accoglimento, di norma ad iniziativa degli uffici del Pm, determinarono polemiche e reazioni. (Ad esempio, i fatti di Genova del luglio 1960, la strage del Vajont, la strage di Piazza Fontana, l’appello sul ‘caso Zanzara’, il caso delle schedature alla Fiat). Avanzava tra i giuristi la tesi che fosse necessaria una più puntuale e rigorosa indicazione dei motivi suscettibili di determinare il trasferimento. Il Parlamento, dopo le polemiche per il trasferimento del processo per la strage di Piazza Fontana da Milano a Catanzaro, interveniva per dettare dei criteri stringenti per la designazione del nuovo giudice (legge 773/1972 e successivamente legge 879/1980, che introdusse il criterio automatico tuttora vigente). La lettura delle riviste giuridiche, dei saggi in materia e dei codici commentati ci presenta una serie lunghissima di casi, in cui si fa riferimento alle più disparate situazioni di fatto per concludere che la ipotesi di rimessione è stata esclusa dalla Corte di cassazione. Pochissimi sono dunque fino al 1989 stati i casi di accoglimento: l’ordine di grandezza è di una dozzina in tutto. Il dato che si può fornire con precisione – ed è estremamente significativo – riguarda il periodo dopo il 1989, con il nuovo Codice di procedura penale: le istanze di rimessione accolte sono state due.»
«Per quanto concerne la remissione per motivi di legittimo sospetto occorre che i capi delle procure generali si attengano a una concezione rigorosamente ristretta dell'istituto». La circolare ministeriale che abbiamo citato non esce dagli archivi del governo Prodi e neppure dal cassetto del terribile ex procuratore di Milano, Francesco Saverio Borrelli. Si tratta invece di una direttiva piuttosto chiara che il ministro fascista Dino Grandi inviava a tutti i tribunali italiani nel 1939, consigliando loro di usare la legittima suspicione con cautela. Eppure se si dà uno sguardo alla storia giudiziaria italiana, se si ritorna su quei casi in cui la legittima suspicione è stata accolta vengono i brividi e si capisce perché la legittima suspicione si trasformi nel legittimo sospetto contro giudici, pubblici ministeri, tribunali. Il caso più drammatico, più doloroso, in cui l'accettazione della legittima suspicione fece danni incalcolabili fu il processo per la strage di piazza Fontana. Non è il caso di soffermarsi più di tanto su quel buco nero della nostra storia. E' tristemente noto: la legittima suspicione riuscì a strappare il processo ai giudici di Milano in un clima golpista e lo trasferì a Catanzaro. Per trent'anni la verità sulla strage rimase sotterrata dalla collusione tra servizi, governi e apparati militari. Il processo di piazza Fontana è il caso più clamoroso ma non certo il primo. Basta scartabellare negli archivi giudiziari per trovare le vittime della legittima suspicione. A due anni dalla fine della guerra si giunge al drammatico processo per la strage di Portella delle Ginestre. Il processo viene spostato da Palermo a Viterbo: la banda di Salvatore Giuliano viene condannata ma i mandanti assolti. Nel 1963 ci imbattiamo nel disastro del Vajont: il processo da Venezia viene trasferito a L'Aquila dove la strage viene definita «evento imprevedibile» e dove governo e Enel vengono assolti. Nello stesso anno il processo per la strage di Ciaculli viene trasferito da Palermo a Catanzaro. Buscetta viene condannato ma altri mafiosi del peso di Pippò Calò se la cavano. Se si leggono gli atti dei processi per mafia si scopre che la richiesta di legittima suspicione viene utilizzata a man bassa, come una chiave magica usata per ottenere in sedi più consone assoluzioni totali o per insufficienza di prove. Il caso più clamoroso è quello di Luciano Liggio, precursore e maestro di Totò Riina. Dopo l'esordio del 1948 con l'uccisione del segretario della Camera del Lavoro di Corleone, Placido Rizzotto, Liggio nel `58 ammazza il boss concorrente Michele Navarra. Liggio viene processato ma prevale la legittima suspicione: nel processo di Bari il fondatore della corrente dei corleonesi viene assolto dal tribunale di Bari per insufficienza di prove. Un altro caso clamoroso fu quello delle schedature Fiat. Negli anni `60 fu proprio Milano il luogo in cui si celebrò il processo alla Zanzara. Quelli sopra i cinquant'anni si ricorderanno che la Zanzara era un giornalino fatto dagli studenti del Liceo Parini usato per contestare ante litteram le regole del conformismo e dell'educazione borghese. In base a denunce e lamentele della parte più reazionaria dei genitori e dell'opinione pubblica ne nacque un processo che fece grande scandalo. Per evitare che nello scandalo finisse il buon nome di qualche famiglia milanese fu invocato addirittura l'ordine pubblico e per legittima suspicione il processo finì a Genova. Nel 1989, comunque, il legislatore decide che le maglie della legittima suspicione sono troppo larghe e discrezionali e soprattutto che vengono usate come strumento per impedire la celebrazione dei processi. A spingere al cambiamento sono proprio i numerosi processi per mafia finiti con l'assoluzione per insufficienza di prove. Viene introdotta una nuova norma, quella attuale. L'introduzione di questa norma restrittiva taglia le unghie a coloro che usavano la legge come un grimaldello, ma limita anche i diritti di coloro che hanno sospetti fondati . Per tutti gli anni `90 i ricchi avvocati dei ricchissimi imputati per tangenti tentano di utilizzare la legittima suspicione per farla franca. Il caso che tutti ricordano è quello di Bettino Craxi che durante la bufera di tangentopoli chiede attraverso i suoi legali ai giudici della Cassazione di spostare da Milano i numerosi processi a suo carico. La richiesta viene presentata in tutte le sedi processuali ma viene respinta proprio perché la suprema Corte si trova a dover fare i conti con una norma restrittiva che lascia poco scampo a chi vuole fare il gioco delle tre carte.
Il 6 maggio 2013 è stata respinta l'istanza di Berlusconi di trasferimento a Brescia dei suoi processi a Milano. La richiesta di trasferimento è basata sul legittimo sospetto che ci sia un accanimento giudiziario, “un’ostilità” da parte della sede giudiziaria del capoluogo lombardo (che giudica sul caso della giovane marocchina) e da parte della Corte d’Appello, che si occupa del processo Mediaset, nei confronti del Cavaliere. In quaranta pagine, stilate dai legali e giunte in Cassazione a metà marzo, vengono rappresentate una serie di decisioni, atteggiamenti e frasi pronunciate in aula dai giudici che sarebbero la dimostrazione dell’accanimento nei confronti del leader del Pdl; tra queste le ordinanze con cui sono stati negati i legittimi impedimenti, le visite fiscali a carico di Berlusconi ricoverato al San Raffaele per uveite, la sentenza del caso Unipol dove gli non sono state concesse le attenuanti generiche, la fissazione di 4 udienze in 7 giorni nel processo Ruby, e alcune affermazioni in aula del procuratore aggiunto Ilda Boccassini e del presidente del collegio, Giulia Turri. Nel 2003 la richiesta di trasferire da Milano a Brescia i processi del cosiddetto filone toghe sporche (Imi-Sir/Lodo Mondadori), in cui era imputato Cesare Previti (mentre Berlusconi era stato prosciolto per prescrizione) fu respinta dai giudici, i quali ritennero che la situazione prospettata non potesse far ipotizzare un concreto pericolo di non imparzialità a Milano.
A volte però non c'è molto spazio per l'interpretazione. Il sostituto procuratore generale Gabriele Mazzotta è chiarissimo: «Una serie di indicatori consentono di individuare un'emotività ambientale tale da contribuire all'alterazione delle attività di acquisizione della prova». È l' ennesimo colpo di scena sul caso Avetrana. Mazzotta parla davanti alla prima sezione penale della Cassazione dove si sta discutendo la richiesta di rimessione del processo per l'omicidio di Sarah Scazzi: i difensori di Sabrina Misseri, Franco Coppi e Nicola Marseglia, chiedono di spostare tutto a Potenza perché il clima che si respira sull'asse Avetrana-Taranto «pregiudica la libera determinazione delle persone che partecipano al processo». Ed a sorpresa il sostituto pg che rappresenta la pubblica accusa sostiene le ragioni della difesa e chiede lui stesso che il caso venga trasferito a Potenza per legittima suspicione. A Taranto, in sostanza, non c'è la tranquillità necessaria per giudicare le indagate. Per spiegare in che cosa consiste la «grave situazione locale» che «turberebbe lo svolgimento del processo», Mazzotta si dilunga sull'arresto di Cosima (la madre di Sabrina) avvenuto praticamente in diretta tivù dopo la fuga di notizie che l'aveva preannunciato («Fu un tentativo di linciaggio» dice il professor Coppi), parla di testimoni presenti a raduni di piazza che contestavano Cosima, ricorda le pietre e le intimidazioni contro Michele Misseri, il marito di Cosima e padre di Sabrina che fece ritrovare il cadavere di Sarah e confessò di averla uccisa dopodiché cambiò versione più volte, accusò sua figlia dell'omicidio e tornò di nuovo al primo racconto («Ho fatto tutto da solo, Sabrina e Cosima sono innocenti»). Per riassumerla con le parole di Coppi: «L'abbiamo sempre detto, in questo procedimento sono avvenuti fatti di una gravità oggettiva e se non c'è serenità è giusto trasferirlo». Per argomentare meglio la sua richiesta, Coppi ha citato la sentenza Imi-Sir/lodo Mondadori del 2003 (imputati Previti e Berlusconi) con la quale le Sezioni Unite della Cassazione stabilirono che in quel procedimento non ci fu legittima suspicione. Tutti i punti che in quel processo motivarono la mancanza del legittimo sospetto, nel caso Avetrana dimostrano, secondo Coppi, esattamente il contrario: cioè che esiste la legittima suspicione.
Eppure nonostante il dettato della legge fosse chiaro, la Corte di Cassazione per l'ennesima volta ha rigettato l'istanza.
Nel novembre del 2002 fu approvata la legge Cirami che riformulò i criteri del legittimo sospetto ampliando le possibilità di togliere un processo al suo giudice naturale. Nonostante ciò da allora non sono stati registrati casi di legittima suspicione. I più noti riguardano trasferimenti ottenuti con la vecchia legge Piazza Fontana ll processo non si tenne a Milano, luogo della strage del 1969 (foto), ma a Catanzaro. La Suprema Corte temeva che a Milano fosse a rischio la sicurezza: il Palazzo di giustizia sarebbe stato assediato dalle contestazioni di piazza Vajont. Il processo per il disastro del Vajont (nel 1963) fu trasferito da Belluno all'Aquila. La Cassazione vide pericoli, anche qui, per l' ordine pubblico Salvatore Giuliano Il bandito accusato di essere l' esecutore della strage di Portella della Ginestra (1947) fu rinviato a giudizio a Palermo ma poi la Cassazione spostò il processo a Viterbo.
L'imputazione di quattro avvocati nelle indagini per l’omicidio di Sarah Scazzi è "sconcertante e inquietante". L’Unione delle camere penali scende in campo contro i pubblici ministeri del caso di Avetrana e chiede al ministro della Giustizia l’invio di ispettori alla procura di Taranto. Lo fa nel silenzio assordante della Camera Penale e dell'intero Consiglio dell'ordine degli avvocati di Taranto, assuefatti o collusi alle anomalie del foro tarantino. Anomalie su cui vi è una coltre di omertà forense e giudiziaria e di censura mediatica. Per l’Ucpi è “assurdo che nel medesimo procedimento si trattino questioni riguardanti il delitto e questioni relative all’indagine sul delitto stesso”. Ma "ancora più grave è che alcune contestazioni mosse a due avvocati letteralmente s'intromettono indebitamente nelle scelte e nelle strategie difensive, le quali dovrebbero, al contrario, costituire un recinto invalicabile e coperto dal segreto professionale".
C'è dunque una "grave violazione del diritto di difesa" da parte dei pm. E in particolare è “sconcertante quanto capita all’avvocato De Cristofaro, il quale per aver sostenuto l'assunzione di responsabilità del proprio assistito, da quest’ultimo reiteratamente dichiarata, si ritrova indagato per 'infedele patrocinio dai pubblici ministeri che si prefiggono l'obiettivo di provare la responsabilità di altra e diversa persona". Secondo i penalisti, "si è verificato un 'corto circuito all’interno del quale i pm che sostengono l'accusa hanno elevato un’imputazione, per un reato riguardante in astratto le condotte del difensore che si pongono in contrasto con l’interesse del proprio assistito, che già a una prima lettura appare addirittura paradossale, poiché‚ si fonda su fatti che dimostrano in maniera lampante il contrario, e cioè che il difensore ha viceversa dato seguito alle richieste del proprio assistito.
In realtà, i pm procedenti hanno valutato come contrastante con l’interesse dell’imputato, puramente e semplicemente, una versione dei fatti da questi offerta che confligge con l’ipotesi di accusa e lo hanno fatto sulla scorta della loro ricostruzione dei fatti". Insomma, "oltre a ergersi arbitri della formulazione dell’accusa, i pm pretendono di determinare anche l’interesse dell’imputato a sostenere l’una o l’altra tesi, e nel far questo criminalizzano l’attività del difensore, il che appare una intollerabile violazione del diritto di difesa oltre che l'espressione di una cultura apertamente inquisitoria. Con il risultato, inquietante e certamente non ignorato, che attraverso la contestazione elevata si vorrebbe determinare, allo stato, un obbligo deontologico di astensione da parte del difensore che, in consonanza con il proprio assistito, ha sostenuto una tesi avversa rispetto a quella caldeggiata dalla Procura". Non solo: "Nel corso dell’indagine le attività difensive - lamenta l’Ucpi - sono state costantemente oggetto di controllo da parte della autorità giudiziaria, e anche di decisioni assai stravaganti quale quella di autorizzare l’espletamento di un atto di parte, come l’assunzione di informazioni, 'alla presenza dei pm procedenti oppure di imporre il potere di segretazione nei confronti di persone sottoposte alle indagini". Tutto ciò si riverbera nell'ipotesi di affrancarsi il diritto di poter far scegliere agli imputati i difensori che più aggradano ai Pm. L'avv. De Cristofaro, per forza di cose prenderà in considerazione la concreta possibilità di rilasciare l'incarico trovandosi in una situazione di contrasto con il suo cliente, mentre per i P.M. l'operato del suo predecessore, l'avv. Galoppa era conforme se non strumentale alle loro attività.
Tutto questo lo sa bene il dr Antonio Giangrande di Avetrana, presidente dell'Associazione Contro Tutte le Mafie, che nel denunciare codeste anomalie, viene perseguitato dai magistrati criticati, con il benestare della Corte di Cassazione, che non rileva affatto il legittimo sospetto che i loro colleghi tarantini possano essere vendicativi contro chi si ribella.
29 agosto 2011. La rimessione del processo per incompatibilità ambientale. «Le lettere scritte da Michele Misseri le abbiamo prodotte perchè‚ sono inquietanti non tanto per il fatto che lui continua ad accusarsi di essere lui l'assassino, ma proprio perchè mettono in luce questo clima avvelenato, in cui i protagonisti di questa inchiesta possono essere condizionati». Lo ha sottolineato alla stampa ed alle TV l’avv. Franco Coppi, legale di Sabrina Misseri riferendosi alle otto lettere scritte dal contadino di Avetrana e indirizzate in carcere alla moglie Cosima Serrano e alla figlia Sabrina, con le quali si scusa sostenendo di averle accusate ingiustamente. «Michele Misseri – aggiunge l’avv. Coppi – afferma che ci sono persone che lo incitano a sostenere la tesi della colpevolezza della figlia e della moglie quando lui afferma di essere l’unico colpevole e avanza accuse anche molto inquietanti. Si tratta di lettere scritte fino a 7-8 giorni fa». «Che garanzie abbiamo – ha fatto presente il difensore di Sabrina Misseri – che quando dovrà fare le sue dichiarazioni avrà tenuta nervosa e morale sufficiente per affrontare un dibattimento?». «La sera c'è qualcuno che si diverte a sputare addosso ad alcuni colleghi impegnati in questo processo. I familiari di questi avvocati non possono girare liberamente perchè c'è gente che li va ad accusare di avere dei genitori o dei mariti che hanno assunto la difesa di mostri, quali sarebbero ad esempio Sabrina e Cosima. Questo è il clima in cui siamo costretti a lavorare ed è il motivo per cui abbiamo chiesto un intervento della Corte di Cassazione». «E' bene – ha aggiunto l'avvocato Coppi – allontanarci materialmente da questi luoghi. Abbiamo avuto la fortuna di avere un giudice scrupoloso che ha valutato gli atti e ha emesso una ordinanza a nostro avviso impeccabile. La sede alternativa dovrebbe essere Potenza. Non è che il processo si vince o si perde oggi, ma questo è un passaggio che la difesa riteneva opportuno fare e saremmo stati dei cattivi difensori se per un motivo o per l'altro e per un malinteso senso di paura non avessimo adottato questa iniziativa».
Intanto Sabrina Misseri si sente come Amanda Knox. Era inevitabile che la ragazza americana, assolta dall’accusa di omicidio di Meredith Kercher dopo quattro anni di carcere, sarebbe diventata il simbolo dell’accanimento giudiziario. Tutti coloro che pensano di trovarsi in prigione ingiustamente usano lei come termine di paragone. L’ha fatto Sabrina Misseri, in carcere per l’altro delitto mediatico italiano, quello di Sarah Scazzi. Sabrina, dal carcere di Taranto, ha detto: “Mi sento come Amanda“. La ragazza di Avetrana, come l’americana e come l’italiano Raffaele Sollecito, sostiene di essere innocente e di essere stata arrestata ingiustamente.
Censurato dalla stampa è che la Corte di Cassazione, di fatto, a vantaggio della magistratura disapplica una legge dello Stato. L’art. 45 c.p.p. parla di Rimessione del processo in caso di emotività ambientale che altera l’acquisizione della prova o ne mina l’ordine pubblico, ovvero per legittimo sospetto che l’ufficio giudiziario non sia sereno nel giudicare, anche indotto da grave inimicizia. Di fatto la legge Cirami non è mai stata applicata, nonostante migliaia di istanze, anche di peso: Craxi, Berlusconi, Dell’Utri. Rigetto ad oltranza: sempre e comunque. Nel novembre del 2002 fu approvata la legge Cirami che riformulò i criteri del legittimo sospetto ampliando le possibilità di togliere un processo al suo giudice naturale. Da allora non sono stati registrati casi di legittima suspicione. I più noti riguardano trasferimenti ottenuti con la vecchia legge:
Piazza Fontana, il processo non si tenne a Milano, luogo della strage del 1969, ma a Catanzaro. La Suprema Corte temeva che a Milano fosse a rischio la sicurezza: il Palazzo di giustizia sarebbe stato assediato dalle contestazioni di piazza. Per Piazza Fontana, in cui vi era sospetto che fosse una strage di Stato: è il primo e più famoso caso di "rimessione". Tutti i processi collegati furono trasferiti a Catanzaro a partire dal 1972, proprio mentre i magistrati milanesi D'Ambrosio e Alessandrini imboccavano la pista della "strage di Stato". Curiosità: il primo dei ricorsi accolti dalla Cassazione fu proposto dall'imputato Giovanni Biondo, che dopo l'assoluzione diventò sostituto procuratore.
Per il Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Cerciello, le cui indagini contro la Guardia di Finanza furono svolte dai propri commilitoni: il 29 novembre 1994 la Cassazione ha spostato da Milano a Brescia il processo per corruzione contro il generale Cerciello. L'avvocato Taormina aveva messo in dubbio tutte le indagini sulle tangenti ai finanzieri, in quanto svolte dai commilitoni. Quella rimessione è però rimasta un caso unico, poi citato da Di Pietro tra i motivi delle sue dimissioni.
Vajont. Il processo per il disastro del Vajont (nel 1963) fu trasferito da Belluno all'Aquila. La Cassazione vide pericoli, anche qui, per l' ordine pubblico.
Salvatore Giuliano. Il bandito accusato di essere l' esecutore della strage di Portella della Ginestra (1947) fu rinviato a giudizio a Palermo, ma poi la Cassazione spostò il processo a Viterbo.
Da dire che il 28 settembre 2011 anche allo stesso dr Antonio Giangrande, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, di Avetrana, è stata rigettata l’istanza di rimessione. I magistrati di Taranto sono stati denunciati a Potenza e criticati sui giornali per i loro abusi ed omissioni. Per la Corte di Cassazione è giusto che siano gli stessi a giudicare, nei processi penali per diffamazione a mezzo stampa e nel concorso pubblico di avvocato, chi li denuncia e li critica. Oltre al rigetto è conseguita sanzione di 2 mila euro, giusto per inibire qualsiasi pretesa di tutela.
Questa di Avetrana è sempre più una storia difficile da raccontare. È infatti una storia senza punti e piena invece di virgole, parentesi e soprattutto di punti interrogativi. Per esempio: i carabinieri dei Ris hanno depositato una relazione sostenendo che non c'è alcun riscontro scientifico all'omicidio di Sarah. Niente tracce della ragazza nel garage. Niente tracce nella macchina, niente sulla corda con la quale Misseri ha raccontato di averla calato nel pozzo, niente nemmeno sulle cinture, presunte arme di delitto. È una storia così complicata, questa, che si arriva al paradosso costruito involontariamente dalla Cassazione che disegna tre "soppressori" di cadavere (Michele Misseri, Sabrina Misseri e Cosima Serrano), ma nemmeno un assassino come se la povera Sarah si fosse ammazzata da sola e poi gli zii e la cugina l'avessero calata nel pozzo. Pozzo che appare un po' una metafora di tutto il resto: questa di Avetrana è sempre più una storia piena di buchi neri. La procura è convinta che a uccidere Sarah siano state Sabrina e Cosima. In realtà, però, come ha sottolineato la Cassazione, Sabrina è in carcere anche per aver ucciso Sarah insieme con il padre Michele: quella ordinanza non è mai stata annullata. Non solo. Non c'è nessuna traccia che inchioda madre e figlia: manca l'arma del delitto. Non ci sono testimoni. L'unico, il fioraio Buccolieri, ha raccontato prima informalmente di aver visto Sarah mentre veniva trascinata nell'auto di Cosima. E poi però ha smentito tutto: "Era solo un sogno". In compenso, però, c'è zio Michele, che mentre si infuria a mezzo stampa con la moglie ("quando ero in carcere ha tagliato male tutta l'uva, ha combinato un disastro"), continua ad autoaccusarsi dell'omicidio di Sarah. Ma non gli crede nessuno. "Il soffocamento avviene ora in casa Misseri, ora nel garage, ora nella macchina di Cosima" scrive la Cassazione. Ed effettivamente non è chiaro dove Sarah sia stata ammazzata, visto che le ricostruzioni si sovrappongono tra loro, ma spesso non combaciano. Questo è il paradosso tutto italiano: da una parte Michele Misseri, un reo confesso di omicidio in libertà che, se pur considerato inattendibile, da lui si prendono per buone solo le versioni che fanno comodo alla tesi della procura; dal’altra parte Cosima Serrano e Sabrina Misseri, che professano la loro innocenza, ma sono in carcere senza prove. Prove che nemmeno la polizia scientifica ha trovato.
Paradossale è anche il fatto che è stato assegnato a Franco Coppi il premio della Camera Penale di Bari “Achille Lombardo Pijola per la Dignità dell'Avvocato”. La decisione di assegnare il premio al prof. Coppi è per lo stile che ha saputo dare, quale difensore in un delicatissimo processo in terra di Puglia, esempio luminoso di professionalità e di dignità dell'Avvocato. Il riferimento è, appunto al processo per l'omicidio di Sarah Scazzi, in cui Coppi difende Sabrina Misseri, cugina della vittima. Processo la cui levatura professionale rispetto ad altri si è contraddistinta nell’assunzione di due atti fondamentali: richiesta di rimessione del processo per legittimo sospetto e minaccia di ricusazione dei giudici Cesarina Trunfio e Fulvia Misserini.
Per quanto innanzi detto sarebbe auspicabile la predisposizione di un difensore civico giudiziario a tutela dei cittadini. Senza sminuire le prerogative ed i privilegi dei magistrati a questi doverosamente si dovrebbe affiancare, come organo di controllo, una figura istituzionale con i poteri dei magistrati, senza essere, però, uno di loro, perché corporatisticamente coinvolto. Tutto ciò eviterebbe l’ecatombe di condanne per l’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
PROPOSTA DI LEGGE
PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO GLI ABUSI E LE OMISSIONI DEGLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA
"Presso ogni sede di Corte d’Appello è istituita la figura del DIFENSORE CIVICO GIUDIZIARIO DISTRETTUALE.
Esso svolge un ruolo di Garante della legalità, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione della Giustizia, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi degli operatori amministrativi, degli operatori giudiziari e degli operatori forensi, nei confronti del cittadino.
Il Difensore Civico Giudiziario deve essere onorato, competente, capace, libero, indipendente e motivato nell’interesse del cittadino.
Il difensore civico Giudiziario, ha i poteri d’indagine riconosciuti dal Titolo VI bis del C.P.P..
La nomina è disposta direttamente dal cittadino su base elettiva e contestuale alle elezioni amministrative regionali.
Ogni Presidente di Corte d’Appello si attiva, affinché il Difensore Civico Giudiziario possa avere la facoltà operativa e logistica per poter operare.
Presso il Ministero della Giustizia è istituita la figura del DIFENSORE CIVICO GIUDIZIARIO NAZIONALE, come organo superiore al Difensore Civico Amministrativo e Giudiziario, con compiti di controllo e coordinamento. La nomina è disposta direttamente dal cittadino su base elettiva e contestuale alle elezioni politiche nazionali.
Il difensore Civico Giudiziario d'ufficio presenta denuncia penale presso gli organi competenti per le illegalità riscontrate e di ciò ne rende conto pubblicamente, senza proroga, al termine dei sei mesi, previsti per le indagini preliminari.
La carica del Difensore Civico Giudiziario dura l’intero periodo di mandato, rispettivamente, dell'assise regionale e nazionale, salvo riconferma, tenuto conto dei risultati ottenuti."
PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO GLI ABUSI E LE OMISSIONI DEGLI UFFICI PUBBLICI E GLI UFFICI DI PUBBLICA UTILITA'
Ogni funzionario, pubblico o privato, addetto ad uno sportello aperto al pubblico, deve essere identificato con cartellino di riconoscimento.
"Il comma 1 dell’art. 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è così modificato: (Ogni Comune, deve istituire la figura del Difensore Civico Amministrativo, con compiti di garanzia della legalità, dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione territoriale in generale e di ogni attività di Pubblica Utilità, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni ed i ritardi nei confronti del cittadino. Il Difensore Civico Amministrativo deve essere onorato, competente, capace, libero, indipendente e motivato nell’interesse del cittadino. La nomina è disposta direttamente dal cittadino su base elettiva e contestuale alle elezioni amministrative comunali ).
Il comma 2 dell’art. 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è così modificato: (Il Difensore Civico Amministrativo ha i poteri d’indagine riconosciuti dal Titolo VI bis del C.P.P.. Il difensore Civico Giudiziario d'ufficio presenta denuncia penale presso gli organi competenti per le illegalità riscontrate e di ciò ne rende conto pubblicamente, senza proroga, al termine dei sei mesi, previsti per le indagini preliminari).
Il comma 3 dell’art. 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è così modificato: (La carica del Difensore Civico Giudiziario dura l’intero periodo di mandato del Consiglio Comunale, salvo riconferma, tenuto conto dei risultati ottenuti)".
Le norme precedenti si applicano anche presso i Consigli Provinciali e Regionali.
CALABRIA: LUCI ED OMBRE. COME E' E COME VOGLIONO CHE SIA. "NDRANGHETISTI A 14 ANNI E PER SEMPRE.
Assenteismo lavoro, alla Calabria la maglia nera. Secondo la Cgia di Mestre ogni dipendente è rimasto a casa mediamente 34,6 giorni. La Calabria è la regione più "assenteista" a livello nazionale, scrivono i giornali. Nel 2012 ogni lavoratore dipendente calabrese è rimasto a casa mediamente 34,6 giorni. La media sale addirittura a 41,8 nel settore privato. E' quanto emerge da uno studio condotto dalla Cgia di Mestre secondo cui nel 2012 (ultimo anno in cui i dati sono a disposizione) i giorni di malattia medi registrati tra i lavoratori del pubblico impiego in Italia sono stati 16,72 (con 2,62 eventi per lavoratore), nel settore privato, invece, le assenze per malattia hanno toccato i 18,11 giorni (con un numero medio di eventi per lavoratore uguale a 2,08). Complessivamente sono stati quasi 106 milioni i giorni di malattia persi durante tutto l'anno. Oltre il 30 per cento dei certificati medici che attestano l'impossibilità da parte di un operaio o di un impiegato di recarsi nel proprio posto di lavoro è stato presentato di lunedì. Nel 71,7 per cento dei casi la guarigione avviene entro i primi 5 giorni dalla presentazione del certificato medico.
E nel 2014 centinaia di arresti per assenteismo, scrive Diodato Pirone su “Il Messaggero”. Non lo sa nessuno ma in Italia l'assenteismo è un fenomeno criminologico. Secondo le statistiche delle forze dell'ordine gli arresti per truffa aggravata causati dalle assenze ingiustificate dal lavoro di dipendenti pubblici sono centinaia all'anno. Di certo si supera quota mille con denunce a piede libero e sospensioni. Contrariamente a quello che si crede, infatti, la vita dell'assenteista s'è fatta dura. Giusta o sbagliata che fosse, la crociata dell'ex ministro Renato Brunetta contro i fannulloni ha lasciato in eredità una regola ferrea. Eccola: «E' previsto l'arresto nei confronti dei dipendenti pubblici accusati di falsa attestazione della presenza in servizio». Poche righe che dal 2010 hanno trasformato gli uffici italiani in covi di microcamere e video-spia con codazzo di denunce, tribunali e manette. Una vitaccia, insomma, quella dell'assenteista. Giornaloni e tivvù non ne danno conto perché i singoli arresti, presi in sè, non fanno notizia e al massimo finiscono nelle brevi. Ma la loro massa critica è sbalorditiva: si resta basiti di fronte alla leggerezza con la quale tanta gente, convintissima che i furbi la facciano sempre da padrone in Italia, finisce per rovinarsi la vita. Qualche esempio? Gli arresti del 2014 sono addirittura tambureggianti: a gennaio scattano le manette per due ginecologhe (sorprese nei propri studi privati mentre risultano al lavoro per l'Azienda sanitaria) e quattro impiegati dell'Asl Napoli Nord; a febbraio tocca a 15 addetti ai servizi veterinari della Asl di Vibo Valentia in Calabria e a due giardinieri di un parco pubblico di Napoli. Il 7 marzo finisce in galera un agente della polizia penitenziaria di Piacenza che nei giorni di falsa malattia spacciava droga e qui - caso rarissimo - piovono sberle anche per il suo medico cui la Procura chiude lo studio per avere concesso certificati senza controllo. Ma l'elenco delle amministrazioni dove sono scattate le manette è infinito: ospedali Monaldi e Cotugno di Napoli; Comuni di Sant'Agnello e Torre Annunziata; Università di Trieste e Udine; ufficio del giudice di Pace di Latina; Day SurgerY di Cuneo; Comune di Ancona; provincia di Chieti (dove un capo cantoniere si assentava dal lavoro per effettuare traslochi con i mezzi pubblici di cui era responsabile). Non c'è pace, da Nord a Sud. A giugno si spara nel mucchio nel Consorzio di Bacino Salerno/1: 22 arresti per truffa aggravata e peculato (gli assenteisti si segnavano anche lo straordinario). Ma è da settembre che le retate si moltiplicano: a Montenero di Bisaccia (il paese di Di Pietro) viene arrestato il medico dell'Asl e un suo collaboratore per danni per 70 mila euro causati dalle loro assenze e poi la Calabria alza il tiro con la decisione della Regione di licenziare quattro assenteisti cronici di in un gruppo di impiegati finito totalmente fuori controllo. Impiegati che vengono puniti anche con 5 sospensioni e 41 rimproveri. Ma l'assenteismo di massa della Regione Calabria non è isolato. Alla Asl di Siracusa la Procura ha imposto 9 sospensioni dopo aver scattato 1.500 fotografie ed effettuato 600 ore di videoregistrazioni per provare l'abitudine di 33 fra medici e impiegati di recarsi spesso insieme in piscina invece che al lavoro. Naturalmente dopo aver fatto timbrare agli amici il loro cartellino.
Invece, in contrapposizione all'immagine nefasta della Calabria, a "Presa Diretta" vanno in onda potenzialità e disagi della Calabria raccontata da Iacona, scrive Domenico Grillone su “Strill”. La Calabria l’11 gennaio 2015 scorre sulle immagini di Rai3 nel programma “Presa Diretta” di Riccardo Iacona. Problematiche, risorse, qualità e bellezze della nostra regione sotto la lente d’ingrandimento e questa volta nessuno potrà maledire la Rai ed i suoi giornalisti, colpevoli, secondo una parte dell’opinione pubblica locale, di mostrare sempre una Calabria tutta ‘ndrangheta e malaffare. Nell’occuparsi di dissesto idrogeologico attraverso un viaggio da Sud a Nord fino alla Liguria, “Presa Diretta” ha raccontato le bellezze e soprattutto i tesori tutti da scoprire della Calabria. Nel denunciare “le bruttezze di una terra spesso generate dall’uomo avido di cemento e non solo”, nel nuovo ciclo di trasmissioni le telecamere di “Presa Diretta” si sono soffermate su “un tesoro di potenzialità che potrebbe produrre ricchezza e posti di lavoro: l’arte, il cibo, l’agricoltura, il paesaggio se solo fossero difesi e valorizzati, renderebbero più ricco il nostro paese”. Il racconto di Iacona, quindi, una sorta di viaggio attraverso il quale, pur mantenendo fede al suo classico stile di denuncia “delle promesse fatte e non mantenute, degli errori che si ripetono da sempre” e nel domandarsi “a chi conviene gestire in regime di eterna emergenza la fragilità del nostro territorio?”, riesce a mostrare tutte, o almeno in buona parte, quelle potenzialità che secondo il giornalista dovrebbero essere messe al centro dell’agenda politica. Ma c’è di più. Perché il conduttore, nel raccontare la bellezza che potrebbero arricchirci, ricorda come spesso la cerchiamo in luoghi lontanissimi “quando a pochi chilometri da casa nostra abbiamo dei tesori tutti da scoprire”. “Quello che abbiamo scoperto in Calabria vale per tutta l’Italia che è un tesoro da accarezzare”, spiega Iacona, “se solo si valorizzassero tutte queste risorse e non si abbandonasse il territorio la Calabria sarebbe una regione ricca”. “La Calabria non è solo ‘ndrangheta malaffare e malapolitica. C’è tanta gente che sta già costruendo la Calabria del futuro” che la dice lunga su uno stile di fare giornalismo che, a differenza di quanto qualcuno rimprovera, non è preconcetto ma, al contrario, racconta le storie con stile semplice e diretto. Una trasmissione andata in onda proprio a ridosso dei risultati dello studio di Demoskopica sul tema “L’anno che verrà – il 2015 nell’opinione dei calabresi”, in cui tra l’altro si evidenzia come la fiducia degli stessi calabresi verso la politica, le istituzioni, e soprattutto verso una possibile ripresa economica si attesta su livelli decisamente ai minimi. Iacona con la sua inchiesta dimostra che forse non tutto è perduto per la Calabria, basterebbe solo una presa….di coscienza vera per voltare pagina e riprogrammare il futuro.
Eppure si leggono queste cose.
PALMI: CAPOMAFIA A 14 ANNI, INDAGATA LA FIGLIA DI UN POTENTE DEI GALLICO. Ha 17 anni e sarebbe un capoclan, scrive Alessandro Bevilacqua su “Telemia”. E' l'incredibile storia di una ragazzina di Palmi finita al centro delle indagini della Procura di Reggio Calabria. Secondo gli investigatori la ragazza, figlia di uno dei personaggi di primo piano della potente cosca armata dei Gallico di Palmi, nel reggino, risulterebbe ancora incensurata. I fatti contestati risalirebbero a quando la giovanissima non aveva neppure 14 anni. Alcuni reati che le vengono imputati sarebbero stati collocati nel periodo successivo al giugno del 2011, mese in cui la ragazza avrebbe compiuto l'età minima prevista dalla legge sui minori per essere imputata di associazione mafiosa. La ragazza, ospite dal 2014 di una famiglia del nord Italia, entrerebbe in un inchiesta che ha consentito di decimare il clan Gallico, nello specifico quella concernente una presunta rete di fiancheggiatori della cosca dedita alle estorsioni. A metà del 2011 gli uomini della Squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Palmi piazzarono nella casa in cui viveva all'epoca la giovane delle cimici che catturarono conversazioni che, sembrerebbe, facessero chiaro riferimento alle estorsioni. Tra i partecipanti al dialogo anche l'allora 13enne. Pochi minuti dopo la ragazza lasciò la casa in questione per salire in auto insieme ad una donna. Gli investigatori predisposero quel giorno un posto di blocco e il risultato è che finirono tutti in caserma dove si scoprì che la 13enne nascondeva negli slip un foglio di calendario contenente i dettagli delle estorsioni. Per gli investigatori dal momento che tutti i suoi parenti e membri del clan si trovavano detenuti l'allora 14enne avrebbe svolto il ruolo di reggente e anello di congiunzione tra la famiglia e il territorio fungendo da figura visibile.
«Quella bambina di 14 anni è un capomafia», scrive Francesco Altomonte su “Il Garantista”. Mancano sei mesi al compimento dei suoi 17 anni, ma leggendo i capi di imputazione riportati nell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari sembra di avere a che fare con un boss di lunga data, di un criminale incallito che ha dedicato la sua vita a “mamma ‘ndrangheta”. Lei (sì, stiamo parlando di una ragazzina), figlia di uno dei personaggi di primo piano della potente cosca Gallico di Palmi, nel Reggino, risulta ancora incensurata, benché la procura dei minorenni di Reggio Calabria l’accusi non solo di associazione mafiosa, ma anche di essere un capo promotore del clan (armato) di riferimento dei suoi genitori. Il primo pensiero che passa nella mente del cronista (o perlomeno dovrebbe passare) è: ma un ragazzina che all’epoca dei fatti non aveva compiuto 14 anni, è imputabile? La risposta è, anzi dovrebbe essere no, ma la data posta in calce al documento che decreta la fine delle indagini preliminari dissiperebbe i dubbi: «Accertato in Palmi e territori limitrofi in epoca successiva al 12.05.2011». Nel giugno di quell’anno (il 2011), infatti, la ragazzina avrebbe compiuto 14 anni, quindi poteva essere perseguita per il delitto associativo. Alcuni fatti che le vengono contestati, infatti, risulterebbero compiuti nei mesi successivi. Da qui, la possibilità da parte della procura dei minori di poterla accusare di associazione mafiosa. La ragazza, che dall’inizio del 2014 è ospite di una famiglia nel nord Italia, entra in una delle tante inchieste che hanno permesso di decapitare il clan Gallico, in particolare quella in cui viene colpita una presunta rete di fiancheggiatori della cosca dedita alle estorsioni. Suo padre e sua madre sono in carcere, lei vive in casa con dei partenti. Gli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Palmi, che stanno conducendo le indagini, hanno piazzato delle microspie in quella casa e a metà del 2011 intercettano una conversazione nella quale alcuni indagati parlano di soldi e di qualcosa nascosto all’interno di quella abitazione. Tra i partecipanti alla discussione c’è anche l’allora tredicenne. La ragazza dopo alcuni minuti lascia la casa insieme a una donna finita in carcere alla fine del 2011, Loredana Rao, salendo in auto con lei. Gli investigatori, per capire dove e cosa trasportassero nell’autovettura, piazzano un posto di blocco appena fuori la città. Le due donne pochi minuti dopo intravedono la volante della polizia, fermano la macchina e fanno marcia indietro. Quella è la prova per i poliziotti che qualcosa non quadra. Partono all’inseguimento e bloccano non solo la macchina nella quale viaggiavano la Rao e la ragazzina, ma anche un’altra autovettura con a bordo alcuni uomini della famiglia. La mossa conseguente è il trasferimento di tutti in commissariato per la perquisizione. Per evitare fughe o altri problemi, due poliziotti salgono a bordo delle due macchine. Un agente, si legge nell’informativa redatta dagli uomini della Mobile, durante il tragitto nota che la ragazzina cercava di sistemare qualcosa che aveva nascosto all’altezza dell’inguine. Appena giunti in commissariato chiedono se vogliono essere assistiti da un legale, soprattutto lei che ancora non ha compiuto 14 anni, ma tutti declinano l’invito. La ragazza, però, non si fa neanche perquisire perché spontaneamente consegna alla poliziotta un foglietto contenuto all’interno dello slip. Si scoprirà nel novembre 2011 di cosa si tratta, quando la procura antimafia di Reggio Calabria emette un decreto di fermo con il quale finisce in carcere l’intera rete di presunti estortori. Si trattava di un foglio di calendario sul quale erano state annotate date e cifre. Per gli inquirenti quei dati parlano chiaro: sono appunti per la riscossione del pizzo imposto dal clan Gallico agli imprenditori e commercianti della città. Alcuni di loro, per inciso, collaboreranno alle indagini confermando quanto ricostruito dalle forze dell’ordine. All’interno di un’altra informativa, la ragazzina viene intercettata con il fratello. Per gli inquirenti il parente le starebbe impartendo degli ordini per andare a ritirare delle estorsioni, o per intimarne in pagamento. Siamo nel 2012 e, quindi, per la legge italiana la 14enne è perseguibile e può essere incriminata. L’equazione sembrerebbe questa: siccome tutti i suoi parenti e membri del clan sono dietro le sbarre, dai mammasantissima fino ai fiancheggiatori, l’allora 14enne svolgerebbe il compito di “reggente” della cosca, anello di congiunzione con i detenuti e figura “visibile” della famiglia sul territorio. La ragazzina, intanto, dopo l’arresto di tutti i suoi parenti, compreso suo fratello ancora minorenne, viene data in affidamento a una famiglia del nord Italia dalla quale la giovane, secondo quanto appreso, fugge con regolarità per ritornare a casa. Con altrettanta regolarità viene ripresa e riportata indietro. Secondo quanto saputo nella giornata di ieri, pare che solo ad agosto scorso, il Tribunale dei minori le abbia concesso la possibilità di visitare suo padre in carcere.
Mio marito, ’ndranghetista per sempre. Ma è innocente anche per la legge, scrive Yvone Graf su “Il Garantista". «Racconto la mia storia, una storia qualunque di malagiustizia, di una vita segnata irrimediabilmente da un marchio posto sulle teste della mia famiglia e mai più rimosso: la ‘ndrangheta. Nel lontano 1991 ho incontrato l’uomo che oggi è mio marito. All’epoca lui era un sorvegliato speciale, doveva ancora scontare 4 anni di sorveglianza per una misura di prevenzione. Li abbiamo scontati insieme. Chi vive con un sorvegliato speciale patisce tutte le limitazioni e le conseguenze che ne derivano: andare tutti i giorni in questura a mettere la firma; non uscire da casa prima del alba e rincasare prima del tramonto; stare tutte le notti pronti a subire un controllo improvviso che può coglierti nel sonno profondo e farti rischiare una denuncia per evasione. Aveva 18 anni mio marito quando fu accusato di appartenere a una cosca della ‘ndrangheta e di essere il super killer di questa cosca. L’avevano accusato di una diecina di omicidi, altrettanti tentati omicidi, sequestri di persona, porto abusivo di armi da guerra e chi più ne ha più ne metta. Fu condannato in primo grado tenuto conto della sua giovane età a 101 anni e 6 mesi di carcere. Dopo i vari gradi di giudizio, nel 1990 fu assolto da tutte le incriminazioni per non aver commesso il fatto ma condannato per associazione a delinquere, art. 416 c.p. – all’epoca dei fatti il reato di associazione mafiosa non era ancora codificato. Mio marito si professava innocente. Le accuse specifiche erano cadute ma era rimasta in piedi quella associativa a salvare il teorema degli inquirenti e una misura di prevenzione, appunto, cinque anni di vigilanza. Condannato senza commettere un reato a tre anni di reclusione; cresciuto e vissuto in un paese dove tutti conoscono tutti e tutti si frequentano, giovani, nelle strade e nelle piazze di paese. Per quel ragazzo che era mio marito fu devastante, fu causa di un grave sbandamento. Era vittima di un’ingiustizia che gli stava distruggendo la giovinezza e la vita. Da detenuto si era ammalato di anoressia ed era stato messo ai arresti domiciliari a causa del suo deperimento organico. Poi mandato al confino nel Lazio, solo e lontano dalla famiglia, affetto da una grave depressione ed in balia di una assoluta incertezza sul suo futuro. Poi una sera, sbandato per come era all’epoca, commise il furto di una macchina e fu arrestato e condannato per questo a 4 mesi di reclusione. Dopo questa carcerazione e dopo di aver scontato la sua sorveglianza, nel dicembre del 1994 decidemmo di lasciare l’Italia e di venire in Svizzera, il mio paese di appartenenza. Speravamo di iniziare una vita serena, di trovarci un lavoro entrambi e di vivere lontano da tutto tranquillamente ma ancora una volta questo ci fu impedito dallo stato italiano. Dopo appena 4 mesi che eravamo in Svizzera siamo venuti a sapere che lui era di nuovo ricercato dalla giustizia italiana. Un pentito lo accusava, per sentito dire, di essere il killer di un duplice omicidio avvenuto nei primi anni 80. In primo grado per queste accuse ha preso una condanna a 26 anni di reclusione. Il pm in appello chiese l’ergastolo. Nel 1998 la polizia svizzera esegue l’arresto di mio marito che nel frattempo era stato inserito nella lista dei 500 latitanti più pericolosi d’Italia su mandato internazionale emesso dall’Italia nonostante da subito ci fossimo opposti all’estradizione. Mio marito si dichiarava un perseguitato dalla giustizia italiana. Intanto mio marito ancora lottava con gli effetti collaterali delle prime ingiustizie subite e le loro conseguenze: attacchi di panico, ansia, depressione maggiore. In quel periodo avviammo le pratiche per poterci sposare. Nel ’96 avevo partorito il mio primo figlio che lui non aveva potuto riconoscere in quanto latitante ed ero incinta al 5 mese, al momento del suo arresto, della mia seconda figlia. Nel dicembre del ’98 ci sposammo nel carcere in svizzera e ai miei figli fu riconosciuta la paternità. Nel febbraio 1999 arrivo l’estradizione e mio marito fu prelevato e portato via dalla Svizzera. Per giorni non sono riuscita a sapere dove l’avevano portato. Poi seppi che era nel carcere a Como. Partii subito e mi accompagnò al carcere un avvocato del posto cui il mio legale aveva chiesto una cortesia. Lo fece malvolentieri precisandomi che non era opportuno per un avvocato stare vicino a chi aveva quel genere di imputazioni. Non trovai mio marito a Como. Era stato trasferito in Calabria. Solo dopo tre settimane dall’estradizione ho potuto fare il primo colloquio con lui: devastante! Mio marito era l’ombra di sé, irriconoscibile, lo sguardo spento, movimenti spaventosamente rallentati, assente e incapace di formulare delle frasi compiute. Non gli somministravano la sua terapia e con delle punture di calmanti lo tenevano in quello stato. A marzo 1999 venne assolto con formula piena per non aver commesso il fatto! Ma non tornò libero subito. Continuavano a tenerlo in virtù di un’accusa fumosa e incomprensibile tanto che la Svizzera rifiutò l’estradizione. Mio marito restava però detenuto. Ho dovuto fare il diavolo a quattro con l’appoggio dell’ambasciatore che richiamava il ministero degli Interni al rispetto dei accordi. Per fortuna sul nostro cammino incontrammo un giudice onesto che dovette intimare la scarcerazione al direttore del carcere avvisandolo che rischiava una denuncia per sequestro di persona e mio marito tornò libero. Sembrava tutto finito, a parte le patologie depressive che ancora affliggono mio marito. Ma le conseguenze di una condanna per associazione sono immortali, ti seguono per sempre. Marchiano una persona e la sua famiglia in modo definitivo, incancellabile. La Svizzera nega a mio marito la cittadinanza in virtù di rapporti segreti e di una pericolosità sociale presunta ineluttabilmente e collegata alla qualifica di ‘ndranghetista. Mio marito non aveva commesso alcun reato ma è ‘ndranghetista per sempre per volontà dello Stato italiano, senza diritto di replica e senza speranza di redenzione. Mafioso da innocente, la sua vita, le nostre vite, proprietà dello stato, per sempre. I nostri figli, mafiosi per discendenza ereditaria e così, da padre in figlio, all’infinito.
I TRIBUNALI PROPRIETA' DEI GIUDICI.
«I Tribunali non sono proprietà dei giudici», scrive Errico Novi su “Il Garantista”. Vogliono rovinare la “festa”. Oggi sarebbe la giornata della giustizia, proclamata dall’Anm per protestare contro la riforma del ministro Orlando e in particolare contro il taglio delle ferie. I penalisti intervengono con una certa, brutale franchezza e mettono in discussione i dati che oggi i magistrati proporranno ai cittadini, per l’occasione liberi di entrare nei Palazzi di giustizia. Intanto, dice il presidente dell’Unione Camere penali Beniamino Migliucci, l’iniziativa del sindacato delle toghe è «la dimostrazione, come se ce ne fosse bisogno, di una concezione proprietaria della giustizia e dei luoghi in cui essa si celebra, da parte dei magistrati». I cittadini, dice, «non hanno bisogno di alcun invito per accedere al Tribunale, luogo sacro in cui si svolgono i processi in nome del popolo italiano». Dopodiché «i numeri forniti dall’Associazione magistrati rischiano di offrire una visione autoreferenziale e alterata della situazione in cui versa la giustizia italiana, nella quale si enfatizza la loro efficienza a tutto discapito di una realtà che ci vede fra i primi paesi in Europa per numero di condanne dalla Corte di Strasburgo». I numeri sono altri, secondo il presidente dei penalisti, «a cominciare dalla sostanziale inattuazione del sistema di controllo sulla responsabilità dei magistrati, dalle frequentissime sentenze di riforma dei giudizi di primo grado, per passare al cospicuo importo dei risarcimenti che lo Stato è costretto ogni anno a pagare per indennizzare le vittime degli errori giudiziari, all’inevitabile ricorso, da parte della magistratura togata, all’ausilio di magistrati onorari, il cui apporto è determinante per il raggiungimento di quegli obiettivi di produttività che la Anm enfatizza». Su una delle “contro-statistiche” proposte da Migliucci interviene anche il cahier de doleance del viceministro della Giustizia Enrico Costa, che dà notizia del boom di risarcimenti per ingiusta detenzione ed errori giudiziari pagati dallo Stato nel 2014. «L’incremento rispetto all’anno precedente è del 41,3%: 995 domande liquidate per un totale di 35 milioni e 255mila euro». Dal 1992, osserva Costa, «l’ammontare delle riparazioni raggiunge così i 580 milioni: sono numeri che devono far riflettere, si tratta di persone che si sono viste private della libertà personale ingiustamente e per le quali lo Stato ha riconosciuto l’errore. Dietro c’è una storia personale, ci sono trepidazioni, ansie, che un assegno, anche di migliaia di euro, non può cancellare». Le contromisure di Parlamento e governo sono note: da una parte la legge sulla custodia cautelare, che naviga ancora in acque incerte, dall’altra quella sulla responsabilità civile dei giudici, prossima all’approvazione della Camera. Sui problemi più generali del processo penale è ora all’esame della commissione Giustizia di Montecitorio l’atteso ddl del governo, che si accoda al testo base adottato proprio ieri dai deputati sulla prescrizione. «Sono soddisfatta, abbiamo avviato tutti e due i provvedimenti, coerenti tra loro», dice la presidente Donatella Ferranti. Su un altro capitolo della riforma, la soppressione di alcuni Tribunali, arriva dalla Consulta la bocciatura del referendum con cui alcune regioni avevano impugnato le chiusure. Tra queste, c’erano anche le sedi delle zone terremotate dell’Abruzzo.
LA BANDA DEGLI ONESTI E MAFIA CAPITALE.
Ma la gente sa cosa succede nei tribunali?
Giornata di ordinaria follia al tribunale di Roma tra prostitute, burini e magistrati oberati dall’obbligo penale. Luglio 14, 2014, scrive Luigi Amicone su “Tempi”. Basta passare un giorno in aula giudiziaria per capire quanti oneri assurdi e pretese inverosimili gravano sulle spalle di pm e giudici. Come mai nel repertorio dei suoi elettrizzanti tweet Matteo Renzi sfiora appena quel filo che porta dritto al circuito mediatico-giudiziario? “Riforma della giustizia in 12 punti”. Così ha promesso il nostro ganzo leader. Se ne riparlerà in autunno. Ma intanto che ciofeca di hashtag è per un guascone che prende l’Europa con un «se si facesse un selfie sarebbe il ritratto della noia»? Paura di rimanere attaccato al filo, folgorato dal circuito? Sia come sia, può capitare anche al nostro simpatico incantatore di serpenti di ritrovarsi per caso, come è capitato alla canaglia che scrive, dentro l’iCloud del sistema giudiziario disegnato dalla più bella costituzione del mondo. Grazie a Dio, se sei solo un testimone (ma stai alla larga dai processi a Berlusconi), una volta di difesa, l’altra di accusa, puoi stare tranquillo: non corri alcun rischio di finire metamorfizzato in un insetto da espellere dalla società. Certo. Ricoprire ruoli opposti nel giro di qualche giorno, fa un bell’effetto. Specie se ti ritrovi rimbalzato tra Roma e Milano. In tribunali di due pianeti diversi. Come testi della difesa siamo stati convocati a Milano. Dove a dispetto dell’architettura fascista, l’amministrazione della giustizia sembra ispirarsi a una efficienza da tecnicalità ospedaliera. Entri al palazzaccio e, al di là dell’odore e sudore di carte, la sensazione è quella che puoi aver provato in un reparto di terapia intensiva. Convocazione alle 9 del mattino. Minuti di attesa in compagnia di persone stranamente in angoscia per essere testimoni della difesa. C’è un direttore di carcere («perché mi hanno convocato? Cosa ho fatto?») e c’è il pannelliano insolente («questi non sanno neanche chi è Beccaria, desolante che se ne siano impipati dell’amnistia»). Poi, come una botola, si apre la porticina dell’aula dell’udienza. L’impiegata fa l’appello, stila l’ordine di comparizione testi, prende nota di eventuali richieste. Arriva il tuo turno. Reciti l’orazione secondo verità, declini le generalità, rispondi ad avvocati e pm. Il giudice tace, non tradisce emozioni, ascolta. Incombe un silenzio da sala operatoria. Sbrigata la deposizione, vieni gentilmente accomiatato. «Si può accomodare». E sei messo alla porta con neanche una mosca che vola. Seicento chilometri più a sud è tutta un’altra musica. A Roma ci arrivi la sera prima. Pernotti. Non puoi fare altrimenti. L’udienza è fissata alla stessa ora, sullo stesso fuso orario della giustizia ambrosiana. Insomma, sono le 9 del mattino e nell’aula della cittadella giudiziaria capitolina non c’è anima viva. Passa un quarto d’ora e arriva un tizio che ha l’aria del mio pony fornitore di giornali. Ha una sua grazia nella strampalata t-shirt che indossa e nel trasportare una pila di fascicoli che finirà sulla scrivania della corte in un bel tonfo rimbombante per tutta l’aula. Verso le 9.30 si appalesano avvocati e altri tizi, seguiti da cai e semproni. In piedi, salutiamo la messa in moto della macchina giudiziaria: entra il giudice monocratico. Breve conciliabolo con il cancelliere. Partono le udienze. E il giudice sale in cattedra. Dirige il traffico delle domande dell’avvocatura. Azzittisce chi chiacchiera. Interroga i testi con puntiglio e vivacità oratoria. Giganteggia per autorità e competenza. Si avverte in lui addirittura un tocco di umanità e l’acume di non dare per scontato alcun elemento istruttorio. Insomma, ha un impianto da persona non supponente, cerca di capire, entra nei dettagli. Il problema è quella pila lì. Fascicoli che si affastellano sul suo tavolo senza una apparente logica. Delitti gravi e reati bagatellari sono sullo stesso piano e finiscono nello stesso ingorgo. È sufficiente lo spettacolo di una mattina di udienze romane per avere la fotografia della giustizia italiana. Che in virtù dell’obbligo dell’azione penale è come un gigante a cui è stato assegnato l’impossibile compito di risolvere tutti i conflitti e lenire tutte le disgrazie in seno alla vita di un popolo. E in più con un assurdo peso sulle spalle, gravando sul gigante-magistrato pure la faticaccia di traversare le sabbie mobili del giudizio alla luce abbacinante dei media. Che, inevitabilmente, heideggerianamente, invariabilmente, invece della trasparenza realizzano il rumore e l’oscuramento di tutto. Colpisce vedere un pubblico ministero caricato dell’intera casistica che passerà al vaglio della corte nel corso di questa giornata di prima estate. Come farà a studiarsi i contenuti della quotidiana pila di fascicoli e presentarsi a dibattimento in aula sapendo quello che fa, quello che dice, quello che chiede come sentenza? Quanto alla spicciolata di cause che scorrono sotto i nostri sensi, si comincia da una denuncia per violenza privata, rissa, danni per traumi fisici, psicologici, morali eccetera. La montagna si rivelerà il topolino di una baruffa chiozzotta tra donne. Con tre-quattro equipaggi di volanti intervenuti su segnalazione della titolare di una macelleria che testimoniano cose al limite dell’ilarità. A un certo punto spunta il mancato pagamento di una “prestazione”. «Scusi – fa il giudice al poliziotto – che genere di prestazioni?». «Beh, pare che una signora non avesse pagato la parrucchiera». «Ah, la parrucchiera. Ma che c’entra la macelleria?». «C’entra perché l’altra signora è l’esercente di carni e la rissa è avvenuta proprio davanti al suo negozio». «Ma ci sono stati feriti?», chiede il giudice a un altro poliziotto di una seconda volante presente sulla scena del delitto. «No». «Ah – riprende il giudice – non ci sono stati feriti… Dunque si è trattato di un alterco. È così?». «No – interviene il pm – è stato infranto un vetro e distrutto un telefono…». «Quale vetro e quale telefono?», incalza il giudice. In breve, dopo la sfilata delle volanti, l’assenza di feriti e nessun bollettino medico, si viene a sapere che il vetro infranto è in realtà un vetro scheggiato e il telefono di cui nessuno dei testi ricorda la tipologia è un cordless della macellaia che nella concitazione – non si è capito per colpa di chi e perché – è stato raccolto in pezzi a terra. L’udienza viene aggiornata a novembre. Sempre con lo stesso pm, ma con un diverso avvocato d’ufficio, segue il caso di una donna di colore che ha rubato due camicette in un grande magazzino. Di nuovo, sporta denuncia da parte del direttore del negozio, «anche se la signora si è mostrata collaborativa quando è stata scoperta e fermata dalla guardia privata», il pm non può far altro che rappresentare l’obbligo dello Stato a perseguire il reato. Risultato? Sentenza costituzionalmente ineccepibile e umanamente abominevole. La povera incensurata si becca sei mesi di carcere e 800 euro di multa. Segue vicenda notte magica italiana. Una bella, giovanissima e molto ben equipaggiata brasiliana è testimone d’accusa e parte lesa in una movimentata avventura notturna avuta con un giovanotto, iniziata in discoteca e finita prima a letto e poi a botte. Due sono le versioni. La bella sostiene che dopo essere stata convinta dal giovanotto a passare la notte con lui in cambio di un “regalo” (mille euro), già ubriaca di beveroni e dopo essersi fatta convincere a strafarsi anche di cocaina, al settimo rapporto sessuale ha detto basta, sono stanca, non ce la faccio più. Il giovanotto a quel punto, per non sapere né leggere né scrivere, avrebbe preteso la restituzione del “regalo” e pure le chiavi dell’automobile di lei». La bella descrive tutto nei minimi particolari. In estrema sintesi: «Intorno all’una di notte il tale mi ha avvicinato in discoteca e mi ha offerto il “regalo” in cambio della notte insieme. Saremo arrivati a casa mia alle tre, alle sei mi ha menata, è scesa la mia amica, gli ha spruzzato lo spray al peperoncino, lui è scappato, poi però mi ha chiesto scusa e mi ha restituito il regalo e le chiavi. Mi chiedeva di perdonarlo perché stava fuori di testa (“ho moglie e figlio”, diceva), poi la polizia se l’è portato via e io sono andata con la mia amica al pronto soccorso. Perdevo sangue dal naso. Avevo paura». Domanda il giudice: «E al pronto soccorso cosa le hanno detto? Dico, le hanno riscontrato ferite? Ha detto di essere stata presa a calci in faccia, è così?». «Sì, è così, ma il naso non era rotto e il medico mi ha dato una settimana di riposo». Versione della bestia (presunta). Ammette la nottata folle. Ma smentisce che abbia preso a calci la bella («che sennò cor peso che c’ho ’a sdrumavo»), la circostanza dei sette rapporti sessuali («ecche so’ Tarzan?!»), l’ora del fattaccio («ma quali tre de mattina, sarò arivato a’e cinque»). Poi si rivolge al pubblico forse cercando gli occhi della bella: «Aò, ma se stavo nudo sur letto, strafatto, t’ho visto che me rubbavi nei pantaloni…». Ma non fa in tempo a finire la frase che il giudice lo richiama: «Scusi, forse non ha capito, deve rivolgersi alla corte, non all’uditorio». Il ragazzotto cerca di biascicare una replica e il giudice stavolta si incazza: «E non mi dia sulla voce! Si limiti a rispondere alle domande! Ha capito?». L’imputato si stremisce e tace. «Le ho chiesto se ha capito. Ha capito?» «Sì, sì, signor giudice, me scusi…». Ed è come un pallone sgonfio che per un po’ risponde solo a monosillabi. «Sì, no, no, sì, sì, sì…». Ma toccato sul soldo arriva la scarica di adrenalina: «Eh no, giudice, ma quali mill’euri! So’ arivato da lei a’e cinque: e che je davo, mill’euri pe’ du ore? J’avrò dato trescento… mannò, che dico, saranno stati duscento ar massimo. Poi quann’ho visto ’a mano ’nfilata nella tasca dei pantaloni nun c’ho visto più: aò, j’ho detto, ma che stai affà?! E j’ho dato ’no schiaffo. E l’ammetto: pure ’no spintone, ma carci no». «Prosegua», fa il giudice un po’ scettico. «E che je devo dì? So passato prima da un amico a prenne i sordi». «Ma scusi, non aveva già con sé i mille euro del “regalo”?». «Vabbè, mica potevo annà ’ngiro senza sordi». «Ah, “in giro senza soldi”, dice lei», ironizza il giudice. «Sì vabbè, c’avevo questi mille, che poi duscento l’ho dati a lei, ma poi dar mio amico ne ho presi artri cinque-seicento e…». «Dunque, dopo che alla signorina ha restituito il “regalo”, aveva con sé altri cinque-seicento euro. Soldi che le servivano per cosa?». «Ma quali sordi? Quella nun m’ha ridato niente, so’ scese queste cor peperoncino, nun c’ho capito più niente, è arrivata ’a polizia e m’ha portato ar gabbio». «Ci sta dicendo che i soldi li ha lasciati nell’appartamento della signorina?». «Embè, io quelli nun l’ho più rivisti, là li ho lasciati, che tra peperoncino e strafatto di alcol e cocaina com’ero nun c’ho capito più niente». L’udienza viene aggiornata al 2015. Causa quarta e testimone d’accusa un’istruttrice di polizia. Il caso riguarda un automobilista fermato senza Rc auto. Seguiva verbale di sequestro dell’auto, apposizione dei sigilli, intervento del carro attrezzi, trasferimento del veicolo medesimo presso un box indicato dal proprietario dell’auto. Fatto avvenuto nel 2010. «L’anno seguente – prosegue il teste della polizia – nel corso di un sopralluogo constatiamo che all’indirizzo indicato non c’è alcun box e neanche il veicolo». Ennesimo obbligo di legge, scattano denuncia e processo a carico del proprietario. Processo che si attorciglia su carte, verbali, carri attrezzi e su chi ha firmato cosa e per conto di chi. La sostanza è che l’auto è sparita. Il pm conclude la sua breve requisitoria con una richiesta di assoluzione perché «non sappiamo dove è stato portato il veicolo, il box non è mai esistito, il bene è scomparso». Camera di consiglio: l’imputato è assolto. Siamo solo a metà mattina. Sotto i nostri occhi scorre la povera Italia. E potrebbe essere chiunque incappi in un colpo di testa, una disgrazia, nell’irruzione del male o del burocratese. C’è il marito che picchia la moglie un giorno sì e l’altro pure. C’è la vertenza per danni patrimoniali tra soci di una srl. Una per diffamazione a mezzo stampa e un’altra che non inizia nemmeno causa vizio di notifica. La giornata del giudice, del cancelliere, degli avvocati, dei testi e degli imputati, non è ancora finita quando lasciamo l’aula. Roma ci ha riconciliati con la legge. Roma non è il porto delle nebbie. Roma è la luce abbagliante sulla guida a fari spenti nella notte della giustizia italiana.
E poi ci meravigliamo della realtà che ci circonda, aliena ai controlli.
Mafia Capitale: “tra fascisti e ladroni”, scrivono quelli di sinistra. Sì, proprio quelli che indicano la pagliuzza negli occhi altrui e non la trave nei propri occhi. In un mondo di sopra, di sotto, di mezzo, nessuno si salva: cittadini ed istituzioni.
Dopo gli arresti di ex terroristi neri e affaristi che tenevano in pugno la Roma di Alemanno, è caccia al tesoro della banda. Ecco la storia dell’inchiesta , al loro dire profetica, condotta da "l'Espresso", scrive Lirio Abbate.
Quella scattata martedì 2 dicembre 2014 è solo la prima ondata di uno tsunami giudiziario che ribalterà il ventre di Roma. Una metropoli finita nelle mani della “ Mafia Capitale ”, l’organizzazione guidata da Massimo Carminati, “er Cecato”: una leggenda nera costruita in quarant’anni di crimini dal terrorismo di destra all’epopea della Magliana, rimasti quasi sempre senza conseguenze giudiziarie. «Un bandito ricco», talmente ricco da faticare per nascondere i soldi che ha accumulato con i suoi traffici. Un manager che ha costruito il suo potere dominando quello che chiamava «il mondo di mezzo»: la sterminata zona grigia che unisce il Palazzo alla strada, quella dove - si vantava - comandava lui. L'azione in cui è stato fermato sulla sua Smart in via Monte Cappelletto, una stradina di campagna a Sacrofano, poco lontano dalla sua abitazione, l'ex terrorista dei Nar al centro dell'inchiesta Mafia Capitale. Il boss era pronto a darsi alla fuga e per la cattura i carabinieri del Ros hanno chiesto la collaborazione del nucleo "cacciatori" dell'Arma di Roma. Carminati si compiaceva del suo ruolo. Anche quando l’inchiesta de “l’Espresso” nel dicembre 2012 svela per la prima volta la sua rete criminale, si mostra spavaldo, convinto di sapere sfruttare la fama criminale per moltiplicare gli affari senza bisogno di minacce. Ma sono proprio quelle parole registrate dalle microspie a fornire l’ossatura giuridica per l’inchiesta che adesso lo ha travolto. Nonostante contromisure ad alta tecnologia, come i jammer per disturbare gli apparati d’ascolto, i carabinieri del Ros del generale Mario Parente sono riusciti a intercettarlo mentre istruiva i suoi “soldati” e illustrava la sua strategia mafiosa, indicando i politici collusi, e i pubblici ufficiali corrotti, e il canale migliore per investire all’estero. Quelle lunghe conversazioni, spesso captate nella stazione di servizio di Corso Francia che aveva trasformato in ufficio a cielo aperto, offrono l’affresco cupissimo della devastazione morale di una capitale: un sacco proseguito per anni che ricorda quello storico dei Lanzichenecchi. Come tutte le mafie anche questa ha la sua trasversalità politica. Il nucleo sono i vecchi camerati, che adesso hanno messo giacca e cravatta come l’ex sindaco Gianni Alemanno, indagato. Ma la rete poi si è estesa a tutti i partiti, mettendo letteralmente a libro paga esponenti di destra, sinistra e centro. «Se Carminati, il capo dell’organizzazione viene dall’eversione dell’estrema destra romana, il suo braccio destro Salvatore Buzzi, ha un passato nell’estrema sinistra già condannato in maniera definitiva per un omicidio del 1980. Buzzi è oggi al comando di una serie di cooperative composte da ex detenuti che operano nel sociale e gestiva per l’organizzazione criminale appalti nelle aziende municipalizzate e del Comune di Roma», spiega il procuratore Giuseppe Pignatone. Ma come dice Buzzi in una intercettazione «la politica è una cosa, gli affari sò affari». "Tu sai quanto ci guadagno sugli immigrati? C'hai idea? Il traffico di droga rende meno", così al telefono Salvatore Buzzi, braccio destro imprenditoriale di Massimo Carminati. E che affari. Gli investigatori hanno sequestrato beni e depositi per un valore di duecentodieci milioni di euro. Ma sanno che c’è molto di più e puntano sul cuore del tesoro. Vogliono trovare le cassaforti e gli investimenti in cui i fascioladroni facevano fruttare i proventi del loro impero. Tutte le tracce portano a Londra, dove sono “rifugiati” molti ex dell’eversione nera e dove Carminati ha molti amici, che nell’ultimo anno si sono presi cura anche del figlio de “er Cecato” spedito lì in fretta e furia. Dopo aver trafficato in pietre preziose e in oro dall’Africa, il boss del “mondo di mezzo” potrebbe aver nascosto in Inghilterra il suo forziere. Nella City ha fatto tanti investimenti immobiliari, a partire da Notthing Hill dove ha acquistato di recente appartamenti. Operazioni confessate, sempre a sua insaputa, davanti alle microspie. Lui che ammette di essere ricco sfondato, di avere tanti milioni ma deve nascondere bene il patrimonio: ufficialmente è nullatenente, non può giustificare un tesoro così grande. Per questo ha scelto la strada di Londra, dove vorrebbe far trasferire definitivamente il figlio. «Ho pensato, apro una o due attività. Andrea sta lì. Anche se fa un altro lavoro però controlla. A questo punto ha un reddito», dice “er Cecato” che accenna a tante conoscenze nella City. «Avrebbe il mondo lì...», facendo comprendere che pure in Gran Bretagna ci sono molte persone a sua disposizione. "Il dieci mattina mi paghi te...nun sgarrà che vengo a casa..non capisci bene...io te taglio la gola il dieci matina...portami i soldi sennò t’ammazzo a te e tutti i tuoi figli", così un indagato in una delle intercettazioni telefoniche dei Ros. Per gli investigatori i contatti londinesi gli sono stati garantiti dal latitante Vittorio Spadavecchia, un veterano della comunità neofascista di Londra. Spadavecchia ha un passato nei Nuclei armati rivoluzionari, è arrivato in Inghilterra nel 1982, costretto alla latitanza dalle condanne per gli omicidi del commissario della Digos romana, Franco Straullu, e di altri poliziotti. È stato condannato pure per numerose rapine messe a segno per finanziare il terrorismo nero. Secondo le indagini, è con lui che uno dei complici di Carminati, Fabrizio Testa, pianifica assieme al rampollo del capo investimenti economici «di varia natura», come l’acquisto a Londra di un immobile e l’apertura di un ristorante: il primo passo per creare una catena di locali. Una holding che potrebbe venire decifrata mettendo le mani sul “libro nero”, il registro occulto custodito dalla “cassiera” del clan, Nadia Cerrito «che contiene una vera partita doppia del dare e avere illecito, dei destinatari delle tangenti - uno dei costi illegali sostenuti dall’organizzazione per il raggiungimento del suo scopo nel settore economico-istituzionale; che contiene l’indicazione dei soggetti cui vengono veicolati i profitti, come Carminati, shareolder ed esponente apicale dell’organizzazione illecita o come Testa, testa di ponte di mafia capitale verso la politica e la pubblica amministrazione; che contiene una rappresentazione del conto economico illecito dell’organizzazione, con una specifica rappresentazione delle relative disponibilità extracontabili». Non bastano i soldi però per impadronirsi di una metropoli. Perché un uomo al di sotto di ogni sospetto come Carminati riesca ad assemblare una simile macchina di potere e farla marciare indisturbata per anni servono coperture che vanno più in alto. Nell’atto d’accusa dei magistrati si fa riferimento a questo “terzo livello”, citando rapporti con istituzioni statali, forze dell’ordine e servizi segreti. L’altro fronte dell’inchiesta, che deve decifrare quanto il sistema criminale fosse affondato nel cuore dello Stato. Ma c’è pure una dimensione orizzontale della collusione, un magma di complicità minute, dai medici ai commercialisti, dai palazzinari ai burocrati, che hanno garantito la prosperità della rete. Il rapporto che Carminati aveva creato con gli imprenditori viene spiegato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino: «Le indagini hanno consegnato una fotografia preoccupante, perché sovrapponibile al modus operandi delle mafie tradizionali nel rapporto con gli imprenditori, che si rivolgono all’organizzazione per avere protezione dall’aggressione della malavita predatoria. Di fronte a questa richiesta scatta la tutela dell’organizzazione mafiosa e, a fronte della protezione accordata, l’organizzazione non chiede soldi, ma di entrare in affari con l’impresa. E ci riesce ottenendo un punto di riferimento imprenditoriale, facce pulite attraverso cui realizzare i propri interessi criminali». E poi aggiunge: «Carminati spiega così il suo approccio con gli imprenditori: “l’obiettivo è entrare in affari, instaurare un rapporto di tipo paritario che garantisce vantaggi reciproci. Mi puoi anche dire che mi dai un milione per guardarti le spalle, ma dall’amicizia nasce un discorso che facciamo affari insieme. Io ho fatto questo discorso a tutti, devono essere nostri esecutori, devono lavorare per noi. Gli faccio guadagnare un sacco di soldi”. L’obiettivo è dunque acquisire attività economiche che significa avere appalti e servizi, soprattutto verso le pubbliche amministrazioni». Quelle romane erano cosa loro. Al Comune negli anni di Alemanno avevano trovato sempre le porte aperte, inserendo uomini di provata fedeltà in strutture chiave come l’Ama, la municipalizzata dei rifiuti, o l’Ente Eur, di cui era amministratore delegato Riccardo Mancini (arrestato). Ma anche il cambio di giunta e l’arrivo della sinistra del sindaco Ignazio Marino non intacca i loro business. Buzzi si vanta di potere contare su sei dei nove assessori designati. Ora l’assessore Daniele Ozzimo e il presidente dell’assemblea capitolina Mirko Coratti, entrambi del Pd, sono finiti sotto inchiesta e si sono dimessi. Il partner di Carminati sostiene di non avere problemi neppure con la Regione Lazio, dove ha chi gli tiene i rapporti con il governo di Nicola Zingaretti. E poi c’è Luca Odevaine, un tempo braccio destro di Walter Veltroni al Campidoglio e ora fondamentale per fare affluire nelle cooperative dei fascio-ladroni quei profughi che «valgono più della droga». Ma oltre ai politici stipendiati con un mensile fisso ci sono quelli pagati a prestazione: una percentuale per ogni appalto. Nomi e cifre censite proprio nel «libro nero» che adesso tutti vogliono recuperare.
Mafia Capitale: Da "Er Cecato" a "o Pazzo" L'alleanza che detta legge nella Capitale. Il clan fascio mafioso di Carminati e la camorra napoletana di Michele Senese detto "O Pazzo" che a Roma Nord ha investito in ristoranti e locali. E al suo servizio ha "La batteria di picchiatori di Ponte Milvio" con a capo Diabolik. Il leader degli Irriducibili della Lazio, scrive Giovanni Tizian su “L’Espresso”. Roma Nord. Ponte Milvio. La zona diventata famosa dopo il film “Tre metri sopra il cielo” diventata il luogo simbolo della Capitale per gli innamorati di tutto il mondo, che qui facevano la fila per attaccare il loro lucchetto in segno di amore eterno. Poi il XX municipio ha deciso, all'unanimità, la rimozione dei lucchetti «per motivi di sicurezza e decoro». Però a Ponte Milvio negli stessi anni, e ancora oggi, scorrazza una banda ben più pericolosa dei gruppi organizzati di innamorati che si spingevano fin qui per legare alle ringhiere la loro promessa di fedeltà. Questa zona chic di Roma, infatti, è sotto l'influenza della Mafia Capitale di Massimo Carminati detto “Er cecato”, finita sotto inchiesta dalla procura antimafia di Roma che ha iscritto cento persone nel registro degli indagati, tra cui l'ex sindaco Gianni Alemanno, e ha arrestato 37 persone. Una cosca fatta da manager, vecchi terroristi neri, imprenditori rossi, politici e reduci della Magliana. Un ibrido criminale la cui scoperta sta rivoltando dall'interno il potere romano. Ma Carminati non è solo su quel territorio. Da lui dipendono altri boss. In particolare gli uomini di Michele Senese detto "o Pazzo". Nei rapporti degli investigatori vengono descritti questi equilibri criminali di Roma Nord. I detective la chiamano la “Batteria di Ponte Milvio”. Particolarmente agguerrita e pericolosa con a capo, scrivono gli inquirenti, Fabrizio Piscitelli, conosciuto con il soprannome di Diabolik e noto per essere il capo ultras degli Irriducibili della Lazio. Da settembre scorso è in carcere per traffico di droga. Non solo, la guardia di finanza gli ha sequestrato pure oltre 2 milioni di euro di beni. E scoperto che aveva in mano la commercializzazione dei gadget della sua squadra del cuore. Ai suoi ordini uno stuolo di picchiatori stranieri, albanesi e rumeni. Ma non finisce qui. L'analisi dei carabinieri del Ros va in profondità e scopre che la Batteria Diabolik è al servizio dei «napoletani insediati a Roma nord tra cui i fratelli Genny e Salvatore Esposito che fanno capo a Michele Senese». “O Pazzo” è considerato dagli inquirenti uno dei quattro Re della Roma criminale così come aveva anticipato “l'Espresso” nell'inchiesta del 2012 sui sovrani della mala capitolina. Il gruppo legato a Senese, scrivono gli inquirenti, controlla diversi locali commerciali nella zona: «tra cui il pub Coco Loco, loro abituale luogo di ritrovo». Il boss Senese è considerato un camorrista a tutti gli effetti. La sua carriere inizia nella formazione del padrino Carmine Alfieri. Contrapposti alla Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. E proprio negli anni della guerra tra i due clan che Senese sceglie Roma come base logistica per i traffici e gli investimenti. “Er Cecato” Carminati e “O Pazzo” Senese hanno rapporti cordiali. E soprattutto interessi in comune. Si sono incontrati spesso e anche dopo l'arresto di Senese sono stati registrati ulteriori contatti tra i due clan. Ora pure Carminati è in carcere. Ma il loro regno non è ancora al tramonto.
Eppure la storia racconta un’altra cosa.
Scandalo di Capodanno 2015: Vigili assenteisti dagli a Marino, scrive Aurelio Mancuso su “Il Garantista”. Il diluvio di certificati medici giunti il 31 dicembre, insieme a permessi per donazione di sangue, assistenza parenti o per gravi motivi, per cui l’83,5% dei vigili urbani dell’urbe ha marcato visita, è un altro grave segnale che si abbatte su una città colpita già dalle inchieste su mafia capitale. Non sfugge a molti osservatori, che sia in atto un tentativo, perlomeno varie azioni anche indipendenti tra loro, di disarcionare un sindaco ritenuto scomodo, non compatibile rispetto a comportamenti, abitudini che si sono sedimentate. Si percepisce che la “casta” compiacente, o peggio che si faceva corrompere o si associava ai progetti criminali sugli appalti, sulla povera gente, sia la parte più esposta di un andazzo generale coerente con la volontà di aggirare le regole, di utilizzarle per condizionare la politica, per mantenere sempre un clima di emergenza. Di tutto questo si avvantaggia sicuramente Matteo Renzi, che ha buon gioco a scrivere su twitter: «Leggo di 83 vigili su 100 a Roma che non lavorano ”per malattia il 31dic. Ecco perché nel 2015 cambiamo regole del pubblico impiego. #Buon2015». Così un episodio gravissimo, collegato anche all’atteggiamento degli autisti della metro A che solo in sette su ventiquattro si son presentati la sera di Capodanno, diventa immediatamente questione nazionale, rende “inevitabile” l’intervento del governo, per correggere le storture come quelle emerse a Roma. I vigili non vogliono che parta la rotazione prevista dalla riforma varata dal comandante e appoggiata convintamente da Marino e, avevano minacciato un’assemblea sindacale proprio nella notte di San Silvestro, gesto poi rientrato, che però in molti sospettano sia stato trasformato in quello che è avvenuto: uno pseudo sciopero. La prima reazione del Campidoglio non lascia dubbi su come la pensa Marino: «Stigmatizza l’atteggiamento di quanti hanno cercato di sabotare i festeggiamenti del Capodanno con una diserzione numerica assolutamente ingiustificata». Lo staff del sindaco accusa che le divergenze sorte nelle ultime settimane sul fronte della rotazione degli agenti o sulla definizione del salario accessorio: «Sono state prese a pretesto per venir meno alla propria professionalità e ai propri doveri. Perciò sarà rigorosamente ricostruita l’intera vicenda a favore dell’autorità giudiziaria e di garanzia. Ogni condotta illecita sarà sanzionata amministrativamente». Le opposizioni se la prendono però con il sindaco. Giovanni Toti consigliere politico di Fi denuncia: «Roma città fuori controllo: 83,5% dei vigili assenti a Capodanno. Macchina amministrativa bloccata e il Pd non vuole votare». Gli fa eco Matteo Salvini, segretario della Lega: «A Roma vigili e autisti di autobus protestano. Invece di prendersela con loro, Renzi licenzi il primo problema della città: il sindaco Marino». Ogni occasione è buona per contestare il sindaco chirurgo, però nessun esponente della passata maggioranza di centro destra che ha amministrato la capitale, riconosce ciò che ai cittadini romani appare lampante: negli scorsi anni la macchina comunale è stata abbandonata e questo ha determinato un generale abbassamento del rispetto delle regole, ma soprattutto degli utenti che ogni giorno subiscono un generalizzato disservizio. Marino non ci sta e anche lui su facebook lapidario scrive: «Non sono riusciti a guastare la festa. In 600 mila abbiamo passato il capodanno in piazza. Ma chi ha provato con assenze ingiustificate e ingiustificabili a far saltare tutto ne deve rendere conto. Stiamo facendo tutte le verifiche per accertare le responsabilità». E’ probabile che molti impiegati pubblici non abbiano compreso che dall’emersione dello scandalo “mondo di mezzo”, Roma è diventata il luogo su cui si giocherà la credibilità non tanto del primo cittadino ma del presidente del Consiglio, intenzionato, come segretario del Pd, attraverso il commissariamento di rivoltare come un calzino il partito locale e, con azioni dell’esecutivo, tra cui la riforma Madia in discussione al Senato, di rimuovere tutte le posizioni di rendita, privilegi, comportamenti lassisti. Per chi ancora avesse dubbi è lo stesso sindaco a chiarire: «Ringrazio il premier Renzi e il ministro Madia per il sostegno che stanno dando alla nostra iniziativa. Chi ha finto di essere malato, chi ha inventato scuse ne dovrà rendere atto nei modi previsti dalla legge e assumersi le propria responsabilità. A chi ha lavorato e lavora per la città vogliamo ribadire la nostra gratitudine e quella dei romani». I sindacati confederali dopo un giorno di silenzio, ieri hanno emanato un comunicato stampa: «Stigmatizziamo con forza i disagi che si sono verificati nella notte di capodanno, è nostra opinione che le responsabilità di quanto successo vadano ricercate comunque a 360 gradi, e gli abusi se accertati, puniti. Anche questa volta non abbiamo in nessun modo dato indicazioni ai lavoratori difformi da quanto previsto dalle norme, contratti e regolamenti». La premessa, che serve a chiamarsi fuori da ogni responsabilità, però è più chiara quando lascia il posto alla risposta politica: «Pretendiamo che sulla vicenda si faccia totale chiarezza. Anche perché le dichiarazioni di queste ore da parte di amministrazione e governo che sparano nel mucchio finiscono per alimentare polemiche dannose e strumentali che non risolvono i problemi. Quanto sta accadendo non fermerà le nostre rivendicazioni, invece dimostra come sia indispensabile per cambiare le cose ricercare soluzioni condivise con il coinvolgimento dei lavoratori». Il Garante per gli scioperi e persino la magistratura valuteranno l’accaduto, rimane che, i sindacati scrivono: “Bisogna interrogarsi sul clima di esasperazione”, rischiando di fornire un lasciapassare culturale a chi ha utilizzato giuste tutele per scopi non nobili. Alcuni però, vigili interpellati dalle agenzie si sono difesi: «Non possono obbligarci a farlo. Alle 19 del 31 hanno fatto scattare la reperibilità. Non c’era nessun motivo. La reperibilità si fa per motivi di emergenza, come la neve, alluvioni, terremoti o altre calamità. Solitamente la notte di Capodanno lavoravamo in 700 in straordinario. L’anno scorso ce ne sono stati 450. Quest’anno era in strada solo chi aveva il turno. Niente straordinari. Quindi tutto è in regola».
Capodanno 2015 a Roma, l'83,5% dei vigili in turno si dà malato. Il comandante: "Diserzione che infanga l'intero corpo". Polemiche per l'incredibile numero di certificati per malattia, donazione sangue e disabilità giunti. Sullo sfondo lo scontro sul contratto decentrato. Il Campidoglio: "Tutto è andato bene grazie ai sostituti reperibili". Ma il vicesindaco accusa: "Un dato inaccettabile, a rischio la sicurezza dei cittadini". Ritardi anche nella metro e Atac ammette: "A San Silvestro, presenti solo 7 autisti su 24", scrive “la Repubblica”. Per la notte di Capodanno, l'83,5 per cento dei vigili che dovevano lavorare era assente per malattia, donazione sangue, disabilità. A renderlo noto è il Campidoglio. "La serata e la nottata si sono svolte senza intoppi per la mobilità e la sicurezza delle 600 mila persone che hanno festeggiato l'arrivo del 2015 nelle strade della Capitale, a via dei Fori Imperiali e al Circo Massimo. Il servizio degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale è stato garantito grazie al previdente ricorso all'istituto della pronta reperibilità, affinché si potesse disporre di un numero sufficiente di personale da impiegare nei servizi di viabilità finalizzati alla sicurezza stradale. Sono state impiegate circa 470 unità, 240 dalle ore 18.00/19.00 (75 di reperibilità) e circa 230 dalle ore 24.00 (45 di reperibilità). Inizialmente, i servizi di Capodanno prevedevano di impiegare circa 700 unità, come nei precedenti anni, in turno straordinario. Ma la mancata adesione allo straordinario aveva indotto il comando del corpo a disporre una ridistribuzione di tutto il personale". Il comunicato del Campidoglio fa riferimento alla dura battaglia dei giorni scorsi, con i vigili che avevano deciso di riunirsi in assemblea e il Prefetto che li aveva richiamati perchè lavorassero. "Dopo il differimento dell'assemblea sindacale dei giorni scorsi, prevista proprio per il 31 dicembre a ridosso della mezzanotte, già ieri pomeriggio era apparso chiaro che, a fronte della iniziale disponibilità di 1000 agenti (in servizio ordinario per il turno di seminotte) si sarebbe giunti progressivamente a 165 unità, per un totale di 835 assenze dell'ultima ora (-83,5%), motivate da malattia, donazione sangue, legge 104, legge 53 art. 19 ecc.. Inoltre, per il turno di notte dal numero iniziale di 300 unità previste si sarebbe arrivati a 185 unità, con 115 assenze riconducibili alle medesime motivazioni (percentuale di assenza del 38%). Ciononostante, proprio grazie alla reperibilità, è stato possibile garantire tutte le chiusure stradali, nonché governare l'afflusso e il deflusso dei tantissimi cittadini e turisti in strada a festeggiare". "Il dato delle assenze per malattia e altre motivazioni, pari all'83,5% è talmente rilevante numericamente da essere inequivocabile e inaccettabile. E poteva essere molto grave per la città di Roma. Tanto più perché arriva nel momento in cui, per altri versi, stiamo cercando un terreno comune di confronto, per concludere positivamente la questione sul contratto decentrato", commenta in una nota il vicesindaco Luigi Nieri. "Nessuno mai, e io per primo, mette in dubbio il legittimo diritto di sciopero per i lavoratori, o il duro ma leale dialogo con l'amministrazione sulle questioni sindacali. Altro - prosegue Nieri - è la mancata assunzione di responsabilità di fronte alla città e ai romani, in occasione di un appuntamento fisso, popolare e seguitissimo, che ieri ha portato in strada a festeggiare il nuovo anno oltre 600mila persone. Il mio più sincero ringraziamento va invece a tutti gli agenti che ieri sera sono scesi in strada per lavorare, con senso di responsabilità e del dovere, per permettere al resto dei cittadini di divertirsi". Parla anche il comandante generale della polizia locale Raffaele Clemente: "Gli agenti che hanno lavorato ieri sera e ieri notte hanno compiuto un eccellente lavoro e per questo li ringrazio, a nome dell'amministrazione, della città e mio personale. Diversamente, non posso che stigmatizzare l'atteggiamento di quanti, tra i miei colleghi, hanno cercato di sabotare, con una diserzione numerica assolutamente ingiustificata, la festa popolare del Capodanno, cercando di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini ma anche il buon nome dell'intero Corpo degli agenti della Polizia locale e della città di Roma. Le divergenze sorte nelle ultime settimane o mesi, sul fronte della rotazione degli agenti o sulla definizione del salario accessorio - conclude Clemente- non dovrebbero essere prese a pretesto per venir meno alla propria professionalità e ai propri doveri . Per questa ragione, per un evidente bisogno di equità nei confronti di quanti ieri hanno prestato il proprio dovere con professionalità e spirito di abnegazione sarà rigorosamente ricostruita l'intera vicenda a favore delle autorità giudiziaria o di garanzia. Ogni eventuale condotta illecita sarà sanzionata amministrativamente".
L'ATAC. E nella notte di San Silvestro, rallentamenti fino a 20-25 minuti d'attesa sulla metropolitana A, secondo quanto sostiene la stessa azienda che parla di corse più lente a causa dell'assenza di conducenti nel turno straordinario 23.30-2.30, cioè quello oltre l'ordinario orario di chiusura del servizio metropolitano, organizzato in occasione della notte di San Silvestro. Nello specifico, sui convogli della linea A della metro - dove sono in totale 150 i macchinisti in servizio - erano disponibili solo 7 conducenti sui 24 che sarebbero stati necessari a garantire la regolarità del servizio. Per questo, fanno sapere dall'azienda, le corse sono state più lente dalle 23.30 fino a fine servizio, "circa 10-15 minuti di attesa a fronte di 5". "E' stato invece regolare il servizio sulla linea B", garantiscono dall'Atac.
Vigili malati, «azioni disciplinari». E il comandante va in procura. Madia: «Attivato l’ispettorato». Indagine interna in Campidoglio, all’esito della quale gli atti potrebbero essere inviati alla magistratura. Anche l’Autorità di garanzia sugli scioperi apre un procedimento, scrive Lavinia Di Gianvito su “Il Corriere della Sera”. Più di otto vigili su dieci in malattia e solo sette macchinisti su 24 alla guida dei treni della metro A: smaltiti i brindisi e i fuochi d’artificio, è bufera sull’astensione di massa della notte di Capodanno. Il primo a intervenire è il premier Matteo Renzi, che su Twitter scrive: «Leggo di 83 vigili su 100 a Roma che non lavorano “per malattia” il 31 dicembre. Ecco perché nel 2015 cambiamo le regole del pubblico impiego #Buon2015». Poco dopo il commento del presidente del Consiglio, ecco l’affondo del ministro Marianna Madia: «Ispettorato ministero Funzione pubblica subito attivato per accertamenti violazioni e sollecito azioni disciplinari» assicura in un tweet la titolare della Pubblica amministrazione. E nel pomeriggio il comandante dei vigili, Raffaele Clemente affida l’indagine interna alla sua vice Raffaella Modafferi: dovrà portare alla luce la verità e metterla a conoscenza delle autorità interessate: quella giudiziaria (nel caso si ravvisassero reati penali), quella amministrativa (per uso e valutazioni interne) e, infine, quella di garanzia (Garante degli scioperi). Poi nella serata del 2 gennaio il premier Renzi è tornato sulla vicenda con un post su Facebook: «Il 2015 sarà l’anno della riforma costituzionale e della nuova legge elettorale. Ci occuperemo di cultura, scuola, Rai, green-act, lavoro. Di pubblico impiego, di modo che non accadano più vicende come quella di Roma dove la notte del 31 dicembre l’83% dei vigili urbani è rimasto a casa per malattia o donazione sangue». La linea dura di Palazzo Chigi è condivisa dal Campidoglio, il vice sindaco Luigi Nieri aveva annunciato in mattina dell’avvio dell’indagine interna aggiungendo: «In tempi rapidi si avranno dei risultati, in base a questi si deciderà se interessare la magistratura». Su Facebook il sindaco Ignazio Marino da un lato esulta per la notte di festa filata liscia anche senza municipale, dall’altro avverte che la «fuga» dalle strade avrà conseguenze:«Non sono riusciti a guastare la festa. In 600 mila abbiamo passato il Capodanno in piazza. Ma chi ha provato con assenze ingiustificate e ingiustificabili a far saltare tutto ne deve rendere conto. Stiamo facendo tutte le verifiche per accertare le responsabilità. Ringrazio il premier Matteo Renzi e il ministro Marianna Madia per il sostegno che stanno dando alla nostra iniziativa». «A Roma vigili e autisti di autobus protestano. Invece di prendersela con loro, Renzi licenzi il primo problema di Roma: il sindaco Marino!». ha commentato su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini. E contro il sindaco, su questa vicenda, si sono schierati numerosi esponenti di centrodestra: da Alfio Marchini («città paralizzata dall’incapacità amministrativa del sindaco») a Giorgia Meloni, Fratelli di Italia («Roma non merita un sindaco che non ha neanche il controllo del suo personale»). In realtà per «interessare la magistratura» (sono le parole di Nieri) non si attende la fine dell’indagine interna. Già a fine mattinata il comandante dei vigili, Raffaele Clemente, viene notato nei corridoi di piazzale Clodio. Al primo piano del palazzo di giustizia infatti incontra il procuratore aggiunto Maria Monteleone: l’accordo è che per ora la magistratura resta in stand by, in attesa dell’esito dell’ispezione avviata dal Comando generale della polizia municipale. Questa durerà alcuni giorni e al termine, se emergeranno indizi di reati, gli atti verranno inviati alla procura. E non solo il governo. Anche l’Autorità di garanzia per gli scioperi avverte che aprirà un procedimento di valutazione sull’«epidemia» della notte di San Silvestro. Al termine delle verifiche, potrebbero essere adottate le sanzioni previste dalla legge, perché lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è possibile - ricorda il garante - solo all’interno delle regole della 146 del ‘90. Sul fronte politico, mentre il Pd prende le distanze dall’astensione di massa della municipale, Forza Italia ne approfitta per attaccare Palazzo Chigi sul Jobs act. «Pur potendo accampare altrettante rivendicazioni - osserva il capogruppo democratico in Campidoglio Fabrizio Panecaldo - non per questo poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, medici, infermieri, fornai, trasportatori, operai, volontari, assistenti sociali si sono dati malati in massa abbandonando la comunità a se stessa. Su questa vicenda si deve andare fino in fondo». Alessandro Cattaneo, di FI, sottolinea che se da una parte «non si possono legittimare certi comportamenti», dall’altra i vigili «possono dormire sonni tranquilli, grazie a un Jobs act che non ha toccato minimamente la pubblica amministrazione». Anche l’Udc, attraverso il vicesegretario vicario Antonio De Poli, vuole punire la municipale: «Contro i fannulloni serve una linea dura. Vanno individuati i responsabili che hanno permesso una situazione così grave e anomala». Nè la polizia municipale trova un qualche sostegno nelle associazioni dei consumatori. È drastica l’Aduc, che propone di ricominciare da zero: «Se per il Capodanno di Roma Caput Mundi si presentano 165 vigili sui 900 previsti, vuol dire che occorre sciogliere il Corpo e definire nuovi assetti. Stessa sorte dovrebbe toccare all’Atac, che con sette autisti presenti su 24 sulla linea A della metro ha creato non pochi disservizi». A difendere la municipale, insomma, restano solo (alcuni) sindacati, che giustificano i vigili assenti con motivazioni diverse. Per Franco Cirulli, della Uil, «la maggior parte ha donato il sangue e, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali, era esentata dal servizio». Il segretario del Sulpl Stefano Giannini sostiene invece: «La maggior parte delle assenze non è stata per malattia, ma per ferie. La verità è che è stato tenuto in servizio un numero di agenti non in grado di coprire l’ordinario. C’è stato un errore di valutazione». E Stefano Lulli, dell’Ospol, precisa: «Il dato delle malattie, a quanto ci risulta, è stato di meno del 50%. Considerati gli agenti malati da giorni, il numero relativo al solo 31 dicembre si abbassa ulteriormente. I medici, poi, le hanno certificate». Anche secondo Lulli c’è stato «un problema di disorganizzazione del comando. In tanti stavolta non hanno aderito volontariamente allo straordinario e questo non è stato calcolato. Il tutto in un Corpo che ha 2.500 agenti in meno rispetto a quelli che dovrebbe avere».
Vigili assenti a Roma la notte di Capodanno, ennesima figuraccia "capitale". La ripicca sindacale dei caschi bianchi che non vogliono accettare le nuove regole, scrive Claudia Daconto su “Panorama”. L'unica vera malattia che può aver tenuto a casa l'83% dei vigili urbani di Roma la sera di Capodanno si chiama “ricatto”. Da mesi infatti i caschi bianchi sono sulle barricate contro l'introduzione del contratto decentrato (che interviene anche sul salario accessorio) e il piano anti-corruzione che, tra le altre cose, prevede la rotazione degli agenti sui territori. Così, quando il Prefetto ha vietato che si riunissero in assemblea a ridosso della mezzanotte del 31 dicembre, improvvisamente loro si sono ammalati, hanno dovuto prestare assistenza a parenti disabili o sono stati colti da un irrefrenabile slancio di generosità e sono andati a donare il proprio sangue. L'ultima notte dell'anno, mentre per le strade del centro di Roma, tra via dei Fori Imperiali e il Circo Massimo, c'erano 600mila persone che festeggiavano l'anno nuovo. Con i rischi per la sicurezza che si corrono ogni volta che tanta gente si concentra in uno spazio limitato. Tutto è andato bene solo perché era stato disposto l'istituto della pronta reperibilità proprio per far fronte al forfait rifilato non tanto ai propri superiori, ma alla città stessa, dalla stragrande maggioranza dei 700 caschi bianchi cui era stata chiesta la disponibilità a fare un turno straordinario. Ma è stata, lo stesso, l'ennesima figuraccia “capitale. Il comandante Raffaele Clemente ha parlato senza mezzi termini di tentativo di sabotaggio, di una “diserzione che infanga l'intero corpo. Il sindaco Ignazio Marino ha accusato i vigili assenti di essere “ingiustificabili”. Il vicesindaco Luigi Nieri ha definito le assenze “inequivocabili e inaccettabili” e fatto sapere che è stata aperta un'indagine. A livello nazionale il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia ha annunciato l'invio di ispettori e sollecitato azioni disciplinari. Il premier Matteo Renzi ha twittato: “Leggo di 83 vigili su 100 a Roma che non lavorano “per malattia” il 31 dic. Ecco perché nel 2015 cambiamo regole pubblico impiego”. Il sindacato Sulpl ha giustificato gli agenti con la scusa del “piano ferie sbagliate” mentre il Garante sugli scioperi ha fatto sapere che sarà aperto un procedimento di valutazione. I romani, nel frattempo, hanno già fatto le loro. Quella dei vigili urbani è sempre stata tra le categorie meno amate. E non solo per la raffica di multe che in una città caotica e indisciplinata come Roma è facilissimo prendere. Ma soprattutto per i tanti casi di corruzione, minacce, estorsioni a loro carico svelati da inchieste giudiziarie più o meno recenti che hanno travolto non solo i semplici dipendenti ma addirittura i massimi vertici. Adesso sarà anche peggio. Perché venendo meno - è il giudizio dei più - a senso del dovere e responsabilità, hanno dimostrato di guardare solo al proprio giardino. Il loro egoismo li sta già esponendo – basta dare un'occhiata ai social network - a critiche ancora più dure da parte di chi li considera dei super garantiti che piantano grane se vengono spostati da una parte all'altra della città per evitare insani radicamenti. La loro autorevolezza è sotto zero. Nessuno ci sta a subire ripicche. Soprattutto non ci sta una città che ambisce oggi a ospitare un evento internazionale come i Giochi olimpici. E che invece si ritrova puntualmente ostaggio una volta dei tassisti, l'altra dei bancarellari abusivi, un'altra ancora dai ristoratori e baristi del centro. O rallentata da quei 17 macchinisti della metro che, sui 24 necessari, non erano in servizio la notte di Capodanno. O addirittura messa sotto scacco proprio da chi, per la divisa che veste, dovrebbe invece garantirne la sicurezza, l'ordine, il decoro.
"I vigili assenteisti non sono una sorpresa. Da anni raccontiamo lo sfascio di Roma". Parla il fondatore di "Roma fa schifo", uno dei blog più letti della capitale, in prima linea nel contrasto al degrado. "La loro è un'opera di sabotaggio. Speravano ci scappasse il morto?" Scrive Daniele Castellani Perelli su “L’Espresso”. «I vigili urbani volevano che ci scappasse il morto», dice il fondatore del blog “Roma fa schifo”: «Bastava leggere le pagine Facebook loro e dei loro sindacati per capire che si preparavano a un sabotaggio, per protesta contro la rotazione del personale e la riforma dello stipendio accessorio. I vigili urbani si occupano della sicurezza, e sabotarla significa sperare che ci scappi il morto. È gravissimo, come se avessero scioperato i medici del pronto soccorso». A Roma, la notte di Capodanno, l'83,5 per cento dei vigili era assente per malattia, donazione sangue o disabilità. E sulla linea A della metro erano disponibili solo 7 conducenti su 24, con i passeggeri che hanno atteso i treni anche per 20-25 minuti. Una figuraccia di cui parla tutta Italia, ma che sicuramente non ha sorpreso gli autori del blog più letto dai romani, “Roma fa schifo”, che da anni attacca il malcostume degli impiegati pubblici come una delle tante varianti del degrado della Capitale. Ma chi c'è dietro questo discusso sito? C'è Massimiliano Tonelli. Romano, 36 anni, cresciuto tra Montesacro e San Giovanni, si è laureato in scienze delle comunicazioni a Siena. In questa intervista si racconta per la prima volta, e sul caso dei vigili dice come al solito parole forti e chiare: «È un problema locale, perché a Torino ci si vergognerebbe di “buttarsi malati”, mentre a Roma ce ne si vanta al bar. Ma è anche un problema nazionale, di leggi sul pubblico impiego, e quindi è un autogol pazzesco, che consentirà al governo, speriamo, di mettere finalmente mano a una riforma». Tonelli è cofondatore e anima di un network di blog che fustiga Roma e i costumi dei romani: Degrado Esquilino, Cartellopoli, Pro Pup Roma (a favore dei parcheggi sotterranei), Bike-Sharing Roma. Ma il più famoso di tutti è appunto Romafaschifo.com (sottotestata: chi ha ridotto così la città più bella del mondo?), un blog in cui i cittadini raccontano e fotografano la decadenza della città, dalle piccole illegalità alle varie mafie, e che Marino stesso un anno fa ammise di leggere con grande attenzione. Ci lavorano, racconta Tonelli, «4-5 persone, più centinaia, anzi migliaia di potenziali reporter, cittadini comuni che ogni giorno ci mandano circa 150 tra foto e segnalazioni su tutto ciò che non va, sono loro i veri padroni del sito, su cui infatti non trovi il mio nome da nessuna parte». È un blog anche discusso, per i toni usati dagli utenti e dagli stessi gestori. Ma è un simbolo di una città stanca, un vero fenomeno per chi vive nella capitale e non solo, visto che Tonelli ultimamente ha attirato l'attenzione della grande stampa internazionale, da “Der Spiegel” a “Business Week”, dalla “Bbc” alla tv pubblica tedesca, che gli sta dedicando un documentario. E il tutto è tanto più sorprendente se si pensa che Tonelli di lavoro fa altro, ovvero gestisce il sito del Gambero Rosso e, dopo aver lasciato Exibart.com, nel 2011 ha fondato la rivista online Artribune.com.
Come è iniziato il progetto di Roma fa schifo?
«L'idea ci è venuta a fine 2007, in piena epoca Veltroni. All'inizio era uno dei siti del nostro network, ma con il tempo ha acquisito un'importanza particolare. Merito della giunta Alemanno, che diciamo ci ha dato molto materiale. Siamo partiti dalla “teoria delle finestre rotte”, che ha ispirato quello che forse è il nostro unico mito, ovvero il sindaco di New York Rudolph Giuliani, capace di risollevare una New York che stava messa persino peggio della Roma di oggi. Se c'è una finestra rotta, va subito riparata, altrimenti presto verranno rotte altre finestre, e in quell'area arriveranno graffitari, gang, prostitute e scippatori. Insomma, bisogna partire dalle piccole cose, da piccoli comportamenti asociali come chi urina per strada o chi non paga il biglietto sui mezzi di trasporto».
Quando è arrivato il salto di qualità?
«Prima con l'apertura del profilo Facebook, che oggi ha 70mila fan, e con l'account Twitter, che hanno avuto un effetto moltiplicatore sul nostro successo. Ma il vero boom lo abbiamo registrato nell'ultimo mese. Siamo passati da 35-40 mila a 440 mila utenti unici al giorno prima con la pubblicazione delle foto della “fellatio di Castel Sant'Angelo”, un rapporto orale fotografato in pieno giorno sul Lungotevere, ennesima dimostrazione del degrado della città. E poi con un articolo sul sindaco Marino. Picchi che hanno fatto interessare al nostro progetto anche grandi gruppi editoriali, anche se, lo dico subito, non siamo in vendita, continueremo a finanziarci con i banner di Google AdSense. Tuttavia è chiaro che, se avessi altro personale, farei riprendere con più continuità le nostre continue campagne, da quella per lo scuolabus all'aumento delle strisce blu fino allo spazzamento meccanico delle strade».
Se dovesse scegliere tra le tante, quali direbbe che sono le vostre battaglie?
«I cartelloni abusivi, la lotta contro i camion-bar, la sosta selvaggia. Tutti temi su cui i grandi nemici sono il benaltrismo e chi dice «poracci, lasciateli lavora'». Ecco, quello è il segnale. Quando qualcuno dice «ben altri sono i problemi» significa che stiamo toccando un nervo scoperto e dobbiamo picchiare duro. Oggi comunque la situazione più esplosiva sono gli scippi sotto la metro da parte delle gang di minorenni».
Vi siete fatti un bel po' di nemici. In generale più di destra o di sinistra?
«I più accesi sono gli estremi, di entrambi i campi. Da un lato gli antagonisti, i centri sociali, che difendono le occupazioni e ci danno dei palazzinari perché siamo a favore di una trasformazione edilizia intelligente. Pensano che siamo fascisti, ma i veri fascisti sono loro, con i loro slogan vecchi di 40 anni sulle “colate di cemento”. Il loro “poraccismo” è nemico dello sviluppo di Roma, perché le grandi aree urbane, come Parigi, sono le uniche a veder crescere il Pil, e invece a Roma nessuno investe. Dall'altra parte c'è Casa Pound, che ci ha denunciato per diffamazione».
Mai ricevuto minacce serie?
«Solo dai writer, che mi telefonano di notte o scrivono sotto casa. Una cosa non molto simpatica, soprattutto per mia moglie e mia figlia. Veniamo alle note dolenti, come il linguaggio spesso violento che usate verso chi vi critica. O il fatto che sembrate giustificare certe reazioni dei cittadini, come chi, tanto per fare un esempio recente, riga le auto parcheggiate sulle strisce pedonali. Il nostro tono volutamente sprezzante fa parte di un'operazione di comunicazione. È un lavoro giornalistico aggressivo, sì. Vogliamo svegliare la gente di questa città prepotente e ignorante, far capire loro che le buche, i manifesti abusivi, i parcheggi in doppia fila sono l'illegalità, non devono più essere la normalità».
Il vostro linguaggio è sprezzante anche verso gli immigrati. Parlate di “vu cumprà”...
«Un'espressione che continueremo a usare».
...e date voce a cittadini che, soprattutto quando si parla di rom, non usano mezze misure.
«Ascolti, la nostra posizione sugli immigrati è questa. Sono una grande opportunità, specialmente economica, come dimostra il Pil che riescono a generare. Poi, è vero, ci sono stranieri che creano problemi, ma mai quanti ne creano i romani. Diro di più, e l'abbiamo scritto pochi giorni fa a proposito dei rom: noi non siamo capaci di accoglierli. Tanti rom sanno benissimo che qui non c'è certezza della pena, e ci sono leggi per cui se sei una minorenne incinta nessuno ti può toccare. I rom ci sono in tutta Europa, ma solo in Italia ripuliscono i turisti in metropolitana. È lo stesso motivo per cui gli immigrati del Bangladesh, se sono ingegneri, vanno a Londra, e se non hanno qualifiche finiscono per vendere i fiori a Roma. Non sappiamo attrarre immigrazione qualificata».
Prima che scoppiasse il caso di Mafia Capitale, il sindaco Marino era nell'occhio del ciclone per la vicenda delle multe non pagate per la sua Panda. Voi, controcorrente e anche un po' a sorpresa, scriveste un post in sua difesa, che ricevette 34mila condivisioni su Facebook. Lo definiste “sindaco marziano” lodando le sue 10 discontinuità, che i poteri romani, Pd incluso, non gli avevano perdonato: la chiusura della discarica di Malagrotta, i camion-bar via dal centro, l'aumento delle strisce blu, le pedonalizzazioni, la battaglia contro i cartelloni abusivi, la pulizia nelle municipalizzate, i soldi tolti ai consiglieri comunali per la "manovra d'aula", le unioni civili, i risparmi per le forniture, la rotazione dei vigili urbani sul territorio.
«Non era una difesa, perché all'inizio di quell'articolo scrivevamo che forse neanche si era reso conto quali poteri avesse sfidato... Abbiamo voluto solo dire: attenzione, chi vuole la testa di Marino vuole la conservazione. A cominciare dal Pd locale, che è un grandissimo problema per questa città, dalla questione dei cartelloni ai lavori pubblici».
E le altre forze politiche?
«Forza Italia è uguale al Pd, ma meno elegante nelle sue “zozzate”. I grillini, poverini, sono completamente inutili. Per questo dico che, se vogliono dimostrare di servire a qualcosa, dovrebbero entrare in maggioranza, chiedere un assessorato, magari sulla scorta dei 10 punti che abbiamo segnalato sul nostro sito».
Pensa che il vostro sito abbia aiutato a cambiare i romani?
«Sì, a quel 10 per cento che ci scrive: «Prima di conoscervi non vedevo certe cose». È solo una minoranza, ma non fa più finta di niente e si ribella a una grande brutalità, quella dell'abitudine al degrado. D'altronde la “Ryan Air generation” è stato un dramma per i politici italiani. Chiunque con pochi euro può andare a Londra, Parigi o Madrid e vedere che, nonostante la crisi, le altre città europee funzionano».
Ha votato più a destra o a sinistra?
«Sono tanti anni che non voto. Direi mai a destra. Forse l'ultima volta avrò votato qualcosa tipo la Lista Dini».
Il sindaco migliore chi è stato?
«C'è poco da scegliere. Sono anche contro il mito di Petroselli e Argan, che non ci hanno certo lasciato in eredità una città europea. Potrei salvare un po' il primo Rutelli».
Alfio Marchini le piace?
«Mi sembra un populista, che cerca gli applausi. A Roma serve un sindaco che cerchi i fischi, se vuole davvero cambiare la situazione».
A luglio un deputato del Pd, Michele Anzaldi, l'ha proposta come assessore alla cultura.
«Non mi interessa scendere in politica, anche se un po' tutti i partiti, in privato, mi chiedono consigli, perché ho il polso del territorio».
Però Roma non fa solo schifo, su. Ci dica una cosa bella di questa città.
«Non è una città provinciale, né razzista, né chiusa. Può essere una piattaforma interessante anche a livello culturale, se venisse dotata di una informazione adeguata. E poi questo è un momento eccezionale per il cibo a Roma, c'è una bella scena enogastronomica. Lo dice uno che lavora per il Gambero Rosso».
Quanto sei sporca Roma: il malaffare dell'Ama e l'emergenza immondizia. L'azienda rifiuti, l'Ama, spreca fiumi di milioni senza pulire. E senza multare chi insudicia la città. Un disservizio che lede ulteriormente l'immagine della Città eterna. E Che viene denunciato da tempo. Senza risultati, scrive Fabrizio Gatti su “L’Espresso”. Un cassonetto ingombro di rifiuti nel centro di Roma Là dentro, in una stanza ad alto isolamento dell’istituto Spallanzani, il medico di Emergency contagiato dal virus sta lottando contro Ebola. Qua fuori, vicino all’ingresso dell’ospedale al numero 292 di via Portuense a Roma, i netturbini dell’Ama hanno abbandonato due camioncini pieni di rifiuti. Le portiere sono aperte, non le hanno nemmeno chiuse a chiave. La Grande Tristezza ti colpisce ovunque. Non c’è bisogno di dritte e soffiate. Se cerchi, trovi. Piazza di Santa Maria Maggiore è una rassegna di cassonetti, rifiuti abbandonati, un cartello divelto, bottiglie lasciate sui gradini. Non appena se ne vanno i turisti, davanti alla basilica e intorno alla fontana comincia il balletto dei ratti. Grandi e piccini. Corrono, raccolgono tra i rifiuti scarti di cibo, si arrampicano a beretti. Chissà quale malsano protocollo prevede che carichi di immondizia maleodorante siano parcheggiati per tutto il weekend proprio davanti a uno dei centri europei più importanti per la cura delle malattie infettive. O forse sì, la risposta è chiara. Basta scorrere l’elenco degli arrestati nell’operazione antimafia che in queste ore ha coinvolto Gianni Alemanno, l’ex sindaco della capitale ed ex ministro Pdl. Franco Panzironi da esperto in incremento delle razze equine è stato amministratore delegato dell’Ama, l’azienda municipale dei rifiuti. Giovanni Fiscon con 220 mila euro di stipendio record è l’attuale direttore generale dell’azienda e in Ama può contare sulla moglie. Tutti amici degli amici di Alemanno, dicono le ultime inchieste: da quella sugli sprechi di parentopoli all’ultima sul boss neofascista Massimo Carminati. Panzironi e Fiscon ovviamente sono innocenti fino al terzo grado di giudizio. Ma in questo clima di allegra famiglia in camicia nera, qualche furgone, qualche cassonetto, qualche sacco può sfuggire al controllo. E continua a sfuggire. Magari vi sarà capitato di vedere sacchetti o rifiuti ingombranti abbandonati per strada, perfino in pieno centro: non è difficile a Roma. Sapete quante multe sono state date per questa sciagurata abitudine? Venticinque in tutto il 2014, da gennaio a ottobre. E se avete pestato una cacca sul marciapiede, in attesa che vi porti fortuna, forse vi incuriosisce conoscere quanti siano i proprietari di cani multati nell’ultimo anno: zero. Perché stupirsi? Se proprio volete chiamare i vigili, provate a cercarli al bar in piazza di Santa Maria Maggiore all’Esquilino: la notte tra il 23 e il 24 novembre ce n’erano addirittura sei in piacevole servizio in divisa per un’ora. Ma il diario di viaggio dell’ultima settimana nel cuore della Grande Tristezza va ben oltre il malcostume. Le pagine romane da martedì raccolgono anche ritagli di cronaca nera: criminalità, politica, appalti e i neofascisti della banda della Magliana ancora lì, in cima alla piramide a muovere soldi e burattini. Turno di notte: sei vigili, due auto, un'ora al bar. Dalle 00.20 all'1.19 sei agenti della Municipale in divisa, tra cui due graduati, con due macchine di istituto hanno chiacchierato al bar-gelateria davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Dopo un'ora sono stati avvicinati da un passante infuriato perché era stato appena aggredito dietro l'angolo da due persone. A quel punto i vigili sono saliti in auto e se ne sono andati, però nella direzione opposta rispetto a quella indicata Il premier Matteo Renzi ha detto e ripetuto di aspettare il 15 dicembre, giorno della consegna dei collari d’oro agli italiani che si sono distinti nello sport, per annunciare la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. Sull’immagine della capitale nel mondo, però, prima dei collari sono arrivate le manette. Spese fuori controllo per centinaia di milioni. Manager incompetenti. Roma e i romani spremuti. E le casse portate al default. La mafia non è mai stata dalla parte della gente. Né della buona amministrazione. Qualcuno lo segnalava da anni, confrontando la spesa corrente con la totale mancanza di piani per il futuro. Sono i ricercatori dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, istituita dodici anni fa dal consiglio comunale. Anche quest’anno, cinque analisti e un direttore tecnico hanno lavorato per oltre tre mesi. Dal loro rapporto sul 2014, pubblicato il 24 novembre, non si salva nessuno. Sentite qua: «Nonostante una specifica previsione del regolamento del consiglio comunale, sin dal 2002 non si è mai svolta un’apposita seduta per l’esame e la discussione della relazione annuale». Fantastico: dal 2002 cinque analisti e un direttore tecnico vengono pagati dal Comune e il loro prezioso lavoro da dodici anni viene puntualmente infilato in un cassetto o buttato nel cestino. Non bisogna però essere pessimisti: «La sensibilità e l’attenzione dimostrata dal presidente Coratti nei confronti dell’attività dell’agenzia sicuramente farà sì che tale mancanza venga sanata, dando l’opportunità all’Assemblea capitolina di confrontarsi sull’intero assetto dei servizi pubblici locali». Complimenti all’onorevole Mirko Coratti, presidente Pd dell’Assemblea capitolina, il consiglio comunale romano. Cioè no, un momento: Coratti è tra gli indagati in Comune, corruzione aggravata e finanziamento illecito. Martedì i carabinieri gli hanno perquisito l’ufficio e si è subito dimesso. Anche lui ovviamente è innocente fino a prova contraria. Ma con l’aria che tira, la qualità dei servizi pubblici rischia di non essere più in cima all’agenda. E quando mai lo è stata? È duro il lavoro dell’analista a Roma se oggetto dell’indagine è la pubblica amministrazione: «L’aspetto relativo ai poteri di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili nei confronti dei soggetti gestori e degli uffici di Roma Capitale», denuncia l’agenzia, «dovrà a nostro avviso essere oggetto di uno specifico atto di indirizzo da parte dell’assessore e del segretario-direttore generale, viste le difficoltà, i ritardi e talvolta forse una certa ritrosia a voler mettere tempestivamente a nostra disposizione i dati e le informazioni richieste». Se non ci riescono loro, che sono stati incaricati dal Comune, figuriamoci cosa può succedere a un cittadino qualunque quando va a protestare agli sportelli. Eppure, calcolando le spese e il personale apparentemente sulle strade, la Grande Tristezza dovrebbe essere lucida come il marmo della Pietà di Michelangelo. Sulla pulizia non sorveglia soltanto la polizia municipale. Ai vigili si aggiungono agenti del “Nucleo decoro urbano di Roma Capitale” e gli ispettori dell’Ama, appositamente formati tra gli ottomila dipendenti dell’azienda pubblica. Negli ultimi mesi sono addirittura aumentati. Meno male. Nel 2014 la violazione contestata con maggiore frequenza dagli agenti accertatori dell’Ama, così vengono chiamati, è quella dell’uso scorretto dei bidoncini condominiali, nelle zone dove la raccolta dell’immondizia viene fatta porta a porta: 6 multe al giorno. E quante volte succede che i camion dell’Ama non riescano a svuotare i cassonetti, perché sono circondati da auto in sosta selvaggia? Vigili, agenti del decoro, accertatori dell’Ama sono rigorosissimi: due multe al giorno in una metropoli di due milioni e 889 mila abitanti. È una media: a volte sono quattro, a volte zero. E nascondere rifiuti nel cassonetto non corrispondente? Una multa al giorno. Lavoro durissimo. Forse è per questo che nell’ultimo anno si è rinunciato a punire chi non raccoglie le cacche dei cani da parchi e marciapiedi e chi getta rifiuti per strada: zero contravvenzioni. «Dato che le strade di Roma sono tutt’altro che pulite né sono prive di escrementi di cani sui marciapiedi, il fatto che non siano state fatte multe... assume una connotazione sociale assolutamente negativa», scrivono gli analisti nella relazione che il consiglio comunale non ha mai esaminato, «in quanto avalla comportamenti collettivi incivili e individualisti che danneggiano direttamente e indirettamente l’immagine della città e della popolazione romana, creando inoltre un danno economico: quantificabile nelle maggiori spese di pulizia a carico di tutti i cittadini». Dal 2009 al 2013 l’attività di vigili, agenti e accertatori per difendere il pubblico decoro è comunque aumentata toccando la ragguardevole produzione di 39 verbali al giorno: suddivisi per municipio sono due verbali al giorno, un record per i quartieri di Roma. Soddisfatti del risultato ottenuto, nel primo semestre del 2014 i controlli sono crollati a otto sanzioni al giorno, una ogni due municipi. Poche? Tante? Nei primi dieci mesi del 2013 l’Amsa di Milano ha emesso 49.769 multe per violazione del regolamento dei rifiuti, 170 al giorno, di cui 2.000 solo per il decoro urbano: «Mentre a Roma veniva elevata una sanzione ogni 263 abitanti, a Milano ne veniva emessa una ogni 25: anche se la città lombarda non si può certo definire dieci volte più sporca della capitale», è scritto nella relazione dell’agenzia inutilmente consegnata al consiglio comunale. Mantenere la città pulita costa meno che pulirla spesso. Sanzionare i cittadini incivili è più corretto che far pagare tutti. Intanto pagano tutti. Soltanto per il lavaggio e la pulizia delle strade il piano finanziario 2014 prevede l’impiego di 171 milioni: cioè 60 euro per ciascuno dei residenti romani, neonati inclusi, con un aumento del 60 per cento in dieci anni per le pulizie e del 138 per cento per la rimozione dei rifiuti abbandonati. E i risultati non si vedono. Ma pagano anche gli italiani. A Roma la raccolta differenziata nel 2013 si è fermata al 31 per cento e l’immondizia continua a finire in discarica, violazione che non riguarda soltanto la capitale: per questo, la Corte europea di Giustizia pochi giorni fa ha condannato l’Italia a 40 milioni di multa una tantum e 42,8 milioni per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure obbligatorie. Altri soldi che saranno sottratti agli investimenti, alla città. Che però si trasformavano in ricchezza per i nuovi boss, intercettati mentre mettevano le mani sui contratti milionari per la differenziata e per la raccolta delle foglie. Perfino gli appalti per la manutenzione del verde sono un enigma a carico dei romani. Da Monte Sacro alla periferia Nord-Est costano 0,38 euro al metro quadro, a Nord-Ovest appena al di là del Tevere li pagano 250 euro al metro: il 6.578 per cento in più. E i cartelloni? La selva pubblicitaria che accompagna i turisti da Fiumicino e Ciampino e nel resto della capitale ha reso al Comune appena 265 mila euro in tutto il 2013. A Genova, la città del sindaco Ignazio Marino, su una superficie molto più piccola sempre nel 2013 hanno incassato un milione e 60 mila euro. Certo, sono genovesi. Ma a Roma non resta nulla: si spendono 900 mila euro all’anno per la rimozione dei cartelli abusivi. Allora, chi è il regista della Grande Tristezza? Gianni Alemanno? Il salotto dei suoi uomini manager? Massimo Carminati? Una capitale cresciuta a immagine e somiglianza di un boss non ha futuro se perfino il consiglio comunale da dodici anni se ne frega della qualità dei servizi. Nel frattempo chissà se l’ex sindaco indagato, la sua alleata Giorgia Meloni e quelli di Casa Pound avranno l’onestà di tornare in piazza: «Porteremo il tema della sicurezza in Assemblea capitolina», ha scritto Alemanno sul suo blog il 17 novembre. Ora che è evidente quanto la mafia sia salita in alto, ha ragione: Roma non è mai stata così insicura.
Vigili: gag, disavventure e scandali. I retroscena dello scontro con Marino. I vigili romani sono il doppio dei milanesi e fanno un terzo delle multe. L’intervento di Cantone, scrive Sergio Rizzo su “Il Corriere della Sera”. Scherzi del destino. Per aver osato scrivere che dei vigili urbani a Roma si nota soprattutto l’assenza, il giornalista del Corriere Maurizio Fortuna è stato querelato da ventotto di loro. Pochi giorni dopo il recapito della citazione, ecco la notizia che la sera di San Silvestro l’83,5% degli agenti in servizio era scomparso. Chi si dava malato, chi donava il sangue, chi stava con la mamma inferma... Questa «diserzione di massa», per dirla con il comandante Raffaele Clemente, è l’ennesimo episodio della guerra dichiarata a Ignazio Marino. Certo non per la bacchettata a un agente troppo galante con una bella automobilista senza patente, come quella appioppata nel film «Il vigile» al pizzardone motociclista Otello Celletti, alias Alberto Sordi, dal sindaco Vittorio De Sica: prontamente ricambiato con una multa per eccesso di velocità. Qui il conflitto è di ben altre proporzioni. E c’è da augurarsi che non vada a finire allo stesso modo, con la macchina del sindaco nella scarpata e il vigile che lo scorta all’ospedale. Il culmine dello scontro, a novembre: quando Marino e Clemente hanno deciso la rotazione degli incarichi. L’iniziativa, senza precedenti, ha scatenato una rivolta. Capitolo chiuso con l’Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone che ha definito la rotazione non solo «legittima», ma «un meccanismo a tutela delle persone per bene». Però gli animi non si sono placati affatto. Il rapporto fra i vigili e Marino è sempre stato turbolento. Un mese dopo il suo insediamento il loro capo Carlo Buttarelli, messo lì da Gianni Alemanno, se n’è andato sbattendo la porta. Al suo posto è stato chiamato un colonnello dei carabinieri selezionato con procedura pubblica. Nonostante tre lauree, però, Oreste Liporace non aveva tutti i requisiti previsti e ha dovuto gettare la spugna. Allora è arrivato un poliziotto della squadra anticrimine della Questura di Roma: Clemente, appunto. Senza provocare, anche in questo caso, manifestazioni di giubilo da parte di quanti hanno interpretato tale nomina, al pari di quella tentata in precedenza, come un gesto di aperta sfiducia verso la polizia municipale. Il cui capo proveniva di regola dai ranghi interni. Anche se poi non sempre tutto filava liscio. Dicono tutto le disavventure del predecessore di Buttarelli, il comandante dei vigili urbani Angelo Giuliani incaricato di sostituire quel Giovanni Catanzaro pizzicato dal Messaggero a parcheggiare la sua Alfa Romeo in una zona off-limits vicino a piazza di Spagna: sul cruscotto un permesso per disabili. Rimosso da Walter Veltroni, Catanzaro sfiora nel 2008 la candidatura al consiglio comunale con l’Udc. Dieci mesi fa Giuliani viene arrestato con l’accusa di corruzione. Dicono i giudici che prendeva tangenti dalla società incaricata di ripulire l’asfalto dopo gli incidenti stradali. Lui si proclama estraneo: «Sono sempre stato ligio ai miei doveri». Mesi prima, un’altra disavventura. Lo scenario, questa volta, un concorso per 300 aspiranti vigili. Giuliani presiede la commissione d’esame quando parte un’inchiesta della Procura di Roma nella quale si ipotizza il reato di falso ideologico. Alemanno revoca tutti e comincia un autentico Calvario. Da allora si sono alternate ben tre commissioni ma i risultati del concorso, bandito ormai cinque anni fa, non ci sono ancora. Le indagini che riguardano Giuliani, invece, si stanno per chiudere. Nemmeno il rapporto degli ispettori inviati dal Tesoro a verificare i conti della capitale è tenero nei giudizi. Sostiene per esempio che dal 2010 al 2013 siano state erogate ai vigili indennità di responsabilità per quasi 23 milioni in eccesso rispetto ai livelli considerati legittimi. Segnalando anche una serie di anomalie come la maggiorazione notturna concessa per le fasce orarie 16-23 e 17-24, nonostante i contratti nazionali la prevedano solo dalle 22 alle 6 del mattino. A Roma i vigili sono potentissimi: addirittura più del sindaco, si è sempre detto. Se ne contano 6.077. Tuttavia ce ne sono costantemente in giro per la città che ha il più alto numero al mondo di auto (oltre 70 ogni cento abitanti) da un minimo di 105, la sera, a un massimo di 993, la mattina. Ovvero, dall’1,7 al 16,3% della forza complessiva. Il tutto fra strade disseminate di vetture in seconda fila e mai una contravvenzione sotto il tergicristallo, neppure davanti a un comando della polizia municipale. E la produttività? Spiega molte cose il confronto con Milano contenuto nello studio Sose-Ifel sui costi standard. Mentre Roma spendeva per gli stipendi dei vigili il 14,5% più del «fabbisogno standard», Milano risparmiava il 38,3%. Con 154 multe mediamente a testa fatte a Roma contro le 370 di Milano. E le 27.990 sanzioni di altro genere elevate dai seimila vigili romani contro le 79.870 dei poco più di tremila loro colleghi milanesi. Talvolta, dobbiamo riconoscerlo, le condizioni non sono facili. Come capita a chi deve misurarsi con un infernale caos di lamiere: ricorrendo a gesti e movenze tanto eleganti da affascinare perfino Woody Allen. Che nel suo film «To Rome with love» ha immortalato la scena del bravissimo vigile Pierluigi Marchionne sulla pedana di piazza Venezia mentre dirige il traffico, nemmeno fosse un direttore d’orchestra. Proprio lì, dove una volta il giorno della Befana si portavano regali ai pizzardoni in segno di riconoscenza. Altri tempi...
In un giorno 393 assunzioni. Quel rapporto del Tesoro su Roma. Dal 2000 al 2012, quasi 95 mila aumenti. Solo tra il 2008 e il 2012 sono stati impegnati per il salario accessorio dei dipendenti comunali 340 milioni di euro, scrive Sergio Rizzo su “Il Corriere della Sera”. Davvero un mercoledì da leoni, quel 25 novembre del 2009, per 393 vigili urbani con contratto a termine. Nel giro di una mattinata presentavano domanda di assunzione a tempo indeterminato, l’ufficio del personale verificava simultaneamente il possesso dei requisiti e il Comune di Roma sfornava istantaneamente il provvedimento di stabilizzazione. Firmato: Mauro Cutrufo, senatore del Pdl e vicesindaco. Peccato che la rapidità da salto nell’iperspazio di questa apparentemente complessa procedura faccia a pugni con quanto affermato nell’ormai arcinoto rapporto degli ispettori del Tesoro sui conti della Capitale. Cioè che in base alle norme allora vigenti quelle stabilizzazioni erano illegittime. Giudizio estendibile a tutte le 2.781 pratiche del genere, di cui ben 500 relative ai vigili urbani, concluse fra il 2007 e il 2010. Che nella gestione del personale il Comune di Roma non rappresentasse il top del rigore, era risaputo. Ma lo scenario delineato in quel rapporto, soprattutto per gli anni che hanno preceduto l’attuale amministrazione, va oltre ogni immaginazione. E ben si comprende il sindaco Ignazio Marino, che descrive l’inqualificabile diserzione dei vigili la sera di San Silvestro come «una ritorsione» per aver lui voluto cambiare certe regole inconcepibili, quali per esempio quelle che garantiscono una valanga di indennità: le più assurde. Perché a toccarle, tutti i 26 mila dipendenti del Comune, tanti quanti i lavoratori della Fiat in Italia, ci rimetterebbero qualcosa. A cominciare da quel salario accessorio che dovrebbe essere collegato a mansioni specifiche ed è sempre stato invece distribuito a chiunque senza particolari motivi. Una pioggerellina fitta e incessante che ha innaffiato tutti dal 2008 al 2012 con oltre 340 milioni di euro. Del resto, che il merito sia sempre stato una variabile ininfluente nel folle panorama retributivo del Comune di Roma lo dimostra una nota del Dipartimento risorse umane del dicembre 2011, nella quale si precisa che per non intascare il compenso di produttività bisogna «aver riportato una valutazione inferiore a 66 punti» e «aver lavorato un numero di giornate inferiore a 110». Cioè, essersi presentati sul posto di lavoro meno della metà del tempo stabilito per contratto. Regole, dunque, che giustificano l’assenteismo e il lassismo. Tanto più, notano gli ispettori, che non è prevista alcuna differenza nella somma corrisposta a chi viene valutato 66 e chi invece prende 100. Ma chi bada mai a una simile inezia, quando la pioggerellina è studiata apposta per bagnare indistintamente ognuno? Prendete le «progressioni orizzontali», termine che definisce i semplici aumenti di stipendio. Dal 2000 al 2012 sono state distribuite ben 5 volte, per un totale di 94.994 gratifiche: effetto di 94.994 valutazioni positive sul rendimento individuale. Quelle negative, 15. E sarebbe interessante sapere che cosa avevano combinato per meritarsele. Sputato in faccia al direttore? Mai andati a lavorare? Rubato? Spesa complessiva, 245,8 milioni fra il 2008 e il 2012. Alla quale si deve sommare quella per un’altra pioggerellina altrettanto stupefacente e copiosa per il capitolo delle indennità. Spesso e prelibato come un millefoglie. Indennità legata all’effettiva presenza in servizio, ovvero una somma erogata in più oltre allo stipendio per il semplice fatto di andare a lavorare. Indennità manutenzione uniforme. Indennità per l’attività di sportello al pubblico. Indennità oraria pomeridiana. Indennità annonaria. Indennità decoro urbano. Indennità di disagio: anche se non si capisce, sottolinea il rapporto, di quale disagio si tratti. E le promozioni, usate esclusivamente «per aumentare la retribuzione ordinariamente corrisposta ai dipendenti». Una slavina, a dire degli ispettori, non proprio legittima: 2.721, nei soli anni 2010 e 2011. E le assunzioni a tempo determinato fatte «intuitu personae» anche quando non riguardavano solo lo staff di fiducia dei politici. E le retribuzioni accessorie dei dirigenti, andate in orbita fra il 2001 e il 2012 passando in media da 45.640 a 88.707 euro l’anno procapite con una impennata del 94,3%. Premiando, per giunta, pure chi avrebbe dovuto essere sanzionato: «Non risulta», sostiene il rapporto, «che a nessun dirigente sia stata negata l’erogazione della retribuzione di risultato». Qualche papavero comunale, poi, prendeva pure compensi dalle società municipalizzate che si andavano ad aggiungere a uno stipendio già non particolarmente modesto. Il che prefigura, dicono gli ispettori, la violazione del principio «di onnicomprensività della retribuzione». Un caso? Il rapporto cita la partecipazione alla Commissione di accordo bonario di Roma metropolitane, la società incaricata di tenere i rapporti con il general contractor della Metro C, del capo dell’Avvocatura comunale Andrea Manganelli. Il quale «nel solo 2013 avrebbe percepito la somma di 53.614 euro e 14 centesimi», anche se «la natura di società in house di Roma metropolitane», stigmatizza il documento del Tesoro, «non sembrerebbe consentire la corresponsione di simili compensi». Fatti singolari. Come «singolare» viene giudicato l’aumento di 1,7 milioni del fondo per gli incentivi economici dei dirigenti, per di più «proprio nell’anno, il 2008, in cui lo Stato si è accollato il debito del Comune di Roma». Una goccia nel mare, in grado però di spiegare molte cose. Per esempio, come sia stato possibile che nel 2012 la spesa corrente di Roma capitale fosse superiore «di circa 900 milioni», per gli ispettori, a quella del 2007. Mentre sull’efficienza delle strutture comunali e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, per carità di Patria, forse è meglio sorvolare.
I «pizzardoni» romani: assenteisti, scansafatiche e pure saccenti. La Capitale è tornata al vigile approfittatore in stile Alberto Sordi, scrive Aldo Grasso su “Il Corriere della Sera”. «Ahò, signori onorevoli assessori della giunta comunale! Ahò, signori industriali! Ahò, signor sindaco! Io qui faccio crollare il governo!». In un batter d’occhio, il pizzardone Otello Celletti (l’Alberto Sordi de Il vigile di Luigi Zampa, 1960) è diventato il simbolo della notte degli assenteisti, dei vigili romani che a Capodanno hanno marcato visita. Celletti, impettito nella sua divisa da vigile motociclista, è uno e trino. Scansafatiche mammone, un approfittatore che dispensa giudizi a destra e a manca: «Er pennello deve passà prima orizzontale e poi verticale, sennò ce lasci ‘a striscia...». Non appena indossa la divisa, da raccomandato, diventa un fustigatore di costumi, persino nei confronti delle autorità. Ha un solo cedimento verso Sylva Koscina. Alla fine (terza identità), impara con chi essere severo e con chi no. La vicenda degli assenteisti finirà forse nel nulla, all’indignazione seguirà la rassegnazione. È la Roma statale e parastatale, con i suoi privilegi quasi intoccabili, difesi dalla compiacenza dei sindaci e dalla complicità dei sindacati. È la «Roma di mezzo», la Roma della mezza-porzione, la Roma dove persino la criminalità organizzata pare cialtrona e millantatrice. È Roma-Italia mezza «ladrona». Otello non farà crollare nessuno. Dovrà solo decidersi, «tra una guera e n’antra, de fà quarcosa ». Anche solo assentarsi dal lavoro.
La bandiera del certificato, scrive Francesco Merlo su “La Repubblica”. Al Sindaco De Blasio, che è il loro capo, i poliziotti di New York hanno mostrato le terga. Al sindaco Marino, che è il loro capo, i vigili di Roma hanno mostrato il certificato. Esporre mille terga, per quanto possa apparire paradossale, significa metterci la faccia. Procurarsi mille certificati falsi significa al contrario nascondere la faccia, imbrogliare e degradarsi. Da un lato c'è il coraggio sfrontato della ribellione, fosse pure per ragioni non condivisibili, dall'altro lato c'è la viltà stracciona, fosse pure per ragioni condivisibili. Qui poi non c'è neppure l'assenteismo dei fannulloni, non c'è l'accidia del travet che Brunetta perseguitava come il pelandrone assistito. Questi sono i ceffi di Stato che usano la truffa del certificato-patacca come lotta sindacale, sino all'odioso ricorso, per disertare, alla donazione del sangue e, peggio, all'assistenza retribuita dei familiari disabili (legge 104), atti generosi ridotti a trucchi pelosi, norme di civiltà usate come forconi, la libbra di carne di Shylock il mercante di Shakespeare. E la regia sindacale, che a New York rimanda alla ribellione ostentata dei simboli e mai all'insubordinazione agli ordini, a Roma rimanda al reato associativo che è molto alla moda nella capitale come ha denunziato anche il Capo dello Stato nel messaggio di fine anno. Ed è drammatico che a questo reato di falso, commesso insieme ai medici di famiglia, concorrano tutti i sindacati, per una volta uniti nella difesa della malattia simulata e spacciata per diritto alla protesta. Siamo ben al di là delle già ridicole indennità, da quella per tenere pulita e in ordine la divisa a quella per il servizio in strada (e dove, se no?), sino alla bizzarria poetica della "seminotte", l'invenzione più creativa del contratto integrativo dei vigili, con inizio (non è uno scherzo) alla 15,48 che è, come dire, due minuti prima delle quattro meno dieci, un orario che evoca il binario 9¾ della stazione di Harry Potter dove si respirava corno di bicorno in polvere e tritato di unghie di cavallo. È un pentagramma di comicità corporativa che sicuramente sta facendo schiattare di invidia gli orchestrali e i coristi dell'Opera di Roma che l'umidità retribuita la subiscono soltanto al calar del sole e non al suo semicalar. A New York, secondo il sindacato dei poliziotti, de Blasio ha offeso la dignità degli agenti perché ha consigliato al proprio figlio (Dante, di origine afro-italiana) di "stare attento alla polizia". A Roma, secondo il sindacato della polizia municipale, Ignazio Marino e il comandante Raffaele Clemente, da lui nominato, hanno offeso la dignità dei vigili perché li hanno obbligati alla rotazione nei quartieri trasformandoli così in presunti corrotti, senza più distinzione tra onesti e disonesti. Ma cosa c'è di più disonesto di 835 certificati falsi? E come può un vigile restare legittimato come controllore delle regole se è il primo che le viola, e per di più in questo modo così meschino e cacasotto? Chi sceglie la ribellione deve pagarne il prezzo e non rifugiarsi nella miseria del certificatuzzo del dottorino di famiglia connivente e correo. E non sto parlando della ribellione del pugno chiuso alla Tommie Smith alle Olimpiadi del 1968, ma soltanto di chi fa sciopero sapendo che perderà il salario. Chi si ammala invece lo conserva. E addirittura lo ruba chi fa finta di ammalarsi. E va bene che la medicina è una scienza incerta, duttile e spaziosa, ma la flogosi che subisce l'influsso sindacale, l'agente patogeno che si scatena in un intero Corpo, imprevedibile, imprendibile e inqualificabile come un pirata della strada, è una deriva triste dell'Italia del certificato, quella della visita fiscale che non sgama più nessuno, e non solo perché avviene in fasce orarie governabili dal finto malato ma anche perché costa troppo alle strematissime amministrazioni. Punito con pene irrisorie, quasi sempre con la multa, e in attesa di depenalizzazione, il falso certificato medico chiama, suscita e raduna tutti i fantasmi dell'Italia rancida dell'inguacchio, del disertore vile, del pavido che si rintana in un letto. Ma attenti a riderne e a evocare il solito Alberto Sordi e la commedia all'italiana, il paese degli assenteisti, dei sempre stanchi, degli sfaticati, del "dottore è fuori stanza", della pubblica amministrazione che tutti vorrebbero giustamente riformare e qualcuno sogna di punire. La verità è che, morta ormai la faccia bonaria di Roma e persino della piccola corruzione tollerata, anche il poliziotto municipale si rivela più fellone dell'ultimo degli automobilisti che supera la fila invadendo la corsia d'emergenza. E il trucco della malattia non è più la risorsa dello studente pelandrone che, per marinare la scuola, alza il mercurio al caldo di un termosifone, o della recluta che si infilava il mezzo toscano sotto l'ascella, o ancora del coscritto che si infliggeva ferite di ogni genere sino al taglio di un dito e alla simulazione della pazzia. Qui è persino più deludente del Badoglio di Tutti a casa il sindacato che mette il falso certificato al posto del riscatto sociale di Di Vittorio e della concertazione di Luciano Lama. C'è anche, nell'epidemia di finti malati, l'ennesima prova dell'inutilità dell'Ordine dei medici che non è intervenuto, non ha represso, non ha intimidito, non ha sospeso, e non ha neppure aperto un'indagine. Tutti ci aspettiamo che Marino licenzi, che il comandate Clemente punisca, che la magistratura metta sotto accusa e nessuno si domanda cosa pensano dei certificati bugiardi i presidenti dell'Ordine di Roma, Roberto Lala, e dell'Ordine nazionale, Amedeo Bianco, anche loro assenti ingiustificati in uno scandalo che dissolve nella nostalgia pure i versi di Gianni Rodari: "Chi è più forte del vigile urbano? / Ferma i tram con una mano. / Con un dito, calmo e sereno, /tiene indietro un autotreno: / cento motori scalpitanti / li mette a cuccia alzando i guanti. / Sempre in croce in mezzo al baccano: / chi è più paziente del vigile urbano?".
Vigliacchi di Stato. I complici sono i sindacati che li proteggono e il governo che ha salvato i dipendenti pubblici dal jobs act, scrive Alessandro Sallusti su “Il Giornale”. Penso a un amico imprenditore che un anno fa ha dovuto chiudere l'azienda e oggi lotta contro una depressione che non gli dà tregua. Penso ai cassintegrati che dopo aver perso il lavoro stanno perdendo anche la speranza di ritrovarlo. E, senza andare lontano, penso ai tanti colleghi rimasti a casa per i tagli nell'editoria che vagano per le redazioni superstiti a caccia di una collaborazione, anche sottopagata. E poi penso ai vigili urbani di Roma che la notte del 31 si sono dati in massa malati per festeggiare in famiglia o perché arrabbiati con il sindaco Marino in quanto «pagati male». Penso queste cose e provo rabbia e vergogna. Comodo non lavorare avendo garantito a vita il posto di lavoro. Facile protestare per avere più soldi sapendo che comunque vada non perderai un centesimo. Da vigliacchi è poi farlo mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini in una notte cruciale per la sicurezza. Manifestato tutto il disprezzo possibile per questi incoscienti, è ora di smascherare i protettori degli statali fannulloni e furbetti. I sindacati, ovviamente, complici dello sfascio strutturale e morale del pubblico impiego. Ma anche una certa politica che non ha mai avuto il coraggio di mettere in riga gli oltre tre milioni di italiani con il posto di lavoro garantito a vita. Parliamo di un esercito di elettori che fa paura anche a Matteo Renzi. Il quale ieri si è detto indignato per i fatti di Roma e ha annunciato misure severe. E pensare che solo pochi giorni fa ha graziato gli statali stralciando di suo pugno la loro posizione dalla nuova legge sul lavoro che prevede il licenziamento in tronco per fannulloni, imbroglioni e incapaci. Senza quell'intervento salvifico, oggi si potrebbero cacciare i vigili di Roma che si sono inventati malattie inesistenti. Questi signori a Renzi devono fargli un monumento, ma se fossi nei panni del premier non ne andrei fiero. A fare il duro con i lavoratori dipendenti, le partite Iva e gli artigiani per poi calare le brache con una massa di privilegiati non si va lontano. E se poi quei privilegiati vestono pure una divisa, l'indignazione per noi comuni mortali è ancora più forte. Nei loro confronti e verso il malato vero, che è chi ci sta governando in questo modo assurdo.
Vittorio Feltri parla dei vigili assenteisti, scrive “Libero Quotidiano”. Nel suo editoriale Il Giornale, prende spunto dalla vicenda di Roma per spiegare come la colpa di tale lassismo sia dei vigili solo a metà e spiega come a partire dagli anni Settanta "il sindacalismo sfrenato prese il sopravvento sul senso del dovere". Parla, anzi scrive, con cognizione di causa perché racconta di quando lui stesso, poco più che ventenne, fu assunto in un'amministrazione provinciale. Era stato assunto come impiegato. Guadagnava 100mila lire al mese "in un'epoca in cui con 500mila compravi un'utilitaria". Ricorda come tutti si dessero da fare, forse perchè controllati ma lui invece non riusciva a stare seduto alla scrivania per più di dieci minuti. "Benché fossi pigro e svogliato non fui cacciato. Ero intoccabile come tutti i colleghi. I quali tuttavia non mi somigliavano, alcuni erano fulmini di guerra e coprivano le mie manchevolezze con santa rassegnazione giudicandomi probabilmente inabile". Feltri ricorda l'attivismo, la voglia di fare che regnava negli uffici, il rispetto che avevano verso il cittadino. E ammette: "Li guardavo mentre smantettavano sulla macchina meccanografica e pensavo: questi sono scemi, chi glielo fa fare di ammazzarsi di lavoro? In realtà lo scemo ero io. Tant'è che nel giro di due o tre anni mi trasferirono di qua e di là nel tentativo di trovarmi una collocazione giusta affinché rendessi quanto gli altri. Alla fine andai in cerca di fortuna e mi è andato di lusso".
Tutti uniti, anche Cantone: «Linciamo i vigili, sono fannulloni!», scrive Piero Sansonetti su “Il Garantista”. Ogni tanto l’Italia, che è un paese diviso – su tutti i piani – trova dei punti in comune e si unisce. Si riscopre, come dire?, Nazione. Da un po’ di tempo il nemico comune era il ceto politico, ribattezzato ”La Casta” dai giornalisti. I giornalisti hanno la specialità di trovarsi sempre alla testa di questi rari fenomeni di riunificazione nazionale. Ora però sembra che l’odio contro i politici non sia più sufficiente. Perché è diventato troppo universale, troppo scontato. Ormai persino i politici hanno accettato l’idea che il male dell’Italia siano i politici, e dunque diventa persino inutile bastonarli. E’ sufficiente che essi riconoscano la superiorità morale e il dritto al comando della magistratura ( e degli stessi giornalisti), cosa che fanno, di buon grado, quasi tutti. Allora occorre trovare un nemico nuovo, che sia davvero il simbolo dei mali dell’Italia, della sua stoltezza, dell’infigardaggine, dei privilegi. In queste feste natalizie si è trovato il nemico nella figura del ”vigile urbano di Roma”. Bersaglio perfetto. Ha due caratteristiche che difficilmente si trovano nella stessa persona: è ”antipatico” al popolo, perché fa le multe. E al tempo stesso é popolo. Il vigile è un lavoratore, che sgobba e ha uno stipendio piccolino. E dunque può perfettamente diventare il simbolo del male, con una specie di ”transfert”, che serve a linciare un personaggio ”antipatico” e indicare contemporaneamente nel ”lavoratore” il colpevole dei mali della nostra economia. E dunque sul vigile urbano, sull’odio per lui e per il suo essere fannullone, può benissimo unificarsi la rabbia popolare, sollevata dai giornalisti, e l’intransigenza del potere, dell’establishment, che ha bisogno assoluto di ”criminalizzare” una figura tipica di lavoratore per affermare, nel senso comune, che il problema dell’Italia sta nella scarsa produttività e nei costi eccessivi del lavoro. Cosa è successo a Roma nella notte di Capodano? Niente di grave, sembrerebbe, perché non pare che ci siano stati seri inconvenienti nella gestione del traffico. Però si è scoperto che una gran quantità di vigili urbani che avrebbe dovuto essere in servizio, o reperibile, aveva presentato certificato medico per starsene a casa. Intendiamoci bene: questi vigili non si sono sottratti al normale orario di lavoro, ma semplicemente allo straordinario. Per svariate ragioni, tra le quali la loro contestazione a una serie di norme varate recentemente dal comando dei vigili, che riguardano proprio la regolamentazione dello straordinario. La massiccia astensione dal lavoro è un atto che sta a metà tra la scelta personale e la protesta. Naturalmente si può dire: ma l’assenteismo non è una forma di protesta, le proteste devono svolgersi dentro le regole stabilite dalla legge e organizzate dai sindacati. Forse però, se si dice così, non si capisce che la crisi, la recessione, e in parallelo la morte dei partiti politici e l’epocale indebolimento dei sindacati, rendono inevitabile il nascere di forme di ribellione nuove, e anche fantasiose. E’ assurdo considerare l’assenteismo contro gli straordinari un semplice atto di vigliaccheria e di irresponsabilità: è in modo limpido un atto di lotta. Poi ciascuno è autorizzato a dire che è una lotta sbagliata, che i metodi sono illegittimi, che questi fenomeni vanno fronteggiati e vinti – così come tante volte si dicono queste cose anche delle più legalitarie battaglie dei sindacati – però bisognerà capire che i ”ribelli” non resteranno fermi ad aspettare gli schiaffoni e rimbrotti del potere, si muoveranno, cercheranno di resistere, di spuntarla. Il conflitto, lo scontro sociale, non è solo una affermazione teorica: è esattamente questa roba qui, questi atti di indisciplina di massa. Il problema vero è la debolezza oggettiva dei ”ribelli”. Sono isolati in modo totale. Persino la Cgil ha paura di difenderli, intimidita, impaurita dalla furia della ”politica per bene” – di destra o di sinistra, leghista o grillista – e dei grandi giornali. Non c’è una sola voce che si leva in loro difesa. Nessuno che avanza un dubbio sulla necessità di linciarli, di preparare subito delle leggi speciali contro di loro, magari – chessò – di dare anche a loro il 416 bis (associazione mafiosa…)!. Non lo dico solo per scherzo: mi ha colpito il fatto che contro i vigili, in questa crociata anti-lavoratori, si è gettato a capofitto anche Cantone, il mitico commissario anticorruzione voluto da Renzi e applaudito dai magistrati. Che cavolo c’entra Cantone con l’astensione dal lavoro dei vigili urbani? C’entra, c’entra, perché il cerchio deve chiudersi: lotta alla corruzione, lotta ai lavoratori, lotta all’articolo 18, potere ai ”giusti”, ai giudici, ai giornalisti, ai saggi, a i tecnocrati, agli imprenditori, agli eletti…Sapete come dicevano i greci? Agli ”aristos”.
E su di questo passo. E poi il paradosso. «Quella bambina di 14 anni è un capomafia», scrive Francesco Altomonte su “Il Garantista”. Mancano sei mesi al compimento dei suoi 17 anni, ma leggendo i capi di imputazione riportati nell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari sembra di avere a che fare con un boss di lunga data, di un criminale incallito che ha dedicato la sua vita a “mamma ‘ndrangheta”. Lei (sì, stiamo parlando di una ragazzina), figlia di uno dei personaggi di primo piano della potente cosca Gallico di Palmi, nel Reggino, risulta ancora incensurata, benché la procura dei minorenni di Reggio Calabria l’accusi non solo di associazione mafiosa, ma anche di essere un capo promotore del clan (armato) di riferimento dei suoi genitori. Il primo pensiero che passa nella mente del cronista (o perlomeno dovrebbe passare) è: ma un ragazzina che all’epoca dei fatti non aveva compiuto 14 anni, è imputabile? La risposta è, anzi dovrebbe essere no, ma la data posta in calce al documento che decreta la fine delle indagini preliminari dissiperebbe i dubbi: «Accertato in Palmi e territori limitrofi in epoca successiva al 12.05.2011». Nel giugno di quell’anno (il 2011), infatti, la ragazzina avrebbe compiuto 14 anni, quindi poteva essere perseguita per il delitto associativo. Alcuni fatti che le vengono contestati, infatti, risulterebbero compiuti nei mesi successivi. Da qui, la possibilità da parte della procura dei minori di poterla accusare di associazione mafiosa. La ragazza, che dall’inizio del 2014 è ospite di una famiglia nel nord Italia, entra in una delle tante inchieste che hanno permesso di decapitare il clan Gallico, in particolare quella in cui viene colpita una presunta rete di fiancheggiatori della cosca dedita alle estorsioni. Suo padre e sua madre sono in carcere, lei vive in casa con dei partenti. Gli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Palmi, che stanno conducendo le indagini, hanno piazzato delle microspie in quella casa e a metà del 2011 intercettano una conversazione nella quale alcuni indagati parlano di soldi e di qualcosa nascosto all’interno di quella abitazione. Tra i partecipanti alla discussione c’è anche l’allora tredicenne. La ragazza dopo alcuni minuti lascia la casa insieme a una donna finita in carcere alla fine del 2011, Loredana Rao, salendo in auto con lei. Gli investigatori, per capire dove e cosa trasportassero nell’autovettura, piazzano un posto di blocco appena fuori la città. Le due donne pochi minuti dopo intravedono la volante della polizia, fermano la macchina e fanno marcia indietro. Quella è la prova per i poliziotti che qualcosa non quadra. Partono all’inseguimento e bloccano non solo la macchina nella quale viaggiavano la Rao e la ragazzina, ma anche un’altra autovettura con a bordo alcuni uomini della famiglia. La mossa conseguente è il trasferimento di tutti in commissariato per la perquisizione. Per evitare fughe o altri problemi, due poliziotti salgono a bordo delle due macchine. Un agente, si legge nell’informativa redatta dagli uomini della Mobile, durante il tragitto nota che la ragazzina cercava di sistemare qualcosa che aveva nascosto all’altezza dell’inguine. Appena giunti in commissariato chiedono se vogliono essere assistiti da un legale, soprattutto lei che ancora non ha compiuto 14 anni, ma tutti declinano l’invito. La ragazza, però, non si fa neanche perquisire perché spontaneamente consegna alla poliziotta un foglietto contenuto all’interno dello slip. Si scoprirà nel novembre 2011 di cosa si tratta, quando la procura antimafia di Reggio Calabria emette un decreto di fermo con il quale finisce in carcere l’intera rete di presunti estortori. Si trattava di un foglio di calendario sul quale erano state annotate date e cifre. Per gli inquirenti quei dati parlano chiaro: sono appunti per la riscossione del pizzo imposto dal clan Gallico agli imprenditori e commercianti della città. Alcuni di loro, per inciso, collaboreranno alle indagini confermando quanto ricostruito dalle forze dell’ordine. All’interno di un’altra informativa, la ragazzina viene intercettata con il fratello. Per gli inquirenti il parente le starebbe impartendo degli ordini per andare a ritirare delle estorsioni, o per intimarne in pagamento. Siamo nel 2012 e, quindi, per la legge italiana la 14enne è perseguibile e può essere incriminata. L’equazione sembrerebbe questa: siccome tutti i suoi parenti e membri del clan sono dietro le sbarre, dai mammasantissima fino ai fiancheggiatori, l’allora 14enne svolgerebbe il compito di “reggente” della cosca, anello di congiunzione con i detenuti e figura “visibile” della famiglia sul territorio. La ragazzina, intanto, dopo l’arresto di tutti i suoi parenti, compreso suo fratello ancora minorenne, viene data in affidamento a una famiglia del nord Italia dalla quale la giovane, secondo quanto appreso, fugge con regolarità per ritornare a casa. Con altrettanta regolarità viene ripresa e riportata indietro. Secondo quanto saputo nella giornata di ieri, pare che solo ad agosto scorso, il Tribunale dei minori le abbia concesso la possibilità di visitare suo padre in carcere.
De Cataldo: "Giustizia, un'utopia da difendere". E' un’aspirazione che spesso non si realizza, ma bisogna continuare a lottare per vederla trionfare. Anche se la crisi economica ha inciso profondamente sui diritti e rimesso in discussione molte conquiste sociali. Il commento dello scrittore, scrive Giancarlo De Cataldo su “L’Espresso”. “Processo e giudizio sono atti senza scopo, i soli atti della vita che non hanno uno scopo”. La citazione non appartiene a un nichilista dell’Ottocento, ma al grande giurista Salvatore Satta. Intende, Satta, che il processo è un mistero. Come la vita, aggiunge: il mistero del processo, il mistero della vita. Sublime astrattezza di un Maestro: ma realmente la giustizia è, o può essere considerata, un mistero? Nella percezione di grandi artisti e narratori sembrano prevalere altri sentimenti. Prendiamo il giudice Briglialoca, immortalato cinque secoli fa da François Rabelais. Per decidere le cause che gli sono affidate, questo onesto e stimato magistrato si affida al lancio dei dadi. Vince colui «che per primo arriva al numero di punti richiesto dalla sorte giudiziaria, tribuniana, pretoriale». Però, almeno una volta, Briglialoca sbaglia, e scrive una sentenza “ingiusta”. E finisce sotto processo. Assolvetemi, invoca l’anziano e stimato giudice, se ho sbagliato è stato per colpa della vecchiaia: la vista è debole, leggendo i dadi ho preso un “4” per un “5”. Nell’episodio del processo a Briglialoca, il genio ribaldo di François Rabelais coglieva il senso di sbigottito sgomento che, al suo tempo, segnava il rapporto fra l’esercizio della giustizia e la sua percezione diffusa. La giustizia. Una partita che si gioca fra misticismo e gnosi. Una tenebrosa palude avvolta dalle nebbie di un linguaggio iniziatico, un viaggio interminabile nelle lungaggini di un formalismo astruso. E, alla fine, l’inganno di un lanciatore di dadi, per giunta dalla vista debole. Come se la dea della bilancia e della spada del mito fosse destinata a trasformarsi, ironicamente, nell’altra sua sorella, la Fortuna dagli occhi bendati che premia o punisce a caso. Sentimento di ingiustizia, indignazione venata di umorismo per le alchimie dei chierici e sarcasmo per l’uso “casuale” della legge. Questo troviamo in Rabelais: razionalità, più che mistero. E l’elogio della durata del processo che fa Briglialoca non si comprende se non si ricorda che, per antica prassi, ai giudici si donavano “sportule”, cioè bustarelle, tanto più ricche quanto più sottili erano le questioni da affrontare: come dire, più la tiri per le lunghe, e più guadagni. Nei secoli a venire, molti altri grandi spiriti ci hanno fornito rappresentazioni ironiche, amare, disperate, ilari della giustizia. Si pensi all’Azzeccagarbugli che tramortisce il povero Renzo a colpi di latinorum; al giudice di Collodi che condanna Pinocchio proprio perché innocente; al corrotto ubriacone Azdak che nel “Cerchio di gesso del Caucaso” di Bertolt Brecht fa la scelta giusta perché risponde alla morale della strada infischiandosene del diritto; al cupo guardiano delle leggi del “Processo” kafkiano; agli eroi dei romanzi di John Grisham alle prese con le storture, spesso atroci, del sistema giudiziario dell’Impero Americano. La giustizia, in tutte queste narrazioni, o non è definita affatto, o lo è in negativo. Ciò che affiora, accanto allo sbigottimento e alla critica, è qualcosa di molto diverso dal mistero. È la tensione verso un oggetto indefinibile: sappiamo confusamente ciò che è giustizia, ma non vediamo mai attuato questo nostro ideale. Tutto ciò si può definire aspirazione. Un’aspirazione che, a guardare alla Storia, fende realmente i secoli e i millenni come la spada fiammeggiante delle antiche icone. Se per Satta il giudizio finale, l’unico che abbia veramente un senso, è rimesso all’Uno che non ha bisogno di punire, perché gli basta giudicare, l’uomo pratico coglie, nella rappresentazione degli artisti, la dialettica continua fra la tensione verso il giusto e i limiti della Storia. E solo trascinata nell’aula della Storia la giustizia accantona l’alone metafisico del mistero per farsi esperienza concreta, vicenda dialettica, dialogo continuo fra luce e oscurità. Nel nome di ciò che è giusto donne e uomini, in tutte le terre conosciute, hanno conosciuto l’ostracismo, la repressione, il martirio. E giusto, peraltro, non necessariamente coincide con legale. Il codice di Hammurabi legittimava il padrone a uccidere il proprio schiavo e l’altrui: in questo caso, l’omicida se la cavava con una modesta multa. Le leggi razziali di Mussolini, inique e ingiuste, erano leggi, pertanto legali. Oggi la schiavitù è un crimine represso dalle convenzioni internazionali. E la nostra Costituzione vieta il razzismo. Ciò che all’antico re babilonese e al dittatore di Predappio appariva giusto e legale oggi è universalmente ritenuto ingiusto e illegale. Quando parliamo oggi di giustizia, dunque, parliamo, in termini storici, dell’ultimo segmento (in ordine di tempo) di un lunghissimo percorso costellato di lotte, contese, guerre e massacri. E in termini oggettivi siamo autorizzati a spendere la parola progresso. Poiché la maggior parte di noi, almeno nei paesi occidentali, vive in regimi democratici, sicuramente preferibili ai regni assolutistici dominati dall’arbitrio. Le Corti internazionali giudicano dei crimini contro l’umanità commessi da individui che, un tempo, furono condottieri e capi di Stato riveriti e acclamati: e anche questo, sino a pochi anni fa, sarebbe stato impensabile. Con il passare del tempo, l’aspirazione generica e indeterminata alla giustizia cresce e si fa sempre più concreta. Abbraccia la legittima pretesa di diritti che si vanno affermando sull’onda di un altro progresso, quello scientifico, e di un’accresciuta sensibilità sociale: il diritto alla salute, al lavoro, all’ambiente. Tuttavia, la stessa Storia che induce a un cauto ottimismo impone un diverso ordine di riflessioni. Le Corti internazionali non sono riconosciute da alcune grandi nazioni, che si rifiutano di aderirvi. E se operano è perché appena vent’anni fa, nel Mediterraneo, a poche miglia dalle nostre coste, nell’ex-Jugoslavia si perpetravano il genocidio e lo stupro etnico. La giustizia, per chi era internato in un campo “etnico” non poteva che essere un’aspirazione: e ancora oggi lo è per i tanti afroamericani che protestano contro le violenze poliziesche o per le donne soggiogate dai regimi sessuofobici, e di esempi se ne potrebbero citare a dozzine. Dopo l’11 settembre, come rivela l’agghiacciante rapporto del Senato statunitense, la prima democrazia al mondo ha praticato la tortura. La crisi economica che stiamo attraversando ha inciso profondamente sui diritti dei lavoratori. Molte delle conquiste sociali degli anni passati sono rimesse in discussione. Lo Statuto dei lavoratori è un ferrovecchio. Il sindacato un inutile orpello. Il welfare è sul banco degli imputati. Mentre l’aspirazione alla giustizia non cessa di crescere, si fa strada nella collettività un crescente senso di sfiducia e disaffezione verso le istituzioni. Gli elementi di ottimismo e di pessimismo si bilanciano, rianimando, sotto diverse spoglie, il costante e irrisolto rapporto dialettico fra la giustizia a cui si aspira e quella che si vede realizzata. È vero che dai tempi di Hammurabi molto è cambiato: ma se possiamo accettare di definire la giustizia come un’aspirazione, non possiamo parlarne in termini di conquista irreversibile. Non c’è niente di irreversibile in questa storia millenaria. La tensione fra lo schiavo e il padrone è il nodo centrale intorno al quale ruota la vicenda della giustizia come aspirazione. In questa corrente dialettica il progresso non può che stare dalla parte dello schiavo. O per meglio dire, delle molteplici maschere che lo schiavo assume nel corso del tempo: il combattente per la libertà di opinione, la donna violata, il profugo in fuga dalla guerra, la vittima della mafia, il minore abusato, il precario senza diritti, il condannato che espia la pena e cerca di reinserirsi. Un’aspirazione che dobbiamo tenerci ben stretta, e per la quale bisognerà ancora e ancora combattere.
Che volete che sia. Con questi italiani!
Palazzo, le sparate dei politici non fanno ferie. Dagli insulti di Gasparri alla crisi Pascale-Silvio. E la cagnolina della Biancofiore, i selfie di Renzi, le analisi economiche di Belen e il mutuo di Razzi. Tra panettoni e cotechino, i politici non hanno mancato di rilasciare dichiarazioni surreali anche sotto l'albero. Ecco le peggiori, scrive Wil Nonleggerlo su “L’Espresso”.
Michaela Biancofiore, onorevole di Forza Italia: "Non partirò mai per le festività natalizie senza la mia cagnolina, la carlina Puggy. Vive in simbiosi con me, ne soffrirebbe troppo" (19 dicembre 2014)
Matteo Renzi, ospite di Antonella Clerici e Bruno Vespa, nel salotto di “Un mondo da amare” (Raiuno): "È come se l’Italia non sapesse farsi i selfie..." (19 dicembre 2014)
Antonio Razzi, la vita grama del senatore berlusconiano (La Zanzara): "Ammé dello stipentio di parlamentare non me rimane niente. Non posso manco aiutare i miei due figli operai. Non è che ti restano in tasca 12mila euro al mese, ci sta da pagare la quota al partito, ci stanno da pagare i collaboratori, alla fine devi stare attento a non finire a mangiare sagne e facioli..." (19 dicembre 2014)
Silvio Berlusconi, su Twitter: "Tutti mi chiedono come sto. E come volete che stia? In libertà condizionata" (22 dicembre 2014)
Matteo Salvini, il grande quesito della Vigilia, su Facebook: "Amici, una curiosità: ma voi ci credete agli Oroscopi?" (24 dicembre 2014)
Barbara Mannucci, ex deputata Pdl, ora stregata da Matteo Salvini: "Salvini è la nostra ultima spiaggia. Che uomo coraggioso. Che energia. O ci salva lui, oppure non abbiamo speranza. Salvini è come Berlusconi nel '94 , è da allora che non sento tanto calore". (Nel 2011 diceva: "Berlusconi è la luce, resterò con lui fino alla fine. Sarò la sua Claretta Petacci") (20 dicembre 2014)
Andrea Orlando, ministro della Giustizia, intervistato da Libero: "Mi mancano pochi esami per laurearmi in Giurisprudenza. Interruppi gli studi per andare a lavorare..." 21 dicembre 2014)
Don Ferdinando, parroco di Villasanta, comune alle porte di Monza, durante la messa della Vigilia di Natale: "Babbo Natale è solo un ciccione ubriacone, inventato dalla Coca-Cola per simboleggiare il consumismo..." (24 dicembre 2014)
Il Mago Otelma, intervistato da Libero: "Simpatie grilline? Le nostre simpatie vanno a tutti coloro che difendono la libertà dei cittadini e tutelano la legalità democratica. Noi leggiamo nella mente del 'duce invitto' (Renzi) una smodata ambizione, una protervia lancinante, una ebbrezza superumana che bene riecheggia Zarathustra... La sua è stata abile propaganda, sapiente utilizzo dei media asserviti e ruffiani, disinvolto impiego di una retorica laurina..." (30 dicembre 2014)
Silvio Berlusconi, dal messaggio di auguri pubblicato sul proprio profilo Facebook: "… Il programma che noi metteremo in pratica, ove avessimo responsabilità di governo, è la formula liberale del benessere e della crescita che ha funzionato sempre e dovunque sia stata realizzata. È un programma in tre punti. Il primo punto: meno tasse. Il secondo punto: meno tasse. Il terzo punto: ancora meno tasse" (24 dicembre 2014)
Beppe Grillo, in passato il leader 5 Stelle aveva elogiato il "modello" Argentina, ora è il turno della Russia: "Fare la fine del Rublo se usciamo dall'Euro? Magari!" (27 dicembre 2014)
Roberta Pinotti, ministro della Difesa, in un'intervista rilasciata a Tv2000, la tv della Cei: "Mi sono iscritta al Pci nell’89, l’anno della svolta di Occhetto che chiamò a raccolta anche Acli e Caritas. Votavo Pci, lo sentivo il partito più attento a quelli che ritenevo gli ultimi, secondo una mia lettura del Vangelo" (27 dicembre 2014)
Mario Borghezio, l'eurodeputato leghista dice la sua sul rinvio a giudizio di 34 “guardie padane” (Il Giornale): "Si figuri che il capo delle famigerate camicie verdi era il generale Pollini. Di professione faceva il guaritore. Credo che imponesse le mani... Fra l’altro il nocciolo duro dell’organizzazione era composto da ex alpini con i capelli bianchi e una discreta propensione all’alcol" (29 dicembre 2014)
Il presidente del Consiglio Matteo Renzi durante la conferenza stampa di fine anno ha fatto riferimento a ''Ogni maledetta domenica'', il film in cui Al Pacino interpreta il ruolo di un allenatore di football americano che riesce a condurre la squadra alle finali del campionato. Matteo Renzi, durante la conferenza stampa di fine anno: "Mi sento un po' come Al Pacino in Ogni maledetta domenica, un coach che dice ai suoi che ce la possono fare" (29 dicembre 2014)
Maurizio Gasparri, il vicepresidente del Senato scatenato su Twitter, anche durante le festività natalizie: "Il Liverpool scarica Balotelli? Un vu gioca' del pallone". "Non vado pazzo per i sanpietrini, ma l'idea di venderli è così da deficiente che meriteresti che te li tirassero in fronte Ignazio Marino". "Sei proprio un deficiente Ignazio Marino". Ad un utente: "Te nu spreca' la corda chiudi l'hanno in bellezza, buttate!". Rispondendo a NaOh: "Io capodanno da solo? Ora vado dagli amici e tu stasera stai a casa, la vita da Rom è dura". Rispondendo a Maria Teresa, che lo critica tirando in ballo la "Repubblica delle banane": "Lei è una nota esperta di banane a giudicare dalle foto, addio" (29 dicembre 2014)
Giuseppe Pecoraro, prefetto di Roma, intervistato da Repubblica in merito all'inchiesta su Mafia Capitale: "A marzo Buzzi non sapevo neanche chi fosse. Io l'ho ricevuto sulla base del rispetto che ho per la persona che me l'ha mandato, Gianni Letta. E devo ammettere che avevo pure rimosso quell'incontro. Mi sono ricordato di lui e di averlo ricevuto solo quando ho letto l'ordinanza" (30 dicembre 2014)
Francesca Pascale, la fidanzata di Silvio Berlusconi spegne sul nascere le voci di una possibile crisi di coppia: "Crisi? Ma quale crisi? Io e il presidente Berlusconi siamo sempre una coppia quasi normale. Una coppia in cui quel 'quasi' c’è sempre stato, e riguarda la differenza d’età. E chi si scolla da lui?". "Non ero a Madrid, vuole che le mandi le mie coordinate geografiche via WhatsApp? Sono ad Arcore, con 'lui', certo. L'unica emergenza è un'altra: mancano gli struffoli". "E a chi si dava pensiero anche di sapere come stessero i miei cagnolini, annuncio che si preparano a festeggiare con noi. Dudù è in ottima forma, e Dudina... non so se posso dirlo... diciamo che è entrata nell’età adulta" (31 dicembre 2014)
Antonio Razzi, l'incredibile ammissione del senatore di Forza Italia, come se nulla fosse... (Repubblica.it): "Io avrei ottenuto qualcosa per passare con Berlusconi? Magari! Non volevo perdere il posto di lavoro. Io volevo rimanere alla Camera perché volevo pagarmi il mutuo. È stato un atto di salvarmi la mia paca... Chi è quel lavoratore che non si salva la sua paca? Era un modo per difendere i miei diritti. Mi mancava tre anni per la penzione svizzera. E così ho detto, se salvo il governo io mi salvo tutto e almeno pago il mutuo. Sennò chi lo paga il mutuo? Lei?" (22 dicembre 2014)
Brunetta: "La legge c'è, basta applicare la mia riforma". L'ex ministro della Pa: "Ridicolo nascondersi dietro il ddl Madia", scrive Fabrizio De Feo su “Il Giornale”.
Onorevole Brunetta, lei è stato per anni simbolo della lotta ai «fannulloni» nella Pa. Cosa pensa dell'episodio romano?
«È un episodio grave che rischia di tramutarsi in un boomerang per chi se ne è reso responsabile. Ma certo colpisce che la sinistra dopo aver combattuto le mie leggi oggi scopra che esistono fannulloni e assenteisti. Quando lo dicevo io mi insultavano».
Renzi invoca nuove regole per il 2015.
«Nascondersi dietro il disegno di legge Madia è ridicolo. Le regole per combattere fannulloni e assenteisti ci sono già e portano il mio nome. Vanno applicate subito, senza scuse, e vanno stigmatizzati certi comportamenti sempre, non solo quando c'è il caso mediatico. È stata la sinistra, è stata la Cgil a combatterle. Sono stati i governi Monti, Letta, e anche il governo Renzi, da oltre 10 mesi, a non applicare queste regole».
In concreto come sono state disattese?
«Proprio sull'assenteismo dei dipendenti. Io pubblicavo i dati delle assenze di tutti i dipendenti della Pa, mensilmente e nel dettaglio. Con la fine del governo Berlusconi questo non è più accaduto. Avevamo ottenuto risultati importantissimi. Ad esempio l'obbligo dei certificati medici online sia del pubblico che del privato con la trasmissione in tempo reale all'Inps. Se vogliono sapere quali medici hanno fatto i certificati, possono farlo in un attimo».
Contro la sua riforma ci furono ribellioni da parte dei dipendenti pubblici?
«No, anzi, la Cgil mise in campo 13 scioperi, tutti falliti, tutti con una partecipazione media del 4%. Il consenso nella Pa era alto, tranne nel Pci-Pds-Ds-Pd, tranne nella Cgil, tranne tra gli intellettuali come Scalfari o Merlo, tranne i cantanti, gli attori e i comici».
Renzi da amministratore locale come si pose rispetto alla sua riforma?
«La applicava salvo dire: "Ma non sono mica Brunetta". Quando era presidente della Provincia di Firenze gli proposi una scommessa: se con la mia riforma tra i tuoi dipendenti l'assenteismo si riduce più del 40% mi regali una Montblanc; se meno del 40% te la regalo io. Vinsi la scommessa, ma la Montblanc non me l'ha mai regalata».
In malattia per cento milioni di giorni all’anno. Non solo per motivi di salute: le assenze dei dipendenti toccano il 20% nel settore pubblico e il 13% nel privato. Brunetta stimò un costo annuo per la PA di 6,5 miliardi, anche se il fenomeno è in calo. Sono tutte giustificate? Scrive Paolo Baroni su “La Stampa”. Solo a causa delle malattie in un anno, il 2013, l’ultimo censito dall’Inps, vanno in fumo oltre 108 milioni di giornate di lavoro: 77,6 nel settore privato e 30,8 nel settore pubblico, dove si registra un totale di 4.838.767 «eventi». In pratica l’altro anno ognuno dei 3 milioni e trecento mila travet si è ammalato una volta e mezzo nel giro di 12 mesi. In media, ferie comprese, le assenze dal lavoro toccano il 20% nel settore pubblico ed il 13 in quello privato. Ma le motivazioni, come insegna la vicenda dei vigili romani, non si limitano alle sole malattie, ci sono infatti permessi di vario tipo ed i giorni concessi dalla legge 104 per l’assistenza ai disabili. Un «danno», per la pubblica amministrazione, che qualche anno fa, quando Brunetta lanciò la sua crociata contro i «fannulloni», venne stimato in 6,5 miliardi di euro l’ anno. L’ultimo monitoraggio della Funzione pubblica, che però si ferma ad agosto 2014, calcola che su 4705 amministrazioni prese in esame, in media ogni dipendente si è assentato per 0,558 giorni per cause di malattia (con ministeri e agenzie fiscali che arrivano a 0,987 e le università che si fermano a 0,218). Con picchi particolarmente alti al ministero della Giustizia (1,827 giorni/dipendente) e alla Difesa (1,218). Per lo più si tratta sempre di malattie di breve durata: gli eventi che comportano assenze superiori ai 10 i giorni, infatti, pesano appena per 0,023 giorni per ogni dipendente. Gli «altri motivi», ovvero le varie tipologie di permesso, pesano molto di più: la media per dipendente è infatti pari a 1,001 giornate perse al mese (1,804 nelle comunità montane e 1,739 nelle università). A livello regionale ci si ammala molto di più al centro (0,725 giorni/dipendenti) ed al Sud (0,607) che nel Nord est (0,386) e nel Nord Ovest (0,403). Dal ministero assicurano che i dati sulle assenze dei dipendenti pubblici saranno aggiornati nei prossimi giorni. Per ora questo ultimo monitoraggio ci dice che rispetto all’anno precedente le assenze di malattia sono scese del 9% e quelle per «altri motivi» del 15,3%. Nulla rispetto ai picchi fatti segnare all’avvio della riforma Brunetta, quando nel giro di pochi mesi si registrò un crollo del 36% delle assenze coi giorni di malattia pro-capite scesi da 1,04 a 0,64. «Da Monti in poi - denuncia oggi l’ex ministro di Fi - i governi di turno non hanno più creduto in questa operazione. I dati non vengono più pubblicizzati e in pratica la lotta all’assenteismo è stata abbandonata. Peccato perché ora con certificati medici e ricette on line la Pa avrebbe nuovi importanti strumenti che potrebbe utilizzare». La pubblicità dei dati, dettagliati per tipologia di amministrazione e territori, in effetti, è lo strumento più efficace per contrastare questi fenomeni. Per legge tutto è infatti on line e pubblico: basta accedere ai vari siti e cercare il link «amministrazione trasparente». E così facendo, ad esempio, si scopre che al Comune di Roma (nel terzo trimestre 2014) i tassi di assenza, ferie comprese, oscillano tra il 25 ed un pericoloso 42%, con una quota che spesso supera il 10% tra malattie e permessi. Quanto ai vigili urbani già a fine 2013 facevano segnare picchi significativi di malattia (7,4% il gruppo di Montemario), di permessi legge 104 (3,01% al Tuscolano) e di permessi «vari» (5,95% al Prenestino). Ma del resto se anche alla Corte dei Conti, dove operano i nostri censori degli sprechi, in un terzo degli uffici si sfora il 30% di assenze, si capisce bene come l’assenteismo sia ancora una malattia nazionale.
Da sinistra si grida al lupo nero, indicando la pagliuzza nell’occhio altrui.
Padrini, terroristi, servizi segreti e massoni: così dalla Magliana è nata mafia Capitale. Quarant'anni fa i capi di 'ndrangheta e banda della Magliana si riunivano al Fungo. Lo stesso luogo dove è cresciuto Massimo Carminati. E che ritorna nell'inchiesta su Mafia Capitale. Che sembra sempre più l'evoluzione criminale della vecchia banda di Romanzo Criminale, scrive Giovanni Tizian su “L’Espresso”. C'è un filo nero che attraversa gli ultimi decenni della storia criminale italiana. È un cordone che unisce l'Italia: da Reggio Calabria a Roma. Dalla 'ndrangheta a Mafia Capitale, passando per la banda della Magliana, terrorismo nero, servizi segreti e massoneria. Con un luogo che ritorna oggi come ieri: il Fungo, zona Eur, Roma. «Con Mancini (Riccardo, l'ex numero uno di Euro Spa inquisito nell'inchiesta su Mafia Capitale ndr) abbiamo fatto dieci processi quando eravamo ragazzini... stavamo al Fungo insieme... cioè... ma... con tante altre persone... che magari hanno fatto carriera... che in questo momento magari non sono indagate». Massimo Carminati rievoca il passato dei “neri” di Roma. Lui racconta e intanto le cimici piazzate dagli investigatori del Ros dei carabinieri intercettano. Carminati ricorda gli anni '70, gli anni di piombo, quando la gioventù neofascista della Capitale si incontrava in un luogo simbolo, che ritorna anche nell'inchiesta Mafia Capitale. Il punto di ritrovo di cui parla “er Cecato” è il Fungo. Un acquedotto costruito negli anni '60 all'Eur, a pochi chilometri dalla Magliana. Sotto questa struttura di cemento armato che assomiglia a un enorme fungo si ritrovavano i giovani della destra radicale, molti dei quali sono poi finiti nei nuclei armati rivoluzionari. L'ala più feroce dell'eversione di destra. Ma all'ombra del Fungo, nel ristorante panoramico all'ultimo piano della torre, si sono incontrati pure altri personaggi da romanzo criminale. Alcuni dei quali condividono con il boss di Mafia Capitale il credo fascista e il fiuto per gli affari, di qualunque colore essi siano. È una storia che comincia quarant'anni fa. Nel 1975. In un 'Italia stremata dalla tensione sociale e politica provocata dalle bombe, dal lavoro sporco dei servizi deviati e dagli accordi sottobanco tra organizzazioni mafiose, estremisti neri e 007. Il Paese era terrorizzato. E il peggio doveva ancora arrivare. Solo un anno prima c'era stata la strage dell'Italicus, sei anni prima il massacro di piazza Fontana a cui seguì, l'anno dopo, la bomba che fece deragliare il treno a Gioia Tauro. È in questo contesto di terrore e tritolo che il 18 ottobre '75 allo stesso tavolo siedono tre capi 'ndrangheta tra i più influenti nell'organizzazione calabrese e alcuni esponenti della banda della Magliana. Il summit si è tenuto proprio al Fungo. E qui che la polizia di Stato interviene e arresta Paolo De Stefano, don Peppe Piromalli, Pasquale Condello, Gianfranco Urbani e Manlio Vitale. «Tale riunione, lungi dall'essere una mera riunione conviviale costituiva invece una vera e propria riunione mafiosa ad alto livello» si legge nelle informative dell'epoca. Paolo De Stefano verrà ucciso dieci anni dopo. L'agguato che gli costò la vita diede il via alla seconda guerra di mafia a Reggio Calabria. Il clan De Stefano però è tuttora il più potente della città. E nell'organizzazione calabrese è la famiglia che conta di più, quella che negli anni ha saputo creare relazioni più solide con il potere: hanno protetto la latitanza del terrorista neofascista Franco Freda; hanno giocato un ruolo importante nella rivolta dei Boia chi molla per Reggio capoluogo; l'avvocato Giorgio De Stefano, ucciso nel '77, è stato, secondo alcuni pentiti, il contatto tra 'ndrangheta e servizi segreti. Tra spioni ed estrema destra, i De Stefano sono cresciuti e dal poverissimo quartiere Archi dove hanno mosso i primi passi, hanno allungato i tentacoli fino in Francia, radicando i propri affari a Roma e Milano. E proprio nel capoluogo lombardo, stando alle recenti indagini dell'antimafia reggina, ha sede il cuore finanziario del clan. L'indagine Breakfast sta scavando nei segreti societari della 'ndrangheta governata dalla famiglia De Stefano, e ha scoperto complicità nella Lega Nord, con l'ex tesoriere Francesco Belsito, e con uomini un tempo dell'avanguardia armata nera, come Lino Guaglianone, anche lui come Massimo Carminati, ex Nar, e precisamente ex tesoriere del nuclei armati rivoluzionari. Non solo, ma nei rapporti investigativi gli inquirenti segnalano più volte la vicinanza dei De Stefano alla banda della Magliana, «di cui sono noti i collegamenti con la destra eversiva e i servizi segreti». Al Fungo c'era anche Pasquale Condello, detto “il Supremo”. Come i De Stefano è cresciuto nel quartiere Archi. Insieme hanno conquistato Reggio, salvo poi dividersi in una guerra durata sei anni e con mille morti ammazzati. Dopo il sangue è tornata l'armonia e la città è stata divisa equamente. Ancora oggi è pax mafiosa. Il profilo di Giuseppe Piromalli detto “Mussu stortu” è simile a quello di don Paolino De Stefano. Le loro famiglie si uniscono alla fine degli anni 70' per fondare una 'ndrangheta più moderna. Sono i precursori della strategia delle alleanze trasversali con pezzi delle istituzioni e di altri gruppi mafiosi. E sono i promotori dei grandi business con la droga. Per farlo hanno dovuto annientare i vecchi capi bastone. Una volta eliminati è iniziata la loro ascesa criminale. Peppe Piromalli trascorreva molto tempo nella Capitale. L'interesse della 'ndrina di Gioa Tauro era quello di allargare la zona di influenza. Un particolare che verrà confermato dal pentito della banda della Magliana Antonio Mancini, “l'Accattone”. I Piromalli ritornano nell'indagine della procura antimafia di Roma su Mafia Capitale. I pm e i militari del Ros hanno infatti scoperto come la banda de “er Cecato” avesse stretto un patto con i clan calabresi, in particolare con i Mancuso, attraverso però un parente del boss Piromalli, dipendente delle cooperative del braccio destro di Carminati, Salvatore Buzzi. Quel giorno di quarant'anni fa al Fungo accanto ai mammasantissima della 'ndrangheta c'erano “er Gnappa” Manlio Vitale e “er Pantera” Gianfranco Urbani. Personaggi di spicco della Magliana. Manlio Vitale con Massimo Carminati ha condiviso più di qualche avventura malavitosa. Nel 2000 sono stati indagati per il furto nel caveu all'interno del Palazzo di giustizia. E nella sentenza sulla banda della Magliana i loro nomi vengono accostati spesso. Vitale come Carminati frequentava il Fungo. D'altronde era zona loro. Per questo gli 'ndranghetisti sono stati invitati in quel ristorante. Non solo. Il nome de “er Gnappa” spunta negli atti di Mafia Capitale. Fino a qualche anno fa, almeno da quel che risulta agli investigatori, frequentava Riccardo Brugia, «compare e braccio destro di Carminati». Brugia secondo gli inquirenti è «dotato di una rilevante storia criminale personale e legato al Carminati da una profonda amicizia e dalla comune militanza nei gruppi eversivi dell’estrema destra». «Er Pantera» invece è morto qualche mese fa. Nella banda, alcuni collaboratori di giustizia, lo indicavano come il manager delle relazioni con le altre organizzazioni. Con la 'ndrangheta ma anche con i clan catanesi, in particolare con la cosca di Nitto Santapaola (famiglia alleata con Piromalli e De Stefano). Fu lui, dicono i testimoni, a tenere i contatti con le 'ndrine di Reggio Calabria e a instaurare il traffico di eroina con la Tailandia. Ora che molti dei protagonisti della riunione del Fungo non ci sono più, l'eredità di quei rapporti è passata di mano. A Roma comanda Mafia Capitale e le sue alleate. Una in particolare, la 'ndrangheta. In fin dei conti, quindi, poco è cambiato. Se non il clima. Per questo l'organizzazione guidata da “er Cecato” in un certo senso sembra l'evoluzione criminale della banda dei testaccini, l'anima più borghese del gruppo della Magliana. Un salto di qualità obbligato. Lo stesso passaggio che hanno dovuto mettere in atto le altre mafie. In questo nuovo contesto rapinatori e i killer hanno sempre meno spazio. Ciò che non muta sono le alleanze di un tempo. E spesso ritornano gli stessi cognomi, gli stessi personaggi. Segno che il capitale di relazioni e conoscenze accumulato negli anni passati frutta ancora oggi. E che la mafia più che rottamare riadatta al nuovo corso i vecchi arnesi.
L’altra faccia della medaglia, invece, è la trave nascosta negli occhi della sinistra.
Lo scandalo dei falsi iscritti Pd: "Tesserate persone inesistenti". Una giornalista della Stampa ha ottenuto una tessera dei dem fornendo false generalità: nessun controllo, nessuna richiesta di documenti. Si paga, si firma e si ottiene la tessera, scrive Ivan Francese su “Il Giornale”. Iscriversi al Pd romano è facile. Facilissimo. Tanto facile che basta scrivere un nome falso e un indirizzo mail di fantasia, pagare la quota di iscrizione e la tessera salta fuori senza alcun controllo. Nessuna richiesta di documenti, carta d'identità, patente, codice fiscale: niente di niente. Questa la clamorosa scoperta della cronista de La Stampa Flavia Amabile, che è riuscita ad iscriversi ad una sezione capitolina del Partito democratico fornendo generalità inventate ed ottenendo la tessera del partito senza problemi. Quello delle tessere è stato a lungo un grosso problema per il Pd nazionale, con il numero degli iscritti soggetto a cali di centinaia di migliaia di persone da un anno con l'altro. In Piemonte si sono registrati casi di anziani pagati per iscriversi al partito e votare, in Puglia è stato segnalato un numero di tessere triplo rispetto a quello degli iscritti. Proprio a Roma, alle primarie per il sindaco della primavera 2013, si erano viste file di rom fuori dai seggi, con conseguenti polemiche sulla regolarità del voto. Ora, anche in seguito allo scandalo di Mafia Capitale, il presidente del partito Matteo Orfini, aveva annunciato di voler fare "pulizia" nel Pd romano, passando ai raggi x gli ottomila iscritti della capitale. Sempre su La Stampa, l'esponente democratico ammette di "non essere sorpreso" per la facilità con cui si possono ottenere tessere false, ma chiede anche di "non crocifiggere nessuno" in attesa che "ci si abitui al rispetto delle regole". Iscriversi agli altri partiti, chiosa la Amabile, non è però così semplice. Complice anche una situazione finanziaria che non permette strutture sul territorio articolate come quelle del Pd, spesso l'iscrizione alle formazioni politiche richiede la compilazione di formulari online oppure all'interno di circoli dove i nuovi arrivati vengono "esaminati" più attentamente. Solo a Sel, scrive la cronista del foglio torinese, "nel tesseramento online non è richiesto alcun tipo di documento".
Venti euro e zero controlli per una tessera falsa del Pd. Nome di fantasia, niente documenti né codice fiscale: il numero di finti iscritti può crescere anche in questo modo. La tessera finta e la ricevuta del versamento con cui la nostra cronista si è iscritta con nome falso al Pd, scrive Flavia Amabile su La Stampa. Da cinque giorni ho in tasca una tessera del Pd totalmente falsa. Non è stato poi troppo difficile ottenerla, mi è bastato dare il primo nome che mi è venuto in mente. Nessuno mi ha chiesto né una carta d’identità né una patente. Mi è stato specificato che anche il codice fiscale non è importante: conta solo versare i 20 euro necessari. Vuol dire che due anni sono stati presi e buttati via. Era l’aprile del 2013 quando esplosero le polemiche intorno alle primarie per il sindaco di Roma con le file di rom fuori dai seggi denunciate da Cristiana Alicata - allora dirigente del partito nel Lazio - e ignorate. E poi lo scandalo delle tessere gonfiate, le rivelazioni dell’inchiesta Mafia Capitale e il commissariamento. Tutto questo non sembra aver ancora insegnato nulla al Pd romano. Matteo Orfini, il presidente del partito mandato dal segretario Matteo Renzi a fare pulizia tra i circoli della capitale, dieci giorni fa aveva annunciato di voler iniziare il suo lavoro dagli 8mila iscritti nella capitale per passare le loro tessere ai raggi X. Ha ragione perché iscriversi al Pd in alcuni casi è davvero troppo semplice. Molto dipende dal fatto che è l’ultimo partito ad avere una presenza davvero capillare sul territorio, oltre 6mila circoli, un punto di forza dal punto di vista elettorale ma anche un’opportunità per chi abbia voglia di sottrarsi ai controlli centrali e usare partito e tessere per i propri interessi. La lista completa dei circoli non è semplice da trovare, sul sito del Pd c’è una mappa 2.0 molto bella ed avanzata con le regioni da cliccare. Peccato che non funzioni. Per trovare l’elenco dei circoli della capitale è più utile andare a cercare sul sito del Pd Roma. Nella mia zona di residenza ne sono indicati almeno sei. Due sono semichiusi perché, fatta eccezione per i circoli storici, gli altri si appoggiano a strutture dove affittano spazi per poche ore a settimana: trovarli aperti al primo colpo è difficile. Il terzo tentativo è in via Galilei 57, un enorme locale al piano terra gestito da diverse associazioni. Per il Pd devo tornare di giovedì, dopo le 18. Giovedì 18 dicembre alle sei sono lì, accolta con incredulità e una certa emozione da un giovane pieddino: deve essere trascorso molto tempo dall’ultimo nuovo tesserato arrivato a sostenere il partito. Mi fa entrare nella stanza a disposizione del partito una volta a settimana, racconta che pagano 400 euro al mese per averla e che 15 dei 20 euro della mia futura tessera andranno al circolo, gli altri 5 alla federazione. Mi spiega che è in corso l’ultimissima fase del tesseramento 2014 ma che per avere la tessera del 2015 bisognerà aspettare almeno sei mesi. Lo rassicuro, voglio sostenere il Pd, verserò la mia quota comunque e inizio a compilare i moduli. Invento un nome, lo scrivo. Invento un numero di telefono, lo scrivo. Sbaglio il codice fiscale, sto per scriverlo di nuovo in base al nome che ho inventato ma il giovane mi spiega che non è necessario, a loro non serve. Scrivo di essere disoccupata, invento una mail che sarà uno scherzo aprire al ritorno a casa per ricevere le comunicazioni, firmo, pago, ringrazio, saluto, vado via. Flavia Alessi è iscritta: non una parola su di me, sui motivi che mi hanno portata a scegliere all’improvviso il Pd. Quando il giorno dopo Flavia Alessi prova a forzare ancora di più il gioco iscrivendosi anche agli altri partiti si trova di fronte ad un’atmosfera molto diversa. Nessuno ha più soldi a sufficienza per tenere aperte tante strutture, i tesseramenti avvengono esclusivamente online oppure all’interno di circoli dove si è talmente pochi che tutti si conoscono e i nuovi arrivati vengono osservati con attenzione. Resta una possibilità aperta solo con Sel: nel tesseramento online non è richiesto alcun tipo di documento. Ma è più facile che in questo momento faccia gola un eventuale assalto al Pd che a Sel.
Militante democrat a sua insaputa. Branco mette alle corde i furbetti. L'ex campione del mondo Branco si ritrova tesserato e scrive a Renzi: cancellato, scrive Matteo Basile su “Il Giornale”. Guai a farlo arrabbiare. Non perché sia cattivo o violento, tutt'altro. Ma perché nella sua più che ventennale carriera di pugile, che lo ha portato ad essere l'europeo più titolato di sempre, Silvio Branco ha imparato molte cose. Tra queste a non farsi mettere i piedi in testa e a guardarsi dalle fregature. Figuriamoci se uno così, abituato a combattere per ottenere risultati, si fa prendere in giro da un partito politico. Succede che nella sua Civitavecchia, città dove Branco è un monumento vivente, il pugile, ritirato solo lo scorso anno dall'attività agonistica alla soglia dei 48 anni, si sia di fatto ritrovato iscritto a sua insaputa al Partito democratico. Lo scorso 20 dicembre infatti si è tenuto in città il congresso straordinario del Pd, con la presentazione delle piattaforme politiche e dei candidati alla segreteria. Inevitabile che nei giorni che hanno preceduto il congresso, come da mondo e mondo accade in ogni partito politico prima di ogni convention, sia scattata la corsa al tesseramento, con i vari dirigenti in prima linea per cercare di «accaparrarsi» quanti più delegati possibili. Missione compiuta si penserebbe dando uno sguardo ai dati, ancora ufficiosi. Un boom in controtendenza rispetto al resto d'Italia e altamente discostante rispetto al clima di anti politica che regna nel Paese: secondo il partito sarebbero state sottoscritte ben 700 tessere in più rispetto all'anno precedente, senza contare che c'è tempo per iscriversi ancora fino a domani, 31 dicembre. Branco, in passato delegato allo sport del Comune visto il suo ruolo di «ambasciatore» italiano del pugilato nel mondo, viene a sapere che anche lui risulta essere nell'elenco dei nuovi iscritti. Un colpo basso che non accetta. «Mi è stato detto che ero tesserato ma non avevo fatto nessuna richiesta né firmato nessun documento - racconta il campione al Giornale - Allora ho messo le mani avanti e inviato una lettera diffidando il partito dall'iscrivermi a qualsiasi lista». Una lettera di fuoco inviata da Branco al segretario del partito Matteo Renzi, al presidente Matteo Orfini e alla commissaria di Civitavecchia Michela Califano. E visto che Branco, come detto, non è solo un grandissimo campione ma in città è un'autentica icona, i dirigenti hanno subito pensato di evitare problemi eliminando il nome del pugile. Una figuraccia del genere, con il tesseramento di un volto tanto noto a sua insaputa, non avrebbe certo giovato al Pd. «Quando ho appreso la notizia mi sono molto amareggiato - confessa Branco - Probabilmente fossi stato il fruttivendolo del paese non ci sarebbe stato clamore e sarebbe stato iscritto a sua insaputa. Nulla contro nessuno, sia chiaro, ma certo non mi va di essere preso in giro». Il campione del mondo dei pesi mediomassimi e dei massimi leggeri, ha quindi evitato il finto tesseramento sul nascere ma pare che a Civitavecchia siano stati in molti a diventare militanti del Pd a loro insaputa. Magari non famosi come Branco ma di certo utili, utilissimi a fare numero. Alla faccia della trasparenza e della correttezza.
Il manicheismo assoluto dell’inchiesta Mafia Capitale, scrive Francesco Petrelli, segretario dell’Unione Camere Penali Italiane su, “Il Garantista”. I fatti accadono. Non accadono come risultato di un complotto. Ma non accadono neppure a caso. Proviamo a leggerli nelle loro cadenze più evidenti. Con l’indagine “Mafia Capitale”, esplosa a Roma i primi di dicembre con alcuni arresti per fatti di corruzione e associazione mafiosa che legano criminalità comune e potere politico capitolino, lo sviluppo investigativo impresso dal Capo della Procura romana assume caratteristiche originali. Ciò che emerge con sufficiente chiarezza è la deliberata decifrazione in chiave di mafiosità di tutti i fenomeni criminali, secondo una prassi che porta con sé tutto l’armamentario affinato nell’ambito della pregressa esperienza investigativa mafiosa, siciliana e calabrese, e che trasforma l’art. 416 bis in un indiscriminato strumento di lettura di tutti i fatti delittuosi più o meno ordinari. Così come scriveva Martin Heidegger: “date un martello a un bambino e trasformerà tutto il mondo in un chiodo”: nonostante qualche analogia con Tangentopoli (che si coglie nei proclami reiterati della Procura, nell’enfatizzazione mediatica dell’indagine e dei suoi sviluppi, e in quella telecamera fissa fuori dalla porta carraia di via Varisco …), è questo il tratto distintivo. Là una quasi inaspettata onda di consenso popolare per l’indagine, sulla quale incredule saltano sopra le Procure, cavalcandola sino alle sue estreme conseguenze, qui una scientifica, preventiva e meticolosa articolazione di sofisticati strumenti mediatici messi in mostra senza alcun pudore. L’ingenuo manicheismo che sortiva fuori dall’azione della magistratura milanese come un fenomeno spontaneo e divideva la società civile buona dalla politica corrotta dei partiti, qui diviene il feroce strumento ideologico che giustifica l’affondo sui crimini della capitale, trasformata in una Gotham city in cui domina l’orbo veggente che teorizza di mondi mediani e nella quale loschi passati carcerari incrociano il disinvolto presente dei manager metropolitani. La Procura antimafiosa è il Bene assoluto che ridisegna la storia e riscrive i codici e attraverso la sua azione giudiziaria modella la Verità e la sua virtuosa rappresentazione. Male è la politica che non si piega più ai veti della magistratura e impone norme contrarie ai suoi voleri. Male è il giornalismo che non si piega ai desiderata delle Procure e che offre spazi informativi a chi cerca il senso delle cose al di fuori dell’unico pensiero che tutti i media pontificando avallano (“Mi conferma – chiede al ministro un po’ stizzita la Annunziata, costituzionalmente mal consigliata – che queste nuove norme anticorruzione non si applicheranno ai fatti di Roma?!). Male sono i giudici che assolvono e che prescrivono i reati, da Roma a L’Aquila e fino agli ermellini della Corte Suprema. Male è l’avvocatura. Obliquo ed obsoleto strumento favoreggiatore. Intralcio pericoloso all’accertamento della verità intesa, non come risultato provvisorio e falsificabile, ma come esito del parto gemellare che ha messo al mondo la Verità e l’Indagine al tempo stesso. La storia, come è noto, non si ripete mai uguale a se stessa, e qui le differenze sotto un profilo strutturale appaiono assai qualificanti: Tangentopoli nasceva spontanea e, a guardarla oggi, un po’ naif. Piegava la procedura, ma lo faceva secondo cadenze improvvisate, via via messe a fuoco sulla spinta cinica della necessità. “Mafia Capitale” è invece il manifesto di un Manicheismo assoluto, una macchina ideologicamente spietata, postmoderna, sofisticata, tecnologica, multimediale e perniciosa perché produttiva di irreparabili squilibri. Vediamone alcuni: visto che il legislatore imbelle tentenna ad introdurre norme che consentano di applicare a fenomeni criminali corruttivi le nome antimafia, la Procura romana trasforma con lucida operazione genetica i fenomeni corruttivi in reati di mafia. I giudici lavorano con i fatti e li plasmano sulle norme. Così se le norme non si piegano ai fatti, saranno i fatti a piegarsi alle norme. Le Procure fanno a meno del Legislatore. Le Procure fanno a meno anche della compressione delle garanzie. Scrive il dott. Gratteri su MicroMega, uscendo a ottobre dall’ “ombra del suo ministero”: “con la nostra riforma non arretreremo le garanzie di un millimetro”. Non c’è bisogno infatti. Le garanzie non si abrogano con le leggi ma si elidono nei fatti: la mafiosità postulata impone al processo ritmi e cadenze necessitate dalla gravità del fenomeno: che l’indagato in vincoli venga interrogato a sua garanzia il più presto possibile e subito dopo l’esecuzione della misura e senza che possa leggere granché delle oltre mille pagine dell’ordinanza appena notificatagli. Se poi davvero vi è tanta urgenza di rimescolare le carte di fronte a tanto evidente e corposa fonte di Verità, che l’avvocato insegua l’indagato nelle carceri poste ai confini del regno, dove è stato collocato per ovvi motivi di sicurezza antimafiosa. La politica debole si mette nelle mani della magistratura. Nonostante le denunce del Procuratore di Palermo, la risalente prassi, cresciuta al di fuori di ogni regolamentazione legislativa, di iniettare magistrati delle procure antimafia direttamente negli assessorati regionali e comunali disastrati, si ripete e si moltiplica, dalla Regione siciliana al Comune di Roma: solo il magistrato antimafia è garanzia di legalità. Anche a Gotham city la politica non si fida più della politica e la Magistratura, che una volta si candidava in libere elezioni per occupare spazi tramite la libera competizione elettorale (come sembrano lontani e ingenui i tempi dei Di Pietro, degli Ingroia e dei De Magistris), ora quegli spazi se li apre di fatto, sull’onda delle sue stesse indagini, per saltum. Con scientifica sapienza postmoderna l’indagine “Mafia Capitale” pone così i nuovi confini del Bene e del Male, impone alle amministrazioni locali i garanti della legalità, impone alla politica le riforme del processo e al tempo stesso dimostra di non aver bisogno di nulla e di nessuno per cambiare il mondo, e di poter fare la Storia da sola, ancora una volta, con un nuovo passo, annunziando la trasformazione con un formidabile trailer nel quale il Male si arrende davanti a tutti alzando le mani…
Quando i magistrati prendevano ordini dalla P2…, scrive Ilario Ammendolia su “Il Garantista”. Non so se in Italia vi sia più corruzione rispetto al passato ma certamente lo scandalo “mafia capitale” non è lontanamente comparabile con quello della Banca di Roma. Carminati non è Giolitti e Buzzi non è Crispi. L’effetto però è stato completamente diverso. In quel caso dinanzi alle accuse del presidente del Banco di Roma Tanlongo che dal carcere aveva fatto i nomi di Giolitti e Crispi, una classe politica, certamente conservatrice, ma dotata di quello che la borghesia ha chiamato per decenni “senso dello Stato” non indietreggiò ma si assunse tutte le responsabilità. Il primo ministro di Rudinì si presentò in parlamento arginando chi avrebbe voluto travolgere la classe politica per prenderne il posto e lo fece con fermezza in nome dei «supremi interessi del Paese e della Patria». Non si comportò diversamente Aldo Moro che, durante lo scandalo Lockheed, dinanzi al Parlamento riunito in seduta congiunta, invitò i parlamentari a guardare alla giustizia «non in senso tecnico-giuridico, ma politico, consapevoli che la valutazione dei fatti.. non riguarda una dichiarazione astratta di giustizia ma un’attuazione concreta di essa». Moro concluse il suo intervento con queste parole «…ci avete preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che noi non ci faremo processare». Flaminio Piccoli da presidente del consiglio dei ministri, dinanzi all’arbitrario debordare di alcuni magistrati, non esitò ad ammonire «…l’Italia non si farà governare dai pretori». Era un corrotto Aldo Moro? Molti dicono sia stato l’unico statista del dopoguerra a parte De Gasperi. Certamente la statura dello statista la ebbe Antonio Giolitti mentre nessuno dubita dell’onestà di Flaminio Piccoli. C’è un antico detto che predice che il giorno in cui il leone si metterà a belare, gli sciacalli prenderanno il suo posto. Quando si pretende di avere un ruolo dirigente senza essere eletti dal popolo, la democrazia reclina il capo, aprendo le porte all’avventura. Basterebbe riflettere sugli scandali falsi costruiti con la complicità di alcuni magistrati per capire cosa diventerebbe l’Italia qualora non si mettesse un argine alla deriva giustizialista. Cito solo due esempi: Felice Ippolito era uno scienziato autorevole quanto onesto ma venne arrestato con grande clamore sui giornali ed in televisione. Era completamente innocente. Lo scandalo è stato ordito dai petrolieri, per impedire l’uso, su vasta scala, dell’energia nucleare in Italia. La procura fu l’arma per fermarlo. Si può discutere nel merito dell’uso dell’energia nucleare, ma certamente quell’arresto è la dimostrazione di cosa sarebbe l’Italia «governata dai pretori». Non meno grave è il falso scandalo della Banca d’Italia che coinvolse il governatore Baffi ed il suo vice Sarcinelli. A Baffi venne risparmiato l’onta della galera per l’età avanzata mentre Mario Sarcinelli, studioso di chiara fama, venne arrestato e tenuto in carcere. Si scoprì in seguito che la magistratura romana aveva concepito gli arresti su stimoli della P2 indispettita dai controlli che la Banca d’Italia aveva operato su alcuni istituti di credito. Potremmo continuare per così tante pagine da fare un enciclopedia ! Ovviamente, non accuso i magistrati in quanto tali proprio perché sono assolutamente consapevole che non sono né peggiori, né migliori degli altri cittadini. Dinanzi alla corruzione, che deve essere combattuta e sconfitta, una Politica degna di questo nome non balbetta, non piagnucola, non impreca e soprattutto non tenta di gabbare i gonzi, elevando le pene. Con queste misure la corruzione non diminuirà di un solo milionesimo. Conoscete meglio di me le inutili “grida” contro i bravi di cui Manzoni parla nei Promessi Sposi. La corruzione è figlia di questo sistema ammalato dove il 5% della popolazione possiede il 50% della ricchezza. Un sistema in cui il privilegio e le caste calpestano quotidianamente il bisogno. Combattere la corruzione significa mettere in campo un grande progetto politico capace di riaccendere passioni e speranze collettive. Non ha senso essere complici di chi trova comodo mettere l’aureola sulla testa di singoli personaggi filtrati dai media e farne dei numi tutelari e per eludere i problemi reali da cui scaturisce la corruzione. Il caso dell’ex pm Antonio Di Pietro è da manuale ma non è il solo. Il dottor Nicola Gratteri è arrivato a due passi dalla nomina a ministro della Giustizia, l’onorevole Nitto Palma ha tagliato il traguardo, mentre il dottor Pietro Grasso, con un solo salto, è stato “eletto” alla seconda carica dello Stato. Un magistrato al pari di tutti i cittadini può essere eletto a qualsiasi incarico politico senza però, saltare a piè pari la fatica, le umiliazioni, le ansie di chi ha fatto politica tra la gente , si è nutrito delle loro speranze, ha respirato le loro frustrazioni ed i loro bisogni. Le scorciatoie stanno portando verso avventure autoritarie e contro queste occorre resistere con coraggio qualsiasi sarà il prezzo da pagare.
Roma, l’ex pm Sabella in giunta: “Difficile capire chi sono gli onesti”. Dopo il via libera del Csm, il sindaco Marino presenta il nuovo assessore alla legalità. L’attacco dell’Unione camere penali: “Prassi degenerativa assai pericolosa per gli equilibri democratici ed istituzionali quella dell’assunzione da parte della politica di magistrati antimafia”, scrive Giuseppe Pipitone su “L’OraQuotidiano”. “Quando vivevo a Palermo mi occupavo di ricerca di latitanti, la battuta che mi viene è facile: in quel caso sapevo chi erano i mafiosi ma non sapevo dove stavano, qui probabilmente si sanno dove stanno le persone ma non si sa chi essi siano in realtà”. Con una battuta fulminante, Alfonso Sabella ha esordito come nuovo assessore alla Trasparenza e Legalità del comune di Roma. Nella giornata di ieri il Csm ha infatti dato il via libera all’aspettativa chiesta dal magistrato con quattordici voti a favore, tre astenuti e otto contrari ( i vertici della Cassazione Giorgio Santacroce e il procuratore generale Gianfranco Ciani, più molti membri laici). Stamattina quindi l’ex pm è entrato nella nuova giunta varata dal sindaco Ignazio Marino. “Per me è un grande acquisto per Roma. Un acquisto necessario se si pensa che nei cinque anni precedenti la mafia aveva raggiunto posizioni di vertice. Con la nostra amministrazione non ci è riuscita però aveva tentato in diversi modi. Io credo che la presenza di una personalità come Alfonso Sabella scoraggerà anche i tentativi” ha detto il primo cittadino capitolino, che ha presentato la nuova giunta stamattina in Campidoglio . La nomina dell’ex pm della procura di Palermo arriva dopo il clamore suscitato dall’inchiesta Terra di Mezzo, che ha svelato l’esistenza della Mafia Capitale, l’organizzazione criminale con al vertice l’ex estremista nero Massimo Carminati. L’arrivo nella giunta capitolina di Sabella è stato bacchettato dall’Unione delle camere penali che ha bollato la nomina come “pericolosa per la democrazia“. I penalisti denunciano una “prassi degenerativa assai pericolosa per gli equilibri democratici ed istituzionali quella dell’assunzione da parte della politica di magistrati antimafia all’interno delle amministrazioni territoriali, approvata dal Csm e sospinta dal favore popolare”. Per l’Unione camere penale “da un lato, al di fuori di ogni regolamentazione legislativa, la magistratura si insedia all’interno della politica legittimando se stessa come unica garante della legalità, e dall’altro la politica dimostra con tali scelte di voler delegittimare se stessa affermando la propria inadeguatezza e la propria incapacità di perseguire la legalità con i suoi propri strumenti e con le sue proprie forze”. Nato a Bivona, piccolo comune in provincia di Agrigento nel 1962, fratello di Marzia, anche lei pm a Palermo, Sabella entra in magistratura nel 1989 e non si iscrive mai ad alcuna corrente delle toghe. All’inizio fa il pm a Termini Imerese, poi nel 1993 viene trasferito a Palermo: sono i mesi successivi alle stragi di Capaci e via d’Amelio e a dirigere la procura del capoluogo è appena arrivato Gian Carlo Caselli. Sabella diventa subito uno dei fedelissimi del magistrato piemontese e inizia a condurre le indagini su decine dei pezzi da novanta di Cosa Nostra, che reggevano l’organizzazione criminale dopo l’arresto di Totò Riina. In breve tempo finiscono in manette a decine:da Leoluca Bagarella fino a Giovanni Brusca, passando da Pietro Aglieri, Cosimo Lo Nigro e Carlo Greco: l’ala militare dei corleonesi è decimata in pochi mesi. Dopo l’esperienza come dirigente dell’ufficio ispettivo del Dap, Sabella viene trasferito prima a Firenze e poi diventa giudicante a Roma.
Pecoraro e l'incontro con Buzzi: "Mi sento pugnalato alle spalle. A Letta dissi: chi mi hai spedito?". Intervista al prefetto: "L'ho ricevuto in segno di rispetto per l'ex sottosegretario. Gli spiegai che non potevano arrivare altri profughi a Castelnuovo", scrive Mauro Favale su “La Repubblica”. "Quando Salvatore Buzzi andò via, dopo l'incontro con me, telefonai a Gianni Letta e gli dissi: "Gianni, ma chi mi hai mandato?". E lui? "E lui mi risposte: "Non lo farò più". Giuseppe Pecoraro ha festeggiato poche settimane fa il sesto anno da prefetto di Roma. Un anniversario che ha anticipato di poco la bufera su mafia capitale che lo vede primo attore in campo: da un lato sono i suoi uffici che stanno analizzando gli atti del Campidoglio e che dovranno relazionare al Viminale sulle infiltrazioni criminali nel Comune di Roma in vista di un eventuale scioglimento. Dall'altro, proprio in questi giorni, Pecoraro è costretto a difendersi per aver incontrato il 18 marzo scorso, nei suoi uffici, proprio Buzzi, il ras delle cooperative, braccio destro di Massimo Carminati, finito in carcere accusato di associazione mafiosa.
Quello stesso giorno di marzo, prefetto, partì dai suoi uffici una lettera, indirizzata al sindaco di Castelnuovo di Porto e al questore, nella quale si segnalava la disponibilità di una delle coop di Buzzi ad accogliere i richiedenti asilo. E ora è finito sotto accusa per questa coincidenza temporale.
"Trattare così questa vicenda la giudico una carognata, una pugnalata alle spalle".
L'incontro e la lettera, però, ci sono stati?
"Sì, certo. Ma quella lettera non è l'unica di quel giorno. Sono state inviate a tutti i sindaci e a tutti gli enti con posti disponibili con posti disponibili o del consiglio territoriale per l'immigrazione. E tra queste c'è anche la 29 giugno di Buzzi".
Dalle carte della procura emerge che quel pomeriggio lei ha incontrato il capo della 29 giugno dopo l'interessamento dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta.
"A marzo Buzzi non sapevo neanche chi fosse. Io l'ho ricevuto sulla base del rispetto che ho per la persona che me l'ha mandato. E devo ammettere che avevo pure rimosso quell'incontro. Mi sono ricordato di lui e di averlo ricevuto solo quando ho letto l'ordinanza".
Ma è prassi che un prefetto riceva il rappresentante di una cooperativa e non anche gli altri?
"Vedere i presidenti delle associazioni è una cosa normale, soprattutto se si tratta di presidenti di cooperative che collaborano con la prefettura. Non sa quante volte ho incontrato monsignor Feroci della Caritas, così come molti altri".
E cosa disse a Buzzi?
"Gli dissi che per Castelnuovo non c'erano possibilità e non potevo cambiare idea. Il mio è stato un no motivato perché lì esisteva già il Cara, il centro per richiedenti asilo, e quel Comune non era in grado di ricevere nuovi immigrati. Tra l'altro, anche il sindaco di Castelnuovo si era sempre lamentato dell'alto numero delle persone nel centro".
E allora come si spiega che Buzzi esce dal suo incontro e, al telefono, racconta che era andato tutto bene? Millantava?
"Questo non lo posso sapere. Forse avrà pensato che avrebbe potuto provare a fare pressioni sul sindaco di Castelnuovo o credeva di poter nuovamente passare per Letta".
Cosa che fece?
"No, Letta l'ho sentito io, subito dopo quell'incontro".
E cosa gli disse?
""Ma chi mi hai mandato?"".
E lui?
""Non lo farò più", mi rispose. E, in effetti, né lui né nessun altro mi ha mai più parlato di Buzzi".
Disse così a Letta perché Buzzi non le fece una buona impressione?
"Sì, non mi aveva convinto particolarmente".
La commissione antimafia potrebbe doverla risentire.
"Ho parlato con la presidente Rosy Bindi, le ho dato la mia massima disponibilità. In ogni caso, loro hanno già la documentazione che dimostra come a quella lettera non fu poi dato alcun seguito".
La storia, dunque, è chiusa?
"Per me sì. Ovviamente gli articoli di giornale usciti in questi giorni verranno valutati dai miei avvocati".
Chi è Giuseppe Pecoraro, il prefetto in guerra che bisticcia con Marino e fa il commissario di se stesso. Lo schizzo di fango da “mafia capitale”, il lungo e difficile rapporto con il Comune di Roma, gli scazzi sulla monnezza e l’assenza di “avveduta precauzione” sciasciana, scrive Marianna Rizzini su “Il Foglio”. Prefetto lo è, Giuseppe Pecoraro, burocrate di lunga carriera ma di non evidente propensione a vestire i panni del classico prefetto: l’uomo uguale fra tanti uomini uguali, rassicurante funzionario al servizio dello stato, ventriloquo della direttiva superiore che, quando è eroe (nei film), lo è alla maniera del “prefetto di ferro” di Pasquale Squitieri con Giuliano Gemma: un uomo che per non adeguarsi ai poteri grigi viene infine promosso (e di fatto rimosso). Il prefetto Pecoraro non soltanto è, di questi tempi, necessariamente diverso dai suoi simili che lavorano nell’ombra discreta delle stanze prefettizie, ché lo si trova un giorno sì e l’altro pure sui giornali per una divergenza di opinioni con il sindaco di Roma Ignazio Marino (sulle nozze gay come sulla cosiddetta mafia capitale) o per quella visita che Salvatore Buzzi, presunto co-boss al fianco di Massimo Carminati, tributò proprio al prefetto, a proposito di un centro accoglienza in quel di Castelnuovo di Porto. C’è poi che il prefetto Pecoraro, prima di tutto per fisiognomica, poco si adatta all’immagine di prefetto alla Elio Petri (quello che in “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” si presenta col fazzoletto bianco nel taschino identico a quello degli altri innumerevoli prefetti in fila con abiti indistinguibili). Si dà il caso, infatti, che Pecoraro abbia sembianze e movenze da sceriffo più che da protagonista meticoloso di riti da vecchia provincia – indimenticabile resta il prefetto che non vuole farsi trasferire nonostante la sequela di scocciature in “L’ultima provincia” di Luisa Adorno, libro Sellerio adorato da Leonardo Sciascia, ritratto di prefetto e prefettessa nell’aria immobile di una Toscana-deserto dei tartari, dove il Natale si trasforma in incubo di notabili in visita e teorie di dame relegate nella stanza “a parte”, quella delle donne, a parlare del più e del meno incrociando le piume dei cappelli. “Avveduta precauzione” dei prefetti, la chiamava Sciascia in “Invenzione di una prefettura”, una piccola storia della prefettura di Ragusa, e chissà se Pecoraro, col senno del poi, vorrebbe averla avuta, quella “avveduta precauzione”. Fatto sta che oggi il prefetto dice che sì, Buzzi l’ha ricevuto per rispetto verso l’ex sottosegretario Gianni Letta che gliel’aveva inviato, ma che dopo averlo ricevuto ha prontamente telefonato a Letta per lamentarsene (“chi mi hai spedito?”) e Letta poi se n’è quasi scusato (“non lo farò più”). E dice il prefetto che, dopo la visita di Buzzi, aveva sì inviato una lettera al sindaco di Castelnuovo di Porto in cui si segnalava la disponibilità di una delle coop di Buzzi ad accogliere i richiedenti asilo, ma che “trattare così questa vicenda”, com’è stata trattata in questi giorni sui giornali, con tanto di titoli su di lui, il prefetto, “è una carognata e una pugnalata alle spalle”, perché quella lettera era stata inviata in automatico e ce n’erano altre dello stesso tenore inviate a Guidonia, a Ciampino, a Rocca Priora, ad Anguillara “e, in copia, alla Questura”. Lungi dal risparmiare dalle luci della ribalta il prefetto, figura tradizionalmente destinata alle pur gloriose penombre della burocrazia, ieri il Corriere della Sera, a firma Fiorenza Sarzanini, raccontava della “gara europea bandita dalla prefettura di Roma” nel 2013 e vinta da una delle coop di Buzzi (la Eriches 29) per gestire il centro accoglienza della discordia (quello di Castelnuovo di Porto) e dell’“esposto del prefetto”, così si leggeva sul Corriere, “contro il giudice Tar ‘nemico’ della coop” di Buzzi. Tuttavia non era cosa inconsueta, per Pecoraro, il ritrovarsi alla ribalta. E’ capitato infatti, pochi giorni fa, che Pecoraro comparisse sul Messaggero, intervistato come parte in causa nella infinita querelle con il sindaco Marino (“se non sapeva il prefetto, che ricevette il capo delle coop, come potevo sapere io”?, aveva detto Marino, e Pecoraro avevo risposto senza salamelecchi prefettizi: “Buzzi era estraneo ai miei uffici; nell’amministrazione Marino, invece, ci sono tre indagati”). E non basta: qualche giorno dopo il prefetto, al giornale RadioRai, aveva parlato della commissione d’accesso agli atti del Comune. Scherzo della sorte vuole, infatti, che Pecoraro sia al tempo stesso l’uomo dell’incontro in prefettura con Buzzi ma anche e soprattutto l’uomo che controlla chi con Buzzi avesse a che fare: dalla prefettura provengono i commissari che devono leggere gli atti del Campidoglio in vista della relazione sul tema “infiltrazioni criminali” al Comune di Roma (in teoria anche a rischio scioglimento). E alla radio il prefetto se ne usciva con la profezia che molto faceva indispettire il sindaco: “… Può venire fuori che ci sia la necessità di uno scioglimento…”, diceva Pecoraro; “immagino che il prefetto sappia molte cose e non le possa dire proprio perché fa il prefetto… ”, diceva Marino. E Matteo Orfini, commissario per il Pd romano, su Twitter scriveva che il prefetto gli pareva intento, ultimamente, a “fare più dichiarazioni e interviste di Matteo Salvini”. “Il ministro Alfano venga in Aula a riferire e valuti l’opportunità di avvicendare il prefetto Pecoraro dopo otto anni di permanenza nella capitale”, dicono intanto, da Sel, i deputati Arturo Scotto e Filiberto Zaratti, mentre il consigliere radicale Riccardo Magi fa notare che “alcuni dei fatti più gravi su cui si indaga”, per esempio per quanto riguarda affidamenti e campi rom, “sono avvenuti in regime commissariale per l’emergenza rom. Non è che il commissariamento mette al riparo dall’illegalità”. Nemmeno nei momenti di massima insofferenza per le processioni locali in cui si dovevano fare passettini accanto a preti e autorità “all’andatura del santo”, e lasciare che la banda “rintronasse il cervello”, il prefetto defilato de “L’ultima provincia” avrebbe potuto immaginare di assurgere al livello di visibilità cui è assurto Pecoraro (e non da oggi). Il prefetto, infatti, è già stato, in tempi di governo Berlusconi (ministro dell’Interno Roberto Maroni), “commissario delegato per il superamento dell’emergenza rom” per la regione Lazio e la città di Roma, e commissario all’emergenza rifiuti in tempi di Comune guidato da Gianni Alemanno e di Regione guidata da Renata Polverini. “Prefetto in guerra”, lo chiama Massimiliano Iervolino nel libro “Roma, la guerra dei rifiuti”, in cui si narra la vicenda della tentata “sostituzione” della discarica di Malagrotta e della ricerca di un sito alternativo (molti vip contestarono il prefetto per via dell’ipotesi Corcolle, nei pressi di Villa Adriana. Si mobilitarono Giorgio Albertazzi, Franca Valeri e Urbano Barberini, quest’ultimo al grido di “è come mettere i rifiuti a Luxor o alle Piramidi”). Alla fine il prefetto si dimise da commissario per l’emergenza rifiuti, senza rinunciare a essere prefetto a modo suo. (Intanto dovrà pronunciarsi, dopo aver ricevuto le “memorie” delle aziende coinvolte, sui primi due commissariamenti di appalti decisi da Raffaele Cantone, presidente dell’Authority anti-corruzione).
Manca un progetto. E Totti è l’alibi della grande schifezza, scrive Sandro Medici su “Il Manifesto”. Marino e la nuova giunta di Roma. Non bastano gli assessori-commissari. E il pm Sabella arriva. Il sindaco Ignazio Marino prova a ripartire. Rinnova la sua giunta e tratteggia quel che d’ora in poi dovrebbe connotare la sua amministrazione: impegno a perdifiato e legalità assoluta. Un nuovo inizio. Con cui si tenterà di riprendere quel faticoso cammino che finora non è apparso particolarmente smagliante, e con cui si proverà a bonificare quel grumo politicomafioso che ha insidiato e a tratti aggredito il Campidoglio. I tre nuovi assessori, più gli altri tre subentrati nei mesi scorsi, hanno ridisegnato sensibilmente l’assetto iniziale: e non sfugge che siano l’esito dei tanti tormenti che hanno attraversato la politica comunale. Al di là delle singole soggettività, tutto questo rimescolamento è la rappresentazione di quanto sia ancora precaria e incerta la prospettiva su cui la città dovrebbe ritrovare fiducia e convinzione. Tra annunci e rassicurazioni, sorrisi e pochi applausi, Roma continua a non avere una strategia di sviluppo, un progetto di rilancio, una visione generale sul suo futuro. È doveroso insistere sulla necessità di superare il trauma politico-criminale che ha investito la politica amministrativa. Anzi, è obbligatorio: c’è da recuperare una credibilità infranta e smarrita. Ma è davvero inevitabile affidarsi a una pletora di commissari, tutori, garanti e supervisori? Forse la politica (almeno a Roma) non è più nelle condizioni di reagire e di responsabilizzarsi. Ma allora, viene da chiedersi, cos’è diventata la politica (almeno a Roma)? L’impressione è che, già esile in partenza, l’amministrazione Marino si sia ulteriormente indebolita: sfiorata dalle pratiche corruttive ereditate dal passato, ma anche per limiti propri. Ed è difficile che l’ingresso di un magistrato in giunta possa migliorare l’impronta politica del Campidoglio. Anzi. Non foss’altro perché il neo-assessore alla legalità, oltre a vantare riconosciuti meriti antimafia, viene ricordato anche per la sua “negligenza” in occasione della terrificante repressione nel 2001, durante il G8 a Genova. L’Associazione Giuristi democratici ricorda che Alfonso Sabella era allora il coordinatore delle attività penitenziarie, comprese quelle nel carcere di Bolzaneto, dove ai molti fermati fu riservato un trattamento ai limiti della tortura. Tanto che in un’ordinanza del Tribunale di Genova viene definito «negligente nell’adempiere al proprio obbligo di controllo», poiché «non impedì il verificarsi di eventi che sarebbe stato suo obbligo evitare». Storie vecchie, certo. Ma comunque dolorose. Soprattutto perché rimandano alla contraddittorietà del profilo politico con cui il sindaco Marino connota la sua amministrazione, non senza imbarazzi nei ranghi della sua maggioranza, che tuttavia non provocano particolari sussulti. Una maggioranza che appare sostanzialmente obbligata a sostenere il suo sindaco: per le note vicende giudiziarie, ma anche perché paventa il pericolo che diversamente possa andar peggio. E così, senza dissensi né contrasti, si approvano politiche economiche antipopolari, si persiste nei processi di privatizzazione, si spengono le esperienze culturali indipendenti e diventa anche possibile approvare delibere inguardabili, come quella che l’altro ieri ha sancito l’utilità pubblica dello stadio della Roma. Per quanto si possa “amare” la squadra giallorossa, autorizzare l’edificazione di un milione di metricubi tra funzioni direzionali, commerciali e d’intrattenimento, sol perché necesari a realizare un impianto sportivo privato, non è precisamente catalogabile come vantaggio sociale o utilità pubblica. Eppure così è andata. Totti è un alibi perfetto per promuovere questa grande schifezza.
L’ombra di Bolzaneto sul nuovo assessore di Roma, scrive Damiano Aliprandi su “Il Garantista”. Gli spettri delle torture subite dai manifestanti contro il G8 a Genova si affacciano sul Campidoglio. E’ arrivato ieri sera l’ok del Csm per l’aspettativa che Alfonso Sabella, giudice presso il tribunale romano, attendeva per poter rispondere positivamente all’offerta di Ignazio Marino, il sindaco di Roma che lo ha voluto come assessore alla Legalità e alla Trasparenza dopo i fatti di Mafia Capitale. La nomina di Sabella viene oggi pesantemente criticata dall’associazione Giuristi Democratici di Roma che rievoca – tramite un comunicato – il ruolo avuto da Sabella durante il G8 di Genova. Il magistrato che a questo punto entrerà nel governo della Capitale della città – si legge nel comunicato dove i giuristi democratici esprimono perplessità riguardo l’idea di nominare Sabella assessore alla legalità- durante i fatti di Bolzaneto era il coordinatore “dell’organizzazione e del controllo su tutte le attività dell’amministrazione penitenziaria”, e dunque era anche deputato a sovrintendere su ciò che accadeva alla caserma Bixio. Per i fatti del G8 Sabella finì a processo e la sua posizione fu archiviata. Tuttavia, scriveva il Tribunale nell’archiviarlo, «il comportamento del dott. Sabella non fu adeguato alle necessità del momento. Egli fu infatti negligente nell’adempiere al proprio obbligo di controllo, imprudente nell’organizzare il servizio (…) imperito nel porre rimedio alle difficoltà manifestatesi»: così i giudici del Tribunale di Genova nella sua ordinanza del 24 gennaio 2007; e ancora: «Alfonso Sabella non adempì con la dovuta scrupolosa diligenza al proprio dovere di controllo e che, pur trovandosi nella speciale posizione di “garante” (…), non impedì il verificarsi di eventi che sarebbe stato suo obbligo evitare». La posizione di Sabella fu stralciata da quella degli altri imputati e per lui venne chiesto il non luogo a procedere. «A Bolzaneto vide che i detenuti erano tenuti in piedi con la faccia contro il muro, ma non fu testimone diretto delle violenze più gravi, né della loro sistematicità, quindi non avrebbe potuto impedirle», scrivevano i Pubblici Ministeri nel richiedere al Gip l’archiviazione per Sabella. Il giudice, dopo l’ordine di un supplemento di indagini a carico del magistrato, e nonostante l’avvocato di Sabella stesso avesse chiesto il processo, dispose l’archiviazione scrivendo nell’ordinanza le parole sopracitate. Ma la dichiarazione di Sabella che fece indignare all’epoca – e che oggi vengono ricordate dai Giuristi Democratici per sollecitare Ignazio Marino affinchè torni sui suoi passi – fu la sua opinione in merito all’operato degli agenti penitenziari durante le giornate terribili del G8 di Genova: secondo il magistrato Sabella il loro comportamento è stato «esemplare». I Giuristi Democratici di Roma infatti scrivono nel comunicato: «Sebbene l’operato del Dr. Sabella non sia stato ritenuto illecito, lo stesso non è stato ritenuto in grado di svolgere i ruoli organizzativi e di controllo sulla commissione di reati affidatigli, avendo per di più creduto alle giustificazioni di chi fu poi condannato per quei fatti gravissimi». E viene anche ricordata la frase di Sabella, pronunciata nel 2001: «Non ho alcuna intenzione di dimettermi. A Genova l’operato degli agenti penitenziari è stato esemplare»; secondo il magistrato, infatti, non sarebbero stati gli agenti penitenziari a picchiare i manifestanti durante il vertice genovese: «Qualcuno è stato. Ma i fermati sono arrivati alla caserma di Bolzaneto già ricoperti di ecchimosi», aggiungeva Sabella, allora, nell’intervista.
Mafia Capitale, penalisti contro assessore-pm Sabella: “Prassi pericolosa”, scrive F. Q. su “Il Fatto Quotidiano”. Oggi per la toga entrata in magistratura nel 1989 è arrivato il via libera dal Consiglio superiore della magistratura al 'prestito' in Campidoglio. Ad avviso dell’Unione delle camere penali "la magistratura si insedia all’interno della politica legittimando se stessa come unica garante della legalità, e dall’altro la politica dimostra con tali scelte di voler delegittimare se stessa". Da magistrato ha fatto scattare le manette ai polsi di pezzi da novanta di Cosa Nostra: da Leoluca Bagarella fino a Giovanni Brusca eppure la nomina di Alfonso Sabella all’assessorato alla Legalità di Roma viene considerata pericolosa dai penalisti. Oggi per la toga entrata in magistratura nel 1989 è arrivato il via libera dal Consiglio superiore della magistratura al ‘prestito’ in Campidoglio. Secondo l’Unione delle camere penali è una “prassi degenerativa assai pericolosa per gli equilibri democratici ed istituzionali quella dell’assunzione da parte della politica di magistrati antimafia all’interno delle amministrazioni territoriali, approvata dal Csm e sospinta dal favore popolare”. Ad avviso dell’Unione delle camere penali, “da un lato, al di fuori di ogni regolamentazione legislativa, la magistratura si insedia all’interno della politica legittimando se stessa come unica garante della legalità, e dall’altro la politica dimostra con tali scelte di voler delegittimare se stessa affermando la propria inadeguatezza e la propria incapacità di perseguire la legalità con i suoi propri strumenti e con le sue proprie forze”. L’ex sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo, guidato da Gian Carlo Caselli, sarà quindi il nuovo assessore alla Legalità della giunta di Ignazio Marino. Una figura di garanzia fortemente voluta dal primo cittadino dopo lo scandalo di Mafia Capitale. Sabella fu pm nel 1993, nel day after delle stragi mafiose che spazzano via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, senza mai iscriversi ad alcuna corrente della magistratura. Sabella è stato anche al vertice del Dap, dove aveva imposto una regolamentazione feroce delle spese. Il suo incarico dura appena due anni: nel 2001 a dirigere l’amministrazione penitenziaria arriva Giovanni Tinebra, e i due magistrati entrano subito in contrasto. Il risultato è che dopo pochi mesi Sabella viene allontanato su ordine diretto dell’allora Guardasigilli Roberto Castelli. Oggi il plenum del Csm ha dato l’ok a maggioranza al collocamento fuori ruolo con quattordici voti a favore, otto contrari e 3 gli astenuti. In particolare hanno votato contro molti consiglieri laici e i vertici della Cassazione, il primo presidente Giorgio Santacroce e il procuratore generale Gianfranco Ciani; si sono invece astenuti i togati Ercole Aprile e Maria Rosaria San Giorgio, oltre al consigliere laico Renato Balduzzi. “Ovviamente per me è una notizia molto positiva. Sabella credo abbia una competenza in materia anche amministrativa di appalti e contratti tale da poterci garantire che, ancora più di prima, con la nostra giunta tutto avverrà nella piena legalità e nella trasparenza” ha commentato il sindaco di Roma Ignazio Marino. “Si tratta di un magistrato con una reputazione straordinaria – aggiunge – e che ha lavorato al fianco di Gian Carlo Caselli per molti anni. Ha condotto alcune delle operazioni di contrasto alla mafia più importanti come l’arresto di Brusca”.
Comunque se i politici onesti son questi?
«Pd, rimborsi fasulli per 2,6 milioni» Sotto inchiesta 6 parlamentari laziali. Dopo il clamoroso caso Fiorito (Pdl), anche il centrosinistra colpito dalle indagini sui brogli nel bilanci del Lazio. La Procura di Rieti: ostriche, vecchie multe e olio con i fondi regionali 2010-2012; rimborsi maggiorati su taxi, biglietti ferroviari e aerei, scrivono Alessandro Capponi e Ilaria Sacchettoni su “Il Corriere della Sera”. Olio extravergine d’oliva soprattutto. Che, nel reatino, non sarà come in Liguria, ma è pur sempre d’origine controllata. Ma anche rimborsi per vecchie multe, cesti natalizi e le immancabili cene che (elettorali e no, anche a base di ostriche) sempre figurano in nota spese. Come ricostruito dai finanzieri del Tributario per la procura di Rieti, le «spese pazze» dei consiglieri regionali del Pd, fra il 2010 e il 2012, varrebbero 2 milioni e 600 mila euro. E se per i consiglieri pidiellini della giunta di Renata Polverini - Franco «Batman» Fiorito, il più rappresentativo - sono già scattate le prime condanne (o assoluzioni), ora potrebbe aprirsi il capitolo processuale che riguarda l’allora opposizione del Partito democratico. Perché gli investigatori coordinati dal procuratore Giuseppe Saieva sono prossimi alla notifica delle conclusione delle indagini a diverse persone. Sotto accusa l’intero gruppo Pd in Regione durante la consiliatura Polverini con accuse che vanno dal peculato, alla truffa aggravata, dal finanziamento illecito al falso. Una volta caduta la giunta Polverini, l’allora candidato del centrosinistra Nicola Zingaretti condusse una battaglia col partito per non far ripresentare in Regione neanche uno dei consiglieri uscenti. Così molti di loro, oggi sotto accusa, sono stati candidati direttamente in Parlamento. Fra gli indagati, infatti, ci sono gli attuali senatori Claudio Moscardelli, Bruno Astorre, Carlo Lucherini, Francesco Scalia e Daniela Valentini. Sotto inchiesta anche il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il cui nome era affiorato all’avvio delle indagini, così come quelli di Enzo Foschi - già nella segreteria del sindaco di Roma, Ignazio Marino - e del tesoriere Mario Perilli. Indagato anche il deputato Marco Di Stefano, già coinvolto in un’altra vicenda giudiziaria: è accusato di corruzione per fatti che risalgono alla giunta Marrazzo, quando da assessore al Demanio avrebbe intascato una tangente milionaria per alloggiare la società «Lazio Service» nei locali dei costruttori romani Pulcini. Un’inchiesta che ha intersecato anche il giallo della scomparsa del suo ex collaboratore Alfredo Guagnelli. Di Stefano e gli altri saranno ascoltati in Procura per rispondere a una serie di contestazioni. Secondo gli investigatori avrebbero chiesto al partito rimborsi maggiorati su spese ordinarie, da quella per il taxi ai biglietti ferroviari e aerei. In nota al partito anche spese ordinarie, pranzi e cene in ristoranti dal menu a base di pesce. Perfettamente bipartisan le ostriche: contestate ai consiglieri Pdl e ora in conto ai rappresentanti del Pd che le avrebbero mangiate vicino al Pantheon. In qualche caso si mascheravano singole elargizioni attraverso la formula delle collaborazioni occasionali che di fatto, per i pm, non sarebbero mai avvenute. Nel mirino degli investigatori anche rimborsi per murales nel quartiere popolare del Quadraro. Sul conto del partito in Regione sarebbero finiti pure il finanziamento di una serie di sagre paesane, di tornei di calcio e, per l’accusa, di attività non riconducibili alla politica.
Ostriche e fagiani, ecco gli sprechi del Pd. Chiusa l’inchiesta dei pm di Rieti sui rimborsi utilizzati per scopi privati Quarantuno gli indagati. Coinvolti 15 ex consiglieri della Regione Lazio, scrivono Augusto Parboni e Martino Villosio su “Il Tempo”. Pesce crudo e ostriche al Pantheon, tanto per andare sul classico. Ma anche guizzi più fantasiosi, come le battute di caccia e i fagiani gustati al ristorante, le sagre di provincia finanziate con i soldi dei rimborsi, lo sfizio di pubblicare la propria autobiografia messo in conto al Gruppo. Il campionario delle prodezze compiute con i soldi pubblici dai consiglieri regionali si aggiorna e impreziosisce di nuovi spunti, e stavolta il «merito» - in base alle accuse della procura di Rieti - è tutto del Gruppo Pd protagonista al consiglio regionale del Lazio nel triennio 2010-2012. Fiorito impazzava, la procura di Roma setacciava gli scontrini del gruppo Pdl alla Pisana, l’opposizione Pd guidata da Esterino Montino fremeva d’indignazione e chiedeva le dimissioni della giunta Polverini. Adesso però i magistrati di Rieti, partiti un anno e mezzo fa dalla denuncia di un blogger locale, hanno chiuso un’indagine corposissima, di cui nei mesi scorsi aveva parlato Il Tempo . E nelle loro carte, c’è l’epicentro di un nuovo devastante terremoto per l’immagine del Partito Democratico non solo a livello locale. L’elenco delle spese contestate ai 15 ex consiglieri regionali Pd indagati, cinque dei quali nel frattempo diventati senatori e due nel frattempo deceduti, è sterminato e imbarazzante. Ci sono i pranzi e le cene offerti ad amici e simpatizzanti, a colpi di otto, dieci e ventimila euro, certo. Ma anche, incredibile eppure vero, le battute di caccia a Fiumicino, dove c’è chi si fa fa mettere in conto perfino i 25 fagiani centrati dalle proprie doppiette e poi serviti in tavola, totale 50 coperti. Il direttore del circolo che ospitò il banchetto racconta alla Guardia di Finanza quella fondamentale riunione di partito: a un certo punto qualcuno si sarebbe alzato, avrebbe fatto un discorsetto elogiativo sul Pd, per poi rimettersi serenamente a mangiare. Col denaro altrui vengono pagate le multe della macchina, i biglietti per i viaggi personali in treno e in aereo, gli omaggi enogastronomici per le festività, gli addobbi per l’albero di Natale, l’olio extrovergine per cucinare a casa, financo la bottiglietta d’acqua da 0,45 centesimi. Vengono retribuiti soggetti incaricati di gestire i profili dei consiglieri sui social nerwork, si assumono familiari e conoscenti come portaborse violando ogni normativa vigente e pagando alcuni di loro senza che abbiano lavorato un solo giorno. C’è chi invece avrebbe sovvenzionato una sagra del tartufo con 5000 euro scrivendo sulla fattura «convegno». Chi è accusato di aver dato 8.000 euro per finanziare i graffiti del museo del Quadraro, a Roma. Una suora di Fara in Sabina chiede un contributo per gli immigrati e lo riceve segnando su un pezzo di carta «prestazione occasionale». Il tentativo di rinascita di Paese Sera, nel 2011, è finanziato con 26 mila euro senza uno straccio di contratto. Alcuni imprenditori emettono inoltre fatture per operazioni inesistenti o fatture gonfiatissime, per poi dividere con il consigliere amico. Mentre il sindaco di Rieti Simone Petrangeli, anche lui indagato, si sarebbe fatto regalare video e manifesti per la campagna elettorale. I 15 ex consiglieri avrebbero distratto con «spese non inerenti i fini istituzionali» 2 milioni e 600 mila euro, la metà dei fondi che la Regione ha versato al gruppo per quei 3 anni. Dopo 200 controlli incrociati e 300 testimoni ascoltati, i 13 rischiano il processo. Cinque sono oggi senatori: Bruno Astorre, Carlo Lucherini, Claudio Moscardelli, Francesco Scalia, Daniela Valentini. Spicca poi nel lungo elenco di questa chiusura indagini il nome di Marco Di Stefano, oggi deputato Pd già sulla graticola perché accusato di corruzione e altro dalla procura di Roma nell’inchiesta su Enpam. Avrebbe speso 36 mila euro per pubblicare 25 mila copie della sua autobiografia. L’ex tesoriere del gruppo, il reatino Mario Perilli (fulcro dell’inchiesta) avrebbe invece sovvenzionato la «famosa» sagra del tartufo con 5000 euro, L’ex capo segreteria del sindaco di Roma Marino, Enzo Foschi, i graffiti del Quadraro. Non manca il nome di Esterino Montino, grande fustigatore all’epoca dello scandalo Fiorito dai banchi del gruppo Pd alla Pisana, oggi sindaco di Fiumicino. Più o meno le accuse sono le stesse accuse per tutti, peculato, truffa aggravata, fatture false, illecito finanziamento. Gli indagati in totale sono 41, tra cui 23 collaboratori dei consiglieri Pd, mentre 16 persone sono state segnalate alla procura. Ci sono anche accertamenti in corso su 27 presunti evasori totali. Nell’inchiesta ci sono anche altri esponenti del Pd del Lazio, imprenditori, professionisti, fornitori, collaboratori. E non finisce qui, gli occhi della procura e della Guardia di Finanza di Rieti sono già puntati sulle spese di altri gruppi protagonisti della precedente consiliatura.
Chi ha paura di chiamarla mafia, scrive Francesco Merlo su “la Repubblica”. Il famoso "la mafia non esiste" si è trasformato in "la vera mafia sta altrove", ma negare la mafia rimane tipico della mafia, la prima prova a carico per applicare il 416 bis. Intanto perché i boss babbìano sempre. Dagli antenati don Calò e Genco Russo - "noi la chiamiamo amicizia" - sino ai nipotini Carminati e Diotallevi: "Eravamo degli straccioni, solo un gruppo di cani sciolti". E poco importa se il loro babbìo negazionista non si conclude con "baciamo le mani" ma con "li mortacci tua". Nell'idea che "questa non è mafia " c'è anche, e forse soprattutto, l'autodifesa di un mondo (di mezzo?) che non vuole scoprirsi e accettarsi come complice. "La mafia è diventata policentrica", disse il generale Dalla Chiesa a Giorgio Bocca e stava parlando di Catania, che a quell'epoca reagiva negando, formando comitati di difesa e contrapponendo l'antropologia levantina a quella araba, i carusi chiacchieroni e senza mistero "che uccidono con la risata" ai picciotti di panza e sottopanza con i piedi incretati, l'innocenza della truffa d'Oriente alla precisione della lupara d'Occidente. E poi Siracusa e Messina non potevano essere mafiose perché erano provincia babba. E a Reggio Calabria erano invece troppo anarchici, troppo Ciccio Franco, troppo umore di terremoto che non sopporta disciplina: feroci sì, ma di natura sregolati e strafottenti. E così via distinguendo sino a Roma appunto dove è subito arrivata, con la mafia, la disputa linguistica e storica sulla parola mafia perché, come insegna la teologia, la suprema astuzia del diavolo è far credere che non esiste. È vero che c'è una profondità di differenza, anche in termini di fuoco e di simboli, perché all'Atac non sono trovate teste di capretto mozzate né è stato usato il tritolo nella sede dell'Ama. Ma anche le diversità fanno mafia alimentando e non impoverendo la ricchezza del fenomeno criminale e dunque dei futuri studi comparati. Infatti sono già all'opera gli esperti che, a partire dall'oziosa ovvietà che Roma non è Palermo, stanno mettendo a confronto codici e grammatiche. E forse la prima grande novità è che Mafia Capitale non è la sciasciana linea della palma che sale verso Nord, ma è la geografia che scende. È Roma che, smottando verso Sud, è ormai diventata Mezzogiorno di suk e di illegalità. L'abusivismo di piazza Navona, la sporcizia per le strade, le buche, il centro storico assediato, le "croste" dei parcheggi in terza fila, la metropolitana senza decoro, i lavori pubblici eternamente incompiuti, la cultura come enorme baraccone di incompetenze, le esecuzioni per strada ... ... sono già identità meridionale e scenografia di mafia anche se l'Opera di Roma è al tempo stesso uguale e distinta dal Massimo di Palermo, e il Corviale è diversamente Zen, e Tor Sapienza (non) è Librino così come Carminati (non) è Matteo Messina Denaro ... Insomma la geografia non è filosofia e non si accontenta di surrogati, ma propone scenari nuovi. Il potere a Roma è relazione gnam gnam, e a Palermo è oppressione bum bum. A Roma l'affare si imbroglia e a Palermo si sbroglia. I circoli sul Tevere non sono cupi come le concessionarie d'auto di Santapaola ma anche a Catania, come adesso a Roma, i distributori di benzina (ricordate Calderone?) sono stati le scuole-quadri della mafia. A Roma i covi sono i bar, e la buvette del Campidoglio ha il ruolo che a Trapani ebbero le cliniche private di Aiello e Cuffaro. Certo, l'innocente e brava Serena Dandini, sponsorizzata dalla cooperativa di Buzzi, non ha lo stesso ruolo che i neomelodici hanno a Napoli, ma nella Roma delle relazioni la Melandri ha lavorato per 15 anni con l'amico commercialista Stefano Bravo che riciclava i soldi di Buzzi e Carminati. E Odevaine, prima ancora di diventare capo di gabinetto di Veltroni, era con lei in Legambiente. Ed è vero che il sindaco Marino non poteva sapere che la cooperativa di Buzzi era criminale. Ma perché ha accettato finanziamenti da un'azienda che faceva affari con il comune di Roma e a cui il Comune, dopo l'elezione, concesse a prezzi d'affitto stracciati i locali di Via Pomona? A Roma sono tutti "amici", ma non nel senso dell'omertà palermitana. Fra sacrestie e conferenze, Andreotti andava a trovare a Rebibbia il suo amico comunista Adriano Ossicini e gli portava le torte di mamma Rosa. E intanto frequentava la segreteria di Stato di Pio XII. Nella Roma dei ponti, "il ponte Andreotti" congiungeva il Vaticano e Botteghe Oscure. C'era di tutto in quel pezzo di storia contemporanea ma non c'era la mafia. C'era l'assassinio di Pecorelli, di cui furono accusati e poi assolti - guarda caso - Andreotti e Carminati. Ma non era ancora mafia. Tutto questo solo ora è diventato quel pasticcio meridionale che anima la terribile degradazione della politica, la sua resa alla mafia. Quel Pd criminale che ieri su Repubblica ci ha raccontato Giovanna Vitale è l'erede del partito comunista di Maurizio Ferrara, di Antonello Trombadori, di Giancarlo Pajetta, sino agli eroi della Resistenza e delle Fosse Ardeatine. Come può rassegnarsi alla mafia chi li ha conosciuti, chi ci credeva? Anche io, se fossi per famiglia, per amicizie o per storia, il custode di quel mondo negherei con sarcasmo che quell'apostolato civile possa essere diventato mafia. Buzzi, nell'intervista a Report del 2007, aveva il Quarto Stato dietro la scrivania perché la sua cooperativa, dove si incontravano i redenti e i dannati, è la degenerazione del cattocomunismo romano, della carità coniugata con la solidarietà di classe, della pietà e della mano tesa alla schiuma della terra. Come è possibile che il vecchio segretario di sezione di quel partito sia stato sostituito dal monatto manzoniano? Com'è possibile che il funzionario del sol dell'avvenire sia diventato il Caron Dimonio che traghetta e deruba le anime in pena verso la speranza? Credevano, quegli uomini, che i banditi fossero i ribelli primitivi da trasformare in rivoluzionari o in santi grazie al catechismo di Marx o al Vangelo di Gesù. Come si può accettare che, nel loro nome, i naufraghi siano oggi il pretesto per i più sordidi affaracci mafiosi? E sono paradigmi depistati persino quelli tolkieniani e dei Nar che, sebbene malviventi e fascisti, avevano comunque in testa un progetto di società, un brandello di idealismo, una distopia più che un'utopia. Quella spada giapponese di Carminati, per esempio, è tutto quel che gli resta dello squinternato armamentario culturale, da Evola a Guénon all'antimodernità del Samurai di Mishima con l'arma bianca, feticci anche per Alemanno che fu l'orsuto attor giovane del rautismo. Quel confuso ragazzo pugliese con il mito della romanità, che posava a ideologo, è il primo responsabile politico della Mafia Capitale, una sorta di Ciancimino de Roma, non si sa quanto consapevole. Come reagirebbe Almirante e cosa direbbe il pittoresco Teodoro Buontempo che dormiva in una Cinquecento? La destra degenerata in mafia è una triste novità romana che a Palermo non si era mai vista e che seppellisce tutto il mondo degli ex camerati e fa deragliare anche il sogno di Giorgia Meloni, la reginetta di Coattonia, candidata sindaco dalla nuova Lega di Salvini. A Roma i fascisti a non sono più fascisti, sono mafiosi. Come si vede, a Roma anche la resistenza alla parola mafia è trasversale, è una larga intesa. A New York, prima di battezzare "mafia" la mafia la chiamavano "la mano nera". La mafia infatti non è mai un trapianto, non è un'emigrazione. E adesso è "romana de Roma", cioè una gran confusione circondata dalla storia come dal mare, uno stridio di uomini e un definitivo pervertimento di ideali apparentemente inconciliabili, un pascolo immenso sul quale non si ancora chi davvero ha regnato e chi regnerà. Ed è un melting pot che si preannuncia longevo e solido perché è vero che "natura non facit saltus", ma Roma lo ha fatto. La sua umanità bonaria e cinica ha preso la durezza e la violenza della mafia, ma in un'eternità di foresta.
Così Mafia Capitale voleva conquistare l'Italia. Tra tangenti, appalti e grazie a politici amici. Il clan di Massimo Carminati aveva il progetto di allargare i suoi interessi criminali all’intera Penisola, senza fermarsi alla città di Roma. Ecco attraverso quali personaggi e con quali alleanze puntava a "scalare" il Paese, scrive Lirio Abbate su “L’Espresso”. Sognavano di costruire un impero. Tra tangenti, ricatti e minacce, la “mafia Capitale” si sentiva in grado di arrivare ovunque. Continuava a impadronirsi di imprese, puntava agli appalti miliardari nel Lazio e in tutta Italia, mettendo a libro paga altri politici, altri burocrati, altri professionisti, altri dirigenti pubblici. Fino a tentare persino la scalata al Viminale. Ogni emergenza per loro si trasformava in denaro sonante. Emergenza neve, emergenza abitativa e soprattutto emergenza immigrati erano parole magiche, capaci di farli “spiottare”, ossia incassare subito milioni. Ma soprattutto di costruire altre alleanze oscure: nuovi ponti tra il “Mondo di Mezzo” e i piani alti del potere. Massimo Carminati è solo il vertice di questa piramide criminale, una vera associazione mafiosa nata e cresciuta nel cuore di Roma. Nell’ultimo decennio il “Nero” è riuscito a tra sformare una banda di eversori e rapinatori in una potente organizzazione che mostra sul territorio la capacità effettiva di incutere timore e soggezione attorno a sé, e in molti casi ha usato la forza dell’intimidazione per piegare uomini dei partiti, dello Stato e delle imprese. Ma l’arresto dell’estremista di destra e di altre 36 persone è solo la prima scossa di un terremoto che avrà ripercussioni per molti mesi. I magistrati guidati dal procuratore Giuseppe Pignatone e dall’aggiunto Michele Prestipino hanno iscritto su l registro degli indagati un centinaio di persone per reati collegati alla mafia, fra loro anche l’ex sindaco Gianni Alemanno. La trascrizione di un anno e mezzo di intercettazioni mostra uno spaccato del malaffare romano che va oltre, mostrando rapporti incredibili tra grandi imprenditori e boss della strada, tra politici e pregiudicati. È Roma Capoccia, che non ammette presenze meridionali: nessun emissario di ’ndrangheta, camorra o Cosa nostra era ammesso. Per entrare nel loro territorio i padrini dovevano venire a patti, con accordi che saranno oggetto delle prossime fasi dell’inchiesta. Il lavoro dei pm Paolo Ielo, Giuseppe Cascini e Luca Tescaroli è solo all’inizio. Ci sono ancora altri complici imprenditoriali e criminali nella rete di Carminati su cui si indaga. E c’è un tesoro da recuperare in giro per i continenti. Il boss si vantava di mettere da parte un milione l’anno (ma gli investigatori pensano che siano decine all’anno), denaro investito soprattutto all’estero per non creare sospetti: è l’oro di Roma sulle cui tracce si sono messi gli uomini del Ros dei Carabinieri e della Guardia di finanza. In questa storia di mafia non ci sono coppole e lupare, ma una schiera di persone perbene che consapevolmente si mettono al servizio della rete di Carminati. La figura forse più inquietante è quella di Luca Odevaine, 58 anni: dal 2001 vice capo di gabinetto del sindaco Walter Veltroni, poi nominato da Nicola Zingaretti direttore di polizia e protezione civile della provincia di Roma. Siede nei comitati nazionali che devono trovare una sistemazione per i profughi che attraversano il Mediterraneo. L’affare più ricco, perché come dice Salvatore Buzzi, presidente della cooperativa “29 giugno” e braccio destro di Carminati, «con gli immigrati si guadagna più del traffico di droga». Odevaine viene chiamato «il Padrone» per la sua capacità di influire sullo smistamento dei profughi e sull’accreditamento dei centri di accoglienza. Più ne sbarcano, più strutture servono e ogni persona vale 35 euro al giorno. Con l’operazione Mare Nostrum il ritmo diventa frenetico: i centri vengono riempiti nel giro di pochi giorni. È una miniera d’oro: 150 milioni di euro da incassare, praticamente senza controlli. Odevaine sostiene di avere convinto il prefetto Morcone - con cui dice di avere preso appuntamento tramite Veltroni - a concentrare i flussi sulle regioni centro-meridionali «tanto al Nord non li vogliono». E spinge Buzzi ad aprire altre strutture di accoglienza in Sicilia, Lazio, Campania. Al telefono se ne citano almeno sette gestite dagli accoliti di Mafia Capitale. Creano un accordo con la più potente arciconfraternita religiosa impegnata nell’assistenza, spartendosi alcuni contratti e ipotizzando interventi del Vicariato di Roma su Alfano per smuovere altre commesse. Odevaine invece grazie al suo ruolo parla con tutti i responsabili del Viminale. È esperto, si mostra efficiente: offre soluzioni ai dirigenti del ministero, ai sindaci e alle imprese. E intasca soldi nella sede della sua fondazione personale. Nelle indagini è stata filmata anche la consegna di una misteriosa busta da parte di un alto dirigente de La Cascina, azienda legata alla Compagnia delle Opere ciellina. Una relazione preziosa, che sembra aprire le porte per altri business. Come i subappalti dell’Expo milanese. E soprattutto gli appalti negli ospedali della Regione Lazio: un contratto colossale, quasi 200 milioni. Si discute di entrare nella partita grazie all’accordo tra Compagnia delle Opere e coop rosse, cavalcando il feeling politico tra Pd e Ncd che ispira il governo nazionale, dove il consorzio ciellino poteva contare sulla benevolenza dei ministri Alfano e Lupi. I soci di Carminati dovevano garantire l’operatività su Roma. E il boss parla del modo di arrivare a Nicola Zingaretti e al suo staff per accaparrarsi l’affare. Puntano pure sul premier Renzi, senza riuscire ad avvicinarlo. Ma Buzzi comunque contribuisce alla cena di finanziamento capitolina del presidente del Consiglio: un evento tenuto all’Eur, poco lontano da quel fungo di cemento dove trent’anni fa nacque il gruppo neofascista che ancora domina la capitale. Odevaine fa le cose in grande. Ed è lui a spiegare che per il salto di qualità la rete romana deve trovare alleati imprenditoriali. Discute di contratti enormi, che finora non sono stati oggetto di indagine, come quello per il centro immigrati di Mineo, il più grande di tutti. «I Pizzarotti sono impresa importante di Parma, molto amici di Gianni Letta, di Berlusconi. Da quello che ho capito hanno fatto un accordo perché Lupi, il ministro Lupi gli ha sbloccato due o tre appalti grossi…». Valuta in parecchi milioni il vantaggio ottenuto dall’azienda parmense. Poi su un’altra gara per i rifugiati Odevaine assicura: «Il presidente della Commissione lo faccio io… è una gara finta». Mafia Capitale, come in precedenza la banda della Magliana, ha continuato ad avere rapporti con Cosa nostra, ’ndrangheta e camorra. Gli investigatori del Ros lo scrivono nelle loro informative ai pm: «le altre organizzazioni criminali presenti nel territorio riconoscevano la forza del sodalizio diretto da Carminati». Chiunque volesse fare affari all’interno del grande raccordo anulare, doveva chiedere il permesso al “Cecato”. Perché qui è lui che comanda. E si scopre che il referente di Cosa nostra a Roma è il vecchio Ernesto Diotallevi, che si definisce in una intercettazione il «capo dei capi». Lui è legato a Riina e ai mafiosi siciliani fin dai tempi di Pippo Calò. Anche lui pare in grado di arrivare a chiunque. Mario Diotallevi, figlio del boss, intercettato lo scorso anno mentre parla con il padre, gli riferisce che avrebbe avuto un appuntamento con Aurelio De Laurentiis «al quale avrebbe proposto di acquistare la villa di Cavallo da destinare ad un giocatore del Napoli calcio».Cosa nostra è ben rappresentata da boss palermitani che hanno lasciato l’isola e si sono trasferiti all’ombra del Colosseo. I siciliani avrebbero fornito a Carminati sicari per commettere omicidi, ma anche appoggio “logistico”: se servivano armi i picciotti sapevano a quale porta bussare. Racconta un collaboratore di giustizia che il gruppo del siciliano Benedetto Spataro aveva anche effettuato “lavori” per conto di Carminati che, in una circostanza, aveva anche venduto ai catanesi delle armi. «Benedetto le ha prese da Carminati qui a Roma e le ha portate in Sicilia», ha dichiarato il pentito Sebastiano Cassia. I legami dell’ex Nar arrivano anche in Campania. A Michele Senese e a tutta la galassia a lui riconducibile. Ci sono legami con i fratelli Esposito, Salvatore e Genny, e con il figlio di quest’ultimo, Luigi, alias “Gigino a’ Nacchella”. Tutti e tre esponenti di spicco del clan camorristico facente capo alla famiglia Licciardi, già parte della “alleanza di Secondigliano”, e legatissima a Senese. Con loro la banda di Carminati faceva affari di piccolo calibro, ma vigeva un rapporto di mutuo soccorso. Non si pestavano i piedi, anzi, spesso si trovavano a condividere le stesse zone di influenza e a darsi una mano. Il 23 gennaio scorso i carabinieri del Ros registrano una conversazione nell’ufficio di una coop di Buzzi. Quest’ultimo racconta a Carminati un episodio che collega i romani con i calabresi e la ’ndrangheta. Buzzi, riferendosi ad un uomo della sua cooperativa, con orgoglio dice al “Cecato”: «... è tremendo.. gli ho visto fare una volta una trattativa con la ’ndrangheta... ce fai sparà gl’ ho detto.. a trattà su 5 lire … gl’ho detto scusa “e questo rompeva il cazzo” ce sparano sto giro... in piena Calabria!». Investigatori e magistrati evidenziano come in passato Carminati ha goduto della protezione «derivante da legami occulti con apparati istituzionali». I camerati di un tempo adesso hanno fatto carriera e sono diventati «rappresentanti politici o manager di enti pubblici economici». Lo spiega lo stesso boss in un’intercettazione: «Io a loro li conosco... c’ho fatto politica... ma poi ognuno ha preso la sua strada. Chi è diventato un bandito da strada, chi si è laureato... A quei tempi ci stava gente che adesso sta nell’ufficio studi della Banca d’Italia, ci sta Fabio Panetta che è il numero tre della Bce. L’unico della Banca d’Italia che si è portato Draghi. Io ci ho fatto le vacanze insieme per tutta la vita è uno dei miei migliori amici, ogni tanto mi chiama... mi ha chiamato proprio dopo l’articolo (de “l’Espresso” ndr), mi ha detto “a Ma’ sei sempre rimasto il solito bandito da strada”, mi ha detto. Gli ho detto “sì, tu sei sempre rimasto il solito stronzo che stai lì a leccare il culo alla Bce”». Panetta ha smentito rapporti recenti con “il Nero”. Ma le parole sono indicative delle relazioni che Carminati può vantare. «Ma lo sai perché Massimo è intoccabile?» dice in una telefonata alla compagna Salvatore Buzzi, «perché era lui che portava i soldi per Finmeccanica! Bustoni di soldi! A tutti li ha portati Massimo!». Alla sua compagna Alessandra Garrone, che come lui è stata arrestata, Buzzi racconta: «Massimo non mi dice i nomi perché non me li dice… Tutti! Finmeccanica! Ecco perché ogni tanto adesso… Quattro milioni dentro le buste! Alla fine mi ha detto Massimo “è sicuro che l’ho portati a tutti!’ tutti!”». La Garrone lo interrompe: «A tutto il Parlamento!». E lui precisa: «Pure a Rifondazione». Carminati si interessa molto alle vicende del gruppo statale. Disprezza Lorenzo Cola, il faccendiere legato ai vertici di Finmeccanica, per la collaborazione con i magistrati che ha fatto finire in cella il commercialista Iannilli, nella cui villa ha abitato fino all’ultimo. In occasione dell’arresto, è preoccupato che la moglie di Iannilli possa parlare con gli investigatori. E in effetti una relazione dei carabinieri riporta le confidenze fatte dalla donna. Al militare parla di come Lorenzo Cola avrebbe fatto consegnare somme di denaro all’amministratore delegato di Alenia. La moglie del commercialista svela che esiste una organizzazione che ha forma piramidale «a tre livelli: al vertice ci sarebbe Lorenzo Cola, al secondo livello ci sarebbero i “controllori”, non meglio identificati, al terzo livello ci sarebbe “l’esercito”, ovvero le persone come Iannilli. Cola, che avrebbe sempre utilizzato Iannilli come un bancomat, sarebbe arrivato ad estorcergli troppo denaro». E suo marito «nel corso degli anni è stato molto “generoso”, tanto che non avrebbe potuto più far fronte alle pretese di Cola e quindi si sarebbe rivolto a Massimo Carminati per ricevere protezione. Quest’ultimo si sarebbe presentato a Cola intimandogli di desistere dalle sue intenzioni». La donna ha dipinto Carminati «come un uomo che ha aiutato lei e la sua famiglia in un momento di grande difficoltà, affermando che non è un “bandito di strada”, è “omologo” di La Russa ed Alemanno, avendo scelto “la strada anziché il Parlamento, ma che “... è uno di loro...”». Ecco, il Mondo di Mezzo, appunto.
Mafia Capitale, Carminati e i dossier scomparsi nel 1999. Il misterioso furto al caveau della Banca di Roma del Tribunale di Roma fa da sfondo all'inchiesta capitolina, scrive Sabino Labia su “Panorama”. In una delle ultime intercettazioni relative all’inchiesta di Mafia Capitale si sente Massimo Carminati parlare il 27 gennaio 2012, con un’altra persona, del Procuratore Capo di Roma Giuseppe Pignatone e dei rischi del suo arrivo alla Procura romana per tutta l’organizzazione perché avrebbe buttato all’aria Roma visto che in Calabria ha capottato tutto e non si fa inglobà dalla politica. Tra il finto stupore generale e lo sgomento che sta provocando questa inchiesta, c’è anche l’anomala, per usare un eufemismo, vicenda di come Carminati, un personaggio dall’oscuro passato, sia uscito sempre indenne da tutte le inchieste che lo hanno coinvolto. Per quale motivo il Guercio si preoccupa proprio dell’arrivo di un giudice completamente estraneo al mondo romano e, soprattutto, dal curriculum di vero servitore dello Stato? E’ sufficiente rileggere la cronaca di qualche anno fa per avere un’idea. C’è una strana storia a fare da sfondo a tutta questa sporca vicenda e che suscita una certa inquietudine. Risale al 1999 e traccia in maniera precisa e inequivocabile il ruolo di Carminati a Roma.
Il furton al caveau della Banca di Roma del Tribunale. E’ il 16 luglio ed è un venerdì, intorno alle 18un furgone blu con il tetto bianco, simile a quelli usati dai carabinieri, ma con la differenza che si tratta di un comune furgone preso a nolo e ridipinto, supera uno dei cancelli del Tribunale della Capitale. Scendono tre uomini e con naturalezza si confondono tra le tantissime persone che in quel momento affollano la cittadella della Giustizia che dispone di quattro palazzi di cinque piani e di quattro ingressi. Alle 14 i due accessi laterali vengono regolarmente chiusi. Alle 20 gli addetti alla sicurezza chiudono l’entrata principale di Piazzale Clodio; a quel punto rimane aperto un solo varco, sul retro, in via Varisco, dove staziona un carabiniere di guardia. Tutti i visitatori, nel frattempo, sono usciti tranne i tre uomini che sono riusciti a nascondersi chissà dove. Passano tre ore e, alle 23, muniti di torce escono dal nascondiglio e si dirigono verso lo sportello della Banca di Roma che si trova nel corridoio della Pretura Penale e che dista soltanto 70 metri dal Commissariato di Polizia interno al Tribunale dove staziona sempre un poliziotto di guardia. Nel giro di quindici minuti i tre, muniti di chiavi false, aprono la porta blindata della banca e con un by-pass elettronico disinnescano il sistema d’allarme collegato al 113 e a un istituto di vigilanza privato. Si dirigono al cancello che dà accesso a due rampe di scale, scendono velocemente e arrivano a un’altra porta blindata, la aprono ed entrano nel caveau. All’interno ci sono 997 cassette di sicurezza, ma l’obiettivo dei tre sono solo 197 cassette segnate con una crocetta rossa da qualche complice che si è preoccupato di svolgere il proprio compito in precedenza. Con una grossa pinza le aprono e trasferiscono il contenuto di 174 cassette in 25 borsoni che si erano portati dietro. Le altre 23 cassette aperte rimangono intatte, forse non interessava il contenuto. Dopo due ore di operazione i tre escono dal caveau e attendono nascosti che alle 3 arrivi il quarto complice con l’auto all’uscita laterale di via Strozzi, un’entrata chiusa da oltre un mese per motivi di sicurezza e utilizzata solo dai magistrati; rompono il lucchetto ed escono. Si fermano a un bar per fare colazione e subito dopo si disperdono nel caldo della notte romana. Alle 6,40 di sabato 17 la donna delle pulizie dà l’allarme. I primi poliziotti che accorrono trovano alcuni pezzi dell’attrezzatura: guanti, piedi di porco e cacciaviti. Manca solo l’estrattore, l’attrezzo utilizzato per scardinare le cassette. Fino a quel momento il caveau della Banca di Roma situato all’interno del Tribunale era considerato una sorta di Fort Knox per la sua sicurezza ma, nel giro di poche ore, è diventato il luogo più insicuro al mondo situato nell’ormai famoso porto delle nebbie (il nome dato al Tribunale della Capitale per come molte inchieste finivano insabbiate tra gli anni ’70 e gli anni ’90). E anche questa storia sembra subire la medesima sorte. Le prime notizie raccontano di un bottino composto da documenti, due chili di cocaina, gioielli per cinquanta miliardi, cinque quintali d’oro e soldi per dieci miliardi di lire. Quello che più inquieta è che i proprietari delle cassette erano magistrati, avvocati e dipendenti del Tribunale. Le prime reazioni sono tra il comico e il grottesco, ma nessuno immagina quello che si scoprirà di lì a qualche mese. A occuparsi dell’inchiesta è, per competenza, la Procura di Perugia che a dicembre dello stesso anno traccia le prime conclusioni. Secondo i magistrati umbri Silvia Della Monica e Mario Palazzi il palazzo di Giustizia romano era, da almeno un anno e mezzo, in mano a Massimo Carminati, (che nel frattempo è stato arrestato, e che in quei giorni era anche accusato di essere l’autore materiale dell’omicidio di Mino Pecorelli poi assolto), e altri tre complici esperti nell’apertura di cassette di sicurezza. Nel corso di questo arco di tempo il Guercio, che secondo i giudici era più interessato ai documenti che al contante, aveva avuto libero accesso oltre che al caveau anche ad alcuni uffici, compresi quelli del sesto piano dove si trovano le sale d’ascolto per le intercettazioni. A fare queste rivelazioni sono due carabinieri che confessano di essere stati i complici della banda. Passano i giorni e la storia del furto si tinge sempre più di giallo. A un anno di distanza i giudici scoprono che non si sarebbe trattato di un semplice furto di una banda di ladri, anche perché di banche a Roma c’è l’imbarazzo della scelta, ma di un preciso colpo su commissione realizzato per ricattare alcuni personaggi. I protagonisti della vicenda sono carabinieri corrotti, esponenti della Banda della Magliana, un cassiere di banca, un impiegato del Ministero della Giustizia, un avvocato massone e, perché non manca mai, un collaboratore dei Servizi Segreti. Detto che di quel bottino e di quei documenti non si è avuta più traccia, a quindici anni di distanza Massimo Carminati si è preoccupato dell’arrivo di Pignatone a Roma perché avrebbe messo ordine soprattutto al porto delle nebbie.
Il Guercio nella terra dei ciechi e tutte le storie di Mafia Capitale, scrive Mariagrazia Gerina su “Internazionale”. Roma sotto inchiesta per mafia. Non più capitale ma “mondo di mezzo”, dove tutto si rimescola: affari, criminalità e politica. La procura di Roma che un tempo era definita il “porto delle nebbie” ha deciso di riscrivere la storia della città. Cento indagati, i palazzi della politica perquisiti, mille e centoventitré pagine fitte di intercettazioni, di nomi, di mazzette. Da cinque giorni, tutti le compulsano ossessivamente. Sono pagine che fanno a pezzi la politica romana, rischiano di distruggerne la credibilità. Hanno provocato finora reazioni scomposte, dichiarazioni d’innocenza anche da parte di chi non era indagato, dimissioni. La confusione regna. Il Partito democratico (Pd) di Roma è stato commissariato, la regione Lazio ha bloccato tutte le gare d’appalto, in Campidoglio si pensa a una giunta d’emergenza “capitale” con dentro il Movimento 5 stelle per allontanare il rischio di scioglimento del comune. Il presidente del consiglio, Matteo Renzi, invoca: processi subito. Già perché in quel migliaio e passa di pagine c’è di tutto, ma non ci sono ancora condanne o assoluzioni. Eppure da lì bisogna ripartire per diradare le nebbie del mondo di mezzo. Dai nomi, dai soldi, dalle intercettazioni. E da quello che di questa inchiesta, fin qui, è stato scritto. Nel film Johnny Stecchino (1991), il comico toscano Roberto Benigni raccontava la mafia con una battuta: “La piaga di Palermo è il traffico”. Adesso finalmente è chiaro che anche a Roma il problema non sono i varchi elettronici e le multe. C’è voluta una corposissima ordinanza con i suoi 100 indagati e 37 arresti, perché tutti si svegliassero una mattina, il 2 dicembre, per leggere nero su bianco: a Roma c’è la mafia. Ed è arrivata fino al Campidoglio. Qualche anno fa, sembrava quasi sconveniente nominarla. Si cominciò a parlare di “Quinta mafia” a metà degli anni duemila per il basso Lazio. Mentre a Roma si era già diffuso il contagio. Adesso bisogna fare i conti con la “Mafia Capitale”. Una mafia “originale” e “originaria”, perché nasce a Roma ed è diversa da tutte le altre. Ha dalla sua la fluidità della criminalità romana: armata e per questo temibile. Così la descrive Flavia Costantini, il giudice per le indagini preliminari, che ha dato questo nome alla nuova organizzazione. In cima, Massimo Carminati, il primo nella lista degli arresti, er Cecato o anche il Pirata (per la ferita all’occhio), l’ex militante dei Nuclei armati rivoluzionari, che aggiorna antichi rapporti per tenere in pugno il Campidoglio. Negli anni settanta si muoveva con scaltrezza tra l’estrema destra armata e la banda della Magliana, negli anni duemila è il “Re di Roma”, come lo definisce il giornalista dell’Espresso Lirio Abbate, capace di mettere d’accordo i clan, ma anche di ottenere informazioni da poliziotti infedeli. È lui, secondo Flavia Costantini, il “capo indiscusso di Mafia Capitale”. Carminati può disporre direttamente anche di alcuni dei più stretti collaboratori del sindaco Alemanno, controlla politici e imprenditori, estorsioni e appalti comunali. La storia della nuova consorteria tracciata dal giudice Flavia Costantini coincide con la sua biografia criminale, mutua le sue principali caratteristiche organizzative dalla banda della Magliana, ma “ha avuto la capacità di adattarsi alla particolarità delle condizioni storiche, politiche e istituzionali della città di Roma”. Dietro, c’è perfino una filosofia criminale. Quella ormai nota del “Mondo di mezzo”, da cui prende nome l’inchiesta condotta da Paolo Ielo, Giuseppe Cascini e Luca Tescaroli, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e dallo stesso procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone. Copyright di Massimo Carminati: “È la teoria del mondo di mezzo compà”, spiega l’ex terrorista in un monologo interrotto appena dagli “embè” e i “certo” dei suoi collaboratori: Ci stanno… come si dice… i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo in cui tutti si incontrano e dici cazzo come è possibile che quello… come è possibile che ne so che un domani io posso stare a cena con Berlusconi… cazzo è impossibile… capito come idea? … è quella che il mondo di mezzo è quello invece dove tutto si incontra… si incontrano tutti là… allora nel mezzo, anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno… e tutto si mischia… Quando la procura di Roma la intercetta, Mafia Capitale è già approdata alla “fase matura” e ha rimestato parecchio nel mondo di mezzo. A Roma, dal 2008, governa Gianni Alemanno, il primo sindaco della capitale che viene dall’estrema destra. Indagato, assicura di non aver mai conosciuto Carminati. Le intercettazioni raccontano invece i rapporti diretti del Pirata con alcuni dei suoi uomini di fiducia. Con il capo della sua segreteria, Antonio Lucarelli, ex Forza nuova. Con Luca Gramazio, allora capogruppo del Popolo della libertà. Lui e suo padre, Domenico Gramazio, vengono avvistati insieme a Carminati a piazza Tuscolo, alla fine del 2012. Discutono del bilancio comunale, ipotizzano gli inquirenti. Nel luglio del 2013 di nuovo tutti e tre sono a cena dar Bruttone. Un’altra volta è Luca Gramazio da solo a incontrare Carminati, che gli passa della documentazione. Sul campo rom di Castel Romano, ipotizzano i magistrati. Il rapporto più stretto der Cecato è con Riccardo Mancini, un passato di militanza nell’estrema destra, fino al 2012 amministratore delegato dell’azienda che gestisce i beni immobiliari dell’Eur, plenipotenziario del sindaco per i rapporti con gli imprenditori e della sua campagna elettorale nel 2008. “È lui che ce sta a passà i lavori buoni perché funzioni questa cosa”, confida Carminati a un uomo di fiducia. Il “grassottello”, lo apostrofa Carminati. Qualche volta non si comporta bene agli occhi dell’associazione: “Lo so, ma poi… io… gli ho menato, eh?”, rivendica con toni da boss. E se rinvia i pagamenti: “Mo’ ‘o famo strillà come un’aquila sgozzata”. Quando sa che sta per essere arrestato per la presunta tangente su un appalto del trasporto pubblico da 600mila euro, Carminati fa in modo di assicurarsi che non parli: “Se deve tenè er cecio ar culo”. Nel mondo di mezzo tra affari, criminalità e politica non c’è alcuna differenza di stato. Ed è da questa incredibile terza dimensione che spunta l’altro protagonista di Mafia Capitale, Salvatore Buzzi, l’uomo delle cooperative rosse romane che diventa sodale del Pirata. Una parabola quasi più sorprendente di quella di Carminati. La sua storia e quella della cooperativa di ex detenuti da lui fondata tocca il cuore della sinistra romana, prima ancora di arrivare a riempire il portafoglio di alcuni esponenti dell’attuale Partito democratico. La cooperativa 29 giugno, oggi una rete di cooperative che conta più di mille dipendenti, prende nome da un convegno sulle misure alternative al carcere che si tenne a Rebibbia nel 1984. Condannato per omicidio all’inizio degli anni ottanta, a Rebibbia Buzzi mette in scena con altri detenuti uno spettacolo, Antigone (“le leggi degli dèi sono più importanti delle leggi degli uomini…”), si lancia in una piccola impresa di imballaggio di pomodori, insomma, si comporta da “detenuto modello”, sotto gli auspici di Miriam Mafai, Laura Lombardo Radice e Pietro Ingrao, che ai pomodori di Rebibbia dedica addirittura un articolo sull’Unità. Uscito dal carcere, fonda la 29 giugno e grazie ad Angiolo Marroni – ala migliorista del partito romano e assessore al bilancio della provincia, suo vero mentore fin dal periodo del carcere – ottiene il primo appalto assegnato con grande urgenza per il taglio dell’erba sulla via Tiberina. Quasi trent’anni dopo, lo ritroviamo mattatore della scena. A capo di una “holding” che dà lavoro a 1.200 persone e fattura 59 milioni di euro. In queste ore spunta anche la sua presenza, poche settimane fa, alla cena romana di finanziamento del Partito democratico, con il segretario Matteo Renzi. Ma nell’inchiesta c’è la foto di un’altra cena, organizzata da Buzzi nel 2010: al suo tavolo siedono il presidente della Legacoop e futuro ministro Giuliano Poletti; il sindaco di Roma Gianni Alemanno; Franco Panzironi, al vertice della municipalizzata dei rifiuti; Luciano Casamonica; il futuro assessore alla casa della giunta guidata da Ignazio Marino, Daniele Ozzimo; e c’è, immancabile, Angiolo Marroni, diventato nel frattempo garante dei detenuti del Lazio, insieme al figlio Umberto, oggi deputato, all’epoca capogruppo dei democratici in Campidoglio. Buzzi ne ha fatta di strada. E ha un nuovo sodale che sa aprirgli, nella Roma governata da Alemanno, anche le porte per lui ancora chiuse. Si chiama Massimo Carminati, il “Re di Roma”. Per Buzzi: l’uomo che portava “i bustoni di soldi a Finmeccanica”. Buzzi ha difficoltà a parlare con il capo segreteria di Alemanno, Antonio Lucarelli, per farsi sbloccare un pagamento? “Allora chiamiamo Massimo”, racconta lo stesso Buzzi, “e faccio: ‘Guarda che qui c’ho difficoltà a farmi fa’… i trecentomila euro’”. A quel punto – prosegue il racconto, con tanto di dialoghi mimati – Carminati gli dice: “Va in Campidoglio, alle tre, che scende Lucarelli e viene parlare con te”. “Aò”, chiosa Buzzi, “alle tre meno cinque scende, dice ‘con Massimo, tutto a posto domani vai…’”. “Io c’ho i soldi suoi”, confida in un’altra intercettazione. “I soldi suoi, lui sai, m’ha detto quando… c’aveva paura che l’arrestavano perché se l’arrestava… se parlava quello il prossimo era lui poi…”. E ancora racconta che Carminati gli avrebbe detto: “Guarda qualunque cosa succede ce l’hai te, li tieni te e li gestisci te, non li devi dà a nessuno, a chiunque venisse qui da te… nemmeno mia moglie”. E aggiunge: “Non so’ soddisfazioni?”. Il ruolo che gli inquirenti assegnano a Buzzi nell’associazione guidata da Carminati è quello di organizzatore: “Gestisce, per il tramite di una rete di cooperative, le attività economiche della associazione nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della accoglienza dei profughi e rifugiati, della manutenzione del verde pubblico e negli altri settori oggetto delle gare pubbliche aggiudicate anche con metodo corruttivo, si occupa della gestione della contabilità occulta della associazione e dei pagamenti ai pubblici ufficiali corrotti”. Le cooperative nate all’ombra del Partito comunista al servizio della Mafia Capitale. Ma la scoperta più inquietante dell’inchiesta è quella del “libro mastro” ritrovato in casa della segretaria personale di Buzzi, Nadia Cerrito, che, arrestata, ha già cominciato a parlare. Un libro nero dove Buzzi tiene con precisione la contabilità occulta delle somme pagate e delle persone a cui sono destinate. Argomento da cui il fondatore della 29 giugno sembra ossessionato. Le intercettazioni sono piene di nomi accompagnati da cifre. Pesci grandi e piccoli della politica romana, ma anche funzionari e dirigenti comunali (in casa di un funzionario dell’ufficio giardini sono stati trovati 572mila euro). È in questa contabilità orale che tutto davvero si rimescola. E che Buzzi millanta rapporti anche con molti nomi del Partito democratico. Quello del presidente del consiglio comunale Mirko Coratti, che, indagato, si è dimesso il giorno degli arresti. “Me so’ comprato Coratti”, annuncia Buzzi all’inizio del 2014, che parla di 150mila euro promessi per sbloccare un pagamento relativo al “sociale”. Per incontrarlo si serve del suo capo segreteria, Franco Figurelli: “Gli diamo mille euro al mese”. Altro nome del Partito democratico è quello del consigliere regionale Eugenio Patanè. “Voleva 120mila a lordo”, sostiene Buzzi (siamo a maggio di quest’anno), richiesta che spiega di aver ricevuto per conto suo da un intermediario. “Gli abbiamo dato diecimila per… per carinerie, e finisce lì, non gli diamo più una lira”, chiosa in una successiva conversazione. È seccato Buzzi quando i conti non gli tornano: “A Panzironi che comandava gli avemo dato il 2 virgola 5 per cento, 120 mila euro su 5 milioni… mo’ damo tutti ’sti soldi a questo?”. Parlano di un appalto per la raccolta dei rifiuti. Franco Panzironi, a cui Buzzi paga 15mila euro ogni mese (“l’ho messo a 15 al mese”), è l’ex amministratore delegato dell’azienda per i rifiuti. Altro fedelissimo di Alemanno, finito agli arresti. Socio fondatore della sua fondazione, la Nuova Italia. Sulla fondazione del sindaco Alemanno piovono bonifici. Nel novembre del 2012, in particolare, arrivano 30mila euro dalle cooperative di Buzzi, proprio nel momento in cui il comune approva i provvedimenti di bilancio. In ballo ci sono i soldi per le aree verdi, per i campi rom e per i minori dell’emergenza in Nordafrica. Smista soldi Salvatore Buzzi. E smista anche i voti. L’11 maggio 2013, a pochi giorni dalle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale, Buzzi parla con Gianni Alemanno al telefono. “Allora? Ma è vera ’sta storia del disgiunto?”, s’informa il sindaco uscente. “Facciamo il disgiunto, facciamo. Ozzimo e Alemanno”, conferma Buzzi e ride. “Eh, questo… questo mi onora molto”, replica il sindaco. E Buzzi, ridendo: “Non lo possiamo dire, però. Mi raccomando, eh!”. Daniele Ozzimo, eletto con 5.317 preferenze, diventa l’assessore alla casa nella giunta guidata da Ignazio Marino. Si è dimesso anche lui, come Coratti. Nelle intercettazioni, un sms della sua ex moglie, Micaela Campana, responsabile welfare nella segreteria di Matteo Renzi, al presidente della 29 giugno: “Bacio, grande Capo”. In realtà Buzzi, qualche mese prima, sembrerebbe essersi entusiasmato a un altro scenario: “Noi oggi alle cinque lanciamo Marroni alle primarie per sindaco, eh!”. Poi la storia va diversamente e Umberto Marroni si candida alla camera. Ma il fondatore della 29 giugno è uomo dalle strategie larghe: “Mo’ c’ho quattro… quattro cavalli che corrono… col Pd, poi con la Pdl ce ne ho tre e con Marchini c’è…”. Qualche differenza c’è: “I nostri sono molto meno ladri di quelli della Pdl”, confida. Comunque rassicura: “Io pago tutti… finanzio giornali, faccio pubblicità, finanzio eventi, pago segretaria, pago cena, pago manifesti”. Specie quando c’è la campagna elettorale per le comunali: “Questo è il momento che pago di più…”. Quando Alemanno viene battuto da Ignazio Marino (sui giornali è spuntato un finanziamento anche alla sua campagna elettorale), non si arrende: di amici in giunta ne conta sei su nove, ma non fa i nomi. “Dacce ’na mano perché siamo messi veramente male con la Cutini”, si lamenta dell’assessore alle politiche sociali (quota Sant’Egidio) con il vicesindaco Luigi Nieri, di Sinistra ecologia libertà, con cui invece mostra un buon rapporto. Mentre l’ex segretario del Partito democratico romano, ora commissariato da Matteo Orfini, Lionello Cosentino lo considera “proprio un amico nostro”. In Campidoglio Buzzi cerca incontri, sponsorizza nomine (come quella di Walter Politano, che Marino ha subito rimosso da responsabile della trasparenza). E s’interroga anche su come “legare a sé” il giovane di punta nel gabinetto del sindaco, Mattia Stella (che non è indagato), già segretario del presidente emerito Oscar Luigi Scalfaro. Sono giorni frenetici, in cui tentare di tessere una nuova tela: “Bisogna vendersi come le puttane”, gli suggerisce Massimo Carminati, il mondo di mezzo. Buzzi da una parte, Carminati dall’altra. In mezzo i politici che si mettono al loro servizio. A leggersi le pagine dell’ordinanza, sembra proprio che Mafia Capitale voglia prendersi tutto: la gara d’appalto per la raccolta differenziata, quella per la manutenzione delle piste ciclabili, la nevicata del 2012, che mise in ginocchio la città governata da Alemanno, e la raccolta delle foglie. Ma anche cemento, affari nell’edilizia. A Roma, in questa città dove niente funziona, dopo la lettura di “Mondo di mezzo”, niente è più come prima. Neppure le foglie che ostruiscono i tombini. Certo, sotto tutta un’altra luce rispetto alle manifestazioni delle scorse settimane, si legge la vicenda dell’accoglienza dei migranti e dei campi rom nella capitale. Due settori su cui l’associazione punta molto. Nelle intercettazioni si parla in particolare del campo rom di Castel Romano, che è stato già costruito, in un mese e mezzo. “A me ’na grande mano per quel campo nomadi me l’ha data Massimo perché un milione e due, seicento per uno, chi cazzo ce l’ha”, rivela Buzzi. Che poi briga perché i fondi siano previsti nell’assestamento di bilancio. Ma è sulla vicenda dei migranti che Buzzi punta ancora di più. Detto con le parole del presidente della 29 giugno: “Tu c’hai un’idea di quanto ce guadagno con gli immigrati? Il traffico di droga rende meno”. E il suo “socio”, Sandro Coltellacci, presidente della cooperativa Formula sociale: “Qui stiamo a parlà della cooperazione sociale a Roma”. Ed è a proposito di immigrati che spunta la figura di Luca Odevaine, ex vicecapo di gabinetto quando il sindaco era Walter Veltroni. Odevaine è uno dei nomi più sorprendenti dell’inchiesta Mondo di mezzo. L’uomo a cui Veltroni aveva affidato tutta l’area della sicurezza, dalle occupazioni delle case ai campi rom, chiamato poi da Nicola Zingaretti a coordinare la polizia e la protezione civile della provincia. Anni dopo lo ritroviamo al fianco di Salvatore Buzzi, che lo vorrebbe capo di gabinetto del sindaco Marino: “Lo sai a Luca quanto gli do? Cinquemila euro al mese… ogni mese…”. L’interesse di Buzzi è legato all’incarico che Odevaine, consulente anche del consorzio che gestisce il Cara di Mineo, ricopre presso il Tavolo di coordinamento nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale, come rappresentante dell’Unione delle province italiane. Gli inquirenti parlano addirittura di un “sistema Odevaine”. “Cioè chiaramente stando a questo tavolo nazionale… e avendo questa relazione continua con il ministero… sono in grado un po’ di orientare i flussi che arrivano da… da giù… anche perché spesso passano per Mineo… e poi… da Mineo… vengono smistati in giro per l’Italia…”, spiega Odevaine al telefono. “Se loro c’hanno strutture che possono essere adibite a tavoli per l’accoglienza… da attivare subito in emergenza… senza gara… le strutture disponibili vengono occupate… e io insomma gli faccio avere parecchio lavoro”. Ora le gare e gli appalti si fermano. In Campidoglio, come in regione (anche lì, Buzzi millanta contatti e un uomo a busta paga per tenere i rapporti con il presidente Nicola Zingaretti). Il mondo di sopra è congelato. Il mondo di sotto, in carcere. Quello delle cooperative pulite è sconvolto. Nella politica romana, sono in tanti a tremare. Alle volte Carminati sembra proprio il Guercio in una terra di ciechi.
Mariagrazia Gerina è una giornalista freelance. Scrive per l’Espresso e per il Fatto Quotidiano. Ha lavorato per molti anni all’Unità, occupandosi soprattutto di Roma e di Campidoglio. Con Marco Damilano e Fabio Martini ha scritto Walter Veltroni. Il piccolo principe (Sperling & Kupfer 2007).
Mafia Capitale. La lunga scia di sangue e affari sporchi che avvolge Roma da 60 anni, scrive Gianni Rossi su “Articolo 21”. La Casta politica italiana non vuole proprio fare i conti con la storia patria. Dall’analisi del substrato capitolino, a partire dal Dopoguerra ad oggi, si possono capire le origini di “Mafia capitale” e il perché dell’improntitudine e dell’incapacità della classe politica di qualsiasi colore di sottrarsi all’abbraccio tentacolare della Piovra.
Roma “Capitale corrotta = Italia nazione infetta”. A 60 anni di distanza dalla prima grande inchiesta giornalistica sulla speculazione edilizia a Roma e gli intrecci con la finanza vaticana e il “generone capitolino” (pubblicata sull’Espresso l’11 dicembre 1955, a firma di Manlio Cancogni), siamo ancora ad interrogarci sulle cause e la diffusione di quel virus che ha nel suo DNA un intreccio perverso tra malaffare, politica e “poteri forti” dello stato. Quel “generume”, come lo ribattezzò il grande Giorgio Bocca, che viveva e vive all’ombra del Cupolone, che si ritrova in circoli esclusivi, che frequenta salotti di anziane “signore” vedove di esponenti della destra romana, che si genuflette nelle ovattate stanze vaticane, che sfoggia abbigliamenti d’altri tempi per omaggiare gli ospiti illustri nei cortili vaticani come “maggiordomi d’ancien regime”, che si divide solo allo stadio Olimpico tra le due opposte tifoserie, che sopravvive alle intemperie economico-politiche e ai rivolgimenti delle amministrazioni capitoline, continuando a mungere affari e stringere alleanze. Quel generone comprendeva un tempo i rampolli della nobiltà decaduta, “papalina e nera”, esponenti di primo piano del mondo politico e governativo, specie democristiano, massoni più o meno “coperti”, ecclesiasti di peso nella Curia, alti ufficiali, dirigenti dei servizi segreti, palazzinari, vertici di alcuni quotidiani. Erano gli anni del “Sacco di Roma”, quando i politici del centrosinistra di allora e gli affaristi in corsa per cementificare ovunque, in barba alle leggi urbanistiche, dovevano comunque passare per le stanze cardinalizie della Società Generale Immobiliare, il nucleo dorato della finanza vaticana, che negli anni Settanta passò nelle grinfie di Michele Sindona. A quel generone, dalla fine degli anni Settanta si è aggiunta una “Cupola” criminale, dalle fattezze mafiose, ma che ha tratto spunto nei modi di operare dai primi e vi ha aggiunto una spregiudicatezza e una efferatezza sconosciuta. Una Cupola che ha di fatto soppiantato i modi felpati di un tempo con l’arroganza e la violenza da “Romanzo criminale”. Ma a bloccare ogni indagine giornalistica e a stroncare qualsiasi denuncia c’era allora la Casta giudiziaria raccolta nel “Porto delle nebbie” del Palazzaccio, che veniva in soccorso alla classe politica e affaristica del momento, “sopendo e troncando”, fino alle avocazioni e ai trasferimenti in procure minori.
1978 – 1979: gli anni della “svolta”. Un giorno forse si scopriranno i fili che tennero insieme nel ‘78 personaggi delle Brigate Rosse, esponenti della Banda della Magliana, apparati deviati dei servizi e massoni “piduisti” durante e dopo il rapimento e l’uccisione del presidente della DC, Aldo Moro, l’uomo dell’apertura governativa al PCI. Una brutta fine la fece anche il giornalista Mino Pecorelli, perché si vantava si saperne molto e di rivelare nomi e cifre, che avrebbero squarciato il velo dell’ipocrisia che coprivano gli intrecci perversi. Moro e Pecorelli furono dunque le vittime ancestrali che segnano il confine della “Terra di mezzo”: il punto di convergenza e di non ritorno tra malavita organizzata, ambienti dell’estrema destra terroristica e del brigatismo rosso, settori dei servizi deviati, massoneria coperta, mondo degli affari e della politica che conta. Qualcuno che ne sapeva più degli altri è purtroppo morto, portando con sé i segreti inconfessabili di quel “delitto di stato”. Si era battuto per liberazione di Moro, aveva perso e si era dimesso dal governo. Più tardi salì al Colle, con un accordo bipartisan e un’unanimità mai più ripetuta. Le sue carte e le sue registrazioni non sono mai state ancora lette né decifrate. E forse non sarà sufficiente neppure aprire gli “armadi della vergogna” di Forte Braschi per decrittarne i segreti tra gli impolverati faldoni. Ma una concomitanza salta agli occhi: da quel periodo, i reduci della Banda della Magliana estendono i loro tentacoli mafiosi e, nonostante sanguinarie vendette personali ed alcune coraggiose indagini, il sistema di quei balordi si è andato affermandosi e incuneandosi negli sulla vita politica e affaristica della Capitale. Durante il periodo epico e di rottura col passato della seconda metà degli anni Settanta, grazie alla Rinascita democratica, sociale e culturale avviata dalle “amministrazioni rosse” con i sindaci comunisti (Argan, Petroselli e Vetere), Roma sembrava aver chiuso per sempre con l’epoca dei palazzinari, con le periferie “accattone” (850 mila abitanti reclusi in quartieri fuorilegge per il Piano Regolatore, senza servizi primari e trasporti), con la malavita rozza e “pastasciuttara”. La città fu restituita ai suoi abitanti, le periferie divennero parte integrante del sistema urbanistico, l’integrazione generò un circuito virtuoso di convivenza e di drastica diminuzione dell’allarme sociale e criminale. Ma sotto, sotto, covavano i prodromi degli epigoni del “Signore degli anelli”. In realtà i “Signori delle tenebre” cominciavano ad uscire dal mondo dei morti per conquistare la “Terra di mezzo” e volare verso le vette rarefatte di Valinor, utilizzando i mostri della “Terra di sotto” per stroncare qualsiasi opposizione. Una mitologia, creata dallo scrittore inglese Tolkien, cara ai giovani della destra più nostalgica e violenta che, abbandonati i pestaggi e gli assalti ai “rossi”, negli anni Ottanta s’infilano i golfini di cachemire, indossano cappotti loden e si introducono negli ambienti del generone romano.
Dalla “corruzione partitica a quella parcellizzata”.Con gli anni Ottanta, la rottura della non-belligeranza tra il PSI e il PCI, l’ascesa di Craxi e l’arrivo sulla scena affaristico-politica dei nuovi “cavalieri bianchi”, si apre la voragine di Tangentopoli, che poi passerà dai finanziamenti occulti ai partiti, a quelli ben più disseminati dei singoli esponenti. E qui trovano spazio anche le “larghe intese” tra destra e sinistra: tutti cercano di guadagnarci qualcosa, perché “tengono famiglia” e perché hanno come mito di riferimento il mondo virtuale creato dai media berlusconiani e dall’affermarsi di valori consumistici decadenti. I partiti tradizionali “ di massa”, con la cosiddetta crisi delle ideologie (in realtà con l’affermarsi dell’unica ideologia dominante, questa capitalista- liberista) si riducono in partiti elettoralistici, buoni per condurre le campagne di propaganda al servizio di leader “padri padroni”. Scompare la selezione dei quadri intermedi, la lunga trafila interna, per immettere personale politico adeguato ai ruoli e agli incarichi istituzionali, locali e nazionali. L’importante è conquistare gruppi di voti nei settori più “sensibili”, grazie alle amicizie inconfessabili, ai finanziamenti sottotraccia, alle tessere gonfiate. Non importa con chi e in che modo allearsi in questo pantano melmoso, basta far eleggere uomini e donne “capaci a disobbligarsi” con i veri padroni della città. Si privilegiano i legami familiari, i circoli e i salotti che contano, alcune categorie lavorative e imprenditoriali, si ricorre al voto di scambio/posti di lavoro nei servizi pubblici, alle promesse di nuovi appalti sempre più gonfiati. Le Primarie e le Parlamentarie del PD sono state le occasioni per imporsi da parte di questo sistema melmoso negli ultimi anni: personaggi politici quasi sconosciuti agli elettori ai vari circoli, che venivano “bloccati” e posizionati ai primi posti, a danno di esponenti noti da tempo e dal passato trasparente; carriere politiche inventate all’ultimo minuto, per arricchire curricula inconsistenti; trascorsi inconfessabili cancellati, di chi nel volgere di pochi anni era passato dalla destra finiana, a quella berlusconiana, per poi entrare nel PD. Alle forti ascendenze di Walter Veltroni e Goffredo Bettini, da una parte, e Massimo D’Alema, dall’altra, che per decenni hanno scelto e imposto i loro candidati sia dentro il partito che nelle amministrazioni locali, si sono affiancati i “nuovi padroni” di Roma, che hanno generato i “mostri” della sinistra che potevano gemellarsi con i “mostri” della destra. Nel frattempo però, qualcosa di importante era cambiato a Roma: il vecchio “Porto delle Nebbie”, il fortilizio di Piazzale Clodio si era come aperto alla luce del sole. Aria nuova stava entrando tra gli uffici tetri del Palazzaccio, proprio sotto la “collina del disonore”, quella di Monte Mario, simbolo negli anni Cinquanta/Sessanta della prima inchiesta giornalistica scandalistica dell’Espresso sulle speculazioni edilizie. E’ come se il cerchio si chiudesse attorno al “Mondo di Mezzo”, grazie ad un pool di giudici, guidati da un binomio esperto nella lotta alla mafia e alla ‘ndrangheta, impersonato dal Procuratore Capo Giuseppe Pignatone e dal suo Aggiunto Michele Prestipino. Se l’opinione pubblica, i media e i corpi intermedi della società sapranno creare attorno a loro una rete di protezione, forse allora per la prima volta, anche la Casta dovrà operare per “purificarsi”. Ma se ai primi segnali di qualche errore giudiziario, più o meno formale, ci si trovasse di fronte al solito coro mediatico del “garantismo” ad oltranza, che già fece arenare l’inchiesta di Mani Pulite, allora i “Pupari” della Terra di Mezzo e gran parte della Casta potranno cantare vittoria: autoassolversi. E l’Italia sprofonderà ancora di più non solo nelle classifiche di Transparency International (oggi al 69° posto su 177 con 43 punti su 100), ultima tra i 28 paesi dell’UE con la Romania, e tra gli ultimi paesi del club esclusivo del G20. Ma soprattutto saranno i mercati finanziari internazionali e le maggiori cancellerie del mondo a condannarci alla decadenza, a causa proprio della corruzione politica, del finanziamento occulto dei partiti, il controllo sui grandi appalti pubblici e il carsico fenomeno dell’evasione fiscale.
Mafia Capitale, Ancora una volta la magistratura commissaria la politica italiana, scrive Lanfranco Caminiti su “Il Garantista”. Se restiamo inchiodati a discutere di 416 bis, a proposito dell’ordinanza “Mafia Capitale” che ha letteralmente sconquassato la vita politica e amministrativa di Roma e del Lazio, cioè se la fattispecie dell’associazione di tipo mafioso contestata dalla procura di Roma sia corrispondente o no al vasto fenomeno di corruzione che ha provocato arresti, indagini e dimissioni a catena, non ne usciamo vivi, schierati in trincea di opinione da una parte o dall’altra. Certo, è una battaglia di garanzia e di diritti, ma questo non è tutto. Non ci vuole la zingara per immaginare – come ha già scritto il direttore di questo giornale – che i pubblici ministeri e il procuratore capo Pignatone sapessero benissimo quale valanga stessero provocando. Quale valanga politica. Non solo l’evidente questione se il Comune di Roma vada sciolto e commissariato, dato che è “quasi giurisprudenza” – quanto meno è la teoria di Gratteri, procuratore di Reggio Calabria, non proprio l’ultimo in merito – che basti anche solo la “infiltrazione mafiosa” di un assessore perché tutto il consiglio vada sciolto. E dato che questa teoria è stata largamente applicata, al Sud almeno, non si capisce perché Roma dovrebbe godere di uno statuto privilegiato. E l’altro versante, quello che lambisce il ministro Poletti, in quanto già capo della Lega delle coop, anche se non c’è alcuna sussistenza di reato né tanto meno alcuna indagine in merito, non è un effetto collaterale da meno. Sarà un effetto mediatico, ma di questo campa la politica. D’altronde, ci si obietterà, non ci più sono “santuari” inaccessibili e il tribunale di Roma, come altri, non è più un “porto delle nebbie” dove tutto si insabbia, e è meglio così. Il punto perciò è che l’indagine “Mafia Capitale”, al di là degli aspetti folckloristici sul “Pirata o “er Cecato” Carminati e su tutta la mole di intercettazioni che lasciano trapelare avidità e pochezza nel mondo dell’amministrazione della cosa pubblica, è soprattutto una “cosa politica”. L’indagine “Mafia Capitale” è una questione squisitamente politica. Era il 17 febbraio 1992 quando arrestarono Mario Chiesa, socialista, che ricopriva la carica di presidente del Pio Albergo Trivulzio a Milano, e che venne colto in flagrante mentre accettava una tangente di sette milioni di lire. Era l’inizio di Tangentopoli. Il “mariuolo” – come lo definì Bettino Craxi – Mario Chiesa sarà il primo tassello di un domino che getterà giù l’impianto politico della Prima repubblica. È una storia che tutti sanno. Si ricordano meno alcuni caratteri della vita politica di allora, in senso sociale, ampio, di partecipazione. Alle elezioni politiche del 5 aprile 1992 – poco dopo l’arresto di Chiesa, perciò – votarono per la Camera in 41 milioni 479.764, cioè l’87,35 per cento degli italiani; e per il Senato, in 35 milioni 633.367, cioè l’86,80 per cento. Alle elezioni politiche del 1994, quando ormai Tangentopoli era un diluvio, un giudizio universale, e Berlusconi era sceso in campo votarono per la Camera in 41 milioni 546.290, cioè l’85,83 per cento; e per il Senato, votarono in 35 milioni 873.375, cioè l’85,83 per cento. Sono dati dell’archivio del ministero dell’Interno, e sono numeri incommensurabili rispetto la partecipazione attuale al voto. Il sindaco Marino, per dire, che di questo stiamo parlando, è stato eletto con il 45,05 per cento degli aventi diritto di voto. Meno di uno su due romani andò a votare. Lo sconquasso politico di Tangentopoli non provocò il vuoto, o quanto meno il vuoto della po-itica che non esiste in natura fu colmato da Berlusconi e dalla Lega, mentre i grandi partiti di massa ancora tenevano. Aggiungo un paio di dati: nel 1991 gli iscritti al Pci/Pds sono 989.708, quasi un milione; l’anno prima ne aveva un milione 264.790 e nel 1987 un milione e mezzo. Insomma, siamo dopo la caduta del muro di Berlino e c’è sconcerto, ma il “partito comunista più forte dell’occidente” tiene ancora botta. Se li confrontiamo, questi numeri – tratti dalle ricerche dell’istituto Cattaneo – con la sconfortantissima polemica tutta intestina sugli iscritti attuali del Pd, che non arrivano nemmeno ai trecentomila, si capisce di costa sto parlando. E gli iscritti alla Democrazia cristiana, sempre nel 1991, erano un milione 390.918, mentre l’anno prima ne aveva sopra i due milioni. Ora, la differenza evidente tra l’indagine “Mafia Capitale” con altri episodi di corruzione della cosa pubblica, tanto per dire il “caso Fiorito” che pure portò alle dimissioni della giunta Polverini, con il suo contorno di feste da Trimalcione e sprechi privati giustificati da pizzini volanti, sta nel carattere di “sistema”: mentre il caso Fiorito, che pure riguardava una pletora di consiglieri che allegramente spendevano i lauti soldi dei loro stipendi ha aspetti erratici e casuali – e peraltro molti si appellavano alle larghe maglie di discrezionalità che la legge offriva loro –, quello che risulta e risalta dall’indagine della procura di Roma è un “sistema” di gestione di flussi finanziari, con la triangolazione tra soggetti pubblici, soggetti privati, cooperative sociali. È qualcosa, insomma, che somiglia molto più a una Tangentopoli che a una Parentopoli. L’anomalia, insomma, è quel signore che teneva in casa centinaia di migliaia di euro “bloccati”: gli altri spendevano, compravano case, automobili, affittavano ville, insomma alimentavano e drogavano il Pil della città, con l’economia criminale. Certo, Tangentopoli era il “sistema Italia” e qui parliamo di un “sistema Roma”. Però, la valenza politica di Roma Capitale è sempre stata tale da avere un risvolto nazionale. Che sia implicato o meno un ministro. La differenza tutta politica tra il 1992 e adesso sta nei numeri che ho dato prima. Il sistema politico è esangue. E neppure il grillismo è riuscito a trasfondervi qualcosa. Il sistema politico è stretto nella tenaglia tra il renzismo (che, va ricordato, non ha mai avuto alcun suffragio elettorale) e l’astensionismo ormai dilagante. Paragonate l’affluenza in Emilia Romagna nel 1992 (per la Camera, Circoscrizione Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì: 94,44 per cento; Circoscrizione Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia: 92, 99 per cento) con il misero 37,7 per cento delle regionali di qualche giorno fa, e si capisce di cosa stia parlando. Il professor De Rita è intervenuto più volte recentemente a proposito del declino dei “corpi intermedi” – della politica, delle istituzioni – e della fragilità complessiva che questo comporterebbe nel sistema Paese, un vuoto non sostituibile con il verticismo e l’avocazione verso il centro che il presidente del Consiglio sembra privilegiare. Il fatto è che il renzismo non sembra coprire il vuoto della partecipazione politica, anzi all’opposto sembra incassarne gli effetti. Non è solo una caduta di stile la battuta arrogante di indifferenza rispetto la scarsa affluenza alle urne. Forse è vero che la magistratura vuole mostrare di poter tenere sempre sotto schiaffo la politica, qualsiasi. O forse, in un certo senso l’indagine della procura di Roma di Pignatone sembra dare una mano al renzismo. È un’indagine rottamatoria. E di lunga durata. E in quanto tale ne prolunga la vita, lo rende ineluttabile. Proprio l’opposto di Tangentopoli. E la risposta politica è: si commissaria il partito, si avocano a sé le decisioni. Se sarà il caso, si procede anche sfidando le urne a livello locale: si può vincere anche con il trenta per cento di voti, o pure meno. Forse, non è di questo che ha bisogno Roma. E neppure il Paese…
Bentornati nel “porto delle nebbie”, scriveva già Ferruccio Sansa su Il Fatto Quotidiano del 13 agosto 2011. Il “porto delle nebbie”. Il Tribunale di Roma si porta addosso il titolo conquistato tra gli anni ’70 e ‘90. Sospetti, indagini contese con altri tribunali, dalle schedature Fiat allo scandalo dei petroli, passando per i fondi neri Iri e la Loggia P2. Un elenco che tocca anche Tangentopoli, con le inchieste romane che, per usare un eufemismo, non produssero gli effetti di quelle milanesi. I magistrati romani oggi ripetono: “Non siamo più il porto delle nebbie”. E, però, ecco il procuratore aggiunto Achille Toro (ormai ex), che patteggia una condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio per l’inchiesta G8. Ecco il procuratore Giancarlo Capaldo sotto inchiesta del Csm per la cena con il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, e il suo braccio destro Marco Milanese, all’epoca indagato a Napoli. Così a qualcuno tornano in mente inchieste approdate a Roma per finire archiviate o apparentemente dimenticate. Pare finita nel nulla l’inchiesta arrivata nella Capitale su Alfonso Pecoraro Scanio, ministro delle Politiche agricole nel governo Amato e dell’Ambiente nell’ultimo Prodi. La Camera ha negato al tribunale dei ministri l’utilizzo delle intercettazioni del pm Henry John Woodcock. Eppure nella richiesta del Tribunale dei ministri si legge: “Dalle intercettazioni emerge che l’imprenditore Mattia Fella si è interessato al reperimento di una sede per una fondazione che sarebbe stata intitolata al ministro nonché all’acquisto per conto del ministro, di un terreno nei pressi di Bolsena dove quest’ultimo avrebbe dovuto realizzare un complesso agrituristico dotato di piscina ed eliporto. Infine, dalle telefonate risulta che il ministro ha sempre manifestato disponibilità a esaudire le richieste del Fella”. Fella ambiva a stipulare convenzioni con il ministero e con l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e alla nomina del fratello Stanislao in una commissione ministeriale, il ministro in cambio avrebbe ottenuto “numerosi spostamenti con un elicottero pagato da Fella per 120 mila euro; numerosi viaggi-soggiorno in Italia e all’estero per decine di migliaia di euro; l’acquisto di un terreno – pagato 265 mila euro da Fella – per l’edificazione di un agriturismo biologico e di una villa con piscina ed eliporto, destinato al ministro”. Pecoraro Scanio ha sempre negato ogni addebito. Archiviato anche il fascicolo sugli appalti per i centri di accoglienza che vedeva tra gli indagati Gianni Letta, accusato di abuso d’ufficio, turbativa d’asta e truffa aggravata per aver favorito, questa la tesi dei pm, imprese legate al gruppo “La Cascina” vicino a Cl, a Giulio Andreotti e al segretario di Stato vaticano, Tarcisio Bertone. L’indagine parte da Potenza: Woodcock lavora su una presunta organizzazione specializzata nell’aggiudicarsi commesse pubbliche truccando le gare. Il 6 agosto 2008 Angelo Chiorazzo (dirigente Cascina) è a Palazzo Chigi. Letta chiama il capo dell’immigrazione al ministero, il prefetto Morcone. Due giorni dopo Chiorazzo torna alla carica. Dopo il secondo incontro, Letta richiama Chiorazzo: “Il prefetto di Crotone mi dice che vuole che lei vada o lunedì o martedì… perché poi lui va a Cosenza dove è stato trasferito e dice: "E’ meglio che lascio le cose fatte". Allora, la aspetta in Prefettura… eh… a nome mio”. Ma l’inchiesta si concentra anche su altri appalti, come quello da un milione e 170mila euro per il Cara di Policoro (Matera), aperto a tempo di record e affidato a società legate ai Chiorazzo. Secondo la Procura di Roma, però, in questa vicenda non ci sarebbe nulla di penalmente rilevante. Il pm Sergio Colaiocco nell’aprile 2009 ha fatto archiviare l’accusa di associazione per delinquere contro Letta e Morcone. A suo avviso, lo stato d’emergenza legittimava tutto, quindi anche le altre accuse dovevano cadere. Secondo Woodcock, invece, l’emergenza non farebbe venir meno l’obbligo di chiedere 5 preventivi prima di assegnare un appalto milionario con un paio di telefonate. Ma alla fine anche il pm di Lagonegro, cui l’inchiesta era stata affidata per competenza, archivia. Nel dimenticatoio pare finita anche la vicenda in cui era indagata Daniela Di Sotto, all’epoca signora Fini. Cioè moglie del vice-premier Gianfranco. È il 19 aprile 2005 quando gli investigatori della Procura di Potenza registrano una telefonata imbarazzante: “Io sono andata a sbattermi il culo con Storace”, allora presidente della Regione Lazio. A parlare era appunto Daniela Fini. Il suo interlocutore era l’allora segretario di suo marito Francesco Proietti, poi divenuto deputato. Lo “sbattimento” di Daniela con Storace secondo l’accusa avrebbe prodotto risultati. Scrive Woodcock: “Proietti e Di Sotto fanno esplicitamente cenno all’interessamento profuso dalla donna presso Storace affinché la clinica Panigea – di cui Di Sotto era socia – operasse in regime di convenzione l’esecuzione di esami costosi”. La richiesta della Panigea è dell’11 febbraio, il parere favorevole Asl è del 14, la delibera della giunta è del 18. Basta una settimana. Ma a beneficiare della convenzione non saranno Di Sotto e Proietti, bensì la loro socia Patrizia Pescatori. Cognata di Gianfranco Fini. Il pm Sergio Colaiocco ha anche archiviato un’inchiesta (partita da De Magistris, prima di approdare a Roma) sull’allora ministro della Giustizia, Clemente Mastella. Al centro dell’indagine i rapporti tra l’esponente politico e l’imprenditore Antonio Saladino. Ma la Procura di Roma non condivide le accuse: Mastella non avrebbe compiuto i reati contestati nell’inchiesta Why Not almeno nel periodo in cui era ministro. Non emergono, secondo il pm, “elementi diversi dall’asserita esistenza di rapporti di amicizia tra Saladino e Mastella” e quindi si esclude che vi siano “fonti di prova che depongano per la sussistenza di reati commessi a Roma”.
Procura romana porto delle nebbie. Mele: "parlarne male è una moda", scriveva Nese Marco su Corriere della Sera (25 settembre 1992). Dicono che nel "manuale Cencelli" (la guida pratica per la spartizione dei posti di potere) l'incarico di capo della Procura di Roma equivalga a due ministeri. E si può ben capire. Il più importante ufficio italiano della pubblica accusa ha gli occhi direttamente puntati sul "Palazzo". Dicono che talvolta i suoi sguardi verso i potenti siano troppo benevoli. I maligni insinuano che proprio adesso ne abbiamo una prova sotto gli occhi. I giudici milanesi hanno fatto arrestare sette alti papaveri romani. Dovevano muoversi quelli di Milano? A Roma non si erano accorti di nulla? Domande più che legittime. Però, almeno stavolta, non si può dare la croce addosso ai magistrati della capitale. La loro parte contro i pubblici amministratori corrotti la stanno facendo. Hanno messo dentro assessori, industriali, personaggi di grosso calibro. La "Tangentopoli" romana coinvolge finora almeno ottanta inquisiti. "Facciamo meno chiasso dei milanesi, ironizza un sostituto procuratore, per questo le nostre inchieste passano inosservate". C'è anche chi polemizza per i sette arresti ordinati da Milano. "Vedremo, dicono alla Procura, se gli episodi contestati si sono svolti al Nord o nella capitale. Se la corruzione e il versamento delle mazzette sono avvenute a Roma, i milanesi dovevano semplicemente passarci le carte per una questione di competenza". Accetta di parlare anche il capo della Procura, Vittorio Mele, che si è insediato da quasi tre mesi. "Non abbiamo riguardi per nessuno. Bisogna considerare, però, che in materia di pubblica amministrazione le indagini non sono semplici. Ci vuole un episodio. Come è capitato a Di Pietro con Mario Chiesa. Quando mi sento dire: voi che fate, non vi muovete?, mi viene da considerare che gli episodi su cui indagano i colleghi milanesi si riferiscono agli anni Ottanta. Allora potrei dire: cosa facevano loro mentre la corruzione si diffondeva, e cosa facevano gli imprenditori? Non lo dico in tono polemico, ma solo per spiegare che non è facile smascherare i corrotti. Soprattutto se non si ha la fortuna di trovare persone disposte a parlare". A Milano questa fortuna l'hanno avuta. "Ne sono felice per loro, dice Mele, ma anche noi stiamo facendo la nostra parte. Io sono arrivato qui da poco, ma in passato, ricordo che un'inchiesta della Procura romana ha fatto cadere la giunta del sindaco Signorello. E oggi, per citare solo alcuni casi, abbiamo in piedi inchieste sugli assessori Lamberto Mancini, Arnaldo Lucari, Carlo Pelonzi. Ma io voglio perfezionare le indagini. Sto pensando a un pool di sostituti solo per le inchieste sulla pubblica amministrazione". Il nuovo Procuratore vuole cancellare anche la brutta nomea di Roma affossatrice di scandali. Alla richiesta di strappare l'inchiesta sugli ex ministri Bernini e De Michelis ai magistrati veneziani ha risposto no. Ha rinunciato a sollevare conflitto di competenza. "Non volevo che domani mi potessero accusare, dice Mele, di essermi intromesso allo scopo di insabbiare. Eppure, a ogni occasione rispunta la storia della Procura romana che è un porto delle nebbie. La verità è che parlare male di questo ufficio è una moda". Adesso, forse, le cose sono cambiate. Ma in passato le accuse alla Procura romana non erano fantasie. E' successo di tutto in quei piccoli uffici male illuminati. All'inizio degli anni Settanta erano state registrate le conversazioni telefoniche tra il boss mafioso Frank Coppola e Natale Rimi, figlio di un capomafia, che si era inserito alla Regione Lazio. Quando gli inquirenti andarono ad ascoltare i nastri, scoprirono che erano stati manomessi, tagliati e ricuciti. Poi cominciò l'epoca dei processi strappati ad altre città. Il primo fu quello per la strage di piazza Fontana, fatto spostare a Roma perchè nello stesso giorno erano esplose bombe anche nella capitale e questo doveva considerarsi il segno di un unico disegno eversivo. Stessa sorte subì l'inchiesta sui petroli. Quella avviata a Genova. La conducevano tre giovani pretori che vennero definiti "d'assalto" perchè avevano osato mettere sotto torchio alcuni personaggi importanti. Anche nelle inchieste sul terrorismo Roma fece la parte dell'arraffatutto. A Milano avevano ordinato l'arresto di Franco Piperno. A Roma fecero altrettanto, contestando però un reato più grave, il delitto Moro. Fra mille polemiche, l'inchiesta passò a Roma, ma le accuse vennero subito smontate. Ci fu un tempo in cui i Procuratori della capitale lasciavano il loro ufficio con un marchio indelebile. A Giovanni De Matteo è rimasta la brutta fama di aver favorito i fratelli Caltagirone, palazzinari legati ad Andreotti. Il suo successore, Achille Gallucci, è passato alla storia per il caso dei cappuccini. A suo avviso, ne bevevano troppi al Consiglio superiore della magistratura, un segno di spreco, che Gallucci bollò come peculato. I maligni dissero che lo scopo di Gallucci era solo quello di far cadere il Csm. E tutte le forze politiche ammisero che si trattava di uno scontro a carattere istituzionale. Un'operazione oscura, mentre divampava lo scandalo P2. Gallucci è stato forse il più chiacchierato Procuratore. Non c'è caso scottante, non c'è scandalo politico-finanziario che non sia passato per le mani di Gallucci, dai fondi neri Montedison, all'Italcasse, alla Sir, alla Rosa dei Venti, alle banche, al caso Calvi. Tutti gli episodi più infelici e sinistri della nostra storia recente.
Mafia Capitale, parlano 2 sbirri: “Nel 2003 avevamo scoperto tutto ma siamo stati bloccati.” Da chi? Si chiede Infiltrato.it. Ieri sera, 4 dicembre 2014, ad Anno Uno, è andato in onda una clamorosa video-denuncia, in cui 2 ex poliziotti della Mobile di Roma ha raccontato la loro assurda vicenda: “Nel 2003 avevamo già scoperto e denunciato Mafia Capitale. Ma siamo stati bloccati.” Da chi?, chiede il cronista. Ecco la risposta, che lascia a bocca aperta. Stefano Bianchi ha incontrato ad Ostia Gaetano Pascale e Piero Fierro, ex poliziotti della squadra mobile di Roma. I due agenti già lo scorso anno avevano rivelato al cronista de ilfattoquotidiano.it Luca Teolato gli insabbiamenti delle inchieste da loro condotte. Nel 2003 Pascale aveva messo le mani sulla mafia di Ostia, prima che lo facesse l’inchiesta “Nuova Alba”. Ma è stato fermato da qualcuno. “Questa cosa ha favorito i narcotrafficanti” – dichiara Fierro – “La prendo con ironia ma bisognerebbe scappare da ‘sto Paese. Ho fatto un giuramento: essere fedele alla patria. e da allora ho preso solo calci in faccia”. E rivela: “Nel 2003 eravamo arrivati alle stesse conclusioni del 2013. C’è stato un solo problema: c’hanno fermato. La mafia e la politica dividono lo stesso territorio: o si mettono d’accordo o si sparano. Voi avete mai visto un politico sparato a Roma?”. E aggiunge: “A Roma c’era Pippo Calò. Secondo voi una volta morto lui hanno tirato giù la saracinesca e scritto ‘chiuso per ferie’. Ho cercato solo di fare il mio dovere: lo sbirro. Ero pagato per questo. poco, ma per questo”. Come raccontava anche Repubblica, “la parola fine alla mafia di Ostia-Roma poteva essere scritta 10 anni fa. Perché quei nomi e cognomi eccellenti della malavita, quei traffici di droga e quei giri di armi, quell'impero economico su cui stavano mettendo le mani i clan (e che fanno parte anche dell’inchiesta Mondo di Mezzo, ndr), erano sotto la lente di un pool di investigatori a cui qualcuno recise le ali. Piero Fierro, agente pluridecorato della polizia di frontiera e Gaetano Pascale, eccellente investigatore della Narcotici alla Mobile, insieme ad altri cinque colleghi erano a un passo dalla verità. Ma qualcuno decise di stroncare la loro carriera, di metterli fuori dai giochi. E oggi i sette poliziotti sono in pensione, con cause per mobbing ancora aperte (seguite dall'avvocato Floriana De Donno) e procedimenti penali che li hanno trascinati da un giorno all'altro nella bufera, archiviati.” Lo Stato ha fermato, deliberatamente, alcuni dei suoi agenti migliori per proteggere i mafiosi. E allora le domande che ci poniamo sono: chi li ha fermati? Chi si voleva proteggere?
Gen. Antonio Pappalardo su “Agora Magazine”: «La mafia a Roma e nello Stato». Nel 1991 ero Comandante del Gruppo Carabinieri Roma 3, con sede in Frascati. Avevo alle dipendenze circa 1.500 uomini, che dovevano soprattutto vigilare affinché la camorra napoletana non si infiltrasse dal sud nella capitale. Un giorno, bello per la giustizia, ma brutto per i politici corrotti, il Capitano della Compagnia Carabinieri di Ostia mi comunicò, estremamente preoccupato, che aveva scoperto un vasto giro di corruzione politica, che investiva i massimi palazzi del potere di Roma. Lo rassicurai: poteva tranquillamente svolgere le sue indagini, colpendo qualsiasi palazzo del potere. Ci sarei stato io dietro le sue spalle. Ed il bravo capitano mollò ceffoni a tutti, senza guardare in faccia a nessuno. La magistratura di Roma, venuta a conoscenza dei fatti, insabbiò tutto, così meritandosi l’appellativo di porto delle nebbie. Qualche mese dopo scoppiò Tangentopoli a Milano e quella magistratura – si è scoperto dopo, per un fine politico, quello di annientare il PSI, che si poneva come ostacolo alla fusione DC-PCI - avviò un’indagine a tappeto, mandando tutto il sistema politico della Prima Repubblica all’aria. Si buttarono nel fango l’acqua sporca e il bambino, favorendo la nascita di nuovi movimenti politici che continuarono, stavolta indisturbati, a rubare. Ancora di più! Mentre dal 2003 al 2006 ero Capo di Stato Maggiore della Divisione Unità Specializzate, un ufficiale dei carabinieri, che non può non essere considerato un fellone, si sfogò dicendo che il ROS Carabinieri, nato per combattere la mafia e il terrorismo, si stava occupando troppo della corruzione politica, dando fastidio a parecchi potenti della Repubblica. Quei potenti, se il ROS non fosse stato frenato, si sarebbero ricordati al momento opportuno di noi, giungendo persino a proporre l’eliminazione della stessa Arma dei Carabinieri. Questi cialtroni ci hanno provato e le voci sull’eliminazione dell’Arma, con l’attribuzione di tutti i poteri alla Polizia di Stato, con l’assorbimento da parte di essa delle stazioni carabinieri, si sono moltiplicate. Ma noi nel 2004 mandammo a farsi benedire il suggeritore malefico mandato dai politici. Oggi, dopo tanti anni di silenzio, dovuti a diversi fattori, non ultimo quello di aver mantenuto al comando del ROS un uomo ricattabile, il nostro reparto speciale è esploso mettendo in luce la grave corruzione politica e mafiosa che pervade Roma e i palazzi del potere. Dopo tanti anni si è capito che il cancro non è a Milano (là c’era una metastasi), ma a Roma dove tutti gli intrallazzi nascono e crescono. Bravi i nostri solerti e incorruttibili investigatori del ROS! Certo, se si fossero mossi subito a seguito delle indagini della Compagnia di Ostia, questo cancro si sarebbe scoperto in quegli anni e molti mascalzoni, che sono stati eletti in Parlamento, oggi sarebbero da anni in galera. Comunque, la colpa non è di loro, ma di qualcuno, che volendo rimanere attaccato alla poltrona ed occuparne delle altre, maggiormente prestigiose, gioca come il gatto con il topo, che viene lasciato libero, ma subito dopo riacciuffato. Il COCER, che dovrebbe vigilare affinché non si facciano brutti giochi o scherzi all’Arma, non guarda nella giusta direzione e si occupa di aspetti secondari. Si limita a guardare la pagliuzza negli occhi di qualche comandante, di mentalità ristretta e ottusa, e non guarda, invece, nell’occhio di qualcuno, che ha la trave. I Delegati non sanno che di talune gravi mancanze, da loro non rilevate, saranno un giorno giudicati, perché solo Dio è eterno. Tutti gli altri, prima o poi, sebbene protetti dai soliti potenti e prepotenti, passano! Palermo, 3 dicembre 2014. Gen. Antonio Pappalardo.
La corruzione passa per il tribunale. Tra mazzette, favori e regali. Nei palazzi di giustizia cresce un nuovo fenomeno criminale. Che vede protagonisti magistrati e avvocati. C'è chi aggiusta sentenze in cambio di denaro, chi vende informazioni segrete e chi rallenta le udienze. Il Pm di Roma: "Un fenomeno odioso", scrive Emiliano Fittipaldi su “L’Espresso”. A Napoli, dove il caos è dannazione di molti e opportunità per gli scaltri, il tariffario lo conoscevano tutti: se un imputato voleva comprarsi il rinvio della sua udienza doveva sganciare non meno di 1.500 euro. Per “un ritardo” nella trasmissione di atti importanti, invece, i cancellieri e gli avvocati loro complici ne chiedevano molti di più, circa 15mila. «Prezzi trattabili, dottò...», rabbonivano i clienti al telefono. Soldi, mazzette, trattative: a leggere le intercettazioni dell’inchiesta sul “mercato delle prescrizioni” su cui ha lavorato la procura di Napoli, il Tribunale e la Corte d’Appello partenopea sembrano un suk, con pregiudicati e funzionari impegnati a mercanteggiare sconti che nemmeno al discount. Quello campano non è un caso isolato. Se a Bari un sorvegliato speciale per riavere la patente poteva pagare un magistrato con aragoste e champagne, oggi in Calabria sono tre i giudici antimafia accusati di corruzione per legami con le ’ndrine più feroci. Alla Fallimentare di Roma un gruppo formato da giudici e commercialisti ha preferito arricchirsi facendo da parassita sulle aziende in difficoltà. Gli imprenditori disposti a pagare tangenti hanno scampato il crac grazie a sentenze pilotate; gli altri, che fallissero pure. Ma negli ultimi tempi magistrati compiacenti e avvocati senza scrupoli sono stati beccati anche nei Tar, dove in stanze anonime si decidono controversie milionarie, o tra i giudici di pace. I casi di cronaca sono centinaia, in aumento esponenziale, tanto che gli esperti cominciano a parlare di un nuovo settore illegale in forte espansione: la criminalità del giudiziario. «Ciò che può costituire reato per i magistrati non è la corruzione per denaro: di casi in cinquant’anni di esperienza ne ho visti tanti che si contano sulle dita di una sola mano. Il vero pericolo è un lento esaurimento interno delle coscienze, una crescente pigrizia morale», scriveva nel 1935 il giurista Piero Calamandrei nel suo “Elogio dei giudici scritto da un avvocato”. A ottant’anni dalla pubblicazione del pamphlet, però, la situazione sembra assai peggiorata. La diffusione della corruzione nella pubblica amministrazione ha contagiato anche le aule di giustizia che, da luoghi deputati alla ricerca della verità e alla lotta contro il crimine sono diventati anche occasione per business illegali. Nello Rossi, procuratore aggiunto a Roma, prova a definire caratteristiche e contorni al fenomeno: «La criminalità del giudiziario è un segmento particolare della criminalità dei colletti bianchi. Una realtà tanto più odiosa perché giudici, cancellieri, funzionari e agenti di polizia giudiziaria mercificano il potere che gli dà la legge». Se la corruzione è uno dei reati più diffusi e la figura del giudice comprato è quella che desta più scandalo nell’opinione pubblica, il pm che ha indagato sulla bancarotta Alitalia e sullo Ior ricorda come tutti possono cadere in tentazione, e che nel gran bazar della giurisdizione si può vendere non solo una sentenza, ma molti altri articoli di enorme valore. «Come un’informazione segreta che può trasformare l’iter di un procedimento, un ritardo che avvicina la prescrizione, uno stop a un passaggio procedurale, fino alla sparizione di carte compromettenti». Numeri ufficiali sul fenomeno non esistono. Per quanto riguarda i magistrati, le statistiche della Sezione disciplinare del Csm non fotografano i procedimenti penali ma la più ampia sfera degli illeciti disciplinari. Nell’ultimo decennio, comunque, non sembra che lo spirito di casta sia prevalso come un tempo: se nel 2004 le assoluzioni erano quasi doppie rispetto alle condanne (46 a 24) ora il trend si è invertito, e nei primi dieci mesi del 2012 i giudici condannati sono stati ben 36, gli assolti 27. «Inoltre, se si confrontano queste statistiche con quelle degli altri Paesi europei redatte dalla Cepej - la Commissione europea per l’efficacia della giustizia - sulla base dei dati del 2010», ragiona in un saggio Ernesto Lupo, fino al 2013 primo presidente della Cassazione, «si scopre che a fronte di una media statistica europea di 0,4 condanne ogni cento giudici, il dato italiano è di 0,6». Su trentasei Paesi analizzati dalla Commissione, rispetto all’Italia solo in cinque nazioni si contano più procedimenti contro i magistrati. Chi vuole arricchirsi illegalmente sfruttando il settore giudiziario ha mille modi per farlo. Il metodo classico è quello di aggiustare sentenze (come insegnano i casi scuola delle “Toghe Sporche” di Imi-Sir e quello del giudice Vittorio Metta, corrotto da Cesare Previti affinché girasse al gruppo Berlusconi la Mondadori), ma spulciando le carte delle ultime indagini è la fantasia a farla da padrona. L’anno scorso la Procura di Roma ha fatto arrestare un gruppo, capeggiato da due avvocati, che ha realizzato una frode all’Inps da 22 milioni di euro: usando nomi di centinaia di ignari pensionati (qualcuno era morto da un pezzo) hanno mitragliato di cause l’istituto per ottenere l’adeguamento delle pensioni. Dopo aver preso i soldi la frode continuava agli sportelli del ministero della Giustizia, dove gli avvocati chiedevano, novelli Totò e Peppino, il rimborso causato delle «lungaggini» dei finti processi. Un avvocato e un giudice di Taranto, presidente di sezione del tribunale civile della città dei Due Mari, sono stati invece arrestati per aver chiesto a un benzinaio una tangente di 8mila euro per combinare un processo che il titolare della pompa aveva con una compagnia petrolifera. Se a Imperia un magistrato ha aiutato un pregiudicato a evitare la “sorveglianza speciale” dietro lauto compenso, due mesi fa un giudice di pace di Udine, Pietro Volpe, è stato messo ai domiciliari perché (insieme a un ex sottufficiale della Finanza e un avvocato) firmava falsi decreti di dissequestro in favore di furgoni con targa ucraina bloccati dalla polizia mentre trasportavano merce illegale sulla Venezia-Trieste. Il giro d’affari dei viaggi abusivi protetti dal giudice era di oltre 10 milioni di euro al mese. Raffaele Cantone, da pochi giorni nominato da Matteo Renzi presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, evidenzia come l’aumento dei crimini nei palazzi della legge può essere spiegato, in primis, «dall’enorme numero di processi che si fanno in Italia: una giustizia dei grandi numeri comporta, inevitabilmente, meno trasparenza, più opacità e maggiore difficoltà di controllo». I dati snocciolati tre mesi fa dal presidente della Cassazione Giorgio Santacroce mostrano che le liti penali giacenti sono ancora 3,2 milioni, mentre le cause civili arretrate (calate del 4 per cento rispetto a un anno fa) superano la cifra-monstre di 5,2 milioni. «Anche la farraginosità delle procedure può incoraggiare i malintenzionati» aggiunge Rossi. «Per non parlare del senso di impunità dovuto a leggi che - sulla corruzione come sull’evasione fiscale - sono meno severe rispetto a Paesi come Germania, Inghilterra e Stati Uniti: difficile che, alla fine dei processi, giudici e avvocati condannati scontino la pena in carcere». Tutto si muove attorno ai soldi. E di denaro, nei tribunali italiani, ne gira sempre di più. «Noi giudici della sezione Grandi Cause siamo un piccolo, solitario, malfermo scoglio sul quale piombano da tutte le parti ondate immense, spaventose, vere schiumose montagne. E cioè interessi implacabili, ricchezze sterminate, uomini tremendi... insomma forze veramente selvagge il cui urto, poveri noi meschini, è qualcosa di selvaggio, di affascinante, di feroce. Io vorrei vedere il signor ministro al nostro posto!», si difendeva Glauco Mauri mentre impersonava uno dei giudici protagonisti di “Corruzione a palazzo di giustizia”, pièce teatrale scritta dal magistrato Ugo Betti settant’anni fa. Da allora l’importanza delle toghe nella nostra vita è cresciuta a dismisura. «Tutto, oggi, rischia di avere strascichi giudiziari: un appalto, un concorso, una concessione, sono milioni ogni anno i contenziosi che finiscono davanti a un giudice», ragiona Rossi. I mafiosi nelle maglie larghe ne approfittano appena possono, e in qualche caso sono riusciti a comprare - pagando persino in prostitute - giudici compiacenti. In Calabria il gip di Palmi Giancarlo Giusti è stato arrestato dalla Dda di Milano per corruzione aggravata dalle finalità mafiose («Io dovevo fare il mafioso, non il giudice!», dice ironico Giusti al boss Giulio Lampada senza sapere di essere intercettato), mentre accuse simili hanno distrutto le carriere del pm Vincenzo Giglio e del finanziere Luigi Mongelli. A gennaio la procura di Catanzaro ha indagato un simbolo calabrese dell’antimafia, l’ex sostituto procuratore di Reggio Calabria Francesco Mollace, che avrebbe “aiutato” la potente ’ndrina dei Lo Giudice attraverso presunte omissioni nelle sue indagini. Sorprende che in quasi tutte le grandi istruttorie degli ultimi anni insieme a politici e faccendieri siano spesso spuntati nomi di funzionari di giustizia e poliziotti. Nell’inchiesta sulla cricca del G8 finirono triturati consiglieri della Corte dei Conti, presidenti di Tar e pm di fama (il procuratore romano Achille Toro ha patteggiato otto mesi), mentre nell’inchiesta P3 si scoprì che erano molti i togati in contatto con l’organizzazione creata da Pasquale Lombardi e Flavio Carboni per aggiustare processi. Anche il lobbista Luigi Bisignani, insieme al magistrato Alfonso Papa, aveva intuito gli enormi vantaggi che potevano venire dal commercio di informazioni segrete: la P4, oltre che di nomine nella pubblica amministrazione, secondo il pubblico ministero Henry Woodcock aveva la sua ragion d’essere proprio nell’«illecita acquisizione di notizie e di informazioni» di processi penali in corso. Secondo Cantone «nel settore giudiziario, e in particolare nei Tar e nella Fallimentare, si determinano vicende che dal punto di vista economico sono rilevantissime: che ci siano episodi di corruzione, davanti a una massa così ingente di denaro, è quasi fisiologico». I casi, in proporzione, sono ancora pochi, ma l’allarme c’è. Se i Tar di mezza Italia sono stati travolti da scandali di ogni tipo (al Tar Lazio è finito nei guai il giudice Franco Maria Bernardi; nelle Marche il presidente Luigi Passanisi è stato condannato in primo grado per aver accettato la promessa di ricevere 200 mila euro per favorire l’imprenditore Amedeo Matacena, mentre a Torino è stato aperto un procedimento per corruzione contro l’ex presidente del Tar Piemonte Franco Bianchi), una delle vicende più emblematiche è quella della Fallimentare di Roma. «Lì non ci sono solo spartizioni di denaro, ma anche viaggi e regali: di tutto di più. Una nomina a commissario giudiziale vale 150 mila euro, pagati al magistrato dal professionista incaricato. Tutti sanno tutto, ma nessuno fa niente», ha attaccato i colleghi il giudice Chiara Schettini, considerata dai pm di Perugia il dominus della cricca che mercanteggiava le sentenze del Tribunale della Capitale. Dinamiche simili anche a Bari, dove l’inchiesta “Gibbanza” ha messo nel mirino la sezione Fallimentare della città mandando a processo una quarantina tra giudici, commercialisti, avvocati e cancellieri. «Non bisogna stupirsi: il nostro sistema giudiziario soffre degli stessi problemi di cui soffre la pubblica amministrazione», spiega Daniela Marchesi, esperta di corruzione e collaboratrice della “Voce.info”. Episodi endemici, in pratica, visto che anche Eurostat segnala che il 97 per cento degli italiani considera la corruzione un fenomeno “dilagante” nel Paese. «Mai visto una città così corrotta», protesta uno dei magistrati protagonisti del dramma di Betti davanti all’ispettore mandato dal ministro: «Il delitto dei giudici, in conclusione, sarebbe quello di assomigliare un pochino ai cittadini!». Come dargli torto?
Così le coop hanno riempito Roma di profughi e campi rom. "Gli immigrati rendono più della droga". Ecco perché, nonostante il tetto di 250 profughi, a Roma ce ne sono più di 2.500, scrive Andrea Indini su “Il Giornale”. "Tu c’hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno". Massimo Carminati aveva un braccio destro proveniente dall'estrema sinistra. Ma Salvatore Buzzi, 59 anni, arrestato con il presunto capo della "Mafia Capitale", intercettato dai carabinieri diceva candidamente che "la politica è una cosa, gli affari sò affari". E lui, condannato in passato per omicidio, si era inventato prima una cooperativa sociale con ex detenuti, poi aveva creato un piccolo impero nel settore. Capace di mettere al tavolo - in senso letterale - esponenti di destra e di sinistra, a lui Carminati aveva chiesto di "mettersi la minigonna e battere" per ingraziarsi la nuova giunta Marino. Perché, grazie alla sua cooperativa e al sodalizio con l'ex vicecapo di gabinetto di Walter Veltroni, Luca Odevaine, facevano tutti una "paccata" di soldi coi fondi per l'accoglienza degli immigrati e per la gestione dei campi nomadi. "Quando la Lega denunciava che c’è gente che si arricchisce grazie alla presenza di Rom e immigrati eravamo razzisti: adesso che a Roma è venuto fuori, forse abbiamo ragione noi?". La denuncia di Matteo Salvini corre su Facebook. E incarna un mal di pancia tutto romano nei confronti del Campidoglio. Il bubbone capitolino esplode a pochi giorni dalle proteste e dagli scontri di Tor Sapienza. Altro che accoglienza, dietro al traffico di immigrati e profughi ci sarebbe un vero e proprio giro d'affari. Che guarda alle cooperative rosse. Il link col welfare è proprio Buzzi, il "braccio destro imprenditoriale" del Nero. Il gip Flavia Costantini nell'ordinanza d’arresto descrive "il suo ruolo apicale indiscusso, la sua posizione di primazia nel settore dell’organizzazione volto alla sfera pubblica, la sua presenza operativa in tutti i numerosissimi reati commessi nel settore". Lui, signore delle coop, lo dice chiaramente in un’intercettazione allegata all’ordinanza di circa 1200 pagine: "Il traffico di droga rende meno". L’affare dei centri di accoglienza per rifugiati e immigrati è, secondo la procura di Roma, garantito da Odevaine, descritto nell’ordinanza come "un signore che attraversa, in senso verticale e orizzontale, tutte le amministrazioni pubbliche più significative nel settore dell’emergenza immigrati". I fondi per i centri d’accoglienza sono un piatto ricco. Gli inquirenti lo chiamano, appunto, "sistema Odevaine". "La gestione dell’emergenza immigrati è stato ulteriore terreno, istituzionale ed economico, nel quale il gruppo si è insinuato con metodo eminentemente corruttivo – si legge nell'ordinanza del gip Costantini – alterando per un verso i processi decisionali dei decisori pubblici, per altro verso i meccanismi fisiologici dell’allocazione delle risorse economiche gestite dalla pubblica amministrazione". Un sistema studiato per far arrivare i soldi pubblici ai gestori amici che "si dividono il mercato". La "qualità pubblicistica" di Odevaine sta tutta nella possibilità di sedere al Tavolo di coordinamento nazionale insediato al ministero dell’Interno e, al tempo stesso, di essere uno degli esperti del presidente del Cda per il Consorzio "Calatino Terra d’Accoglienza", l'ente che soprintende alla gestione del Cara di Mineo. In una intercettazione è lo stesso Odevaine a spiegare al commercialista che, "avendo questa relazione continua" con il Viminale, è "in grado un po’ di orientare i flussi che arrivano da… da giù… anche perché spesso passano per Mineo… e poi… vengono smistati in giro per l’Italia… se loro c’hanno strutture che possono essere adibite a centri per l’accoglienza da attivare subito in emergenza… senza gara… le strutture disponibili vengono occupate… e io insomma gli faccio avere parecchio lavoro…". Siriani, libici, tunisini e iracheni. Tutti smistati a Roma, tra Caracolle e Tor Sapienza. I residenti delle banlieue capitoline lo dicevano che, forse forse, erano un filino troppi. È lo stesso Odevaine a spiegare il perché: "I posti Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ndr) che si destinano ai comuni in giro per l'Italia fanno riferimento a una tabella tanti abitanti tanti posti Sprar... per quella norma a Roma toccherebbero 250 posti... che è un assurdo... pochissimo per Roma, no?... allora... una mia... un mio intervento al ministero ha fatto in modo che... lo Sprar a Roma... fosse portato a 2.500 per cui si sono presentati per 2.500 posti... di cui loro... secondo me ce n'hanno almeno un migliaio". Insomma, a Roma erano destinati 250, ma grazie allo zampino di Odevaine i posti sono lievitati a dieci volte tanto, in modo che almeno mille venissero "ospitati" nelle case accoglienza di Buzzi. Per questo "servizio" l'ex vicecapo gabinetto di Veltroni riceveva un regolare stipendio da 5mila euro. La cupola di Mafia Capitale specula (e fa affari) con qualsiasi emergenza della Capitale. Dal maltempo ai protocolli per la prevenzione del rischio, dal servizio giardini del comune alla raccolta differenziata. Ma, soprattutto, con i fondi per la costruzione e la gestione dei campi nomadi. Gli inquirenti hanno, infatti, messo a nudo la capacità di interferire nelle decisioni dell’Assemblea Capitolina in occasione della programmazione dei bilanci pluriennale in modo da "ottenere l’assegnazione di fondi pubblici" per rifinanziare i campi nomadi, la pulizia delle aree verdi e il progetto "Minori per l’emergenza Nord Africa". Tutti settori in cui operano le società cooperative di Buzzi. "Noi quest'anno abbiamo chiuso... con quaranta milioni di fatturato - spiega lo stesso Buzzi - ma tutti i soldi... gli utili li abbiamo fatti sui zingari, sull'emergenza alloggiativa e sugli immigrati, tutti gli altri settori finiscono a zero".
Inchieste e scandali, quante ombre sulle cooperative rosse, scrive Alessandro Genovesi su “Ibsnews”. Dentro gli scandali degli ultimi tempi, su tutti l'EXPO, un ruolo nient'affatto marginale è stato giocato dalle cosiddette cooperative rosse. Si guardi, tanto per non fare nomi, al gigante Manutencoop Facility Management e al suo presidente Claudio Levorato, iscritto nel registro degli indagati per concorso in turbativa d'asta e utilizzazione di segreti d'ufficio. Per il manager di Manutencoop i PM della procura della Repubblica di Milano avevano addirittura chiesto anche l'applicazione di misure cautelari. Tuttavia il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta, ritenendo che nei confronti di Levorato non sussistessero le esigenze cautelari richieste dal codice di procedura penale. Un'ombra piuttosto imbarazzante per il mondo delle coop, da sempre legato a doppio filo alla sinistra, in tutte le sue diverse declinazioni (PCI-PDS-PD). Vedasi, ad esempio, il caso di Giuliano Poletti, ministro del Lavoro del governo Renzi dopo essere stato per anni Presidente di Legacoop. Ma gli intrecci delle cooperative vanno al di là della politica. Sentite, a tal proposito, cosa ha detto la segretaria CGIL, Susanna Camusso, in occasione del congresso di Rimini del mese scorso: "Sappiamo bene che veniamo dalle stesse radici, ma proprio per questo ci indigniamo di più quando non si riesce a dare risposta al tema della falsa cooperazione, quando si usano appalti alla qualunque e non si firmano i contratti, quando si disdettano gli accordi come una qualunque catena straniera della grande distribuzione. Ci indigniamo non per la presenza di soci lavoratori, ma se sono tali solo per non applicare i contratti, che lo si faccia nella cooperazione industriale o in quella sociale, non va bene". Parole dure e inconsuete, se si pensa al triangolo PCI-COOP-CGIL che per decenni ha costituito un inscalfibile centro di potere e di interesse. Parole, ci permettiamo di osservare, anche tardive: da molti anni oramai le cooperative si comportano alla stessa maniera delle aziende di tipo "capitalista", vale a dire mettendo, nella scala delle priorità, molto avanti i profitti e molto indietro i diritti dei lavoratori-soci. Quando va bene. Perché quando va male, ad essere aggirate sono le norme del codice penale. Oltre al caso Manutencoop, ancora tutto da dimostrare, sono in corse altre indagini che coinvolgono altri colossi del mondo cooperativo. Si pensi alla CMC, società con sede a Ravenna che si occupa di costruzioni, finita agli onori della cronaca per il caso del "porto fantasma" di Molfetta, cantiere aperto - secondo l'ipotesi accusatoria della procura di Trani - per incassare i contributi pubblici poi stornati verso altri impieghi. La CMC, per non farsi mancare nulla, è implicata anche nell'inchiesta sulla bonifica dell'area Rho-Pero, che fa parte dell'operazione Expo, con l'accusa a un suo esponente di aver corrotto il direttore tecnico del cantiere perché non ostacolasse il lavoro della cooperativa. Anche altri due giganti del mattone come Coopsette e Unieco sono finiti nell'occhio del ciclone l'anno scorso quando, in occasione dell'arresto del Presidente della regione Umbria Maria Rita Lorenzetti, i magistrati hanno ipotizzato l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata proprio a finanziare indirettamente le due cooperative, entrambe in odore di fallimento. Insomma, altro che solidarietà e tutela del lavoro. Le COOP sono ormai perfettamente integrate nel capitalismo all'italiana, dove la spintarella, l'aiutino e la mazzetta la fanno da padrone, alla faccia dei "sacri" valori del libero mercato.
Coop rosse di vergogna tra inchieste e lotte sindacali. Ora nel mirino della Cgil, scrive Giorgio Meletti su Il Fatto Quotidiano di mercoledì 14 maggio 2014. L'indagine sulle tangenti per l'Expo milanese fotografa un mondo allo sbando. Orfano della politica, ostaggio di padri-padroni inamovibili. Il coinvolgimento nell'inchiesta del gigante Manutencoop e del suo presidente Claudio Levorato non sorprende. La settimana scorsa un duro attacco era arrivato dal segretario generale Susanna Camusso: “Sappiamo bene che veniamo dalle stesse radici, ma proprio per questo ci indigniamo di più quando non si riesce a dare risposta al tema della falsa cooperazione". Altro che magistrati. L’attacco più duro alle coop cosiddette rosse è venuto dal capo della Cgil, Susanna Camusso. La settimana scorsa, chiudendo il congresso di Rimini, il segretario generale del primo sindacato italiano ha riservato alle cooperative parole al vetriolo: “Sappiamo bene che veniamo dalle stesse radici, ma proprio per questo ci indigniamo di più quando non si riesce a dare risposta al tema della falsa cooperazione, quando si usano appalti alla qualunque e non si firmano i contratti, quando si disdettano gli accordi come una qualunque catena straniera della grande distribuzione. Ci indigniamo non per la presenza di soci lavoratori, ma se sono tali solo per non applicare i contratti, che lo si faccia nella cooperazione industriale o in quella sociale, non va bene”. I fendenti di Camusso sono in parte strumentali, giusto per castigare un po’ il ministro del Lavoro Giuliano Poletti che ha appena lasciato la presidenza di Legacoop per farsi interprete del verbo renziano sul mercato del lavoro. Ma non nuovi. Negli anni 90 il suo predecessore Sergio Cofferati già parlava di cooperative “che considerano il lavoro come occasione di profitto sulla pelle dei giovani”. Insomma, è da almeno vent’anni che le coop hanno scoperto il mercatismo e sciolto ogni legame con i valori laburisti e solidaristi. Rivendicano di essere aziende come le altre, e si comportano di conseguenza. Non solo calpestando quando serve i diritti dei loro dipendenti – che molto spesso non sono nemmeno soci, cosicché la cooperative che li assume più che di lavoratori si potrebbe definire di datori di lavoro. Ma anche infischiandosene del codice penale nella stessa misura delle normali imprese private, sebbene pretendano di vedersi ancora riconosciuta una superiorità morale. Il coinvolgimento del gigante Manutencoop e del suo presidente Claudio Levorato nell’inchiesta sulle tangenti per l’Expo milanese non sorprende. La presunzione d’innocenza è fuori discussione, naturalmente, ma l’interessato deve invocarla anche per lo scandalo degli appalti della Asl di Brindisi, per il quale proprio la settimana scorsa sono state chiuse le indagini, e Levorato è uno dei 51 indagati. Il referente locale di Manutencoop, Mauro De Feudis è finito ai domiciliari e, secondo la procura di Brindisi, citata dalla Gazzetta del Mezzogiorno “candidamente afferma di aver richiesto l’intervento del legale rappresentante della Manutencoop Facility Management spa per risolvere la problematica relativa alla mancata assunzione di soggetti segnalati dal consigliere regionale De Leonardis che nel frattempo garantiva loro l’aggiudicazione illecita di appalti in tutto il territorio pugliese”. Il gigante delle costruzioni Cmc di Ravenna, che oggi deve la sua fama all’appalto per il tunnel di servizio dell’alta velocità in Val di Susa, è all’onore delle cronache per il caso del “porto fantasma” di Molfetta, cantiere aperto – secondo l’ipotesi accusatoria della procura di Trani – per incassare i contributi pubblici poi stornati verso altri impieghi. Il costruttore Enrico Maltauro e il faccendiere Sergio Cattozzo, intercettati prima di essere arrestati dai magistrati milanesi per l’Expo, mostrano di conoscere bene la vicenda. Dice Maltauro: “Il casino di Molfetta, non è solo un fatto di corruzione, ma c’è un fatto di truffa ai danni dello Stato”. Specifica Cattozzo: “Per cui i soldi per fare il porto li hanno utilizzati per altre cose”. A fine 2013 la Cmc è stata coinvolta nell’inchiesta sulla bonifica dell’area Rho-Pero, che fa parte dell’operazione Expo, con l’accusa a un suo esponente di aver corrotto il direttore tecnico del cantiere perché non ostacolasse il sereno dispiegarsi del lavoro della cooperativa. C’erano di mezzo questioni di rispetto dell’ambiente anche nell’inchiesta sul tunnel dell’alta velocità di Firenze, per la quale l’anno scorso fu arrestata la presidente di Italferr (gruppo Fs) Maria Rita Lorenzetti, ex presidente della regione Umbria. In quel caso i magistrati hanno ipotizzato un’associazione a delinquere il cui scopo principale era soccorrere una coop con i conti in difficoltà: “Pianificavano una serie di interventi a vasto raggio per influire e determinare le varie amministrazioni coinvolte, in maniera da superare ogni possibile ostacolo e intralcio agli obiettivi dell’associazione: ovverosia favorire al massimo in termini economici Nodavia e tramite essa Coopsette (di cui si teme la prossima insolvenza) a scapito dei costi dell’appalto e a danno delle casse dello Stato”. In effetti la Coopsette e la Unieco, due giganti del mattone cooperativo emiliano, hanno attraversato l’inferno del concordato preventivo e adesso si preparano a fondersi nella nuova Unisette per salvarsi. Evidentemente il ricorso al doping della corruzione, abbastanza tipico per le imprese italiane, è un vizietto che non risparmia le coop, soprattutto adesso che gli affari non vanno per niente bene. Storia antica anche qui. L’idea che esista un blocco compatto chiamato “coop rosse” e unito ai partiti della sinistra è superata nei fatti da un ventennio. Dopo la svolta della Bolognina è scomparso dalla scena il Pci che garantiva alle coop le loro quote di mercato al tavolo della spartizione degli appalti pubblici. I boiardi rossi hanno allora imparato ad arrangiarsi da soli, al grido di “ognuno per sé e tangenti per tutti”. Già il pool Mani pulite, indagando su Tangentopoli, scoprì con una certa sorpresa che era in corso una guerra feroce tra le coop emiliane e quelle lombarde per l’accesso al mercato della Lombardia, che le seconde impedivano alle prime. In uno scenario del genere la Legacoop si è trasformata da holding di fatto, quale era ai tempi del Pci a una pressoché inutile Confindustria delle coop. Poletti, per esempio, è stato tenuto rigorosamente all’oscuro dei traffici in corso tra le grandi coop del consumo per organizzare la scalata alla Fonsai da parte dell’Unipol di cui sono azioniste. E Poletti, come il suo successore Mauro Lusetti, si limitano a minimizzare come “casi isolati” gli scandali che coinvolgono grandi e piccole imprese cooperative. Non sorprende quindi che il risultato della “balcanizzazione” sia stato il consolidamento dei padri-padroni delle singole coop. Personaggi che già vent’anni fa l’allora presidente di Legacoop Lanfranco Turci, poco prima di essere fatto fuori, accusò di “spinte cesaristiche”. Gente come Levorato, presidente di Manutencoop da trent’anni, o come Turiddo Campaini, alla testa di Unicoop Firenze dal 1973, due anni prima della nascita di Matteo Renzi, o come Pier Luigi Stefanini, presidente di Unipol da otto anni dopo una vita alla Coop Adriatica. Logica conseguenza di questa parabola e di queste logiche spietate è ciò che rileva Camusso. Le coop si stanno sempre più spesso qualificando come datori di lavoro efferati. Sul Fatto del 16 marzo scorso Marco Palombi ha raccolto un florilegio di casi incredibili: “Sulla scheda di valutazione di un dipendente abbiamo letto che l’interessato non può essere promosso. Motivo? Fa il sindacalista. Non manca nemmeno l’ordinario marchionnismo: dal delegato Rsu trasferito o demansionato fino alla schedatura fotografica degli scioperanti”.
"Mafia Capitale". "A Roma non c'è un'unica organizzazione mafiosa a controllare la città. Ci sono diverse organizzazioni mafiose. Oggi abbiamo individuato quella che abbiamo chiamato Mafia Capitale, romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso", ha anche detto Pignatone in conferenza stampa il 2 dicembre 2014. "Ci sono approfondimenti in corso sul personale di forze dell'ordine ma l'operazione non si chiude oggi: la posizione di alcuni è al vaglio per favoreggiamento".
Non è più vero che il crimine non paga; rende, eccome. Perfino ai magistrati. Dopo le mazzette a giudici romani.
A volte ritornano anche i titoli dei giornali. Quello, celebre, dell’Espresso suonava così: “Capitale corrotta=nazione infetta”. Era il 1956, ma sembra ieri, nel senso proprio di ieri, se si guarda all’inchiesta esplosiva che a Roma ha appena portato in carcere 37 persone, indagandone altre cento per una serie di reati gravissimi, a partire dall’associazione mafiosa. Un intreccio tra affari, politica e delinquenza che sembra evocare anche un altro e più recente titolo di film e di puntate televisive tratte dal libro “Romanzo criminale”. Cinquantotto anni fa l’inchiesta a puntate dell’Espresso a firma Manlio Cancogni, denunciò con questo titolo, diventato famoso, la corruzione e la speculazione edilizia che strangolavano Roma. Oggi la situazione è molto peggiorata e Roma continua ad essere la vetrina di un’Italia ormai preda delle mafie, della corruzione politica e dello sfacelo ambientale. “Capitale corrotta, Nazione infetta” è il titolo della celebre inchiesta de L’Espresso del 1955, a firma di Mario Cancogni, sulla speculazione edilizia di Roma; un titolo riproposto diverse volte in occasione di scandali con conseguente indignazione popolare, come fu per Tangentopoli e come è stato negli ultimi mesi in occasione delle inchieste sugli appalti o sul finanziamento pubblico dei partiti. E’ un titolo che ci ricorda come in sessant’anni di vita democratica del nostro Paese alcuni vizi del potere non siano mai tramontati, seppur con declinazioni diverse a seconda delle circostanze e dei periodi storici.
"A Roma mi sento come nella mia Palermo" dice Maurizio Crozza truccato da Padrino nella copertina di "diMartedì" del 2 dicembre 2014 su La7. "I carabinieri hanno voluto fare un omaggio a Michelangelo: rinvio a giudizio universale, dall'affresco a tutti al fresco".
"Ci sono i vivi sopra e i morti sotto e noi in mezzo. C'è un mondo in cui tutti si incontrano, il mondo di mezzo è quello dove è anche possibile che io mi trovi a cena con un politico...", così Massimo Carminati nell'intercettazione di una conversazione tra lui e il suo braccio destro Brugia. "Carminati ha creato sinergie illecite con mondi diversissimi tra di loro - spiega il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone nel corso della conferenza stampa - La teoria del mondo di mezzo è un mondo in cui tutti si incontrano indipendentemente dal proprio ceto. Un mondo in cui tutto si mischia. Carminati parla con il mondo di sopra (ossia la politica e gli imprenditori) e con quello di sotto, ossia quello criminale. E' al servizio del primo avvalendosi del secondo soprattutto per il suo vantaggio".
"Il dieci mattina mi paghi te...nun sgarrà che vengo a casa..non capisci bene...io te taglio la gola il dieci matina...portami i soldi sennò t’ammazzo a te e tutti i tuoi figli", così un indagato in una delle intercettazioni telefoniche dei Ros.
Un approfondimento a 360 affinchè si superi quel vizio italiano per il quale, per partito preso, si considera criminale solo la parte avversa.
Mafia e politica a Roma, Buzzi: "C'ho quattro cavalli che corrono col Pd e tre col Pdl", scrive di Rita Cavallaro su “Libero Quotidiano”. Mafia Capitale, alla fine, è venuta alla luce. Ci sono voluti due anni d’indagini dei carabinieri del Ros, che hanno effettuato pedinamenti e intercettazioni. Giorno dopo giorno le «gesta» del gruppo dell’ex Nar Massimo Carminati sono finite sulle 1.249 pagine di ordinanza che hanno fatto scattare i 37 arresti di ieri e un centinaio di avvisi di garanzia. Nel faldone c’è di tutto: l’estrema destra eversiva che ha terrorizzato Roma negli anni ’70, ma anche insospettabili manager e politici locali. Che parlano, al telefono e in strada. Sicuri di non essere ascoltati e di poter controllare affari e appalti in barba alle regole della gestione pubblica. Le intercettazioni descrivono la cupola nera. E danno addirittura il nome all’operazione dei carabinieri. «Mondo di mezzo» nasce infatti dalle parole di Carminati, che in gergo spiega l’intreccio tra Mafia Capitale e amministratori. È l’11 gennaio 2013 e l’ultimo Re di Roma descrive con una metafora al suo braccio destro, Riccardo Brugia, i rapporti con i politici. «È la teoria del mondo di mezzo compà...ci stanno...come si dice...i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo. Ci sta un mondo...un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano e dici cazzo come è possibile che quello...il mondo di mezzo è quello invece dove tutto si incontra...cioè...hai capito?...si incontrano tutti là...ma non per una questione di ceto...per una questione di merito, no?...allora nel mezzo, anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno». Carminati si sente il padrone della città: «È il re di Roma che viene qua, io entro dalla porta principale». Lo dice chiaramente a un interlocutore davanti a un bar a Vigna Stelluti: «Nella strada tanto comandiamo sempre noi, nella strada tu c’avrai sempre bisogno». Non solo nella strada, anche nei palazzi, tanto che il «cecato» si prende la libertà di lamentarsi dell’ad di Eur Spa, Riccardo Mancini, chiamato «il sottoposto». «Vede io che gli combino...a me non mi rompesse il cazzo...a me me chiudesse subito la pratica là», dice a un sodale. In un’altra intercettazione diceva «passo le ’stecche» (la sua parte, a Mancini, ndr) per i lavori che fa, però l’altro giorno gli ho menato». Nelle carte ci sono pure le preoccupazioni dell’organizzazione criminale sulla probabile vittoria di Ignazio Marino al Campidoglio. Secondo gli inquirenti Salvatore Buzzi, braccio destro imprenditoriale di Carminati, «pone in essere l’avvicinamento dei decisori pubblici, sia con la vecchia che con la nuova amministrazione, in funzione degli interessi del sodalizio». E infatti, con l’avvento della nuova giunta, Buzzi entra in azione. «Eloquente esempio», per i magistrati, è l’attività di Buzzi che, «secondo l’indicazione strategica di Carminati di “mettere la minigonna e andare a battere con la nuova amministrazione”, nell'immediatezza del cambio di maggioranza politica al comune di Roma» cerca «con Coratti, presidente dell’assemblea Comunale di Roma Capitale» di intessere rapporti. A tal proposito a pagina 138 si citano Mirko Coratti e Franco Figurelli, suo capo segreteria, i quali, venivano interessati da Salvatore Buzzi affinché si occupassero di aggiudicarsi una gara d’appalto all’Ama, l’azienda dei rifiuti, di sbloccare i pagamenti sui servizi sociali forniti al Comune di Roma e di pilotare la nomina di un nuovo direttore del V Dipartimento. «Oh, me so’ comprato Coratti», dice Buzzi, che racconta anche come Figurelli veniva retribuito con 1.000 euro mensili, oltre a 10.000 euro pagati per poter incontrare il Presidente Coratti, mentre a quest’ultimo venivano promessi 150.000 euro qualora fosse intervenuto per sbloccare un pagamento di 3 milioni sul sociale. Sempre Buzzi parla con un’amica degli affari fatti con la gestione delle cooperative di immigrati. Dice la donna: «Perchè su Tivoli non è che un cantiere che ti guadagna miliardi». Lui: «Apposta tu c’hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Eh. Il traffico di droga rende di meno». Con un imprenditore, infine, Buzzi, spiega come funziona il sistema: «Tu li voti, vedi, i nostri sono molto meno ladri di...di quelli della Pdl». E poi aggiunge più avanti nella conversazione: «Ma lo sai agli altri soldi che gli do’ Giova’? Ma tu lo sai perché io c’ho lo stipendio, non c’hai idea di quante ce n’ho... non ce li hanno… pago tutti pago...Anche due cene con il sindaco settantacinquemilaeuro ti sembrano pochi? Oh so centocinquanta milioni eh. I miei ti posso assicura’ che non li pago». «Mo’ c’ho 4 cavalli che corrono col Pd e 3 col Pdl».
Roma tra mafia, sangue e giochi di potere nel libro "Grande raccordo criminale". Nell'inchiesta di Floriana Bulfon e Pietro Orsatti (Imprimatur), le connivenze e la violenza che stringono da tempo la Capitale e che oggi sono culminati con gli arresti di Massimo Carminati e altre cento persone. Eccone alcuni stralci, scrive “L’Espresso”. «E’ la terra di mezzo, i vivi sopra e i morti sotto, noi siamo nel mezzo, un mondo in cui tutti si incontrano, perché anche il sovramondo ha interesse che qualcuno del mondo di sotto faccia qualcosa nel suo interesse». Massimo Carminati, arrestato oggi con l’accusa di essere a capo della mafia Capitale, descrive così la terra di mezzo, quella in cui la criminalità e il potere si incontrano per fare affari. Quella in cui la corruzione lascia il posto alla violenza solo quando è necessario ribadire chi comanda. E’ Carminati per gli inquirenti a scegliere i dirigenti dell’Ama, l’azienda dei rifiuti di Roma, e persino il presidente della Commissione Trasparenza in Campidoglio ai tempi del sindaco Gianni Alemanno, oggi indagato per il reato di 416 bis, ossia l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Ed è sempre lui a tenere legami con l’ex vice capo di gabinetto della giunta Veltroni, Luca Odevaine, accusato di aver orientato le scelte sui flussi di migranti verso le strutture cooperative in mano a Carminati. Quella di Carminati è una figura di primo piano nella malavita romana. Il suo arresto mina alle fondamenta il crimine della Capitale. Grande raccordo criminale di Floriana Bulfon e Pietro Orsatti, edito da Imprimatur, è un'inchiesta che svela le connivenze, il sangue e la violenza che stringono da tempo la Capitale, ricostruendone i rapporti mafiosi e gli intrecci di potere che oggi sono emersi con l’operazione ‘Mondo di mezzo’. Ne riportiamo alcuni stralci. “«Non ama farsi vedere, tanto meno parlare. Si spiega più con i gesti. Ogni passo è una frustata, ogni movimento una scarica elettrica. Una forza gelida e oscura che ti inchioda a terra e non ti fa alzare lo sguardo». Una vita all’apparenza ordinaria: nessun lusso, nessuna ostentazione, nessuna retorica. «Niente inflessioni dialettali, niente eccessi. Sempre misurato e cortese». Si muove come un’ombra, raccontano. Massimo Carminati, un’ombra che fa tremare. A lui la Roma criminale si rivolgerebbe per le primizie, per avere un’intercessione negli affari che contano. Il suo nome si sussurra. Ed è già troppo farlo. In tanti gli tributano deferenza e rispetto. Tutti ne hanno paura. Non eserciterebbe il potere direttamente, preferirebbe valutare, mediare, e solo dopo decidere. Ma se qualcuno dei suoi è toccato, saprebbe come agire. Non ha amici, solo camerati. La fratellanza politica per lui sarebbe il valore più importante. E quei camerati, come li difendeva allora fisicamente, sembra sia pronto a difenderli anche ora. Sono pochi però, quelli fidati. In nome di quel senso di appartenenza a un gruppo ristretto e a un ideale che dalla gioventù ha portato con sé nell’età adulta. Appartenenza e coraggio. Pochi valori, infrangibili, che non si discutono mai. Carminati, il nero. È stato un terrorista dei Nar e accusato di essere killer al servizio della banda della Magliana. Anello di congiunzione tra la criminalità romana ed i gruppi eversivi di estrema destra. Al centro dei misteri più controversi della Repubblica Italiana, processato per rapine e omicidi, ne è uscito quasi sempre indenne. «Uno che non voleva porsi limiti nella sua vita spericolata, pronto a sequestrare, uccidere, rapinare, partecipare a giri di droga, scommesse, usura». Valerio Fioravanti l’ha descritto così. La violenza, un signum distinctionis.” “Potere che pare esplodere quando Gianni Alemanno varca la soglia del Campidoglio. Chi trent’anni fa ha condiviso la militanza nell’estremismo di destra sembra sappia di non potergli dire di no. Una famiglia con un legame più forte della parentela. Il vincolo della militanza politica, degli ideali, delle battaglie condivise, e anche dei segreti da custodire.” Gianni Alemanno oggi indagato per 416 bis. ( …) “Una corte di fedelissimi, tra cui molti ex di quella stagione di piombo, stretti ad Alemanno. Una corte di cui Carminati pare conosca ogni segreto. Le sue frequentazioni di Carminati del resto possono arrivare ovunque, lui vanterebbe sempre ottima accoglienza, da Gennaro Mokbel, prodotto glocal di una Roma oscura, a Lorenzo Cola, superconsulente di Finmeccanica, negoziatore di accordi da miliardi di euro, in rapporto con agenti segreti di tutti i continenti.”
Roma, le mani della mafia nera sulla città. L'operazione "Terra di mezzo" svela l'alleanza fra la politica, l'eversione neofascista e la criminalità comune per gestire gli affari sporchi, scrive “Panorama”. Un'alleanza di ferro fra mafia, politica, frammenti dell'estrema destra eversiva e la criminalità comune. L'ha rivelata l'operazione "Terra di mezzo", condotta ieri dai Ros e guidata dalla Procura di Roma, che ha portato all'arresto di 37 persone e ha coinvolto fra gli indagati anche l'ex sindaco Gianni Alemanno, che dice: sono estraneo alla faccenda e lo dimostrerò. Obiettivo dell'offensiva la una cupola nera che ha gestito gli affari romani per anni pilotando appalti, riciclando denaro che scotta, alleandosi con i clan emergenti del litorale capitolino, con boss in odore di camorra come Michele Senese e con politici e burocrati spregiudicati e corrotti. Un'inchiesta che è solo all'inizio ed è destinata a segnare la storia della capitale. Roma appare così come una Capitale della Mafia dove ogni affare veniva gestito dal malaffare. Dove quei personaggi finiti nei libri e nei film, come il "Nero" Massimo Carminati, ex Nar accusato di legami con la Banda della Magliana, in realtà erano attivissimi e contemporanei. L'organizzazione, dicono gli inquirenti, aveva modus operandi e radicamento propri della mafia. Col valore aggiunto criminale di un filo nerissimo che lega molti dei personaggi principali, con trascorsi nell'eversione di destra. Massimo Carminati è dunque il protagonista, guida l'organizzazione, usando minacce e violenza, e manovra il potente di turno, l'imprenditore, il professionista e il manager di Stato. Carminati di fatto gestiva un ecosistema versatile: dagli appalti all'estorsione, dall'usura al recupero crediti. Aveva contatti con manager, politici e col crimine di ogni specie: da Michele Senese, boss in odore di Camorra, alla "batteria" di Ponte Milvio che controlla i locali della movida romana, dalla potente famiglia nomade romana dei Casamonica alla spiccia criminalità di strada. L'organizzazione, secondo l'accusa, ha potuto contare anche su figure di vertice dell'amministrazione capitolina dal 2008 al 2013. Per i magistrati guidati da Giuseppe Pignatone il clan era arrivato anche all'ex sindaco Gianni Alemanno, indagato per associazione a delinquere, e ai suoi uomini. In manette, nell'operazione congiunta di Ros e Guardia di Finanza, sono finiti infatti l'ex amministratore dell'Ente Eur, Riccardo Mancini (da sempre braccio destro di Alemanno) e quello dell'Ama, Franco Panzironi. I due erano "pubblici ufficiali a libro paga" che fornivano "all'organizzazione uno stabile contributo per l'aggiudicazione degli appalti". I due manager si sono adoperati anche per "lo sblocco dei pagamenti in favore delle imprese riconducibili all'associazione e come garanti dei rapporti dell'associazione con l'amministrazione comunale". Di fatto quello presieduto da Carminati è a tutti gli effetti un comitato d'affari che copriva tutti i settori produttivi della Capitale compreso il business dell'accoglienza degli immigrati e quello dei campi nomadi. Tra gli arrestati c'e' anche Luca Odevaine, già capo di gabinetto nel 2006 dell'allora sindaco di Valter Veltroni, che nella sua qualità di appartenente al Tavolo di Coordinamento Nazionale sull'accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale ha orientato, in cambio di uno "stipendio" mensile di 5 mila euro garantito dal clan, le scelte del tavolo per l'assegnazione dei flussi di immigrati alle strutture gestite da uomini dell'organizzazione. Tra gli indagati anche tre esponenti di punta dell'attuale amministrazione capitolina: l'assessore alla casa Daniele Ozzimo e il presidente dell'assemblea capitolina Mirco Coratti, entrambi del Pd, che si sono gia' dimessi pur dichiarandosi "estranei". Indagato anche il responsabile della Direzione Trasparenza del Campidoglio, Italo Walter Politano, che domani sarà rimosso dal suo incarico. Oltre a Massimo Carminati, tra le carte si incontrano altre conoscenze tra eversione nera e crimine. Gennaro Mokbel, ex militante nella gioventù nera romana e Marco Iannilli, commercialista, già coinvolti nella maxi truffa di 2,2 milioni di euro Fastweb-Telecom Italia Sparkle. Il fedele del sindaco Alemanno, anche lui indagato per associazione di stampo mafioso, Riccardo Mancini, ex ad di Ente Eur, già coinvolto nell'inchiesta su una presunta tangente per la fornitura di bus per il corridoio Laurentina a Roma. E poi Franco Panzironi, ex ad di Ama, coinvolto nell'ormai famosa Parentopoli della municipalizzata romana. E nell'ordinanza spunta pure il nome di Lorenzo Alibrandi, fratello dell'ex Nar Alessandro, morto nel 1981 in un conflitto a fuoco. Prima di approdare nella maxi inchiesta, gli intrecci pericolosi tra clan emergenti, politica e affari tutti romani erano emersi di recente soprattutto dalle indagini su un delitto "per caso", ovvero l'omicidio di Silvio Fanella, custode di un vero e proprio tesoro per conto della galassia nera romana. Fanella era il cassiere di Mokbel: un commando nel luglio scorso lo voleva prelevare dalla sua abitazione romana ma qualcosa andò storto e il tentativo di sequestro finì con la morte di Fanella. A capo del commando c'era un ex componente dei Nar, Egidio Giuliani. Un nome non indifferente tra gli addetti ai lavori. Ex compagno di cella del killer Pierluigi Concutelli, (condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio) e accusato di voler ricostruire gruppi eversivi di destra negli anni '90, Giuliani avrebbe avuto in passato collegamenti anche con la banda della Magliana. E nel gruppo di fuoco anche un ex di Casapound, Giovanni Battista Ceniti. Dopo l'omicidio Fanella fu ritrovato anche il tesoro: 34 sacchetti con diamanti purissimi che si sono lasciati alle spalle anche una scia di sangue fatta di omicidi e ferimenti. I diamanti, uno dei beni di lusso favoriti dal gruppo "nero" di Mokbel - secondo i magistrati - per riciclare i fiumi di denaro frutto di truffe e malaffare.
Mafia, arrestato il re di Roma Massimo Carminati. Indagato Gianni Alemanno. Una holding criminale che spaziava dalla corruzione all'estorsione, dall'usura al riciclaggio, con infiltrazioni “diffuse” nel tessuto imprenditoriale politico e istituzionale. E' ciò che emerge dall'inchiesta della procura di Roma che ha portato all'arresto di 28 persone. Indagini sull'ex sindaco e altri politici capitolini, scrive Lirio Abbate su “L’Espresso”. L'arresto di Carminati Il “re di Roma” Massimo Carminati è stato arrestato nell'ambito di una grande operazione per associazione mafiosa ordinata dai pm della Procura di Roma ed eseguita dai carabinieri del Ros. Una holding criminale che spaziava dalla corruzione, per aggiudicarsi appalti, all'estorsione, all'usura e al riciclaggio, con infiltrazioni “diffuse” nel tessuto imprenditoriale politico e istituzionale. Un'organizzazione radicata a Roma con a capo Massimo Carminati. Carminati, Fasciani, Senese e Casamonica. Ecco i boss che si sono spartiti il controllo della città. Mettendo a freno omicidi e fatti di sangue troppo eclatanti per garantire il silenzio sui propri traffici. In cella sono finite 28 persone, ma in totale nell'inchiesta coordinata dal procuratore capo Giuseppe Pignatone, dall'aggiunto Michele Prestipino e dai sostituti Paolo Ielo, Giuseppe Cascini e Luca Tescaroli, sono indagate 37 persone, fra queste anche l'ex sindaco Gianni Alemanno, accusato di reati collegati alla mafia. Indagati politici di destra e sinistra. E beni per un valore complessivo di 200 milioni di euro sono stati sequestrati agli indagati, in particolare a Carminati, che è risultato di fatto proprietario di immobili e attività commerciali intestati a prestanome. Il momento dell'arresto dell'ex terrorista dei Nar nella maxi operazione a Roma per associazione di stampo mafioso. Tra i 37 finiti in manette anche l'ex ad dell'Ente Eur, Riccardo Mancini, l'ex presidente di Ama, Franco Panzironi e Luca Odevaine, a capo della polizia provinciale. I magistrati hanno disposto decine di perquisizioni, in particolare negli uffici della Regione Lazio e del Campidoglio. I carabinieri del Ros stanno acquisendo documenti presso gli uffici della Presidenza dell'Assemblea Capitolina e presso alcune commissioni della Regione Lazio. Perquisizioni negli uffici del consigliere regionale Pd Eugenio Patanè e di quello Pdl Luca Gramazio, e in Comune negli uffici del presidente dell'Assemblea capitolina Mirko Coratti, il quale in serata si è dimesso dall'incarico, dichiarandosi, tuttavia, «totalmente estraneo a quanto emerge in queste ore dalle indagini». È un'indagine che non ha precedenti nella storia giudiziaria della Capitale, da cui emerge che Roma non è una città, ma un intreccio di traffici e intrallazzi, delitti e truffe, su cui si è imposta una cupola nera. Invisibile ma potentissima, ha preso il controllo di Roma. Trasformando la metropoli nel laboratorio di una nuova forma di mafia, comandata da estremisti di destra di due generazioni, con la complicità di uomini della sinistra. Al vertice ci sono vecchi nomi, veterani degli anni di piombo, abituati a trattare con le istituzioni e con i padrini, abili a muoversi nel palazzo e sulla strada. Ai loro ordini c’è un’armata bifronte, che unisce banditi e narcos, manager nostalgici e giovani neofascisti. L’ideologia garantisce compattezza, il credo nell’azione e nella sfida. I soldi, tanti e subito, premiano la fedeltà. E la componente borghese, dai maturi colletti bianchi ai ragazzi in camicia nera, gli permette di arrivare ovunque. Con le buone o con le cattive. Per comprendere bene cosa accade oggi nella Capitale, in questo grande spazio circoscritto dal Grande raccordo anulare, occorre mettere da parte quello che accade a Napoli, a Palermo o a Reggio Calabria. È nella Capitale che ha messo radici un sistema criminale senza precedenti, con fiumi di cocaina e cascate di diamanti, ma anche tanto piombo. Per il procuratore Giuseppe Pignatone «a Roma non c'è un'unica organizzazione mafiosa a controllare la città. Ci sono diverse organizzazioni mafiose. Oggi abbiamo individuato quella che abbiamo chiamato “mafia Capitale”, romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso». L'ex ad dell'Ente Eur, Riccardo Mancini, e l'ex amministratore di Ama, Franco Panzironi, arrestati entrambi, rappresentano per i pm «pubblici ufficiali a libro paga che forniscono all'organizzazione uno stabile contributo per l'aggiudicazione degli appalti». I due manager si adoperavano anche per «lo sblocco dei pagamenti in favore delle imprese riconducibili all'associazione e tra il 2008 e il 2013 come garanti dei rapporti dell'associazione con l'amministrazione comunale». Per quanto riguarda un altro manager, Fabrizio Franco Testa, invece, per i magistrati è «una testa di ponte dell'organizzazione nel settore politico e istituzionale, coordinando le attività corruttive dell'associazione e occupandosi della nomina di persone gradite al sodalizio in posti chiavi della pubblica amministrazione». Fra i cento indagati c'è anche il nome dell'uomo d'affari Gennaro Mokbel, accusato di tentata estorsione, avrebbe preteso dal commercialista Marco Iannilli la restituzione di circa 7-8 milioni di euro che gli aveva messo a disposizione perchè fosse investita nell'operazione Digint. Secondo i pm Mokbel già condannato a 15 anni di carcere per la truffa ai danni delle compagnie telefoniche Tis e Fastweb, ha desistito dopo l'intervento di Massimo Carminati che ha operato in difesa di Iannilli. «Nel marzo 2013 nel Cda dell'Ama viene nominato con provvedimento del sindaco Alemanno un legale scelto da Carminati stesso. Lo stesso per il direttore generale di Ama e un altro dirigente operativo». Lo ha detto il procuratore aggiunto di Michele Prestipino descrivendo «l'incessante attività di lobbying» dell'organizzazione criminale individuata «per collocare con successo manager asserviti ai loro interessi». Prestipino ha citato anche la nomina del presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Roma e la candidatura a sindaco di Sacrofano - dove risiede Massimo Carminati - di un uomo fidato poi eletto. Uomini delle forze dell'ordine sono iscritti nel registro degli indagati per favoreggiamento al clan di Carminati. I pm stanno vagliando la loro posizione per comprendere il ruolo che hanno avuto nell'organizzazione di “mafia Capitale”. Appalti per decine di milioni di euro a società collegate a Massimo Carminati, considerato il capo dell'organizzazione mafiosa, in cambio di tangenti per centinaia di migliaia di euro. È il “patto corruttivo-collusivo” descritto dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. «In cambio di appalti a imprese amiche venivano pagate tangenti fino a 15 mila euro al mese per anni. Ma anche centinaia di migliaia di euro in un solo colpo». Tra gli appalti pubblici Prestipino ha citato quello del 2011 per la raccolta differenziata dei rifiuti del Comune di Roma e quello per la raccolta delle foglie. Su altri appalti dell'Ama, municipalizzata romana dei rifiuti, per altri cinque milioni di euro sono in corso approfondimenti d'indagine. «L'organizzazione scoperta a Roma affonda le sue radici nella criminalità organizzata degli anni Ottanta, ma ha saputo riciclarsi con una duttilità sorprendente». Lo ha spiegato il comandante dei carabinieri del Ros, generale Mario Parente. «Un'evoluzione del sodalizio che però rimane sempre ancorato alle sue radici, ovvero quelle criminali».
Mafia a Roma, 37 arresti per appalti del Comune. Indagato Alemanno. Pignatone: "Gli uomini dell'ex sindaco nell'organizzazione". In carcere l'ex Nar Carminati e l'ex ad dell'Ente Eur Mancini. L'ex primo cittadino: "Ne uscirò a testa alta". Un centinaio gli indagati, tra cui l'assessore alla Casa, Daniele Ozzimo e Mirko Coratti, presidente dell'Assemblea capitolina, entrambi si sono dichiarati "estranei ai fatti" e si sono dimessi. Coinvolto anche Politano, responsabile della direzione Trasparenza e Anticorruzione del Comune di Roma. Perquisizioni alla Pisana e in altre amministrazioni della Capitale. Sequestri per 200 milioni della Guardia di finanza. L'indagine ribattezzata "Mondo di mezzo". Affari nella gestione dei rifiuti, manutenzione del verde e campi nomadi, scrivono Federica Angeli, Valeria Forgnone e Viola Giannoli su “La Repubblica”. Massimo Carminati Maxi operazione a Roma per "associazione di stampo mafioso" con 37 arresti, di cui 8 ai domiciliari, e sequestri di beni per 200 milioni. Un "ramificato sistema corruttivo" in vista dell'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici dal Comune di Roma e dalle aziende municipalizzate con interessi, in particolare, anche nella gestione dei rifiuti, dei centri di accoglienza per gli stranieri e campi nomadi e nella manutenzione del verde pubblico: è quanto emerso dalle indagini del Ros che hanno portato alle misure restrittive e ai sequestri da parte del Gico della Finanza. Le accuse vanno dall'associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e altri reati. "Con questa operazione abbiamo risposto alla domanda se la mafia è a Roma - ha spiegato il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, nel corso della conferenza stampa dopo la maxi-operazione - Nella capitale non c'è un'unica organizzazione mafiosa a controllare la città ma ce ne sono diverse. Oggi abbiamo individuato quella che abbiamo chiamato 'Mafia Capitale', romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso". Nello specifico, ha riferito Pignatone, "alcuni uomini vicini all'ex sindaco Alemanno sono componenti a pieno titolo dell'organizzazione mafiosa e protagonisti di episodi di corruzione. Con la nuova amministrazione il rapporto è cambiato ma Massimo Carminati e Salvatore Buzzi (presidente della cooperativa 29 giugno arrestato oggi) erano tranquilli chiunque vincesse le elezioni". Gli arresti. A capo dell'organizzazione mafiosa l'ex terrorista dei Nar, Massimo Carminati che, secondo gli investigatori, ''impartiva le direttive agli altri partecipi, forniva loro schede dedicate per comunicazioni riservate e manteneva i rapporti con gli esponenti delle altre organizzazioni criminali, con pezzi della politica e del mondo istituzionale, finanziario e con appartenenti alle forze dell'ordine e ai servizi segreti''. L'organizzazione di Carminati è trasversale. Ne è convinto il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone che sull'argomento ha precisato: "Con la nuova consiliatura qualcosa è cambiato, in una conversazione Buzzi e Carminati prima delle elezioni dicevano di essere tranquilli". Carminati diceva a Buzzi, ha spiegato Pignatone: "Noi dobbiamo vendere il prodotto, amico mio, bisogna vendersi come le puttane" e di fronte alle difficoltà presentate da Buzzi, Carminati aggiungeva: "Allora mettiti la minigonna e vai a battere con questi".
Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma dal 2008 al 2013. Ancora da verificare il ruolo che ha avuto nell'ingresso dell'associazione criminale e delle sue aziende di riferimento all'interno degli appalti più importanti assegnati dal Campidoglio.In mattinata è stata perquisita la sua casa nel quartiere Camilluccia a Roma.
Massimo Carminati, da molti considerato il vero capo della criminalità romana. Conosciuto da molti come il "Nero" del libro "Romanzo Criminale", è finito nelle pagine più oscure della storia italiana, dalla strage alla stazione di Bologna fino all'omicidio Pecorelli, processi da cui è uscito assolto.
Franco Panzironi, già indagato per la Parentopoli Ama, ora sarebbe un altro dei personaggi chiave dell'associazione criminale. Il suo ruolo sarebbe stato quello di ponte con l'Ama e con tutti gli appalti assegnati dall'azienda romana dei rifiuti. Panzironi ha legato la sua storia recente a Gianni Alemanno. E' accusato di associazione di tipo mafioso, corruzione aggravata e turbativa d'asta.
Riccardo Mancini è un altro nome chiave della vicenda. Da sempre legato all'estrema destra romana e in particolare a quella dell'Eur. Ha guidato l'Ente Eur ed è già sotto inchiesta per la tangente pagata da una società legata al Gruppo Finmeccanica per i filobus della Laurentina. E' accusato di associazione di tipo mafioso.
In carcere è finito anche Luca Odevaine, ex capo di gabinetto della giunta Veltroni e ora direttore extradipartimentale di polizia e Protezione civile della Provincia di Roma. L'accusa parla di corruzione aggravata.
Giovanni Fiscon, attuale direttore generale dell'Ama: è stato arrestato per corruzione aggravata e turbativa d'asta.
Daniele Ozzimo, assessore capitolino alla Casa: è indagato a piede libero per corruzione aggravata. Si è dimesso dall'incarico: "Pur essendo totalmente estraneo allo spaccato inquietante che emerge dagli arresti, rimetto il mio mandato per senso di responsabilità e serietà. Una scelta sofferta perchè sono orgoglioso del lavoro portato avanti in questi mesi".
Mirko Coratti, presidente dell'assemblea capitolina: è indagato a piede libero per corruzione aggravata e illecito finanziamento. Si è immediatamente dimesso dall'ìncarico: "Sono estraneo, ho piena fiducia nel lavoro della magistratura ma mi dimetto per correttezza verso la città e l'amministrazione".
Eugenio Patanè, consigliere regionale del Pd: è indagato a piede libero per turbativa d'asta e illecito finanziamento.
Antonio Lucarelli, capo segreteria di Alemanno durante il suo mandato di sindaco: è accusato di associazione di tipo mafioso.
Luca Gramazio, consigliere regionale Pdl: è indagato a piede libero per associazione di tipo mafioso, corruzione aggravata e finanziamento illecito.
Tra gli arrestati anche altri nomi di spicco come l'ex ad dell'Ente Eur, Riccardo Mancini e l'ex presidente di Ama, Franco Panzironi: per i pm romani "pubblici ufficiali a libro paga che forniscono all'organizzazione uno stabile contributo per l'aggiudicazione degli appalti". E Luca Odevaine, ex capo di gabinetto della giunta Veltroni e ora direttore extradipartimentale di polizia e Protezione civile della Provincia di Roma. Gli indagati. Fra gli indagati figura l'ex sindaco della città Gianni Alemanno, la sua abitazione è stata perquisita. "Chi mi conosce sa bene che organizzazioni mafiose e criminali di ogni genere io le ho sempre combattute a viso aperto e senza indulgenza - ha commentato a caldo l'ex primo cittadino - Dimostrerò la mia totale estraneità ad ogni addebito e da questa incredibile vicenda ne uscirò a testa alta. Sono sicuro che il lavoro della magistratura, dopo queste fasi iniziali, si concluderà con un pieno proscioglimento nei miei confronti". "L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è indagato per il reato di 416 bis, ossia l'associazione a delinquere di stampo mafioso, ma la sua posizione è ancora da vagliare - ha detto il procuratore capo Pignatone - Sugli indagati preferiamo non fare alcuna precisazione''. Pignatone ha inoltre aggiunto che l'inchiesta ''non si chiude oggi'' e che tra gli indagati ci sono anche alcuni esponenti delle forze dell'ordine che hanno agevolato l'organizzazione guidata da Massimo Carminati. Non solo. "Nel marzo 2013 nel Cda dell'Ama viene nominato con provvedimento del sindaco Alemanno un legale scelto da Carminati stesso. Lo stesso per il direttore generale di Ama e un altro dirigente operativo - ha spiegato il pm di Roma Michele Prestipino parlando dell''incessante attività di lobbying' dell'organizzazione criminale individuata "per collocare con successo manager asserviti ai loro interessi". Prestipino ha citato anche la nomina del presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Roma e la candidatura a sindaco di Sacrofano - dove risiede Massimo Carminati, considerato capo di Mafia Capitale - di un uomo fidato poi eletto. Indagato anche l'ex capo della segreteria di Gianni Alemanno, Antonio Lucarelli. Il procuratore Giuseppe Pignatone ha riferito di un incontro tra uno dei bracci destro di Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e Lucarelli. "Buzzi voleva far sbloccare un finanziamento e Lucarelli non lo riceveva - ha detto - dopo la telefonata di Carminati si precita sulla scalinata del Campidoglio da Buzzi che gli dice che è tutto a posto, che ha già parlato con Massimo. Buzzi commentando questo incontro dice 'c'hanno paura di lui'". Coinvolti come indagati anche l'assessore capitolino alla Casa, Daniele Ozzimo, che ha deciso di dimettersi dalla carica pur dichiarandosi "totalmente estraneo allo spaccato inquietante emerso". Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha accettato le sue dimissioni e aggiunto: "Siamo fiduciosi nel lavoro della magistratura. Ci auguriamo sia fatta piena luce su una vicenda inquietante e che sta facendo emergere l'esistenza di un sistema diffuso di illegalità ai danni della città. Questa amministrazione ha improntato il suo lavoro sulla trasparenza. Per questo apprezzo la decisione personale e il coraggio di Daniele Ozzimo che rassegnando le dimissioni, ha agito prima di tutto nell'interesse della città mettendo in secondo piano se stesso", ha detto Marino. Indagati anche il consigliere regionale Pd Eugenio Patanè, quello Pdl Luca Gramazio, e il presidente dell'Assemblea capitolina Mirko Coratti. Che si è dimesso anche lui, dopo qualche ora: "Con sconcerto ho appreso che nei miei confronti è stata aperta un'indagine giudiziaria nell'ambito di una maxi-inchiesta dai risvolti inquietanti. Nel dichiararmi totalmente estraneo a quanto emerge in queste ore dalle indagini, per correttezza verso la città e verso l'amministrazione comunale ho deciso di dimettermi dall'incarico che mi onoro di servire, rimetto pertanto da subito a disposizione dell'Assemblea capitolina che mi ha eletto la mia carica. Nell'esprimere piena fiducia nel lavoro della magistratura sono certo che dalle inchieste in corso emergerà con chiarezza la mia totale estraneità ai fatti contestati". Nei loro uffici alla Regione Lazio e in Campidoglio sono scattate le perquisizioni dei militari. Nella lista degli indagati c'è anche il responsabile della Direzione Trasparenza del Campidoglio, Italo Walter Politano: è accusato di associazione di stampo mafioso. Nominato dal sindaco Ignazio Marino il 15 novembre 2013, Politano è di fatto referente al Comune di Roma del Commissario nazionale anticorruzione Raffaele Cantone. Domani dovrebbe essere rimosso dall'incarico. Ma ci sarebbero un centinaio di nomi negli atti della Procura di Roma. Tra cui quello di Gennaro Mokbel, già condannato in primo grado per l'inchiesta Telecom Sparkle-Fastweb, e tre avvocati penalisti, ai quali i pm contestano il reato di concorso esterno in associazione mafiosa: avrebbero concordato con gli associati "la linea difensiva da adottare" in un procedimento in cui era coinvolto Riccardo Mancini, ex amministratore delegato dell'Ente Eur, arrestato in passato per un giro di presunte mazzette legate all'appalto per la fornitura di filobus al Comune di Roma. Tra gli indagati c'è anche Lorenzo Alibrandi, il fratello più piccolo di Alessandro Alibrandi, il terrorista dei Nar, figlio dell'ex giudice istruttore del tribunale di Roma, Antonio Alibrandi. Ci sono anche una ventina di quadri di valore tra gli oggetti sequestrati durante le perquisizioni, come ha riferito il capo dei carabinieri del Ros, il generale Mario Parente. Si tratta di quadri trovati nell'abitazione di uno degli indagati e di proprietà dello stesso Carminati che vanno da opere di Andy Warhol a Jackson Pollock. Le opere verranno ora analizzate dagli esperti. A casa di un altro indagato sono invece stati trovati 570mila euro in contanti. Appalti per decine di milioni di euro a società collegate a Massimo Carminati, considerato il capo dell'organizzazione mafiosa, in cambio di tangenti per centinaia di migliaia di euro. E' il "patto corruttivo-collusivo", secondo il pm della Direzione antimafia (Dda) di Roma Michele Prestipino, individuato dall'indagine Mondo di Mezzo. "In cambio di appalti a imprese amiche - ha detto il magistrato - venivano pagate tangenti fino a 15 mila euro al mese per anni. Ma anche centinaia di migliaia di euro in un solo colpo, fino a versamenti di denaro a enti e fondazioni legate alla politica romana". E tra queste "anche la fondazione creata da Alemanno". Tra gli appalti pubblici Prestipino ha citato quello del 2011 per la raccolta differenziata dei rifiuti del Comune di Roma e quello per la raccolta delle foglie. Su altri appalti dell'Ama - municipalizzata romana dei rifiuti - per altri 5 milioni di euro sono in corso approfondimenti d'indagine. E' infatti un'azione senza precedenti quella che ha messo a soqquadro Roma e il suo hinterland. Coordinata da tre pubblici ministeri - Luca Tescaroli, Paolo Ielo e Giuseppe Cascini - sotto la supervisione del procuratore capo della procura di Roma Giuseppe Pignatone ha infatti smantellato un'organizzazione che racchiude almeno dieci anni di malavita. Personaggi che hanno solcato la scena della mala capitolina, come il nero Carminati ex della Banda della Magliana, ma anche politici e amministratori che hanno favorito e consentito a questo malaffare di radicarsi, di mettere le radici, di infilarsi coi suoi tentacoli ovunque. Ribaltando di netto le regole del gioco. Ricostruire la trama e gli intrecci che hanno reso possibile tutto questo malaffare è stata un'impresa titanica. C'è un'intercettazione che spiega il senso dell'organizzazione mafiosa messa su da Massimo Carminati e ha dato il nome all'indagine. "L'intercettazione per noi più significativa è questa - ha spiegato Giuseppe Pignatone - quando Carminati parlando con il suo braccio destro militare, Riccardo Brugia, gli dice 'E' la teoria del mondo di mezzo, ci sono i vivi sopra e i morti sotto e noi in mezzo. C'è un mondo in cui tutti si incontrano, il mondo di mezzo è quello dove è anche possibile che io mi trovi a cena con un politico...'. Carminati parla col 'mondo di sopra', quello della politica e col 'mondo di sotto', quello criminale, e si mette al servizio del primo avvalendosi del secondo al servizio del primo. La caratteristica principale di questa organizzazione sta nei suoi rapporti con la politica e nel fatto che alterna la corruzione alla violenza, preferendo la prima perché fa meno clamore". Le perquisizioni scattate all'alba hanno riguardato boss della malavita, come esponenti di noti clan di Ostia, e politici di elevato spessore a Roma. Il reato ipotizzato nei confronti degli arrestati è il 416 bis, l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Reato per cui sono già indagate 51 persone dei clan Fasciani e Triassi di Ostia, e che a dicembre si concluderà con la sentenza di primo grado. Reato per cui a Roma, nessuno mai è stato condannato. Perché, come in un refrain, per anni si è continuato a dire che la mafia a Roma non esiste. Almeno fino a oggi. "Quello che sta emergendo è un quadro inquietante - ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - E' un bene che la magistratura sia impegnata a fare piena luce. Con sempre più forza bisogna proseguire, ognuno nei propri ambiti, sulla via della legalità senza se e senza ma". "E' un'inchiesta che certifica il profondo inquinamento delle istituzioni, al di là delle vicende dei singoli, e che conferma sempre di più la presenza di una cupola criminale con le mani sulla città. Il sistema mafioso corruttivo svelato oggi impegna subito chi ha responsabilità amministrative e politiche ad assumere urgenti misure nella lotta alla criminalità e alla corruzione - si legge in una nota dell'Ufficio di Presidenza di Libera - Siamo convinti che accanto alla repressione e gli strumenti giudiziari, è necessario il risveglio delle coscienze, l'orgoglio di una comunità che antepone il bene comune alle speculazioni e ai privilegi, contrastando in tutte le sedi la criminalità organizzata e i suoi complici". "Cade il velo di ipocrisia sulla città e Roma diventa Capitale delle mafie", ha commentato l'Associazione dasud che "denuncia dal 2011 gli affari criminali a Roma con dossier e inchieste, da "Roma città di mafie" all'ebook "Mammamafia". Il welfare lo pagano le mafie". L'indagine di oggi, finalmente racconta di un patto trasversale inquietante che tiene insieme boss, imprenditori, manager, funzionari, amministratori pubblici e politici di destra e sinistra, rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del terzo settore e descrive come ha funzionato fino a ieri il sistema degli affari a Roma, quale ruolo le mafie abbiano svolto sul degrado delle periferie,? quanta speculazione sia stata fatta sui migranti e i rom della città,? quale sistema di corruzione abbia regolato i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, quali relazioni pericolose regolino i rapporti tra politica e pezzi significativi della storica eversione nera e l'estrema destra di oggi. Il sodalizio con a capo Carmati come ha detto il procuratore Pignatone è solo uno dei tanti che opera su Roma. Il negazionismo e l inerzia della politica e delle classi dirigenti sono serviti solo a farli agire indisturbati. Non è più il tempo dell antimafia di facciata, serve subito un impegno trasversale".
Ecco la "mafia Capitale": 37 arresti per appalti del Comune. Indagato anche Alemanno. Carminati, l'intercettazione che spiega la teoria del "mondo di mezzo". Un centinaio le persone coinvolte nell'operazione "Mondo di mezzo". Affari nella gestione dei rifiuti, manutenzione del verde e campi nomadi. In carcere l'ex Nar Carminati e l'ex ad dell'Ente Eur Mancini. L'ex primo cittadino: "Ne uscirò a testa alta". Tra gli inquisiti anche Politano, capo dell'anticorruzione in Campidoglio, scrive “La Repubblica”. La mafia a Roma c'è ed è autoctona. Sono le conclusioni del procuratore capo Giuseppe Pignatone che, nell'illustrare la maxi operazione "'Mondo di mezzo" che ha portato all'arresto di 37 persone per associazione mafiosa, ha parlato dell'esistenza di una "mafia capitale, tutta romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso e con cui si confronta alla pari". Una mafia che "non ha una struttura precisa ma ha la capacità essenziale di creare equilibri tra mondi diversissimi tra loro". A Roma dunque in questi ultimi anni ha agito un'associazione di stampo mafioso che ha fatto affari con imprenditori collusi, con dirigenti di municipalizzate ed esponenti politici, per il controllo delle attività economiche in città e per la conquista degli appalti pubblici. Ne sono convinti i magistrati della Dda della procura e i carabinieri del Ros che hanno chiesto e ottenuto dal gip Flavia Costantini l'arresto di 37 persone (29 in carcere e otto ai domiciliari) per una molteplicità di reati: estorsione, corruzione, usura, riciclaggio, turbativa d'asta e trasferimento fraudolento di valori. A guidare questa organizzazione è un volto noto alla giustizia, l'ex terrorista dei Nar Massimo Carminati, ritenuto colui che "impartiva le direttive agli altri partecipi, forniva loro schede dedicate per comunicazioni riservate e manteneva i rapporti con gli esponenti delle altre organizzazioni criminali, con pezzi della politica e del mondo istituzionale, finanziario e con appartenenti alle forze dell'ordine e ai servizi segreti". A disposizione dell'organizzazione, secondo gli investigatori, ci sono, tra gli altri, l'ex capo di Ama Franco Panzironi e l'ex amministratore delegato di Ente Eur Riccardo Mancini, soggetti che per i pm hanno fatto dal 2008 al 2013 da garante o da tramite "dei rapporti del sodalizio con l'amministrazione comunale". La lista, poi, comprende anche il manager Fabrizio Franco Testa accusato di "coordinare le attività corruttive dell'associazione" e di "occuparsi della nomina di persone gradite all'organizzazione in posti chiave della pubblica amministrazione". Tra gli indagati a piede libero (almeno 100), coinvolti negli accertamenti che porteranno sicuramente a sviluppi importanti nei prossimi mesi, ci sono anche l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il commercialista Marco Iannilli, l'uomo d'affari Gennaro Mokbel e il consigliere regionale del Pdl Luca Gramazio. "Dimostrerò la mia totale estraneità a ogni addebito e da questa incredibile vicenda ne uscirò a testa alta", ha replicato Alemanno. "Chi mi conosce - ha aggiunto l'ex sindaco - sa bene che organizzazioni mafiose e criminali di ogni genere io le ho sempre combattute a viso aperto e senza indulgenza". Pignatone ha detto che quella di Alemanno "è una posizione ancora da vagliare".
"Soldi per le elezioni in cambio di appalti. Così Alemanno favoriva il clan dei camerati". Sindaco della capitale dal 2008 al 2013, "aveva contatti diretti e aiutava il sodalizio mafioso". Tra finanziamenti, accordi politici e nomine ai vertici delle municipalizzate, scrivono Fabio Tonacci e Maria Elena Vincenzi su “La Repubblica” L'uomo che governava Roma era nelle mani dell'uomo che la derubava. Gianni Alemanno, sindaco dal 2008 al 2013, con la "mafia capitale" di Massimo Carminati aveva "contatti diretti e ne favoriva il sodalizio". Nominando i vertici delle partecipate che la banda decideva. Riservando, a sfregio del già disastrato bilancio del Comune, denaro per alimentare l'appetito di Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative. "Senti, noi qui abbiamo rimediato quindici milioni eh", comunicava personalmente l'allora sindaco al suo capo Dipartimento servizi sociali il 23 novembre del 2012, risolvendo così il problema di finanziare l'ampliamento del campo nomadi di Castel Romano, che tanto interessava al "guercio", l'ex Nar che si è preso Roma. In cambio, ricavandone da Buzzi 75.000 euro in cene elettorali e sostegno economico alla sua fondazione Nuova Italia. Pure una claque elettorale di 50 persone, alla bisogna. Perché tutti al Comune sapevano di che pasta erano fatte le amicizie di Alemanno, ora indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso. Carminati aveva un filo diretto con il suo più stretto collaboratore, Antonio Lucarelli, capo della segre- teria. Lo chiama al telefono, ci va a pranzo, si frequentano. Quando Buzzi, in ansia per uno sblocco di 300.000 euro, cerca un contatto, deve passare attraverso Carminati. "Mi dice - spiega il manager delle coop in un'intercettazione del 20 aprile 2013 - "va in Campidoglio, alle tre, che scende Lucarelli e viene a parlare con te"... Aò alle tre meno cinque scende, dice "ho parlato con Massimo (Carminati, ndr), tutto a posto"... aò tutto a posto veramente! C'hanno paura delui ". "Ero il sindaco di Roma - com- menta ora Alemanno con i suoi fedelissimi - è facile tirarmi in ballo. C'è molto millantato credito, è in atto un tentativo di attacco politico nei miei confronti". Stando all'ordinanza del gip Flavia Costantini, Alemanno non ha rapporti diretti con Carminati. Ci fa parlare i suoi, Luca Gramazio (ex capogruppo comunale del Pdl, ora alla Regione) e Fabrizio Franco Testa, manager e "testa di ponte" tra l'organizzazione mafiosa e la politica. Sono loro a decidere, insieme a Buzzi e Carminati, chi mettere nel cda dell'Ama, la municipalizzata dei rifiuti che assegnerà infatti alle società di Buzzi tre appalti milionari finiti nell'inchiesta, relativi alla raccolta differenziata, alla raccolta delle foglie e altri lavori per 5 milioni di euro. Così Alemanno nomina Giuseppe Berti nel consiglio di amministrazione e Giovanni Fiscon alla direzione generale, "espressione diretta degli interessi del gruppo" Gente di cui il "guercio" e compagnia si possono fidare. Il 20 aprile del 2013 le microspie dei carabinieri del Ros captano la conversazione in automobile tra Salvatore Buzzi e il suo collaboratore Giovanni Campennì. I due parlano delle imminenti elezioni amministrative di Roma. "Oh l'avevamo comprati tutti ho... - dice Buzzi - se vinceva Alemanno ce l'avevamo tutti comprati, c'amo l'assessore ai lavori pubblici, Tredicine (Giordano, ndr) doveva stà assessore ai Servizi Sociali, Cochi andava al verde, Cochi non è comprato però è un amico, Alemanno... che cazzo voi di più...". Campennì chiede se pagasse anche l'altra parte politica, il centro sinistra da cui proviene. "No, no questo te lo posso assicurà io che pago tutti, i miei non li pago. Ma lo sai agli altri i soldi che gli do già? Anche due cene con il sindaco, 75mila euro ti sembrano pochi? ". Alemanno ha mai preso soldi dal gruppo di Carminati? Direttamente non risulta. Buzzi racconta dei 75mila euro in cene elettorali che ha sborsato. Ma ci sono anche i bonifici alla fondazione politica di Alemanno, "Nuova Italia". Il 6 dicembre 2012, "a poche settimane dall'approvazione del bilancio che avrebbe stanziato ulteriori fondi in favore del campo nomadi di Castel Fusano - annota il gip - e in concomitanza con la cena elettorale e l'aggiudicazione della gara Ama", dalle società di Buzzi partivano bonifici a Nuova Italia per 30mila euro divisi in tre assegni. Altri 5mila euro dal Consorzio "Enriches 29" il 28 novembre 2011. E ancora, il 17 aprile 2013, 15mila euro dalla cooperativa "Formula Sociale", riconducibile a Buzzi, in favore del mandatario elettorale di Alemanno, più altri 5mila nel novembre dello stesso anno. A cui si aggiungono i soldi che arrivavano attraverso Franco Panzironi, ex ad di Ama "a libro paga". Oltre al mensile di 15mila euro, lo foraggiavano con finanziamenti "non inferiori a 40mila euro" alla fondazione. Ma Buzzi, per Alemanno, non è soltanto un bancomat. Gli serve anche per mettere in scena entusiasmo elettorale. Il 9 novembre 2013 Panzironi chiama Buzzi e gli chiede di reperire "un po' di gente per fare volume" alla manifestazione organizzata dall'ex sindaco all'Adriano per il suo rientro in politica. E per sostenere la candidatura alle europee, Buzzi ha delle risorse insospettabili. "Devo fare delle telefonate? ", gli chiede Alemanno al telefono. "No, no, tranquillo, manderemo a Milardi (Claudio, fa parte dello staff dell'ex sindaco, ndr ) l'elenco di persone, nostri amici del sud, che ti possono dare una mano cò parecchi voti". Qualche giorno dopo, Buzzi spiega a sua moglie di chi parlava: "Sono 7-8 mafiosi che c'avemo in cooperativa".
Appalti e criminalità a Roma: nei verbali la mappa di Mafia Capitale. Una rete di contatti, una piovra che controlla la città: appalti, usura, estorsioni, corruzione. Tutto gira intorno a Massimo Carminati, ma tra i 37 arrestati e i centinaia di indagati ci sono nomi eccellenti della politica e para-politica, scrive Fabio Tonacci su “La Repubblica”. La banda, la nuova banda di Roma. "La Mafia capitale", per dirla con le parole dei magistrati. Strutturata come una piovra che asfissia la città. Ogni uomo ha un compito, ogni compito ha un prezzo. Appalti, usura, estorsioni, corruzione. Dentro il Comune di Roma, nelle istituzioni, nelle cooperative. Amministratori "a libro paga" come Franco Panzironi, ex presidente Ama, e Carlo Pucci dirigente di Eur spa. Pubblici ufficiali "a disposizione", come Riccardo Mancini, ex presidente di Eur spa, che ha fatto da garante con l'amministrazione di Alemanno dal 2008 al 2013. La collusione con forze di polizia e servizi segreti. Un luogo: il distributore di benzina di Corso Francia, gestito da Roberto Lacopo, "base logistica del sodalizio". E tutto quest'universo criminale che ruota attorno a Massimo Carminati, l'ex nar, 56 anni. Capo, organizzatore, fornitore ai suoi sodali di schede telefoniche dedicate, reclutatore di imprenditori collusi "ai quali fornisce protezione", l'uomo che "mantiene i rapporti con gli esponenti delle altre organizzazioni criminali operante su Roma, nonché esponenti del mondo politico istitutzionale, con esponenti delle forze dell'ordine e dei servizi". La sua villa di Sacrofano, Carminati la intesta fittiziamente a Alessia Marini, acquistandola per 500mila euro, di cui 120 mila in contanti. Accanto a lui c'è sempre Riccardo Brugia, col quale condivide il passato di estremista di destra. Nell'organizzazione di Carminati, armata e di stampo mafioso secondo i pm di Roma, Brugia ha il compito di gestire le estorsioni, "di coordinare le attività nei settori del recupero crediti e dell'estorsione, di custodire le armi in dotazione del sodalizio", scrive il gip Flavia Costantini nelle 1249 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare. Brugia e Carminati, tra le altre cose, sono accusati di estorsione ai danni di Luigi Seccaroni per farsi vendere il terreno in via Cassia. Ogni uomo ha un compito, dunque. Ad esempio Fabrizio Franco Testa, manager, e presidente di Tecnosky (Enav) e uomo di Alemanno ad Ostia. "Lui è la testa di ponte dell'organizzazione nel settore politico e istituzionale, coordina le attività corruttive dell'associazione, si occupa della nomina di persone gradite all'organizzazione in posti chiave della pubblica amministrazione". Oppure Salvatore Buzzi, l'uomo della rete di cooperative. Amministratore delle coop riconducibili al gruppo Eriches-29 giugno, affidatarie di appalti da parte di Eur Spa, gestisce per conto della banda Carminati le attività criminali nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della accoglienza dei profughi e rifugiati, della manutenzione del verde pubblico, settori "oggetto delle gare pubbliche aggiudicate anche con metodo corruttivo". Si occupa anche - secondo i pm - della contabilità occulta dell'associazione. Sullo sfondo una pletora di imprenditori collusi, in primo piano, invece Franco Panzironi. Nel suo ruolo di componente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Ama spa dal 2008 al 2011, ha del tutto "asservito la sua qualità funzionale". Nelle carte ci sono tutti gli addebiti a suo carico: violando il segreto d'ufficio, violando il dovere di imparzialità nell'affidamento dei lavori, ha preso accordi con Buzzi "per il contenuto dei provvedimenti di assegnazione delle gare prima della loro aggiudicazione". Panzironi è accusato anche di averla turbata, quella gara. L'appalto è quello della raccolta delle foglie per il comune di Roma, 5 milioni di euro. Per la sua attività di "agevolazione dell'associazione mafiosa di Carminati" nel tempo ha ricevuto, per sé e per la sua fondazione Nuova Italia, 15.000 euro al mese dal 2008 al 2013, 120.000 euro in una tranche (il 2,5 per cento dell'appalto assegnato da Ama), la rasatura gratuita del prato di casa, e finaziamenti non inferiori a 40.000 euro per la sua fondazione. Per dire come funzionavano le cose al Campidoglio, basta leggere le accuse che vengono fatte a Claudio Turella, funzionario del Comune di Roma e responsabile della programmazione e gestione del Verde Pubblico: per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio nella assegnazione dei lavori per l'emergenza maltempo, la manutenzione delle piste ciclabili e delle ville storiche, "riceveva da Buzzi, il quale agiva previo concerto con Carminati e in accordo con i suoi collaboratori, 25.000 euro per l'emergenza maltempo, la promessa di 30.000 euro per le piste ciclabili, più la promessa di altre somme di denaro". Nel calderone degli arresti c'è anche Luca Odevaine, ex vice capo di gabinetto di Veltroni. Nella sua qualità di appartenente al Tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza dei rifugiati, dunque pubblico ufficiale, "orientava le scelte del Tavolo al fine di creare le condizioni per l'assegnazione dei flussi di immigrati alle strutture gestite da soggetti economici riconducibilia Buzzi e Coltellacci", "effettuava pressioni finalizzate all'apertura di centri in luoghi graditi al gruppo Buzzi". E per questo "riceveva 5.000 euro mensili in forma diretta e indiretta da Coltellacci e Buzzi". Con l'aggravante di aver agevolato la banda di Carminati. Infine Gennaro Mokbel, che finisce in questa inchiesta con l'accusa di estorsione, perché "mediante violenza e minacce" voleva costringere Marco Iannilli a restituire 8 milioni di euro "comprensiva dell'attesa remunerazione, consegnatagli un anno prima per investirla nell'"operazione Digint"". E qui è intervenuto Carminati il quale, su richiesta della vittima, "la proteggeva da Mokbel". Faceva anche questo, Carminati. Il protettore.
Mafia e politica: perquisizioni, arresti Indagato anche ex sindaco Alemanno. In corso perquisizioni tra uffici di consiglieri della Regione Lazio, uffici del Campidoglio e abitazione dell’ex primo cittadino. Notificati 37 ordini di custodia cautelare, scrivono la Redazione Online, Lavinia Di Gianvito e Fiorenza Sarzanini su “Il Corriere della Sera”. Pedinamenti, intercettazioni e verifiche sui flussi di denaro. Si sono mosse su un doppio binario le indagini del Ros dei carabinieri e del Nucleo tributario della Finanza sfociate, mercoledì mattina, in 37 arresti, decine di perquisizioni - comprese la Regione, il Campidoglio e 24 aziende - e la notifica di 39 avvisi di garanzia. È l’inchiesta «Mondo di mezzo», che nel legare gli affari di politici, malavitosi e manager ipotizza l’associazione a delinquere di stampo mafioso, a cui sono da aggiungere altri reati come la corruzione, l’estorsione e il riciclaggio. Sono stati circa 500 i carabinieri del Comando provinciale di Roma impiegati nelle perquisizioni, più i militari del gruppo cacciatori di Calabria, elicotteri e unità cinofile. Le Fiamme gialle, al comando del colonnello Cosimo Di Gesù, hanno controllato 350 posizioni tra persone fisiche e società e hanno bloccato 205 milioni frutto del reimpiego di capitali illeciti, senza calcolare i conti correnti e il contenuto delle cassette di sicurezza. In due abitazioni dell’ex Nar Massimo Carminati, finito in carcere, sono stati sequestrati 50 quadri di enorme valore: fra gli autori Andy Warhol e Jackson Pollock. L’imprevista scoperta potrebbe aprire un nuovo filone d’inchiesta poiché, spiega il comandante del Ros, il colonnello Mario Parente, «possono essere riconducibili a un traffico di opere d’arte». Nella lista dei 37 arrestati compaiono il direttore generale dell’Ama Giovanni Fiscon, gli ex amministratori delegati dell’ Ama Franco Panzironi (coinvolto anche nello lo scandalo Parentopoli) e di Eur spa Riccardo Mancini (già rinviato a giudizio per le tangenti sui filobus), l’ex capo della polizia provinciale Luca Odevaine, che è stato anche a vicecapo di gabinetto del sindaco Veltroni.Tra gli indagati ci sono l’assessore alla Casa Daniele Ozzimo, il presidente dell’assemblea capitolina Mirko Coratti (entrambi dimissionari), il responsabile della direzione Trasparenza del Campidoglio Italo Walter Politano (che domani sarà rimosso dal suo incarico), i consiglieri regionali Eugenio Patanè e Luca Gramazio, l’ex sindaco Gianni Alemanno («foraggiata», secondo gli inquirenti, anche la sua fondazione Nuovaitalia) e i suoi fedelissimi Antonio Lucarelli e Stefano Andrini. E poi tre avvocati, fra cui Pierpaolo Dell’Anno, alcuni appartenenti alle forze dell’ordine accusati di favoreggiamento e il faccendiere Gennaro Mokbel, già condannato in primo grado per la truffa a Fastweb e Telecom Sparkle . «Con questa operazione abbiamo risposto alla domanda se la mafia è a Roma. La risposta è che Roma la mafia c’è e dimostra originalità e originarietà», sottolinea il procuratore Giuseppe Pignatone. Lo scorso sabato 30 novembre, all’assemblea dei democratici, Pignatone aveva ammonito: «Corrotti e mafia, patto che fa paura» riferendosi al mondo politico romano. Quel giorno nessuno aveva compreso che gli inquirenti stavano tirando le fila di un’inchiesta durata oltre due anni, che disegna una holding criminale capace di aggiudicarsi gli appalti per i rifiuti, le piste ciclabili, i punti verdi qualità, la raccolta delle foglie, la realizzazione dei villaggi nei campi nomadi, l’assegnazione dei flussi di immigrati. Al vertice dell’organizzazione, secondo la Direzione distrettuale antimafia, c’era Carminati, che con le sue società avrebbe incamerato commesse per decine di milioni. «In cambio - spiega il capo della Dda, Michele Prestipino - sono state pagate per anni tangenti fino a 15 mila euro al mese. Ma anche centinaia di migliaia di euro in un solo colpo». Odevaine, per esempio, avrebbe avuto uno «stipendio» mensile di cinquemila euro. Carminati, sostengono gli inquirenti, «manteneva i rapporti con gli esponenti delle altre organizzazioni criminali, con pezzi della politica e del mondo istituzionale, finanziario e con appartenenti alle forze dell’ordine e ai servizi segreti». Il procuratore ricorda una conversazione tra Carminati e il suo braccio destro, Salvatore Buzzi: «Dobbiamo vendere il prodotto amico mio. Bisogna vendersi come le puttane adesso. Mettiti la minigonna e vai a battere con questi amico mio». Dopo le ultime elezioni comunali «qualcosa è cambiato», precisa Pignatone, tuttavia in un’intercettazione «Carminati con i suoi collaboratori dicono: “Siamo tranquilli abbiamo amici”». Nell’ordinanza firmata dal giudice Flavia Costantini si legge: «Allo stato dell’indagine può essere affermato con certezza che vi erano dinamiche relazionali precise, che si intensificavano progressivamente, tra Alemanno e il suo entourage politico e amministrativo da un lato e il gruppo criminale che ruotava intorno a Buzzi e Carminati dall’altro. Dinamiche relazionali che avevano a oggetto specifici aspetti di gestione della cosa pubblica e che certamente non possono inquadrarsi nella fisiologia di rapporti tra amministrazione comunale e stakeholders». Quanto a Mancini e Panzironi, stando all’accusa, rappresentano «i pubblici ufficiali a libro paga che forniscono all’organizzazione uno stabile contributo per l’aggiudicazione degli appalti». I due manager si sarebbero dati da fare anche per «lo sblocco dei pagamenti in favore delle imprese riconducibili all’associazione» e tra il 2008 e il 2013 come «garanti» dei rapporti dell’organizzazione con il Campidoglio. Il manager Fabrizio Franco Testa, invece, per i magistrati è «una testa di ponte» del gruppo «nel settore politico e istituzionale, coordinando le attività corruttive dell’associazione e occupandosi della nomina di persone gradite al sodalizio in posti chiave della pubblica amministrazione». L’ex sindaco di Roma, nel dichiararsi fiducioso nel lavoro della magistratura, precisa in una nota: «Chi mi conosce sa bene che organizzazioni mafiose e criminali di ogni genere io le ho sempre combattute a viso aperto e senza indulgenza. Dimostrerò la mia totale estraneità». E annuncia: «Dimostrerò la mia totale estraneità ad ogni addebito e da questa incredibile vicenda ne uscirò a testa alta». Per il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, «quello che sta emergendo è un quadro inquietante». Dopo lo scandalo di Marco Di Stefano (deputato Pd a lungo in Regione Lazio, dove fu anche assessore al Patrimonio) travolto a fine ottobre dall’inchiesta per le tangenti da due milioni di euro nel caso degli affitti pilotati alla Pisana, una nuova «puntata» giudiziaria sembra travolgere le istituzioni della Capitale. Proprio mentre scattavano le perquisizioni, martedì Di Stefano è arrivato a Piazzale Clodio per essere interrogato nell’ambito dell’inchiesta su una presunta tangente da 1,8 milioni di euro che avrebbe ricevuto, quando era assessore alla Regione Lazio nella giunta Marazzo, dai costruttori Antonio e Daniele Pulcini. Di Stefano è indagato per corruzione e falso: per l’accusa la tangente servì per favorire la locazione di due immobili dei Pulcini alla società «Lazio service». Di Stefano sarà sentito anche come testimone sulla scomparsa del suo braccio destro Alfredo Guagnelli.
«Mafia capitale», la strana piovra che avvolge la politica debole di Roma. Lo choc di una città che si ritrova in mano a un ex estremista nero e a un ex detenuto, scrive iovanni Bianconi su “Il Corriere della Sera”. Nel quadro dipinto dalla Procura antimafia di Roma e dai carabinieri del Ros, l’immagine che traspare è quella di una piovra che ha avvolto la Capitale attraverso i suoi tentacoli, arrivando fino al Campidoglio. Con i politici – l’ex amministrazione di centro-destra, e qualche propaggine che sostiene la nuova – al servizio di un gruppo in grado piegare la politica e l’imprenditoria ai propri interessi. Un gruppo criminale chiamato “Mafia capitale”, perché si avvale del metodo mafioso nell’intimidazione e nel condizionamento dei pubblici poteri. In maniera diversa da come si muovono le cosche dei Cosa nostra in Sicilia o quella della ‘ndrangheta in Calabria e in Lombardia, ma ugualmente pervasiva. Un sistema messo in piedi da un ex militante della destra sovversiva degli anni Settanta, Massimo Carminati, poi passato ai rapporti con la malavita comune, che può contare – secondo l’accusa - anche sul “carisma criminale” guadagnato in decenni di cronache giudiziarie e processi andati per lo più a buon fine (per lui), e da un imprenditore legato al mondo delle cooperative: Salvatore Buzzi, anche lui ex detenuto che proprio in carcere, trent’anni fa, ha cominciato a intessere relazioni con l’esterno grazie alle occasioni di reinserimento offerte ai condannati; e oggi gestisce, stando alle carte degli inquirenti - «le attività economiche» di mafia capitale, occupandosi «della contabilità occulta e dei pagamenti ai pubblici ufficiali corrotti». Una città in mano a un ex estremista nero e a un ex detenuto, insomma. Almeno nel disegno dei pubblici ministeri e del giudice che ha concesso gli arresti. Accuse da provare, ovviamente, ma dalle quali emerge già, con nettezza, la debolezza della politica cittadina e amministrativa che si lascia quantomeno tentare e influenzare, nelle sue scelte, da metodi e interessi poco commendevoli. Nella capitale d’Italia.
«L’ho comprato, gioca per me». La rete che arruolava i politici. I boss cambiavano perfino il bilancio. «Cosentino (Pd) è amico nostro», scrive Fiorenza Sarzanini su “Il Corriere della Sera”. In ogni posto chiave avevano sistemato una persona fidata. Aziende municipalizzate, assessorati, persino il bilancio del Campidoglio erano in grado di modificare. Per riuscire a controllare le commissioni Trasparenza e Anticorruzione hanno fatto carte false, forse convinti che questo li avrebbe salvati. È una rete di potere autentico quella creata da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, «inserendo nei ruoli decisionali della pubblica amministrazione uomini che, per ragioni diverse di affiliazione o di subordinazione, rispondono direttamente al sodalizio, non sempre con una piena consapevolezza delle sue caratteristiche». Quando Gianni Alemanno cede la guida di Roma a Ignazio Marino, si concentrano sugli esponenti del Pd che potevano mettersi a disposizione in cambio di favori e tangenti. E riescono ad agganciarli. Nelle intercettazioni che fanno da filo conduttore alle indagini dei carabinieri del Ros guidati dal generale Mario Parente, si parla di appuntamenti chiesti al vicesindaco Luigi Nieri, di incontri con il capo di gabinetto Mattia Stella. Mentre Eugenio Patanè avrebbe preso soldi per «pilotare» appalti alla Regione, del senatore del Pd Lionello Cosentino, segretario della federazione Pd romana, dicono: «È proprio amico nostro». Ad Alemanno, dipinto dalle carte dell’accusa quasi come un burattino nelle loro mani, pagano le cene elettorali oltre ai contanti versati alla sua Fondazione «Nuova Italia» e portano «comparse» per la claque ai comizi. A far da «cerniera» ci pensa spesso l’assessore Luca Gramazio. Ma alla vigilia delle amministrative di giugno 2013, quando lui tentenna sulla concessione di una proroga alle cooperative, il ricatto di Buzzi è esplicito: «Me la proroghi a sei mesi, arrivi a dopo le elezioni... se li famo tutti in santa pace, qui c’hai pure gente che ti vota... così ci costringi a fare le manifestazioni». Riccardo Mancini, amministratore delegato di Eur spa è sempre stato uno dei personaggi di riferimento, «espressione dell’amministrazione comunale avendo gestito le campagne elettorali di Alemanno ed essendo considerato una sorta di plenipotenziario nella gestione dei rapporti con gli imprenditori, soprattutto nel settore trasporti». È quello che «deve passa’ i lavori buoni». Quando finisce sotto inchiesta Buzzi racconta: «Lo semo annati a pija’, gli amo detto cioè “o stai zitto e sei riverito o se parli poi non c’è posto in cui te poi anda’ a nasconde’‘». Regolarmente stipendiato con 15 mila euro mensili è Franco Panzironi, ex amministratore delegato di Ama spa, «indicato quale reale dominus della stessa municipalizzata, nonostante non rivestisse più nessun incarico formale». Buzzi è categorico: «M’ha prosciugato tutti i soldi Panzironi... dovevo daje un sacco de soldi, 15 mila euro, gli ultimi glieli do oggi e poi ho finito». Con la giunta Alemanno il controllo dell’Ama è totale. Quando arriva Marino, l’organizzazione si attrezza. E in vista della gara per la raccolta del Multimateriale Buzzi appare sicuro: «I nostri assi nella manica per farci vince la gara dovrebbero essere la Cesaretti per conto di Sel, Coratti che venerdì ce vado a prende un bel caffè e metto in campo anche Cosentino». Parlando del presidente dell’assemblea capitolina Mirko Coratti, Buzzi dice «me lo so’ comprato, ormai gioca con me», e il 23 gennaio 2014 racconta di avergli «promesso 150 mila euro se fosse intervenuto per sbloccare un pagamento di 3 milioni sul sociale». L’8 aprile invia un sms a Mattia Stella: «Sono da Coratti». Lui lo chiama immediatamente: «Oh Salvato’ io sto giù da me». Buzzi è pronto: «Appena finisco da Coratti, scendo giù da te». Del resto con i collaboratori più stretti era stato esplicito: «Sto’ Mattia lo dobbiamo valorizzare, lo dobbiamo lega’ di più a noi». Luca Odevaine, vicecapo di gabinetto del sindaco Walter Veltroni, viene ritenuto un esponente dell’organizzazione e infatti Buzzi conta sulla possibilità che diventi capo di gabinetto di Marino «così ci si infilano tutte le caselle... qualche assessore giusto... ci divertiremo parecchio». L’interesse dell’organizzazione a orientare la politica è palese sin dalla scelta del candidato sindaco. A ottobre 2012 Carminati si informa con Buzzi: «Come siete messi per le primarie?» e lui risponde: «Stiamo a sostene’ tutti e due... avemo dato 140 voti a Giuntella e 80 a Cosentino che è proprio amico nostro». In realtà a novembre Buzzi annuncia: «Noi oggi alle cinque lanciamo Marroni alle primarie per sindaco eh!». Il possibile cambio in giunta era per loro un’ossessione e il 22 gennaio 2013, analizzando ogni possibilità dice: «È vero, se vince il centrosinistra siamo rovinati, solo se vince Marroni andiamo bene». Marroni diventa deputato del Pd mentre l’altro «amico» Daniele Ozzimo è nominato assessore alla Casa. Tutti restano comunque inseriti nella «rete» che ha continuato a garantire affari e potere.
Carminati, il "Nero" interpretato da Scamarcio, scrive Roberto Scafuri su “Il Giornale”. Gioventù bruciata, vecchiaia maledetta. C'è da chiedersi che cosa attragga di più della trasgressione senza rimedio, che cosa porti a decidere un giorno di buttare al macero la tua vita in un bar dell'Eur chiamato il «Fungo». Era lì che Massimo Carminati, il «Nero» di Romanzo criminale interpretato da Riccardo Scamarcio, milanese piombato nella Capitale negli anni Settanta con la famiglia, incontrò il suo destino. Assieme a nomi al pari suo passati alla storia del terrorismo nero, prima Avanguardia nazionale poi Nar, amici di sangue come Valerio Giusva Fioravanti, Alessandro Alibrandi, Franco Anselmi. Lì, in quel fasullo mondo di pulizia medio-altoborghese, e poi al bar Fermi e in quello di via Avicenna, Massimo frequenta gli esponenti più in vista della banda della Magliana, e vi si lega a filo doppio. In quei giardinetti verdi nasce una strategia del terrore che si trasforma via via in malavita ordinaria e quotidiana, scelta che costa a Carminati un occhio, l'uso di una gamba, quella sinistra, il soprannome di «Cecato», quando la mattina del 20 aprile dell'81 sta cercando di fuggire in Svizzera, e di lì in Spagna. Di quella metamorfosi inesorabile che i neofascisti cresciuti nel quartiere di Monteverde subiscono, diventando delinquenti, Carminati diventa snodo centrale e rispettato, anche in virtù dei suoi stretti rapporti con i boss Giuseppucci e Abbruciati. Rapine, omicidi, attentati ai treni, la morte di Pecorelli: negli anni bui d'Italia il nome del Guercio è una certezza: finisce alla sbarra, spesso senza un adeguato impianto accusatorio, ne esce sempre assolto. La condanna a dieci anni arriverà invece solo nel '98 nel processo che vedrà alla sbarra l'intera banda della Magliana. Per il Nero comincia un altro dei suoi tunnel maledetti.
Carminati, dai neri alla Magliana: «Sono il Re, vedi che gli combino». Un imprenditore legato al gruppo dell’ex terrorista: «Io qui sono diventato intoccabile», scrive Giovanni Bianconi su “Il Corriere della Sera”. Quando lo arrestarono la prima volta mentre tentava di attraversare il confine tra Italia e Svizzera, nel 1981, dopo che un poliziotto gli sparò un colpo di pistola che gli fece perdere un occhio, faticarono a identificarlo. Perché aveva addosso un documento falso, e perché il suo vero nome era uno dei tanti estremisti di destra ricercati, niente più. Oggi, trentatré anni e qualche vita dopo, quello stesso nome è sufficiente a fare paura come l’identità di un boss, utile a incutere timore e rispetto insieme. Al pari dei soprannomi derivati dalla pallottola conficcata nell’occhio: «Il Cecato» o «Il Pirata». È quel che sostengono gli inquirenti a proposito di Massimo Carminati, 56 anni compiuti a maggio, l’ex militante dei Nuclei armati rivoluzionari poi transitato armi e bagagli dalle parti della banda della Magliana, rimanendo coinvolto - e riuscendo a uscirne pulito, il più delle volte, o con pochi danni - nelle vicende criminali più clamorose: dall’omicidio del giornalista Mino Pecorelli (assolto in tutti i gradi di giudizio) al furto consumato nel caveau del tribunale di Roma nel 1999 (condanna ridotta a quattro anni), passando per altre vicende più o meno misteriose. Un altro ex sovversivo «nero» degli anni Settanta arrestato nell’operazione di ieri (ce ne sono diversi, anche se ormai l’ideologia e la politica c’entrano poco e niente; sembra più una questione di soldi, e di metodi per accaparrarne) racconta in un colloquio intercettato che quando lo arrestarono per una rapina nel 1994, nella quale era rimasto ferito, appena arrivato a Regina Coeli tutti gli offrirono assistenza e solidarietà in virtù della sua amicizia con Carminati; «anche persone che, non conoscendo, però sapevano». Perfino l’averla quasi sempre scampata nei tribunali, o comunque essersela cavata con pene leggere, secondo gli inquirenti contribuisce ad accrescere il mito dell’impunità e quindi del potere sotterraneo che riesce a esercitare. Il resto l’hanno fatto alcuni articoli di rotocalco dove veniva definito (insieme ad altri) il «Re di Roma», e lui stesso commentava: «Sul nostro lavoro... sono pure cose buone... Se sentono tranquilli», riferito alle persone con cui aveva rapporti. Oppure, quando c’era da sfruttare l’aura di duro con chi doveva adeguarsi alle sue indicazioni: «Sennò viene qua il Re di Roma... tu sei un sottoposto... è il Re di Roma che viene qua... entro dalla porta principale... vede io che gli combino». Sia quando militava nelle file della destra sovversiva, sia nei rapporti con i banditi della Magliana (in particolare Franco Giuseppucci, boss con simpatie neofasciste), Carminati si è mostrato attento a mantenere un ruolo autonomo, amico che non tradisce gli amici e fa valere più il vincolo personale che quello politico o di «batteria». Pronto a usare metodi maneschi e «convincenti», abituato a parlare poco e apprezzare chi parla poco, rispetto a quelli che vantano rapporti altolocati. Consapevole del proprio ruolo e della propria capacità intimidatoria ma anche imprenditoriale, attento agli affari e a nuove forme d’investimento attraverso persone fidate. Come Salvatore Buzzi, l’imprenditore delle cooperative che - nella ricostruzione dell’accusa - gli gestiva buona parte dei soldi ed è divenuto il suo principale socio occulto. «È uno di quelli cattivi -, dice a proposito di Carminati uno degli imprenditori collusi con la presunta associazione mafiosa -. Questi c’hanno i soldi pe’ fà una guerra, ai tempi d’oro hanno fatto quello che hanno fatto... Quando te serve una cosa vai da lui, non è lui che viene da te». E chi poteva godere della sua protezione si sentiva come un altro imprenditore legato al gruppo di Carminati: «Non me può toccare manco Gesù Cristo... cioè qui... io qui a Roma sono diventato intoccabile».
"Li compriamo tutti. Se vinceva Alemanno saremmo stati a posto. Proviamoci con Marino". Salvatore Buzzi come punto di raccordo tra gli interessi di Carminati e la politica. Il suo ruolo chiave emerge dalle intercettazioni a ridosso delle elezioni 2013. L'uomo delle coop autocollocato "a sinistra" si vantava del suo potere di persuasione. Una "vocazione corruttiva" che secondo i magistrati non aveva distinzioni di colore, scrivono Mauro Favale e Giovanna Vitale su “La Repubblica”. "Me li sto a comprà tutti", si vantava al telefono Salvatore Buzzi, uomo chiave dell'inchiesta, figura centrale e di raccordo tra gli interessi di Massimo Carminati e la politica. Era lui, da uomo delle cooperative che si auto-collocava "a sinistra", a gestire le attività economiche della associazione nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della accoglienza dei profughi, della manutenzione del verde pubblico. Nella sua rete, secondo le indagini, finiscono politici di centrodestra e di centrosinistra, senza particolari distinzioni di colore. Durante la campagna elettorale per le elezioni del 2013, quando le quotazioni di Gianni Alemanno vengono date in discesa, si esprime così al telefono con Emilio Gammuto, figura "tra le più attive - scrive la gip Flavia Costantini - sul versante della corruzione".
Buzzi: "Se vinceva Alemanno ce l'avevamo tutti comprati, partivamo fiuuuu (fonetico intendendo partiamo a razzo, ndr.). C'amo l'assessore ai lavori pubblici, Tredicine doveva stà assessore ai servizi sociali, Cochi andava al verde. Cochi non è comprato però è un amico, Alemanno... Che cazzo voi di più?".
Ma quella che i magistrati definiscono "vocazione corruttiva", per Buzzi non ha barriere politiche. A suo dire è in "trattative corruttive" anche con l'amministrazione Marino. Dall'altra parte del telefono c'è sempre Gammuto.
Buzzi: "E mo vedemo Marino, poi ce pigliamo 'e misure con Marino".
Gammuto: "Va bè mò, Marino tramite Luigi Nieri".
Buzzi: "Ma Nieri, è entrato Nieri?".
Gammuto: "Non lo so".
Buzzi: "Cazzo ne sai? Noi c'avemo Ozzimo, quattro: Ozzimo, Duranti, Pastore e Nigro".
L'ex assessore alla Casa della giunta Marino, indagato per corruzione, si è dimesso ieri, dichiarandosi "estraneo ai fatti". Nelle chiacchiere tra gli arrestati contenuti nell'ordinanza del gip viene a più riprese definito "un amico", tanto che Buzzi confessa ad Alemanno di aver dato indicazioni di un voto disgiunto alle elezioni "Ozzimo-Alemanno".
Alemanno: "Pronto?".
Buzzi: "Gianni come stai?".
Alemanno: "Allora? Ma è vera 'sta storia del disgiunto?".
Buzzi: "Facciamo il disgiunto, facciamo. Ozzimo ed Alemanno". (ride)
Alemanno: "Eh, questo mi onora molto".
Buzzi: "No, ma non se fa più".
Alemanno: "Mi onora molto".
Buzzi: "Non lo possiamo dire, però. Mi raccomando, eh". (ride).
Alemanno: "Come?"
Buzzi: "Non lo possiamo dire".
Alemanno: "No, no. Vabbè, vabbè. Poi, ma poi si nota. Per cui, vediamo dopo. Però mi raccomando eh! Fate i bravi ragazzi".
Buzzi: "Per me vinci. Per me gliela fai, gliela fai".
Alemanno: "Sì, sì. Penso, penso di sì e siamo in recupero. Poi, ovviamente bisogna vedere, non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Va bene".
Sempre per quanto riguarda i legami con l'amministrazione Alemanno, risulta che attraverso alcune sue società, Buzzi avrebbe pagato due cene elettorali all'ex sindaco attraverso la Fondazione Nuova Italia. Non solo: su richiesta di Franco Panzironi, ex ad di Ama, Buzzi recupera 50 uomini per formare una claque elettorale nel corso della campagna elettorale di dell'ex sindaco. L'uomo delle cooperative, inoltre, è in ottimi rapporti anche con Luca Gramazio, attuale capogruppo di Fi in Regione e, all'epoca, presidente dei consigliere comunali del Pdl. Secondo il gip "le indagini hanno delineato un quadro indiziario tale da indurre ad ipotizzare che Gramazio possa essere un collegamento dell'organizzazione con il mondo della politica e degli appalti". Gramazio, oltre ad avere una costante frequentazione direttamente con Massimo Carminati, il leader del gruppo, è anche la figura incaricata di collocare all'interno dell'amministrazione "soggetti che esprimevano gli interessi dell'associazione, quali Berti, Fiscon e Quarzo". Si interessa alle vicende relative agli appalti per il campo nomadi di Castel Romano e, soprattutto, per recuperare le risorse necessarie nonostante l'assenza di fondi nel bilancio comunale 2013. "Una trama di rapporti che, secondo le conversazioni che sono state indicate a proposito della corruzione di Turella, relativa allo stanziamento per le piste ciclabili, lo avrebbe visto remunerato con la somma di almeno 50.000 euro", scrive la gip. Quando l'amministrazione cambia colore, l'organizzazione criminale non si scoraggia e riesce a "reclutare" anche rappresentanti del centrosinistra. In particolar modo l'abboccamento funziona con Mirko Coratti, Pd, presidente dell'Aula Giulio Cesare, anch'egli ieri dimessosi dopo l'avviso di garanzia, accusato di aver intascato una tangente da 150.000 euro. L'intercettazione tra Buzzi e Claudio Caldarelli (suo collaboratore) è esplicativa.
Caldarelli: "Vabbè, ricordate sta cosa: so un milione e 8, è importante. Perché è politica la scelta al di là...".
Buzzi: (a bassa voce:) "Oh, me sò comprato Coratti".
Caldarelli: "Eh, ricordate da diglielo".
Buzzi: "Lui sta con me. Gioca con me ormai".
Caldarelli: "Eh, ricordateglie de questo perché... ".
Buzzi: "Oh ma che sei peggio de lui, ce vado venerdì a pranzo ma che sei rincoglionito. Ma che cazzo, non cambi mai, sempre la stessa cosa".
Caldarelli ride.
Buzzi: "E che cazzo, che me so rincoglionito, poi non tutte riescono però uno ce prova, eh (ride). Gliel'ho detto: "Guarda, lo stesso rapporto che c'abbiamo con Giordano lo possiamo aver con te. M'ha capito subito. Poi però il problema è che lui non so quanto a quanta gente c'ha... mentre con Giordano semo... Quando io gl'ho detto tutto lui non m'ha detto no. M'ha detto ci vediamo a pranzo venerdì. Più de questo, che me deve di'? Al capo segreteria suo noi gli diamo 1000 euro al mese. Sò tutti a stipendio Cla'. Io solo per metteme a sede a parlà con Coratti 10 mila gli ho portato". L'arruolamento di Coratti e del suo capo segreteria, secondo gli inquirenti, ha tre obiettivi: "L'aggiudicazione del bando di gara AMA n. 30/2013 riguardante la raccolta del multimateriale; lo sblocco dei pagamenti sui servizi sociali forniti al Comune di Roma; la nomina di un nuovo direttore del V Dipartimento, in sostituzione della neo incaricata Gabriella Acerbi, ritenuta persona poco disponibile". Per provare a condizionare la giunta Marino, Buzzi stringe i legami anche con Mattia Stella, capo segreteria di Marino, che non risulta indagato ma che gli arrestati provano a blandire. "Eloquente nel senso della costruzione di un rapporto privilegiato con Stella - scrive la gip - è la conversazione nella quale Buzzi chiamava Carlo Guarany, lo informava che prima sarebbe andato in Ama e successivamente presso il "Gabinetto per incontrare Mattia". In questa conversazione si sottolinea la necessità di "valorizzare Mattia e legarlo di più a noi". Gli interessi di "mafia capitale" si rivolgono anche alla Regione. E lì, col cambio di giunta agganciano Eugenio Patanè, consigliere Pd. Anche lui sarebbe coinvolto, secondo la procura, nell'appalto Ama del 2013 per il quale sarebbe stato pagato con una tangente più bassa rispetto alle richieste. Lo spiega Buzzi intercettato al telefono con la sua compagna Alessandra Garrone.
Buzzi: "Noi dovremmo dare a Patanè per la gara che abbiamo vinto...".
Garrone: "122 euro".
Buzzi: "122 euro e non esiste proprio. Non esiste che quelli hanno chiesto i soldi a Patanè. 120.000 euro, 120 noi e 120... hai capito come funziona?"
Garrone: "Ho capito".
In un'altra intercettazione, questa volta ambientale, Buzzi spiega meglio il sistema ai suoi interlocutori.
Buzzi: "Noi a Panzironi che comandava gli avemo dato 2,5%, 120 mila euro su 5 milioni. Mo damo tutti 'sti soldi a questo?".
A insistere per i soldi a Patanè è Franco Cancelli, della cooperativa Edera, finito ai domiciliari.
Buzzi: "Lui mi dice "ah però bisogna da'" e alla fine dice, "la differenza sarebbero 10 mila euro" perché ne vorrebbe subito 60 e gliene toccherebbero 50, dice. Ho fatto "oh, guarda che il problema però è la tua aggressività. Perché se Patanè garantisce, non c'avemo problemi".
I quattro re di Roma. Carminati, Fasciani, Senese e Casamonica. Ecco i boss che si sono spartiti il controllo della città. Mettendo a freno omicidi e fatti di sangue troppo eclatanti per garantire il silenzio sui propri traffici, scrive Lirio Abbate “L’Espresso”. Non ama guidare e preferisce spostarsi a piedi o cavalcando uno scooter. Nessun lusso negli abiti, modi controllati e cortesi: in una città dove tutti parlano troppo, lui pesa le parole ed evita i telefonini. Sembra un piccolo borghese, perso tra la folla della metropoli, ma ogni volta che qualcuno lo incontra si capisce subito dalla deferenza e dal rispetto che gli tributano che è una persona di riguardo. Riconoscerlo è facile: l'occhio sinistro riporta i segni di un'antica ferita. Il colpo di pistola esploso a distanza ravvicinata da un carabiniere nel 1981: è sopravvissuto anche alla pallottola alla testa, conquistando la fama di immortale. Anche per questo tutti hanno paura di lui. Ed è grazie a questo terrore che oggi Massimo Carminati è considerato l'ultimo re di Roma. La sua biografia è leggendaria, tanto da aver ispirato "Il Nero", uno dei protagonisti di "Romanzo criminale" interpretato sullo schermo da Riccardo Scamarcio. È stato un terrorista dei Nar, un killer al servizio della Banda della Magliana, l'hanno accusato per il delitto Pecorelli e per le trame degli 007 deviati, l'hanno arrestato per decine di rapine e omicidi. Come disse Valerio Fioravanti, «è uno che non voleva porsi limiti nella sua vita spericolata, pronto a sequestrare, uccidere, rapinare, partecipare a giri di droga, scommesse, usura». Sempre a un passo dall'ergastolo, invece è quasi sempre uscito dalle inchieste con l'assoluzione o con pene minori: adesso a 54 anni non ha conti in sospeso con la giustizia. Ma il suo potere è ancora più forte che in passato. Il nome del "Cecato" viene sussurrato con paura in tutta l'area all'interno del grande raccordo anulare, dove lui continua a essere ritenuto arbitro di vita e morte, di traffici sulla strada e accordi negli attici dei Parioli. L'unica autorità in grado di guardare dall'alto quello che accade nella capitale. "L'Espresso" è riuscito a ricostruire la nuova mappa criminale di Roma tenuta in pugno da quattro figure, con un ruolo dominante di Carminati. Lo ha fatto grazie alle rivelazioni di fonti che hanno conoscenza diretta dei traffici che avvengono all'interno della metropoli e a cui è stato garantito l'anonimato. Queste informazioni sono state riscontrate e hanno permesso di ricostruire un quadro agghiacciante della situazione. Il business principale è la cocaina: viene spacciata in quantità tripla rispetto a Milano, un affare da decine di milioni di euro al mese, un'invasione di droga che circola in periferia, nei condomini della Roma bene e nei palazzi del potere, garantendo ricchezza e ricatti. I quattro capi non si sporcano le mani con il traffico, si limitano a regolamentarlo e autorizzare la vendita nei loro territori, ottenendo una percentuale dei proventi. Cifre colossali, perché ogni carico che entra sulla piazza romana rende fino a quattrocento volte il prezzo pagato dagli importatori che lo fanno arrivare dalla Colombia, dal Venezuela o dai Balcani: il fatturato è di centinaia di milioni di euro. Carminati viene descritto come il dominus della zona più redditizia, il centro e i quartieri bene della Roma Nord. Dicono che la sua forza starebbe soprattutto nella capacità di risolvere problemi: si rivolgono a lui imprenditori e commercianti in cerca di protezione, che devono recuperare crediti o che hanno bisogno di trovare denaro cash. Non ha amici, solo camerati. E chi trent'anni fa ha condiviso la militanza nell'estremismo neofascista sa di non potergli dire di no. Per questo la sua influenza si è moltiplicata dopo l'arrivo al Campidoglio di Gianni Alemanno, che ha insediato nelle municipalizzate come manager o consulenti molti ex di quella stagione di piombo. Le sue relazioni possono arrivare ovunque. A Gennaro Mokbel, che gestiva i fondi neri per colossi come Telecom e Fastweb. E a Lorenzo Cola, il superconsulente di Finmeccanica che ha trattato accordi da miliardi di euro ed era in contatto con agenti segreti di tutti i continenti: un'altra figura che - come dimostrano le foto esclusive de "l'Espresso" - continua a muoversi liberamente tra Milano e la capitale nonostante sentenze e arresti. Come Carminati, anche gli altri re di Roma sono soliti sospetti. Personaggi catturati, spesso condannati, ma sempre riusciti a tornare su piazza. Michele Senese domina i quartieri orientali e la fascia a Sud-Est della città, fitta di palazzi residenziali e sedi di multinazionali. La sua carriera comincia nella camorra napoletana: diversi pentiti lo hanno indicato come un sicario attivo nelle guerre tra cutoliani e Nuova Famiglia. Poi si è trasferito nella Capitale ed è diventato un boss autonomo, chiamato "o Pazzo" perché le perizie psichiatriche gli hanno permesso più volte di uscire dalla cella: i medici - che lo hanno definito capace di intendere e volere - lo hanno però indicato come incompatibile con il carcere. Fino allo scorso febbraio era detenuto in una clinica privata, dove però avrebbe continuato a ricevere sodali e gestire affari e ordini nonostante una sentenza a 17 anni ridotta a 8 in appello. Poi è finito a Rebibbia, ma per poco: da sei mesi ha ottenuto gli arresti domiciliari, sempre per l'incompatibilità con la prigione, confermata anche dalla Cassazione, e a fine anno tornerà libero. All'interno del territorio di Senese c'è un'enclave in mano ai Casamonica, altra presenza fissa nelle cronache nere romane. Sono sinti, etnia nomade ormai stanziale in Italia da decenni, che spadroneggiano nella zona tra Anagnina e Tuscolano e fanno affari di droga con la zona dei Castelli. Ricchi, con ville arredate in modo sfarzoso e auto di lusso, si muovono tra usura e cocaina, senza che le retate abbiano intaccato i loro traffici: rifornivano anche il vigile urbano che faceva da autista a Samuele Piccolo, il vicepresidente del consiglio comunale arrestato lo scorso luglio. Ormai sono più di trent'anni che si parla di loro, ma soltanto nel gennaio di quest'anno gli è stata contestata l'associazione per delinquere: secondo la Squadra Mobile possono contare su un migliaio di affiliati, pronti a offrire i loro servizi criminali alla famiglia. Dopo l'arresto del leader di un anno fa, Peppe Casamonica, adesso alla guida del clan c'è la moglie del boss. I processi hanno avuto scarsa incidenza anche sulle attività di "don" Carmine e Giuseppe "Floro" Fasciani, i fratelli avrebbero la supervisione sulla fascia Sud-Occidentale, che comincia da San Paolo e comprende i quartieri a ridosso della Cristoforo Colombo fino al litorale di Ostia. Don Carmine è un'altra vecchia conoscenza, che compare nei dossier delle forze dell'ordine dai tempi della Magliana. Come uno dei figli di Enrico Nicoletti, lo storico cassiere della Banda, adesso segnalato tra le figure emergenti nonostante un arresto e una condanna non definitiva. Carmine Fasciani invece è finito in cella nel 2010, quando gli venne sequestrato uno dei locali più trendy dell'estate romana con discoteca sulla spiaggia: lo aveva comprato per 780 mila euro nonostante ne dichiarasse al fisco solo 14 mila. Meno di due anni dopo è stato assolto in primo grado, con restituzione dei beni. Pochi mesi più tardi è tornato dentro e in più operazioni i carabinieri hanno messo i sigilli ad altre proprietà per un valore di oltre dieci milioni di euro. Anche Fasciani aveva amicizie nei reduci dei Nar. E con lui al telefono il solito Mokbel millantava di avere pagato per fare assolvere Valerio Fioravanti e Francesca Mambro: il segno di come tutte le storie criminali a Roma finiscano per intrecciarsi intorno allo stesso filo nero. E anche Fasciani ha tenuto rapporti con camorra, 'ndrangheta e Cosa nostra. Per le grandi mafie Roma resta una città aperta. Possono investire liberamente in ristoranti, negozi e immobili a patto di non pestare i piedi ai quattro re. E possono tranquillamente prendere domicilio. Da Palermo si sono trasferiti nel quartiere africano Nunzia e Benedetto Graviano, fratelli dei boss di Brancaccio, gli stragisti di Cosa nostra. E poi l'ex capomafia di Brancaccio, il medico Giuseppe Guttadauro, che dal suo salotto di casa dava direttive a politici e giornalisti e ordinava omicidi e attentati: è tornato libero dopo uno sconto per buona condotta mettendo su casa a Roma. Operano a Nord, in zona Flaminia, nel territorio di Carminati, anche alcuni componenti della 'ndrangheta di Africo, in particolare i Morabito. Non è forse un caso che il capobastone Giuseppe Morabito, detto Peppe Tiradritto, è il nonno di Giuseppe Sculli, ex giocatore della Lazio, coinvolto nell'indagine su alcune combine di partire di serie A: Sculli, secondo gli investigatori, avrebbe avuto contatti proprio con "il Nero". In tutto il Lazio ormai i clan campani e calabresi hanno insediato feudi stabili, ma a Roma è un'altra storia. Non comandano loro: nella Capitale per qualunque operazione illecita devono chiedere l'autorizzazione dei sovrani capitolini e riconoscergli la percentuale. Perché la situazione che si è creata all'ombra dei sette colli non ha precedenti: è come il laboratorio di una nuova formula criminale, flessibile ed efficiente, che permette il controllo del territorio limitando l'uso della violenza. Sotto certi aspetti, ricorda Palermo degli anni Settanta, prima dell'avvento dei corleonesi, quando le vecchie famiglie dominate da Stefano Bontate pensavano ad arricchirsi con droga ed edilizia evitando gesti clamorosi. Roma è lontanissima dal capoluogo siciliano: non ci sono clan che impongono il pizzo sistematicamente a tutti i commercianti. Anzi, spesso sono esercenti e imprenditori a rivolgersi ai boss cercando protezione, prestiti o offrendo capitali da investire nell'acquisto di partite di coca. Le indagini hanno evidenziato il ruolo di costruttori e negozianti impegnati come finanziatori nell'importazione di neve dal Sudamerica, quasi sempre dei quartieri nord, quelli che fanno capo a Carminati. I quattro re e le grandi cosche, secondo quanto appreso da "l'Espresso", hanno raggiunto un accordo dieci mesi fa: niente più omicidi di mafia nella Capitale. In questo modo le forze dell'ordine non si dovranno muovere in nuove indagini e il business illegale non avrà ripercussioni. Il patto è stato siglato dopo che i boss hanno appreso dell'arrivo a Roma del nuovo procuratore Giuseppe Pignatone. Gli undici delitti che lo scorso anno hanno fatto nascere l'allarme su Roma in realtà non sarebbero semplici regolamenti di conti, ma tanti episodi di una strategia finalizzata a imporre questo nuovo modello criminale: venivano punite le persone che violavano i patti, mettendo in crisi il sistema di potere. Per spiegare i meccanismi di questo sistema, "l'Espresso" ha raccolto il retroscena del delitto più clamoroso avvenuto lo scorso anno: l'uccisione di Flavio Simmi, a poca distanza da piazza Mazzini e dal palazzo di giustizia. Figlio di un gioielliere e ristoratore coinvolto nelle inchieste sulla Banda della Magliana e poi assolto, Flavio gestiva un Compro oro e pochi mesi prima era stato ferito: un solo colpo di pistola ai testicoli. Un avvertimento che sarebbe stato deciso da un calabrese legato alla 'ndrangheta, arrestato all'inizio del 2011. L'uomo dal carcere avrebbe chiesto alla sua convivente di andare da Simmi e ritirare una grossa somma di denaro, forse provento di attività comuni. Ma il debitore le manca di rispetto e così il detenuto decide di ucciderlo. Prima però chiede il permesso a chi controlla il territorio. A questo punto interviene il padre, che per salvare il figlio probabilmente contatta vecchi amici della banda ancora importanti, ottenendo che la sentenza di morte sia trasformata in un avvertimento: la pistolettata sui genitali e l'ordine di andare via da Roma. Il giovane però rimane in città e allora viene decisa l'esecuzione, senza che scattino vendette. Le istituzioni per anni non sono riuscite a scardinare questo sistema. Ha pesato anche un deficit culturale: l'incapacità di riconoscere la manifestazione di questo differente modo di essere mafia e imporre il dominio sulla città. Il reato di associazione mafiosa non è stato mai riconosciuto in una sentenza: i giudici hanno sempre stabilito che a Roma ci fossero trafficanti, rapinatori, spacciatori ma non vere organizzazioni criminali. È questo il clima che serve ai clan per prosperare. E non appena i giornali hanno fatto trapelare la possibilità che alla guida della procura capitolina potesse arrivare Giuseppe Pignatone, con decenni di esperienza nella lotta alle cosche, i boss hanno deciso di imporre la pace. I delitti sono cessati all'improvviso: negli ultimi dodici mesi ci sono stati solo due omicidi connessi alla criminalità, entrambi però sul litorale, lontanissimo dal centro. È la stessa strategia criminale della sommersione o dell'invisibilità che è stata attuata in Sicilia dal vecchio padrino Bernardo Provenzano nel 1993 dopo l'arresto di Riina. Niente più omicidi ma solo affari svolti in silenzio con l'aiuto della politica sostenuta dalla mafia. Le fonti de "l'Espresso" hanno descritto come si sia trattato di una scelta imposta dai "quattro re". Pronti a debellare in qualunque modo chi infrange la moratoria: poche settimane fa un ex dei Nar che stava per assaltare una banca armato fino ai denti è stato catturato durante un controllo dei carabinieri scattato al momento giusto. Questo silenzio ha indotto in inganno, alcuni mesi fa, qualche investigatore, il quale avrebbe riferito al prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, facendolo sobbalzare dalla sedia, che la mafia non è presente in città. La realtà è ben diversa. Con un potere invisibile che trae linfa dalla corruzione generalizzata. La scorsa settimana il procuratore Pignatone partecipando ad un convegno organizzato nell'ambito del salone della Giustizia ha detto: «Roma è una città estremamente complessa perché mentre a Palermo e Reggio Calabria tutto viene ricondotto alla mafia, nella capitale i problemi sono tanti. Credo che da un lato non bisogna negare, come accaduto a Milano, che ci sia un problema di infiltrazioni mafiose». Pignatone al Salone della Giustizia ha detto: «A Roma c'è un rischio: l'inquinamento del mercato e dell'economia per l'afflusso di capitali mafiosi. Facciamo appello agli imprenditori perché stiano attenti: diventare soci di un mafioso significa prima o poi perdere l'azienda. Nella capitale è diffusa la corruzione ed è altissima l'evasione fiscale. La procura è impegnata a far sì che non appaiono come fenomeni normali. Qualche giorno fa abbiamo sequestrato il libretto degli assegni di un signore, che sulla causale aveva scritto "tangente". Questa è la dimostrazione del rischio di assuefazione, di accettazione. Bisogna reagire a questo stato di cose». Per questo motivo Pignatone non è solo; oltre a validi pm, lavora con un pool di investigatori che il procuratore ha voluto portare nella capitale e con lui hanno condiviso il "modello Reggio Calabria", che con intercettazioni e pedinamenti ha smantellato il volto borghese della 'ndrangheta. Poliziotti, carabinieri e finanzieri abituati a lavorare in squadra, l'unico modo per dare scacco ai re di Roma.
Roma, poltrone ai fascisti. Ex di Avanguardia Nazionale, esponenti di Terza Posizione, perfino naziskin vicini a Mokbel. Così Alemanno ha piazzato nei posti che contano della Capitale i suoi amici estremisti neri, scrive Emiliano Fittipaldi su “L’Espresso”. Boia chi molla, gridava a fine anni Ottanta il giovane Gianni Alemanno, al tempo capo del Fronte della Gioventù e fedelissimo di Pino Rauti, leader dell'ala movimentista dell'Msi e futuro suocero. Vent'anni dopo, nessuno può accusarlo di incoerenza: Gianni, diventato sindaco di Roma, non ha mollato nessuno. Non ha tradito, non ha lasciato per strada i vecchi camerati, nemmeno quelli finiti in galera per banda armata e atti terroristici, neppure i personaggi più discussi della galassia d'estrema destra protagonista degli anni di piombo. Anzi. Nell'anno di grazia 2010 Roma è sempre più nera, con fascisti ed ex fascisti che spuntano dappertutto. Nei posti cardine dell'amministrazione comunale e nell'entourage ristretto del nuovo Dux, nell'assemblea capitolina e nelle società controllate dal Comune, passando per enti regionali e ministeri. Vecchie conoscenze sono comparse anche nella parentopoli che ha investito l'Atac, dove lavorano - come ha scritto Ernesto Menicucci sul "Corriere" - l'ex Nar Francesco Bianco (in passato arrestato e processato per rapine e omicidi insieme ai fratelli Fioravanti, fu scarcerato per decorrenza dei termini) e l'ex di Terza posizione Gianluca Ponzio. Ponzio oggi è a capo del Servizio relazioni industriali della municipalizzata del Comune, negli anni Ottanta fu protagonista di arresti plurimi per rapina e possesso d'armi. La sinistra ha gridato allo scandalo, ma i due sono sono solo la punta dell'iceberg di un gruppo di potere sempre più radicato in città, cementato dagli ideali e dall'antica appartenenza, da interessi (anche economici) e da relazioni amicali e familiari. La lista comprende ex militanti di Terza posizione e dei Nuclei armati rivoluzionari, uomini di Forza nuova, naziskin vicini alla cricca di Gennaro Mokbel, capi storici di Avanguardia nazionale, ultrà e combattenti delle battaglie degli anni Settanta e Ottanta. Battuto a sorpresa Francesco Rutelli, disintegrati i potentati di Forza Italia (già messi a dura prova durante la giunta regionale guidata da Francesco Storace) ora sono nella cabina di controllo e, nella nerissima capitale, comandano loro. I due personaggi più influenti dell'amministrazione non sono assessori, ma due amici del sindaco: Franco Panzironi e Riccardo Mancini. Del primo, a capo dell'Ama, si sa praticamente tutto. Meno noti, invece, sono i trascorsi dell'uomo che Alemanno ha voluto alla guida di Eur spa, società controllata dal Campidoglio e dal ministero dell'Economia che ha nel suo portafoglio immobili per centinaia di milioni. Mancini, classe 1958, ha finanziato la campagna elettorale del 2006 e ha fatto da tesoriere durante quella del 2008. È un imprenditore di successo: erede di parte del patrimonio della famiglia Zanzi (energia e riscaldamento), ha comprato nel 2003 la Treerre, società di bonifiche e riciclaggio che fattura oltre 6 milioni di euro l'anno. Anche lui, che ha sempre vissuto all'Eur, è stato vicino ai camerati di Avanguardia nazionale: nel 1988 è stato processato - insieme ai leader del movimento Stefano Delle Chiaie e Adriano Tilgher, che oggi lavora in Regione con Teodoro Buontempo - e la Corte d'Assise lo condannò a un anno e nove mesi per violazione della legge sulle armi. Ora, dopo vent'anni, Alemanno gli ha dato le chiavi di un quartiere che conosce bene, quello del "mitico" bar Fungo, dove un tempo si ritrovavano quelli di Terza posizione, i ragazzi di Massimo Morsello e il gruppo di Giusva Fioravanti. Una curiosità: un socio in affari di Mancini, Ugo Luini (amministratore della holding del gruppo, la Emis) è pure tra i consiglieri della fondazione del sindaco, Nuova Italia. Mancini e Panzironi, ovviamente, si conoscono bene. A novembre il capo dell'Eur Spa ha assunto Dario, il figlio di Franco, già portaborse al Comune e ora funzionario con contratto a tempo indeterminato. La scelta ha fatto gridare allo scandalo il centrosinistra, ma sono altre le indiscrezioni che preoccupano Alemanno. Mancini, l'uomo che dovrebbe gestire la Formula 1, è infatti amico di Massimo Carminati, tra i fondatori dei Nar e leader della sezione dell'Eur, simpatizzante di Avanguardia nazionale e sodale della Banda della Magliana: il personaggio del "Nero" del film "Romanzo Criminale" è ispirato alla sua storia. I due sono spesso insieme, tanto che qualcuno sospettava che l'ex estremista (incriminato per vari delitti efferati ma assolto - quasi sempre - da ogni accusa) fosse stato assunto dalla municipalizzata. «Una sciocchezza» chiosano a "L'espresso" gli uomini del sindaco «Mancini lo vede solo perché si conoscono da anni. Nessun rapporto di lavoro». Un lavoro ben retribuito Alemanno e Panzironi l'avevano invece trovato a Stefano Andrini, assurto agli onori delle cronache perché insieme a un gruppetto di naziskin picchiò selvaggiamente, nell'estate del 1989, due "compagni" davanti al cinema Capranica. Andrini, 40 anni, fa parte di una generazione successiva a quella dei movimenti storici degli anni di piombo. La rissa costò a lui e al fratello gemello una condanna a quattro anni e otto mesi (poi ridotti a tre) per tentato omicidio. La carriera criminale continua anche dopo la reclusione: entrato nell'orbita del gruppo di Delle Chiaie, Stefano nel 1994 viene arrestato per alcuni scontri con gli autonomi. Un passato burrascoso che nel 2009 non gli impedisce di sedersi sulla poltrona di amministratore delegato di Ama Servizi Ambientali. Andrini, ultrà della Lazio, non c'è rimasto molto. Lo scorso febbraio è stato travolto dall'inchiesta sugli affari della banda capeggiata da Gennaro Mokbel. Secondo i magistrati sarebbe stato proprio lui a organizzare - tramite i suoi agganci a Bruxelles - la falsa candidatura di Nicola Di Girolamo, il senatore tanto caro a Mokbel («Sei il mio servo», gli diceva) e alle famiglie 'ndranghetiste di Isola Capo Rizzuto. Il sindaco, si sa, non molla mai nessuno. E perdona tutti, forse perché anche lui è stato sfiorato da vicende giudiziarie, come aggressioni e lancio di bombe molotov (sempre assolto). Non bisogna sorprendersi, così, che abbia provato a sistemare anche altri ex skin protagonisti del pestaggio al cinema Capranica. Così Mario Andrea Vattani (arrestato con gli Andrini ma poi assolto al processo), figlio del potente presidente dell'Ice Umberto, è diventato capo delle relazioni internazionali e del cerimoniale del Campidoglio. Assunto fino al 2013, costerà ai contribuenti 488 mila euro tra stipendio e oneri previdenziali. Anche Demetrio Tullio, pure lui arrestato e prosciolto, ha ottenuto un posto fisso. Stavolta al ministero delle Politiche agricole: è entrato grazie a un concorso bandito nel 2006, quando Alemanno era titolare del dicastero. Tullio lavora alla direzione generale della Pesca marittima, ma nel tempo libero si occupa anche di manifestazioni culturali. Il mensile di Ostia "Zeus" lo indica come «presidente dell'associazione Minas Tirith», dal nome della città assediata del Signore degli Anelli, che qualche giorno fa ha organizzato un convegno intitolato "Serate dannunziane". Secondo il giornale, la tre giorni è stata un successo. Non sappiamo se Alemanno ha perdonato anche Mokbel, che si è vantato di averlo preso a schiaffi durante una manifestazione (era il 1998) in cui Gennaro organizzava il sevizio d'ordine. Di sicuro l'inchiesta sul faccendiere che ha messo in piedi la più colossale truffa dal dopoguerra non gli fa dormire sonni tranquilli. Mokbel (in passato «destinatario», scrive il gip Aldo Morgigni nell'ordinanza, «di provvedimenti cautelari per fatti omicidiari collegati ad azioni di gruppi terroristici di estrema destra unitamente a soggetti - quali ad esempio Carminati Massimo - ancora oggi oggetto di ricerche da parte delle forze di polizia») ha infatti complici assai vicini al mondo di quella che fu Alleanza nazionale. In primis l'avvocato Paolo Colosimo, finito anche lui in galera per associazione a delinquere: fino a qualche tempo fa tra i suoi clienti c'era Nicolò Accame, l'ex portavoce di Francesco Storace alla Regione Lazio. Rampollo della dinastia Accame (il papà Giano, "fascista di sinistra", fu un intellettuale influente, la sorella Barbara è la moglie del leader carismatico di Terza posizione Peppe Dimitri, morto tragicamente nel 2006) è stato condannato per corruzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta "Lazio-gate". Non solo. Del gruppo Mokbel fa parte anche Silvio Fanella, considerato dagli inquirenti il cassiere della banda. Il suo nome è spuntato a sorpresa nella compravendita di una società, la Mondo Verde, fondata anni fa dal capo della segreteria di Alemanno, Antonio Lucarelli, e da due suoi cugini. A "L'espresso" risulta che Fanella rilevi il 50 per cento delle quote nel luglio del 2000, quando Antonio ha già lasciato l'impresa. Dopo pochi mesi, Fanella e il suo socio Teodolo Theodoli vendono le azioni a una ditta amministrata da tal Fabrizio Moro. Sarà un caso, ma Moro è un amico di Lucarelli. Sarà una coincidenza, ma per la Mondo Verde targata Moro lavorerà in alcuni progetti - come ha rivelato "Repubblica" - il cognato di Gennaro Mokbel. Lucarelli, classe 1965, imprenditore, è uno dei fedelissimi di Alemanno. Con l'estrema destra ha sempre avuto grande feeling: il segretario del sindaco nel 2000 era il portavoce romano di Forza Nuova, movimento di estrema destra fondato nel 1997 dai latitanti Massimo Morsello, ex Nar, e Roberto Fiore, ex Terza posizione, che sfuggirono a una retata. Era il 1980, l'anno della strage di Bologna. I due scapparono a Londra, e tornarono solo quando le condanne per banda armata furono prescritte o, nel caso di Morsello gravemente malato, inapplicabili. Lucarelli si dà da fare: con i suoi organizza sit in inneggianti al leader dell'ultradestra austriaca Haider, manifestazioni contro il gay pride (i volantini lo definivano «la saga del pervertito») e risse davanti al Campidoglio (Marcello Fiori, vicecapo di gabinetto di Rutelli, denunciò di essere stato spintonato da Lucarelli). Nel who's who della cerchia di Alemanno ci sono anche altri ex camerati di rango. Vincenzo Piso, ex militante di Terza posizione e di Ordine nuovo, siede oggi in Parlamento ed è coordinatore del Pdl regionale. Venne arrestato nel 1980, restò in carcere per quattro anni con l'accusa di banda armata, venne poi prosciolto. Influente consigliere di Piso e del sindaco è poi Marcello De Angelis, anche lui di Terza posizione, cinque anni di carcere alle spalle e una carriera come cantante del gruppo musicale 27Obis, riferimento all'articolo del codice penale sulle associazioni con finalità di terrorismo. Fratello del leader di Terza posizione Nanni, morto in circostanze misteriose in carcere, Marcello ora è senatore e direttore di Area, la rivista fondata da Alemanno e Storace. Da un anno al Comune lavora anche Loris Facchinetti (nell'ordinanza del 31 dicembre 2009 si specifica che la collaborazione è «a titolo gratuito»), ex leader di Europa civiltà, un movimento neopagano e paramilitare di estrema destra nato nel 1969 che aveva rapporti pure con la massoneria. Fermato «per reticenza nell'inchiesta di piazza Fontana», come ricorda Ugo Maria Tassinari nel suo libro "Fascisteria", Facchinetti - sposato con la sorella di Fabio Rampelli - oggi è delegato del sindaco di Roma per il Mediterraneo, ed esperto di "Politiche internazionali" della fondazione di Alemanno. Che ha voluto vicino a sé pure Claudio Corbolotti, aiutante di Lucarelli al Comune, arrestato nel 2004 per gli scontri avvenuti fuori l'Olimpico durante il derby Lazio-Roma. A proposito di ultrà, anche Guida Zappavigna, ex dei Boys della Roma ed ex Fuan, arrestato come presunto Nar e prosciolto in istruttoria, ha avuto un incarico dalla Polverini: ora è presidente del parco del Lago Lungo e Ripa. Grande tifoso di Totti e compagni è anche Mirko Giannotta. Le cronache ricordano che è stato arrestato nel 2003 insieme al fratello perché accusato di rapine ai danni di banche e gioiellerie, e che dal 2008 è diventato capoufficio del decoro urbano del gabinetto del sindaco. Già. Alemanno, cuore nero, non molla mai nessuno.
I fasciomafiosi alla conquista di Roma. Ex terroristi e colletti bianchi uniti dall’ideologia e dal denaro. E ormai più forti dei tradizionali clan. Ecco l’inedita rete di potere che oggi controlla la Capitale. E l'arresto per l'omicidio Fanella legato al caso Mokbel è solo l'ultimo tassello di un mosaico più grande, scrive Lirio Abbate su “L’Espresso”. Non è una città, ma un intreccio di traffici e intrallazzi, delitti e truffe, su cui si è imposta una cupola nera. Invisibile ma potentissima, ha preso il controllo di Roma. Trasformando la metropoli nel laboratorio di una nuova forma di mafia, comandata da estremisti di destra di due generazioni. Al vertice ci sono vecchi nomi, veterani degli anni di piombo, abituati a trattare con le istituzioni e con i padrini, abili a muoversi nel palazzo e sulla strada. Ai loro ordini c’è un’armata bifronte, che unisce banditi e narcos, manager nostalgici e giovani neofascisti. L’ideologia garantisce compattezza, il credo nell’azione e nella sfida. I soldi, tanti e subito, premiano la fedeltà. E la componente borghese, dai maturi colletti bianchi ai ragazzi in camicia nera, gli permette di arrivare ovunque. Con le buone o con le cattive. Per comprendere bene cosa accade oggi nella Capitale, in questo grande spazio circoscritto dal Grande raccordo anulare, occorre mettere da parte quello che accade a Napoli, a Palermo o a Reggio Calabria. È nella Capitale che ha messo radici un sistema criminale senza precedenti, con fiumi di cocaina e cascate di diamanti, ma anche tanto piombo. Una fascio-mafia, che sintetizza la forza perversa di due tradizioni in un’efficacia che gli ha consegnato anni di dominio incontrastato. Persino gli investigatori hanno fatto appello alla sociologia per spiegare il modello romano. Qui si incarna la microfisica del potere teorizzata da Paul Michel Foucault: il potere criminale-mafioso si esercita, si infiltra, «non è qualcosa che si divide tra coloro che lo possiedono o coloro che lo detengono esclusivamente e coloro che non lo hanno o lo subiscono. Il potere deve essere analizzato come qualcosa che circola, o meglio come qualcosa che funziona solo a catena. Non è mai localizzato qui o lì, non è mai nelle mani di alcuni, non è mai appropriato come una ricchezza o un bene. Il potere funziona, si esercita attraverso un’organizzazione reticolare». Si estende in tutte le strutture sociali ed economiche, con dinamiche che cambiano continuamente e costruiscono altri patti e altri affari. Si infiltra, entra nei ministeri, nelle finanziarie, nelle grandi società pubbliche come nei covi dei rapinatori e nelle piazze di spaccio. A Roma non ci sono zone in cui commercianti e imprenditori sono obbligati a pagare il pizzo. Non c’è l’oppressione del boss di quartiere. E gli omicidi sono calibrati con estrema attenzione. Luglio si è aperto con l’assassinio di un pezzo da novanta di questo sistema, Silvio Fanella, nei condomini bene. Agosto si è chiuso con l’esecuzione di un’autista della nettezza urbana, Pietro Pace, nella periferia estrema: il padre ha offerto una taglia di 100 mila euro sui killer. Delitti miratissimi, perché quello che conta è far girare i soldi, che si tratti di gestire immobili, licenze, investimenti o di vendere droga. Gli architetti di questo sistema non si sporcano le mani con il sangue. Sanno a chi affidare il lavoro sporco. E quando devono colpire duro, hanno a disposizione una centuria nera compattata dall’estremismo di destra. Uno dei componenti di questa cupola rivoluzionaria è Massimo Carminati, che sembra avere trasformato il suo personale romanzo criminale in una marcia trionfale. È stato nella banda della Magliana e nelle squadre terroriste dei Nar, con amicizie di rango in Cosa nostra e negli apparati deviati dello Stato. Coinvolto in processi importanti, come quello per l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ne è sempre uscito assolto. Ha scontato pochi anni di carcere per episodi minori. Nella Roma nera è un mito: un leader da seguire e ascoltare. E lui da leader si comporta e agisce. Si mostra, a chi non lo conosce, con modi felpati ed educati. Ma quando vuole sa imporsi con la forza, tanto che sodali e rivali lo rispettano con timore. È lui “l’ultimo re di Roma”. I suoi avvocati Ippolita Naso e Rosa Conti respingono questa ricostruzione: «Se tutto ciò rispondesse a verità, più che un uomo di potere sarebbe corretto definirlo uomo dai super poteri, che ha in mano le redini dell’imprenditoria capitolina, in grado di condizionare le vicende della politica romana, capace di passare dal traffico di droga ai vertici degli affari economici controllando, già che c’è, anche il territorio. E il tutto con un occhio solo!». Un riferimento a quella ferita vecchia di trent’anni, l’eredità di un conflitto a fuoco con i carabinieri che gli ha fruttato il soprannome di “er Cecato”. Per i legali però, come scrivono in un atto di citazione per difendere il loro cliente: «Siamo all’apoteosi dei luoghi comuni cinematografici. E di questo strabordare di informazioni neanche l’ombra di un elemento, un indizio, una circostanza oggettiva, una testimonianza, un riscontro, una indicazione di massima, una traccia, un segno che si sforzi di dare una parvenza di verità a quanto riferito». Per gli avvocati, «Carminati non ha più alcun conto in sospeso con la giustizia, è attualmente privo di pendenze penali e soprattutto re-inserito in un contesto sociale e familiare del tutto lecito, nel quale lodevolmente egli sta cercando di recuperare» e poi «si prende cura costantemente del figlio ventenne e convive stabilmente con la compagna, Alessia Marini, con la quale gestisce il negozio di abbigliamento “Blue Marlin”». Le parole degli avvocati sono un punto di partenza per decifrare la pista nera. Il negozio fa capo alla “Amc Industry srl” di cui è amministratore unico Alessia Marini e Carminati non compare come socio. La “Amc industry” dal primo gennaio 2011 ha preso in affitto una villa a Sacrofano, alle porte di Roma, su una collinetta che domina tutta la zona. Si tratta di una bella abitazione, ben rifinita, su due piani, con grande piscina circondata da prato all’inglese e un lungo viale che separa dal cancello. Qui vive Massimo Carminati. La villa risulta di proprietà del commercialista Marco Iannilli, un professionista dalle alte relazioni che negli ultimi quattro anni è diventato protagonista della cronaca giudiziaria. È stato arrestato e condannato in primo grado per la colossale truffa su Fastweb e Telecom Sparkle, che ha fatto girare centinaia di milioni di euro. Ma ha anche un ruolo chiave nelle istruttorie su Enav, l’azienda pubblica che gestisce il traffico aereo, su Digint e su Arc Trade: procedimenti che ruotano intorno a Finmeccanica, il gigante statale degli armamenti hi-tech. È nei guai anche per la vicenda della mazzetta pagata da Breda Menarini, sempre del gruppo Finmeccanica, per aggiudicarsi la fornitura di autobus da Roma Metropolitane, in cui sono indagati anche l’ex sindaco Gianni Alemanno e Riccardo Mancini. Che in passato avevano avuto rapporti con Carminati: un passato forse non così remoto. Solo coincidenze? Quando nel febbraio 2010 i carabinieri del Ros arrestano Iannilli, lo trovano in possesso di una Smart intestata a Carminati. E quando il commercialista a novembre 2011 finisce ancora in cella, i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Roma e i militari del Ros annotano che «immediatamente dopo l’arresto di Iannilli, si recava presso la sua abitazione Massimo Carminati, allertato a tal proposito dalla moglie del commercialista». Perché tanto interesse? Negli atti non c’è risposta. Ma Iannilli per gli inquirenti era un esperto «nell’utilizzo di prestanome» e «per la costituzione o la rilevazione di società italiane ed estere, e la conseguente apertura dei relativi conti correnti, allo scopo di veicolare i profitti illeciti provenienti da operazioni di frode fiscale di notevole entità». Un professionista insomma che gestisce decine di milioni di euro e che sarebbe stato capace di dare copertura pulita ad attività in tutto il mondo, «il tutto per agevolare altri soggetti o organizzazioni criminali, in attività di riciclaggio di denaro». Il commercialista sembra pendere dalle labbra del “Cecato”. E non pare essere l’unico. C’è un altro uomo introdotto nei salotti buoni e di manifesta fede fascista che avrebbe subito il carisma dell’ex terrorista: Lorenzo Cola, tra i principali collaboratori di Pierfrancesco Guarguaglini, fino al 2011 numero uno di Finmeccanica. Per gli investigatori ha controllato un sistema illegale «in grado di influenzare le scelte societarie e commerciali dell’Enav». In questo modo ha creato operazioni di sovrafatturazione fra le aziende di Finmeccanica e società subappaltanti riconducibili a Iannilli: somme trasferite all’estero grazie alla rete del commercialista. Iannilli e Cola erano in affari con un altro estremista duro e puro: Gennaro Mokbel, condannato in primo grado come regista della truffa Fastweb con un riciclaggio da due miliardi. Ma è anche l’uomo che con l’aiuto, da una parte degli amici di Carminati e dall’altra della ’ndrangheta, è riuscito a far eleggere al Senato Nicola Di Girolamo, oggi detenuto ai domiciliari. In ogni indagine condotta dalla magistratura romana che riguardi grandi operazioni finanziarie spunta sempre qualcuno legato all’estrema destra, alla ’ndrangheta, agli 007 deviati, e a boss napoletani trapiantati nella Capitale. E su tutto si allunga l’ombra del “Cecato”. Perché lui vive in una terra di mezzo, perché sa come risolvere i problemi di chi abita negli attici dei Parioli e sa a chi chiedere nei meandri delle periferie più malfamate. L’intreccio di business e crimine, di manager e fasci, è esploso con i proiettili che il 3 luglio scorso in un condominio elegante della Camilluccia hanno ucciso Silvio Fanella. Gli inquirenti lo definiscono “il cassiere di Mokbel” e stava scontando ai domiciliari la condanna a nove anni proprio per l’affaire Fastweb-Telecom Sparkle. Uno degli aggressori è rimasto ferito ed è stato arrestato: Giovanni Battista Ceniti, ex dirigente piemontese di Casa Pound. Non doveva essere un omicidio. In tre, fingendosi militari delle Fiamme Gialle, volevano rapire Fanella e farsi rivelare il nascondiglio di un tesoro da sessanta milioni di euro. Solo una parte è stata poi ritrovata dal Ros: mazzette di denaro e sacchetti pieni di diamanti, sepolti in un casale ciociaro. La caccia a quel forziere è stata un’ossessione, che potrebbe avere incrinato antichi accordi tra i nuovi re di Roma. Già due anni fa avevano provato a rapire Fanella. E proprio le indagini sul primo raid hanno aperto un altro spaccato sui poteri occulti della Capitale. Per quel blitz la procura ha ordinato l’arresto di tre persone. Uno è Roberto Macori, 40 anni, fino al 2011 factotum di Mokbel che poi si è legato ad un altro dei senatori della Roma criminale: Michele Senese, detto “o Pazzo”, il padrone della periferia a Sud del raccordo anulare, dove domina lo spaccio. Anche lui passato dalla banda della Magliana, ma soprattutto boss legato alla camorra e ai casalesi: da un anno è in cella per omicidio. Anche lui abituato a pensare in grande e muoversi nell’imprenditoria, sempre in accordo con Carminati. Prima dell’arresto, assieme a Macori voleva mettere in piedi una truffa da 60 milioni, rilevando un deposito di carburante a Fiumicino. Entrambi erano in stretto contatto e Macori al telefono parlava dell’interesse «dei napoletani» per il tesoro custodito da Fanella. Non sarà un caso se a casa di Macori, dopo l’arresto, i carabinieri hanno sequestrato sei diamanti purissimi che sembrano essere uguali a quelli trovati nel caveau di Fanella. E gli investigatori non credono più alle coincidenze. Stanno ricostruendo un mosaico in cui tanti delitti, tante acrobazie finanziarie in cui compaiono gli stessi nomi e gli stessi metodi. I reduci dei Nar, gli emissari di ’ndrangheta e camorra, la manovalanza a mano armata reclutata tra i neofascisti: l’organigramma della nuova fascio-mafia romana.
Alemanno, il missino che ha scalato il Campidoglio. Per i detrattori Paperino in virtù di un timbro di voce non proprio suadente, scrive Roberto Scafuri su “Il Giornale”. Gianni Alemanno, per i detrattori Paperino in virtù di un timbro di voce non proprio suadente. Genero di Pino Rauti, ideologo della Destra sociale, il giovane Alemanno è uno degli esponenti di punta della gioventù neofascista. D'origine barese, ricalca il modello dell'«intellettuale tenebroso», spesso vestito di nero, sempre apparentemente cupo, fascinoso per il gruppo che gli va dietro. Finirà implicato in una sola azione violenta, il lancio di una molotov all'ambasciata Usa. Ma siamo già alla fine della stagione incendiaria: Gianni nel frattempo ha conosciuto Isabella Rauti, ne frequenta la casa, di lì a poco sarà deputato con il Msi. La sua esclation politica, il suo «passaggio di grado» avviene soltanto nella terza vita, quando dopo aver accettato di malavoglia la trasformazione del Msi in An, viene lanciato prima come ministro (all'Agricoltura, probabilmente la sua stagione migliore), quindi nella sfida per la poltrona del Campidoglio. Stracciò Rutelli, ex «big» a corto di charme , ma tanto del merito fu anche suo. Luci e ombre nella sua stagione da sindaco, dove un uso assai disinvolto di concorsi e assunzioni per gli amici gli è costata il voltafaccia dei cittadini.
Gianni Alemanno, primo sindaco nero di Roma, indagato per associazione mafiosa. Cinque anni vissuti maldestramente in Campidoglio, contornato di presunti corruttori e delinquenti, fedelissimi travolti via via da avvisi di garanzia e scandali, danze delle parentopoli dell’Ama e dell’Atac, scrive Susanna Turco su “L’Espresso”. Nel suo fu comitato elettorale romano, ex deposito Atac di via della Lega Lombarda, giganteggia ancora lo slogan dell’ultima perdente campagna elettorale per il Campidoglio: “Il coraggio del fare”. Su Twitter, l’ultima foto è quella con “mia zia Maria di oltre 102 anni”, postata esattamente 20 ore prima del diluvio. Adesso che il diluvio è arrivato, quasi con un salto spazio temporale da brividi, Gianni Alemanno, primo sindaco nero di Roma e primo ex sindaco ad essere indagato per associazione mafiosa, dirama note e messaggi in cui assicura: “Dimostrerò la mia totale estraneità e ne uscirò a testa alta. Chi mi conosce sa che ho sempre combattuto a viso aperto mafia e criminalità”. Il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, titolare dell’ inchiesta “Mondo di mezzo” , spiega che “alcuni uomini vicini all'ex sindaco Alemanno sono componenti a pieno titolo dell'organizzazione mafiosa e protagonisti di episodi di corruzione”, ma chiarisce che “la posizione di Alemanno è tutta da vagliare”. Parole che, fuori dalla vicenda giudiziaria s’intende, non stridono con l’adagio politico per cui nei palazzi s’è sempre descritto Alemanno come “un perfetto gregario, non un leader”, che ha fatto di questo “il segreto del suo successo”. Comunque, per la cronaca, a poche ore dalla notizia della procura l’unico a scomodarsi subito per dirsi pubblicamente “certo della sua estraneità alle accuse” è Ignazio La Russa. Il resto, silenzio assoluto. L’accelerazione dentro un romanzo criminale in piena regola, intanto, cade per Alemanno su un percorso di quieta ricostruzione di sé – e magari di una qualche destra possibile – dopo i nefasti fasti del potere: un percorso che fino a ieri aveva accenti gozzaniani. Con l’adorabile zia Maria, le scritte “noi Alemanno duriamo a lungo”, le foto invero tristissime con la pizza a taglio sulla scrivania, le presenze in piazza e a Tor Sapienza, e il tintinnare delle multe sulla panda rossa, e le foto dei temporali romani, gli immigrati, le foto dei Fori imperiali vuoti di macchine (“la grande tristezza”), le iniziative di presentazione a Rieti della “rivoluzione italiana”, i pomeriggi a convegno con “gli amici di Fratelli d’Italia” per il porto di Gioia Tauro, i plausi al ribellismo azzurro di Raffaele Fitto, il figlio che studia l’esame all’università, le trasferte a Orvieto, a Crotone, a Catanzaro, le presentazioni del suo ultimo libro. Insomma, il disegno complessivo di un crepuscolo politico battagliero, tutto sommato ben vissuto, nello stile di un grande avvenire dietro le spalle. Salvo naturalmente il puntuale, reiterato, a tratti ossessivo attacco a Marino, l’uomo che gli soffiò la poltrona in Campidoglio: comprensibile anche questo, in fondo. E non solo per motivi personali. Già, perché adesso che Alemanno è indagato, e il senatore grillino Andrea Cioffoli ne chiede le “dimissioni”, a Montecitorio parlamentari e giornalisti sbottano: “Ma dimissioni da che?”. Con il che chiarendo in che punto fosse precipitata – prima del diluvio appunto – la percezione pubblica di un personaggio che i più avevano salutato nella primavera del 2013, dopo i ballottaggi. Ecco invece Alemanno è sempre rimasto lì, da perdente ai ballottaggi, nel consiglio comunale a Roma. Mancata pure la catapulta delle europee con Fdi, ha continuato ad essere legato a doppio filo col regno che una volta guidò. Cercando anche di far dimenticare i lati peggiori di quei cinque anni vissuti maldestramente in Campidoglio, contornato di presunti corruttori e delinquenti, fedelissimi travolti via via da avvisi di garanzia e scandali, danze delle parentopoli dell’Ama e dell’Atac, fino alla sublime catastrofe della gestione della neve a Roma. Ombre che parevano sbiadite, consegnate al passato – anche grazie alle disgrazie dell’amministrazione Marino – e che invece ora tornano a brillare.
Buzzi, la mente della coop con le mani in pasta. Salvatore Buzzi, 59 anni, in galera è di casa. Fu lì che gli venne l'idea, e non si trovava in gita di piacere, scrive Roberto Scafuri su “Il Giornale”. Il 29 giugno dell'85, dopo un convegno tenutosi a Rebibbia l'anno prima, fonda la cooperativa sociale per il reinserimento dei detenuti. «Non fu un atto volontario, ero un detenuto in attesa di giudizio», ricorderà con ironia. Nel 2004 la «29 giugno» (la chiamarono proprio così, «per tenere a mente quella giornata che aprì le nostre gabbie mentali») ha già 215 dipendenti. Uno snodo delle politiche ambientali e sociali del Comune. Di lì a poco, secondo gli inquirenti, per Buzzi ci sarebbe stata una seconda «illuminazione», ancora più brillante della prima. «Tu c'hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno», dice nelle intercettazioni. Sistema perfetto per far arrivare i soldi pubblici ai gestori amici, il cui crocevia porta il nome di Luca Odevaine, ex vicecapo di gabinetto del sindaco Veltroni. Anche Buzzi godeva di buone entrature : «Solo in quattro sanno quello che succede e sono nell'ordine Bianchini, Marino, Zingaretti e Meta», dice a Carminati. E questi, senza esitazioni: «E allora mettiti la minigonna e vai a batte co' questi , amico mio».
Ozzimo, dal volontariato a ras del piano casa. Daniele Ozzimo è un ragazzo di Centocelle, classe '72, uno conosciuto dalle parti della Tiburtina perché s'è fatto largo nel volontariato, scrive Roberto Scafuri su “Il Giornale”. Classico studente «impegnato» di Scienze politiche alla Sapienza, nel '94 s'iscrive al Pds, continua a occuparsi di servizi sociali e disabilità. Nel 2000 è segretario del partito al V Municipio, nel 2008 entra nel Consiglio comunale tra le fila del Pd. Ma è già un altro Daniele, rispetto al ragazzo di Centocelle che si batteva per handicappati e barriere architettoniche. Ora può contare su appoggi importanti e conoscenze influenti, che gli valgono la poltronissima di assessore alla Casa nella giunta Marino. Con deleghe dall'emergenza abitativa al piano casa, ai centri di formazione professionale. Ieri Ozzimo si è dimesso subito, non credendo ai propri occhi e reclamando la totale estraneità ai fatti, «per non arrecare in nessun modo danno all'amministrazione della città». Attestati di stima gli sono arrivati dal sindaco e altri esponenti del Pd cittadino, duramente colpito anche per il coinvolgimento nell'inchiesta di Mirko Coratti, presidente dell'Assemblea capitolina, e due consiglieri: Franco Figurelli ed Eugenio Patanè (regionale).
La foto che imbarazza il ministro Poletti, scrive “Libero Quotidiano”. C'è una foto che sta girando online e che certamente imbarazzerà l'attuale ministro del Lavoro del governo Renzi, Giuliano Poletti. E' uno scatto risalente al 2010, quando Poletti era presidente della Lega Coop. E lo vede a tavola in un ristorante romano assieme ad alcuni dei personaggi che sono stati coinvolti e indagati nell'indagine sulla "cupola romana" che controllava gli appalti nella capitale con modalità di stampo mafioso. Poletti è seduto accanto a Franco Panzironi, ex ad della municipalizzata dei rifiuti Ama (arrestato); il deputato del Pd Umberto Marroni (non indagato); l'ex assessore alla Casa della giunta Alemanno Daniele Ozzimo (indagato); Angelo Marroni, garante dei detenuti del Lazio (non indagato); Salvatore Buzzi, responsabile della coop "29 giugno" (indagato); l'allora sindaco Gianni Alemanno (indagato). per la cronaca, seduto a un altro tavolo c'è il pregiudicato Luciano Casamonica.
Da Poletti al Pdl tutti a tavola col capo clan Una foto racconta il potere di mafia Capitale. Nel 2010 il braccio destro di Massimo Carminati, Salvatore Buzzi organizzò una cena per ringraziare "I politici che ci sono a fianco". Da Rebibbia al Palazzo, l'incredibile carriera di un ex detenuto modello divenuto il dominus di una cooperativa da sessanta milioni, scrive Emiliano Fittipaldi “L’Espresso” C'è una foto che racconta alla perfezione la parabola di Salvatore Buzzi, secondo la procura di Roma capo della nuova Mafia capitolina insieme all'ex fascista Massimo Carminati. Lo scatto risale al 2010, e immortala una cena in un centro di accoglienza organizzata da Buzzi e la sua cooperativa, "29 giugno". Attorno al tavolo ci sono tutti quelli che a Roma contavano qualcosa. Politici di destra e sinistra, assessori e esponenti del clan dei Casamonica, tutti insieme appassionatamente. Buzzi, detenuto negli anni '70 e '80 per omicidio, poteva dirsi più che soddisfatto: era riuscito infatti a far sedere fianco a fianco l'allora sindaco Gianni Alemanno (oggi indagato con Buzzi per associazione mafiosa), l'ex capo dell'Ama Franco Panzironi (arrestato con Buzzi), un esponente del clan dei Casamonica in semilibertà, l'attuale assessore alla Casa Daniele Ozzimo (al tempo consigliere Pd e pure lui indagato oggi dai magistrati: si è dimesso ), il portavoce dell'ex sindaco Sveva Belviso e il potente parlamentare del Pd Umberto Marroni, seduto, sorridente, vicino a Panzironi. Marroni (accompagnato dal padre Angiolo, al tempo garante dei detenuti della Regione Lazio) era capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, sulla carta il capo dell'opposizione ad Alemanno. Oggi è onorevole, e siede alla Camera. «Per due anni - raccontò Buzzi - insieme ad altre nove cooperative abbiamo lottato contro Alemanno che voleva tagliarci i fondi. Abbiamo organizzato sette manifestazioni in Campidoglio. Alla fine abbiamo raggiunto un accordo e perciò c'è stata quella cena. Invitammo i politici che ci erano stati a fianco, per questo c'erano anche esponenti del Pd». Nella cena bipartisan Buzzi era riuscito a infilare anche Giuliano Poletti, attuale ministro del Lavoro e allora gran capo della Lega Coop. Poletti e Buzzi si conoscono bene: il ministro (non indagato e non coinvolto nell'inchiesta) è stato invitato dal braccio destro di Carminati anche all'assemblea della cooperativa 29 giugno per l'approvazione del bilancio 2013. Tanto che, per festeggiare l'arrivo di Giuliano al dicastero del Lavoro, lo scorso maggio Buzzi ha dedicato la copertina del magazine dell'associazione proprio all'ignaro Poletti. Numero del magazine sul quale troviamo le firma di Angiolo Morroni e interviste di Ozzimo e Giovanni Fiscon, dirigente dell'Ama anche lui finito in manette. Buzzi è uno che ci sa fare. La sua carriera ha dell'incredibile. Arrestato per omicidio, condannato a trent'anni, nel 1980 decide di mettersi a studiare e di laurearsi. Tre anni più tardi, risulta a "L'Espresso" riesce a diventare dottore in Lettere Moderne, con una tesi sull'attività giornalistica dell'economista Pareto. Un lavoro eccellente: Buzzi prende 110 e lode, è il primo a laurearsi all'interno delle mura di Rebibbia. Un anno dopo, sempre in carcere, si fa notare prendendo la parola in un convegno su "Misure alternative alla detenzione e ruolo della comunità esterna". La sua relazione chiede che la riforma carceraria venga applicata rapidamente, in modo da garantire ai carcerati misure alternative alla detenzione. Anche stavolta, applausi a scena aperta, tanto che Stefano Rodotà, allora deputato della sinistra indipendente, secondo l'Ansa dichiara che «la relazione svolta dal detenuto Buzzi rappresenta un documento concreto e di grandissimo interesse per cui d'ora in poi per le istituzioni non ci sono più alibi». Un detenuto modello, insomma. Buzzi due anni dopo corona il suo sogno, ed esce dalla cella. Fonda con altri soci la cooperativa «Rebibbia 29 giugno» e comincia a rifarsi una vita. Partecipa nel 1986 a un convegno sugli anni di piombo a Roma a cui partecipano ex terroristi dissociati che hanno aperto cooperative, e racconta di aver ottenuto - con la sua - alcuni lavori di ristrutturazione sulla Tiberina, persino quelli per la ristrutturazione di una caserma dei carabinieri. «Se non ci saranno altri lavori» spiega dal palco «tutto finirà. Cosa aspetta il comune di Roma a dare una destinazione ai 500 milioni di lire che la Regione Lazio ha attribuito ad ogni comune sede di istituzioni carcerarie?». Non sappiamo quando Buzzi decide si tornare al crimine, né quando conosce Carminati e e i sodali con cui costuira l'associazione mafiosa che - ha spiegato Giuseppe Pignatone - da lustri domina Roma attraverso tangenti, intimidazioni, usura, riciclaggio e corruzione. Sappiamo che di soldi, alla sua cooperativa, ne arriveranno a bizzeffe. Grazie, soprattutto, agli accordi con la politica: spulciando il bilancio 2013, si scopre che i ricavi della galassia presieduta da Buzzi hanno sfiorato i 59 milioni di euro, mentre il patrimonio di gruppo ha superato i 16,4 milioni. Possibile che la politica, in tutti questi anni, non si sia mai accorta che l'ex detenuto modello era tornato dalla parte dei cattivi?
«Ohh ma che... me so’ comprato Coratti» Intercettazioni, imbarazzo nel Pd romano. Secondo gli inquirenti che indagano sulla Mafia Capitale, all'esponente dem Mirko Coratti sarebbero stati promessi "150 mila euro di stecca" qualora fosse intervenuto per sbloccare un pagamento di 3 milioni di euro, scrive Giovanni Tizian su “L’Espresso”. «E allora mettiti la minigonna e vai a batte co' questi amico mio, eh capisci». A buon intenditor poche parole. E l'ultimo Re di Roma, Massimo Carminati detto “Er cecato”, le parole sa dosarle con attenzione. Metafore e mezze parole per dire e non dire. I suoi interlocutori però capiscono al volo gli ordini. Mettersi la minigonna e andare a battere è un messaggio preciso che coglie al volo Salvatore Buzzi, il presidente della Cooperativa 29 giugno, legata a Legacoop, imprenditore di riferimento di Carminati e con quest'ultimo finito agli arresti nell'operazione sulla Mafia capitale della procura antimafia di Roma. Quella frase vuol dire che il gruppo, che i pm definiscono Mafia Capitale, ha necessita di trovare nuovi referenti politici nell'era post Alemanno. «A seguito del mutamento nella maggioranza del comune di Roma sortito dalle consultazioni elettorali, investe nell’acquisizione di nuovo capitale istituzionale, decisione strategica mimeticamente rappresentata dall’espressione di Carminati, a suo dire rivolta a Buzzi». All'ordine di Carminati segue una campagna acquisti nella nuova compagine di maggioranza. «La scuderia è pronta», commenta Buzzi, che i pm definiscono come uomo in «indiretta collaborazione con Carminati», riferendosi ad alcuni amici politici che hanno ricevuto incarichi istituzionali. Tra le figure agganciate a sinistra, i magistrati e gli investigatori del Ros guidati dal colonnello Stefano Russo, indicano Mirko Coratti. Esponente del Partito democratico e presidente dell'Assemblea capitolina. Un'insospettabile cui si rivolge Buzzi, il quale sostiene che« solo per metteme a sede a parla’ con Coratti, 10mila gli ho portato». E' sempre il presidente della cooperativa rossa a rivelare altri particolari captati dalle cimici dei detective dell'Arma. A Coratti sarebbero stati promessi 150 mila euro di stecca qualora fosse intervenuto per sbloccare un pagamento di 3 milioni di euro sul sociale. «Ohh ma che..me so’ comprato Coratti» esclama il manager della 29 giugno. Un ulteriore riferimento al presidente del Consiglio comunale è in una conversazione tra il boss Carminati e lo stesso Buzzi. «Con ste bustine, il libricino nero e bustine qua, eh!» chiede il Re di Roma, «Vedo Coratti, il segretario vediamo ste cose con lui» risponde l'imprenditore riferendosi alle «bustine» sul tavolo. I rapporti diretti con Coratti, scrivono i magistrati, non sono millanteria. «Emerge non solo dalle conversazioni intrattenute con il capo segreteria di costui finalizzate a costruire momenti d’incontro, ma anche da contatti tra Buzzi e Coratti, riconducibili alla gara del multimateriale di Ama e ad altre questioni di rilevanza pubblica», scrive il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare. A tirare in ballo il politico del Pd un'altra frase intercettata pronunciata sempre da Buzzi: «Perché Coratti sicuramente me chiede da divide già l’anticipo per cui io glie dò un lotto.. ah gliel’ho detto che il milione già se lo so…possono..». Intercettazioni che hanno fatto luce sul sistema de "Er cecato" e che stanno mettendo in forte imbarazzo il Pd capitolino.
Killer neri e violenti rossi. Il "cupolone" trasversale nel nome degli affari. La strana alleanza tra l'ex Nar Carminati e l'uomo delle cooperative Buzzi. Distanti in politica ma uniti nel mettere in società i loro contatti per far soldi, scrive Massimo Malpica su “Il Giornale”. Il Rosso e il Nero, a braccetto, nel nome degli affari. Secondo la procura di Roma, la capitale era coperta da un «cupolone» rigorosamente trasversale, che per i magistrati ha, in pratica, reinventato la mafia. Perquisizioni dei Carabinieri in Campidoglio nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione di stampo mafioso. Ma se toccherà alle toghe dimostrare la concretezza delle accuse, non può non colpire la «strana coppia» al centro dell'indagine che ha sconvolto la città eterna. Da una parte c'è Massimo Carminati, l'esponente dei Nar legato alla banda della Magliana (è il «Nero» nell'epopea di libri, film e tv sulla banda, ma il suo vero soprannome è il «Cecato»). Dall'altra c'è Salvatore Buzzi, una condanna per omicidio risalente agli anni '80 prima di far carriera come presidente della cooperativa di detenuti ed ex detenuti «29 giugno», legata a Legacoop. Che c'azzeccano Nar e coop rosse? Che ci fanno insieme due tipi così? Fanno soldi, nel «mondo di mezzo». Secondo la procura di Roma, la loro «cupola» pilotava e lucrava su gare e appalti pubblici, dai rifiuti ai campi nomadi, dalla manutenzione del verde pubblico ai centri d'accoglienza. Tutto contando su solidissimi appoggi politici, naturalmente trasversali anch'essi. Tant'è che tra gli indagati c'è l'ex sindaco di centrodestra della capitale, Gianni Alemanno, perché per la procura uomini a lui vicini erano legati all'organizzazione. Ma c'è anche l'assessore alla Casa della giunta Marino targata Pd, Daniele Ozzimo, come pure il presidente dell'assemblea capitolina, Mirko Coratti. E tra i nomi citati a vario titolo nelle mille e passa pagine di ordinanza c'è quasi tutta la politica locale a 360 gradi. Lo slogan, insomma, è che «la politica è una cosa, gli affari so' affari», come riassume, intercettato, proprio Buzzi, rispondendo a chi gli chiede come, lui di sinistra, possa lavorare con Carminati. E se la guida è bicefala, ognuno cura i rapporti con gli «amici» della propria parte politica, nel comune interesse. E bicefale, trasversali, inevitabilmente lo diventano anche le ramificazioni del comitato d'affari. La «mafia capitale», come l'ha battezzata la procura di Roma. O semplicemente la «scuderia», per rubare proprio a Carminati e Buzzi la metafora ippica che i due usano a proposito della nuova giunta di Ignazio Marino, sperando che dei «nove cavalli» alla fine ce ne fossero almeno «sei dentro», così «la scuderia è pronta» - spiega Buzzi - e «poi si cavalcherà», replica Carminati. Diversi, appunto, ma soci, collaborativi, in grado di usare sia le amicizie che le intimidazioni. Tanto che Buzzi racconta a un collaboratore di quella volta in cui, non riuscendo a parlare al capo segreteria di Alemanno, Antonio Lucarelli, per lo sblocco di un finanziamento, era intervenuto con una telefonata Carminati: «Aò alle tre meno cinque scende, dice, “ho parlato con Massimo, tutto a posto domani vai”... aò, tutto a posto veramente! C'hanno paura de lui». Intimidazione o amicizia, l'importante è il business. E appunto la vocazione agli affari, annotano gli inquirenti, «non ha barriere politiche». Con Buzzi che, subito dopo le ultime comunali romane, quando Marino al ballottaggio sconfigge Alemanno, si rammarica ma assicura di non essere impreparato. Perché lui, e l'organizzazione, erano già pronti a qualunque evenienza, indipendentemente dall'esito del voto. «Se vinceva Alemanno ce l'avevamo tutti comprati», racconta intercettato, «e mo vedemo Marino, poi ce pigliamo 'e misure con Marino». Sono i traghettatori e parlano con tutti. Mediatori, sensali, collettori, ricattatori quando serve, portano le tangenti e decidono le assunzioni, definiscono gli affari e spartiscono la torta, raccomandano e suggeriscono, tramano e fanno girare il mondo. Sono le anime del mondo di mezzo, sono i padroni del purgatorio, né vivi né morti. Non esiste più destra e sinistra, ma alto e basso, sopra e sotto. L'obiettivo è sempre lo stesso: denaro e potere. Nessun timore nel mettere le mani su una giunta e nel lavorare per fare il bis con la successiva, di colore opposto. Nessun problema nel trovare gli agganci, a destra prima e a sinistra poi. Il Rosso e il Nero, insieme alla conquista di Roma.
"Bustoni di soldi a tutti, anche a Rifondazione". Nelle carte dell'indagine Carminati descrive la rete di contatti tra criminali e politici. I pm: "Era intoccabile perché foraggiava partiti di ogni genere", scrive Patricia Tagliaferri su “Il Giornale”. Nel mondo di Massimo Carminati, «il mondo di mezzo» che ha dato il nome all'inchiesta della Procura di Roma, è normale che un ex Nar vada a cena con un politico. È lo stesso Carminati a dirlo al suo braccio destro militare Riccardo Brugia. Per il procuratore Giuseppe Pignatone l'intercettazione più significativa di tutta l'indagine è quella in cui Carminati spiega la teoria del mondo di mezzo, quello dove «ci sono i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo...un mondo in cui tutti si incontrano e dove è possibile che un domani io mi trovi a cena con un politico». Perché per i pm la struttura messa in piedi da Carminati era una vera e propria cerniera tra ambienti criminali e settori istituzionali, che traeva il suo potere e la sua forza di intimidazione dai legami storici con la Banda della Magliana e con l'eversione nera e il cui sviluppo criminale si era evoluto al punto da individuare come terreni privilegiati della sua azione, quelli dell'economia e degli appalti. Carminati utilizzava i suoi trascorsi criminali per convincere gli imprenditori ad affiliarsi alla sua organizzazione. Con uno di questi, che incuriosito gli aveva chiesto quale fosse a suo dire la rappresentazione cinematografica più calzante che era stata fatta del suo personaggio, si mette a fare una vera e propria classifica del suo palmares: «Bene Romanzo Criminale , ma solo il film, perché la serie è una buffonata, ma la vera banda della Magliana è quella descritta su History Channel». Per i magistrati sarebbe un errore derubricare il ruolo di Carminati a quello di pensionato del crimine. Piuttosto deve essere considerato un personaggio dalla caratura criminale assoluta, un «intoccabile per aver foraggiato partiti di ogni genere che rende intoccabili quelli che con lui si associano». Nell'ordinanza viene citata un'informativa del Ros in cui Salvatore Buzzi spiegava di aver saputo dallo stesso Carminati del suo coinvolgimento negli affari illeciti in cui era coinvolta Finmeccanica: «Ma lo sai perché Massimo è intoccabile? Perché era lui che portava i soldi per Finmeccanica, bustoni di soldi. A tutti li ha portati Massimo. Non mi dice i nomi perché non me li dice....tutti! Ecco perché ogni tanto adesso...4 milioni dentro le buste...Alla fine mi ha detto Massimo “è sicuro che l'ho portati a tutti! Pure a Rifondazione!”». I pm citano una conversazione tra Carminati e l'ex direttore commerciale di Finmeccanica Paolo Pozzessere, imputato di corruzione per vicende interne alla controllata pubblica, in cui quest'ultimo chiede protezione all'ex Nar: P.:«Chi c'hai te di cose là...per difendermi?» C.:«C'ho il gruppo....so' tosti loro, comunque sono tosti, so' duri insomma, eh. È dura cioè, però capito loro una volta che si liberano del processo una cosa è finita la festa no, che cazzo te ne frega...vuoi mette. A te praticamente l'accusa viene da coso, da Borgogni la tua, l'accusa de Borgogni». Quando sta per cambiare la maggioranza al Comune cominciano le strategie per tessere rapporti con la nuova amministrazione. Carminati dà a Buzzi indicazioni precise: «Mettiti la minigonna, amico mio, e vai a batte co' questi». L'obiettivo è di tessere rapporti con Mirko Coratti, presidente dell'assemblea comunale, e di legare il più possibile a loro il dirigente delle segreteria del nuovo sindaco Marino, Mattia Stella. Dopo la nomina di Giovanni Fiscon a direttore generale dell'Ama, frutto di una pesante attività di lobbying, i pm intercettano una telefonata nel corso della quale il manager informa Buzzi della nomina e questi gli dispensa alcuni consigli tranquillizzandolo nel caso le elezioni comunali le avesse vinte Marino: «Marino viaggia in area Zingaretti, capito? Riusciamo a parlarci, tranquillo». La ricerca di interlocutori nell'amministrazione romana non ha confini nè colori. La mancata vincita di Alemanno, certo, li ha rammaricati («Se vinceva Alemanno ce l'avevamo tutti comprati, c'amo l'assessore ai lavori pubblici, Tredicine doveva sta' assessore ai servizi sociali, Cochi andava al verde, Cochi non è comprato però è un amico, Alemanno che cazzo voi di più»). Ma si sono presto riorganizzati e le trattative corruttive sono andate avanti anche con l'amministrazione successiva. Buzzi riferisce che Franco Figurelli, capo segreteria dell'assemblea, veniva retribuito con mille euro mensili, oltre a 10mila euro pagati per poter incontrare Coratti, mentre a quest'ultimo venivano promessi 150mila euro qualora fosse intervenuto per sbloccare un pagamento di 3 milioni sul sociale. Buzzi intercettato spiega quante ruote vanno unte nel suo lavoro: «Pago tutti, anche due cene con il sindaco, 75mila euro ti sembrano pochi?». Poi prosegue: «La cooperativa campa di politica, perché il lavoro che faccio io lo fanno in tanti, perché lo devo fare io? Finanzio giornali, eventi, faccio pubblicità, pago segretaria, pago cena, pago manifesti, lunedì c'ho una cena da 20mila euro pensa... questo è il momento che paghi di più perché stanno le elezioni comunali...noi spendiamo un sacco di soldi sul Comune». Cercando sponde anche nei media a proposito di un appalto contestato per un centro rifugiati, salta fuori un sms della parlamentare Pd pugliese Micaela Campana in risposta alla richiesta di Buzzi di presentare un'interrogazione. Il messaggio della deputata, annotano gli investigatori, si chiude con un «bacio grande Capo». Buzzi vanta buoni rapporti anche con il vice di Ignazio Marino, Luigi Nieri di Sel. Tanto da caldeggiare direttamente con lui la nomina di un capo dipartimento che «avesse risposto alle loro esigenze». Dopo sms e chiacchiere, Buzzi conclude: «Dacce una mano perché stamo veramente messi male con la Cutini (assessore alle Politiche sociali che aveva voce in capitolo, ndr)». E Nieri lo rassicurava: «Lo so lo so, come no? Assolutamente...va bene? Poi ce vediamo pure...».
Il business dei migranti e l'asse con le cooperative. Primarie inquinate per il Pd di Roma, tangenti a un esponente dem, rapporti profondi con LegaCoop e con tutto il sistema della cooperazione, scrive Gian Maria De Francesco su “Il Giornale”. Primarie inquinate per il Pd di Roma, tangenti a un esponente dem, rapporti profondi con LegaCoop e con tutto il sistema della cooperazione. Non è solo il centrodestra il terreno di coltura dell'organizzazione criminale guidata da Massimo Carminati. Nel corso di una conversazione intercettata nell'ufficio di Salvatore Buzzi il 15 novembre 2013, Claudio Bolla illustra a tre avvocati la storia delle cooperative costituite dallo stesso Buzzi. Qui di seguito il riassunto dei pubblici ministeri: «Negli anni 1999/2000 la cooperativa (29 Giugno Onlus, ndr) entrava in contatto con la Lega Coop dell'area emiliano-romagnola, con la quale iniziò a collaborare nell'ambito delle pulizie industriali. Ciò faceva compiere un primo salto di qualità alla cooperativa stessa, la quale decideva di interessarsi anche della raccolta dei rifiuti e manutenzione del verde. Bolla spiegava quindi che, nel tempo, la cooperativa 29 Giugno era cresciuta sempre di più, tanto che nel 2010 venne deciso di costituire anche la cooperativa 29 Giugno Servizi, attiva ne settore delle pulizie. (...) A tal proposito, Bolla precisava: «...però nasce e c'ha uno scatto di qualità nel momento in cui ci viene affidata l'emergenza Nord Africa, che riusciamo anche con l'apporto della Lega Coop a contendere al gruppo della Cooperativa cattolica: l'Arciconfraternita.. il rapporto con loro, soprattutto dal punto di vista diciamo delle attività è sempre di l a 5, nel campo dell'accoglienza richiedenti asilo, nel campo dell'accoglienza minori...ai Misna, perché abbiamo anche quel settore... però già essere entrati... contemporaneamente riusciamo con Eriches anche nel campo dell'emergenza alloggiativa». Poi precisava: «...Questo 1 a 5 però ci ha consentito di far si che il consorzio Eriches, diciamo da un consorzio poco significativo che a stento raggiungeva il milione di curo fino al 2010... abbia avuto un fatturato significativo, che stiamo intorno ai 16 milioni di euro».
Rapporti anche con Zingaretti. Il 22 gennaio 2013 Salvatore Buzzi parla nel suo studio con Carlo Guarany, referente dell'organizzazione per i rapporti con la pubblica amministrazione. L'associazione a delinquere è preoccupata di un'eventuale vittoria del centrosinistra alle amministrative, ma i rapporti con alcuni esponenti del Pd non sembrano poi cattivi. In particolare, con l'ex capogruppo dem in consiglio comunale e ora deputato Umberto Marroni (candidato alle primarie ma sconfitto da Ignazio Marino), con Mario Ciarla (attuale presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio) e con il governatore laziale Nicola Zingaretti.
Buzzi: è vero, è vero se vince il centro sinistra siamo rovinati, solo se vince Marroni andiamo bene.
Guarany: e chi ci va più dal Sindaco poi..(...)
G: va bene, senti un po' Salvatore, siccome poi oggi pomeriggio devo passare da Marroni per la... siccome mi ridirà di «Ciarla» (fonetico, ndr) ci pensi tu a fissa' con lui?
B: con Ciarla?
G: eh
B: ma si fa una cena, famo un incontro.
G: no, no, ma io pensavo di vederlo io e te, andarlo a trova'... incontrarlo io e te.
B: esatto.
G: si, si, poi magari lo famo venì quando famo la cosa con Zingaretti.
S: esatto..
Tangenti a Patané. Particolare rilievo assume la figura del consigliere regionale Pd, Eugenio Patané. Ecco un'intercettazione del 16 maggio 2014: Particolare rilievo assume la figura del consigliere regionale Pd, Eugenio Patané. Ecco un’intercettazione del 16 maggio 2014: «Buzzi: eh .. se lui riesce .. se Massimo se riesce a piglià quello della destra noi pigliamo (inc) ... sta a loro trovasse co la destra! ... terza cosa .. Patané voleva 120 mila euro a lordo .. allora gli ho detto "scusa ... Caldarelli: de quale? .. parli de? Gauarany: del Multimateriale"».
Altri agganci con il Pd. Nelle conversazioni del sodalizio si accenna a un non megli oprecisato Leonori in riferimento al Pd. Potrebbe trattarsi di Marta Leonori, deputata chiamata da Ignazio Marino nella giunta del Comune di Roma per «liberare» un posto all’inquisito Marco Di Stefano. «Proseguendo nell’analisi degli appalti sui quali focalizzare l’impegno delle proprie risorse, Guarany palesava anche la necessità di trovare un sostegno politico( «madobbiamo sceglie la strada politica pure .. capito .. la strada politica sono 2 ..odentro il Pd.. che sarebbe questa de Leonori.. »). In merito ad una non meglio precisata gara da “60 milioni”,Massimo Carminati ricordava ai presenti che Regione Lazio potevano contare anche sull'appoggio di Luca Gramazio».
Primarie «inquinate». Nell’ottobre 2013 il sodalizio criminale tenta di accreditarsi ulteriormente con il Pd romano sostenendo i principali candidati alla segreteria locale: il senatore Lionello Cosentino, poi vincitore, e Tommaso Giuntella. Nelle intercettazioni compare pure il nome di Daniele Pulcini,l’imprenditore da cui il piddino Marco Di Stefano affittò due immobili a 7 milioni di euro per Lazio service, società della Regione. Il 28 ottobre 2013 «Salvatore Buzzi tentava di effettuare delle chiamate e, non riuscendo a mettersi in contatto, esclamava: “non risponde Daniele!“ (riferendosi a Daniele Pulcini). Alla domanda di Massimo Carminati: “come siete messi per le primarie?“ Buzzi rispondeva: “stiamo a sostene' tutti e due ... avemo dato centoquaranta voti a Giuntella e 80 a Cosentino“, puntualizzando: “Cosentino è proprio amico nostro“.
Spunta anche il ministro Cancellieri. In una conversazione del1 4novembre 2012 tra gli indagati si fa riferimento anche ad una telefonata di Gianni Alemanno all’ex ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri per ottenere risorse pubbliche per Roma. «Quadrana da Alemanno .. . ha chiamato la Cancellieri(Ministro dell’Interno,ndr), mo domani si sente Salvi con questo del Ministero, intanto vediamo un attimo di riuscire a far partire, anche tramite solo una lettera ... che serve a Salvi per sbloccare gli impegni».Gramazio precisava che la lettera da parte del Ministero ad Alemanno,sarebbe stata sufficiente per sbloccare i fondi.
C’è pure Bettini. Il 9 aprile 2014 Buzzi chiamò Carlo Guarany dicendogli che sarebbe andato lui da Coratti (presidente del consiglio comunale di Roma), quindi gli chiedeva di andare da Bettini (Goffredo Bettini, deus ex machina di Ignazio Marino; ndr).
L’affare «verde». In una intercettazione del novembre 2012 Fabrizio Testa afferma: «perfetto ... importantissimo ... D'Ausilio (verosimilmente Francesco D’Ausilio: Capogruppo PD, ndr) chiama Giovanni Quarzo (Consigliere Roma Capitale-Presidente Commissione Trasparenza, ndr) e gli dice “Sul verde Roma stanno (inc) i soldi“ dice “voi chi c’avete“... allora ha detto “io c’cho Buzzi della 29 giugno è il mio referente per tutto il verde di Roma».
"Gli immigrati rendono più della droga". La mafia nera nel business accoglienza. Così i fascio-mafiosi di Massimo Carminati si sarebbero spartiti secondo i Pm i soldi per i richiedenti asilo. Milioni di euro. Senza controlli, grazie alla logica dell'emergenza. E a rapporti privilegiati con le autorità. La parte delle indagini che riguarda il consorzio Eriches e Salvatore Buzzi, scrive Francesca Sironi su “L’Espresso”. Uno sbarco a Brindisi«Rendono più della droga». Per la mafia nera che comandava su Roma gli immigrati erano un business favoloso. Messi da parte gli ideali politici, la banda fascista che rispondeva agli ordini di Massimo Carminati, arrestato questa mattina insieme ad altre 36 persone, aveva trovato nell'accoglienza dei profughi l'occasione per intascare milioni. Il regista dell'operazione è Salvatore Buzzi, anche lui finito in carcere. L'idea di trasformare il sociale in un business gli è venuta negli anni '80 proprio in prigione, mentre scontava una pena per omicidio doloso. Oggi come presidente del consorzio di cooperative Eriches guidava un gruppo capace di chiudere il bilancio 2013 con 53 milioni di euro di fatturato. Gli incassi arrivano da servizi per rifugiati e senza fissa dimora, oltre che da lavori di portineria, manutenzione del verde e gestione dei rifiuti per la Capitale. Un colosso nel terzo settore. Che secondo gli atti delle indagini rispondeva agli interessi strategici del “Nero” di Romanzo Criminale. Buzzi infatti, secondo i pm, sarebbe «un organo apicale della mafia capitale», rappresentante dello «strumento imprenditoriale attraverso cui viene realizzata l'attività economica del sodalizio in rapporto con la pubblica amministrazione». I documenti dell'operazione che ha portato in carcere referenti politici e operativi della mafia fascista svelata da Lirio Abbate su “ l'Espresso ” in numerose inchieste, mostrano nuovi dettagli sull'attività della ramificazione nera di Roma. A partire appunto dall'attività per gli stranieri in fuga da guerra e povertà. «Tu c'hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati?», dice Buzzi al telefono in un'intercettazione: «Non c'ho idea», risponde l'interlocutrice. «Il traffico di droga rende di meno», spiega lui. E in un'altra conversazione aggiunge: «Noi quest’anno abbiamo chiuso con quaranta milioni di fatturato ma tutti i soldi, gli utili li abbiamo fatti sui zingari, sull’emergenza alloggiativa e sugli immigrati, tutti gli altri settori finiscono a zero». "Tu sai quanto ci guadagno sugli immigrati? C'hai idea? Il traffico di droga rende meno", così al telefono Salvatore Buzzi, braccio destro 'imprenditoriale' di Massimo Carminati. Più chiaro di così. Il suo consorzio, Eriches, dentro cui si trova anche la "Cooperativa sociale 29 giugno", nel 2011 riesce ad entrare a pieno titolo nella gestione dell'Emergenza Nord Africa: un fiume di soldi (1 miliardo e 300 milioni) gestiti a livello nazionale dalla Protezione Civile e dalle prefetture per l'accoglienza straordinaria delle persone in fuga dalla guerra in Libia e dalle rivolte della Primavera Araba. È in quel periodo che le cooperative di Buzzi, nate come progetto durante la sua permanenza in carcere negli anni '80, arrivano a fatturare oltre 16 milioni di euro solo con l'accoglienza degli stranieri. Business che continueranno a seguire. Anche che sono proseguiti fino ad oggi con la marea umana di Mare Nostrum. Per ottenere immigrati da ospitare, intascando rimborsi che vanno dai 30 ai 45 euro al giorno a persona, Buzzi s'impone nelle trattative. E può contare, stando alle indagini, su referenti di primo piano. Come Luca Odevaine, presidente di Fondazione IntegrAzione ed ex vice capo di Gabinetto di Walter Veltroni al comune di Roma. In qualità di rappresentanza dell'Upi, l'unione delle province italiane, Odevaine seide al “Tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza”, da cui, spiega in diversi incontri con Buzzi e i suoi colleghi, può «orientare i flussi che arrivano», favorendo le cooperative amiche, perché ricevano più immigrati e quindi più soldi dallo Stato. In un'altra intercettazione sostiene di poter controllare le decisioni del prefetto Rosetta Scotto Lavina «che è in difficoltà, ha troppi sbarchi, non sa dove mettere le persone», e per questo lui può aiutarla indicandole a chi affidare i fondi. Per questa attenzione, spiega Buzzi in una serie di intercettazioni riportate negli atti, Odevaine avrebbe ricevuto dal clan di Carminati uno stipendio da 5mila euro al mese. Ma non era l'unico riferimento politico del consorzio. Anche l'assessore alle politiche sociali Angelo Scozzafava in una telefonata assicura: «su Roma quanti posti c'hai? Perché me sa che sta per arrivà l'ondata...». Per controllare l'accoglienza degli stranieri, Buzzi avrebbe avuto un accordo «al 50/50», ovvero per dividersi a metà tutti gli appalti, con la rete dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e di San Trifone, network di coop cattoliche in cui rientra anche Domus Caritatis, la cooperativa di cui “ l'Espresso ” aveva raccontato le politiche spregiudicate durante l'Emergenza Nord Africa del 2012, quando barboni e adulti furono fatti passare per minorenni pur di ottenere rimborsi duplicati dal ministero (malagestione denunciata da Save The Children e dal Garante per l'Infanzia). Stando agli atti dei Pm, l'accordo per la spartizione del business dei profughi sarebbe stato sancito con Tiziano Zuccolo, rappresentante della rete dell'Arciconfraternita, con cui ancora nel maggio del 2013 Buzzi parlava del “Patto” in riferimento all'arrivo dei siriani scappati dalla guerra. «Va be’, a Salvato’, noi l’accordo, l’accordo è quello al cinquanta, no?», chiedeva Zuccolo, e Buzzi confermava: «Ok, io sto premendo per riceverne altri 140» e Zuccolo ribadiva: «Eh, bravo, l’accordo è al cinquanta per cento, dividiamo da buoni fratelli, ok?» Grazie a queste poltiche la holding dominata da Buzzi, che condivideva tutte le scelte, secondo le indagini, con il boss Carminati, è riuscito a ricevere anche fondi europei. Nel 2011 ad esempio ha avuto dal Fondo Europeo per i Rifugiati ben 234mila e 400 euro, di cui 130 direttamente da Bruxelles e gli altri dallo Stato. Nel 2012 le cooperative che rispondevano alla “mafia capitale” hanno assistito 1320 famiglie per conto del Comune di Roma nell'ambito di un'altra emergenza, quella abitativa. Ma è stato il 2013 l'anno migliore per il consorzio Eriches, come si legge nel bilancio, chiuso con un margine netto di quasi tre milioni di euro. «Nell’ambito dell’accoglienza, siamo cresciuti ed abbiamo continuato la gestione delle attività assistenziali in favore di immigrati, senza fissa dimora, mamme con bambini, ex detenuti, nomadi e famiglie in difficoltà», spiega il presidente, Salvatore Buzzi: «e abbiamo vinto il bando promosso da Roma Capitale per 491 immigrati facenti parte dello SPRAR, una commessa significativa che ci consentirà di stabilizzarci nel settore», con rimborsi garantiti da 35 euro al giorno. E pochi controlli sulla qualità degli aiuti. Nel 2013 Eriches ha vinto anche il bando della prefettura di Roma per il Cara di Castelnuovo di Porto, ovvero il centro per richiedenti asilo di Roma: centinaia di posti, continue proteste per le condizioni indegne di vita. L'appalto da 21 milioni di euro è stato però bloccato dal Tar. E nel bilancio Buzzi si lamenta, evocando il conflitto d'interessi: «nonostante le nostre giustificazioni siano state accettate dalla Prefettura, non siamo riusciti ad iniziare il servizio peralcuni “dubbi” provvedimenti adottati della Terza Sezione Ter del TAR Lazio», scrive: «presieduta da Linda Sandulli, la quale, per inciso, è proprietaria insieme al marito di una ditta edile (PROETI Srl) che effettua manutenzioni proprio all’interno del CARA; un enorme conflitto di interessi». «Siamo fiduciosi che il Consiglio di Stato possa a breve ripristinare legalità e diritto», conclude. Forse con un senso, implicito, dell'ironia.
Minori come schiavi ai Mercati generali. Bambini egiziani ospiti delle case di accoglienza che lavorano oltre 12 ore al giorno per pochi euro, intimidazioni e ricatti alle famiglie che hanno pagato il viaggio della speranza verso l'Italia. È la realtà del Centro Agroalimentare di Guidonia, alle porte di Roma, il più grande del paese e terzo in Europa come volume d'affari. Malgrado gli sforzi di sorveglianza e le inchieste della magistratura continua a essere preso d'assalto da giovanissimi in cerca di un lavoro che si trasforma spesso in un brutale sfruttamento, scrivono Rosita Fattore e Caterina Grignanisu “La Repubblica”.
Caporalato al servizio dei negozi di frutta, scrive Rosita Fattore. Come una prigione il Centro agroalimentare di Roma è circondato da una rete di acciaio alta due metri e mezzo, con sopra 20 centimetri di filo spinato. Tre turni di agenti controllano continuamente l'intera area con cani lupo al guinzaglio, ma non è per non far uscire qualcuno: scoraggiano l'ingresso dei non autorizzati. Ma ogni giorno decine di minori scavalcano le recinzioni e spostano cassette di frutta per 12 ore, guadagnando 20 euro a giornata. Questo prevedeva l'accordo che le loro famiglie hanno sottoscritto in patria, quando li hanno spediti attraverso il mare, a fare fortuna in Italia. Per la legge sono le vittime dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro minorile. Caporalato insomma. Il Centro agroalimentare di Roma, a Guidonia, è il mercato generale più grande d'Italia, il terzo in Europa per volume di affari. Loro, i clandestini che scavalcano, sono ragazzi egiziani fra gli 11 e i 18 anni. "Abbiamo eseguito anche 200 respingimenti al giorno - racconta Flavio Massimo Pallottini, direttore della Car scpa, società proprietaria dei 140 ettari di via Tenuta del Cavaliere - ma non possiamo fare molto se non accompagnare questi ragazzi fuori dal perimetro del Car. È un fenomeno preoccupante e odioso che riguarda le persone di età minore che alloggiano nelle case famiglia che sono pagate dai contribuenti, e che magari il giorno vanno a fare cose di questo tipo". Sono giovani arrivati in Italia senza adulti che li accompagnassero e quindi non possono essere ricondotti nella nazione di provenienza. "La presenza di minori immigrati irregolari a Roma è rilevantissima - osserva il vicecomandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio - Il nostro Nucleo assistenza emarginati (Nae) riceve decine di richieste ogni giorno. I ragazzi arrivano al centro, dicono di essere minori e chiedono assistenza da parte del Comune". L'impressione è che sappiano perfettamente che la legge italiana li tutela e che siano informati perfino degli spostamenti che questo ufficio ha subito negli ultimi tempi, da viale Trastevere e via Goito. "Arrivano al Nae vestiti bene, a volte con dei telefonini - prosegue Di Maggio - È chiaro che dietro a questo fenomeno ci sono sicuramente uno o più gruppi, più o meno strutturati, che gestiscono questa organizzazione". Le indagini sul caporalato diffuso in tutta la Capitale partono dalle frutterie etniche. Il 3 gennaio 2012 proprio Di Maggio diffonde una circolare, in cui chiede a tutti i dirigenti delle unità operative di comunicare al comando centrale "i dati completi delle attività commerciali gestite da persone originarie del Nord Africa". Un documento che trascina Di Maggio nella polemica politica, tacciato da alcuni esponenti del consiglio capitolino di razzismo. In realtà il vicecomandante vuole leggere dentro un fenomeno in cui il comando è inciampato per caso pochi mesi prima. Da alcuni sopralluoghi nei negozi di frutta gestiti da stranieri emerge che in quei locali spesso lavorano, e addirittura vivono, "stranieri che soggiornano illegalmente nel paese". O che da lì si spostano per andare a lavorare altrove. L'intuizione è giusta, bastano pochi mesi e viene a galla lo scandalo del caporalato che dilaga nel Centro agroalimentare di Guidonia. "C'è un fenomeno particolare nell'ortofrutta ed è la crescita di questi negozi gestiti da extracomunitari, in particolare egiziani che hanno creato in questo settore un tessuto e una rete importante - spiega ancora Pallottini che riveste anche la carica di amministratore delegato della Cargest srl, società che gestisce operativamente il centro di Guidonia - ed è egiziana la componente maggiore che riscontriamo tra chi si introduce abusivamente. I minori entrano nel Car in modo illegittimo scavalcando, forzando le recinzioni, nascosti nei camion, risalendo dai campi. Vengono per lavorare e a volte per accaparrarsi gli imballaggi". Gli abusivi nei mercati ci sono sempre stati. Ci sono qui come a Torino, Milano e Napoli o altrove. Ma a Guidonia capita che i ladri di lavoro siano minori, "infra-sedicenni e addirittura bambini", sottolineano i rapporti della Polizia Locale di Roma Capitale che lo scorso 18 dicembre hanno fatto scattare un'operazione nel Car. Quel giorno gli investigatori trovano al lavoro 12 minori e denunciano due operatori del Car. Secondo gli inquirenti, il punto di collegamento tra l'arrivo dei ragazzi in Italia e il loro sfruttamento sarebbero proprio i negozi di ortofrutta gestiti da egiziani che sfruttano vincoli di conoscenza o anche familiari con chi lavora al Car. Sono loro che gestirebbero in modo più o meno diretto la manodopera. Il fenomeno era talmente diffuso che la Cargest ha cercato una soluzione. Qualche mese fa ha riaperto il bando per la movimentazione di merci all'interno del centro. La vecchia azienda che lo faceva non riusciva a garantire efficienza. La Rossi Transworld si è aggiudicata l'appalto e ha iniziato a lavorare a pieno regime. Dopo neanche due settimane, a metà settembre, è scoppiata però una gigantesca rissa proprio tra i banchi dell'ortofrutta. Un gruppo di "abusivi" come sono definiti nei verbali, ragazzi e tutti stranieri, ha aggradito i lavoratori della Transworld. È una vera e propria guerra di territorio. "Il grave episodio di settembre - osserva Pallottini - attesta che il lavoro nero a Guidonia sta trasformandosi in qualcosa di simile ad un racket intimidatorio dedito a violenze e pretese egemoniche di tipo criminale". Un gruppo di facchini abusivi ha aggredito lavoratori regolari di un'azienda che opera al Centro Agroalimentare di Roma. La denuncia arriva dall'amministratore delegato della società di gestione del Car Massimo Pallottini. "Evidentemente hanno sentito crollare le loro ambizioni di controllo sulle attività di carico e scarico nei padiglioni ortofrutticoli, così ieri sera una cinquantina di giovani abusivi stranieri ha fatto irruzione nel Padiglione Ovest del Mercato Ortofrutticolo per aggredire i lavoratori regolari di una azienda logistica privata che, da lunedì, ha assunto in concessione i servizi di trasporto e spostamento di pedane e cassette nel Car". Dopo le indagini e la rissa, oggi la situazione è più o meno calma sia dentro che fuori dal centro. I respingimenti sono una quarantina ogni giorno. Una quiete tra una tempesta e l'altra. La Cargest ha potenziato la sicurezza al punto di investire in sorveglianza 80mila euro al mese. "Va da sé che una struttura come questa - dice ancora Pallottini - non può arrivare a spendere 2 milioni di euro, cioè il doppio di quello che c'è ora in bilancio, solo per tutelarsi da questo fenomeno". Dal canto loro, le forze dell'ordine non hanno personale a sufficienza per presidiare l'accesso e il perimetro del mercato e le cose rischiano di aggravarsi ulteriormente quando i soldi finiranno.
Il procuratore: "Fenomeno indecoroso", scrive Rosita Fattore. "Siamo di fronte a un fenomeno indecoroso per il nostro paese". Con queste parole Luigi De Ficchy, procuratore di Tivoli, descrive quello che ogni giorno avviene al di là dei cancelli dei mercati generali di Roma. Un vero e proprio sistema di facchinaggio abusivo che spesso si avvale della manodopera di minori immigrati irregolarmente.
Procuratore, può dirci cosa sta succedendo?
"Polizia e Carabinieri svolgono controlli giornalieri e da settembre una nuova cooperativa di facchini si è stabilita regolarmente all'interno del Centro agroalimentare di Guidonia. Questo ha tolto un po' di spazio agli irregolari e la situazione sta migliorando, ma nel Car rimane un grande interesse dietro allo sfruttamento del lavoro irregolare di adulti e minori".
Quando parla di sfruttamento fa riferimento al caporalato?
"Posso dirle che pensiamo che c'è una rete di attività che cerca di incanalare queste persone sin dalla partenza dal loro paese. Arrivano qui con l'idea di poter lavorare al Centro agroalimentare, ma al momento non abbiamo elementi sufficienti per andare oltre le ipotesi".
Chi sono i ragazzi che vanno a lavorare a Guidonia, da dove arrivano?
"Quando vengono fermati ovviamente non dicono nulla: non raccontano chi li ha introdotti all'interno del centro né per chi lavorano. Alcuni hanno mostrato dei documenti che dichiaravano che sono nelle case famiglia di Roma e da lì si muovono come possono e vogliono...".
Ma queste strutture non hanno delle responsabilità nei confronti dei minori che ospitano?
"Il loro dovere verso i ragazzi è lo stesso di un genitore o di un tutore. Non c'è obbligo di tenerli all'interno della casa famiglia, o di seguirli una volta fuori".
Quindi vengono lasciati soli?
"Ci sono delle regole riguardo alle attività, ma non è facile sorvegliare questi ragazzi quando escono dalle strutture. Si potrebbe però valutare una sanzione amministrativa, per esempio la revoca delle autorizzazioni per chi non vigila".
E all'interno del Car come funziona la sicurezza?
"E' un centro privato e quindi la vigilanza interna non spetta allo Stato. Certo, ci sono stati dei pattugliamenti sul posto, ma abbiamo enormi problemi di controllo del territorio: un'estensione troppo grande per le risorse che abbiamo. Magari potessimo avere un commissariato solo per gli accessi al Car".
L'avvocato: "Manca una legge ad hoc", scrive Caterina Grignani. Quando arriva un ragazzo che dichiara di essere minorenne, le forze dell'ordine lo portano da un medico che attraverso il rilevamento del polso stabilisce se è al di sopra o al di sotto dei 18 anni. I minori vengono portati nei centri di accoglienza che ne diventano, di fatto, i tutori. Idealmente in queste strutture dovrebbero imparare l'italiano, ricevere informazioni sulla loro condizione legale ed essere avviati a un lavoro che gli consentirà, una volta compiuti i 18 anni, di ottenere il permesso di soggiorno. In realtà questo avviene in poche realtà e la via per sopravvivere si apre fuori dal centro e dalla legalità. L'avvocato Antonello Ciervo, dello studio legale Pernazza-D'Angelo di Roma, è membro dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) che recentemente ha vinto due cause con minori egiziani. Dato che ai minori si applica la legge del paese di provenienza, e in Egitto la maggiore età si raggiunge a 21 anni, questi ragazzi sarebbero potuti restare nel centro di accoglienza altri tre anni.
Quale legge tutela i minori migranti non accompagnati che arrivano in Italia?
"Una legge al momento non esiste. L'Italia ha aderito a diverse convenzioni per tutelare i minori ma una norma specifica non c'è, quindi, in via ordinaria, si applica il Codice civile. Al momento è in discussione alla Camera il progetto di legge Zampa, fortemente voluto da molte associazioni di tutela, in particolare da Save the Chidren. È alla Commissione Affari costituzionali. Non affronta tutti i nodi e soprattutto in generale considera i minori stranieri più stranieri che minori. Così come è stato presentato il progetto di legge sembrerebbe introdurre una normativa speciale per minori all'interno di quella per gli stranieri".
I centri di accoglienza sono tenuti al controllo dei minori durante il giorno? È possibile che i minori possano girare per la città (e di conseguenza lavorare in condizioni di sfruttamento)?
"I centri sono tenuti a controllare gli ospiti all'interno del centro. Ai minori viene affidato come tutore il sindaco del Comune dove il centro si trova. I ragazzi possono uscire, c'è un controllo sugli orari, ma tendenzialmente sono liberi di andare in giro. Se si verificano episodi di lavoro in nero e di sfruttamento e chi gestisce il centro non se ne accorge, questo significa che c'è scarsa diligenza".
Con l'aumento degli arrivi appare evidente che mancano le risorse per affrontare la questione.
"I centri idealmente dovrebbero organizzare un avviamento professionale in modo che i minori una volta diventati maggiorenni abbiano un punto di riferimento lavorativo e quindi maggiori possibilità di ottenere un permesso per lavoro. È vero che i fondi mancano, le strutture sono sempre al limite e si è costretti a ragionare in termini emergenziali. Ma credo che ci sia anche una scelta politica di fondo, basti pensare che praticamente non esistono uffici per l'assistenza legale dei ragazzi".
Dall'Egitto sognando di fare fortuna, scrive Caterina Grignani. "Fashkara" è il nome che in Egitto usano per descrivere chi vive in Italia e a casa ci torna solo per le vacanze. Con vestiti di marca, l'iPhone e soprattutto i racconti. Chi in Egitto ci vive, ascolta e immaginando quella vita migliore inizia a pensare al viaggio. I giovani egiziani sono invidiosi di quelle che in realtà sono favole perché i lavori che gli egiziani svolgono in Italia sono faticosi, malpagati e spesso sconfinano nello sfruttamento. La voglia di lasciare il proprio Paese passa anche attraverso l'osservazione delle famiglie di chi è partito: iniziano a stare meglio, a comprare auto, elettrodomestici e vestiti, a migliorare, con i soldi che gli vengono inviati, la loro condizione. I social network hanno un forte peso: sono racconti ancora più credibili perché corredati di fotografie. Scorrendo i profili si vedono foto di soldi, che magari sono quelli di un affitto in nero da pagare per una casa strapiena, smartphone, lettori mp3 e computer. E poi scarpe e tute come quelle dei calciatori. Sulle bacheche di chi parte ci sono le canzoni dei rapper egiziani ma anche di quelli italiani e le foto dei ragazzi scimmiottano quelle pose da duro, da chi ce l'ha fatta. "Sono venuto qui per prendermi tutto", scrive M. su Facebook. Si alimenta così la visione distorta della vita al di là del mare. Si può migrare regolarmente, ricongiungendosi a un parente già arrivato in Italia. Oppure si migra irregolarmente. Save The Children nel dossier "Percorso migratorio e condizioni di vita dei minori non accompagnati egiziani" frutto del progetto europeo "Providing Alternatives irregular migration for unaccompanied children in Egypt", spiega come la decisione della partenza sia spesso appoggiata e condivisa dalla famiglia. Ma anche nei casi in cui i genitori non approvano, trovare qualcuno che conosca un B'saffar, un intermediario, è facile. Il B'ssafar ha spesso accanto a sé un mandoub, un portavoce. Si tratta di micro organizzazioni composte da circa sei persone che operano nelle città. Il viaggio ha un costo che varia dai 4.000 ai 10.000 euro. Sono cifre alte e se la famiglia non ha il denaro si firma un contratto per un finto acquisto di merce o una cambiale. In questo modo il tribunale potrà far ottenere all'organizzazione il denaro pattuito in caso di mancato pagamento. L'intermediario indica ai minori dove recarsi, solitamente nelle città più grandi. Il viaggio può essere autonomo o organizzato. Prima del 2007 la costa di imbarco era la Libia, ora è più difficile perché per attraversare la frontiera ci vuole un visto che si ottiene solo avendo un lavoro nel paese. Le partenze avvengono quindi sempre più spesso dalle coste egiziane. In attesa del momento giusto per salpare i ragazzi rimangono in capannoni o in case per un periodo variabile tra le due settimane e i due mesi. La maggior parte dei minori egiziani arrivati in Italia ha affrontato il viaggio via mare, sui barconi. Una minoranza ottiene un visto e arriva via aereo. Si tratta di chi proviene da famiglie con più disponibilità economica o con parenti già emigrati che li aiutano una volta arrivati. La partenza via mare avviene da Alessandria, oppure dalle coste tra il Lago di Burullus e Dumyat e dal Porto di Burg Mghizil. Durante il viaggio non si ha alcuna possibilità di ribellarsi o di reagire alla violenza degli scafisti, anche una denuncia in Egitto di queste persone viene percepita dai ragazzi come un atto inutile. Lo sbarco avviene sulle coste della Sicilia, della Calabria e della Puglia. I minori egiziani poi si spostano e le città in cui si registra una presenza maggiore sono Roma, Milano e Torino. Save the Children ha studiato e approfondito il fenomeno, ha redatto rapporti molto precisi. A Roma inoltre è attivo il centro Civico Zero che oltre all'accoglienza e a diverse attività, offre assistenza legale gratuita ai minori. Secondo Viviana Valastro, responsabile protezione minori per Save the Children, è oggettivamente difficile credere che a quell'età i giovani egiziani si autorganizzino per lavorare, sapendo dove andare e a che ora. L'organizzazione ha adottato iniziative formali per portare le autorità a conoscenza del fenomeno e con il Progetto Egitto ha cercato di informare i minori sui rischi, non per disincentivarne la partenza, ma per fa sì che fosse una decisione consapevole, e si è sforzata di creare alternative in loco. Una delle conclusioni è che i ragazzi hanno una bassissima percezione dello sfruttamento anche perché sono abituati a lavori pesanti anche in Egitto, sin da piccoli. E poi perché con il cambio euro lira egiziana gli sembra comunque di guadagnare una bella somma. Il video cartone "The italianaire" è stato un altro degli strumenti utilizzati durante il progetto per sensibilizzare i minori. È stato ideato insieme ai ragazzi stessi. Anche in questo video il gioco serve a spiegare più chiaramente. E le testimonianze dei coetanei vogliono essere il punto di partenza per riflettere sulle reali condizioni che si trovano una volta sbarcati in Italia.
L'economia dello sfruttamento, scrive Vladimiro Polchi. "Lavoro tutti i giorni, dalle dieci alle dodici ore. A fine mese il padrone mi paga solo 400 euro. Da due anni è così. Sono stanco, la schiena mi fa male. Non voglio più vivere da schiavo". Singh è un bracciante dell'agro pontino: un indiano sikh sfruttato a due passi dalla Capitale. Sì, perché il nostro è ancora il Paese degli schiavi invisibili. Terra di caporali, che non si preoccupano neppure dell'età delle loro vittime. È l'Italia dello sfruttamento: mille norme, qualcuna anche buona, pessime prassi. Si parte dalla sciagurata Bossi-Fini, che tiene sotto ricatto i lavoratori stranieri facendoli dipendere dal "padrone" non solo per lo stipendio, ma anche per il permesso di soggiorno. Perdi il posto? Peggio per te: sei a rischio clandestinità. Una pessima legge che sta lì da 12 anni, nonostante i continui propositi di riforma. Il nostro paese però, nel tempo, si è dotato anche di qualche norma più avanzata. Vediamola. Lo stop al caporalato, innanzitutto, è arrivato col decreto legge 138/2011, che ha introdotto nel codice penale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nel mirino soprattutto agricoltura e cantieri. Se c'è prova dello sfruttamento del lavoratore con violenza, minaccia o intimidazione scatta una pena da 5 a 8 anni, oltre alla multa da mille a 2mila euro per ciascun lavoratore coinvolto. Non solo. Nel luglio 2012 si è aggiunta la "legge Rosarno": il decreto legislativo che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi denuncia il datore di lavoro che lo sfrutta. Le nuove norme hanno diversi limiti. Difficile applicarle. Qualcosa comincia comunque a vedersi: dall'introduzione del reato di caporalato sono 355 i caporali arrestati o denunciati, di cui 281 solo nel 2013 (dati Flai-Cgil). Quanto allo specifico caso dei minori stranieri non accompagnati (12.300 quelli sbarcati dall'8 ottobre 2013 a oggi), nel nostro paese nero su bianco non c'è ancora niente. Eppure qualcosa si muove, anche se lentamente: la Commissione Affari costituzionali della Camera a ottobre ha approvato una proposta di legge (prima firmataria la deputata Pd, Sandra Zampa) che promette di rafforzarne la protezione. Vedremo. Intanto lo sfruttamento continua. Stando alla Flai-Cgil, "sono circa 400mila i lavoratori che trovano un impiego tramite i caporali, di cui circa 100mila presentano forme di grave assoggettamento, dovuto a condizioni abitative e ambientali considerate paraschiavistiche". Perché? Forse perché c'è "un'economia dello sfruttamento". È questo il punto: "I lavoratori impiegati dai caporali - prosegue la Flai-Cgil - percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50% a quello previsto dai contratti nazionali". E se sono immigrati le cose vanno anche peggio. A confermarlo è un'indagine curata dall'economista Tito Boeri per la Fondazione Rodolfo Debenedetti: gli immigrati, meglio se irregolari, sono funzionali a molte imprese perché lavorano di più e guadagnano di meno. Molto di meno. Non solo. Anche dove non si sfrutta illegalmente la manodopera, i salari vengono comunque ridotti: "Le aziende agricole di piccola dimensione (entro i 15mila euro di fatturato) - scrive l'ong Crocevia - confrontano la crisi economica generale con durezza, tagliando all'osso la remunerazione del lavoro". Insomma, forse non basta il nuovo reato a colpire le sacche di sfruttamento, ma dovrebbero essere sanzionate anche tutte quelle aziende, grandi e piccole, che si avvalgono dei caporali. Come? Escludendole dai fondi europei, per esempio.
QUANTI GUAI CON LA GIUSTIZIA PER GLI EX AN.
Quanti guai con la giustizia per gli ex An. Così la destra si riunisce (davanti al giudice). Matteoli inquisito per corruzione. Gasparri imputato per peculato. Alemanno a rischio processo per finanziamento illecito. E altri vari ex con problemi giudiziari. Così è scomparsa la diversità morale rivendicata ai tempi del Msi, scrive Paolo Fantauzzi su “L’Espresso”. “L’Italia onesta in piazza con la Destra”, “Tangentocrazia, ti spazzeremo via”. Sabato 17 ottobre 1992 il Movimento sociale italiano sfilava per il centro della capitale in guanti bianchi. Oltre 50 mila neofascisti (definizione rivendicata con orgoglio, anche se ancora per poco) che a 70 anni dalla marcia su Roma manifestavano a sostegno di Mani pulite. Contro i partiti corrotti ma anche per simboleggiare, proprio attraverso quei guanti bianchi, la diversità di un partito non toccato dagli accertamenti della magistratura. Per una serie di coincidenze, unica ma significativa, a poco più di vent’anni di distanza alcuni dei principali protagonisti di quel corteo sono inquisiti contemporaneamente. Col paradosso che la diaspora degli ex An, divisi in quattro partiti, sembra riunita proprio dalle inchieste dei pm. L’ultimo è l’ex ministro Altero Matteoli, all’epoca già parlamentare missino da una decina d’anni e oggi berlusconiano convinto. La Procura di Venezia ha inviato al Senato la richiesta di autorizzazione a procedere nell’ambito dell’inchiesta sul Mose. Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, il reato ipotizzato: Matteoli avrebbe ricevuto complessivamente 550 mila euro in contanti per favorire l’assegnazione al Consorzio Venezia Nuova e alle imprese consorziate i finanziamenti per la bonifica dei siti industriali di Marghera. Nei giorni scorsi la Giunta delle autorizzazioni di Palazzo Madama ha iniziato l’esame della vicenda, che si preannuncia lunga e complessa. Chissà se finirà come nel 2009, quando Montecitorio negò l’autorizzazione nei suoi confronti per un’indagine che lo vedeva accusato di favoreggiamento: aveva informato il prefetto di Livorno di un'inchiesta che lo riguardava. Ma Matteoli è solo l’ultimo dei colonnelli di Alleanza nazionale finiti nel mirino della magistratura negli ultimi mesi. Non se la passa troppo bene nemmeno Maurizio Gasparri, altro ex An rimasto in Forza Italia ( e nel 1992 appena eletto deputato ), dal momento che è sotto processo per peculato: nel 2012, da presidente dei senatori del Pdl, si sarebbe appropriato di 600 mila euro del gruppo per stipulare una polizza vita a lui intestata, indicando i suoi eredi legittimi come beneficiari in caso di morte (la somma è stato poi restituita un anno dopo attraverso due bonifici). Gasparri ha respinto l’addebito, sostenendo di essersi limitato a tutelare il gruppo parlamentare in previsione di una serie di contenziosi ai quali stava andando incontro. Ma il giudice dell’udienza preliminare non ha ritenuto la motivazione convincente, visto che lo scorso aprile lo ha rinviato a giudizio. Chi invece un processo lo rischia a breve è un altro federale di peso della Alleanza nazionale che fu: Gianni Alemanno, oggi in Fratelli d’Italia, accusato di finanziamento illecito. Secondo la Procura di Roma, dietro un falso sondaggio sulla qualità dei servizi scolastici realizzato nel 2010 si sarebbe in realtà nascosta una attività di telemarketing a favore della candidatura di Renata Polverini, nel cui listino era candidata la moglie, Isabella Rauti. Secondo il gip l’allora sindaco sarebbe stato il regista dell’operazione, avendo di fatto commissionato il sondaggio alla società di consulenza Accenture, che poi a sua volta lo avrebbe pagato con 30 mila euro ricavati da false fatture. Luogo dell’incontro, ha sostenuto un manager dell’azienda: lo studio di fisioterapista. I pm un mese e mezzo fa hanno chiesto il rinvio a giudizio ma la decisione del gup non è ancora arrivata. Da un anno si sono invece perse le tracce di un’altra inchiesta che vede l’ex sindaco inquisito, sempre con l’accusa di finanziamento illecito: quella sulle presunte tangenti versate dalla Menarini per la fornitura di 45 filobus. Indagine divenuta involontariamente trasversale alla diaspora di Alleanza nazionale: oltre ad Alemanno fra gli indagati c’era infatti anche Paolo Di Paolantonio, attualmente capogruppo di Nuovo centrodestra alla Regione Lazio e marito della deputata Barbara Saltamartini, anche lei altra ex An di rito alfaniano. “Ma quale immunità parlamentare: il popolo, il popolo deve giudicare” gridavano i giovani missini in quel lontano autunno del ‘92. D’altronde l’abolizione dello scudo giudiziario per gli onorevoli era uno dei cavalli di battaglia del Movimento sociale e dell’Alleanza nazionale dei primi tempi. «Un privilegio medievale che va abolito» tanto per usare la definizione dell’epoca di Gianfranco Fini. E invece, solo per restare a questa legislatura, il sistema dell’autorizzazione a procedere ha già “salvato” un ex An. Si tratta di Francesco Proietti Cosimi, stretto collaboratore di Fini dai tempi del Msi e suo segretario particolare dopo la svolta di Fiuggi. Una fiducia tale da averlo spinto a seguire il leader anche nella disastrosa esperienza di Futuro e libertà. L’anno scorso la Procura di Roma voleva utilizzare dieci conversazioni telefoniche di Proietti Cosimi in un’inchiesta sul crac della Keis srl, in cui era indagato per bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e finanziamento illecito ai partiti. Ma prima la Giunta delle autorizzazioni (presieduta da un altro ex colonnello di An, Ignazio La Russa) e poi l’Aula di Montecitorio hanno detto “no”. Questa la discutibile motivazione: è vero che le intercettazioni erano avvenute fortuitamente sui cellulari della figlia e del nipote, inquisiti prima di lui, ma “ponendo sotto controllo le utenze di suoi strettissimi parenti vi era una certezza quasi assoluta di incorrere in comunicazioni” del deputato. Di fatto una sorta di estensione dell’immunità parlamentare anche ai familiari. L’anno precedente era invece toccato ad Amedeo Laboccetta (altro ex Msi-An rimasto in Forza Italia) essere oggetto di una richiesta di autorizzazione a procedere, per una vicenda divenuta celebre per la sua unicità: la perquisizione a casa del re delle slot machine Francesco Corallo nell’inchiesta sui finanziamenti concessi dalla Bpm (148 milioni nel caso in questione). In quell’occasione Laboccetta sottrasse ai finanzieri un pc portatile sostenendo fosse suo, lasciando i militari stupefatti e impossibilitati a intervenire proprio in virtù dell’immunità parlamentare. Circostanza che valse al deputato un’accusa di favoreggiamento. La Giunta della Camera intimò all’onorevole di restituire il laptop e prima che l’Aula si esprimesse, il deputato lo consegnò ai pm come forma di “rispetto della decisione” e quale segno di “leale collaborazione”. Peccato, si scoprì poi, che il pc era stato nel frattempo manomesso e che alcuni file cancellati risultavano irrecuperabili. Insomma, una casistica dai variegati capi d’imputazione. In ogni caso guai a parlare di “vendetta e accanimento nei confronti di Alleanza nazionale”, come fece nel 2006 Francesco Storace rivolgendosi al pm Henry John Woodcock : per quelle parole il leader de La Destra la scorsa primavera è stato condannato per diffamazione dal tribunale di Roma.
Il 25 settembre del 2010 Gianfranco Fini ha fatto questa promessa a tutti gli italiani: "Se dovesse emergere che l'appartamento di Montecarlo appartiene a Tulliani lascerò la presidenza". E’ stato dimostrato che la casa ex AN è stata venduta a prezzi non di mercato al cognato, ma la promessa del Presidente della Camera e di Futuro e Libertà per l’Italia non è stata mantenuta: per la serie, quando la parola data è un impegno d’onore…..Affari di famiglie secondo Maurizio Caverzan su il Giornale.it. Anzi, di famiglie allargate: mogli, cognati, figli, amici e parenti vari. I tre moschettieri Italo Bocchino, Carmelo Briguglio e Fabio Granata, fedelissimi del presidente della Camera Gianfranco Fini, il D’Artagnan della situazione, grandi moralizzatori della vita politica che hanno combattuto la crociata separatista del Fli «non sembrano immuni dal morbo familistico». Come scrive Panorama nel numero in edicola il 28 gennaio 2011, «negli ultimi anni milioni di euro pubblici sono andati a società amministrate o partecipate da parenti dei tre finiani». In Sicilia ci sono le società che fanno capo alla famiglia Granata e quelle del clan Briguglio. A Napoli invece c’è la ragnatela di Bocchino e consorte. Ricerca e innovazione, corsi di formazione, sport e eventi sono i campi di azione della galassia di Granata. Dal 2001 al 2006 lui è assessore regionale ai Beni culturali e poi al Turismo. Così, tra il 2005 e il 2006, la Lucas Engine di cui è amministratore Luigi Martines, sposato con Sabrina Cortese, sorella di Paola, moglie di Granata, percepisce la bellezza di 423.450 euro per attività di «promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l’innovazione». Interpellato da Panorama Granata dichiara di non aver «mai dato direttamente contributi a mio cognato, al limite lo hanno fatto altri assessorati». Ma la Lucas Engine che privilegia il settore energetico, ottiene casualmente denaro pubblico (24mila euro) anche per un progetto di studio su bizantini, normanni e svevi in Sicilia proprio durante il suo mandato. Quando Granata torna a Siracusa come vicesindaco, il palazzo a cinque piani che ospita la ragioneria comunale acquistato dalla solita Lucas Engine viene affittato allo stesso comune con contratti prima di sei poi di 10 anni, con una procedura che «ricorda alla lontana quella del cognato per eccellenza: Giancarlo Tulliani». Si resta sempre a Siracusa ma si cambia campo d’intervento con i 351mila euro assegnati in dieci anni da Regione, Provincia e Comune al club sportivo Match Ball (nove campi da tennis e due piscine), a cento metri dal Teatro Greco di Siracusa, di proprietà della moglie di Granata. Con la Cuiform i fondi (non ancora definiti) arrivano invece per un progetto sulla formazione. Ma la formazione è il terreno d’azione privilegiato dell’altro campione del futurismo, Carmelo Briguglio, messinese che, insieme a Granata, vara il Cufti (Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale), ente pubblico con le quote distribuite a metà tra l’Azienda del turismo di Taormina (area Briguglio) e quella di Siracusa (Granata). Ma anche qui c’è di mezzo una donna. È Crocifissa Maltese, detta Fina, che ha sposato Briguglio in seconde nozze. È lei il dominus del Consorzio, nel quale, distribuiti nei vari organismi, si trovano amici d’infanzia e cognati vari fino a un totale di cinque parenti dell’inflessibile onorevole. Morale, scrive Panorama «dal 2002 a oggi il Cufti, o l’“Ente Briguglio” come l’hanno malevolmente ribattezzato nel Messinese, ha ricevuto dalla regione quasi 16,6 milioni di euro». Per scavare nell’«impero di carta di Bocchino», invece bisogna spostarsi a Napoli, dove il braccio destro di Fini sfoga la sua «passionaccia per l’editoria». E dove si pubblica il Roma, quotidiano da 4.500 copie che percepisce, attraverso la società di cui è azionista di maggioranza Gabriella Buontempo, mogli di Bocchino, la cifra spropositata di quasi 2,5 milioni di euro l’anno di fondi pubblici. Poi ci sono i finanziamenti ottenuti da L’Indipendente fino a prima della cessione della testata...
Certo è che ci sentiamo garantiti da un Parlamento così.
IL PARLAMENTO DEI PRIVILEGI E DEI POMPINI AI COMMESSI.
"Mi piace andare nei luoghi dove le cose accadono. Mi piace entrare nell’ascensore di Montecitorio dove fu beccato un ex presidente della Camera che praticava sesso orale a un commesso”: parla Vincino, all’anagrafe Vincenzo Gallo, vignettista e architetto intervistato da Giancarlo Dotto per Diva e Donna. Vincino, palermitano di 68 anni, ha appena pubblicato il suo ultimo libro, La cavalcata di Renzi, e nel suo lungo colloquio con Dotto racconta un retroscena inquietante dalle mura del Palazzo: "A Montecitorio un ex presidente della Camera fu beccato mentre praticava sesso orale con un commesso". Vincino non fa il nome dell'ex presidente, ma le sue parole comunque alzano il velo su una realtà tra le mura di Montecitorio che forse non è così nota al pubblico, abituato a guardare in tv solo l'attività parlamentare in Aula. Fuori, tra i corridoi e gli ascensori a quanto pare accade ben altro....intervista di Giancarlo Dotto per Diva & Donna.
Sbuca puntuale da dove sarebbe dovuto sbucare. La porta del “Coming Out”, bar e ritrovo gay dalle parti del Colosseo. Intendiamoci, Vincenzo Gallo, in arte Vincino, palermitano, 68 anni, architetto mancato, disegnatore di giorno e di notte, è gay come io sono un carmelitano scalzo. Zero. Semplicemente, abita là da anni, due portoni prima. Lo riconosci facile tra le centinaia di turisti smaniosi di farsi spennare dallo spacciatore di menù turistici tutto compreso o dal falso gladiatore di turno. E’ un uomo invaso dagli oggetti e lo sguardo sospeso come certi alberi a Natale, dentro una giacca beige e la t-shirt rosa salmone. Più stralunato e architetto di lui ho incrociato solo Marenco, la metafisica marionetta di Arbore. Occhialone in punta di naso, un altro da vista al collo, due i cellulari nella mano destra, tanto per alimentare il caos, bloc notes e penne varie nella sinistra, l’orologio giallo smagliante al polso sinistro. All’ingresso del bar, il cartonato a grandezza naturale di Matteo Renzi stile Fonzie. Non credo sia una dichiarazione di voto. A occhio e croce, una citazione ironica. Matteo Renzi a cavallo è anche in una delle tanti mani di Vincino. Copertina del suo ultimo libro, “La cavalcata di Renzi” (Cairo Editore), sottotitolo: “Come in sei mesi conquistò tutto”, spassosa e attualissima rilettura made Vincino dell’incalzante performance tra Italia ed Europa dell’homus novus. 188 pagine di vignette. La più bella? Tante. A sceglierne una, prendo quella che sta in quarta di copertina. Firenze alle Cascine. Mezzanotte. Il cliente al finestrino alla signora da marciapiedi. “Quanto?”. “80 euro”. Titolo: “Quando nacque il mito degli ottanta euro”. Sul taschino sinistro porta un numero imprecisato di pennarelli a punta fina, direi cinque a occhio.
«Sono anche pochi oggi, ma questo è quello a cui non potrei mai rinunciare...”. Mi mostra con l’occhio che, improvvisamente, da vago si è fatto febbrile, una tratto clip, che sembra comune. Sembra. “Vedi, l’ho modificata con la lametta. La taglio, zic, questo mi permette d’avere un inchiostro più morbido e più fluido per una giornata intera, la trasformo in un pennello».
Questa è tecnologia molto ingegnosa. Usi ancora la carta?
«Sempre. Mi piace la carta. Alterno la liscia con la ruvida. La ruvida mi permette di sentire il rumore quando disegno».
Come hai convinto Cairo a pubblicarti il libro?
«Ci siamo trovati d’accordo su tutto in mezz’ora. Una velocità pazzesca. A fine maggio raccolgo i miei disegni su Renzi. Un mese dopo, ecco il libro».
Definisciti come designatore. Sei uno rapido?
«Dipende. Quando, per quattro mesi, ho fatto l’inviato a Montecitorio per “Lotta Continua”, dovevo essere velocissimo per forza».
Più compulsivo o più ossessivo?
«Dipende dal racconto. A volte mi piace indugiare sui particolari. Nel libro troverete un disegno complesso, lui sull’elefante».
Lui sarebbe Renzi, immagino. Pagina 46, l’entrata trionfale di un marajà in groppa a un elefante.
«Una suggestione presa dalla scena di un film, “Vanity Fair”. C’è il ricco principe con questa giovane donna, un’arrampicatrice che poi diventa una nobildonna, che arrivano in questa città indiana accolti da corone di fiori...e da Fassina. Fassina risulta schiacciato nella lotta impari con questo principe fascinoso sull’elefante».
L’elefante, il principe, la città indiana, Renzi e Fassina. Associazioni libere ai confini del delirio.
«Liberissime. La satira è anche questo, una ricerca della verità che ruba a tutto, a tutte le immagini della Storia. A volte, è la satira stessa a fornire le immagini alla Storia».
Sei un preveggente o comunque un abile analista politico. Nel 2010 hai detto che Renzi avrebbe fatto un sedere così a Berlusconi.
«L’ho conosciuto nel 2009, Renzi, a Firenze. Un mio amico me lo presentò come presidente della provincia e futuro sindaco. Mi sembrò un ragazzino molto determinato. Aveva le idee chiare sulla classe dirigente del suo partito».
Quattro anni dopo è presidente del consiglio.
«Io ho una visione negativa dei politici. La politica attira di per sé i peggiori. È un mestiere terribile, ma in lui ho visto un politico diverso».
Scegli un’immagine per rappresentare a te stesso lo schifo della politica.
«Impossibile. Ce ne sono troppe. Ci lavoro tutti i giorni sulla politica, dal primo scandalo, quarant’anni fa, quello della Lockeed».
Incontri Renzi e capisci...
«Che questo ragazzo guarda il mondo e guarda lontano».
La sua diversità?
«La voglia matta di portare a casa risultati. Io l’ho praticata la politica. Da ragazzi volevamo cambiare il mondo. Anche se poi, pure là, mi consideravo uno di passaggio, quasi un avventuriero. Non era quella la mia vita».
Ti hanno molestato i tuoi amici di “Lotta Continua” quando hai iniziato a collaborare per “Il Foglio” berlusconiano?
«No, mi hanno molestato altri, quelli che credevano fosse un tradimento e non lo era affatto. “Il Foglio” mi ha dato una libertà totale. Giuliano Ferrara è un grande direttore. In tanti anni ho disegnato le peggio cose. Mai un problema. Al “Corriere della Sera”, invece...Mi dicevano: “No, questa su Berlusconi è troppo pesante».
Dicevi dei molestatori...
«Disegni e Caviglia mi fecero una cosa contro. Mi stroncò anche un carissimo amico cui volevo un sacco di bene, Sergio Saviane. Ci siamo subito chiariti. E poi tutta quella sinistra radical chic per cui Ferrara era considerato il male dei mali. Lui e Vittorio Sgarbi, due tra i più intelligenti».
Tornando a Renzi. Ambizioso, loquace e telegenico, ma non solo.
«Inizia e si mette contro tutto l’apparato del suo partito, i dalemiani e i veltroniani. Quello che gli manca a Veltroni, ce l’ha Renzi, inclusa la capacità di sintesi. E, mentre Veltroni fa patti con tutti, lui non fa patti con nessuno. Capisce che non deve farlo. Che è meglio perdere non facendo patti».
Nel momento in cui decidi di fare satira su Renzi, scegli la chiave di Thor, del superman egoico.
«Non scelgo una chiave. Non mi chiudo in un clichè. E’ una cosa che altri hanno fatto. Penso a Craxi con gli stivaloni. Io voglio capire la politica. Il personaggio bloccato non mi aiuta a capire. Ho bisogno di sentirmi fluido, se no mi annoio. Non uso lo stampino».
Resta la prevalenza nei tuoi disegni di un Renzi superdotato.
«È di una velocità pazzesca. Stupisce la sua capacità di correre da una parte all’altra, di fare ventitrè cose in contemporanea. Questo, naturalmente, lo porta ad arronzare un po’...».
Arronzare?
«Vediamo questo governo che prepara tante pietanze e lui si precipita da un fornello all’altro, ma non sempre la cosa gli riesce e così arronza».
Nessuna riserva di fondo sul personaggio?
«Penso che, siccome è un ragazzo di trentanove anni, sia anche un gran disgraziato nel senso umano voglio dire, erotico e tutto il resto. Ha una moglie deliziosa, ma ha anche delle ministre meravigliose, ha una pulsazione continua…».
Gli italiani hanno un debole per il leader carismatico.
«Se un leader non è carismatico, è un disastro. Se non interpreta questo ruolo, se non è qualche passo avanti…».
Il pericolo è lo sconfinamento, l’eccesso di ambizione.
«Il pericolo è quando la sua visione non è più in comunicazione con la nostra. Quando lui non interpreta più ciò che è giusto. Com’è stato con Berlusconi».
La prima volta pubblica di Renzi con la Merkel. Un’immagine forte.
«Lui è già oltre la Merkel. La Merkel rappresenta l’Europa di ieri, Renzi quella di domani. Avremmo bisogno di uno come lui al posto di questo Juncker, un vecchio politico, il peggior guaio che ci potesse capitare... Da come me la sta raccontando, Renzi si prepara ad essere il primo politico europeo tra quattro o cinque anni».
Mi ha colpito D’Alema. Prima lividamente ostile, poi quasi sodale di Renzi.
«Spera, ma non c’è trippa... D’Alema è arrivato al capolinea da parecchi anni, da quando è finito il suo governo. Là ha dimostrato tutto il suo limite».
Veltroni si è dato al cinema.
«Ha fatto un buon film su Berlinguer. Ha una sua grazia. Poteva fare una schifezza agiografica e invece ha avuto un certo garbo. Che, invece, non ha come scrittore. Quando scrive è banale».
Certo, da Togliatti a Renzi, fa impressione.
«Anche là, Palmiro Togliatti era un leader fortemente carismatico. Sai cosa mi piacerebbe fare? Un film comico ed erotico, da crepare dal ridere, ma anche drammatico su Togliatti all’Hotel Lux di Mosca, la sua suite al piano rialzato, con le persone che sparivano, le ammazzavano là intorno. Ci sono stato in quell’hotel».
Ti piace respirare i posti che devi raccontare.
«Mi piace andare nei luoghi dove le cose accadono. Mi piace entrare nell’ascensore di Montecitorio dove fu beccato un ex presidente della Camera che praticava sesso orale a un commesso. Sono andato a Mosca, inviato di “Cuore”, quando succede il golpe e Eltsin sale sul carro armato».
Perché proprio Togliatti?
«Perché su di lui circolano una serie di racconti laterali che mi appassionano. Ma lo sai che portava sull’asola della giacca un cosetto a forma di fallo? C’era un altro dell’epoca che diceva: se il segretario vuole una figa. Noi gli portiamo una figa».
Era uno molto attivo. Ci risiamo con i politici satrapi.
«Molti politici sono molto attivi. O attivi e passivi. E’ naturale, perché te ne stai dieci ore a fare riunioni e devi sfogarti in qualche modo. Poi hai queste compagne giovani... Quelli di sessant’anni sono terribili, li conosco bene».
Il dramma della concupiscenza senile.
«È un disastro immane. Siamo tutti vittime, io per primo. Li capisco. Capisco quello che si mette il casco e corre dall’attrice giovane. Quello che con quattro mogli e sette figli va e parte...».
E come si può far fronte?
«Non si fa fronte. Bisogna cedere agli impulsi. Resistere è la cosa più sciocca, bisogna coltivare i propri vizi. Siamo arrivati a una certa età, siamo dei sopravvissuti, non possiamo diventare monaci. Già siamo tutti così ridicoli...».
Noi cediamo agli impulsi e le persone che ci stanno attorno?
«Io sono liberale anche nei confronti del prossimo. Ho diretto tre o quattro giornali di satira, un direttore di satira non può essere geloso. Sarebbe ridicolo. Come un attore di satira, non puoi mai denunciare nessuno. Puoi incazzarti, ma te lo devi tenere dentro».
Mai stato divorato dalla gelosia?
«Assolutamente sì, ma me la sono tenuta dentro, per quanto si può».
Una moglie, Giovanna, e due figlie, Costanza e Caterina. Ti sei consegnato alle donne.
«Più o meno sì. È una lotta impari. L’ho capito col tempo che la loro vittoria è a priori».
Quanto è comprensiva tua moglie?
«Dipende. Siamo insieme da trentacinque anni, un numero immane. Il nostro è un rapporto solido basato sull’affetto, la complicità e la tolleranza reciproca, con discussioni a volte perenni».
La sparizione politica che più ti ha impressionato?
«Mi colpì la sparizione nel ’90 di partiti che credevamo eterni, come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista o quello Liberale».
Antonio Di Pietro?
«Il Di Pietro politico non ha capito niente. Basta vedere la gente che si è messo al fianco. Uno peggio dell’altro».
Gianfranco Fini?
«Peggio mi sento. Era l’elegante a capo di quel partito di straccioni terribili. Tenta di disarcionare Berlusconi e poi inciampa nel cognato».
Francesco Rutelli?
«Eccone un altro. Ma come cavolo fai? Stai cinque anni nella “Margherita”, sei ancora presidente e non t’informi, non fai una chiamata per sapere quanto hanno speso? Non puoi far finta di non sapere niente».
Qualcuno dice che sia la moglie, Barbara Palombelli, l’eminenza grigia dei due.
«Assolutamente sì, ma da sempre. Quando il marito fu candidato alla presidenza del consiglio, era lei che organizzava tutto. Però, quando uno è incapace, non c’è niente da fare».
Gli dai il colpo di grazia a Enrico Letta con le tue vignette.
«Letta non l’ho mai digerito. E’ più forte di me. Renzi è uno dei pochi ex democristiani che sopporto».
M’aspettavo che ti dedicassi di più a disegnare Beppe Grillo.
«E’ solo nell’ultimo mese che Grillo fa questa grande cazzata di lanciare il guanto di sfida a Renzi. E là si frega completamente. Anche Grillo è un incapace totale. E’ un attore bravo, uno che capisce alcune cose di pancia e di umori, ma poi mette insieme un gruppo di sprovveduti totali e pretende di starsene a Genova tranquillo, senza far niente».
In una vignetta metti insieme Sorrentino e Renzi.
«La stessa basetta, stile Fonzie. Il suo “La grande bellezza” mi ha annoiato, a metà film me ne volevo andare. E’ pieno di luoghi comuni, citazioni ridondanti su una Roma raccontata da un napoletano. Una Roma che non c’è più».
A Renzi superman pronostici un ciclo berlusconiano, venticinque anni al potere.
«Bisogna vedere che succede con il governo, può anche andare a infrociare tra sei mesi. Per ora non ha avversari, questo è anche un suo problema».
C’è il formidabile Alfano.
«Alfano è uno dei più scarsi. Il problema vero di Berlusconi è questa corte di “cosi” che ha cresciuto lui. Lui doveva fare una sola cosa, prendere un radicale, metterlo alla giustizia e fargli fare la riforma. Invece si è trovato un avvocaticchio democristiano che gli ha costruito trecentoventi leggi una peggio dell’altra e gli diceva sempre sì».
Salvo poi voltargli le spalle.
«Inevitabile. Anche Renzi ha un casino di falsi intorno a sé, approfittatori di ogni genere».
Berlusconi è fregato dalla vanità. Renzi sa diffidare”.
«È fiorentino».
Se ne intende di veleni. Un politico particolarmente permaloso?
«Parecchi. Uso su tutti Rutelli. Mi fece una pippa terribile».
Un collega che ammiri.
«Italiani? Ce ne sono diversi cui voglio bene, a cominciare da Vauro. Altri che ammiro molto, ma non sono italiani. Francesi, inglesi, americani e argentini. Tra i nostri giovani dico Alessio Spataro e poi l’unico mio allievo, Dario Campagna di Palermo».
“Il Male” è il giornale più canaglia che hai diretto?
«Sì, anche il più bello. C’era una grande creatività in giro e spesso le idee ce le portavano da fuori, come la finta prima pagina di Ugo Tognazzi capo delle Br».
Pensi sempre di Travaglio che è uno sadico?
«Sì. Anzi, negli anni peggiora».
Meglio o peggio Saviano?
«Quasi quasi è meglio. Il ragazzo è intelligente, ma deve capire che c’è una contraddizione profonda tra fare lo scrittore e il maestro di etica. Ha fatto un errore gravissimo, doveva rimanere libero».
Lui e Fabio Fazio ci spiegano le cose buone e giuste.
«Trovo Fazio superficiale a livelli indescrivibili, le buone maniere di un cameriere insopportabile. Era partito facendo l’imitatore, da là si è costruito un suo mondo perfetto».
Da disegnatore, cosa ti fa soffrire?
«Io generalmente disegno piccolo, ma succede che qualche volta disegno grande e me lo riducono, gli do un affresco e ne fanno un francobollo. In quei casi soffro fisicamente. Ho passato una parte della mia vita a litigare con il “Corriere della Sera” per questo. Ogni tanto succede anche con “Il Foglio».
Che fai in quei casi?
«Mi attacco al telefono e chiamo Giuliano Ferrara, ma solo nei casi più gravi. In generale mi licenzio o entro in sciopero. Mi sono licenziato una decina di volte».
A PROPOSITO DI COMMESSI PARLAMENTARI E DEI LORO STIPENDI.
Lo stipendio dei commessi alla Camera. Uno scandalo (vecchio). Il tetto a 240mila euro stabilito ieri li ha fatti infuriare; ecco la storia di uno degli scandali della politica cominciato 40 anni fa, scrive Sabino Labia su “Panorama”. Gli Uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama, si sono riuniti in contemporanea, e hanno stabilito che il tetto massimo di retribuzione, relativo ai Consiglieri Parlamentari, non superi i 240 mila euro all’anno al netto della contribuzione previdenziale (l’8,8% della retribuzione). Naturalmente, la decisione non è stata presa bene e polemicamente i dipendenti di Montecitorio hanno accolto l'uscita dei componenti dell'ufficio di presidenza della Camera al coro di "Bravi, Bravi, Bis!" e "grazie!". Alla vicepresidente della Camera, Marina Sereni, che ha la delega sul personale, è stato riservato un: "Bel capolavoro, grazie!". La questione delle indennità dei dipendenti di Camera e Senato ha vissuto per anni nel più assoluto anonimato, anche perché agli occhi dell’opinione pubblica quello che più urtava erano gli stipendi dei parlamentari. Tuttavia, anche chi lavora a stretto contatto con la Casta per antonomasia, gode dei suoi piccoli privilegi. Sin dal 1950 le retribuzioni del personale del Parlamento erano adeguate automaticamente al costo della vita attraverso l’utilizzo della Scala Mobile, più correttamente “Indennità di contingenza”. Era l’unico settore a usufruire di questo privilegio insieme a quello dei bancari. Per tutte le altre categorie di lavoratori, l’adeguamento automatico al costo della vita venne inserito, dopo contrattazione, soltanto nel 1975. Nel corso degli anni oltre agli aumenti automatici che facevano lievitare gli stipendi, si registravano anche i doni da parte de benefattori come Amintore Fanfani, che nel 1970 quando ricopriva la carica di presidente del Senato decise di fare un regalo a tutti i dipendenti di Palazzo Madama deliberando un anno d’anzianità valevole a fini pensionistici. Il motivo del dono era per celebrare il centenario di Roma Capitale. Nel 1974 con l’Italia che era costretta ad andare a piedi la domenica e l’inflazione alle stelle, il nuovo presidente del Senato, Giovanni Spagnolli, decise di apporre una piccola modifica per cercare di dare il classico buon esempio e cioè che l’adeguamento al costo della vista fosse ogni sei mesi, invece di due. Tutto qui. Un anno dopo, però, la situazione diventò insostenibile e così scoppiò lo scandalo degli stipendi d’oro dei funzionari del Parlamento. A provocarlo fu il vicepresidente del consiglio Ugo La Malfa, fustigatore dei mali della politica, che attraverso l’organo del suo Partito“La Voce Repubblicana”con un duro editoriale dal titolo“Il Parlamento centro della crisi nazionale”, denunciò senza mezzi termini“le posizioni di assurdo privilegio”di cui godevano i dipendenti di Camera e Senato. Fu tale lo sconcerto da parte dell’opinione pubblica, che il sindacato nazionale autonomo dei dipendenti dell’amministrazione scolastica (Snadas) inviò polemicamente un telegramma a La Malfa chiedendo, per conto di tutti i suoi iscritti, di essere assunto alla Camera dei Deputati. Passarono pochi giorni e, il 13 ottobre, Sandro Pertini, presidente della Camera e, anche lui come La Malfa, politico intransigente, si dimise perché, nonostante avesse tentato di modificare una situazione ereditata da precedenti presidenze, si sentì in dovere di assumersi ogni responsabilità. Qualche anno dopo, in un’intervista al settimanale Epoca, dichiarò:“Io non ne avevo colpa, quella situazione l’avevo semplicemente ereditata. Tuttavia, mi dimisi perché ho sempre pensato che chi sta in un certo posto debba pagare di persona, non trincerandosi dietro alle responsabilità di altri”. Il 16 ottobre 1975 gli uffici di presidenza di Camera e Senato decisero di bloccare la Scala Mobile. L’indennità integrativa speciale di dipendenti e funzionari del Parlamento aveva toccato il 50% in più rispetto agli stipendi base di altre categorie di lavoratori. Per giunta, fino a quella data, ai cittadini italiani, non era dato sapere quanto realmente guadagnassero i dipendenti del Palazzo. Si stabilì allora di realizzare un bollettino dei servizi dove pubblicare le retribuzioni del personale e le relative variazioni. Trascorsero altri cinque anni e, nel 1980, a scatenare la polemica ci pensò Vittorio Gorresio su La Stampa che, a seguito della richiesta della Corte dei Conti di poter controllare le spese del Parlamento, svelò l’esistenza di una commissione interna a Montecitorio che aveva stabilito nuovi aumenti per i vertici dell’amministrazione della Camera: il segretario generale passava da 3mln e 874 mila lire lorde mensili a 5 mln e 25 mila lire; il vice segretario da 3mln e 345 mila lire lorde mensili a 4mln e mezzo lorde. Tutto ciò per 15 mensilità. Più di ministri, sottosegretari, deputati e senatori. La sua conclusione fu, e potrebbe essere presa in prestito anche oggi, vista la situazione del Paese:“Il problema è politico e morale”.
L’ITALIA COME LA CONCORDIA. LA RESPONSABILITA’ DELLA POLITICA.
Da Formigoni a Errani, la caduta dei governatori 2010.
Roberto Formigoni è stato a capo della Regione Lombardia per 18 anni. Si è dimesso dopo aver concordato la dissoluzione della giunta e di un consiglio regionale nel quale la Lega Nord aveva chiesto la sua testa, bersagliata in quel momento dalle inchieste giudiziarie. Avrebbe voluto mantenere un piede a Milano, come commissario generale dell’Expo. Ma ha dovuto mollare anche quello. Eletto in Senato con il Popolo della libertà nel 2013, è passato con Ncd e ora è nella maggioranza che sostiene Matteo Renzi. E’ anche presidente della commissione Agricoltura di Palazzo Madama.
Renata Polverini è rimasta con Berlusconi. Ma come Formigoni è caduta in piedi. L’hanno eletta in Parlamento nel 2013, a dispetto di un passaggio meteorico alla presidenza della Regione Lazio. Nel settembre 2012 la sua giunta cola a picco insieme al consiglio regionale affondato dallo scandalo dei fondi milionari dei gruppi politici consiliari, di cui è stato portabandiera Franco Fiorito, il “batman di Anagni”.
Roberto Cota, ex governatore del Piemonte, se n’è dovuto andare per decisione dei magistrati amministrativi che hanno dato ragione alla sua avversaria Mercedes Bresso circa irregolarità nelle firme per le liste elettorali commesse 3 anni prima.
Vasco Errani. Condannato a un anno per la vicenda Terremerse decide per le dimissioni irrevocabili. Dopo 15 anni ininterrotti alla guida della Regione, e 19 di presenza nella giunta.
Giuseppe Scopelliti, ex presidente della Regione Calabria, condannato a 6 anni di reclusione per falso e abuso d’ufficio. Accompagnato alla porta dalla legge che porta il nome dell’ex ministro di Giustizia Paola Severino, che stabilisce la decadenza degli amministratori condannati.
Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto. Per lui i giudici hanno chiesto l’arresto, ritenendolo una delle pedine chiave dello scandalo Mose. Sicuro di essere rieletto per un quarto mandato, ha dovuto mollare la presidenza della Regione che occupava da 15 anni. Due volte ministro e ora deputato: presidente della commissione Cultura della Camera.
…E PROTESTANO PURE…..
Politici in piazza. A casa mai? Gli imprenditori che aspettano i rimborsi dallo Stato, le partite Iva perseguitate dal fisco, gli esodati, i pensionati: ecco chi avrebbe diritto ad avere udienze non richieste da Napolitano, scrive Alessandro Sallusti su “Il Giornale”. Marciare da parlamentare sulle istituzioni, occupare per protesta i luoghi simbolo dello Stato, diventa improvvisamente lecito. E dire che ancora adesso a Forza Italia si rinfaccia, come un attentato alla Costituzione, il sit in del marzo scorso davanti al Palazzo di giustizia di Milano per protestare contro l'accanimento dei pm nei confronti di Silvio Berlusconi. Senatori grillini, pezzi consistenti della sinistra e leghisti ieri hanno cambiato idea e in corteo hanno raggiunto il Quirinale occupandone il piazzale. Non ci stanno a varare la riforma del Senato, impantanata in aula in un drammatico braccio di ferro: da una parte il governo (sostenuto da Forza Italia) che vuole arrivare al voto per mettere fine alla sciagura del bicameralismo perfetto entro l'8 agosto usando tutti gli strumenti di cui dispone, dall'altra le opposizioni (e pezzi del Pd) che per impedirlo hanno presentato ottomila emendamenti alla legge. Noi restiamo fermi al giudizio espresso all'epoca del sit in anti magistrati politicizzati: ognuno ha il diritto di protestare dove e come meglio crede. Ma oggi siamo anche convinti che chi ieri ha marciato sul Quirinale rappresenta solo la difesa di se stesso. Difende il suo prestigioso posto di lavoro e il relativo lauto compenso, non gli interessi degli italiani. I quali, se il Senato chiudesse domani mattina, non verserebbero una lacrima. Anzi, credo che un applauso si leverebbe dal più profondo del Paese. Se qualcuno ha il diritto di occupare lo spiazzo del Quirinale non sono certo quei privilegiati dei senatori. Gli imprenditori che aspettano i rimborsi dallo Stato, le partite Iva perseguitate dal fisco, gli esodati, i pensionati: ecco chi avrebbe diritto ad avere udienze non richieste da Napolitano. Il futuro e gli stipendi sono temi che non ci appassionano. E il danno che provocano resistenze così violente a una legge di riforma tutto sommato «soft» dimostra una sola cosa: è gente fuori dal tempo. Il Senato è un'istituzione obsoleta, inutile e ora anche dannosa. Prima questa partita si chiude prima si affronteranno, finalmente, le questioni vitali. Se poi Grillo o la sinistra vorranno fare precipitare la situazione, si accomodino. Voglio vederli andare a elezioni anticipate al motto di: «Più Senato per tutti».
Ci avete rotto con questa Costa Concordia! Scrive Fulvio Abbate su “Il Garantista”. E basta! La storia della Costa “Concordia”, nonostante i suoi poveri morti, non riuscirà mai a creare un’epopea, com’è accaduto invece alla sagoma del “Titanic”. Già, iceberg contro scoglio è quasi una metafora, una povera immagine da strapaese. Già, nulla che vada oltre l’immaginario da rotocalco nazionale con tutti gli strilli dei titoli che sappiamo, e con questo ritengo di avere già detto tutto, o comunque molto dello stato delle cose. Basta con la “Concordia”, insomma. Dimenticavo: ancora c’è da mettere in conto la figura dal fulgore rionale di capitan Schettino, cominciando dalla cura che l’uomo metteva nella pettinatura, gel su gel, da vero orgoglioso, fascinoso capitano sul ponte, appunto, di comando, che poi non si rivelò affatto tale. Altrimenti l’unico fermo-fotogramma della nostra vicenda non mostrerebbe l’immagine della nave lì spiaggiata, come ulteriore metafora della balena italiana, come un capitolo significativo dell’autobiografia nazionale. Capitolo chiuso. Basta con la “Concordia”, dai. E poi ecco le parole dell’eroe positivo, l’altro ufficiale, finalmente gentiluomo, che non può mancare in ogni melodramma italico, quel “Torni a bordo, cazzo!” che in pochi giorni, tra nuovi titoli dei giornali e battute da cabaret, da “Bagaglino” redivivo, ha assunto lo stesso peso simbolico del garibaldesco “Nino, domani a Palermo”, e infine i turisti, tutti lì, al Giglio, a fotografare l’intruso, il mostro del mare, l’orca bianca spiaggiata, e ancora tutte le parole spese nella rosea prospettiva di riportare presto il pesce-relitto fuori dallo sguardo per ristabilire la pax turistica, lungamente violata per colpa di quel maledetto “inchino”, capitolo ulteriore del già citato costume da pagliaccio nazionale, salvo poi scoprire che proprio quel relitto era diventato un’attrazione non meno turistica di una basilica di Pompei o di Loreto, una sorta di Torre di Pisa trasfigurata in cadavere di natante, un po’ come l’immagine di King-Kong morto sulla spiaggia di Long Island che il regista Marco Ferreri piazzò in un suo film sul declino del maschio. Maschio italiano o comunque italico, campano, con accompagnatrice esotica, anche Schettino in questa nostra storia accompagnata a sua volta dal fiato sospeso nel tentativo di liberarsi dall’incubo, e dunque ecco arrivare i Pico della Mirandola e gli Archimede in grado di riportare in asse la “Concordia”, e da lì allontanarla verso il suo ultimo viaggio con rotta verso il bacino del disarmo, fra un: “E’ mia!”, e un “No, la voglio io”, e ancora “No, ho detto che è mia”, un po’ come certe liti condominiali tra sfasciacarrozze quando c’è da rottamare, metti, un pezzo meccanico di valore come, che so?, la Porsche 550 Spyder di James Dean, visto che non si sa mai che non possa diventare un cimelio, una reliquia, un ottovolante d’affari. E poi, una volta rimessa dritta, ecco le foto dei saloni risparmiati dalla ruggine, i resti dei bagagli, e allora riecco lo spettro del Titanic con le sue argenterie finite nel fondo del mare, quasi una location perfetta per un reality sulle catastrofi non meno da rotocalco. E basta con la “Concordia”. E i servizi per mostrare che il tempo si è fermato, retorica e ancora retorica asserragliata dietro al pianoforte rimasto intanto, quasi che se arrivasse lì, per puro caso, un Fred Bongusto o perfino un Vinicio Capossela, il pianobar potrebbe ricominciare come se nulla fosse accaduto, e c’è perfino da giurare che lo stesso Schettino lascerebbe la plancia di comando e i fianchi della simpatica Domnica Cemortan, così come il vassoio di ostriche galantemente offerto per senso d’ospitalità, per scendere giù a cantare pure lui perché, come dirà la moglie del eroe negativo in un’intervista a “Oggi”, rotocalco a favore delle alghe dei fondali: “Mio marito non è un mostro”. E allora, anche se così fosse, basta con la “Concordia”. E intanto, mentre la sagoma bianca si allontana dal Giglio, viene voglia di dire davvero che questa storia è insostenibile! Sognando di liberarsi da questo incubo perché, sì, come ha detto proprio Domnica: “Sì, mi ero presa una cotta per il capitano Schettino. Sì, ci siamo baciati. Penso che saremmo finiti a letto, ma poi la nave ha colpito lo scoglio e si è capovolta”. Così parlò la signorina Cemortan, 25 anni, moldava che era a bordo della Costa Concordia la notte del disastro davanti all’isola del Giglio, in un’intervista al domenicale britannico Mail on Sunday. Ora che ci penso, anche Gemma Politi, allo scoccare dei suoi novant’anni, madre del sottoscritto, era il 2010, come testimonia una foto che la vede accanto a un sorridente d’ufficio commissario di bordo, fu ospite della “Concordia”, al momento di rimettere piede a terra però disse soltanto: “Un viaggio da schifo, Fulvio! Ho litigato pure con mio fratello Gino”, e io, prendendola sotto braccio, cercando di liberarla dall’incubo scampato: “E dunque, mamma?” E lei: “Mai più crociere”. Già, mai più “Concordia”, cazzo!
Qual è la vera Italia? L'impresa di Nibali, le lamentele dei commessi alla Camera, il recupero della Concordia la lentezza della politica. Facce della stessa medaglia: il nostro paese, scrive Marco Ventura su “Panorama” Qual è la vera Italia? E' quella di Vincenzo Nibali, la “pulce” diventata “Squalo” che pedala macinando chilometri e dondolando testardo sul sellino fino a trionfare sul Tourmalet al Tour de France? O è quella dei commessi e dipendenti miracolati da decenni di privilegi alla Camera con mega-pensioni e che da semplici centralinisti o documentaristi guadagnano più d’un primario d’ospedale e poi se gli diminuisci lo stipendio fischiano e urlano ai deputati dentro Montecitorio (a dimostrazione che quei soldi non erano meritati, almeno non da tutti)? L’Italia è l’ingegneria italiana, è l’ingegno e l’efficienza degli italiani che hanno rimesso in linea, in “navigazione”, addirittura in anticipo sui tempi, la Costa Concordia dopo che un altro italiano l’aveva portata a schiantarsi sugli scogli, fatta affondare e abbandonata con disonore al suo destino di morte? L’Italia è quella che con abilità si inserisce in una trattativa tra la Sudan e gli Stati Uniti, due Paesi che non dovrebbero neppure guardarsi in faccia per l’embargo che il primo applica al secondo e perché il leader sudanese è sotto accusa all’Aja per crimini contro l’umanità, e tuttavia il nostro viceministro Lapo Pistelli con scatto felin-diplomatico riesce a imbarcare sul volo di Stato tricolore e riportare libera a Roma Meriam, con i piccoli Martin e Maja e il marito somalo-americano, sottraendola alla sorte possibile di 100 frustrate e, peggio, dell’impiccagione nel 2016? L’Italia è quella che persegue il rinnovamento, le riforme, la sobrietà, il merito, mettendo fine a un’ubriacatura di privilegi castali e corporativi, dalla magistratura ai sindacati, dalla politica agli ordini professionali (o almeno ci prova), o è quella che nel pieno del crollo di un sistema si aggrappa miseramente al soldo e mentre i giovani oggi non sanno se avranno mai una pensione decente, anzi sanno perfettamente che mai l’avranno, nelle sembianze di consiglieri regionali lombardi di vari partiti (compresi nomi famosi come la Minetti e il figlio di Bossi) si precipita a chiedere la liquidazione dei contributi già versati, prima che nuove regole insidino il “tesoretto”? Ecco, l’Italia è fatta di slanci generosi e testarda voglia di fare bene il proprio lavoro, ma anche di freni, marce indietro, recidive (im)morali. Forse è sempre stato così. Forse adesso i comportamenti positivi e quelli negativi risaltano di più perché la torta è più piccola e gli squilibri sono più evidenti (e quindi ingiusti). Ma è positivo almeno questo: che sempre di più si diffonda la percezione di un’equità necessaria che consenta all’Italia di rialzare la testa. Anche perché alternativa è una “Concordia nazionale”, nella versione che affonda.
ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO BISIO.
In molti mi hanno scritto chiedendomi il testo del mio monologo effettuato durante il Festival di Sanremo 2013 il 16 Febbraio scorso. Beh, eccolo. Inoltre alcuni di voi, sull'onda del contenuto di quel monologo hanno creato una pagina facebook "Quelli che domenica voteranno con un salmone". Come vedete, l'ho fatto anch'io...
Sono un italiano. Che emozione... E che paura essere su questo palcoscenico... Per me è la prima volta. Bello però. Si sta bene… Il problema ora è che cosa dire. Su questo palco è stato fatto e detto davvero di tutto. E il contrario di tutto. Gorbaciov ha parlato di perestroika, di libertà, di democrazia… Cutugno ha rimpianto l’Unione Sovietica. Gorbaciov ha parlato di pace… e Cutugno ha cantato con l’Armata Rossa… Belen ha fatto vedere la sua farfallina (io potrei farvi vedere il mio biscione, ma non mi sembra un’ottima idea… è un tatuaggio che ho sulla caviglia, dopo tanti anni a Mediaset è il minimo…) Ma soprattutto Benigni, vi ricordate quando è entrato con un cavallo bianco imbracciando il tricolore? Ecco, la rovina per me è stato proprio Benigni. Lo dico con una sana invidia. Benigni ha alzato troppo il livello. La Costituzione, l'Inno di Mameli, la Divina Commedia... Mettetevi nei panni di uno come me. Che è cresciuto leggendo Topolino... Però, se ci pensate bene, anche Topolino, a modo suo, è un classico. Con la sua complessità, il suo spessore psicologico, le sue contraddizioni… Prendete Nonna Papera, che animale è? ... chi ha detto una nonna? Non fate gli spiritosi anche voi, è una papera. Ma è una papera che dà da mangiare alle galline. Tiene le mucche nella stalla... Mentre invece Clarabella, che anche lei è una mucca, non sta nella stalla, sta in una casa con il divano e le tendine. E soprattutto sta con Orazio, che è un cavallo. Poi si lamentano che non hanno figli... Avete presente Orazio, che fa il bipede, l’antropomorfo, però ha il giogo, il morso, il paraocchi. Il paraocchi va bene perché Clarabella è un cesso, ma il morso?!? Ah, forse quando di notte arriva Clarabella con i tacchi a spillo, la guêpiere, la frusta: "Fai il Cavallo! Fai il cavallo!" nelle loro notti sadomaso… una delle cinquanta sfumature di biada. E Qui Quo Qua. Che parlano in coro. Si dividono una frase in tre, tipo: "ehi ragazzi attenti che arriva Paperino/ e/ ci porta tutti a Disneyland", oppure: "ehi ragazzi cosa ne direste di andare tutti/ a/ pescare del pesce che ce lo mangiamo fritto che ci piace tanto..." ecco, già da queste frasi, pur banali se volete, si può evincere come a Quo toccassero sempre le preposizioni semplici, le congiunzioni, a volte solo la virgola: "ehi ragazzi attenti che andando in mezzo al bosco/, / rischiamo di trovare le vipere col veleno che ci fanno del male" inoltre Quo ha sempre avuto un problema di ubicazione, di orientamento... non ha mai saputo dove fosse. Tu chiedi a Qui: "dove sei?" "sono qui!" ... Chiedi a Qua "dove sei?", e lui: "sono qua!" tu prova a chiederlo a Quo. Cosa ti dice? "sono Quo?" Cosa vuol dire? Insomma Quo è sempre stato il più sfigato dei tre, il più insulso: non riusciva né a iniziare né a finire una frase, non era né qui, né qua... Mario Monti. Mari o Monti? Città o campagna? Carne o Pesce? Lo so. So che siamo in piena par condicio e non si può parlare di politica. Ma sento alcuni di voi delusi dirsi: ma come, fra sette giorni ci sono le elezioni. E questo qui ci parla di mucche e galline... Altri che invece penseranno: basta politica! Io non voglio nascondermi dietro a un dito, anche perché non ne ho nessuno abbastanza grosso… decidete voi, volendo posso andare avanti per altri venti minuti a parlare di fumetti, oppure posso dirvi cosa penso io della situazione politica… Ve lo dico? Io penso che finché ci sono LORO, non riusciremo mai a cambiare questo paese. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Non mantengono le promesse. Sono incompetenti, bugiardi, inaffidabili. Credono di avere tutti diritti e nessun dovere. Danno sempre la colpa agli altri… A CASA! Tutti a casa!!! (A parte che quando dici tutti a casa devi stare attento, specificare: a casa di chi? No perché non vorrei che venissero tutti a casa mia) Vedo facce spaventate... soprattutto nelle prime file... Lo so, non devo parlare dei politici, ho firmato fior di contratti, ci sono le penali... Ma chi ha detto che parlo dei politici? Cosa ve l'ha fatto pensare? Ah, quando ho detto incompetenti, bugiardi, inaffidabili? Ma siete davvero maliziosi... No, non parlavo dei politici. Anche perché, scusate, i politici sono in tutto poche centinaia di persone... cosa volete che cambi, anche se davvero se ne tornassero tutti a casa (casa loro, ribadisco)? Poco. No, quando dicevo che devono andare tutti a casa, io non stavo parlando degli eletti. Io stavo parlando degli elettori... stavo parlando di NOI. Degli italiani. Perché, a fare bene i conti, la storia ci inchioda: siamo noi i mandanti. Siamo noi che li abbiamo votati. E se li guardate bene, i politici, ma proprio bene bene bene... è davvero impressionante come ci assomigliano: I politici italiani… sono Italiani! Precisi, sputati. Magari, ecco, con qualche accentuazione caricaturale. Come le maschere della commedia dell'arte, che sono un po' esagerate, rispetto al modello originale. Ma che ricalcano perfettamente il popolo che rappresentano. C'è l'imbroglione affarista, tradito dalla sua ingordigia “Aò, e nnamose a magnà!... A robbin, ‘ndo stai?”; C'è il servitore di due padroni: "orbo da n'orecia, sordo de n'ocio"… qualche volta anche di tre. Certi cambiano casacca con la velocità dei razzi… C'è il riccone arrogante...”Guadagno spendo pago pretendo” C'è la pulzella che cerca di maritarsi a tutti i costi con il riccone, convinta di avere avuto un'idea originale e che ci rimane male quando scopre che sono almeno un centinaio le ragazze che hanno avuto la sua stessa identica idea... C'è il professore dell'università che sa tutto lui e lo spiega agli altri col suo latino/inglese perfetto: "tananai mingheina buscaret!" Cos’ha detto? “Choosy firewall spending review” Ah, ecco, ora finalmente ho capito… C'è quello iracondo, manesco, pronto a menar le mani ad ogni dibattito... “culattoni raccomandati” Insomma, c'è tutto il campionario di quello che NOI siamo, a partire dai nostri difetti, tipo l'INCOERENZA. Come quelli che vanno al family day... ma ci vanno con le loro due famiglie... per forza poi che c'è un sacco di gente.... E se solo li guardi un po' esterrefatto, ti dicono: "Perché mi guardi così? Io sono cattolico, ma a modo mio”. A modo tuo? Guarda, forse non te l'hanno spiegato, ma non si può essere cattolico a modo proprio... Se sei cattolico non basta che Gesù ti sia simpatico, capisci? Non è un tuo amico, Gesù. Se sei cattolico devi credere che Gesù sia il figlio di Dio incarnato nella vergine Maria. Se sei cattolico devi andare in chiesa tutte le domeniche, confessare tutti i tuoi peccati, fare la penitenza. Devi fare anche le novene, digiunare al venerdì... ti abbuono giusto il cilicio e le ginocchia sui ceci. Divorziare: VIETATISSIMO! Hai sposato un farabutto, o una stronza? Capita. Pazienza. Peggio per te. Se divorzi sono casini… E il discorso sulla coerenza non vale solo per i cattolici... Sei fascista? Devi invadere l’Abissinia! Condire tutto con l'olio di ricino, girare con il fez in testa, non devi mai passare da via Matteotti, anche solo per pudore! Devi dire che Mussolini, a parte le leggi razziali, ha fatto anche delle cose buone! Sei comunista? Prima di tutto devi mangiare i bambini, altro che slow food. Poi devi andare a Berlino a tirare su di nuovo il Muro, mattone su mattone! Uguale a prima! Devi guardare solo film della Corea… del nord ovviamente. Devi vestirti con la casacca grigia, tutti uguali come Mao! …mica puoi essere comunista e poi andare a comprarti la felpa da Abercrumbie Sei moderato? Devi esserlo fino in fondo! Né grasso né magro, né alto né basso, né buono né cattivo... Né…Da quando ti alzi la mattina a quando vai a letto la sera devi essere una mediocrissima, inutilissima, noiosissima via di mezzo! Questo per quanto riguarda la coerenza. Ma vogliamo parlare dell'ONESTÀ? Ho visto negozianti che si lamentano del governo ladro e non rilasciano mai lo scontrino, Ho visto fabbriche di scontrini fiscali non fare gli scontrini dicendo che hanno finito la carta, Ho visto ciechi che accompagnano al lavoro la moglie in macchina, Ho visto sordi che protestano coi vicini per la musica troppo alta, Ho visto persone che si lamentano dell’immigrazione e affittano in nero ai gialli… e a volte anche in giallo ai neri!, Ho visto quelli che danno la colpa allo stato. Sempre: se cade un meteorite, se perdono al superenalotto, se la moglie li tradisce, se un piccione gli caga in testa, se scivolano in casa dopo aver messo la cera: cosa fa lo stato? Eh? Cosa fa?... Cosa c’entra lo stato. Metti meno cera, idiota! Lo sapete che nell'inchiesta sulla 'ndrangheta in Lombardia è venuto fuori che c'erano elettori, centinaia di elettori, che vendevano il proprio voto per cinquanta euro? Vendere il voto, in democrazia, è come vendere l'anima. E l'anima si vende a prezzo carissimo, avete presente Faust? Va beh che era tedesco, e i tedeschi la mettono giù sempre durissima, ma lui l'anima l'ha venduta in cambio dell'IMMORTALITA'! Capito? Non cinquanta euro. Se il diavolo gli offriva cinquanta euro, Faust gli cagava in testa. La verità è che ci sono troppi impresentabili, tra gli elettori. Mica poche decine, come tra i candidati… è vero, sembrano molti di più, ma perché sono sempre in televisione a sparar cazzate, la televisione per loro è come il bar per noi... "Ragazzi, offro un altro giro di spritz" "E io offro un milione di posti di lavoro" e giù a ridere. "E io rimborso l'imu!” “e io abolisco l'ici!" “Guarda che non c'è più da un pezzo l'ici" "Allora abolisco l'iva... E anche l'Emy, Evy e Ely!" "E chi sono? "Le nipotine di Paperina! "Ma va là, beviti un altro grappino e tasi mona!..." Vedi, saranno anche impresentabili ma per lo meno li conosci, nome e cognome, e puoi anche prenderli in giro. Invece gli elettori sono protetti dall’anonimato… alle urne vanno milioni di elettori impresentabili, e nessuno sa chi sono! Sapete quale potrebbe essere l’unica soluzione possibile? Sostituire l'elettorato italiano. Al completo. Pensate, per esempio, se incaricassimo di votare al nostro posto l'elettorato danese, o quello norvegese. Lo prendiamo a noleggio. Meglio, lo ospitiamo alla pari... Au pair. Carlo, ma chi è quel signore biondo che dorme a casa tua da due giorni? “Oh, è il mio elettore norvegese alla pari, domenica vota e poi riparte subito... C'è anche la moglie”... E per chi votano, scusa? "Mi ha detto che è indeciso tra Aspelünd Gründblomma e Pysslygar". Ma quelli sono i nomi dell'Ikea!, che tra l’altro è svedese… "Ma no, si assomigliano… però ora che mi ci fai pensare, effettivamente ho visto nel suo depliant elettorale che i simboli dei loro partiti sono un armadio, una lampada, un comodino. Mah. E tu poi, in cambio cosa fai, vai a votare per le loro elezioni? In Norvegia? "Ah, questo non lo so. Non so se mi vogliono. Mi hanno detto che prima devo fare un corso. Imparare a non parcheggiare in doppia fila. A non telefonare parlando ad alta voce in treno. A pagare le tasse fino all'ultimo centesimo. Poi, forse, mi fanno votare." Si, va beh, qualche difficoltà logistica la vedo: organizzare tutti quei pullman, trovare da dormire per tutti... Ma pensate che liberazione, la sera dei risultati, scoprire che il nostro nuovo premier è un signore o una signora dall'aria normalissima, che dice cose normalissime, e che va in televisione al massimo un paio di volte all'anno.
(Lancio di batteria e poi, sull’aria de “L’italiano”)
Lasciatemi votare
con un salmone in mano
vi salverò il paese
io sono un norvegese…
LA CASTA VIEN DA LONTANO.
La casta? Ce la portiamo dietro dai tempi dei Savoia. Un romanzo dell'Ottocento racconta i vizi di Montecitorio, dei deputati del Regno e dei ministeriali e pure di certa stampa. In un scandalo che dura da 150 anni, scrive Luca Sappino su “L’Espresso”. "I misteri di Montecitorio" di Ettore Socci. Prima di Beppe Grillo. Prima di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Prima della Casta. Prima c’era Ettore Socci, garibaldino e parlamentare maremmano. È un filone quello dei romanzi di palazzo. O lo era, almeno, prima che i retroscena giornalistici cominciassero a raccontare i dettagli più succosi del potere. E del filone fa parte I misteri di Montecitorio, opera pressoché inedita, scritta dal deputato del regno Socci alla fine del 1800. Il racconto uscì a puntate sulla rivista La democrazia. Poi le puntate furono raccolte in alcuni volumi. Ora il libro è tornato in libreria grazie a Studio Garamond, Edizioni della sera. Ed è un racconto divertente, e una denuncia di impressionante attualità. Sui costi della politica, sulle ruberie, sull’inconcludenza a cui sono spesso portate le assemblee parlamentari. Siamo sempre lì, è la sensazione che rimane in testa, letta la storia dell’avvocato Guidi, scapestrato ma buono, scansafatiche ma attento agli ultimi, sempre pronto ad attacar briga con i potenti del paese, di quel paese qualunque, a cui Socci non dà un nome, che tanto uno vale l’altro. All’avvocato Guidi, Socci, lo catapulta a Roma come esito di un’inattesa vittoria elettorale. È deputato del regno, il protagonista di fantasia, Guidi, ben prima che lo stesso Socci lo diventi. Tant’è che nella prefazione di una ristampa per ricordare al lettore che la sua ricostruzione si basava sulle cronache del tempo, non essendo lui ancora mai stato deputato, Socci scriveva: «Nemmeno nelle più scapigliate polemiche il giornalista si sarebbe permesso di ritenere possibile, sia pure come ipotesi, la disonorata baraonda, in cui è stata travolta la cosa pubblica». Era solo il febbraio del 1899. Il meglio doveva ancora arrivare. E quella raccontata era, alla fine, ancora «un’assemblea di galantuomini che, senza retribuzione alcuna, offre l’opera sua per provvedere» al Paese, «come meglio può». Tra molte avventure, anche sentimentali, nella Roma dei palazzi, Guidi scopre però che «l’uomo politico è uno schiavo bianco» e che «il primo idiota si permette di dargli consigli; il primo bottegaio ingrassato ha il diritto di comandarlo a bacchetta», perché così si accontenta il proprio collegio. Così si fanno trattare molti deputati, di ogni orientamento, spesso amici, perché nel Transatlantico di Montecitorio non si perde occasione di fare comunella: «Il deputato ministeriale di tre cotte dice roba da chiodi dei ministri che sostiene col voto; l’oppositore gabella i suoi capi per mistificatori: uno mette in burletta gli elettori; l’altro fa le matte risate sui grandi principi; destri e sinistri ridono e scherzano insieme alle spalle del povero diavolo che ha preso sul serio il mandato ricevuto». I capanelli bipartisan, insomma, sono sempre esistiti: «non è tanto raro il caso che invece che parlare di politica in quel crocchio si parla, con linguaggio scollacciato e con espressioni pornografiche, dell’ultima mina che ha agito all’Argentina, o della bellezza, più o meno serotina, venuta giù da Parigi». A Montecitorio, scopre Guidi, quando non si è impegnati a ottener marchette per i propri collegi, «spesso e volentieri si sta come scolari in vacanza», spesso con la complicità della libera stampa. Che si avventa subito sul nuovo arrivato, Guidi. Come Asdrubale Mattiroli, corrispondente di una rivista milanese, che «era un giornalista alla moda, e vantavasi del suo americanismo». Nulla da invidiare ad alcuni eredi contemporanei, il Mattiroli: «Non aveva né ritegni, né scrupoli: si piantava accanto a un gruppo di deputati influenti per carpir loro una dichiarazione, una frase, e ammanirla poi ai lettori inghirlandata da tutti i fronzoli della sua fantasia, e quando non poteva giungere a carpire una sillaba, inventava di sana pianta». C’erano anche già i Responsabili, poi, i Razzi e gli Scilipoti. «Si chiamano gli extra-vaganti e costituiscono una vera schiera di soldati di ventura. La loro proclamata indipendenza è il più bel sistema per sgranare ogni giorno qualche cosellina». Tra loro Guidi conosce il collega deputato Civetti, «uno dei tanti che, col pretesto di esser più innanzi di tutti gli altri», non si iscrive in nessun gruppo. «Legione pratica: merce sempre all’incanto per il miglior offerente, stoppa adattissima per imbottire tutte le poltrone ministeriali». Ora chissà se il secolo trascorso, e le indennità, e gli scandali, avrebbero scalfito l’orgoglio repubblicano di Socci che, severissimo e indignato, nello scrivere l’ironico libro, non ha però ceduto all’antipolitica, né all’antiparlamentarismo: «si dice roba da chiodi contro la Camera dei deputati e la si accusa come l’autrice principale delle disgrazie che tormentano l’Italia». «Nulla di più inesatto» mette nero su bianco, punto e a capo. «Il parlamentarismo è una fase morbosa del sistema rappresentativo», sì, ma «il sistema rappresentativo è l’egida dei popoli liberi, è il controllore dei governi, è la possibilità per tutti di denunziare un arbitrio, di svelare uno scandalo, d’invocare un provvedimento». Insomma. Socci si lancia in dichiarazioni di incredibile attualità: «se pochi malfattori, approfittandosi del loro mandato, hanno tentato lauti guadagni, non è detto che non vi siano caratteri adamantini, coscienze serene, menti che pensano e cuori che palpitano per l’avvenire e per la grandezza della patria».
ITALIA. NAZIONE DI LADRI E DI IMBROGLIONI.
Italia. Quello che manca è la credibilità nelle istituzioni. Come dire….il pesce inizia a puzzare dalla testa.
"Falcone e Borsellino erano due persone diverse: l'uno, Giovanni, aveva un carattere introverso, quasi schivo, Paolo, invece aveva un carattere goliardico, era estroverso. Si scambiavano continuamente battute. Borsellino diceva a Falcone: 'Finché sei vivo tu io sono tranquillo, perché se devono fare qualcosa ad uno di noi prima lo faranno a tè'. Era uno scambio continuo di battute e scherzi". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, partecipando ad un incontro-dibattito all'Assemblea regionale siciliana per celebrare la "Giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie". "Entrambi avevano, però, una caratteristica professionale comune - ha aggiunto -: erano dei fuoriclasse, eccellevano e questo creava invidie dei colleghi. Dopo il maxi processo iniziarono a vivere un attacco continuo. Attacchi dal Csm e dalle istituzioni, vennero le accuse di insabbiare le carte, mettendo in difficoltà il loro lavoro".
Già. Il CSM. "Apprestandosi a chiudere la scandalosa vicenda degli abusi e delle irregolarità emerse in alcune delicate inchieste della Procura di Milano, senza neanche un 'Pater, Ave e Gloria' di penitenza, il Csm dimostra di essersi definitivamente trasformato da organo di autogoverno dei giudici a organo di autoinsabbiamento di ogni malefatta, specie se riguardante magistrati molto in vista e ritenuti intoccabili". E' quanto afferma Luca d'Alessandro (Fi), segretario della commissione Giustizia della Camera.
VELENI IN PROCURA E MALI DI CORRENTE, scrive Bruno Tinti (magistrato) su “Il Fatto Quotidiano”. La Procura di Milano è sconvolta dalla denuncia di un Aggiunto, Robledo, contro il suo capo, Bruti Liberati: non mi voleva affidare i reati contro la Pubblica amministrazione, mi ha blandito, minacciato, emarginato, violato le procedure di assegnazione. È vero? Il Csm traccheggia, difende Bruti, impedisce un’approfondita istruttoria. Lo dice un suo componente, Racanelli. È vero? Lo stesso Racanelli, nel corso di un plenum cui partecipa il ministro della Giustizia, chiede che questi proceda a un’ispezione; e spiega che è stato costretto a farlo perché il Csm voleva insabbiare tutto. Ha fatto bene?
1) È nota la frase di Bruti: “Ricordati che sei stato nominato aggiunto per un solo voto, di Magistratura democratica. Avrei potuto dire a uno dei miei al Csm che Robledo mi rompeva i coglioni e di andare a fare la pipì, così sarebbe stata nominata la Gatto che poi avremmo sbattuto all’esecuzione”. Bruti non ha negato di aver detto queste parole. Il corriere.it del 14/3 riferisce che – al Csm che gliene chiedeva conto – avrebbe sorriso e sostenuto che si trattava di humour inglese. Supponendo che la frase sia stata effettivamente pronunciata, le conclusioni sono obbligate. Bruti ritiene normale che le decisioni del Csm dipendano dagli schieramenti correntizi. Bruti ritiene normale che, nei contrasti interni all’ufficio, non si debba ricorrere al Csm, ma ricordare a chi gli si oppone il suo ruolo di correntocrate (in grado – evidentemente – di condizionarne la carriera). Bruti ritiene normale ghettizzare i magistrati a lui sgraditi “sbattendoli” in uffici valutati di secondo piano (Nunzia Gatto, poi divenuta Aggiunto, si occupa effettivamente di esecuzione). Ora, è vero che l’ultima versione dell’ordinamento giudiziario (legge Castelli–Mastella, due nomi, una garanzia), ha rafforzato molto i poteri del Procuratore capo; ed è vero che Bruti avrebbe potuto destinare al dipartimento che gli fosse sembrato opportuno Robledo (e Gatto). Ma ciò con un provvedimento motivato, passibile di ricorso al Csm. Minacce e ritorsioni non fanno parte delle prerogative di un magistrato.
2) Le mancate assegnazioni di importanti indagini a Robledo si prestano a considerazioni meno perentorie. L’indagine Expo, affidata a Boccassini. Vero che i reati per cui si procede sono quelli contro la Pa (corruzione). Ma sono anche vere altre circostanze. La prima informativa giunta alla Procura di Milano segnalava un’associazione a delinquere di stampo mafioso funzionale a commettere corruzioni. Competenza della Dda, Boccassini. E però il Gip non ha ritenuto sufficienti le prove con riferimento a questo reato. Il fascicolo doveva essere trasferito a Robledo? Parrebbe di no: sia perché le indagini sul 416 bis proseguono; sia perché, quando un magistrato comincia un procedimento, la cosa peggiore che si può fare è toglierglielo e affidarlo a un altro; giorni e giorni di lavoro buttato. E poi Bruti ha inserito, nel pool che si occupa dell’indagine Expo, un Sostituto appartenente al dipartimento di Robledo, D’Alessio. Il Ruby bis, le false testimonianze a favore di Berlusconi. Vero, la falsa testimonianza è un reato contro la Pa. Ma è prassi costante in ogni Procura che di questo tipo di indagini si occupino i Pm che hanno trattato il procedimento principale. Per una ragione di efficienza: conoscono bene gli atti, sanno già quali prove dimostrano la falsa testimonianza, non ha senso che qualcun altro ricominci tutto da capo. E il processo Ruby era stato trattato da Boccassini. Ma non doveva esserlo, dice Robledo: l’accusa più grave era quella di concussione, di competenza del dipartimento della Pa. Ma, anche in questo caso, l’indagine era cominciata per tutt’altro: la telefonata di Berlusconi al questore e tutto quello che ne seguì avvennero a procedimento iniziato da tempo. Sarebbe stato dissennato sostituire i Pm a indagine praticamente conclusa. Però il veto all’iscrizione di Podestà, che ordina di raccogliere firme false per le liste Pdl alle regionali 2010, perché potrebbe creare problemi al Pdl, se vero, è inaccettabile. Se vero… Robledo dice che, dopo l’iscrizione (cui egli aveva proceduto contravvenendo all’ordine del capo) Bruti gli avrebbe detto “allora non ci siamo capiti”. Sta di fatto che, in una lettera successiva, Bruti evidenzia il suo disappunto: “Hai proceduto a stretto giro (come prevede la legge ndr), senza adottare la cautela dell’iscrizione con nome di fantasia, che ti avevo indicato come opportuna”. E Robledo nega di aver ricevuto tale suggerimento. E, quanto alla mancata iscrizione e assegnazione del processo ESA-Gamberale per turbativa d’asta, Bruti l’ammette: “Me ne sono dimenticato”. Da procedimento disciplinare: è rimasta nel cassetto per più di 3 mesi. Per molto meno (ritardi nel deposito delle sentenze e mancate iscrizioni per fatti da quattro soldi) decine di magistrati sono stati condannati. Insomma luci e ombre. Il Csm dovrebbe accertare le une e le altre; è quello che dice l’art. 105 della Costituzione.
3) Ma Racanelli dice che non lo fa. Riferisce di volontà “politica” di insabbiare tutto; di rigetto di richieste di audizione dei magistrati che possono fornire informazioni sulla vicenda; di nuovo e sconcertante strumento di accertamento dei fatti: un contraddittorio cartaceo a distanza. E se qualcuno volesse fare qualche domanda? È per questo che si rivolge al ministro.
4) Ha fatto malissimo, tuonano le correnti. Il Csm è organo sovrano, indipendente dalla politica. Vero. Solo che questi stessi correntizzati e correntocrati, tutti uniti, invocarono e approvarono le ispezioni ministeriali a De Magistris e alla Procura di Salerno. L’indignazione a corrente alternata è poco credibile. E comunque, se è vero che al Csm c’è la “volontà politica” di insabbiare, che altro resta?
Come si dice, il difetto sta nel manico. Bisogna mandare al Csm gente che non abbia nulla a che fare con le correnti. Quello che si sta tentando adesso, con il sorteggio. A tacer d’altro, senza le correnti, Bruti forse nemmeno ci sarebbe arrivato alla Procura di Milano.
Se davvero la «guerra alla Procura di Milano» finisce in nulla. Quello che avevamo creduto di capire nello scontro tra Alfredo Robledo ed Edmondo Bruti Liberati. E che ora il Csm, invece, nega sia mai esistito, scrive Maurizio Tortorella su “Panorama”. Scusateci, avevamo sbagliato. Alla Procura di Milano, dalla metà di aprile a oggi, avevamo capito fosse scoppiata una guerra senza esclusione di colpi. Non era così. Avevamo creduto di capire che l'alto magistrato Alfredo Robledo, nientemeno che un procuratore aggiunto (in ordine gerarchico, il numero 2 dell'ufficio), senza infingimenti e senza giri di parole, accusava davanti al Consiglio superiore della magistratura il suo capo, Edmondo Bruti Liberati, nell'ordine:
1) di avere attribuito illegittimamente ad altri magistrati una serie d'importanti inchieste, tutte «politicamente rilevanti», per il solo motivo che il medesimo capo della Procura, uomo dai lunghi trascorsi nel sindacalismo di categoria e per questo particolarmente abile nella gestione delle correnti giudiziarie e del potere nel suo senso più lato, riteneva in qualche modo più «affidabili» i destinatari delle indagini;
2) di avere indebitamente e gravemente rallentato l'avvio di due o tre inchieste, tutte «politicamente rilevanti», sostenendo in aperti dialoghi che in certi casi fosse meglio non intervenire in certe faccende per motivi di opportunità economica, finanziaria, politica...
3) di avere rimproverato Robledo, anche per questo autore della denuncia, di «scarsa collaborazione», e di avergli per questo rinfacciato che se era in quell'incarico lo doveva esclusivamente alla sua corrente di appartenenza, Magistratura democratica. In particolare, Robledo aveva denunciato, mettendolo nero su bianco, che Bruti gli aveva detto queste sconvolgenti parole: «Ricordati che al plenum (del Csm, ndr) sei stato nominato aggiunto per un solo voto di scarto, e che questo è un voto di Magistratura democratica. Avrei potuto dire a uno dei miei colleghi al Csm che tu mi rompevi i coglioni e di andare a fare la pipì al momento del voto, così sarebbe stata scelta la Gatto, che poi avremmo sbattuto alle esecuzioni” (Nunzia Gatto, poi nominata procuratore aggiunto a Milano, è effettivamente andata a occuparsi del trattamento dei condannati, ndr)».
4) di avere tenuto per sé (e poi chiuso in una cassaforte per almeno tre mesi) un fascicolo proveniente dalla Procura di Firenze, contenente elementi che ipotizzavano una turbativa d'asta su una delicata cessione d'azienda da parte del Comune di Milano.
A sua volta, il procuratore rispondeva al Csm con una serie di accuse: Bruti sosteneva che il suo aggiunto gli aveva sottaciuto di avere personalmente querelato due degli indagati sui quali chiedeva la titolarità delle inchieste aperte dalla procura. Lo accusava anche di avere disposto un doppio pedinamento di un altro indagato e di avere «intralciato le indagini». Questo, avevamo capito. Invece no, lo ripeto: ci siamo sbagliati. È stato tutto un equivoco, spiacevole ancorché collettivo. Perché se tutto questo fosse stato vero, come finora pareva, di certo il Csm (come sembra) non si appresterebbe a chiudere la feroce disputa fra Bruti e Robledo con una serena archiviazione. È impossibile, non starebbe né in cielo né in terra che l'organo di autogoverno della magistratura, istituto di rilevanza costituzionale, non disponga nemmeno una censura, un trasferimento per incompatibilità ambientale. Non starebbe né in cielo né in terra: perché è evidente. Ma certo, è impossibile, ci siamo sbagliati. Perché la giustizia italiana è una cosa seria. Perché lo Stato di diritto è uno dei pilastri del nostro ordinamento democratico. Perché l'obbligatorietà dell'azione penale è un principio incontrovertibile, un caposaldo della giurisdizione. Perché il Consiglio superiore della magistratura è fatto esclusivamente di persone intellettualmente oneste, che rispondono alla legge e non alle spinte delle correnti. Perché il Csm è il baluardo dell'indipendenza dei magistrati e del loro corretto operare, non è un ente dove si patteggiano soluzioni, si insabbiano questioni, si coprono scandali. Perché a volte gli asini volano, e noi ancora ci crediamo.
Per il CSM nessuno ha ragione, ma noi sappiamo che hanno tutti torto. Se andiamo più nel dettaglio è indiscutibile affermare che un trasferimento d’ufficio contro il Procuratore Capo non sarebbe mai stato preso veramente in considerazione..., scrive Massimo Melani su “Totalità”. In molti, giorni fa, avevamo immaginato che Edmondo Bruti Liberati e Alfredo Robledo, il primo capo della Procura di Milano e il secondo suo vice del pool antitangenti, occupati in una battaglia a campo aperto e ambedue sostenuti dai rispettivi alleati e sostenitori, non sarebbero mai stati richiamati all’ordine o trasferiti in altre sedi, ma ahiloro, dovranno sopportarsi ancora quattro anni. Il CSM, com'è solito fare quando di mezzo ci sono alcuni suoi protetti, tende ad insabbiare tutto ciò che può arrecare danno al proprio enorme strapotere e anche stavolta, coerentemente, ha deciso di archiviare il caso. Né il capo della procura, né Robledo, verranno sbattuti fuori dalla sede milanese. Entrambi resteranno al loro posto, con tutta la loro serenità per niente ammaccata da un esilio meritato, così da poter continuare reciprocamente a darsi, questa volta lontani da telecamere e taccuini, del bugiardo. Ambrose Bierce, scrittore statunitense, nel suo libro Il Diario del Diavolo, ebbe a scrivere: “Giustizia. Un articolo che lo stato vende, in condizioni più o meno adulterate, al cittadino, in ricompensa della sua fedeltà, delle tasse e dei servizi resi.” Nient’altro che un articolo, un prodotto di scambio che lo Stato italiano fa amministrare autonomamente da persone illecitamente parziali e dove, anche in quest’ultima situazione, non viene a mancare la paradossale, bizzarra, grottesca leggerezza di chi comanda il sistema giudiziario: nei prossimi mesi, non sto scherzando, sarà proprio Bruti Liberati a dover redigere, come procuratore capo, la scheda di valutazione di Robledo, per stabilire se sia in grado di rimanere al suo posto. E la stessa scheda dovrà compilarla anche per la Boccassini e Greco, i procuratori aggiunti che per Robledo erano stati aiutati in maniera sfacciata da Liberati in questi ultimi anni, e che sono sempre stati pedissequamente al suo fianco in ogni battaglia, in primis contro Silvio Berlusconi. Se andiamo più nel dettaglio è indiscutibile affermare che un trasferimento d’ufficio contro il Procuratore Capo non sarebbe mai stato preso veramente in considerazione, vuoi per l’affronto che sarebbe stato fatto al numeroso gruppo di persone importanti che quattro anni addietro lo vollero fortissimamente come capo, unitamente al Presidente della Repubblica; vuoi per la netta presa di posizione di Magistratura Democratica che, immantinente, ha isolato Robledo, colpevole di aver leso l’onore del grande capo. Facile, dunque, la scelta “pilatesca” del CSM che ha deciso di lavarsene le mani lasciando tutto com’era, senza infierire su nessuno, scimmiottando un tipico comportamento democristiano; cioè quello di non parteggiare né per l’una né per l’altra parte. In tutto questo, però, ne esce vincitore solo Robledo, che né il nemico Bruti Liberati né MD sono riusciti a scalzare dal suo posto, tentando di passarlo per le armi per disobbedienza alla causa o addirittura per interazione intellettiva col nemico. Provate adesso a ragionare un po’ sulla cosa e arriverete a capire ciò che può essere successo, o ciò che può sapere Robledo di tanto compromettente se, sia il massimo potere giudiziario, il CSM, sia il suo appoggio naturale, il sindacato di MD, si sono dovuti accontentare di un moscio e insignificante niente di fatto? L’importante è insabbiare i veleni venuti tragicamente a galla e, in questo, c’è serenamente da ammetterlo, quelli del CSM sono dei veri maestri.
Ma in Procura continua la faida tra correnti. La scelta di salvare entrambi i litiganti è scontata, però il clima rimane irrespirabile, scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. Milano I vecchi conoscitori dei riti eterni della magistratura italiana lo avevano previsto da tempo: «Non succederà niente e quei due dovranno rassegnarsi a convivere per altri quattro anni». Laddove quei due erano Edmondo Bruti Liberati e Alfredo Robledo, il capo della Procura milanese e il suo vice del pool antitangenti, impegnati in uno scontro senza quartiere, e spalleggiati entrambi da alleati e supporter. La profezia si avvera ieri, con la Prima commissione del Consiglio superiore della magistratura che insabbia tutto quanto. Non viene cacciato Bruti ma neanche Robledo (che a dire il vero non era mai stato formalmente sotto procedimento, anche se mediaticamente si è cercato di farlo passare per tale). Restano entrambi al loro posto, con la serenità d'animo e di rapporti reciproci che si possono immaginare tra due magistrati in là con gli anni, arrivati a darsi pubblicamente e vicendevolmente del bugiardo. E con un dettaglio oltretutto quasi grottesco: nei prossimi mesi sarà Bruti a dover stendere, come capo dell'ufficio, il pagellino di Robledo, per valutare se sia in grado di restare al suo posto. E la stessa pagellina Bruti dovrà stenderla anche per Francesco Greco e Ilda Boccassini, i procuratori aggiunti che Robledo lo accusava di avere favorito in questi anni, e che più sono stati al suo fianco in questa battaglia. Che il Csm potesse trasferirlo per «incompatibilità ambientale», Bruti Liberati lo aveva escluso già nei giorni scorsi: «Se al Consiglio non piace il mio modo di fare il procuratore dovrebbe rimuovermi dalla magistratura, perché io farei dovunque il mio lavoro come lo faccio a Milano», aveva confidato a chi lo conosce da tempo. D'altronde una rimozione d'ufficio di Bruti sarebbe suonata come uno schiaffo al vasto fronte che quattro anni fa lo scelse come procuratore, con l'autorevole benedizione del Quirinale. A temere di più per la propria sorte era in queste settimane Alfredo Robledo, che si era trovato quasi isolato all'interno del sindacalismo di categoria: solo la destra di Magistratura Indipendente si era schierata con lui, e c'era persino chi chiedeva la sua testa per il reato di «lesa maestà» nei confronti della Procura milanese. Invece, almeno per ora, lo «zero a zero» sancito dal Csm salva capra e cavoli. Decisivo, perché finisse senza spargimenti di sangue, è stato il documento che due veterani della Procura milanese, Ferdinando Pomarici e Armando Spataro, hanno fatto circolare nei giorni scorsi, raccogliendo la grande maggioranza delle firme dei pm: un documento vagamente democristiano, che non si schierava né con l'uno né con l'altro dei contendenti. Ma già l'equidistanza, l'accortezza di evitare difese d'ufficio del capo Bruti Liberati (che né Pomarici né Spataro amano particolarmente) ha finito con suonare come un messaggio esplicito a chi, come una parte di Magistratura Democratica, puntava a rovesciare il tavolo e a fare del grande accusatore Robledo l'unica vittima della faccenda, passandolo per le armi per diserzione o addirittura per intelligenza col nemico. La partita non è ancora del tutto chiusa, perché ieri non finisce i suoi lavori la Settima commissione del Csm, quella che potrebbe tirare le orecchie a Bruti per la sua gestione dei fascicoli. Ma nel frattempo la Procura milanese si prepara a restare in mezzo al guado, ad affrontare anni in cui non basterà una delibera del Csm a riportare sotto la sabbia i veleni venuti drammaticamente alla luce in queste settimane.
Repubblica inetta, nazione corrotta, scrive Massimo Cacciari su “L’Espresso”. Nonostante gli angeli vendicatori di Tangentopoli la corruzione dilaga ancora in Italia. E la spiegazione si trova in Machiavelli: è l’incapacità di governare a produrre malaffare e conflitti d’interessi. Corruzione, corrotti, corruttori. Non si parla d’altro. Ma come? Non avevamo stretto un patto col destino dopo Tangentopoli? Che mai più saremmo incorsi in simili peccati? Non erano discesi dal Sinai eserciti di Di Pietro, con il loro seguito di angeli vendicatori? E ancora non vi è chi tema le loro pene? Neppure i nipotini di Berlinguer e i giovani scout? Nulla dunque può spezzare l’aurea catena che dalle origini della patria va ai Mastellas e da lì ai Boccias, e abbraccia in sé destri e sinistri, senes, viri et iuvenes? Ah, se invece di moraleggiare pedantemente, leggessimo i padri! «Uno tristo cittadino non può male operare in una repubblica che non sia corrotta» (Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Libro III, cap.8). Niccolò vedeva dall’Albergaccio meglio che noi ora da Montecitorio. Tristi cittadini sempre ci saranno. Ma in una repubblica che non sia, essa, corrotta, poco potranno nuocere e facilmente essere “esiliati”. Gli “ordini” contano, le leggi, che non sono fatte dai giudici. Le leggi non cambiano la natura umana, ma la possono governare. È la repubblica corrotta che continuamente produce i corrotti. E quando una repubblica è corrotta? Quando è inetta. Quando risulta impotente a dare un ordine alla molteplicità di interessi che la compongono, quando non sa governare i conflitti, che sono la ragione della sua stessa vita, ma li patisce e li insegue. Se è inetta a mutare in relazione all’“occasione”, se è inetta a comprendere quali dei suoi ordini siano da superare e quali nuovi da introdurre, allora è corrotta, cioè si corrompe e alla fine si dissolverà. Corruzione è anzitutto impotenza. E impotenza è incapacità di “deliberare”. Una repubblica strutturata in modo tale da rendere impervio il processo delle decisioni, da rendere impossibile comprendere con esattezza le responsabilità dei suoi diversi organi, una repubblica dove si è costretti ogni volta alla “dannosissima via di mezzo” (sempre Niccolò docet), alla continua “mescolanza” di ordini antichi e nuovi, per sopravvivere - è una repubblica corrotta e cioè inetta, inetta e cioè corrotta. Ma quando questa infelice repubblica darà il peggio di sé? Con megagalattiche ruberie da Tangentopoli? Purtroppo no. Piuttosto (“banale” è il male), allorchè diviene quasi naturale confondere il privato col pubblico, concepire il proprio ruolo pubblico anche in funzione del proprio interesse privato. Magari senza violare norma alcuna - appunto perché una repubblica corrotta in questo massimamente si manifesta: nel non disporre di norme efficaci contro i “conflitti di interesse”, di qualsiasi tipo essi siano. Una repubblica è corrotta quando chi la governa può credere gli sia lecito perseguire impunemente il «bene particulare» nello svolgimento del proprio ufficio. Che questo “bene” significhi mazzette, o essere “umani” con amici e clienti, “essere regalati” di qualche appartamento, manipolare posti nelle Asl o farsi le vacanze coi soldi del finanziamento pubblico ai partiti, cambia dal punto di vista penale, ma nulla nella sostanza: tutte prove della corruzione della repubblica. Poiché soltanto “il bene comune è quello che fa grandi le città” (Discorsi, Libro II, cap.2). Il politico di vocazione può riuscire nel difficile compito di tenerlo distinto sempre dal suo privato. Il politico di mestiere, mai. Quello che si è messo alla prova nei conflitti della repubblica senza corrompersi, può farcela. Il nominato, il cooptato, che abbia cento anni o venti, mai. Ma abbiamo forse toccato il fondo. E questo deve darci speranza. Per vedere tutta la virtù di Mosè, diceva Niccolò, era necessaria tutta la miseria di Israele.
ALL’INIZIO FU TANGENTOPOLI. L’ultimo bilancio dell’inchiesta mani pulite, condotta dal pool di magistrati della procura di Milano, risale al febbraio del 1999. Anche perché da allora la stessa inchiesta mani pulite può dirsi morta, mentre Tangentopoli continua ad imperare. A sette anni dall’avvio delle indagini sulla corruzione politica e finanziaria che va sotto il nome di Tangentopoli, cominciate il 17 febbraio 1992 con l’arresto di Mario Chiesa, il solo pool di Milano aveva indagato 3.200 persone, aveva chiesto 2.575 rinvii a giudizio e aveva ottenuto 577 condanne, di cui 153 con sentenza passata in giudicato. Le statistiche ci dicono ancora che fino alla fine 1997 la guardia di finanza aveva accertato reati fiscali legati a Tangentopoli per un importo di 3.609 miliardi. Sono cifre che bastano da sole a dare un’idea della diffusione in Italia del sistema della corruzione che ha riguardato arricchimenti personali, ma anche e soprattutto maniere illecite di finanziamento dei partiti mediante il sistema delle tangenti, le cosiddette bustarelle, pagate da imprenditori ad esponenti politici. Quello che le statistiche non possono però raccontarci riguarda i criteri in base ai quali, non solo il pool di Milano, ha portato avanti queste inchieste. Anche perché, pur essendo – per ammissione degli stessi magistrati inquirenti - la corruzione estesa a tutti i partiti, nessuno escluso, decapitando di fatto solo una parte della classe politica e permettendo ad un’altra di salire al potere, l’inchiesta giudiziaria mani pulite ha avuto un notevole impatto sugli assetti istituzionali del Paese.
Mose, ultimo capitolo della tangentopoli della Seconda Repubblica. Da Bertolaso a Galan, passando per Penati, scrive Pietro Salvatori su “L’Huffingtonpost” All’inizio fu Tangentopoli. Una purga benefica per il sistema, dicevano. Qualcosa non deve essere andato per il verso giusto se vent’anni dopo un pubblico ministero come Carlo Nordio presenzia ad una conferenza stampa snocciolando parole come queste: “Avendo trattato Tangentopoli 20 anni fa posso dire che gran parte della corruzione scoperta oggi è simile e molti dei protagonisti sono gli stessi. Ma questo è un sistema molto più sofisticato". Punto. Si riparte da Expo, Mose, la cricca del G8, gli scandali milanesi, il “colpo di culo” del terremoto abruzzese. Se è vero, come sosteneva Honoré de Balzac, che “la corruzione è l’arma della mediocrità”, la grande aspirazione della classe politica emersa nel post-Tangentopoli sarebbe dovuta essere quella di elevare la schiera dei mediocri spazzati via dalle procure in un giardino di ottimati dai saldi principi e dalla retta condotta. Non sembra essere andata così. Perché nel pieno di una crisi economica di portata storica il ricorso alle Grandi opere salvifiche è stata spesso la bandiera sotto la quale combattere per creare occupazione, sviluppo e rivitalizzare una filiera produttiva in debito d’ossigeno. Ma è indubbio che quella dei “big deal all’amatriciana” è sovente stata un’etichetta latrice di operazioni opache, appalti pilotati, se non di corruttele. Gli ultimi sono gli episodi che hanno visto trentacinque arresti nell’ambito della realizzazione del Mose, il gigantesco sistema di paratoie mobili che dovrebbe isolare Venezia dai rovesci delle maree. Trentacinque paia di manette sono scattate ai polsi di altrettanti indagati. Tra questi figurano l’azzurro Renato Chisso, assessore regionale ai Trasporti, il democratico Giampietro Marchese, collega di Chisso in Regione, ma soprattutto Giorgio Orsoni, sindaco Pd della città lagunare. I provvedimenti di custodia cautelare sarebbero stati trentasei, se non che il berlusconiano Giancarlo Galan siede tra i banchi della Camera, e per lui bisognerà attendere l’autorizzazione a procedere da parte di Montecitorio. Quello delle fila di Forza Italia è uno sfarinamento che va avanti da tempo. Per tacer del leader, le inchieste che coinvolgono i fedelissimi dell’ex Cavaliere occupano da mesi le pagine della cronaca giudiziaria: da Denis Verdini (sotto botta per la gestione del Credito cooperativo fiorentino) a Marcello Dell’Utri (condannato per concorso esterno in associazione mafiosa), passando per Claudio Scajola, arrestato per aver favorito la latitanza dell’ex collega onorevole Amedeo Matacena. La vecchia guardia, si dirà. Vero, ma solo in parte. Perché, a molte delle figure riemerse da un’epoca che fu, si affiancano volti nuovi di una classe dirigente maturata dopo il 1994. Prendiamo Orsoni. Fino alla metà degli anni zero ha guidato la società ingegneristica dell’aeroporto di Venezia ed è stato consigliere di amministrazione alla Biennale. La sua frequentazione con gli ambienti della politica è tutto sommato residuale (tecnico al ministero dei Lavori pubblici dal ’96 al ’98, un’esperienza da assessore del capoluogo lagunare terminata nel 2005) fino al 2010. È quando la svolta fusionista veltroniana si è consumata da tempo che viene individuato come volto nuovo, profilo da grand commis tecnico, da presentare sul palcoscenico nazionale, lanciato nel 2010 verso la polverizzazione dell’avversario di centrodestra, Renato Brunetta, e da innalzare a guida Democratica di uno dei patrimoni storici dell’umanità. Sorte condivisa da Giampietro Marchese, che, forte di una prima elezione in consiglio regionale nel 2005, non ha ancora festeggiato il primo decennio con una targhetta di un certo rilievo sulla porta dell’ufficio. Orsoni avrebbe ricevuto soldi per finanziare la propria campagna elettorale, in cambio di “agevolazioni” ai suoi co-imputati una volta eletto. Proprio da questo punto di vista, sono stati i magistrati che indagano sull’altro grande scandalo delle ultime settimane, quello che riguarda l’Expo 2015, a mettere in luce un paradigma delle inchieste che hanno terremotato la politica del post-Tangentopoli. Mentre vent’anni fa ci si sporcava le mani avendo come scopo principale quello di apportare benefici al proprio partito, oggi a muoversi sono cupole ramificate che sì coltivano rapporti con la politica o che ne fanno parte, ma che si mettono in moto per tornaconto personale. Così se alla metà degli anni ’90 si poteva dare a Primo Greganti il beneficio del dubbio che i soldi in nero fossero transitati per un suo conto avendo come destinazione finale il sol dell’avvenire, oggi l’accusa è quella che si sia mosso per intascarsi una bustarella degli appalti che tentava di pilotare. Così come i suoi sodali tripartisan nella cricca che sguazzava nelle ricche commesse dell’esposizione universale: l’ex democristiano Gianstefano Frigerio, e l’ex senatore berlusconiano Luigi Grillo. Anche qui un miscuglio di protagonisti datati di un’epoca che sembrava archiviata si unisce senza soluzione di continuità a rampanti arrivisti dell’ultima ora, come il responsabile dell’ufficio contratti Angelo Paris, che ha ammesso di aver commesso alcuni dei presunti illeciti contestatigli “per la promessa di una futura carriera”. La primogenitura della lunga serie di mani sporcatesi nel tentativo di drenare parte del fiume di denaro diretto verso le grandi opere è dell’uomo nuovo per eccellenza dell’epoca d’oro di Silvio Berlusconi, quel Guido Bertolaso che ha guidato le sorti di mezza Italia da capo della Protezione civile e sottosegretario della presidenza del Consiglio. Una carriera folgorante, rimasta invischiata in un “sistema gelatinoso” che lo ha visto coinvolto insieme ad Anemone e Balducci, accusati di aver distratto soldi dall’organizzazione del G8 della Maddalena, dai cantieri messi in piedi per i 150 anni d’Italia e dall’allestimento dei mondiali di nuoto. Vecchi sistemi, uomini e fini nuovi. Il trait d’union delle due epoche è quel Filippo Penati che non ha conosciuto il carcere forse solamente perché la prescrizione è intervenuta a estinguerne i reati. Anche il “sistema Sesto” era imperniato su opere pubbliche. Da un lato due aree industriali (le cosidette Falck e Marelli) per la cui riqualificazione, secondo gli inquirenti, girarono una serie di mazzette. Dall’altra l’acquisto (dal gruppo Gavio) della Provincia di parte delle quote della Milano-Serravalle, con un danno per le casse erariali stimato in 119 milioni di euro. Penati ha un cursus honorum nel corpaccione dei partiti della Prima repubblica simile a quello di Greganti. Ma i fatti contestatigli risalgono a quando, da semplice assessore di Sesto San Giovanni, arrivò a toccare con mano il potere vero, come presidente della Provincia meneghina, un incarico che lo fece incamminare verso la grande sfida (persa) per la guida del Pirellone contro Roberto Formigoni. Da semplice quadro di partito negli anni nei quali l’Italia veniva sconvolta dalle inchieste del pool di Milano, è nella Seconda Repubblica che l’ex sindaco di Sesto San Giovanni si proiettò sul panorama nazionale. Prima da presidente provinciale, nel 2004, poi da membro del coordinamento del Pd veltroniano, infine da capo della segreteria politica di Pier Luigi Bersani una volta che questi vinse le primarie per la segreteria del 2009. Insomma, per le mele marce della politica dalla metà degli anni ’90 a oggi, le grandi opere sono spesso “una botta di culo”. Così Ermanno Lisi, assessore della giunta di centrosinistra de L’Aquila, definiva il terremoto che provocò 309 vittime nel capoluogo abruzzese. In barba alle bare e alle migliaia di sfollati, Lisi vedeva nelle montagne di soldi che sarebbero arrivati per la ricostruzione una grande opportunità di business. Dello stesso parere sembrerebbero altri tre amministratori aquilani: il vicesindaco Roberto Riga, indagato per una presunta mazzetta da 30mila euro, un ex consigliere comunale con delega, Pierluigi Tancredi del Pdl, accusato di corruzione, e un altro ex assessore, Vladimiro Placidi. Solo punte dell’iceberg in un sistema che ha portato l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici a trasmettere negli ultimi anni alle procure e alla Corte dei Conti più di settanta indagini e quasi mille denunce per false dichiarazioni nelle gare di appalto. Tante, troppe, per la voracità di quella classe politico-imprenditoriale che si doveva affrancare dalla mediocritas dei propri padri. E che, al contrario, a dar retta a Nordio, insieme ai suoi predecessori rischia di trasmettere sugli schermi degli italiani il brutto film di una nuova Tangentopoli.
TANGENTOPOLI VENETA. Il procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio nel corso della conferenza stampa sui 35 arresti evoca Mani pulite anche se parla di meccanismo "più sofisticato". E il procuratore capo Luigi Delpino aggiunge: "Il sistema di false fatture serviva in gran parte a finanziare forze politiche a livello comunale, regionale e nazionale e a corrompere pubblici ufficiali", scrive Alice D'Este su “Il Fatto Quotidiano”. “Avendo trattato Tangentopoli 20 anni fa posso dire che gran parte della corruzione scoperta oggi è simile e molti dei protagonisti sono gli stessi. Ma questo è un sistema molto più sofisticato”. È la riflessione del procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, nel corso della conferenza stampa sui 35 arresti eseguiti questa mattina dalla Guardia di Finanza. “Il sistema di false fatture o meglio di sovrafatturazioni serviva in gran parte a finanziare forze politiche a livello comunale, regionale e nazionale e a corrompere pubblici ufficiali di elevato ruolo istituzionale” spiega il il procuratore capo Delpino. L’aggiunto Nordio: “Finanziamento illecito a entrambi gli schieramenti politici”. Ai domiciliari per finanziamento illecito è finito il sindaco Pd Giorgio Orsoni, arrestato anche l’assessore regionale alle Infrastrutture di Forza Italia Renato Chisso. In manette imprenditori, rappresentanti delle forze dell’ordine e anche due ex Magistrati delle acque. Richiesta d’arresto per l’ex ministro Giancarlo Galan e la europarlamentare Amalia Sartori. I fondi neri del Mose “sono stati utilizzati per campagne elettorali e, in parte, anche per uso personale da parte di alcuni esponenti politici. Hanno ricevuto elargizioni illegali persone di entrambi gli schieramenti” chiarisce Nordio. “Ho letto l’intervento del Capo dello Stato e del vice presidente del Csm che hanno invitato i magistrati a essere attenti in merito alle indagini più delicate. Voglio assicurare che la Procura di Venezia non ha nessuna intenzione di interferire su un’opera come il Mose, altamente tecnologica e che onora l’Italia” prosegui Nordio. “Ci addolora il fatto che è stato accertato che attorno ai lavori di realizzazione di quest’opera, continuino a interferire perniciose operazioni illecite”. Il procuratore Delpino: “Le indagini vanno avanti, gli sviluppi possono essere tantissimi”. “Le indagini vanno avanti, non sono concluse con questa operazione. Gli sviluppi possono essere tantissimi e non riguardano solo l’ulteriore fase di accertamenti di reati fiscali”, dovuti alla sovrafatturazione e false fatturazioni per creare fondi neri per pagare esponenti politici, osserva il procuratore di Venezia, Luigi Delpino. “È stato un eccezionale lavoro della Guardia di Finanza che con una lunga e difficile indagine ha portato alla luce un sistema illecito ben radicato. La Procura della Repubblica sente il dovere di dare atto agli appartenenti della Gdf per l’alto livello di professionalità e di riserbo che ha consentito di far emergere perniciosi settori di illegalità e di recuperare ingenti risorse finanziarie frutto di attività illecite”. Delpino ha ringraziato anche le autorità della Svizzera e di San Marino che hanno collaborato per risalire ai fondi neri creati all’estero. “Il sistema di false fatture o meglio di sovrafatturazioni serviva in gran parte a finanziare forze politiche a livello comunale, regionale e nazionale e a corrompere pubblici ufficiali di elevato ruolo istituzionale”. La Gdf ha resistito a “tentativi di interferenze” dall’esterno nell’ambito dell’indagine. “Spartizione equivalente tra le varie forze politiche di destra e di sinistra”. ”Gli elementi in comune di questa vicenda con il passato sono una spartizione equivalente di risorse tra le varie forze politiche di destra e di sinistra e la constatazione che la madre della corruzione, 20 anni fa come oggi, non è solo l’avidità umana, ma appunto la complessità delle leggi. Se devi bussare a cento porte invocando cento leggi diverse per ottenere un provvedimento è quasi inevitabile che qualcuna resti chiusa e qualcuno ti venga a dire che devi imparare a oliarla” ragiona Nordio. “Al di là dell’inchiesta di oggi – sottolinea il magistrato – voglio ricordare quanto scrissi già 15 anni fa: una delle cause della corruzione deriva dalla farraginosità delle leggi, dal numero delle leggi e dalla loro incomprensibilità, e da una diffusione di competenze che rende difficile individuare le varie responsabilità”. “Se è consentito al magistrato dare un messaggio forte, per ridurre, se non eliminare, la corruzione la strada è la riduzione delle leggi e l’individuazione delle competenze. Alzare le pene, come si continua a fare, e contemplare nuovi reati non serve assolutamente a niente, come dimostra questa inchiesta dove si può dire che le forze politiche non hanno imparato nulla dal passato. Unica differenza – riflette – è che oggi il sistema è molto più sofisticato”. Il generale della Finanza Buratti: “Venticinque milioni di fondi neri”. Dall’indagine sul Mose è emerso un “sistema che ha prodotto 25 milioni di euro di fondi neri” dei quali ora si è “accertata la destinazione” afferma il comandante della Gdf del Veneto, Bruno Buratti. “Si tratta di un’indagine che parte da lontano e che trae origine da verifiche fiscali iniziate nel 2008. Questa terza fase dello sviluppo investigativo aveva il fine di accertare la destinazione dei fondi neri realizzati dalle aziende impegnate nei lavori del Mose”, dice il generale Buratti, nel corso della conferenza stampa in Procura a Venezia. “Abbiamo accertato che il sistema ha prodotto, attraverso triangolazioni con società estere con sedi in Svizzera e San Marino, 25 milioni di euro di fondi neri. Si trattava con questo filone d’indagine di accertare la destinazione di questi fondi e le responsabilità soggettive”. Il generale rivela che, tra le ipotesi di reato, vi sono “corruzione, finanziamento illecito ai partiti, violazione del segreto istruttorio, millantato credito, favoreggiamento personale”. Buratti sottolinea che “è stato realizzato un sistema nel quale venivano emesse fatture per operazioni inesistenti non per evadere il fisco ma appunto per creare fondi neri. Non si tratta solo di dazioni di denaro connesse a fatti specifici, ma di un fatto sistematico e continuativo. Esisteva un fenomeno continuativo in cui i soggetti con funzioni pubbliche avevano il compito di agevolare le attività”. Fatturazioni aumentate per operazioni inesistenti che facevano dunque ricadere i finanziamenti illeciti in opere pagate dalla collettività.
Il Mose (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) è un'opera di ingegneria idraulica pensata negli anni '80 per difendere Venezia e la sua laguna dal fenomeno dell'acqua alta e specialmente da quelle superiori ai 110 centimetri. Il sistema di dighe mobili, la cui realizzazione è stata autorizzata dal Comitatone del 3 aprile 2003 e i cui lavori sono partiti lo stesso anno, viene realizzato dal Consorzio Venezia Nuova, che opera per conto del Magistrato delle Acque di Venezia, emanazione del Ministero delle Infrastrutture. Lo scorso 12 ottobre, alla bocca di porto del Lido-Treporti, una delle tre che permettono l’ingresso in laguna, sono state per la prima volta sollevate quattro delle 78 paratoie che dovranno difendere la città dall'alta marea attraverso un meccanismo fatto di cassoni di alloggiamento in cemento armato, cerniere e, appunto, paratoie. Il costo complessivo dell’opera è di 5.493 milioni di euro (prezzo "chiuso" stabilito nel 2005), lo stato di avanzamento dei lavori è pari all'87% e, ad ottobre, serviva ancora un miliardo di euro circa per la realizzazione completa. L'obiettivo, ricordato anche in quell'occasione, è di concludere l'opera entro il 2016. L'idea di difendere Venezia dalle acque alte che la flagellano da sempre, nasce dopo la terribile alluvione del 1966, poi dagli anni Ottanta, tutto si concentra sul progetto del Mose, un sistema idraulico di paratoie mobili che stanno appoggiate invisibili sul fondo delle bocche di porto e si alzano con l'alta marea, riempite di aria compressa. Nel 2003 la posa della prima pietra, poi oltre 10 anni di cantieri per realizzare la struttura che sarà controllata da una sede operativa all'Arsenale, attiva già da due anni, in grado di fornire previsioni sul meteo e sulle maree con un anticipo di 3 giorni.
4 giugno 2014, tutta Italia ne parla. Mose, 35 arresti per tangenti: anche il sindaco di Venezia. Chiesta la custodia cautelare per l'ex governatore Galan, gli atti dovranno essere trasmessi al Senato. Un centinaio di persone nel registro degli indagati, scrive “La Repubblica”. Imprenditori e tanti politici. Una raffica di arresti clamorosi. Il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, del centrosinistra, è finito in manette con le accuse di corruzione, concussione e riciclaggio. L'inchiesta è quella della Procura di Venezia sugli appalti per il Mose e sull'ex ad della Mantovani Giorgio Baita, già colpito da un provvedimento di custodia cautelare lo scorso febbraio. In manette anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Renato Chisso, di Forza Italia. Le persone finite in manette sono in tutto 35 persone, un altro centinaio gli indagati. Tra gli arrestati anche il consigliere regionale del Pd Giampiero Marchese, gli imprenditori Franco Morbiolo e Roberto Meneguzzo nonchè il generale in pensione Emilio Spaziante. E una richiesta di arresto è stata formulata per il senatore di Foza Italia Giancarlo Galan. Trattandosi di un parlamentare, gli atti dovranno essere tramessi al Senato. Galan è coinvolto per il periodo in cui è stato presidente della Regione Veneto. Gli arresti partono da una partono da una inchiesta della Guardia di finanza di Venezia avviata circa tre anni fa. I pm Stefano Ancillotto, Stefano Buccini e Paola Tonino (Dda) avevano scoperto che l'ex manager della Mantovani Giorgio Baita, con il beneplacito del proprio braccio destro Nicolò Buson, aveva distratto dei fondi relativi al Mose, le opere di salvaguardia per Venezia, in una serie di fondi neri all'estero. Il denaro, secondo l'accusa, veniva portato da Claudia Minutillo, imprenditrice ed ex segretaria personale di Galan, a San Marino dove i soldi venivano riciclati da William Colombelli grazie alla propria azienda finanziaria Bmc. Le Fiamme gialle avevano scoperto che almeno 20 milioni di euro, così occultati, erano finiti in conti esteri d'oltre confine e che, probabilmente, erano indirizzati alla politica, circostanza che ha fatto scattare l'operazione di questa mattina all'alba. Dopo questa prima fase, lo stesso pool, coadiuvato sempre dalla Finanza, aveva portato in carcere Giovanni Mazzacurati ai vertici del Consorzio Venezia Nuova (Cvn). Mazzacurati, poi finito ai domiciliari, era stato definito "il grande burattinaio" di tutte le opere relative al Mose. Indagando su di lui erano spuntate fatture false e presunte bustarelle che hanno portato all'arresto di Pio Savioli e Federico Sutto, rispettivamente consigliere e dipendente di Cvn, e quattro imprenditori che si spartivano i lavori milionari.
La Laguna degli scandali. Fatture gonfiate. Consulenze fasulle. E arresti eccellenti. Ma l'inchiesta sul consorzio concessionario per la realizzazione del Mose, non è ancora conclusa. E rischia di arrivare a Roma, scriveGianfrancesco Turano su “L’Espresso”. Adesso tocca alla politica. Devono emergere le responsabilità di chi ha creato questo mostro giuridico che si chiama Consorzio Venezia Nuova». La frase non appartiene agli inquirenti che negli scorsi sei mesi, da febbraio a luglio, hanno arrestato vertici, azionisti e fornitori del raggruppamento di imprese incaricato di realizzare le dighe mobili a protezione della Serenissima. Sono le parole di un politico, Massimo Cacciari, sindaco di Venezia per tre mandati. Avendo trascorso un quarto di secolo a fare la vox clamantis in deserto, non ci credeva più neanche lui che il mostro della Laguna sarebbe andato in crisi dopo avere inghiottito e distribuito nel suo vasto organismo oltre 4 miliardi di euro su un investimento complessivo che arriva a 5,5 miliardi. E chissà poi se il mostro è davvero in crisi. Tutto dipende da quanto la magistratura vorrà, o potrà, approfondire un contesto di fatture gonfiate, consulenze fasulle, massi comprati dalle cave istriane al prezzo di diamanti e pagamenti che si perdono dietro società croate, austriache o sanmarinesi e fiduciarie made in Italy. Di sicuro, l'arresto dell'ex presidente e direttore generale Giovanni Mazzacurati, lo scorso 12 luglio, è stato assorbito in anticipo. L'ingegnere padovano, 81 anni di cui 31 trascorsi all'interno del consorzio, si è dimesso il 28 giugno, ufficialmente per motivi di salute. Tempi, modi e protagonisti dell'avvicendamento al vertice del Consorzio sono all'insegna delle ingerenze denunciate da Cacciari e del cambiare perché nulla cambi. Mazzacurati è stato sostituito alla presidenza dal vicentino Mauro Fabris, perquisito con altre cento persone mentre Mazzacurati finiva agli arresti. Di mestiere, Fabris farebbe il consulente d'azienda. Ma forse è un po' più noto come parlamentare irrequieto, capace di attraversare per tre legislature (1996-2008) ogni fase del centrismo (Margherita, Udr, Ccd, Udeur) prima di abbracciare il credo berlusconista e di consolarsi, dopo la mancata candidatura alle politiche del 2008, con la presidenza della Lega pallavolo femminile e un incarico da commissario per il tunnel del Brennero firmato dal ministro di allora, Altero Matteoli. Qualcuno gli ha chiesto se il suo sponsor per la nomina al Consorzio fosse il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi oppure lo stesso premier Enrico Letta, nipote del sottosegretario berlusconiano Gianni che in Laguna ha comandato a lungo attraverso i suoi emissari Angelo Balducci e Fabio De Santis, prima che i processi alla Cricca li portassero in carcere nel 2010. Stroncando ogni sospetto di patronage politico, Fabris ha replicato che il Consorzio Venezia Nuova (Cvn) è composto da imprese private (Mantovani, Condotte, Mazzi, Lega coop), che sono stati gli azionisti del Cvn a sceglierlo e che il sindaco di New York, Michael Bloomberg, gli ha già chiesto le planimetrie del Mose perché pensa di adottarle contro le piene del fiume Hudson. In un momento di pessimismo, ha aggiunto che il Consorzio potrebbe sciogliersi subito dopo la fine dei lavori, prevista nel 2016, e affidare non si sa a chi la fase più delicata dei primi anni di attività di un sistema sul quale molti tecnici qualificati hanno espresso gravi perplessità. Il fatto che il vicentino Fabris sia stato scelto da un gruppo di imprenditori privati mostra come in una delle opere più ambiziose e costose in corso in Italia un lobbista sia più competitivo di un ingegnere o di un manager. Del resto, per l'ex deputato, ex senatore ed ex sottosegretario ai Lavori pubblici è un ritorno sui luoghi dove la sua carriera ebbe inizio circa un quarto di secolo fa. Nella seconda parte degli anni Ottanta Fabris è stato il primo portavoce in quota Dc del Consorzio allora guidato da Luigi Zanda, prima di essere sostituito da Franco Miracco, al tempo di sinistra e poi riciclatosi come eminenza grigia dell'ex governatore regionale ed ex ministro Giancarlo Galan. In un contesto local-nazionale dominato dai virtuosi del trasformismo, il mostro raffigurato da Cacciari ha avuto una testa per ogni forza politica che l'ha nutrito. Quindi, ha avuto tutte le teste possibili fin dai tempi della Prima Repubblica, quando la legge speciale su Venezia del 1984 stabilì che il Cvn, in quanto concessionario unico dello Stato, lavorasse con fondi pubblici messi a disposizione dal Cipe. Lo schema è sopravvissuto a ogni polemica, a ogni restrizione di spesa sulle infrastrutture e a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea perché il sistema Mose-Cvn era sospettato di essere un monopolio. Per anni, Mazzacurati si è speso in una spola continua tra palazzo Morosini, la splendida sede del Consorzio nel sestiere di San Marco, e palazzo Chigi mentre Piergiorgio Baita reggeva di fatto l'operatività del Cvn a nome dell'azionista di maggioranza Mantovani. Baita, che per molti resta il custode dei segreti del Mose, è finito in carcere a febbraio. Durante la sua detenzione, la Mantovani lo ha rimpiazzato con un ex questore di Treviso, Carmine Damiano, giusto per dare un segnale di buona condotta al committente statale che, peraltro, non ha mai smesso di tenere in cima alle priorità infrastrutturali il Mose chiunque fosse il premier, Romano Prodi o Silvio Berlusconi, Mario Monti o Enrico Letta. In sede regionale, si è vista la stessa continuità e i referenti non sono cambiati da quando Galan ha lasciato la giunta al leghista Luca Zaia dopo avere comandato in Veneto dal 1995 al 2010. Renato Chisso, ex socialista assessore alle Infrastrutture fedelissimo di Galan, è stato confermato anche nella nuova giunta. Al momento, il sistema politico è rimasto fuori dai provvedimenti della magistratura. Ma la diga sembra fragile e l'acqua alta, stavolta, potrebbe arrivare fino a Roma.
Mose, inchiesta sugli appalti: arrestato il sindaco di Venezia. Chiesta custodia cautelare per Galan, scrive “La Repubblica”. Cento indagati, 35 provvedimenti restrittivi. Ai domiciliari Giorgio Orsoni, accusato di finanziamenti illeciti, ma non di corruzione. Chiesto l'arresto per l'ex governatore del Veneto: "Milioni in stipendi da fondi neri". Ma lui: "Totalmente estraneo". In manette anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Chisso, coinvolti un magistrato della Corte dei Conti e un generale della finanza. I pm: "Peggio di una tangentopoli". Imprenditori, manager e soprattutto amministratori e politici di primo piano. Dopo il caso Expo, uno sviluppo clamoroso dell'inchiesta sugli appalti per il Mose ha sconvolto stamattina Venezia: il sindaco Giorgio Orsoni, eletto con il centrosinistra, è stato arrestato e ora è ai domiciliari. In carcere, invece, è finito l'assessore regionale alle Infrastrutture, Renato Chisso, di Forza Italia. E la procura veneziana ha chiesto un provvedimento di custodia cautelare anche per Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto e attuale parlamentare di Forza Italia, sul quale, essendo deputato, dovrà pronunciarsi la Camera. L'inchiesta è quella della Procura di Venezia che a febbraio aveva portato all'arresto di Giorgio Baita, ex amministratore delegato della Mantovani, una delle imprese impegnate nei lavori per la costruzione delle barriere del Mose che dovranno proteggere Venezia da alte maree ed allagamenti. Le accuse per gli indagati variano dai reati contabili e fiscali alla corruzione, dalla concussione al finanziamento illecito. Le accuse a Orsoni. Secondo quanto si legge nell'ordinanza integralmente riportata dalla Nuova Venezia, il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni è accusato di finanziamento illecito poiché "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale candidato sindaco del Pd alle elezioni comunali di Venezia del 2010, riceveva i contributi illeciti", "consapevole del loro illegittimo stanziamento da parte del Consorzio Venezia Nuova": si parla 110 mila euro al Comitato elettorale del candidato sindaco e 450 mila ricevuti in contanti "di cui 50 mila procurati dal Baita quale amministratore delegato della Mantovani che il Sutto (dipendente del Consorzio Venezia Nuova, società coinvolta nella realizzazione del Mose, ndr) e Mazzacurati (allora presidente di Cvn, ndr) consegnavano personalmente in contanti a Giorgio Orsoni, in assenza di deliberazione dell'organo sociale competente e della regolare iscrizione in bilancio". La posizione del sindaco. "Le circostanze contestate nel provvedimento notificato paiono poco credibili", hanno subito risposto gli avvocati di Orsoni, in quanto "gli si attribuiscono condotte non compatibili con il suo ruolo ed il suo stile di vita". Un anno fa, in un'intervista ad Antenna 3, sulla questione di un finanziamento dal Consorzio Venezia Nuova, il sindaco disse: "Non credo di aver avuto contributi, ma sulla questione va interrogato il mio mandatario elettorale". Nell'ambito dell'inchiesta sono stati perquisiti gli uffici del sindaco di Venezia e dell'assessore regionale Chisso. "False fatture per 25 milioni". "E' doveroso precisare che al sindaco di Venezia Orsoni non è stato contestato il reato di corruzione", ha sottolineato il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio. "Orsoni è indagato per finanziamento illecito ai partiti". Nordio ha definito l'inchiesta "peggio di una Tangentopoli". L'ordinanza del gip (711 pagine), citata dal pm, sostiene che "i fondi neri sono stati utilizzati per campagne elettorali e, in parte, anche per uso personale" e che "hanno ricevuto elargizioni illegali persone di entrambi gli schieramenti politici". Il procuratore capo, Luigi Delpino, ha spiegato che alla base di questo sviluppo 'politico' dell'inchiesta ci sono triangolazioni di denaro e fondi neri ottenuti attraverso false fatture maggiorate per un totale accertato di 25 milioni di euro. Trentacinque arresti, un centinaio di indagati nell'inchiesta avviata dalla procura di Venezia per gli appalti del Mose. Tra gli arrestati il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. Per tutti le accuse vanno dalla corruzione alla concussione e al riciclaggio. Le persone destinatarie di provvedimento restrittivo sono in tutto 35 (25 in carcere, 10 ai domiciliari), mentre sono un altro centinaio gli indagati, tra cui anche Marco Milanese, il consigliere politico dell'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti già coinvolto nell'inchiesta P4, per il quale il gip non ha accettato la richiesta di arresto. Tuttavia, come si legge nell'ordinanza, Milanese "al fine di influire sulla concessione di finanziamenti del Mose", avrebbe ricevuto dal presidente del Consorzio Venezia Nuova la somma di 500 mila euro. Tra gli arrestati ci sono inoltre il consigliere regionale del Pd Giampiero Marchese (coinvolto nell'inchiesta per un finanziamento sospetto di 33mila euro per la campagna delle regionali 2010), gli imprenditori Franco Morbiolo (presidente del Coveco, cooperativa impegnata nel progetto Mose) e Roberto Meneguzzo (ad di Palladio Finanziaria, avrebbe messo in contatto Mazzacurati con Milanese), nonché il generale della Guardia di finanza in pensione Emilio Spaziante, il magistrato della Corte dei Conti Vittorio Giuseppone, Patrizio Cuccioletta, ex presidente del Magistrato delle Acque, e Amalia Sartori, eurodeputata di Forza Italia non rieletta alle recenti elezioni (la richiesta d'arresto è stata inviata all'europarlamento). La GdF ha sequestrato beni per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro e sta effettuando perquisizioni e sequestri in Veneto, Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna con oltre 300 uomini impegnati. Le accuse a Galan. Corruzione è invece il reato ipotizzato nella richiesta di arresto formulata per il deputato di Forza Italia Giancarlo Galan. L'ex governatore veneto è indagato dalla Procura di Venezia con l'accusa di aver ricevuto fondi illeciti per milioni di euro dal Consorzio Venezia Nuova (Cvn) nell'ambito delle opere del Mose. Le dazioni, da fondi neri realizzati dal Consorzio e dalle società che agivano in esso, risalirebbero agli anni tra il 2005 e il 2008 e il 2012. "Gli stipendi annuali". Secondo quanto si è appreso, i fondi all'assessore regionale alle Infrastrutture Renato Chisso sarebbero stati dati tramite la segreteria, circostanza che ha portato il politico agli arresti in carcere stamani all'alba. Il denaro veniva poi trasferito a Galan. Il reato contestato a Galan, Chisso e a un paio di funzionari della Regione è quello di corruzione contro i doveri d'ufficio. Nei brani dell'ordinanza riportati da La Nuova Venezia si legge che Galan è accusato di aver ricevuto "per tramite di Renato Chisso, che a sua volta li riceveva direttamente dallo stesso Mazzacurati", "uno stipendio annuale di circa 1 milione di euro, 900 mila euro tra il 2007 e il 2008 per il rilascio nell'adunanza della commissione di salvaguardia del 20 gennaio 2004 del parere favorevole e vincolante sul progetto definitivo del sistema Mose, 900 mila euro tra 2006 e 2007 per il rilascio (...) del parere favorevole della commissione Via della regione Veneto sui progetti delle scogliere alle bocche di porto di Malamocco e Chioggia". L'ex governatore: "Totalmente estraneo a accuse". Trattandosi di un deputato, gli atti della richiesta di arresto dovranno essere trasmessi alla Camera, dove Galan è presidente della Commissione cultura. "Sono estraneo ad accuse, voglio essere ascoltato", ha detto Galan, che è coinvolto per il periodo in cui è stato presidente della Regione Veneto, dal 2005 al 2010. "Mi riprometto di difendermi a tutto campo nelle sedi opportune con la serenità ed il convincimento che la mia posizione sarà interamente chiarita. Chiederò di essere ascoltato il prima possibile con la certezza di poter fornire prove inoppugnabili della mia estraneità". Le accuse a Chisso e Marchese. L'assessore regionale ai Lavori pubblici Renato Chisso è accusato, invece, di aver percepito "uno stipendio annuale oscillante tra i 200 e i 250 mila euro, dalla fine degli anni Novanta sino ai primi mesi del 2013". Secondo il gip, Mazzacurati avrebbe concordato con i componenti del Consorzio il versamento della presunta tangente sotto forma di "stipendio" annuale, in cambio di nulla osta regionali per i lavori. Mentre Giampietro Marchese è accusato "quale candidato dal Consiglio regionale del veneto per il Pd alle elezioni 2010 riceveva i contributi illeciti" per 58 mila euro". Le accuse a Spaziante. Per quanto riguarda Spaziante, invece, nell'ordinanza del Gip si legge che in qualità "di Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza", per "influire in senso favorevole sulle verifiche fiscali e sui procedimenti penali aperti nei confronti del Consorzio Venezia Nuova", avrebbe ricevuto dal presidente del Consorzio Giovanni Mazzacurati la promessa di 2 milioni e 500 mila euro. Nell'ordinanza, si legge che la somma versata fu poi di 500 mila euro, che poi sarebbe stata divisa anche con Milanese e Meneguzzo. Le accuse a Giuseppone (Corte dei Conti). Coinvolto anche il magistrato della Corte dei Conti Vittorio Giuseppone, indagato nell'inchiesta sul Mose per aver "compiuto atti contrari ai suoi doveri". "Nella sua qualità di magistrato in servizio presso la Corte dei Conti", scrive il giudice, Giuseppone avrebbe percepito "uno stipendio annuale oscillante tra i 300mila e i 400mila euro, che gli veniva consegnato con cadenza semestrale a partire dai primi anni duemila sino al 2008" e "non meno di 600mila nel periodo tra il 2005 e il 2006, con creazione delle idonee provviste da parte del Baita". I soldi, afferma ancora il Gip, servivano per "accelerare le registrazioni delle convenzioni presso la corte dei Conti da cui dipendeva l'erogazione dei finanziamenti concessi al Mose e al fine di ammorbidire i controlli di competenza della medesima Corte dei Conti sui bilanci e gli impieghi delle somme erogate al Consorzio Venezia Nuova". Le accuse a Cuccioletta. Per il presidente del magistrato delle acque Patrizio Cuccioletta, in carica dal 2008 al 2011, le utilità, invece, non sarebbero stati solo soldi. Ai 400mila euro l'anno di stipendio, e ai 500mila di 'buonuscita' versatigli, secondo l'accusa, dal Consorzio su un conto svizzero, l'uomo sarebbe riuscito a far assumere la figlia in una controllata del Cvn e il fratello in un'altra azienda del gruppo, che pagava lo stipendio. Sarebbero rimasti invece solo una promessa gli altri benefit: voli aerei per tutta la famiglia, alloggi di lusso a Venezia, Cortina e altre località per le vacanze. L'inchiesta. Gli arresti partono da una inchiesta della Guardia di finanza di Venezia avviata circa tre anni fa. I pm Stefano Ancillotto, Stefano Buccini e Paola Tonino (Dda) avevano scoperto che l'ex manager della Mantovani Giorgio Baita, con il proprio braccio destro Nicolò Buson, aveva distratto fondi relativi ai lavori del Mose, le opere di salvaguardia per Venezia, in una serie di fondi neri depositati all'estero. Il denaro, secondo l'accusa, veniva portato da Claudia Minutillo, imprenditrice ed ex segretaria personale di Galan, a San Marino dove i soldi sarebbero stati riciclati da William Colombelli, titolare della finanziaria Bmc. Appalti e partiti. Le Fiamme gialle avevano scoperto che almeno 20 milioni di euro, così occultati, erano finiti in conti esteri, ipotizzando che la riserva potesse essere destinata a "sovvenzionare" amministratori e politici in cambio di ulteriori commesse pubbliche. Da questa tesi d'accusa è partita l'operazione di questa mattina all'alba. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dunque, attraverso un giro consistente di false fatture avrebbe creato fondi neri sarebbero serviti, almeno in parte, per finanziare politici e partiti di ogni schieramento durante le campagne elettorali. Dopo questa prima fase, lo stesso pool aveva ordinato l'arresto di Giovanni Mazzacurati ai vertici del Consorzio Venezia Nuova (Cvn). Mazzacurati, poi finito ai domiciliari, era stato definito "il grande burattinaio" di tutte le opere relative al Mose. Indagando sul suo operato erano spuntate fatture false e presunte bustarelle che hanno portato in seguito all'arresto di Pio Savioli e Federico Sutto, rispettivamente consigliere e dipendente di Cvn, e di quattro imprenditori che si sarebbero spartiti lavori per importi milionari. "Una vera e propria lobby". Il Consorzio Venezia nuova "si comporta come una vera e propria lobby o gruppo di pressione per ottenere le modifiche normative d'interesse", ha scritto il gip del tribunale di Venezia Alberto Scaramuzza, nell'ordinanza di custodia cautelare. Il riferimento è al tentativo di ottenere una modifica al tetto del 15% al nord dello stanziamento dei Fondi Fas (fondo aree sottoutilizzate) per avere 400 milioni di euro per il Mose attraverso una delibera Cipe. Mazzacurati, presidente del Cvn, secondo il Gip si muove su più livelli, da un incontro con Gianni Letta, che era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, passando per alcuni contatti con funzionari ministeriali, fino alla "terza possibilità, ossia l'appuntamento con Marco Milanese". Il Cvn, in una nota, ha negato tutte le accuse, definendosi "parte offesa".
Dal milione a Galan ai soldi per il giudice. La rete delle accuse. Al centro dell'inchiesta l'ingegnere Mazzacurati (Consorzio Venezia nuova) che pagava per ottenere finanziamenti pubblici. L'ex governatore: "Io estraneo, ho le prove". E rispunta Milanese, scrive Stefano Zurlo su “Il Giornale”. Altro che trasparenza. Il Consorzio Venezia nuova, guidato dal grande burattinaio delle tangenti Giovanni Mazzacurati, riusciva addirittura a far scrivere le leggi su misura per mettere le mani sui finanziamenti dei fondi Fas (Fondo aree sottoutilizzate). «Il Consorzio Venezia Nuova - scrive il gip Alberto Scaramuzza nell'ordinanza di custodia - si comporta come una vera e propria lobby o gruppo di pressione per ottenere le modifiche normative d'interesse». Per raggiungere lo scopo e ottenere una deroga al tetto del 15 per cento dei fondi Fas per il Nord, Mazzacurati le prova tutte. Vorrebbe incontrare pure il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Gianni Letta che così atterra fra le carte dell'indagine. Tirato in ballo in una girandola di conversazioni. In una telefonata, Mazzacurati annuncia al suo interlocutore il meeting con il «dottor Letta». Per il gip Letta riceve Mazzacurati a Palazzo Chigi almeno una volta. Ma i contatti, scrive Scaramuzza, sono «del tutto privi di rilievo penale, non risultando... alcun tipo di richiesta ma risultando esclusivamente un interessamento rispetto ad un'importante opera quale il Mose». Ma fra una telefonata e un colloquio volano anche le mazzette. Addirittura codificate, secondo l'accusa, con la retribuzione stabile di alcuni big della politica. Almeno 20 milioni, del resto, sono finiti sui conti esteri preparati dalla rete creata dall'ex top manager della Mantovani, Giorgio Baita, fra i primi ad essere arrestato. E sono pronti per soddisfare le diverse esigenze. Galan è in testa alla lista: l'ex governatore avrebbe ricevuto «900mila euro nel periodo fra il 2007 e il 2008, per il rilascio dell'adunanza della commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004, del parere favorevole e vincolante al progetto definitivo del sistema Mose» e ancora 900mila euro nel periodo fra il 2006 e il 2007 per il rilascio nell'adunanza del 4 novembre 2002 e del 28 gennaio 2005 del parere favorevole della commissione V.i.a. della Regione Veneto, su progetti delle scogliere esterne alle bocche di porto di Malamocco e Chioggia». Dunque, in conclusione Galan, «in qualità di presidente della Regione Veneto» si sarebbe adoperato più di una volta «per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio», ovvero per sbloccare pratiche care al Consorzio Venezia Nuova, ricevendo di fatto «uno stipendio annuale di un milione di euro». Il tutto fra il 2005 e il 2012. «Chiedo di essere ascoltato al più presto - replica l'ex ministro - ho le prove inoppugnabili della mia estraneità alle accuse che mi sono mosse, accuse che si appalesano del tutto generiche e inverosimili, per di più provenienti da persone che hanno goduto di miti trattamenti giudiziari e che hanno chiaramente evitato una nuova custodia cautelare». Il sindaco Giorgio Orsoni è stato arrestato per un reato meno grave: un finanziamento illecito di 110mila euro. La somma sarebbe arrivata in vista delle amministrative del 2010, quelle in cui sconfisse Renato Brunetta. Attenzione: Orsoni «beneficia di un contributo elettorale sì formalmente deliberato di 110mila euro, ma attraverso passaggi effettuati per impedire che risultasse il vero finanziatore, ossia il Consorzio Venezia Nuova, trattandosi quindi di finanziamenti illeciti». Insomma, Orsoni avrebbe mascherato l'imbarazzante contributo. Formalmente a pagare sarebbero state alcune aziende - dalla Mazzi alla Mantovani alla Covela - che a loro volta avrebbero ottenuto il denaro dal Consorzio Venezia nuova sulla base di false fatturazioni. Finisce ai domiciliari il magistrato della Corte dei conti Vittorio Giuseppone. Sarebbe stato corrotto dal solito Mazzacurati fra il 2000 e il 2008 «per ammorbidire i controlli i controlli di competenza della medesima Corte dei conti sui bilanci e gli impieghi delle somme erogate al Consorzio Venezia Nuova. Anche lui, come Galan e altri politici, avrebbe ricevuto uno stipendio fisso. L'importo? «Oscillante fra 300 e i 400mila euro, che gli veniva consegnato con cadenza semestrale, a partire dai primi anni del 2000 sino al 2008» e «non meno di 600mila euro nel periodo compreso fra il 2005 e il 2006». Fra gli arresti eccellenti c'è quello di Roberto Meneguzzo, il finanziere vicentino di Palladio finanziaria, crocevia di molti affari nel Nordest. Meneguzzo è «a conoscenza dell'illecita finalità perseguita da Giovanni Mazzacurati - scrive il gip - e «lo metteva in contatto» con l'ex ufficiale della Gdf ed ex deputato del Pdl Marco Milanese. Milanese è «il consigliere politico dell'allora ministro Giulio Tremonti. Mazzacurati gli consegna «personalmente» 500mila euro, «al fine di influire sulla concessione dei finanziamenti del Mose, in particolare nel far inserire fra gli stanziamenti inclusi nella delibera Cipe n. 31 2010 e nei decreti collegati anche la somma relativa ai lavori gestiti dal Consorzio Venezia Nuova, inizialmente esclusa dal ministro». Milanese, che è indagato, compare in un secondo gravissimo episodio. Mazzacurati, sempre per il tramite di Meneguzzo e Milanese, entra in contatto con il generale delle Fiamme Gialle Emilio Spaziante, all'epoca comandante interregionale dell'Italia centrale e oggi in pensione. Spaziante serve per influire «in senso favorevole sulle verifiche fiscali e sui procedimenti penali aperti nei confronti del Consorzio Venezia Nuova». Mazzacurati «consegnava, a titolo di acconto, in una prima occasione a Spaziante e Meneguzzo, e in una seconda a Spaziante e Milanese, una somma complessiva pari a 500mila euro». Secondo l'ordinanza, Mazzacurati prometteva a Spaziante «il versamento di una somma pari a 2,5 milioni di euro». Ma i versamenti si sarebbero interrotti prima.
Tutti i protagonisti della Cupola del Mose. Nell’inchiesta-choc di Venezia ci sono ex ministri indagati, sindaci democratici e potenti assessori regionali. Una sacra alleanza per drenare fondi pubblici e accumulare mazzette all’estero. Con imprenditori compiacenti e spioni pagati in nero per inquinare le indagini, scrive Michele Sasso su “L’Espresso”. La cupola del Mose è esplosa. La tangentopoli veneta è diventata di dominio pubblico con arresti clamorosi. Il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e l’ex governatore Giancarlo Galan sono tra i trentacinque destinatari delle misure cautelari eseguite questa mattina dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Al centro delle indagini ci sono i “protettori politici” e gli imprenditori privati del progetto Mose, come scritto da Paolo Biondani sull'Espresso già lo scorso novembre: «La più grande opera pubblica varata in Italia: un enorme sistema di dighe mobili, che dovrebbe proteggere Venezia dall'acqua alta ma dopo più di trent'anni non è ancora in funzione. Gran parte delle indagini sono per ora segrete, ma il quadro disegnato dalle prime confessioni è già chiaro: il Mose è diventato una monumentale fabbrica di denaro nero. I soldi ce li mette lo Stato, che ha già garantito ben 5 miliardi e 496 milioni di euro. Questa marea di denaro pubblico entra nelle casse di un soggetto privato, il Consorzio Venezia Nuova, che ha la concessione a gestire tutti gli appalti senza gara, senza concorrenza, senza alcun confronto tra costi e progetti alternativi. Il Consorzio è come una porta girevole: incassa i soldi dello Stato e li distribuisce ai suoi associati, cioè a un gruppo di fortunatissime aziende private che grazie al Mose sono diventate sempre più ricche e potenti». E poi, attraverso intrecci societari e triangolazioni con paradisi fiscali, le Fiamme gialle hanno scoperto che almeno 25 milioni di euro, occultati, erano finiti in conti esteri o riversati alla classe politica. L’alleanza Pd-Pdl per una marea di soldi. Un appoggio bipartisan per drenare fondi e salvare la città più bella del mondo. Oggi è un terremoto in casa dei democratici con il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, accusato di finanziamento illecito per la sua vittoriosa campagna elettorale del 2010. In quella sfida aveva battuto al primo turno il candidato-ministro Renato Brunetta. Lui ha sessantasette anni, avvocato amministrativista erede dello studio di Feliciano Benvenuti, primo procuratore di San Marco, vicepresidente della Biennale, prima di diventare sindaco era stato assessore al patrimonio con la giunta Costa. Una carriera dentro il centrosinistra anche per Lino Brentan l’amministratore delegato dell'autostrada Padova-Venezia arrestato due anni fa (e ai domiciliari oggi) e condannato per aver intascato mazzette, obbligando i suoi dirigenti a firmare atti anche se loro erano contrari, per favorire imprenditori amici. Entrambi muovono enormi flussi di denaro, memorizzano procedure, prassi, facce e nomi che li rendono indispensabili. Sulla sponda politica opposta il potente assessore alle infrastrutture Renato Chisso e Lia Sartori sono i protagonisti assoluti di Forza Italia, ramo Veneto. Chisso è nella giunta Zaia: ha abbracciato la causa berlusconiana fin dalla sua fondazione e dal 1995 non ha mai mancato un’elezione al parlamentino regionale. Dal 2000 ha in mano il portafoglio e le decisioni per le strade e grandi opere. Oggi è accusato di aver percepito «uno stipendio annuale oscillante tra i 200 e i 250 mila euro, dalla fine degli anni Novanta sino ai primi mesi del 2013», si legge nell’ordinanza per assicurare tutti i permessi necessari alla grande opera. L'europarlamentare Lia Sartori è stata per anni la vera eminenza grigia della politica di Galan. La sua esperienza a Palazzo Balbi, sede veneziana della Regione, è iniziata nel partito socialista di Bettino Craxi. Utilissima a Galan nel momento in cui l'ex manager di Publitalia dovette organizzare la nuova creatura di Berlusconi in Veneto, da allora ne diventò l'ombra, qualcuno dice la vera mente. Lo studio Altieri, che era stato fondato dal suo compagno, fu coinvolto nei grandi progetti infrastrutturali regionali e nella edificazione di molti ospedali. Dopo 15 anni a Bruxelles nelle ultime elezioni del 25 maggio non ha spuntato la rielezione. Ministri e indagati. Nella pattuglia degli ex spunta il nome di Giancarlo Galan: il governatore del Veneto dal 2005 al 2010 (e poi ministro dell’Agricoltura) è accusato di corruzione e, secondo la tesi dell'accusa, avrebbe intascato tangenti per un milione di euro all'anno dalla fine degli anni '90 fino al 2011, oltre a farsi ristrutturare gratis la sua villa di Cinto Euganeo. Non solo: Galan è indagato dalla Procura di Venezia anche con l'accusa di aver ricevuto fondi illeciti per almeno 800mila euro dal Consorzio Venezia Nuova nell'ambito delle opere del Mose. Il denaro, secondo l'accusa, veniva portato da Claudia Minutillo, imprenditrice ed ex segretaria personale di Galan, a San Marino dove i soldi venivano riciclati da William Colombelli grazie alla propria azienda finanziaria Bmc. Sotto accusa anche un altro ex potente ministro dell’era Berlusconi: Altero Matteoli ha ricevuto un avviso di garanzia. I fatti contestati risalgono al periodo in cui il senatore 74enne di Forza Italia era ministro all'Ambiente e alle Infrastrutture del governo Berlusconi. Dagli uffici dei pm Stefano Ancillotto, Stefano Buccini e Paola Tonini, titolari dell’inchiesta-choc, il fascicolo contenente gli elementi che chiamano in causa l'ex ministro sono stati trasferiti al tribunale dei ministri che si sostituisce all'indagine, per poi decidere in materia. Spioni e imprenditori. Le indagini si sono concentrate anche sull’ex generale della Guardia di Finanza Emilio Spaziante, massimo responsabile fino allo scorso autunno per tutta l'Italia centrale, che sarebbe stato corrotto tramite Marco Milanese, braccio destro dell'ex ministro Tremonti, e Roberto Meneguzzo, ricchissimo finanziere della Palladio. Una macchina da guerra che ha macinato le posizioni di maggiore prestigio negli anni d'oro di Nicolò Pollari. Gli viene attribuito un filo diretto con l'entourage berlusconiano e nel pasticcio della Laguna è sospettato di essersi fatto consegnare pacchi di banconote in contanti. Almeno mezzo milione di euro. I magistrati veneti hanno già messo in allarme altre procure italiane, bersagliate da analoghe manovre di inquinamento delle indagini che potrebbero aver avuto la stessa regia. I costi e i rischi di una corruzione di tale livello si spiegano con l'importanza del movente: impedire ai magistrati di scoprire un colossale sistema di malaffare gestito da un cartello di aziende collegate alla politica. Così si spiega un altro arresto eccellente: il presidente della Grandi lavori Fincosit di Roma e vice presidente del Consorzio Venezia Nuova Alessandro Mazzi. Il suo nome era finito già quattro anni fa nel filone veneto nell’inchiesta sulla Protezione civile che ha portato in galera l’imprenditore Diego Anemone e i tre alti funzionari incaricati per contro della Presidenza del consiglio dei ministri della gestione dei «Grandi eventi»: Angelo Balducci, Fabio De Santis e Mauro Della Giovampaola. Dopo la cricca, ora c'è la nuova Tangentopoli veneta: in Italia la vera legge degli appalti è la corruzione.
La Cupola del Mose. Inchiesta a Venezia su una rete di ufficiali che proteggevano gli affari sporchi del Mose. Sotto indagine per tangenti un alto ufficiale della Finanza. E gli inquirenti sospettano fondi neri per centinaia di milioni di euro, scrive Paolo Biondani su “L’Espresso”. La cupola degli appalti in Veneto aveva una super-copertura: una rete di controspionaggio guidata da un generalissimo della Guardia di Finanza. Un comandante di rango nazionale, con un passato nei servizi segreti, che poteva impartire direttive e farsi trasmettere informazioni sensibili da schiere di graduati senza destare sospetti. I magistrati di Venezia, con una squadra di fidati investigatori della stessa Guardia di Finanza, stanno scoperchiando una nuova Tangentopoli con centinaia di indagati. E come ai tempi delle inchieste milanesi di Mani Pulite, anche i pm di oggi si trovano costretti prima di tutto a coprirsi le spalle. Con un troncone d'indagine che punta contro un network di pubblici ufficiali sospettati di aver messo in vendita un servizio illegale di protezione dalle inchieste giudiziarie. Non le solite mazzette per addomesticare verifiche fiscali, insomma, ma una corruzione programmata per fermare sul nascere ogni possibile istruttoria. A libro paga c'era e forse c'è tuttora una rete di funzionari di varie forze di polizia, con agganci nei servizi e in agenzie private, in grado di spiare le procure, allertare gli intercettati, falsificare o far sparire documenti compromettenti e trafugare atti giudiziari. In settembre era stato arrestato il vicequestore bolognese Giovanni Preziosa, accusato di aver intascato circa 160 mila euro proprio per spiare le indagini venete. Ora i pm sono risaliti ai livelli più alti. E sotto accusa c'è un generale a tre stelle delle Fiamme gialle, sospettato di essersi fatto consegnare pacchi di banconote in contanti. Almeno mezzo milione di euro. I magistrati veneti hanno già messo in allarme altre procure italiane, bersagliate da analoghe manovre di inquinamento delle indagini che potrebbero aver avuto la stessa regia. I costi e i rischi di una corruzione di tale livello si spiegano con l'importanza del movente: impedire ai magistrati di scoprire un colossale sistema di malaffare gestito da un cartello di aziende collegate alla politica. Al centro delle indagini c'è il Mose, la più grande opera pubblica varata in Italia: un enorme sistema di dighe mobili, che dovrebbe proteggere Venezia dall'acqua alta ma dopo più di trent'anni non è ancora in funzione. Gran parte delle indagini sono per ora segrete, ma il quadro disegnato dalle prime confessioni è già chiaro: il Mose è diventato una monumentale fabbrica di denaro nero. I soldi ce li mette lo Stato, che ha già garantito ben 5 miliardi e 496 milioni di euro. Questa marea di denaro pubblico entra nelle casse di un soggetto privato, il Consorzio Venezia Nuova, che ha la concessione a gestire tutti gli appalti senza gara, senza concorrenza, senza alcun confronto tra costi e progetti alternativi. Il Consorzio è come una porta girevole: incassa i soldi dello Stato e li distribuisce ai suoi associati, cioè a un gruppo di fortunatissime aziende private che grazie al Mose sono diventate sempre più ricche e potenti. Tutte gli altri imprenditori possono spartirsi solo le briciole, a condizione di essere accettati e graditi. Questo sistema di arricchimento privato con soldi pubblici, contestato apertamente dall'Unione europea ma sopravvissuto a tutti i governi, è entrato in crisi per la prima volta il 28 febbraio 2013. Quel giorno finisce in carcere l'ingegnere idraulico Piergiorgio Baita , 64 anni, amministratore e azionista al 5 per cento della Mantovani spa, il socio forte del Consorzio. Baita scivola su una buccia di banana: fatture false per dieci milioni. La Mantovani dichiarava al fisco di pagare fantomatiche consulenze a una ditta di San Marino, la Bmc Broker, che in realtà restituiva i soldi in nero, trattenendo dal 22 al 24 per cento per il disturbo. A trasportare le valigie di contanti erano William Colombelli, presidente della società-fantasma, e Claudia Minutillo , fino al 2005 segretaria-factotum del presidente berlusconiano della Regione Veneto, Giancarlo Galan, poi diventata manager di Adria Infrastrutture, l'azienda stradale del gruppo Mantovani. Colombelli e Minutillo confessano subito dopo l'arresto: la Bmc produceva solo «carta straccia», il nero serviva a Baita per comprare politici, burocrati e ufficiali corrotti. Difeso dal parlamentare Pietro Longo, l'ingegner Baita tiene duro per tre mesi. Poi cambia avvocato e confessa. E mentre lui torna libero e chiede di patteggiare, nei palazzi della Serenissima comincia a tremare un sistema di potere ventennale. La seconda retata arriva a metà luglio. Tra i 14 arrestati c'è l'uomo più potente del Veneto, l'ingegnere idraulico Giovanni Mazzacurati, padre padrone del Consorzio Venezia Nuova. Mazzacurati scivola su un'indagine diversa: una gara da 15 milioni per il dragaggio dei canali. Le intercettazioni svelano che a pilotare quell'appalto portuale è proprio lui, il re del Mose. Per favorire una cordata di piccole imprese locali, Mazzacurati ordina ai colossi degli affari di non presentare offerte. In cambio di quei lavori, i piccoli devono girare allo staff del Consorzio una percentuale in nero. E così le grandi aziende possono continuare indisturbate a spartirsi la gigantesca torta delle dighe mobili per salvare Venezia. Ma anche per il Mose, dopo il caso Baita, spunta un altro giro di nero. Una cooperativa di Chioggia è accusata di aver gonfiato i costi dei massi per le barriere subacquee: arrivano dalla Croazia, ma sulla carta passano dall'Austria, dove c'è una ditta-fantasma che sforna fatture false per 5,5 milioni. A questo punto le due inchieste s'incrociano e disegnano lo stesso quadro: a pilotare tutti gli appalti è lo staff di Mazzacurati, ma per entrare nel club dei privilegiati le aziende devono consegnare una fetta del nero. Ora le indagini, in pratica, devono misurare l'ampiezza del sistema: la regola del nero valeva solo per Baita e pochi altri o il malaffare era generalizzato? E i fondi occulti restavano alle imprese o finivano anche alla classe politica che dispensa i soldi pubblici a Venezia e magari a Roma? L'inchiesta conta già più di cento indagati, venti arrestati e fatture dichiaratamente false per più di 30 milioni, ma finora si è vista solo la punta dell'iceberg. La Guardia di Finanza ha scoperto altre "cartiere" in Svizzera, Austria, Canada, oltre che in Italia, e indaga su possibili fondi neri per «centinaia di milioni di euro». Baita ha già dovuto confessare che il gruppo Mantovani ha gonfiato anche i costi di altre opere, come le tangenziali Verona-Padova o le autostrade bellunesi. Il top manager avrebbe anche ammesso di aver finanziato «politici di destra e di sinistra» in almeno tre elezioni. Grazie ai soldi del Mose la Mantovani ha potuto aggiudicarsi anche faraonici "project financing" sanitari, come l'appalto trentennale da 2 miliardi di euro per l'ospedale di Mestre, sempre in cordata con altre imprese agganciate alla politica. I più importanti sponsor istituzionali del duo Baita-Mazzacurati sono sicuramente Galan, governatore in carica dal 1995 al 2010, il suo assessore Renato Chisso, rimasto in carica con il presidente leghista Luca Zaia, l'europarlamentare Lia Sartori e il super-tenico Silvano Vernizzi di Veneto Strade. Solo Galan però ha difeso Baita dopo l'arresto e ha dovuto pure ammettere di avergli presentato la sua ex segretaria e l'altro signore del nero di San Marino. Tra le sponde a sinistra, più del modesto contributo finito alla fondazione VeDrò di Enrico Letta, pesa il ruolo delle cooperative rosse. E tutta l'inchiesta è nata dai controlli su Lino Brentan, amministratore in quota Pd dell'autostrada Padova-Venezia, arrestato nel gennaio 2012 per corruzione.
E poi....il caso Expo. La denuncia dell'Authority dei contratti a Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione: "Deroghe a ottanta regole, così la spesa è lievitata", scrivono Giuliano Foschini e Fabio Tonacci su “La Repubblica”. "Appalti senza controlli per mezzo miliardo". È stato più facile costruire le fondamenta dell'Expo che una pista ciclabile a Monza, più semplice affidare un contratto di vigilanza da qualche milione di euro che non assumere due bidelli in una scuola pugliese. In attesa di vedere quello che sarà, l'Esposizione universale del 2015 si è già rivelata per quello che è: una delle più grandi deroghe che lo Stato abbia mai concesso a se stesso. Mezzo miliardo di euro di denaro pubblico sottratto "alle norme e ai controlli" in nome dell'"emergenza" più prevista del mondo. "Ben 82 disposizioni del Codice degli appalti sono state abrogate con quattro ordinanze della Presidenza del consiglio - denuncia Sergio Santoro, l'Autorità garante per la vigilanza dei contratti pubblici - così hanno escluso noi e la Corte dei conti da ogni tipo di reale controllo". Dopo gli arresti dell'inchiesta di Milano, però, è scattato l'allarme e gli uffici tecnici dell'Authority hanno analizzato tutti i contratti per capire cosa sarebbe accaduto se quelle deroghe non ci fossero state, se il Codice nato nel 2006 apposta per combattere i fenomeni di corruzione fosse stato rispettato alla lettera. Ed ecco che sono venuti fuori affidamenti diretti oltre le soglie consentite, goffi riferimenti a commi di legge inesistenti, procedure ristrette poco giustificabili. "Le nostre sono osservazioni - ci tiene a specificare Santoro - fatte sui documenti disponibili online". Numeri, casi, segnalazioni, appunti, finiti in un dossier che Repubblica ha avuto modo di consultare e che è stato consegnato al magistrato Raffaele Cantone, il commissario voluto dal premier Matteo Renzi per evitare altri scempi. Le falle. Per capire di cosa stiamo parlando basta prendere l'opera al momento più famosa dell'Expo, le cosiddette "Architetture di servizio" per il sito, cioè le fondamenta dei capannoni. Famosa per il costo, 55 milioni di euro, ma soprattutto perché attorno a quel contratto ruota l'indagine di Milano sulla banda di Frigerio. Lo ottiene la Maltauro, ma come? Per l'affidamento Expo sceglie di non bandire una gara europea, aperta a tutti, ma di seguire la procedura ristretta. Partecipano sette aziende e dopo la valutazione della commissione vince un'Ati (Associazione temporanea di imprese) che ha come capofila appunto la Maltauro, l'azienda che è accusata di aver pagato mazzette a Frigerio e Greganti. La procura di Milano accerterà cosa è accaduto e come. Per il momento si può dire che a spalancare la porta alla corruzione è stata proprio la legge, permettendo la procedura abbreviata. "Come in molti altri casi per l'Expo - scrive il Garante nel suo dossier - si è seguito il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa". A individuare quale sia, deve essere una commissione di 3 o 5 membri, "imparziale e altamente qualificata". Ma, ed ecco l'anomalia, nell'offerta della Maltauro hanno avuto più peso gli elementi qualitativi "per loro natura soggettivi", quali l'estetica e il pregio, rispetto al prezzo e ai tempi di esecuzione, "che sono invece dati oggettivi". Il punteggio qualitativo era 65 punti, quello quantitativo 35 punti. In sintesi, basta avere dei commissari amici e il gioco è fatto. "Ne abbiamo due su tre", si compiacevano Frigerio e Greganti, al telefono. E lo stesso Maltauro, interrogato dopo l'arresto, ha confermato il sistema. L'urgenza che non c'è. Ma a impressionare l'Authority è l'"emergenza perenne" che tutto giustifica. Perché, per esempio, viene affidato "in deroga" a Fiera di Milano spa l'allestimento, la scenografia e l'assistenza tecnica (2,9 milioni)? "Non si ravvisano evidenti motivi di urgenza - annota Santoro - per un appalto assegnato il 28 novembre scorso, un anno e mezzo prima della data del termine dei lavori". Ancora: con procedura "ristretta semplificata" sono stati dati i 2,3 milioni per il servizio di vigilanza armata a un'Ati (la mandataria è la Allsystem Spa), nonostante quella modalità "è consentita solo per contratti che non superino il milione e mezzo di euro". Sforamenti simili, ma di entità inferiore, sono avvenuti con l'"affidamento diretto", utilizzato 6 volte. "Il tetto massimo ammissibile è 40mila euro", segnala Santoro, ma nella lista figurano i 70mila a un professionista per lo sviluppo del concept del Padiglione 0 e i 65mila per servizi informatici specialistici. Ben 72 appalti sono stati consegnati "senza previa pubblicazione del bando", tra cui figurano il mezzo milione a Publitalia per la fornitura di spazi pubblicitari e i 78mila euro per 13 quadricicli alla Ducati energia, impresa della famiglia del ministro dello Sviluppo Federica Guidi. A Fiera Milano congressi - il cui amministratore delegato era Maurizio Lupi fino al maggio scorso, quando si è autosospeso - viene invece affidata l'organizzazione di un meeting internazionale dal valore di 881mila euro. Anche in questo caso Expo decide di seguire la via della deroga, appoggiandosi a una delle quattro ordinanze della presidenza del Consiglio (il dpcm del 6 maggio 2013). Lo fa in maniera quantomeno maldestra, perché nel giustificativo pubblicato sul sito ufficiale "si rileva un riferimento al comma 9 dell'articolo 4 che risulta inesistente". Un refuso. Il caso Mantovani. Su un caso, la realizzazione della "piastra del sito espositivo", l'Authority si sofferma un po' di più. È l'appalto più consistente, la base d'asta è fissata a 272 milioni di euro. Con un ribasso addirittura del 41 per cento e un offerta di 165 milioni lo ottiene, il 14 settembre di due anni fa, una cordata guidata dal colosso delle costruzioni Mantovani, il cui presidente Piergiorgio Baita sarà arrestato il febbraio successivo nell'ambito di un'inchiesta sul Mose di Venezia. "Con lo stesso aggiudicatario - rileva il garante - Expo ha stipulato però altri due contratti, rispettivamente di 34 milioni e 6 milioni, in opere complementari alla piastra". Un'osservazione che rimane tale, che non arriva ad assumere le forme di una qualche accusa specifica contro la cordata di imprese vincitrici, ma che per Raffaele Cantone (che martedì si incontrerà con Santoro) potrebbe valere un approfondimento. La Pedemontana. Quando l'Authority ha potuto ficcare il naso, sono stati guai. "Solo per la costruzione della Pedemontana - spiegano - non siamo stati esautorati dal nostro ruolo di vigilanza". A marzo del 2013, dopo uno screening dello stato di avanzamento, oltre a segnalare gravi ritardi ha individuato un incremento del costo complessivo dell'opera complementare all'Expo di 250 milioni di euro. Non sarebbe un caso. Nella relazione ispettiva si legge che l'appalto era stato affidato con "elementi oggettivi di distorsione della concorrenza e conseguente alterazione del risultato della gara". In sostanza appalto sbagliato, costi impazziti, autostrada che rischia di non essere mai terminata.
Inchiesta Mose: Renzo Mazzaro e i padroni del Veneto. Un sistema senza controlli. Dove giravano miliardi. Finiti nelle tasche di pochi. Lo scandalo anticipato dal libro di Mazzaro. Brani estratti da I padroni del Veneto (Laterza) di Renzo Mazzaro e pubblicati su “Lettera 43”. Se il project è la finanza privata che soccorre lo Stato senza soldi, il Mose è lo Stato da mungere finché ce n’è. Almeno su questo Baita è d’accordo. Il Mose (acronimo di Modulo sperimentale elettromeccanico) ha due caratteristiche fondamentali. La prima è che, trattandosi di un progetto sperimentale, non ha precedenti: è un prototipo da mettere a punto strada facendo. Questo significa che Mazzacurati, Baita e i loro collaboratori lavorano seguendo il motto dell’Accademia del Cemento fondata a Firenze nel 1657 da discepoli di Galileo: «Provando e riprovando». Con la differenza che Galileo provava e riprovava (bocciava) in laboratorio, mentre l’attuale Accademia del Cemento fa gli esperimenti direttamente in laguna, senza possibilità di correzioni. Si stima che complessivamente verranno annegati in acqua la miseria di 8 milioni di metri cubi di gettata. Una volta messo in opera, il cemento solidifica e non si torna indietro. La seconda caratteristica del Mose è che ha rischio d’impresa zero. Il Consorzio è concessionario esclusivo dell’opera, incassa i finanziamenti dello Stato e li gira alle imprese che eseguono i lavori, le stesse che fanno parte del Consorzio. Su 3.243 milioni finanziati, ma meno di 3 miliardi effettivamente resi disponibili, a fine 2010 il Consorzio aveva messo in gara opere per meno di 10 milioni di euro (9). Chi garantisce il controllo dei costi di questo mostro? Il prezzo chiuso. Per il Mose lo Stato spenderà in ogni caso 4.241 milioni di euro, non un centesimo in più. L’opera dovrà funzionare con questa cifra. La fine dei lavori è indicata nel 2014. Ma il Consorzio rispetterà questo termine? Baita ha una risposta che fulmina l’interlocutore: «No». Come no? «Il Mose è fatto da quattro bocche di porto: quella di Chioggia, quella di Malamocco e quella del Lido che è divisa in due dall’isola artificiale, Lido-San Nicolò e Lido-Treporti. Nella bocca di Lido-Treporti noi cominceremo le prove in bianco, cioè con le paratoie che si alzano, nella primavera del 2013. Naturalmente chiudere una bocca e lasciare aperte tutte le altre consentirà una serie importantissima di prove, test e messe a punto dei metodi di gestione, ma non difenderà certo Venezia dalle acque alte. Quando hai quattro buchi o li chiudi tutti o hai fatto un lavoro inutile. E la chiusura delle altre bocche dipende dall’erogazione dei finanziamenti». Eccoci al collo della bottiglia: l’opera governata dalla spesa deve fare i conti con le casse vuote dello Stato. È il collo della bottiglia o la canna del gas? Cosa succede se lo Stato non scuce il miliardo e mezzo di euro che ancora mancano per completare il finanziamento? Il diabolico Baita ha studiato come uscirne: convertendo la concessione dei lavori in una forma diversa di rapporto, che prevede il subentro del concessionario nella gestione. Lo Stato paga in base al funzionamento dell’opera. «Siamo d’accordo che il Mose deve funzionare? Se lo Stato si indebita per fare il Mose, la cifra è a debito nel momento in cui firma il contratto. Se invece si indebita con qualcuno che gli garantisce la gestione del Mose, il debito nasce anno per anno solo dopo che questi ha dimostrato di poter gestire l’opera. È diverso per lo Stato indebitarsi adesso oppure non avere nessun debito finché io non gli dimostrerò che per un anno ho difeso Venezia dalle acque alte. Il mio debito nascerà per quell’anno dal lavoro che avrò già fatto, non prima che lo faccia. È una conversione del rapporto esistente nel cosiddetto contratto di disponibilità, previsto dalla legge». Con i dovuti adattamenti di interesse, si suppone. 9 Cfr. Gianfrancesco Turano e Alberto Vitucci, Mose, una voragine a Venezia, l’Espresso, 27 dicembre 2010. Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto e ora deputato di Fi, e Giovanni Mazzacurati, allora presidente del Consorzio Venezia Nuova, in un' immagine d'archivio del 12 luglio 2013.
Dove scorrono i soldi. Il partito degli affari. C’è un partito degli affari che controlla gli appalti pubblici indirizzandoli verso i soliti noti? La questione tiene banco per tutto il decennio 2000-2010. Ci sono gli affari, questo è certo. E sono tanti. Un mare di soldi pubblici scorre nel Veneto: solo dal 2006 al 2009 si stima che il mercato delle opere pubbliche regionali valga 2,5 miliardi di euro. Escludendo il Mose, finanziato dallo Stato per oltre 4 miliardi di euro. Escludendo il Passante di Mestre, finanziato a metà fra Stato e Regione, partito con un costo di 650 milioni e arrivato alsaldo con 850. Escluse le Ferrovie, che spendono 2 miliardi per l’Alta Velocità tra Padova e Mestre, unico tratto realizzato per i collegamenti Verona-Padova e Venezia-Friuli, di là da venire, saranno necessari altri 10 miliardi. Escludendo strade, autostrade, porti e aeroporti: solo Veneto Strade spa, che ha ereditato patrimonio e competenze dall’Anas, ha da spendere nei tre anni un miliardo di euro. In questo mare di soldi pubblici navigano pochi operatori privati. Tutti gli altri stanno sulle rive a guardare. I vincitori delle gare sono un numero ristretto di aziende che da sole o in associazione di impresa (Ati) si assicurano le commesse con una frequenza sistematica. Gli appalti variano ma i nomi si ripetono. Contano indubbiamente le capacità, bisognerà mettere nel conto le versioni denigratorie prodotte dall’invidia per il successo altrui. Ma il fatto è sotto gli occhi di tutti: c’è un monopolio che non si spiega con assenza di concorrenza. Nasce da qui il sospetto che il vantaggio acquisito sia frutto non di merito ma di favore. Un privilegio di pochi costruito con i soldi di tutti. Chi parla per primo di un partito degli affari è Massimo Carraro che nel giugno del 2000, da parlamentare europeo dei Ds, pone la questione del finanziamento della campagna elettorale vinta dal presidente Giancarlo Galan contro Massimo Cacciari, candidato del centrosinistra. Una campagna di grande effetto, lanciata già nel dicembre 1999 con manifesti di ogni grandezza su spazi commerciali in tutto il Veneto. L’imponenza dello sforzo e il dispendio esibito colpiscono gli stessi pubblicitari. All’inizio di marzo, prima di entrare sotto il controllo delle leggi elettorali, lo stato maggiore di Cacciari stima che la spesa sostenuta per questo battage oscilli fra i 3 e i 6 miliardi di lire, considerando 30 mila manifesti per 100 giorni di uscita al costo unitario tra 1.000 e 2.000 lire, non precisabile ulteriormente per gli sconti diffusi nel settore. «Cifre fuori da ogni logica», replica il coordinatore regionale di Forza Italia Giorgio Carollo, che riduce la stima drasticamente: «Al massimo avremo speso 30 milioni». Dall’Ulivo gli replica Valter Vanni, capogruppo dei Ds in Regione, sfidandolo al confronto: 21.000 manifesti del centrosinistra affissi su spazi commerciali per 10 giorni (1) sono costati 109.512.000 lire, più altri 10.290.000 per la stampa, fatture saldate da lui in persona. Andando alla ricerca di chi ha sborsato i soldi per la campagna elettorale di Galan, Massimo Carraro cita Enrico Marchi e Giuseppe Stefanel, imprenditori impegnati in una grossa operazione immobiliare a Padova Est, la cosiddetta lottizzazione Ikea. Chiede loro di chiarire pubblicamente «se siano stati, magari a mezzo di loro società, generosi finanziatori della campagna elettorale di Forza Italia». Si becca una querela, non dai due ma da Giancarlo Galan, benché il presidente abbia appena confidato in una cena con gli eletti di Forza Italia - sui Colli Berici, ad Arcugnano, la settimana prima - di aver speso 3 miliardi di lire raccolti anche attraverso sostenitori. A corredo della denuncia, l'avvocato di Galan produce una montagna di documenti sulla base dei quali, sorpresa, il pm padovano Antonino Cappelleri non indaga Massimo Carraro bensì il sindaco di Padova Giustina Mistrello Destro e l'assessore Tommaso Riccoboni, entrambi di Forza Italia. Il contraccolpo è notevole, la procura si trova al centro di reazioni eccellenti. L'indagine prosegue ma non emergono elementi di rilevanza penale. Cappelleri passa all'ufficio di sorveglianza e il pm Matteo Stuccilli, che gli succede, finisce per archiviare. La lottizzazione non subisce rallentamenti. 1 Dal 9 febbraio in poi. I manifesti, 70x100, più piccoli di quelli di Galan, denunciavano l’incompatibilità di Lia Sartori e di Gian Paolo Gobbo ad essere insieme parlamentari europei e consiglieri regionali, cumulando doppi stipendi e doppi vitalizi. Sergio Berlato, che era nella stessa situazione, aveva dato le dimissioni dal Consiglio regionale.
Inchiesta Mose, ritratto dei protagonisti. Galan il doge. Chisso il braccio destro. E l'eminenza Sartori. Il ritratto dei potenti veneti finiti agli arresti nell'inchiesta Mose, scrive Giovanna Faggionato su “Lettera 43”. Trentacinque arresti e un'intera regione che trema. L'inchiesta sul Mose rischia di decapitare la classe dirigente che ha governato il Veneto negli ultimi vent'anni, a partire da Giancarlo Galan, che della Regione è stato tre volte presidente e per cui i magistrati hanno chiesto l'arresto. Sotto indagine sono finiti anche la sua segretaria, Claudia Minutillo, il suo numero due, il sempiterno assessore ai Trasporti Renato Chisso e soprattutto Lia Sartori, appena rieletta europarlamentare per Forza Italia e considerata la grande artefice dell'ascesa di Galan al potere e la sua più fidata consigliera, nonché compagna dello scomparso Vittorio Altieri, fondatore dell'omonimo studio di Thiene che ha progettato molte delle infrastrutture regionali. Al centro dell'inchiesta anche l'imprenditore Pier Giorgio Baita, indagato anche sul caso Expo, e il sindaco del Partito democratico Giorgio Orsoni. Ecco il ritratto di una famiglia allargata che ha comandato sulla Laguna e ora rischia di finirci dentro.
Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto e deputato di Forza Italia. Giancarlo Galan, il re sole del Veneto. Lo chiamano anche il Colosso di Godi, per dire della sua capacità di godersi la vita. Libertario, esponente del partito liberale veneto assieme a Niccolò Ghedini, prima di diventare manager di Publitalia, e infine dirigente di Forza Italia, tre volte governatore del Veneto e ministro. Giancarlo Galan non doveva nemmeno candidarsi a governatore nel 1995, ma riuscì a emarginare gli avversari e a convincere Silvio Berlusconi da poco entrato in politica. Galan ha esercitato sul Veneto un potere indiscusso, grazie soprattutto al sostegno di Lia Sartori, che per anni ne è stata la più fidata consigliera. Nel 2008, non a caso, si è autoproclamato Re Sole, con un libro intervista dal titolo eloquente: Il Nord Est sono io. Nel 2010, lasciò a malincuore la poltrona di Palazzo Balbi al leghista Luca Zaia, che venne sostituito al ministero dell'Agricoltura durante l'ultimo governo Berlusconi proprio dall'ex governatore: una staffetta che a Galan sembra non essere mai andata molto a genio. Il suo è stato il regno delle grandi opere e delle relazioni d'acciaio, anzi di cemento, tra impresa e politica. Oggi è stato chiesto il suo arresto con l'accusa di corruzione. Gli atti ora devono essere tramessi alla Camera, che ha il compito di valutare se dare l’ok al fermo.
Lia Sartori, europarlamentare di Forza Italia. Lia Sartori, la Richelieu di Galan. L'europarlamentare Lia Sartori è stata per anni la vera eminenza grigia della politica di Galan. La sua esperienza a Palazzo Balbi, sede veneziana della Regione, è iniziata nel partito socialista di Bettino Craxi. Tra 1986 e '87 diventò assessore ai Trasporti della Regione, il ruolo che oggi è di Renato Chisso. Utilissima a Galan nel momento in cui l'ex manager di Publitalia dovette organizzare la nuova Forza Italia in Veneto, da allora ne diventò l'ombra, qualcuno dice la vera mente. Lo studio Altieri, che era stato fondato dal suo compagno, fu coinvolto nei grandi progetti infrastrutturali regionali e nella edificazione di molti ospedali. Dopo aver accompagnato il doge padovano alla conquista della presidenza regionale, Sartori si è guadagnata un posto da europarlamentare che ha mantenuto per tre legislature, quattro considerando che nel voto del 25 maggio si è conquistata la riconferma. A Strasburgo Sartori siede nella commissione industria ed energia. Ma la sua influenza sugli affari veneti sembra ancora indiscussa. Ancora nel 2008, il consigliere regionale Raffaele Grazia, parlando delle scelte sulla sanità con un giornalista del gruppo Espresso, ha affermato: «Galan non ha alcuna autonomia (...). È Lia Sartori che sceglie i direttori generali e anche i primari, stabilisce dove si fanno gli ospedali e li progetta o li fa progettare dallo studio Altieri». Lia Sartori si è rivolta al giudice, ma il tribunale per ora ha dato ragione a Grazia considerandola la denuncia di un conflitto di interessi. Il 4 giugno i magistrati hanno chiesto per lei le misure cautelari ai domiciliari.
Renato Chisso, assessore alle Politiche di mobilità e agli Investimenti strategici del Veneto. Renato Chisso, inamovibile assessore alla Mobilità del Veneto. Se Galan è stato il re delle opere pubbliche, Renato Chisso è stato il suo gran ciambelliere, braccio destro per decenni e gran regista degli investimenti pubblici grazie a tre mandati consecutivi come assessore. Eletto per la prima volta consigliere nella prima infornata di uomini di Forza Italia nel 1995 e finito subito nella commissione urbanistica, dal 2000 occupa la poltrona di assessore alla Mobilità e all'Ambiente che significa ovviamente anche infrastrutture. Nel 2005, quando è stato riconfermato, la dicitura si fa ancora più precisa: assessore alle Politiche di mobilità e agli Investimenti strategici. La convivenza obbligata con i leghisti di Luca Zaia non è semplice per la vecchia leva di Forza Italia, ma dopo essere stato il più votato per Fi nella provincia di Venezia, Chisso ha riottenuto puntuale le sue deleghe, con la competenza dunque anche sul Mose. Il 4 giugno 2014 è stato arrestato nell'ambito delle indagini sulla grande opera.
Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia dal 2010. Giorgio Orsoni, un avvocato con la passione per le infrastrutture. Il primo cittadino di Venezia, Giorgio Orsoni, è noto ai più per aver battuto Renato Brunetta nella corsa a sindaco nelle elezioni del 2010. Durante la campagna elettorale veniva presentato soprattutto come un professionista dell'avvocatura, essendo stato presidente dell'Ordine degli avvocati di Venezia e membro del Consiglio Nazionale Forense. Ma nella sua carriera sono molti i ruoli che ha ricoperto nel settore infrastrutture. Dal 1996 al 1998 è stato consigliere del ministero dei Lavori pubblici, dal 1997 al 2003 è stato presidente della Save Spa, la società che controlla l'aeroporto di Venezia, la stessa poltrona dove anni prima si era seduta Lia Sartori. Arrestato il 4 giugno, Orsoni è accusato di aver intascato fondi illeciti dal Consorzio Venezia Nuova, la società del Mose, proprio per la campagna delle Comunali del 2010.
Pier Giorgio Baita, ex amministratore delegato di Mantovani spa e Adria Infrastrutture. Pier Giorgio Baita, nel mirino dei pm dai tempi di Tangentopoli. Il suo nome, come quello di Primo Greganti e di Gian Luca Frigerio, arriva direttamente dalle cronache della Tangentopoli degli Anni 90. Ed è rispuntato nelle indagini sugli appalti per l'Expo. Ex amministratore delegato della Mantovani Spa e di Adria Infrastrutture, era stato indagato anche in un'inchiesta sulle tangenti pagate per l'autostrada Padova Venezia, di cui la Mantovani (in prima fila nella costruzione del passante di Mestre) è terzo azionista. Baita è stato arrestato nel febbraio 2013 per un presunto giro di false fatturazioni, per cui era finita in manette anche la segretaria personale di Galan, Claudia Minutillo, e il responsabile amministrativo della Mantovani Niccolò Buson. Da allora gli arrestati hanno raccontato molte cose ai magistrati. Per esempio, la segretaria Minutillo ha spiegato che fu Galan a farle conoscere William Colombelli, presidente della Bmc Broker, la società di San Marino attraverso cui sarebbero passati i fondi neri. L'incontro sarebbe avvenuto a casa di Niccolò Ghedini, padovano come Galan, suo amico di lunga data e compagno di partito dai tempi dei liberali e poi in Forza Italia. Ghedini è stato anche l'avvocato di Baita, assieme all'altro legale di Silvio Berlusconi e suo socio professionale, Piero Longo. Dopo tre mesi e mezzo di carcere però, a giugno 2013, l'imprenditore ha deciso di cambiare difensori e strategia: ha scelto l'avvocato Alessandro Rampinelli e ha iniziato a parlare. Gli arresti di oggi arrivano con tutta probabilità anche dalla sua testimonianza.
Galassia Galan. Ripubblichiamo l'articolo uscito sul numero 48 dell'Espresso del 2006 in cui veniva anticipato tutto il sistema do potere dell'allora governatore della regione e dove compaiono molti dei personaggi coinvolti nell'inchiesta sul Mose, scrive Gigi Riva su “L’Espresso”. Giancarlo Galan Sulla vetta dell'Olimpo c'è il governatore Giancarlo Galan, "GG", il Doge. Sta lì piantato come un «colosso di Godi» (è alto un metro e 90) da quasi 12 anni. Da quando, cioè, Silvio Berlusconi lo trasformò da venditore di Publitalia nella punta di lancia di Forza Italia nel Nordest. Dicono i biografi che ormai si disinteressa o quasi delle terrene vicende, dedito com'è a inseguire le sue passioni: pesca d'altura al tonno, buen retiro nel cason in Laguna e ora nella reggia campestre di Cinto Euganeo, ozi sul litorale istriano nella casa sul mare della Serenissima Rovigno. L'unico uomo, forse, a cui i veneti non rinfacciano la scarsa propensione al lavoro, tanto da avergli cucito il nomignolo quasi affettuoso di «fancazzista di successo». Ha 50 anni, la sua compagna Sandra Persegato 33, fra poco gli darà un figlio e ha promesso/minacciato di ritirarsi. Se si potrà dedicare ai suoi lussuosi hobby e alle gioie della paternità lo si deve a due motivi: può campare di rendita perché dall'esperienza politica esce più ricco (e lo vedremo) a scorno delle sue lamentazioni per le quali ci avrebbe rimesso; ha messo in piedi una macchina ben oliata che ormai funziona da sola. Poche persone fidate che compongono il sistema. I potenti del Veneto. Un gradino sotto la vetta dell'Olimpo stanno in tre. Enrico Marchi, coetaneo del governatore e come lui nato nel Partito liberale (corrente Altissimo, Galan stava con Biondi), amico di vecchia data, premiato con la presidenza della Save, la società che controlla l'aeroporto di Tessera, il terzo in Italia per volume di traffico. Uno che un giorno si era messo in testa l'idea meravigliosa di assaltare la Gemina, mettere sotto scacco Cesare Romiti, e impadronirsi degli Aeroporti di Roma salvo fallire e battere in ritirata. E poi due ex socialisti convertiti sulla via di Arcore, more solito, come la potentissima eurodeputata di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio regionale Amalia Sartori detta Lia, 58 anni, già compagna di Vittorio Altieri, un ingegnere morto tre anni fa e che con Galan condivideva le scorribande in Adriatico, titolare dell'omonimo studio di progettazione. O come Renato Chisso, piazzato nello strategico assessorato alle Politiche della mobilità e infrastrutture. Traduzione: appalti. Ci sarebbe poi un altro uomo di fiducia, il portavoce, quel Franco Miracco, ex giornalista del "Manifesto", che si occupa però di un settore impalpabile come la Cultura, tanto da essere indicato come l'assessore-ombra (Galan si è tenuto quella delega). Ma quella è un'altra storia. Il livello politico di chi conta, termina, più o meno, qui. Cerchia ristretta. Come ristretta, ristrettissima, è la cerchia delle aziende (livello economico) che fa man bassa degli appalti pubblici. Anche se non sempre presentano le offerte più vantaggiose, anche se variegati sono i campi d'azione. Dalla sanità alle strade, il risultato non cambia, vincono sempre loro. Perché, adesso, non basta ribassare l'offerta, il punteggio complessivo si basa su valori assai più discrezionali come l'affidabilità e la qualità, i veri cavalli di Troia per eventuali favoritismi. Studio Altieri, Mantovani costruzioni e Gemmo impianti, queste tre vincono sempre (sono, per inciso, le stesse tre che hanno acquistato ampie pagine pubblicitarie della pubblicazione monografica "Il Veneto ha cambiato strada" supplemento della rivista "Tempi" e agiografia della giunta). Spesso in cordata con le cooperative, a quote minime. Perché il sistema Veneto del nuovo Doge non è poi così dissimile a quello della vituperata Prima Repubblica e per la pace sociale si accontenta anche la tanto odiata sinistra. Le aziende sempre vincenti bisogna vederle da vicino e congratularsi perché risultano sempre le migliori. Cominciamo dalla Gemmo impianti di Arcugnano (Vicenza), già devastata da Tangentopoli. Figura nell'elenco, guarda caso, dei finanziatori della prima campagna elettorale di Galan, quella del 1995 con la cifra più alta: 10 milioni, allora si ragionava in lire. Il capostipite è conoscente di vecchia data di Lia Sartori. La figlia, Irene, è invece buona amica del governatore che non ha esitato, qualche mese fa, a piazzarla a capo di Veneto Sviluppo, la Finanziaria regionale, nonostante la sua azienda concorra e come nelle gare della Regione. E se non c'è una incompatibilità giuridica, ce n'è una morale. Ma qualunque richiamo al conflitto di interessi non trova orecchie nel partito azzurro. Dopo una storica vocazione negli impianti di illuminazione, la Gemmo è stata folgora dalla sanità, che significa due terzi del bilancio regionale. Da sola o associata con altri, fa la parte del leone per la fornitura di energia a Dolo-Mirano, Bassano, Arzignano, Cittadella, Verosa Usl e Verona ospedale. Contratti milionari che durano, in alcuni casi fino al 2015. E aggiudicati con criteri che il nuovo assessore, il leghista Flavio Tosi, ha trovato quantomeno discutibili, tanto da proporre una delibera con la quale si istituisce l'obbligo di bandire gare al massimo ribasso ogni volta che è possibile e comunque di riconoscere al prezzo un peso di almeno il 60 per cento nel giudizio complessivo. In modo da evitare (è successo a Verona) che una ditta di pulizie vinca col 36 per cento di rialzo. Galan avrebbe commentato che era ora che i direttori generali fossero messi sotto controllo. E c'è da chiedersi dove stesse lui quando erano fuori controllo. Ma torniamo alla Gemmo. Gli ospedali, se è redditizio gestirli, immaginarsi cosa significa costruirli. A Schio e Thiene (Alto Vicentino) ce ne sono due a distanza di una manciata di chilometri. Stando a uno studio dell'ingegner Gianni Plicchi di Bologna, l'ammodernamento dell'esistente costerebbe 63 milioni di euro. La giunta Galan ha bocciato la soluzione per privilegiare un'altra via: un terzo ospedale da edificare ex novo a Santorso, località baricentrica, al costo di 143 milioni, più del doppio, 72 dati dal pubblico e il resto con un project financing promosso - c'erano dubbi? - dalla Gemmo, unitamente allo studio Altieri e alla Serenissima ristorazione. Il Doge in persona aveva tuonato in commissione durante uno dei vari passaggi burocratici: «Signori, chi vota contro lo metto sulla lista nera». Meglio non mettersi contro l'invincibile armata degli amici del governatore che, del resto, avevano già sperimentato con successo la formula del project financing per l'ospedale di Mestre, affare da 220 milioni di euro di cui 80 a carico dello Stato e 10 della Usl competente. In cambio dello sforzo dei privati, la concessione dei servizi per una durata di 24 anni e un valore stimato in 1,26 miliardi di euro. Una concessione che comprende anche i servizi tecnico-amministrativi di supporto alle attività di radiologia, laboratorio e neuroradiologia. E poi parcheggi, servizi alberghieri, ristorazioni. Con tanti saluti al rischio d'impresa. C'è sempre da guadagnarci se di mezzo c'è il pubblico. Chi promuove un project financing difficilmente si vede sfuggire l'appalto durante una gara. Perché ha studiato la materia e perché agli eventuali concorrenti viene dato sempre meno tempo. Per la Pedemontana veneta, 64 chilometri da costruire tra l'interconnessione con la A13 Valdastico e la A27 Mestre-Belluno, affare quantificato in 2,3 miliardi di euro di cui 243 milioni a contributo pubblico, il bando è stato reso pubblico il 10 novembre scorso e scadrà il 12 dicembre alle ore 12. Poco più di un mese per studiarsi un'opera complessa. Logico che vincerà il gruppo del "project". Ma da chi è composto? In origine furono le banche. Man mano che si avvicinava il momento di aprire i cantieri ecco che le quote sono passate di mano e compaiono i costruttori. Dall'Impregilo fino ai soliti noti Gemmo, studio Altieri e Mantovani costruzioni. Chi si prende i lavori avrà un contributo pubblico per i prossimi 30 anni col seguente meccanismo: se i pedaggi non garantiranno un introito congruo, se cioè transiteranno sull'arteria meno di 840 milioni di veicoli l'anno, la Regione verserà un contributo di 10,2 milioni di euro ogni sei mesi. Se ne passeranno di più, calerà il contributo in proporzione. Nella Pedemontana, come in tutte le grandi opere, è presente la Mantovani dell'ingegner Piergiorgio Baita, pure vecchia conoscenza di Tangentopoli (assolto, giusto precisarlo). Fa la parte del leone nel Mose, la mastodontica opera che dovrebbe salvaguardare Venezia dall'acqua alta, costo 4,3 miliardi di euro, quasi una Finanziaria da tempi normali. Naturalmente ha i suoi uomini impegnati sui cantieri del Passante di Mestre, l'opera più attesa del Nordest, 750 milioni di euro, 32 chilometri da inaugurare nel 2008 se tutto andrà bene. Dentro c'è anche la Gemmo, of course. Che pure era stata capofila, con grande arrabbiatura dei concorrenti, per la terza corsia dinamica della Tangenziale di Mestre quando non aveva alcuna esperienza in fatto di strade. Sarà utile far notare che, anche per il Passante, non è mai stato preso in considerazione un progetto meno oneroso di una società norvegese che prevedeva un tunnel. L'elenco potrebbe proseguire all'infinito. La Mantovani si è aggiudicata due lotti del nuovo Piano acquedotti (progetto Altieri), del valore complessivo di 300 milioni e la rete di distribuzione del degasificatore. Per non dire del piano integrato Fusina, un complesso sistema di depurazione (500 miliardi di vecchie lire). Attorno, naturalmente, una rete di aziende satellite che ci campano, mentre le altre sono perennemente escluse. E cominciano ad arrabbiarsi, fanno sapere che la misura è colma. Per ora fanno ammissioni a mezza bocca e lasciano trapelare qualche dato oggettivo su cui riflettere. C'è un'azienda che, svenandosi, aveva ribassato fino all'11 per cento l'offerta per ammodernare la linea ferroviaria Adria-Mestre (21.047.404,72 euro) e si è vista sorpassata da un gruppo concorrente (dentro c'è la Gemmo) che aveva ribassato molto meno (attorno al 2 per cento), ma aveva fatto razzia di tutti i punti qualità e affidabilità. C'è un grossista di frutta e verdura che ha perso l'appalto con l'Usl malgrado non abbia avuto alcuna contestazione negli anni di onorato servizio e fosse previsto un congruo punteggio per la vicinanza: è stato battuto da un concorrente milanese. E c'è la fila alla sua porta, giura Giorgio Carollo, ex coordinatore regionale di Forza Italia silurato dalla coppia Sartori-Galan e ora impegnato a rifondare il Grande Centro, «di imprenditori che non ne possono più». Aggiunge: «Solo che io mi sono stufato, invece di lamentarsi con me, andassero dai giudici se hanno qualcosa da denunciare». Carollo avrà anche il dente avvelenato, però esprime un disagio riscontrato e pensa gli tocchi un compito: «Cambiamo noi la classe dirigente prima che ci pensi la magistratura». Galan ha promesso che se ne andrà da solo. Del resto ora tiene famiglia e, prima, ha piazzato già amiche e segretarie, da signore sensibile al fascino femminile. Irene Gemmo alla finanziaria regionale il colpo più grosso. L'ex segretaria Lorena Milanato in Parlamento, l'ex segretaria Barbara Degani in consiglio regionale. Un'altra ex segretaria, Claudia Minutillo, è stata oggetto di un'interrogazione diessina perché a lei farebbe capo la BMC Broker di San Marino cui sono stati riconosciuti finanziamenti regionali. Per non dire della sorella della morosa, Carla Irene Persegato, giunta prima tra varie ironie a un concorso da tecnico comunale a Monselice dopo aver sbaragliato 80 concorrenti tra cui un geometra che da cinque anni lavorava in quell'ufficio con contratti a termine. A Galan stesso non è andata male. Nel modello 740 dell'anno precedente la prima elezione aveva dichiarato 202 milioni di vecchie lire e una proprietà a Milano. Da allora ha sempre denunciato solo lo stipendio da presidente, 140 mila euro lordi. Il che non gli ha impedito un tenore di vita esagerato e una serie di acquisti che vorrebbero ben altro reddito. La nuda proprietà di un appartamento a Milano; un'imbarcazione a motore Boston Whaler Walk Around anno 1991; una imbarcazione a motore Whaler 28 Conquest del 2001; 15.247 azioni ordinarie di reti bancarie. Risulta amministratore unico e titolare al 100 per cento di una società con sede a Rovigno (Croazia) con capitale sociale di 1.173.000 kune (al cambio attuale un euro è uguale a 7,3 kune). C'è da aggiungere la favolosa villa di Cinto Euganeo. A chi gli chiede conto di tanta sproporzione tra reddito e proprietà risponde sbrigativo di essere «ricco di famiglia». Il padre Nelson era uno stimato primario radiologo di ospedale pubblico a Padova e doveva mantenere moglie e tre figli.
Chi è Giorgio Orsoni, il sindaco sotto accusa. Un professionista di prim'ordine, non un politico puro. Ambizioso e non amato da tutti, scrive Guido Moltedo su “Europa Quotidiano”. Giorgio Orsoni abita a San Silvestro, proprio dirimpetto a Ca’ Farsetti che con Ca’ Loredan è la sede del comune di Venezia. Una sola fermata di vaporetto e attraversi il Canal Grande. Ma il sindaco preferisce di solito usare il motoscafo di servizio per andare nel suo ufficio, pareti di raso rosso veneziano, arredo di eleganza solida e sobria, lo stile degno di una città che fu la Serenissima. Una mattina incontra un ex assessore mentre sta per salire sul motoscafo, e quasi si giustifica: «Sai, in vaporetto mi vedono, mi riconoscono e cominciano a chiedere, a far domande, a lamentarsi…». Se l’incontri nelle calli, dalle parti del suo studio di avvocato ai Tolentini, zona stazione, lo vedi d’inverno col cappello calato giù, il bavero alzato, a passo spedito, immerso nei suoi pensieri o affiancato da un collaboratore. Dicono che Orsoni sia snob. In realtà, è schivo. Riservato. Ma affabile. Cortese. Pronto all’ascolto. Certo, Orsoni non è come Cacciari, che da sindaco andava in vaporetto o a piedi, che parlava con la gente, che era capace di inveire contro il turista reo di dar mangime a un piccione o di fare picnic in calzoncini sui gradini di una chiesa. Infatti Cacciari, che pure nel suo ultimo mandato non ha fatto faville e ha lasciato un po’ di rogne al suo successore – Orsoni, appunto – resta un beniamino a Venezia, mentre Orsoni ha sempre faticato a far breccia tra i suoi elettori veneziani, ancora più tra quelli di Mestre e della terraferma, l’altra metà e più della città di Venezia. Non per ragioni politiche, ma perché dà l’impressione di fare il sindaco con riluttanza, come facesse un sacrificio a svolgere pienamente la sua “missione”, che non è solo amministrativa, ma anche, spesso soprattutto, un’attività di relazioni, di rapporti, di vita tra la gente. Qui è la differenza sostanziale tra un politico di professione e un professionista prestato alla politica. L’altra differenza è che da un politico-politico ti aspetti, di questi tempi, che prima o poi venga fuori qualcosa di losco. Da uno col “profilo” di Orsoni non te l’aspetti. Infatti, a Venezia, nel giro delle persone che lo conoscono bene, sono certi che ne uscirà bene, da quest’inchiesta. E lo pensa anche un collega autorevole come Piero Fassino, presidente dell’Anci, che ha avuto modo di lavorare con lui. «Chiunque conosca Giorgio Orsoni e la sua storia personale e professionale – ha detto il sindaco di Torino, immediatamente dopo la notizia del suo arresto – non può dubitare della sua correttezza e della sua onestà. Siamo sicuri – ha aggiunto Fassino – che la magistratura, nel compiere gli accertamenti successivi, giungerà rapidamente a stabilire la verità dei fatti, consentendo così ad Orsoni di ritornare alla sua funzione di sindaco di Venezia». Quest’ultimo punto è invece discutibile. L’arresto, anche se si rivelerà ingiusto, è considerato in città uno stop alla sua carriera di primo cittadino. Nel frattempo è già in moto la macchina dell’insulto su Facebook. Ed è scattato il prevedibile tormentone del “rinnovamento” di una classe dirigente invischiata in affari e intrecci opachi e sospetti. Per come è fatto Orsoni, se effettivamente uscirà bene dalla vicenda, si può perfino pensare che ne faccia un punto d’onore, quello di ritornare a Ca’ Farsetti e anche di ricandidarsi il prossimo anno per un secondo mandato. Una prospettiva, quella della ricandidatura, che non si sa se l’avesse in mente o meno. Questi quattro anni sono stati per lui molto duri, ci sono stati momenti in cui avrebbe voluto perfino lasciare, altri in cui si è sentito sfidato e ha provato gusto a rilanciare. Gli amici si dividono tra chi prevede che la vicenda, comunque si concluda, lo stacchi, nauseato, dalla politica, e chi pensa che la vivrà come una sfida. Sessantasette anni, ordinario di diritto a Ca’ Foscari, titolare di uno studio “ereditato” dal grande amministrativista Feliciano Benvenuti, il placido Orsoni sconfisse sonoramente, al primo turno, il pirotecnico Renato Brunetta l’8 aprile 2010. Arrivava a Ca’ Farsetti dopo Massimo Cacciari e dopo Paolo Costa, con cui era stato assessore al patrimonio. Alle sue spalle, oltre l’attività prestigiosa di avvocato, incarichi di peso in città, tra cui quello di Primo procuratore di San Marco. Di fronte aveva invece una città problematica e un comune con le casse pressoché vuote, soprattutto per via della crisi del Casinò, una vera miniera di finanziamenti che nessun’altra città italiana ha, e l’esaurirsi dei fondi speciali. Il nuovo sindaco ereditava in compenso problemi complicati, tipici di una città unica come Venezia, più grane antipatiche, dal ponte di Calatrava al “buco” del palazzo del cinema al Lido, dal passaggio delle grandi navi alla gestione di un turismo pervasivo e prepotente. Senza contare che ormai il grosso di Venezia è in terra ferma, Mestre e Marghera, a loro volta alle prese con la questione della deindustrializzazione e dell’immane impresa del risanamento ambientale. E lui, veneziano, la passione per il mare e per la vela, fa spesso fatica a sintonizzarsi con i mestrini e le loro lagnanze contro l’eccesso di attenzione per Venezia. «Sono così. Sono moderato, riflessivo e razionale», disse di sé a Manuela Pivato della Nuova Venezia, che gli dedicò un ritratto poco dopo la sua elezione a sindaco. “La sua forza tranquilla – scriveva la giornalista – l’ha portato negli anni esattamente dove voleva, e forse anche un po’ più in là, al punto da consacrarlo come uno degli uomini più “incaricati” della città: avvocato, professore di Diritto amministrativo a Ca’ Foscari, Procuratore di San Marco, ex presidente di Save Engineering, vicepresidente della Fondazione Cini, presidente dell’assemblea dell’Oua (il sindacato degli avvocati), presidente della Compagnia della Vela e in più solido borghese, cattolico, buona forchetta, gran bevitore di thè caldo sia d’estate che d’inverno, amante dei libri di storia, velista e padre di tre figli uno più bravo dell’altro, tutto in un sol uomo». Il sogno di Orsoni andava in realtà oltre Venezia. Si dice che coltivasse il desiderio di un incarico a Roma, che pensasse a un ministero o un posto di sottosegretario che si occupasse delle città metropolitane. Da sindaco, negli ultimi due anni, è diventato il massimo esperto della questione, e ha lavorato intensamente a quest’idea, immaginando una grande città metropolitana che tenga insieme Venezia, Padova e Treviso. Ci ha creduto, ed è un progetto ambizioso, importante per il Nordest, ma che fatica a farsi strada. In Orsoni aveva trovato un propulsore convinto. Peccato, anche per questo, se il suo percorso politico si debba ora davvero fermare.
Tangenti Mose, Massimo Carlotto: «Il Nord è più criminale del Sud». Tangentopoli in Veneto. Lo scrittore Carlotto: «All'estero ci studiano come laboratorio della nuova malavita economica». Intervista di Gabriele Lippi su “Lettera 43”. Chi ha letto i suoi libri, probabilmente, nella mattinata di mercoledì 4 giugno 2014 è rimasto meno stupito di altri. Di intrecci tra criminalità e politica in Veneto, Massimo Carlotto ne aveva parlato anni prima che lo scandalo Mose scoppiasse coinvolgendo il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, l'assessore regionale alla Infrastrutture Renato Chisso e l'ex governatore, ora deputato di Forza Italia, Giancarlo Galan. «NORD PIÙ CRIMINALE DEL SUD». Nessuna sorpresa dunque per Carlotto, che a Lettera43.it spiega come questo sistema fosse «evidente da tempo», e racconta come, ormai, «il Nord è ben più criminale del Sud» e viene studiato nelle università straniere «come il laboratorio della nuova criminalità economica». Una situazione riemersa con prepotenza dalle acque torbide dei canali veneziani. Massimo Carlotto, scrittore nato a Padova.
DOMANDA. Politica, malaffare, criminalità. Quello scoppiato a Venezia sembra un romanzo di Carlotto.
RISPOSTA. Devo dire che questo l'avevo raccontato in Alla fine di un giorno noioso.
D. Sapeva già tutto?
R. In Veneto si aspettava da tempo questa azione della magistratura, il sistema era evidente, era stato messo a nudo dai comitati sul territorio.
D. Come si sapeva?
R. Le denunce sono state fatte nel corso degli anni in un silenzio assordante e nella protervia con cui i politici coinvolti rispondevano alle domande dei comitati. La battaglia è stata gestita da una minoranza forte e agguerrita del Veneto. Ora, finalmente, il territorio può tirare un sospiro di sollievo.
D. Corruzione e politica. Cosa sta succedendo al Veneto?
R. Nulla di nuovo. Questo è un sistema che ha governato la Regione per moltissimi anni. Ci sarà un motivo per cui nelle università straniere il Nord Est italiano è studiato come il laboratorio della nuova criminalità economica. Si è creata una connessione tra la criminalità e tre ambienti fondamentali della società: imprenditoria, politica e finanza.
D. E da questa unione cosa è nato?
R. Un sistema che ha permesso nel passato grandi accumulazioni di capitale che poi si sono riversate in tutti questi agganci nel mondo dei grandi appalti. Ma si tratta di una situazione definita ormai da tempo.
D. Quello del Nord Est virtuoso e motore dell'economia italiana è un falso mito, dunque?
R. Il mito è dovuto anche al fatto che ci sono stati moltissimi imprenditori onesti che hanno creato un sistema economico vincente. Poi si sono infilati anche quelli che hanno accumulato grandi ricchezze evadendo sistematicamente le tasse, con il lavoro nero, con lo smaltimento illegale dei rifiuti industriali.
D. La superiorità morale del Nord vantata dalla Lega non esiste?
R. Lo dico da moltissimo tempo che il Nord è ben più criminale del Sud, perché i veri affari avvengono qui. Bisogna dire la verità anche sui tempi in cui le mafie si sono insediate in Settentrione. La 'ndrangheta è arrivata a Torino nel 1964. È l'Italia nel suo complesso che ha un sistema criminale di cui bisogna liberarsi al più presto.
D. L'inchiesta sul Mose andava avanti da anni, ma si aspettava uno scandalo di tali proporzioni?
R. Mi sorprende solo il coinvolgimento del sindaco di Venezia. Gli altri nomi circolavano da tempo nell'ambito delle indagini e tra coloro che si occupavano di queste cose.
D. Il sindaco di Venezia, un assessore regionale, l'ex presidente della Regione. Uno scandalo bipartisan. La politica veneta è tutta da rottamare?
R. Esiste anche una parte della politica onesta, anche in senso bipartisan. C'è però un sistema che ha governato il Veneto per tantissimi anni e che ora deve essere debellato completamente. Ma poteva essere fatto prima.
D. In che senso?
R. Si sta facendo ora un'opera di pulizia che prima della magistratura toccava alla politica. Agli elettori. Il sistema politico era evidente, ma si è preferito mantenerlo perché era fortemente ancorato a quello economico.
D. Come si spiega il ritorno forte della magistratura sugli appalti?
R. Credo che siano cambiati anche gli equilibri politici, in particolare per quanto riguarda il Veneto. Pensare che il lavoro dei magistrati non sia influenzato da queste cose significa non essere ancorati alla realtà. D'altra parte gli appalti sono diventati un'occasione di riciclaggio del denaro sporco per la criminalità organizzata.
D. Come mai proprio gli appalti?
R. Quando la criminalità ricicla su attività normali non c'è guadagno, c'è una perdita che la guardia di finanza calcola intorno al 30%. Investendo in attività pubbliche, invece, la criminalità riesce anche a guadagnare sui soldi che investe, oltre a riciclarli.
D. Per Galan c'è una richiesta d'arresto. Pensa che il parlamento darà l'ok?
R. Questo non lo so ed è difficile dirlo. Quello che secondo me è politicamente importante è la dimensione complessiva dell'inchiesta per cui il sistema nel suo complesso è stato messo a nudo.
D. Sembra anche qualcosa che va oltre Tangentopoli. Tra gli indagati ci sono magistrati, ex generali della guardia di finanza. La criminalità si insinua ovunque.
R. Questo è il dato della mutazione antropologica di questa società. La dimensione dell'agire criminale è di una illegalità diffusa che ha contagiato nel suo complesso la società.
D. Cioè?
R. Non c'è aspetto che non sia toccato o influenzato da queste forme illegali. Niente di cui stupirsi in un Paese in cui la corruzione aumenta del 100% ogni anno.
D. Se fosse un libro di Carlotto come andrebbe a finire?
R. Arriverebbe qualcuno che mette tutto a tacere, come successo con Tangentopoli. Si sono accordati sul 10% di tangente e tutto è continuato nella normalità, fino allo scandalo successivo. In questo Paese gli scandali sono serviti spesso a sanare le contraddizioni. Questo è un po' diverso, ma non bisogna abbassare la guardia per il futuro.
D. Insomma, il lieto fine c'è solo per i cattivi della storia.
R. Esattamente.
Basta sdegno e chiacchiere. Trentuno anni e costi quadriplicati. Quando diremo basta alle mazzette? Per il Mose ci sono voluti nove volte i tempi del colossale ponte di Donghai, scrive Gian Antonio Stella su “Il Corriere della Sera”. «Votatelo, pesatelo, se sbaglia impiccatelo», diceva un antico adagio veneziano. Certo, se anche le accuse contro Giorgio Orsoni, Giancarlo Galan e gli altri politici e affaristi coinvolti nell’inchiesta trovassero conferma nei processi e nelle sentenze, nessuno pretende corda e sapone. Il quadro di corruzione disegnato dai giudici, però, è così vasto da imporre finalmente una guerra vera, non a chiacchiere, contro la mazzetta. L’«affare» del Mose è esemplare. Perché c’è dentro tutto. C’è dentro lo spaccio dell’«emergenza», dei lavori da fare a tutti i costi in tempi così drammaticamente rapidi da non consentire percorsi lineari nei progetti, nella scelta degli esecutori, nelle gare d’appalto, nelle commesse. Risultato: di fretta in fretta sono passati 31 anni, nove volte di più di quelli bastati alla Cina per fare il ponte di Donghai, che coi suoi 32 chilometri a 8 corsie sul mare collega Shanghai alle isole Yangshan. C’è dentro l’idea della scorciatoia per aggirare (non cambiare: aggirare) le regole troppo complicate con la creazione d’un concessionario unico, il Consorzio Venezia Nuova che, dopo tre decenni passati senza lo straccio di una concorrenza e dopo essere stato così pesantemente coinvolto negli scandali coi suoi massimi dirigenti, giura oggi d’essere estraneo alle brutte cose e pretende di presentarsi come una verginella al primo appuntamento. C’è dentro quel rapporto insano tra la cattiva politica e il cattivo business così stretto da chiudere ogni spazio ai controlli veri sui costi, sui materiali, sugli uomini, sui tempi. Basti ricordare l’impegno preso dall’allora vicepresidente del consiglio Gianni De Michelis il 4 novembre 1988, quando dopo anni di tormentoni fu presentato il prototipo del Mose: «La scadenza? Resta quella del 1995. Certo, potrebbe esserci un piccolo slittamento...». Sono passati quasi vent’anni, da quella scadenza: ci saranno anche stati degli intoppi, ma cosa succederebbe, in Germania o in Olanda, se lo Stato si sentisse preso per i fondelli sui tempi in modo così sfacciato? E cosa direbbero i leghisti da tre lustri al governo del Veneto se un cantiere interminabile come quello del Mose fosse ancora aperto dopo tanti anni a Reggio Calabria o a Napoli? C’è dentro il disprezzo per i pareri discordanti e più ancora, alla faccia del chiacchiericcio federalista, per le opinioni del Comune, tagliato fuori da decisioni prese altrove: «Sinistra e destra, sul Mose, erano d’accordo, e io sono rimasto inascoltato», ha accusato più volte, negli anni, Massimo Cacciari. Ieri l’ha ripetuto: «Le procedure erano tali che da sindaco io non potevo toccare palla». Una linea verticistica che la Serenissima non avrebbe accettato mai. Al punto di pretendere, se c’erano di mezzo opere idrauliche, che oltre a quello degli ingegneri si sentisse il parere di «otto pescadori» e cioè «due da S. Nicolò, uno da Sant’Agnese, uno da Muran, due da Buran e due da Chiozza». E poi c’è dentro, in questa brutta storia, il continuo rincaro delle spese, la peste bubbonica delle nostre opere pubbliche: doveva costare un miliardo e trecento milioni di euro attuali, il Mose. E di anno in anno, di perizia in perizia, di furbizia in furbizia, ha sfondato i cinque miliardi e non è detto che ne basteranno sei. C’è dentro la blandizia verso i possibili «amici» e insieme l’insofferenza arrogante verso ogni critica, come nel caso della stupefacente querela per «accanimento mediatico» (avevano dato battaglia sui giornali) contro Vincenzo Di Tella, Paolo Vielmo e Giovanni Sebastiani, tre ingegneri rei di avere criticato il costosissimo progetto delle paratie mobili, la gallina dalle uova d’oro del consorzio. C’è dentro la ripartizione di incredibili privilegi, come ad esempio, per citare le Fiamme Gialle, «il compenso di un milione di euro riconosciuto nel 2009» all’allora presidente Giovanni Mazzacurati «a titolo di “una tantum”, nonché i periodici rimborsi spese privi di giustificazione contabile», per non dire delle case affittate in California, delle consulenze distribuite ad amici e parenti o della liquidazione finale di 7 milioni di euro incassata dopo l’arresto: l’equivalente di trentuno anni di stipendio del presidente della Repubblica. Una buonuscita stratosferica, per un uomo finito in manette. E tutti soldi pubblici. Sia chiaro. Tutti soldi privatamente gestiti come in una combriccola di società private ma tirati fuori dalle tasche degli italiani. Per amore di Venezia. Per salvare Venezia dall’acqua alta dovuta non solo ai capricci della Natura e del Fato ma anche a interventi come la cosiddetta «sussidenza», cioè lo sprofondamento del suolo dovuta al pompaggio dell’acqua dolce nel sottosuolo o la creazione del canale dei petroli, un canyon lungo 14 chilometri, largo 200 metri e profondo fino a 17, scavato nel ventre di una laguna delicata la cui profondità media era di 110 centimetri. E torniamo al rispetto per l’acqua, la terra, le barene della Serenissima Repubblica. «Tre condition de homeni ruinano la Laguna: li Signori, li Inzegneri e li Particulari», cioè i proprietari, scriveva nel ‘500 il Magistrato alle acque Cristoforo Sabbadino. Scordava gli affaristi dell’appalto facile. Quelli della spartizione fra sodali. Che non guardano alla destra o alla sinistra ma al business. O, per dirla alla veneta, ai «schei». Montagne di «schei». Certo è che quest’ultima ondata di arresti colpisce i cittadini italiani, proprio mentre mostravano di voler credere in un riscatto e in una nuova speranza, come una frustata in faccia. E dimostra che, nella scia dei moniti di papa Francesco che batte e ribatte contro il «pane sporco» del «dio tangente», è indispensabile una svolta vera. Nei fatti. L’Expo 2015, i restauri a Pompei, il G8 alla Maddalena e poi all’Aquila, i primi interventi e poi la ricostruzione in Abruzzo, i Mondiali di nuoto, il Mose... Non c’è Grande Evento, da anni, che non sia infettato dalla corruzione. E dopo ogni arresto, lagne su lagne. E tutti a chiedersi come sia possibile, come mai non cambi mai niente, perché proprio qui e bla bla bla... Poi, passata la tempesta di sabbia, appena si posa la polvere, le leggi che parevano ur-gen-tis-si-me vengono rinviate dal lunedì al martedì, poi alla settimana dopo, poi al mese seguente, poi all’autunno e da lì all’estate successiva... Eppure è tutto chiaro: per vent’anni, come denunciano don Luigi Ciotti, Piercamillo Davigo e tanti altri, ogni sforzo della cattiva politica (troppo comodo dare tutta la colpa ai berlusconiani) è stato dedicato a smontare le leggi che c’erano e a buttare bastoni tra le ruote dei giudici. Pochi numeri: nel decennio dopo la stagione di Mani Pulite, 1996-2006, secondo l’Alto Commissariato, le condanne per corruzione precipitarono dell’83,9%, quelle per concussione del 90,4%, quelle per abuso d’ufficio del 96,5%. Come mai? Perché l’Italia è più pulita? Magari! L’abbiamo scritto ma vale la pena di ripeterlo: dice il rapporto 2013 dell’Institut de criminologie et de droit pénal curato dall’Universita di Losanna, che nelle nostre carceri solo 156 detenuti, lo 0,4% del totale, sono lì per reati economici e fiscali, tra cui la corruzione e la concussione. Una percentuale ridicola. Dieci volte più bassa rispetto alla media europea del 4,1%. È una coincidenza se la Germania, il Paese di traino del Continente, ha le galere più affollate di «colletti bianchi»? Ed è solo una coincidenza se noi, che arranchiamo faticosamente in coda, ne abbiamo 55 volte di meno?
Dopo i «100 motivi per amare l’Italia». Ecco (almeno) 10 motivi di vergogna. L’amore per il nostro Paese non cambia ma vicende come quella di Venezia (Mose), o di Genova (Carige) e Milano (Expo), impongono una riflessione, scrive Beppe Severgnini su “Il Corriere della Sera”. Abbiamo appena pubblicato su Corriere.it «100 buoni motivi per amare l’Italia». Sono stati tradotti in inglese, spagnolo e francese. Vicende come quella di Venezia (Mose), Genova (Carige), Milano (Expo) - tanto per restare alla cronaca di questi giorni, e restare lontani dalle paludi romane e dai buchi neri del sud - non ci fanno cambiare idea. Ma onestà impone di aggiungere, ai 100 motivi d’orgoglio, almeno 10 motivi di vergogna: intraducibili. Ecco perché, purtroppo, in queste ore l’Italia ci imbarazza.
1. Perché tutti sono innocenti finché non è provata la colpevolezza. Ma insomma.
2. Perché gli oppositori drammatizzano e i governanti minimizzano. Salvo scambiarsi i ruoli al prossimo giro.
3. Perché la fame è fisiologica, ma l’ingordigia è patologica: dove finiscono tutti quei soldi? Cosa se ne fanno? Quanti auto tedesche e appartamenti svizzeri deve comprare, un uomo, prima di essere sazio?
4. Perché le grandi opere, da decenni, sono occasioni di grandi saccheggi. Ma ce ne accorgiamo sempre dopo.
5. Perché la nostra indignazione è tribale: il peccato è grave quando lo commettono i nostri avversari. Altrimenti, parliamone.
6. Perché i collettori di frustrazioni sono lì che aspettano. E non tutti sono inoffensivi come Grillo & C.
7. Perché viene il dubbio che non ci meritiamo Venezia, sprechiamo Milano, svergogniamo Genova, umiliamo Siena, roviniamo Roma. E al Sud, ormai, abbiamo rinunciato.
8. Perché «Delitto e castigo», in Italia, è solo il titolo di un romanzo russo che hanno letto in pochi. C’è sempre un’amnesia, un’amnistia o una prescrizione per tirarsi fuori dai guai.
9. Perché le pene italiane sono drammatiche, lontane e incerte. Quando dovrebbero essere proporzionate, rapide e certe.
10. Perché abbiamo la memoria di un pesce rosso (quattro secondi). Dimentichiamo tutto subito. E qualcuno, questo, se lo ricorda bene.
Corruzione, la Grande Ipocrisia. L'analisi. Da Tangentopoli in poi, e per un infinito ventennio di malaffare, non solo si è fatto assai poco. Ma quel poco che si è fatto lo si è fatto male, scrive Massimo Giannini su “La Repubblica”. Cos'altro deve succedere, per convincere la politica a muovere un passo concreto, tangibile e inequivocabile, contro la corruzione che torna a minare le basi della convivenza civile e della concorrenza economica? Quante altre retate devono accadere, per spingere il governo e il Parlamento a ripristinare con un atto definitivo, responsabile ed efficace, il principio di legalità di cui in questi anni di fango hanno fatto strame tutti, ministri e sottosegretari, amministratori centrali e cacicchi locali? Domande tutt'altro che oziose (o capziose), di fronte all'acqua lurida che tracima dal Mose, dove proprio la politica si è definitivamente messa "a libro paga", esigendo quello che i magistrati chiamano "lo stipendio di corruzione". Da Tangentopoli e Mani Pulite in poi, e per un infinito ventennio di malaffare pubblico e privato, non solo si è fatto assai poco. Ma quel poco che si è fatto lo si è fatto assai male. Grandi proclami, piccoli compromessi. Leggi-feticcio, da dare in pasto al popolo bue. E poi appalti in deroga a volontà, per lucrare fondi neri. Non solo in epoca berlusconiana, che sappiamo straordinariamente nefasta sul piano etico. Anche in tempi più recenti, che speravamo finalmente proficui sul piano della ricostruzione morale e della legislazione penale. Così non è stato. Così non è ancora. E al presidente del Consiglio Renzi, che meritoriamente dichiara di voler "cambiare verso" all'Italia anche dal punto di vista della giustizia e che opportunamente si accinge a dare più poteri al commissario anti-corruzione Cantone, non è inutile ricordare quanto è accaduto e quanto sta ancora accadendo. Al di là degli annunci, che pure servono a scuotere la coscienza di un Paese disabituato al meglio e assuefatto al peggio, ma che da soli non bastano a consolidare nell'opinione pubblica la percezione di un vero cambiamento. Da troppo tempo - interrotti solo dai blitz dei pm sulle infinite cricche tricolori, dal terremoto dell'Aquila al G8 della Maddalena, dai mondiali di nuoto al sacco di Carige, dall'Expo milanese al Mose veneziano - abbiamo ascoltato alti lai e asciugato lacrime di coccodrillo. Ma nulla è cambiato, nei codici e nelle norme di contrasto. C'è come l'accidiosa consapevolezza che la corruzione, con i suoi 60 e passa miliardi di "fatturato" l'anno, rappresenti una parte essenziale e forse irrinunciabile del Pil nazionale. Così l'establishment, politico ed economico, celebra a ogni nuovo arresto la Grande Ipocrisia. Interviste sdegnate, riunioni d'emergenza. Poi più nulla. O leggi fatte male, a volte col legittimo sospetto che le si vogliano esattamente così, per convenienza bipartisan. Non parliamo, stavolta, dei misfatti compiuti da Berlusconi premier. Sono tristemente noti. Diamo dunque per acquisite le 12 leggi ad personam azzardate dall'ex Cavaliere sulla giustizia. La colossale occasione, miseramente mancata, è stata la legge Severino, approvata dal governo Monti nel novembre 2012. Insieme a qualcosa di buono (le nuove norme sulla decadenza e l'incandidabilità, che costano allo stesso Berlusconi condannato il seggio al Senato) la legge "spacchetta" inopinatamente il reato di concussione, riducendo i reati (e dunque i tempi di prescrizione) per l'ipotesi meno grave (ma infinitamente più frequente) dell'"induzione". L'anomalia viene segnalata dai magistrati, rilevata dal "Sole 24 Ore" e da "Repubblica", che ne chiede conto al ministro Guardasigilli consegnandole 250 mila firme raccolte a favore di una "seria legge contro la corruzione". Ma non c'è niente da fare. La legge passa così com'è, con la benedizione trasversalissima delle appena nate Larghe Intese: "tecnici" montiani, Pd e Pdl votano compatti, alla Camera: 480 favorevoli, solo 19 contrari, il Parlamento approva. Di lì nascono tutti i guai successivi. Berlusconi userà i benefici derivanti dal caos normativo innescato dalla legge Severino nel processo Ruby. La stessa cosa farà Filippo Panati nel processo Falck. Un caos che nel frattempo viene autorevolmente certificato. A febbraio di quest'anno tocca alla Ue, nel suo rapporto sulla corruzione, evidenziare la lunga "serie di problemi irrisolti" lasciati dalla legge Severino (prescrizione, falso in bilancio, autoriciclaggio, voto di scambio) e stigmatizzare "gli effetti della frammentazione del reato di concussione". Il 15 marzo tocca invece alla Corte di Cassazione denunciare per sentenza i danni causati da quella legge all'esercizio della giurisdizione, e chiedere a governo e Parlamento di porvi rimedio al più presto. La richiesta cade nel vuoto. Mentre cominciano a scoppiare i nuovi scandali, governo e Parlamento non solo non raccolgono l'invito. Ma si muovono lanciando al Paese segnali contraddittori, su tutti i fronti che riguardano lo Stato di diritto. Due esempi, ma clamorosi perché passati sotto silenzio. Il 28 gennaio 2014 il governo Letta approva il decreto legge numero 4, "disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero". È la cosiddetta "voluntary disclosure", in voga in altri Paesi dell'Unione. Ma da noi viene allentata oltre misura. Al Senato il testo originario viene modificato, le imposte dovute sui capitali rientrati vengono dimezzate e i reati di frode "con altri artifici", oltre alla omessa o infedele dichiarazione, vengono depenalizzati. Di fatto, quasi un colpo di spugna, che alla fine non passa solo perché la Camera il 19 marzo decide di stralciare queste norme e di farle confluire in un ddl che sarà presentato in futuro. Per uno scampato pericolo, un disastro compiuto. Il 17 maggio è entrata in vigore la legge numero 67, che introduce la possibilità di chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali nei procedimenti per delitti economico-finanziari con pene fino a 4 anni di detenzione. In questi casi, su richiesta del soggetto incriminato, si sospende il processo e si avvia un percorso di servizio e risarcimento, di durata massima 2 anni, al termine del quale il reato si estingue. Nella lista dei delitti per i quali si può ottenere il beneficio ci sono l'omessa dichiarazione dei redditi, la truffa, il falso in bilancio e persino il furto. Questo sì, a tutti gli effetti, ha le fattezze di un "colpo di spugna", studiato proprio per i reati dei "colletti bianchi". Il Parlamento approva unanime la legge, il 2 aprile scorso, nell'indifferenza dei più. Mentre riesplodono le nuove e vecchie Tangentopoli, che vedono il potere politico alternativamente vittima e a volte carnefice di quello economico, il Parlamento invia dunque questi strani segnali di fumo al Paese. Delinquere non è poi così compromettente. Alla fine si può scendere a patti. Di fronte a tanto cinismo consociativo, la Grande Speranza si chiama Matteo Renzi. Solo lui può spazzare via la Grande Ipocrisia chiamata lotta alla corruzione. Ma le prime mosse del premier non sono confortanti. Nel discorso sulla fiducia alle Camere, il 22 febbraio, il nuovo presidente del Consiglio non dice una parola sul tema della legalità e delle strategie di contrasto al malaffare. Un silenzio che assorda, e che spinge Roberto Saviano a scrivere una lettera aperta al premier, su "Repubblica" del 28 febbraio. Renzi raccoglie la sollecitazione, e il giorno dopo annuncia dal salotto di Fabio Fazio, a "Che tempo che fa", la nomina di Raffaele Cantone alla guida dell'Autorità anti-corruzione, nata un anno prima e mai formata. È un primo indizio, che sembra rassicurante. Ma le mosse successive, purtroppo, non sembrano trasformarlo nella prova che tutti aspettiamo. La vicenda del Documento di Economia e Finanza, non aiuta a capire qual è la vera strategia del governo. Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, approva il Def l'8 aprile. Renzi ne illustra le linee guida, con le solite slide. Il giorno dopo, sul suo sito, il ministero dell'Economia pubblica il testo integrale. A pagina 27 del Piano Nazionale delle Riforme, compare un ricco capitolo dedicato alla giustizia: "Asset reale per lo sviluppo del Paese", è il titolo. Pier Carlo Padoan, dai tempi dell'Ocse, ha bastonato duramente l'Italia, proprio per i ritardi sulla corruzione. Per questo, nel Def, il ministro scrive parole chiarissime, non solo sulla giustizia civile e amministrativa, ma proprio sulla lotta alla corruzione: occorre "rivedere la disciplina del processo penale, con particolare riferimento all'istituto della prescrizione, ferma restando l'esigenza di assicurare la certezza e ragionevolezza dei tempi". Più avanti: "Introduzione dei reati di autoriciclaggio e autoimpiego, anche rafforzando il 41 bis". E infine: "È necessario affrontare in modo incisivo il rapporto tra gruppi di interesse e istituzioni e disciplinare i conflitti di interesse e rafforzare la normativa penale del falso in bilancio". Finalmente una dichiarazione programmatica impegnativa. Il segno che "cambiare si può". Ma sei giorni dopo, quando il Def arriva alle Camere per l'avvio dell'iter parlamentare, il testo è sorprendentemente cambiato. Il capitolo Giustizia rimane, alle pagine 29 e 30, e poi a pagina 63, nel capitolo II.10 intitolato "Una giustizia più efficiente". Si parla di tutto, dalla riforma della giustizia civile al sovraffollamento carcerario, dalle leggi già varate sul voto di scambio a quelle contenute nella Severino. Si propone la "mediazione obbligatoria" e la "depenalizzazione dei reati minori", la "difesa dei soggetti più deboli" e la "tutela dei minori". Ma per quanto li si cerchi, i paragrafi sulle modifiche al processo penale, dalla prescrizione all'autoriciclaggio, dall'autoimpiego al falso in bilancio, non ci sono più. Chi e perché le ha cancellate? Una spiegazione possibile, anche se parziale, la forniscono gli atti parlamentari. Il 16 aprile, durante il dibattito in Commissione Giustizia della Camera, i deputati Cinquestelle almeno per una volta fanno bene il loro mestiere. Alfonso Bonafede "ritiene che sia estremamente grave che nella formulazione presentata alle Camere del Def in data 9 aprile 2014 venga fatto espressamente riferimento all'esigenza di affrontare definitivamente entro giugno 2014 il problema dei tempi di prescrizione e che ieri, martedì 15 aprile, dopo che nella serata di lunedì 14 aprile il presidente del Consiglio si sia incontrato con Silvio Berlusconi, sia pervenuta alle Camere una "errata corrige" da parte della presidenza del Consiglio, nella quale è stato cancellato ogni riferimento alla questione della prescrizione". La risposta di Donatella Ferranti, presidente della Commissione, arriva di lì a poco: "Le correzioni apportate con l'errata corrige - replica l'esponente del Pd - erano state in realtà segnalate dagli uffici del Ministero della Giustizia alla Presidenza del Consiglio la scorsa settimana". Dunque, non sarebbe stato il premier a "depotenziare" il testo, e meno che mai l'avrebbe fatto dopo l'incontro di due ore, a Palazzo Chigi, con l'ex Cavaliere. Possiamo credere alla ricostruzione della Ferranti. Ma l'anomalia resta. E se a "sbianchettare" i paragrafi sul programmato giro di vite per la prescrizione, l'autoriciclaggio e il falso in bilancio è stato il ministro Orlando, e non Renzi, che differenza fa? Di nuovo: che segnale si vuol mandare al Paese? Siamo all'oggi. La gigantesca metastasi delle mazzette, che si propaga da Milano a Venezia nel corpo malato dell'"operosa Padania", obbliga il governo a fare qualcosa, subito. Orlando ha preso tempo sui vari provvedimenti già all'esame del Parlamento da più di un anno (dal testo della Commissione Fiorella sulla prescrizione alle diverse proposte sul falso in bilancio). Ha rinviato tutto a un più organico disegno di legge anti-corruzione, originariamente previsto entro l'estate e ora forse anticipato alla prossima settimana. Ma nel frattempo deve battere un colpo, almeno sulla promessa attribuzione dei pieni poteri a Cantone e magari anche sull'autoriciclaggio. Se ci riuscirà, al Consiglio dei ministri di domani, sarà tanto di guadagnato. Ma di fronte alla nuova Questione Morale, che torna a devastare drammaticamente il Paese e a sporcarne irrimediabilmente l'immagine, non basta più la narrazione riformista. Serve l'azione riformatrice. Chiara e severa, senza concessioni e senza ambiguità. Anche così si difende la memoria di Enrico Berlinguer dagli iconoclasti pentastellati.
Democratici divisi anche sulle mazzette. Fassino: "Orsoni uomo onesto". Ma i renziani non vogliono scandali. Moretti: "Nuova classe dirigente per mettere fine alla corruzione", scrive Fabrizio Boschi su “Il Giornale”. È sempre così. Quando succedono queste cose è tutto un fuggi fuggi. Quello non c'entra, quell'altro è innocente, ci auguriamo che la magistratura faccia chiarezza al più presto, bla bla bla. A una settimana dai sorrisoni a trentadue denti mostrati al Nazareno, dopo la schiacciante vittoria di Renzi alle Europee, da ieri mattina il Pd si è improvvisamente ammutolito. Anzi no, di chiacchiere se ne sono sentite sin troppe, ma del fiume di parole sgorgate dalle bocche dei dirigentoni e esponentoni del partito, qualcuna non solo era dissonante, ma in certi casi contrastante. Nordisti contro sudisti. Veneti contro il resto del mondo. Soprattutto la nuova contro la vecchia guardia. Ex comunisti contro neo demo-renziani. C'è da capirli ahiloro. Il loro cristallino sindaco di Venezia, di specchiata moralità e ineccepibile levatura, è finito in manette. E si levò nell'aria un unico attestato di stima: «Chiunque conosca Orsoni non può dubitare della sua correttezza e della sua onestà». Parola di Piero Fassino, sindaco di Torino. Virginio Merola gli fa eco da Bologna. Ma loro appartengono al vecchio, due che Renzi, se fosse il rottamatore, avrebbe già rottamato (per motivi anagrafici). Uno ad uno hanno fatto capolino i nuovi, o quelli rivestiti di nuovo, come la ex bersaniana, poi ultrà renziana, Alessandra Moretti, che da ex vicesindaco di Vicenza scarica tutte le colpe sui vecchi compagni con una frase che i politici di razza definirebbero «concreta»: «È arrivato il tempo che una nuova generazione di politici si prenda la responsabilità di scommettere sul futuro». Parole sacrosante. L'altra conterranea, Laura Puppato, ex sindaco di Montebelluna in provincia di Treviso, salita a forza sullo stipato carro renziano, dà la colpa di tutto questo marciume a quei vecchi bacucchi del suo partito, in via di rottamazione: «Dall'inchiesta sul Mose viene fuori la parte peggiore della politica del passato», mentre «noi con Renzi stiamo voltando pagina da tutto questo». E pure il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Sandro Gozi, si smarca dalla puzza che fuoriesce dalla laguna, tirando fuori un evergreen: «Siamo il governo del cambiamento». Quel discolo di Pippo Civati non ci casca e pretende «una maggiore selezione della classe dirigente». Il filosofo ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari aveva la soluzione in tasca ma, guarda caso, nessuno l'ha ascoltato: «Da sindaco, durante i governi Prodi e Berlusconi ebbi modo di ripetere che le procedure assunte non permettevano alcun controllo da parte degli enti locali e che il Mose si poteva fare a condizioni più vantaggiose. L'ho ripetuto milioni di volte». L'eurodeputato rieletto David Sassoli s'improvvisa spazzino e si augura che si faccia «pulizia rapidamente» con un pizzico di retorica: «Voglio una Repubblica fondata sul lavoro non sulle mazzette». Sarà il prossimo ad essere rottamato.
Per l'avvocato mito della sinistra figuraccia nel "Biennale day". Dopo aver sconfitto Brunetta nel 2010 fu osannato come un Monti "ante litteram", scrive Stefano Filippi su “Il Giornale”. Nel sito internet del Partito democratico la biografia di Giorgio Orsoni appare sotto un titolo che è tutto un programma: «Buone mani». Orsoni il cattolico, il moderato, il pacato, il senza tessere, l'avvocato delle cause vinte. La barba bianca garantiva la saggezza, gli occhialini la preparazione, la fronte alta l'esperienza. Un doge sobrio e democratico, del giro prodiano. E chi si aspettava le manette per un sindaco del genere? Nel 2010 prese il posto di Massimo Cacciari e la sinistra lo elesse a simbolo della riscossa. Erano gli ultimi anni di Silvio Berlusconi premier, impazzava il gossip sul bunga-bunga, eppure in Veneto il centrodestra era ancora capace di piazzare il leghista Luca Zaia come governatore della regione al posto di Giancarlo Galan con il 60 per cento dei voti: Carroccio al 35, Pdl al 25. Nel comune di Venezia, invece, il ministro Renato Brunetta fu surclassato senza ballottaggio da questo avvocato esperto di diritto amministrativo che da tempo si agitava nelle seconde file della politica, quelle degli assessorati, delle consulenze, dei consigli di amministrazione, dei posti nelle fondazioni. Orsoni non ebbe neppure il tempo di indossare la fascia tricolore che fu fatto santo subito. Una specie di Mario Monti «ante litteram», un tecnico capace di mettere insieme dall'Udc a Rifondazione, diavolo e acqua santa. Ecco il peana intonato da Repubblica: «Portato al dialogo e alla riflessione pacata. Uno che non alza mai la voce. E proprio la sua tranquillità, la sua campagna elettorale che è sembrata persino sottotono tanto è stata sobria, ha prevalso, nella scelta degli elettori, rispetto alla campagna arrembante del ministro fantuttone». Gli mancava soltanto il loden, che a Venezia non si porta e oltretutto è inadatto al girovita di Orsoni. Le accuse di finanziamenti illeciti che lo costringono agli arresti domiciliari riguardano proprio quella campagna elettorale contro Brunetta. Oggi Massimo Cacciari non si spende troppo in parole di solidarietà, ma quattro anni fa fu lui a indicarlo come successore. Docente di diritto a Ca' Foscari, erede dello studio legale di un principe del foro come Feliciano Benvenuti, era stato assessore al patrimonio nella giunta del sindaco Paolo Costa, allora suo grande sponsor. Uomo di Romano Prodi nel Nordest, da ministro dei Lavori pubblici nel primo esecutivo del Professore (subentrato ad Antonio Di Pietro) Costa aveva voluto Orsoni come consulente giuridico e capo dell'ufficio legislativo al dicastero. Le poltrone non sono mai mancate a Orsoni. È stato presidente della Save Engeneering, società satellite dell'aeroporto Marco Polo; presidente degli avvocati veneziani e veneti e membro del Consiglio nazionale forense; consigliere di amministrazione della Biennale; primo procuratore di San Marco; vicepresidente della Fondazione Cini; insignito della Legion d'onore. Le sue «buone mani» sono sempre state mani in pasta. Quando mesi fa scattarono le prime manette per gli appalti del Mose, Orsoni non fece una piega, sicuro del fatto suo: «Non sono io a dovermi preoccupare, ma altri: quelli che vogliono mantenere nascoste le cose. Perché in questa vicenda c'è qualcuno che vuole seminare del fumo». Nella torrenziale relazione della Guardia di finanza (740 pagine) il suo era l'unico nome di un politico non coperto da omissis. Orsoni si sentiva le spalle coperte nonostante avesse preso le distanze dai vecchi sponsor: contrario al passaggio delle grandi navi da crociera nel bacino di San Marco, mentre Costa (ora presidente del Porto) è favorevole; ostile ai progetti di sviluppo dell'aeroporto, al punto da aprire una battaglia legale contro la Save che un tempo l'aveva accolto tra gli amministratori. In questi ultimi mesi era impegnato a trasformare Venezia in città metropolitana assieme ai sindaci di Padova e Treviso, entrambi di sinistra. Domenica Padova va al ballottaggio e Massimo Bitonci, candidato di Lega e Forza Italia, ha riempito Facebook di foto in cui il suo avversario, Ivo Rossi, bacia e abbraccia Orsoni. Il quale oggi avrebbe dovuto inaugurare la Biennale architettura con l'archistar Rem Koolhaas. Una serenissima figuraccia.
PARLAMENTARI SENZA ARTE NE' PARTE. COME DA POVERI SI DIVENTA MILIONARI.
Così i parlamentari sono diventati milionari. Quando nacque la Repubblica i costituenti guadagnavano 1.300 euro odierni. Adesso deputati e senatori incassano tredici volte più di un operaio. Il tutto grazie a una serie di leggi che nel tempo hanno gonfiato le retribuzioni. E a provvedimenti ad hoc, furbizie, trucchi e tanta sfacciataggine. Che ha ricostruito Paolo Fantauzzi su “L’Espresso”. «Onorevoli colleghi, l'opinione pubblica non ha in questo momento molta simpatia e fiducia per i deputati. Vi è un'atmosfera di sospetto e discredito, la convinzione diffusa che molte volte l'esercizio del mandato parlamentare possa servire a mascherare il soddisfacimento di interessi personali e diventi un affare, una professione, un mestiere». La solita tirata contro la casta di qualche parlamentare del Movimento cinque stelle? Macché. Frasi di Piero Calamandrei, giurista, antifascista, partigiano e deputato eletto col Partito d'azione all'Assemblea costituente. Parole pronunciate nel lontano 1947, mentre a Montecitorio era in discussione l'articolo 69 della Costituzione, relativo allo stipendio dei parlamentari. Il paradosso è che all'epoca i costituenti guadagnavano quanto un precario di oggi: 25 mila lire al mese, circa 800 euro. Più un gettone di presenza da 1.000 lire al giorno (30 euro), ma solo quando le commissioni si riunivano in giorni differenti rispetto all'Aula. Insomma, per quanto diligenti, i 556 rappresentanti che scrissero la Costituzione non riuscivano a portare a casa più di 1.300 euro al mese. Roba da far apparire i grillini - che, al netto dei rimborsi, trattengono circa 3 mila euro - degli sfacciati crapuloni. E in effetti nel dopoguerra lo stipendio dei parlamentari non era altissimo in termini assoluti ma comunque più che dignitoso per una nazione ancora sconvolta dall'economia di guerra, fame, mercato nero e inflazione vertiginosa. Un Paese senza dubbio più povero ma di certo meno "squilibrato" a favore del Palazzo, visto che un operaio di terzo livello arrivava a raggranellare 13 mila lire al mese, un terzo di un deputato. Mentre dopo quasi 70 anni - come mostra la tabella elaborata dall'Espresso - chi siede in Parlamento guadagna quasi 10 volte più di un impiegato e 13 più di una tuta blu. All'alba della nuova Italia, retribuire i parlamentari era considerato un decisivo fattore di indipendenza e democrazia, tale da consentire anche alle classi non abbienti di partecipare alla vita politica. Senza però esagerare, vista la drammatica situazione del Paese. Per questo nel giugno 1946 fu fissata provvisoriamente la somma di 25 mila lire. Ma l'inflazione era tale che a febbraio 1947 fu necessario portarla a 30 mila lire (740 euro) e a settembre a 50 mila lire (850 euro), elevando il gettone di presenza a 3 mila lire al giorno (51 euro), dimezzato per i residenti a Roma. La prima legge sul tema, varata nell'estate 1948 dal governo De Gasperi, è figlia di questa mentalità che allora ispirava la giovane e fragile democrazia italiana: "Ai membri del Parlamento è corrisposta una indennità mensile di L. 65.000, nonché un rimborso spese per i giorni delle sedute parlamentari alle quali essi partecipano". Tradotto ai giorni nostri: 1.230 euro fissi più un gettone da 100 euro scarsi al giorno (5mila lire) legato alla presenza effettiva. Togliendo fine settimana più i lunedì e i venerdì, in cui le convocazioni sono rare, non più 2.500 euro al mese dunque. Tutto esentasse, visto che lo stipendio era considerato un rimborso spese e non un reddito. Ma comunque una chimera se si considera che oggi i rimborsi sono prevalentemente forfettari, che le decurtazioni per gli assenteisti valgono solo per i giorni in cui si vota e che per risultare presenti è sufficiente partecipare a una votazione su tre. Che l'aria sarebbe ben presto cambiata lo dimostra una legge emanata dal governo Segni nel 1955: "Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato". Pensata per garantire l'esercizio del mandato popolare, finì per trasformarsi in un privilegio ingiustificato per una pletora sterminata di soggetti. Non solo i politici in carica e il Capo dello Stato ma anche gli ex: presidenti del Consiglio, ministri e sottosegretari (bastava un anno), parlamentari, alti papaveri dei dicasteri, cardinali, familiari del ministro e del sottosegretario ai Trasporti e perfino quelli dei dipendenti delle Camere. Un privilegio al quale, col passare del tempo, si sarebbero aggiunti una innumerevole serie di altri benefit - molti ancora esistenti - dai biglietti aerei alla telefonia fissa (e poi mobile), dalle tessere autostradali agli sconti sui trasporti marittimi. E così nel 1963, in appena 15 anni, grazie ai bassi salari che furono alla base del miracolo economico, col suo mezzo milione al mese un parlamentare era già arrivato già a guadagnare il quintuplo di un impiegato (il cui salario si aggirava sulle 100 mila lire) e otto volte più di un operaio (poco sopra le 60 mila lire). Ma è con la legge varata nel 1965 dal centrosinistra (premier Aldo Moro, vicepresidente il socialista Pietro Nenni) che si deve l’esplosione dei redditi dei nostri rappresentanti: lo stipendio veniva infatti agganciato a quello dei presidenti di sezione della Cassazione e fra l'altro soggetto a imposta solo per il 40%. Inoltre a titolo di rimborso per le spese di soggiorno a Roma si istituiva la diaria (esentasse). Ciliegina sulla torta: siccome la legge non lo specificava, le 120 mila lire per vivere nella capitale (1.250 euro di oggi) furono accordate anche quelli che vi risiedevano già. Un capolavoro. Tuttora in vigore, sia pure con qualche modifica. Certo, anche i comuni mortali hanno avuto le loro soddisfazioni. Negli anni '70, ad esempio, per effetto delle lotte sindacali, i lavoratori dipendenti e in particolar modo degli operai hanno conosciuto un aumento delle retribuzioni che ha fatto diminuire il distacco dagli onorevoli. Al punto che nel 1977 un metalmeccanico poteva guadagnare un quarto di un parlamentare: rispetto al 1963, un dimezzamento dello "spread". Poi il governo Craxi taglia la scala mobile e la forbice torna ad allargarsi inesorabilmente. E sia tute blu che impiegati cominciano a perdere progressivamente potere d'acquisto: i loro salari reali scendono lentamente, mentre deputati e senatori iniziano a stappare bottiglie di champagne. Per festeggiare una busta paga che in un trentennio raddoppia il suo valore: dai 7 mila euro degli anni '80 (rivalutati al 2014) oggi siamo arrivati a quasi 14 mila. Gli impiegati, invece, si aggirano sui 1.500 euro al mese, mentre i metalmeccanici sono inchiodati da allora fra 1.100 e 1.200 euro. Nel mezzo, ci sono i generosi regali che i parlamentari si fanno nel corso del tempo. Nel 1986, ad esempio, l’indennità viene equiparata completamente a quella dei presidenti di sezione della Corte suprema (era al 91,3%), che regala in un colpo solo 400 mila lire nette in più al mese più dieci mensilità arretrate: cinque mesi di lavoro di un operaio. Ma le disparità sono anche nella dichiarazione dei redditi. Già, perché un terzo dell'indennità per deputati e senatori, dopo lunghe lotte assimilata al lavoro dipendente, resta esente dalle imposte (solo dal 1995 la tassazione è al 100% come tutti i comuni mortali). Senza contare che grazie a una generosa interpretazione del Testo unico delle imposte sui redditi (governo Craxi), come ha raccontato sull’Espresso Stefano Livadiotti, il prelievo fiscale si aggira attorno al 19 per cento. Intanto, anno dopo anno, i rimborsi aumentano a dismisura, dai viaggi di studio alle spese telefoniche, dai costi di trasporto a quelli di spostamento. Fino alle spese postali, in seguito soppresse: nel 1988 a ogni deputato veniva riconosciuto ogni mese il corrispettivo di 500 francobolli (erano 300 fino a un paio di anni prima), circa 350 euro odierni. Che poi si spedissero davvero tutte quelle missive, poco importa. Non fossero bastati i benefit, a fine anni '80 per le deputate finì in busta paga perfino l’indennizzo per il coiffeur. Già, perché non essendoci a Montecitorio il parrucchiere (al contrario dei colleghi maschi, che possono contare sul barbiere), alle parlamentari viene assegnato un rimborso forfettario sostitutivo. Come dire: scusate il disservizio, la messa in piega la offriamo noi. Questo aumento degli stipendi, fra l'altro, ha prodotto effetti a cascata anche sugli enti locali. Perché se gli eletti nelle Camere si sono agganciati ai magistrati di Cassazione, i consiglieri regionali hanno fatto altrettanto con i parlamentari. E ogni ritocco all’insù sancito dall'Istat è costato miliardi e miliardi di lire a tutta la collettività. L'ultimo colpo grosso - prima della sterilizzazione degli stipendi avviata nel 2006 e dei vari piccoli tagli apportati negli ultimi anni - risale al 1997: quasi 7 milioni al mese in più sotto forma di “spese di segreteria e rappresentanza” al posto dei precedenti contributi per i portaborse, che venivano erogati al gruppo parlamentare di appartenenza. In questo modo, non solo i soldi sono finiti direttamente sulla busta paga dell'onorevole, ma non è stato nemmeno più necessario rendicontarli (dal 2012 basta documentare il 50%). Risultato: come ha raccontato l'Espresso, in maniera assolutamente lecita molti parlamentari si sono tenuti i soldi e vari collaboratori hanno continuato a lavorare a nero . Che avesse ragione Calamandrei?
Tasse, ecco come la Casta si è dimezzata l'aliquota. Con un trucchetto, grazie a un lavorìo rimasto sempre sotto traccia, è passata la riduzione al 18,7 delle tasse sulla busta paga di deputati e senatori, scrive Stefano Livadiotti su “L’Espresso”. I partiti politici italiani se le sono date di santa ragione per favorire a colpi di leggi i loro rispettivi bacini elettorali. Ma su un fronte hanno lavorato tutti insieme appassionatamente. L’obiettivo era quello di garantire un trattamento fiscale di straordinario privilegio ai loro rappresentanti in parlamento (ma le stesse regole sono previste anche per gli onorevoli regionali). Ed è stato perfettamente centrato, con un lavorìo rimasto sempre sotto traccia. Pochi lo sanno: l’indignazione dei cittadini per i costi della politica si è finora concentrata sui benefici economici e pensionistici degli onorevoli. Ma quelli fiscali sono ancora più scandalosi: la retribuzione complessiva di chi siede alla Camera in rappresentanza del popolo italiano è sottoposta a un’aliquota media Irpef del 18,7 per cento. Ecco come funziona, documenti ufficiali alla mano (ricavati dal sito istituzionale della Camera). Prendiamo un parlamentare che non svolge altre attività ed è talmente ligio da non saltare mai una seduta di Montecitorio. La voce più pesante della sua busta paga è l’indennità mensile, oggi ridotta a 10.435 euro, pari a 125.220 euro l’anno. Dall’importo vengono sottratte ritenute previdenziali per 784 euro al mese (9.410 euro l’anno) come quota di accantonamento per l’assegno di fine mandato, che è esentasse, come vedremo (e come d’altronde è scritto nero su bianco nella relazione al 31 dicembre 2011 su Attività e risultati della Commissione Giovannini sul livellamento retributivo Italia-Europa). L’onorevole subisce poi una ritenuta mensile per il trattamento pensionistico di circa 918 euro (11.019 euro l’anno). Dall’indennità parlamentare viene infine detratta una ritenuta mensile di 526 euro (6.320 euro l’anno) per l’assistenza sanitaria integrativa. Il trattamento del deputato è però arricchito da altre quattro voci con il segno positivo, tutti benefit esentasse. La prima è la diaria, una sorta di rimborso per i periodi di soggiorno a Roma, che ammonta a 3.503 euro al mese (42.037 l’anno) e viene decurtata di 206 euro per ogni giorno di assenza. La seconda è il rimborso delle spese per l’esercizio del mandato, pari a 3.690 euro al mese (44.280 l’anno), che per il 50 per cento va giustificato con pezze d’appoggio (per certe voci) e per il restante 50 per cento è riconosciuto a titolo forfettario. La terza voce non è perfettamente quantificabile e deriva dal fatto che il deputato è fornito di una serie di tessere per volare, prendere treni e navi e viaggiare in autostrada senza sborsare un soldo (ai fini della nostra simulazione abbiamo ipotizzato che ciò gli consenta di risparmiare 5 mila euro tondi l’anno) e un rimborso forfettario delle spese di trasporto (ma non viaggia già gratis?) di 3.995 euro a trimestre (15.980 l’anno). La quarta voce è rappresentata da una somma a forfait mensile di 258 euro (3.098 euro l’anno) per le bollette telefoniche. Il pallottoliere dice che il totale fa 235.615 euro. Che, dedotte le ritenute previdenziali e assistenziali e i rimborsi spese documentati, si riduce a 189.431 euro. Ma per l’onorevole, come per magia, grazie ai trattamenti di favore architettati dal parlamento stesso, la base imponibile ai fini Irpef è di soli 98.471 euro e comporta il pagamento di tasse per 35.512 euro. Che corrisponde in concreto a un’aliquota media, appunto, di appena il 18,7 per cento. Qualunque altro cittadino italiano, un manager per esempio, che percepisse la stessa somma a titolo di stipendio e di benefit di analoga natura, si ritroverebbe con una base tassabile ai fini dell’imposta sul reddito di 189.431 euro e dovrebbe mettere mano al portafoglio per 74.625 euro di Irpef (con un’aliquota media del 39,4 per cento). L’onorevole paga dunque solo il 47 per cento di quello che toccherebbe a un cittadino comune (e per semplicità non si è tenuto conto degli ulteriori benefici di cui gode sulle addizionali regionale e comunale) e risparmia ogni anno qualcosa come 39 mila euro d’imposta (vedere la tabella nella pagina a fianco). A consentire questa incredibile iniquità è un’interpretazione alquanto generosa, da parte del parlamento, dell’articolo 52, comma 1, lettera b del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), in base al quale non concorrono a formare il reddito le somme erogate a titolo di rimborso spese ai titolari di cariche elettive pubbliche (parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali) e ai giudici costituzionali, «purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi». Il rispetto dei principi di capacità contributiva e il divieto di disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti imporrebbe la limitazione dell’esenzione fiscale ai soli rimborsi spese effettivi, quelli cioè strettamente legati alle funzioni pubbliche svolte e corredati di documentazione. Ma il parlamento ha deciso diversamente. Costringendo altri uffici pubblici a fare i salti mortali per non doverne censurare le scelte. Basti pensare che il Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale, costituito a suo tempo da Tremonti per tagliare la spesa pubblica e presieduto da Vieri Ceriani, non avendo altri criteri di rilievo costituzionale per giustificare le ragioni di tali benefici fiscali ha dovuto classificarli tra le misure a rilevanza sociale, cioè alla stregua di quelle a favore delle Onlus e del terzo settore e di quelle che aiutano l’occupazione. Poi dice l’antipolitica. Ma non è finita. Siccome pagare l’Irpef al 18,7 per cento a Lorsignori doveva sembrare ancora poco e per non farsi mancare proprio nulla, i parlamentari hanno pensato bene di trovare un escamotage per mettersi in tasca pulito pulito l’assegno di fine mandato, che dovrebbe invece essere sottoposto a tassazione in base all’articolo 17, comma 1, lettera a del Tuir (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Ecco come hanno fatto. Ogni mese, lo abbiamo appena visto, l’onorevole subisce, proprio in vista dell’assegno di fine mandato, una ritenuta sull’indennità parlamentare di 784 euro. Trattandosi di contributi previdenziali, la somma viene dedotta annualmente dal reddito da tassare, nel presupposto che ciò avverrà poi al momento della consegna dello chèque. L’articolo 17, comma 1 del D.P.R. 917/86 prevede, come per il Tfr dei lavoratori, una tassazione separata dell’assegno di fine mandato, per evitare che si sommi al reddito dell’anno in cui viene incassato, facendo così scattare un’aliquota fiscale più alta. Ma c’è un’altra disposizione (contenuta nell’articolo 19, comma 2 bis del Tuir) che riguarda il metodo di tassazione separata dell’indennità spettante ai dipendenti pubblici (buonuscita per gli statali) e agli assimilati (soci lavoratori delle cooperative, sacerdoti e parlamentari): dice che la base imponibile dell’assegno va determinata in funzione del peso del contributo a carico del datore di lavoro sul totale del contributo previdenziale. Per capire meglio, prendiamo un caso concreto. Quello di un dipendente pubblico, la cui indennità di buonuscita è alimentata da un contributo obbligatorio a carico del lavoratore nella misura del 2,5 per cento e da contributi a carico del datore di lavoro del 7,10, per un totale del 9,60 per cento. Il contributo pubblico del 7,10 per cento corrisponde al 73,96 del 9,60 per cento. Quindi al travet verrà tassato il 73,96 per cento della buonuscita. Non avviene così nel caso dei parlamentari. Disciplinando da soli il sistema di rappresentazione contabile della loro busta paga, gli onorevoli hanno creato un meccanismo perfetto, che rispetta formalmente la legge, ma consente di non pagare un euro bucato di tassazione separata sull’assegno di fine mandato. Il trucco è tanto banale quanto efficace: mentre per il dipendente pubblico, come abbiamo visto, il 73,96 per cento dell’accantonamento è a carico del datore di lavoro; nel caso del parlamentare la quota da accantonare per l’indennità di parlamentare è tutta figurativamente imputata a lui. E così non deve pagare. Non è certo da questi politici (a parte qualche lodevole eccezione) che ci si può aspettare una seria guerra ai ladri di tasse. Testo tratto dal saggio di Stefano Livadiotti “Ladri - Gli evasori e i politici che li proteggono” (Bompiani).
Quanti furbetti sul portaborse. Lo Stato paga ai parlamentari oltre 3.500 euro al mese per l'assistente. Ma c'è chi se li intasca. Chi assume la moglie. E chi con quei soldi ingrassa le casse del suo partito. Mentre ai collaboratori vanno solo le briciole, scrive Primo Di Nicola su “L’Espresso” con la collaborazione di Giorgio Caroli, Cristina Cucciniello e Michela Giachetta. Ci sono quelli che non ce l'hanno, come il deputato del Pdl Simone Baldelli, e che i soldi del fondo per il portaborse se li mettono direttamente in tasca: "Sono vicecapogruppo alla Camera e non ho bisogno di assistenti personali", spiega: "Se mi serve qualcosa, mi affido ai collaboratori che lavorano per il gruppo". Ci sono gli altri che invece ce l'hanno, li contrattualizzano, ma con compensi da fame. È il caso di Soaud Sbai, parlamentare del centrodestra eletta in Puglia, che di collaboratori ne ha tre, uno dei quali, Nicola Nobile, pagato appena 500 euro al mese. E ci sono quelli, come il presidente della Camera Gianfranco Fini, già dotati di uno stuolo di segretari e collaboratori a carico del bilancio di Montecitorio, che non avendo bisogno di altri assistenti i soldi li destinano interamente al proprio partito: "Per un movimento politico nuovo come Futuro e Libertà", chiarisce, "è una risorsa importante visto che non percepisce neanche un centesimo di finanziamento pubblico". Ecco tre casi dalla giungla dei portaborse, assistenti, segretari, portavoce ed esperti dai titoli e incombenze tra le più strane e variegate, per i quali gli eletti ricevono ogni mese una ricca prebenda. Soldi in abbondanza, 3.690 euro per i deputati, 4.180 per i senatori (e vai a capire il perché di questa differenza) che dovrebbero consentire di stipulare contratti di lavoro regolari e soprattutto adeguatamente compensati. Invece, sia a Montecitorio che a Palazzo Madama le cose vanno in maniera del tutto diversa, con molti casi di lavoro in nero e compensi prossimi alla fame. Una vera macchia per il Parlamento che Fausto Bertinotti , ex presidente della Camera, nel 2007 provò a cancellare imponendo ai deputati il deposito di regolari contratti per concedere agli assistenti gli ambiti accrediti e i relativi badge per l'ingresso al palazzo di Montecitorio. Risultato? Un clamoroso fiasco, visto che ad avere depositato i contratti con i portaborse sono stati solo 236 su 630. Un andazzo che, sotto la spinta delle lamentele e delle denunce di alcuni assistenti ha spinto l'ufficio del lavoro di Roma ad aprire un'inchiesta, acquisire documenti e contratti da Camera e Senato e a convocare gli stessi portaborse. Le risultanze dell'ispezione dovrebbero arrivare entro tempi brevi, nel frattempo Fini e Renato Schifani, il presidente del Senato, hanno annunciato novità importanti sul trattamento degli assistenti che, sulla scorta di quanto succede al Parlamento europeo, a partire dalla prossima legislatura, grazie anche ad una apposita leggina, dovrebbero essere pagati direttamente dal Parlamento previo deposito dei regolari contratti. Ma sinora non si è visto niente. La legge per i portaborse è ancora allo studio mentre l'unica cosa certa è che i parlamentari dovranno rendicontare al massimo il 50 per cento del fondo erogato dalle Camere. Sul resto tutto rimarrà come prima. Già, ma come sono andate sinora le cose? Come si regolano gli onorevoli con questo fondo? Lo utilizzano davvero per assumere un assistente? Che tipo di contratto scelgono e quanto li pagano? "L'Espresso" ha interpellato un centinaio di parlamentari. Non tutti hanno risposto. Le spiegazioni fornite offrono comunque uno spaccato interessante sugli usi e gli abusi del fondo per i portaborse. Certo, sarebbe bello in epoca di invocata trasparenza, di tagli ai servizi e di grandi sacrifici richiesti ai cittadini, se i soldi stanziati per uno scopo preciso, come quello dell'assunzione di un assistente, venissero restituiti quando non sono utilizzati. Invece, ai vertici delle due Camere, tra coloro che si avvalgono di personale stipendiato direttamente dal Parlamento e che non hanno bisogno di altro personale (presidenti e vicepresidenti di Camera e Senato, segretari d'aula, questori, presidenti di commissioni, capigruppo), le cose vanno in maniera diversa. Come nel caso del presidente del Senato Schifani che a "l'Espresso" spiega di dedicare ("Nel pieno rispetto dell'attuale disciplina", puntualizza) una parte del fondo "a tutte le iniziative politiche e culturali che il parlamentare assume sul territorio quale rappresentante della nazione", mentre un'altra parte, "mediante ritenuta diretta sul proprio conto corrente", viene dal presidente del Senato versata al Pdl. Come se i partiti non ricevessero già dallo Stato, attraverso i cosiddetti rimborsi elettorali, cifre da capogiro ad ogni tornata elettorale. Sono infatti molti i parlamentari che destinano una parte del fondo alla forza politica di appartenenza. Gli eletti nel Pd e nell'Udc staccano ogni mese un assegno di 1.500 euro, 800 versano mediamente i parlamentari del Pdl, molto di più quelli della Lega. Spiega Massimiliano Fedriga, deputato del Carroccio: "Non ho un collaboratore a Roma, il servizio mi viene fornito dal gruppo parlamentare". E i soldi dei portaborse? Al partito, al quale versa circa 3 mila euro al mese, come tutti i colleghi lumbard. E non è finita. A Trieste, "dove sono coordinatore provinciale", aggiunge Fedriga, "usufruisco invece dei servizi di una società di comunicazione con una persona che mi segue e che rilascia regolare fattura". Al partito, ma non solo. Confessa Beatrice Lorenzin, deputata berlusconiana del Lazio: "Ho un assistente parlamentare che pago a fatica. E la ragione è presto detta: con i soldi del plafond della Camera finanzio la mia scuola di formazione politica e molte attività sul territorio, per le quali sono arrivata persino a dover andare a comprare i gazebo all'Ikea. Comunque", aggiunge la Lorenzin, "il mio collaboratore ha un contratto co.co.pro che mi è stato indicato dagli uffici della Camera, dove l'ho anche depositato". Il compenso? "Prende sui mille euro al mese, più bonus". Neanche Linda Lanzillotta, esponente dell'Api rutelliana spende tutto il fondo disponibile per pagarsi il portaborse. Attualmente, Lanzillotta dice di avere una giovane assistente, con contratto a tempo determinato e contributi previdenziali pagati. Sul trattamento economico non aggiunge di più anche se, afferma, "certamente non spendo tutto il contributo per l'assistente". Dove finiscono allora gli altri denari? Una parte, afferma, va all'attività di "documentazione ed elaborazione per il lavoro parlamentare"; il restante all'associazione Glocus di cui è presidente. Simone Baldelli non è il solo a mettersi in tasca tutti i soldi dei portaborse. A fare la cresta ci sono anche altri personaggi molto conosciuti. Come Andrea Ronchi, ex ministro per le Politiche comunitarie, da poco riapprodato nel Pdl: "Non ho collaboratori, faccio tutto da me", giura: "La mia attività è prevalentemente di livello europeo, investo in viaggi legati all'attività politica". O della levatura di Angelino Alfano. Il segretario del Pdl ha due collaboratori storici, un segretario particolare e una portavoce. Fino a qualche mese fa, cioè sino a quando è stato ministro della Giustizia, i due erano pagati direttamente dal ministero. Diventato segretario del Pdl, sono invece passati a carico del partito. Quando divenne Guardasigilli, inoltre, Alfano annunciò anche la chiusura del suo storico ufficio di Agrigento: "Per non rischiare contatti con ambienti strani", disse. Morale: senza spese sul territorio e con i collaboratori pagati prima da via Arenula e poi da via dell'Umiltà, Alfano ha potuto intascarsi comodamente l'intero ammontare del fondo. Anche quando va bene, cioè nei casi in cui contrattualizzano i portaborse, deputati e senatori non si rivelano però molto generosi. Rita Bernardini, deputata radicale che negli ultimi anni ha fatto le pulci al bilancio della Camera denunciandone sprechi e spese pazze , dice di avere due contratti depositati alla Camera. Uno di consulenza con l'avvocato Alessandro Gerardi, pagato 1.200 euro lordi, che per un legale non è certo un granché; l'altro, a progetto, con Valentina Ascione, compensata addirittura con meno: appena 900 euro lordi mensili. "Ma è tutto in regola", spiega l'onorevole, che rivela di aver superato brillantemente l'esame dell'Ispettorato del lavoro a cui ha inviato i contratti. Ciononostante, non prende bene l'intrusione de "l'Espresso": "Ma perché non chiamate anche chi fa battaglie sulla legalità e poi non ha nessun collaboratore?". Molto generoso con i portaborse è invece il senatore del Pdl Lucio Malan che alle due persone assunte nella propria segreteria in questa legislatura devolve in pratica l'intero importo del fondo per gli assistenti. Ma la ragione c'è: una, Maria Termini, è la moglie; l'altra, Ilenia, è la nipote dell'amata consorte. Ma per carità, nessuno scandalo a sentire Malan, che si giustifica dicendo di avere assunto la signora nel 2006 su richiesta del gruppo parlamentare di Forza Italia di cui era dipendente. Volendo il gruppo sfoltire i ranghi, aveva chiesto ai propri senatori di assorbire qualche segretaria. Malan ha preso la consorte ("Bravissima") e successivamente, la di lei nipote, di cui ha sempre rivendicato la grande professionalità. E poi dicono che i parlamentari non hanno fantasia. Per risparmiare, in molti si sono inventati il portaborse-sharing, l'assistente condiviso. A illustrare l'innovazione è il senatore democratico Roberto Della Seta che racconta di avere due contratti depositati. Uno con una collaboratrice in esclusiva, Sonia Pizzi; l'altro con Daniele Sivori, collaboratore a metà con il collega Francesco Ferrante, eletto in Umbria. Entrambi gli assistenti hanno un contratto a tempo determinato fino alla scadenza della legislatura, spiega Della Seta. Quanto al guadagno, portano a casa appena mille euro lordi al mese. Davvero poco, considerando che nel caso della Sivori lo stipendio è pagato a metà dai due senatori. Sono quelli che affermano di impiegare le risorse erogate dalle Camere interamente per il portaborse. Qualcuno, anzi, fa di più. Ermete Realacci, storico ambientalista democratico, ha due collaboratori contrattualizzati, Matteo Favaro e Francesca Biffi. La somma dei loro compensi, parola dell'onorevole, sarebbe addirittura superiore a 3.600 euro lordi. "Esattamente, spendo di più di quello che mi danno alla Camera". Realacci ha poi un altro giovane che lavora per lui a Pisa, suo collegio elettorale: a costui vanno invece solo 300 euro netti al mese. Anche Barbara Pollastrini ha due collaboratori con regolare contratto a progetto. Uno dei due, Ettore Siniscalchi, giornalista, spiega che l'onorevole versa 1.300 euro netti a ciascuno di loro. Calcolando tutti i costi, compresi quelli contributivi, i due assistenti finiscono per far spendere alla Pollastrini più dei 3 mila 600 euro erogati per i collaboratori dalla Camera: "Proprio così", dice Siniscalchi, "l'onorevole ci rimette". Veri maestri nell'arte di arrangiarsi con i portaborse sono gli avvocati-parlamentari, anche quelli di grido. Tra questi, il senatore Piero Longo, con Niccolò Ghedini storico difensore di Silvio Berlusconi. "Certo che ce l'ho", dice Longo: "Il mio collaboratore parlamentare è una collega di studio, l'avvocatessa Anna Desiderio". Una collega di studio? "Non c'è niente di strano, il rapporto è passato al vaglio della commissione del Senato ed è stato ritenuto congruo", spiega Longo senza fornire altre spiegazioni su questa fantomatica "commissione". Aggiunge il senatore: "A fine mese la collega rilascia regolare fattura anche per l'attività di mia assistente parlamentare. Lavora a Padova, non è necessario che venga a Roma, non mi serve ancora che mi si porti la borsa. Lei deve tenere i rapporti politici con la base e fungere da segreteria politica". Altro caso da manuale quello di Pierluigi Mantini, deputato eletto nel Pd ma passato all'Udc, professore universitario e avvocato residente a Milano. Mantini confessa con candore di avvalersi, per la sua attività parlamentare, dei ragazzi del suo studio legale. Li tiene a progetto o a partita Iva, dice. Sui dettagli, a cominciare dagli importi dei compensi, preferisce sorvolare, inutile insistere: "Scusatemi, non ho tempo, sono in palestra". Beato lui. Sono i parlamentari che, agganciati telefonicamente, accettano a malincuore di rispondere cercando comunque di tagliare la conversazione con vaghe promesse di continuare successivamente. Qualche caso: Ignazio Abbrignani, deputato del Pdl: "Ho un collaboratore con contratto depositato". Tipo di contratto? Retribuzione? "Non lo so, se ne occupa il mio commercialista. Glielo chiedo, la richiamo". Entro breve? "Sì sì, certamente...". Stiamo ancora aspettando. Peppino Calderisi, ex radicale, eletto nelle liste del Pdl: " Sono impegnato...", "richiami...". Lo abbiamo fatto, non ha più risposto. Colomba Mongiello, senatrice democratica: "Sono nel traffico, richiamatemi". Dopo più di un'ora il telefono squilla ma la senatrice nemmeno risponde. Michaela Biancofiore, altra berlusconiana. Dice di avere un collaboratore nel collegio di Bolzano, con un contratto a tempo indeterminato. Non dice il nome, né la retribuzione: "Non lo vengo certo a a dire a voi quanto pago i miei collaboratori". E a Roma, com'è organizzata? "Sto per fare un contratto ad un assistente". Di che tipo? "Non ho tempo, arrivederci...".
2015. I portaborse: "Siamo sfruttati e umiliati". Intanto l’onorevole fa la cresta sul rimborso. Collaboratori costretti a pagare le bollette. Altri inquadrati come colf per pagare meno contributi. Malgrado i parlamentari ricevano oltre 3500 euro al mese per regolarizzarli. E adesso gli assistenti chiedono di modificare la normativa. Per una maggiore trasparenza nell’uso dei soldi pubblici, scrive Paolo Fantauzzi su “L’Espresso”. Marta tutte le mattine varca l’ingresso della Camera dei deputati. Consegna la sua carta d’identità e riceve il badge di “ospite”. In realtà sarebbe una collaboratrice parlamentare a tutti gli effetti. Una portaborse, insomma. Per l’onorevole con cui lavora scrive discorsi, comunicati e prepara le interrogazioni. Ma lui non ne ha voluto sapere: troppi contributi da pagare. E così Marta si è dovuta piegare e ha firmato un contratto da colf, che prevede invece oneri fiscali e previdenziali bassissimi. Collaboratrice sì, ma familiare. E per andare al lavoro, nel tempio della democrazia, deve sottoporsi quotidianamente all’umiliazione della finta visitatrice accreditata come ospite. Nel luogo in cui si fanno le leggi Marta (il nome è di fantasia) è in buona compagnia: sia alla Camera che al Senato sono diverse le ragazze, tutte laureate come lei, formalmente assunte con un contratto da donna delle pulizie. Eppure i loro datori di lavoro ricevono in busta paga un apposito “rimborso delle spese per l’esercizio del mandato parlamentare” (quindi esentasse) con cui pagare i collaboratori, oltre che gestire l’ufficio e affidare consulenze e ricerche. Non si tratta di spiccioli: 3.690 euro al mese per i deputati e addirittura 4.190 per un senatore. Moltiplicando per il totale degli eletti, fanno 44 milioni l’anno. E il bello è che per avere diritto a queste somme basta rendicontare metà delle spese, il resto viene erogato forfettariamente. Insomma, come nel caso del finanziamento pubblico ai partiti formalmente abolito ma di fatto reintrodotto con un altro nome - si tratta di rimborsi di nome ma non di fatto. Ma proprio per questo l’onorevole con cui lavora Marta si comporta così: perché tutto quello che risparmia, se lo può mettere in tasca. Ed è grazie a questo perverso meccanismo che, nel tempio dove si fanno le leggi, ancora accade che i portaborse siano lavoratori in nero, inquadrati con finti contratti a progetto o pagati con stipendi da fame. Nel 2012 un’inchiesta dell’Espresso fece luce sul modo in cui venivano spesi questi soldi extra e scoprì tanti “furbetti” che facevano la cresta su questi fondi. Oggi non molto sembra essere cambiato, come racconta Andrea (nome di fantasia), che alla soglia dei 40 anni lavora per un parlamentare dell’opposizione a 600 euro al mese: «Pago regolarmente le sue bollette ma mi è anche capitato di andare a ritirare pacchi natalizi che gli avevano spedito. E non è nemmeno il peggio che possa capitare. Un collega è costretto a fare la spesa per la deputata che lo ha assunto e un altro ha perfino presentato delle pratiche di invalidità, come se fosse un’agenzia di servizi». Adesso qualcosa forse si muove. Stanchi di questa situazione, i collaboratori parlamentari si sono riuniti in associazione (Aicp, un’ottantina gli aderenti) e hanno deciso di uscire allo scoperto, chiedendo espressamente una modifica della normativa. Così da tutelare il loro lavoro, spesso indispensabile all’attività legislativa degli onorevoli, e far gestire in maniera trasparente i soldi pubblici. «Non abbiamo modo neppure di sapere quanti siamo esattamente» spiega Francesca Petrini, portavoce dell’Aicp al Senato: «Per far rilasciare ai loro assistenti il badge per l’accesso a Montecitorio o Palazzo Madama, i parlamentari devono depositare i contratti. Ma gli uffici di Questura, formalmente per motivi di privacy, non ci hanno mai voluto dare il numero preciso». Il modello vagheggiato è quello del Parlamento europeo: un contratto con maternità, ferie, contributi previdenziali pagati e livelli retributivi rispettosi delle mansioni svolte. Senza più dover dipendere dalla magnanimità del politico di turno né doversi ridurre a fare i collaboratori familiari, più che parlamentari. La soluzione sarebbe semplice: l’onorevole indica il collaboratore da contrattualizzare ma a pagare sono direttamente Camera e Senato. Risultato: niente più cresta né abusi. Soprattutto, senza spendere un euro in più di quanto avviene nella giungla attuale perché basterebbe prevedere come soglia massima lorda quella già attualmente erogata sotto forma di rimborso. Ci vorrebbe anche poco, fra l’altro, in virtù dell’autonomia che i due rami del Parlamento rivendicano ogni vota che si tratta di toccare qualche privilegio: una delibera degli Uffici di presidenza, come accaduto con la revoca dei vitalizi ai condannati . Del resto l’Italia, al contrario di Francia e Regno Unito, è l’unico Paese dove vige ancora il far west: per gli assistenti non è previsto alcun nessun riconoscimento giuridico, nessuna voce di spesa specifica o vincolata, controlli solo formali e in particolar modo zero trasparenza. Facile immaginare, però, che le resistenze sono fortissime, perché quei soldi extra fanno comodo a tutti: a chi se li mette in tasca così come a chi li versa ai partiti di appartenenza, a corto di risorse col taglio dei contributi pubblici (che finiranno definitivamente nel 2017). Non a caso il Parlamento sta facendo di tutto per non muovere un dito. Nel 2012 a Montecitorio fu approvata una proposta di legge che cercava di mettere ordine, ma a causa delle elezioni anticipate il provvedimento non è stato ratificato dal Senato. Nel 2013, con la nuova legislatura, si è deciso di seguire la strada degli ordini del giorno in occasione dell’approvazione dei bilanci. Ne sono stati approvati addirittura 4 per “disciplinare tempestivamente” la materia ma sono rimasti tutti lettera morta. Stessa scena l’estate scorsa al Senato, dove è stato approvato un generico odg della maggioranza per “valutare ulteriori misure idonee a disciplinare in modo trasparente il rapporto coi collaboratori”. Ma la valutazione evidentemente è ancora in corso…
LA POLEMICA SULLA NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E DEGLI SCRUTATORI.
La polemica sulla nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
E’ solo una guerra tra poveri.
Ogni anno, dappertutto in Italia ad ogni tornata elettorale, vi sono aspettative e delusioni e si scatena la tradizionale bagarre sulla nomina degli scrutatori e dei presidenti di seggio, col corollario di polemiche ed accuse contro i nominati.
L'accusa più ricorrente è che a svolgere le funzioni di scrutatore e presidente di seggio siano più o meno sempre gli stessi raccomandati.
Dichiarazione di Antonio Giangrande, presidente della “Associazione contro tutte le mafie”, noto autore di saggi pubblicati su Amazon, che raccontano questa Italia alla rovescia. «E’ come se l'ufficio di collocamento fosse gestito dai partiti politici, e ogni partito potesse fare assumere un certo numero di lavoratori, in base alla percentuale di voti ottenuti. Sarebbe ovviamente uno scandalo: ma è proprio questo che avviene con le attuali modalità di nomina. La differenza risiede solo nella durata dell'occupazione, ma la sostanza dell'ingiustizia è la stessa. Ma ci sono altri aspetti importanti da valutare. Facciamo chiarezza. Cominciamo dagli scrutatori che dal 2005 vengono scelti non più tramite sorteggio ma per nomina diretta da un comitato elettorale costituito da soggetti politici, i cui criteri di scelta sono discrezionali. Quindi per farsi scegliere bisogna presentare a loro le proprie referenze. Qualcuno, per orgoglio, non si abbasserà a tanto, ma è anche vero che la conoscenza conta, anche solo dei motivi della scelta necessaria rispetto ad altri candidati. Cosa diversa è per la nomina dei presidenti di Seggio-Sezione. In questo caso la scelta spetta al presidente della Corte d'Appello competente per territorio. In più vi è una circolare del 2009 del Ministero dell'Interno che, per limitare il verificarsi di problemi in un ruolo comunque delicato, di fatto invita a favorire chi, in passato, ha già svolto bene l'incarico, senza commettere errori o irregolarità. Per questo salta all’occhio la periodica nomina di alcuni presidenti di Seggio, evidentemente capaci, e questo unito al fatto che ai suddetti presidenti sono aggregati i soliti segretari da loro nominati (molte volte loro parenti). Spesso gli incarichi di segretario e presidente si alternano tra loro, ma da fuori sembra che sia sempre uguale ed ecco spiegato come mai, sopratutto nei piccoli comuni, vengano percepiti come "sempre gli stessi". Quello che la gente dovrebbe sapere, però, prima di incorrere in qualunquistici luoghi comuni è che le elezioni sono una cosa seria e gli adempimenti burocratici sono onerosi e dispendiosi. Il collegio deve essere formato da gente capace e dedita all’incarico. A volte ci si trova a dover coordinare persone svogliate, o che non sanno, o non possono, per handicap, o non vogliono scrivere. In questo modo l’ingranaggio si inceppa e la gente fuori fa la fila, impedita a votare. Gente che guarda caso si da appuntamento all’orario dello struscio e si accalca sempre negli orari di punta che sono sempre gli stessi: il pomeriggio tardi e la prima sera. E poi c’è che il sabato molti dei nominati non si presentano ed allora bisogna che il presidente chiami il primo soggetto disponibile che ha di fronte, la cui capacità è tutta da dimostrare. Per gli assenti della domenica, poi, non vi è sostituzione ed allora il collegio è monco. Ancora una cosa la gente non sa. Non è il far votare che stanca, ma l’aspetto burocratico con la redazione dei doppi verbali ed il bilanciamento dei numeri e la formazione dei pacchi. Inoltre vi è l’incognita dei rappresentanti di lista. Situazione da monitorare. Molti rappresentanti di lista sono nominati apposta per falsare od intralciare il regolare andamento della votazione. Ecco perché, spesso, le polemiche sono montate ad arte, specie se a presiedere il seggio vi è qualcuno non propenso ad agevolarli. Comunque le strumentali o fondate diatribe circa la nomina è solo una guerra tra poveri. Un solo dato attinente le ultime elezioni. Preparazione seggio al sabato dalle ore 16,00. Un paio di ore, se non tre, per autenticare le schede elettorali (bollatura e firmatura) e tutti gli altri adempimenti. La domenica apertura alle ore 07,00, ma con rientro almeno mezzora prima per istruire gli scrutatori. Cosa che nessun comune fa nei giorni precedenti al voto. Termine votazione alle ore 23,00. Spoglio e chiusura dopo almeno 3 ore. Ricapitolando: 3 ore al sabato ed una ventina la domenica. Sono 23 ore di lavoro impegnativo e di responsabilità, ricoprendo la qualità di pubblico ufficiale. Si percepisce 96 euro (un decina in più per il presidente). Fate i conti: 4 euro circa ad ora. La dignità e l’orgoglio imporrebbe a questo punto rendersi conto che è inutile alimentare una guerra tra poveri e favorire il clientelismo sostenuto dalle nomine, ma ribellarsi al fatto che ci hanno ridotto ad anelare quei 4 euro l’ora per una sola e misera giornata.»
LA VITTORIA CENSURATA DEL PARTITO DEL NON VOTO.
PD, 40% di che? Le elezioni e la vittoria del partito della protesta. Come i media manipolano la realtà.
Italia. Ha vinto il partito del “non voto”. Monta la protesta, ma i giornalisti la censurano.
Prendiamo per esempio le elezioni dei parlamentari europei del 25 maggio 2014. Dati ufficiali definitivi del Ministero dell’Interno tratti da suo portale. Affluenza:
6-7 giugno 2009 Italia+Estero 65,05%, Italia 66,46%;
25 maggio 2014 Italia+Estero 57,22%, Italia 58,68%;
Quindi si deduce che il partito del “non voto” si attesta in quest’ordine:
Italia + estero astenuti 21.671.202 ossia il 42,78%;
Italia astenuti 20.348.165 ossia il 41,32%;
Questo è il dato nazionale. Più eclatante e sintomatico se si tiene conto dei risultati nell’Italia meridionale, più incazzata verso questa politica qualunquista ed inconcludente. Spesso, corrotta.
Sardegna astenuti 58%
Sicilia astenuti 57,12%
Calabria astenuti 54,24
Puglia astenuti 48,48
Basilicata astenuti 50,44
Campania astenuti 48,92
A questi elettori astenuti bisogna aggiungere un altro milione e mezzo di elettori che hanno deciso di mandare “affanculo” i nostri politici direttamente nelle urne.
Schede bianche 577.856 1,99%;
Schede nulle 954.718 3,30%;
In tutto “i non voto” italiani sono il 47,29 %.
In più vi è quella parte che vede nel Movimento 5 Stelle il collettore ideale della loro protesta. 5.807.362, 21,15% Italia+estero, Italia 5.792.865, 21,16%.
In definitiva 22 milioni di italiani hanno deciso di protestare con il sistema del non voto, che i denigratori chiamano astensione.
Che diventano 29 milioni se si sommano a chi della protesta ne ha fatto un movimento. Movimento che non rappresenta tutte le aspettative della totalità dei protestanti, perché troppo giustizialista o violento verbalmente o troppo volto a sinistra. O perché si arroga il diritto di essere l’unico “partito degli onesti” di stampo dipietrista.
Tutta questa astensione malgrado il traino delle amministrative in quasi 4000 comuni e in due Regioni, l’Abruzzo e il Piemonte. Amministrative dove spesso e volentieri tutte le famiglie, (con parenti candidati) sono costrette ad andare a votare.
Da tener conto anche dell’exploit della Lega che, esportando in Europa la sua politica secessionista, ha tirato voti, nella prospettiva di far venir fuori l’Italia dall’Euro, tralasciando per il momento la sua battaglia di far venir fuori la Padania dall’Italia.
Bisogna che si capisca e farlo capire agli italiani ignari e corrotti da questa stampa, galoppina del Potere, che 29.011.138 di italiani si non rotti il cazzo di questi politici, delle loro ideologie e dei magistrati che li proteggono. (L’intercalare rende l’idea). Politici cooptati e nominati dalla nomenclatura tra i peggio. Lontani dai bisogni della gente ed ignari della realtà quotidiana di malati, disoccupati, carcerati, ecc…..
Il tanto decantato Renzi e il Pd, con il suo 40%, ha preso solo 11.172.861 voti in Italia o 11.203.231 + estero.
Insomma. In definitiva Renzi ed il Pd ha preso in effetti il 22%. Ossia solo 2 italiani su 10 lo hanno votato. E questo anche perché con i rossi non c’è protesta che tenga. Il loro voto ed il loro sostegno al partito non lo fanno mai mancare. Anche con candidati impresentabili. Addirittura alle prime ore delle aperture dei seggi, sia mai che arrivi la morte ad impedire quello che loro chiamano “senso civico”. E questo i presidenti di seggio lo sanno bene.
Ciononostante il giorno dopo della tornata elettorale ogni giornale o tg mistifica la realtà e porta l’acqua al mulino del partito di riferimento. E dato che sono tutti politicizzati, i giornalisti commentano la vittoria (inesistente) della loro parte politica o ne limitano da debacle.
Checche se ne dica: più di Grillo, più di Berlusconi, più di Alfano, più della Meloni, più di Salvini, più dei seguaci del greco Tsipras, più del prodigioso e mediatico Pd di Renzi, con un’affluenza in Italia al 57 per cento, 8 punti in meno rispetto al 65 del 2009, il partito più forte in Italia è il partito della protesta, ossia del “non voto”.
E’ strano, però, che nessuno ne renda conto e, cosa più importante, che i politici non se ne rendano conto.
Anzi, errata corrige. Ognuno di noi, “cittadini onesti ed immacolati” e ognuno di loro, “politici corrotti ed incapaci”, ha una spiegazione: "Uno Stato di coglioni...", commenta stizzito Emanuele Cozzolino del M5S. Commento che è fatto proprio da tutti gli schieramenti, rivolto verso chi non ha votato per la loro parte politica. Questo commento è fatto proprio anche da parte dei “Non votanti”, coacervo anarchico di idee confuse che si limita a protestare, senza proporre. Incapaci di aggregarsi tra loro o con gli altri per il sol fatto di essere composto da sedicenti prime donne. Se qualcuno di loro, poi, presenta la proposta e si candida ad attuarla, vien tacciato di essere come gli altri: “corrotto ed incapace”. In questo modo tarpandogli le ali.
Che alla fine abbia ragione Cozzolino? Con questi italiani ignavi (coglioni) non cambierà mai nulla? Si deve arrivare alla fame per dar vita alla rivoluzione?
IL BERLUSCONI INVISO DA TUTTI.
Quando la disinformazione è l’oppio dei popoli, che li rincoglionisce. I giornalisti corrotti ed incapaci ti riempiono la mente di merda. Anziché essere testimoni veritieri del loro tempo, si concentrano ad influenzare l’elettorato manovrati dal potere giudiziario, astio ad ogni riforma che li possa coinvolgere e che obbliga i pennivendoli a tacere le malefatte delle toghe.
Silvio Berlusconi: ossessione dei giornalisti di destra e di sinistra.
Il Caimano in prima pagina: vent'anni di copertine dell'Espresso. 88. La prima, il 5 ottobre del 1993. L'ultima, ma non ultima, il 25 novembre 2013. Ecco come l'Espresso ha sbattuto il Cavaliere in prima pagina.
5 ottobre 1993. Berlusconi a destra. Nuove Rivelazioni: QUI MI FANNO NERO! Dietro la svolta: Le ossessioni, la megalomania, la crisi Fininvest….
17 ottobre 1993. Esclusivo. I piani Fininvest per evitare il crac. A ME I SOLDI! Rischio Berlusconi. Rivelazioni. Il debutto in politica e l’accordo con segni. A ME I VOTI!
21 novembre 1993. Elezioni. Esclusivo: tutti gli uomini del partito di Berlusconi. L’ACCHIAPPAVOTI.
7 gennaio 1994. BERLUSCONI: LE VERITA’ CHE NESSUNO DICE. Perché entra in politica? Forse per risolvere i guai delle sue aziende? Che senso ha definirlo imprenditore di successo? Quali sono i suoi rapporti oggi con Crazxi? Cosa cambina se si impadronisse del Governo? Quali banchieri lo vedono già a Palazzo Chigi? Esistono cosi occulti nella Fininvest? Chi sono? Insomma: questo partito-azienda è una barzelletta o una cosa seria?
4 marzo 1994. Speciale elezioni. CENTO NOMI DA NON VOTARE. Dossier su: buoni a nulla, dinosauri, inquisiti, riciclati, voltagabbana.
11 marzo 1994. DIECI BUONE RAGIONI PER NON FIDARSI DI BERLUSCONI. Documenti esclusivi da: commissione P2, magistratura milanese, Corte costituzionale.
29 luglio 1994. Troppe guerre inutili. Troppi giochetti d’azzardo. Troppe promesse a vuoto. Troppo disprezzo degli altri. Troppe docce fredde per lira e borsa….LA FANTASTICA CANTONATA DEGLI ITALIANI CHE SI SONO FODATI DI BERLUSCONI.
26 agosto 1994. Tema del giorno. Atroce dubbio su Berlusconi: ci sa fare o è un…ASINO?
18 novembre 1994. Dossier Arcore: LA REGGIA. Storia di un Cavaliere furbo, di un avvocato, di un’ereditiera. Dossier alluvione. LA PALUDE. Storia di un governo ottimista e di una catastrofe.
14 aprile 1995. L’incubo di pasqua. Ma davvero la destra vince? VENDETTA!
9 giugno 1995. L’AFFARE PUBBLITALIA. Tre documenti eccezionali. 1. Dell’Utri. Viaggio tra i fondi neri. Della società che voleva conquistare un paese. 2. Berlusconi. Le prove in mano ai giudici: dal caso Berruti alla pista estera. 3. Letta. I verbali dei summit di Arcore. Con i big di giornali e televisioni Fininvest.
10 settembre 1995. Case d’oro/ esclusivo. L’ALTRA FACCIA DELLO SCANDALO. Rapporto sui raccomandati di sinistra. Rivelazioni: manovre ed imbrogli della destra.
17 settembre 1995. L’ALTRA FACCIA DI AFFITTOPOLI/NUOVE RIVELAZIONI. 745.888.800.000! Come, dove e quanto hanno incassato i fratelli Berlusconi rifilando palazzi e capannoni agli enti previdenziali.
25 ottobre 1995. SHOWMAN. Berlusconi ultimo grido. L’attacco a Dini e Scalfaro: astuzie, bugie, sceneggiate.
2 febbraio 1996. L’uomo dell’inciucio. Segreti, imbrogli, stramberie, pericoli…. SAN SILVIO VERGINE.
5 aprile 1996. Dall’album di Stefania Ariosto: festa con il cavaliere. C’ERAVAMO TANTO AMATI. Nuove strepitose foto/La dolce vita di Berlusconi & C. Caso Squillante/Tutto sui pedinamenti. E sui gioielli Fininvest. Se vince il Polo delle Vanità/Poveri soldi nostri…
24 ottobre 1996. D’Alema e Berlusconi: il nuovo compromesso. Origini, retroscena, pericoli. DALEMONI.
18 dicembre 1996. FORZA BUFALE. Rivelazioni. Chi e come alimenta la campagna contro Di Pietro. Qual è la fabbrica delle false notizie agghiaccianti sul Pool Mani Pulite. Che cosa fa acqua nei rapporti della Guardia di Finanza. I segreti dell’agenda di Pacini Battaglia. Le grandi manovre per l’impunità. E il ritorno di fiamma dell’amnistia….C’è in Italia un partito antigiudici. Ha capi, quadri, ha compagni di strada. Per vincere deve spararle sempre più grosse. Inchiesta su un malessere che non passa. E che nessuna riforma risolve.
3 maggio 1996. THE END.
10 aprile 1997. ALBANIA SHOW. Speciale/tragedie e polemiche, sceneggiate e pericoli.
3 agosto 2000. Esclusivo. Un rapporto dei tecnici della Banca d’Italia. COSI’ HA FATTO I SOLDI BERLUSCONI.
22 marzo 2001. LA CARICA DEI 121. Fedelissimi, folgorati e riciclati. Con loro Berlusconi vorrebbe governare l’Italia.
16 maggio 2001. L’AFFONDO. Berlusconi si gioca il tutto per tutto. Ma la partita è ancora aperta. Le urne diranno se sarà alba o tramonto.
24 magio 2001. E ORA MI CONSENTA. L’Italia alle prese con il Cavaliere pigliatutto.
19 dicembre 2001. GIUSTIZIA FAI DA ME. Sondaggio choc: i giudici, gli italiani e Berlusconi.
7 febbraio 2002. L’importante è separare la carriera degli imputati da quella dei giudici. L’ILLUSIONE DI MANI PULITE.
15 MAGGIO 2003. COMPARI. Negli affari, nella politica, nei processi. Berlusconi e Previti pronti a tutto. A riscrivere le leggi e a sconvolgere le istituzioni.
11 settembre 2003. Esclusivo. GLI ZAR DELLA COSTA SMERALDA. Le foto segrete dell’incontro Berlusconi-Putin.
29 gennaio 2004. RISILVIO. Vuole rifare il governo, rifondare Forza Italia, riformare lo Stato. E per cominciare si è rifatto.
13 maggio 2004. LE 1000 BUGIE DI BERLUSCONI. Il suo governo ha stabilito il record di durata. E anche quello delle promesse non mantenute. Ecco il bilancio.
24 giugno 2004. – 4.000.000. Ha perso voti e credibilità. Ora gli alleati gli presentano il conto. L’estate torrida del cavalier Silvio Berlusconi.
3 marzo 2005. AFFARI SUOI. Società e fiduciarie nei paradisi fiscali. Falsi in bilancio. Così Silvio Berlusconi dirottava i proventi del gruppo Mediaset sui diritti Tv.
7 aprile 2005. RISCHIATUTTO. Il voto delle regionali segnerà il destino dei duellanti. Romano Prodi e Silvio Berlusconi? Ecco che cosa ci aspetta dopo il verdetto delle urne.
21 aprile 2005. FARE A MENO DI BERLUSCONI. L’ennesima sconfitta ha chiuso un ciclo. Gli alleati del Cavaliere pensano al dopo. E a chi potrà prendere il suo posto.
2 febbraio 2006. PSYCHO SILVIO. Impaurito dai sondaggi tenta di rinviare la campagna elettorale. Occupa radio e tv. Promuove gli amici nei ministeri. Distribuisce una pioggia di finanziamenti clientelari. Così Berlusconi le prova tutte per evitare la sconfitta.
6 aprile 2006. DECIDONO GLI INDECISI. Identikit degli italiani che ancora non hanno scelto. Ma che determineranno l’esito del voto del 9 aprile.
9 novembre 2006. LA CASA DEI DOSSIER. Da Telecom-Serbia alle incursioni informatiche. Ecco il filo che lega le trame degli ultimi anni. Con un obbiettivo: delegittimare Prodi e la sinistra.
29 novembre 2007. Retroscena. VOLPE SILVIO. Il piano segreto di Berlusconi per far cadere Prodi e tornare al Governo. Fini e Casini azzerati. L’Unione sorpresa. Ma Veltroni è tranquillo. Non mi fanno paura.
24 aprile 2008. Elezioni. L’ITALIA DI B&B. Il ciclone Berlusconi. Il trionfo di Bossi. Lo scacco a Veltroni. E l’apocalisse della sinistra radicale rimasta fuori dal Parlamento.
15 maggio 2008. Inchiesta. LA MARCIA SU NAPOLI. Silvio Berlusconi arriva in città con il nuovo governo. Per liberarla dai rifiuti ma anche per spazzare via la sinistra da Comune e Regione.
25 giugno 2008. DOPPIO GIOCO. Si propone come statista. Aperto al dialogo. Ma poi Berlusconi vuole fermare i suoi processi. Ricusa i giudici. Vieta le intercettazioni. Manda l’esercito nelle città. Ed è solo l’inizio.
3 luglio 2008. Esclusivo. PRONTO RAI. Raccomandazioni. Pressioni politiche. Affari. Le telefonate di Berlusconi, Saccà, Confalonieri, Moratti, Letta, Landolfi, Urbani, Minoli, Bordon, Barbareschi, Costanzo….
19 febbraio 2009. Berlusconi. L’ORGIA DEL POTERE. L’attacco al Quirinale e alla Costituzione. Il caso Englaro. La giustizia. Gli immigrati. L’offensiva a tutto campo del premier.
19 marzo 2009. Inchiesta. PIER6SILVIO SPOT. Le reti Mediaset perdono ascolto. Ma fanno il pieno di pubblicità a scapito della Rai. Da quando Berlusconi è tornato al governo, i grandi inserzionisti hanno aumentato gli investimenti sulle tivù del cavaliere.
14 maggio 2009. SCACCO AL RE. Il divorzio chiesto da Veronica Lario a Berlusconi. Tutte le donne e gli amori del Cavaliere. La contesa sull’eredità. Le possibili conseguenze sulla politica.
11 giugno 2009. SILVIO CIRCUS. Per l’Italia la fiction: tra promesse fasulle e clamorose assenze come nel caso Fiat-Opel. Per sé il reality: le feste in villa e i voli di Stato per gli amici.
17 giugno 2009. Governo. ORA GUIDO IO. Umberto Bossi è il vero vincitore delle elezioni. E già mette sotto ricatto Berlusconi e la maggioranza. Nell’opposizione Di Pietro si prepara a contendere la leadership al PD, reduce da una pesante sconfitta.
25 giugno 2009. ESTATE DA PAPI. Esclusivo. Le foto di un gruppo di ragazze all’arrivo a Villa Certosa. Agosto 2008.
9 luglio 2009. Il vertice dell’Aquila. G7 E MEZZO. Berlusconi screditato dalle inchieste e dagli scandali cerca di rifarsi l’immagine. Con la passerella dei leader della terra sulle macerie. L’attesa per un summit che conferma la sua inutilità.
16 luglio 2009. SILVIO SI STAMPI. Tenta di intimidire e limitare la libertà dei giornalisti. Ma Napolitano stoppa la legge bavaglio. E i giornali stranieri non gli danno tregua. Umberto eco: “E’ a rischio la democrazia”.
23 luglio 2009. TELESFIDA. Tra Berlusconi e Murdoch è il corso una contesa senza esclusione di colpi. Per il predominio nella Tv del futuro. Ecco cosa succederà e chi vincerà.
30 luglio 2009. Esclusivo. SEX AND THE SILVIO. Tutte le bugie di Berlusconi smascherate dai nastri di Patrizia D’Addario. Notti insonni, giochi erotici, promesse mancate, E ora la politica si interroga: può ancora governare il paese?
12 agosto 2009. Governo. SILVIO: BOCCIATO. Bugie ed escort. Conflitti con il Quirinale. Assalti al CSM. Debito Pubblico. Decreti di urgenza. Soldi al Sud. Clandestini e badanti. Bilancio del premier Berlusconi. E, ministro per ministro, a ciascuno la sua pagella.
3 settembre 2009. DOPPIO GIOCO. Montagne di armi per le guerre africane. Vendute da trafficanti italiani a suon di tangenti. Ecco la Libia di Gheddafi cui Berlusconi renderà omaggio. Mentre l’Europa chiede di conoscere il patto anti immigrati.
10 settembre 2009. SE QUESTO E’ UN PREMIER. Si scontra con la chiesa. Litiga con l’Europa. Denuncia i giornali italiani e stranieri non allineati. E, non contento, vuol metter le mani su Rai 3 e La7.
1 ottobre 2009. GHEDINI MI ROVINI. Oggi è il consigliere più ascoltato del premier. Autore di leggi ad personam e di gaffe memorabili. Storia dell’onorevole-avvocato, dai camerati al lodo Alfano.
8 ottobre 2009. SUA LIBERTA’ DI STAMPA. Attacchi ai giornali. Querele. Bavaglio alle trasmissioni scomode della tv. Così Berlusconi vuole il controllo totale dell’informazione.
15 ottobre 2009. KO LODO. La Consulta boccia l’immunità, Berlusconi torna imputato. E rischia un’ondata di nuove accuse. Ma la sua maggioranza si rivolge alla piazza. E apre una fase di grande tensione istituzionale.
19 novembre 2009. LA LEGGE DI SILVIO. Impunità: è l’obbiettivo di Berlusconi. Con misure che annullano migliaia di processi. E con il ripristino dell’immunità parlamentare. Mentre Cosentino resta al governo dopo la richiesta di arresto.
16 dicembre 2009. SCADUTO. I rapporti con i clan mafiosi. Lo scontro con Fini. I guai con la moglie Veronica e con le escort. L’impero conteso con i figli. L’anno orribile di Silvio Berlusconi.
21 gennaio 2010. Palazzo Chigi. SILVIO QUANTO CI COSTI. 4.500 dipendenti. Spese fuori controllo per oltre 4 miliardi di euro l’anno. Sono i conti della Presidenza del Consiglio. Tra sprechi, consulenze ed eventi mediatici.
4 marzo 2010. UN G8 DA 500 MILIONI DI EURO. Quanto ci è costato il vertice tra la Maddalena e l’Aquila. Ecco il rendiconto voce per voce, tra sprechi e raccomandazioni: dal buffet d’oro ai posacenere, dalle bandierine ai cd celebrativi.
18 marzo 2010. SENZA REGOLE. Disprezzo della legalità. Conflitti con il Quirinale. Attacchi ai magistrati e all’opposizione. Scandali. E ora per la sfida elettorale Berlusconi mobilita la piazza. Con il risultato di portare il paese nel caos.
31 marzo 2010. STOP A SILVIO. Le elezioni regionali possono fermare la deriva populista di Berlusconi. Bersani: “Pronti al dialogo con chi, anche a destra, vuole cambiare”.
13 maggio 2010. IL CASINO DELLE LIBERTA’. Le inchieste giudiziarie. Gli scontri interni al partito. La paralisi del Governo. Dopo le dimissioni di Scajola, Berlusconi nella bufera.
27 maggio 2010. STANGATA DOPPIA. Prima il blocco degli stipendi degli statali, i tagli sulla sanità, la caccia agli evasori e un nuovo condono. Poi la scure sulle pensioni e un ritorno alla tassa sulla casa.
8 luglio 2010. I DOLORI DEL VECCHIO SILVIO. La condanna di Dell’Utri per mafia e il caso Brancher. La rivolta delle Regioni contro i tagli e l’immobilismo del governo. Le faide nel Pdl e i sospetti della Lega. Il Cavaliere alla deriva.
15 luglio 2010. SENZA PAROLE.
11 novembre 2010. BASTA CON ‘STO BUNGA BUNGA. BASTA LO DICO IO.
18 novembre 2010. QUI CROLLA TUTTO. Le macerie di Pompei. L’alluvione annunciata in Veneto. L’agonia della maggioranza. L’economia in panne. Per non dire di escort e bunga bunga. Fotografia di un paese da ricostruire.
16 dicembre 2010. La resa dei conti tra Berlusconi e Fini è all’atto finale. Chi perde rischia di uscire di scena. FUORI UNO.
22 dicembre 2010. FINALE DI PARTITA. Voti comprati. Tradimenti. Regalie…Berlusconi evita a stento la sfiducia, ma ora è senza maggioranza e deve ricominciare daccapo. Anche se resisterà, una stagione s’è chiusa. Eccola, in 40 pagine, di foto e ricordi d’autore.
27 gennaio 2011. ARCORE BY NIGHT. Un harem di giovanissime ragazze pronte a tutto. Festini, orge, esibizioni erotiche, sesso. L’incredibile spaccato delle serate di Berlusconi nelle sue ville. Tra ricatti e relazioni pericolose.
10 febbraio 2011. PRETTY MINETTI. Vita di Nicole, ragazza chiave dello scandalo Ruby. Intima di Berlusconi, sa tutto sul suo harem. Se ora parlasse.
26 maggio 2011. MADUNINA CHE BOTTA! Milano gli volta le spalle, Bossi è una mina vagante, il PDL spaccato già pensa al dopo. Stavolta Berlusconi ha perso davvero. Analisi di una disfatta. Che, Moratti o non Moratti, peserà anche sul governo.
21 giugno 2011. Esclusivo. VOI QUORUM IO PAPI. Domenica 12 giugno l’Italia cambia, lui no. Domenica 12 giugno l’Italia corre a votare, lui a villa Certosa a occuparsi d’altro. In queste foto, la wonderland del cavaliere. Lontana anni luce dal paese reale.
7 luglio 2011. Sprechi di Stato. IO VOLO BLU MA PAGHI TU. Il governo brucia centinaia di milioni per i suoi viaggi. E Berlusconi si regala due super elicotteri. A spese nostre.
21 luglio 2011. MISTER CRACK. La tempesta economica. La borsa in bilico. La paura del default. E un premier sempre isolato. Il varo della manovra è solo una tregua. Prima della resa dei conti. E spunta l’ipotesi di un governo guidato da Mario Monti.
25 agosto 2011. LACRIME E SANGUE. Diceva: ,meno tasse per tutti. Ma la pressione fiscale non è mai stata così alta. Chiamava Dracula gli altri. Ma ora è lui a mordere i soliti. Processo all’iniqua manovra d’agosto. Che ci cambuia la vita e non tocca gli evasori.
15 settembre 2011. E SILVIO SI TAGLIO’ 300 MILIONI DI TASSE. Il Premier impone il rigore agli italiani. Ma gli atti sulla P3 svelano le trame per evitare la causa fiscale sulla Mondadori. Dal presidente della Cassazione al sottosegretario Caliendo, ecco chi si è mosso per salvarlo dalla maximulta.
29 settembre 2011. SERIE B.
13 ottobre 2011. SQUALIFICATO. Condannato dalla Chiesa, mollato dagli imprenditori, bocciato dalle agenzie di rating. E’ l’agonia di un leader né serio né credibile che non si decide a lasciare. Denuncia Romano Prodi a “L’Espresso”: Qualsiasi governo sarebbe meglio del suo.
17 novembre 2011. THE END. Berlusconi tenterà di sopravvivere, ma ha dovuto prendere atto della fine del suo governo. Intanto la crisi economica si fa sempre più drammatica e la credibilità dell’Italia è ridotta a zero. Non c’è più tempo da perdere.
19 gennaio 2012. I GATTOPARDI. Crescita, liberalizzazioni, lotta all’evasione e alla casta…Monti è atteso alla prova più dura. Ma i partiti frenano. Come se avessero voluto cambiare tutto per non cambiare niente.
5 luglio 2012. RIECCOLO. Attacco euro e Merkel. Destabilizza il governo Monti. Blocca la Rai. E rivendica la leadership del suo partito. Così Berlusconi prova ancora una volta a farsi largo.
14 febbraio 2013. VI AFFONDO IO. Pur di risalire al china Silvio Berlusconi sfascia tutto accende la campagna elettorale con promesse da marinaio e terrorizza i mercati. Davvero può farcela? Chi lo fermerà? E come dovrebbe reagire il PD? L’Espresso lo ha chiesto a due guru.
19 settembre 2013. BOIA CHI MOLLA. Accettare il silenzio la decadenza o l’interdizione. O fare un passo indietro prima del voto. Berlusconi ha pronta una via d’uscita. Per restare il capo della destra.
29 novembre 2013. EXTRA PARLAMENTARE. Per Berlusconi si chiude un ventennio e comincia lo scontro finale: fuori dal Senato e in piazza, dalle larghe intese all’opposizione dura. Contro il governo, contro Napolitano, contro l’Europa…..
1977: quell'articolo premonitore di Camilla Cederna su Silvio Berlusconi. Uno splendido pezzo di una grande firma de "L'Espresso". Che aveva già capito tutto dell'ex Cavaliere, agli albori della sua ascesa. Il 9 maggio 2014 Silvio Berlusconi ha cominciato a scontare la pena per frode fiscale con il “servizio sociale” per gli anziani della Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Ma continua a dominare le tribune elettorali, convinto di un destino da «padre della patria» e dei risultati di Forza Italia. Inarrestabile, come è sempre stato. Ecco gli albori della sua ascesa descritti da Camilla Cederna sul numero de “l’Espresso” del 10 aprile 1977: un articolo in cui del personaggio si capiva già tutto e pubblicato proprio dal “L’Espresso” il 12 maggio 2014. In un ambiente di lusso, saloni uno via l’altro, prati di moquette, sculture che si muovono, pelle, mogano e palissandro, continua a parlare un uomo non tanto alto, con un faccino tondo da bambino coi baffi, nemmeno una ruga, e un nasetto da bambola. Completo da grande sarto, leggero profumo maschio al limone. Mentre il suo aspetto curato, i suoi modini gentili, la sua continua esplosione di idee piacerebbero a un organizzatore di festini e congressi, il suo nome sarebbe piaciuto molto a C.E. Gadda. Si chiama infatti Silvio Berlusconi. Un milanese che vale miliardi, costruttore di smisurati centri residenziali, ora proprietario della stupenda villa di Arcore dove vissero Gabrio Casati e Teresa Confalonieri (con collezione di pittori lombardi del ’500, e mai nessun nudo per non offendere la moglie, religiosissima), quindi della villa ex Borletti ai margini del parco di Milano. Allergico alle fotografie («magari anche per via dei rapimenti», spiega con un sorriso ironico solo a metà) è soddisfattissimo che nessuno lo riconosca né a Milano né in quella sua gemma che considera Milano 2. Siccome è la sua prima intervista, è felice di raccontarmi la sua vita felice. Media borghesia, il papà direttore di banca che, a liceo finito, non gli dà più la mancia settimanale; ma lui non si dispera, perché, mentre studia legge, lavora in vari modi: suonando Gershwin o cantando le canzoni francesi alle feste studentesche. Non solo, ma fra un trenta e lode e l’altro, fa il venditore di elettrodomestici, e la sua strada è in salita: da venditore a venditore capo a direttore commerciale. Dopo la sua tesi di laurea sulla pubblicità (il massimo dei voti) inizia la sua vera attività entrando successivamente in due importanti imprese di costruzione. A venticinque anni crea un complesso di case intorno a piazza Piemonte, ecco quindi la fortunatissima operazione di Brugherio, una lottizzazione destinata al ceto medio basso, mille appartamenti che van via subito; e preso dal piacere di raccontare, ogni tanto va nel difficile, dice “congesto”, macrourbanistica, architettura corale, la connotazione del mio carattere è la positività, “natura non facit saltus”. Il suo sogno sarebbe esser ricercato in tutto il mondo per fare città, e “chiamiamo il Berlusconi” dovrebbe essere l’invocazione di terre desiderose di espandersi. Di Milano 2, l’enorme quartiere residenziale nel Comune di Segrate, parla come di una donna che ama, completa com’è di ogni bellezza e comfort, e centomila abitanti, che a dir che sono soddisfatti è dir poco. Lui legge tutte le novità di architettura e urbanistica, qualche best-seller ogni tanto, rilegge spesso “L’utopia” di Tommaso Moro, sul quale vorrebbe scrivere un saggio. Si ritiene l’antitesi del palazzinaro, si ritiene un progressista, è cattolico e praticante, ha votato Dc; e «se l’urbanistica è quella che si contratta fra costruttori e potere politico, la mia allora non è urbanistica». Grazie, e vediamo cosa dicono gli altri di lui. Lo considerano uno dei maggiori speculatori edilizi del nostro tempo che, valendosi di grosse protezioni vaticane e bancarie, vende le case e prende i soldi prima ancora di costruirle, lucrando in proprio miliardi di interessi. Si lega prima con la base dc (Marcora e Bassetti), poi col centro, così che il segretario provinciale Mazzotta è il suo uomo. Altro suo punto di riferimento è il Psi, cioè Craxi, che vuoi dire Tognoli, cioè il sindaco. E qui viene contraddetta la sua avversione verso l’urbanistica come compromesso tra politici e costruttori. La società di Berlusconi è la Edilnord, fondata nel ’63 da lui e da Renzo Rezzonico, direttore di una società finanziaria con base a Lugano, liquidata nel ’71 per segrete ragioni. Viene fondata allora la Edilnord centri residenziali con le stesse condizioni della compagnia di prima: lo stesso capitale sociale (circa 10 mila dollari), la stessa banca svizzera che fa i prestiti (la International Bank di Zurigo), ed ecco Berlusconi procuratore generale per l’Italia. Nel ’71 il consiglio dei Lavori Pubblici dichiara ufficialmente residenziale la terra di Berlusconi (comprata per 500 lire al metro quadralo nel ’63 e venduta all’Edilnord per 4.250). Da Segrate (amministrazione di sinistra prima, poi socialista e dc) vengono concesse all’Edilnord licenze edilizie in cambio di sostanziose somme di danaro. Umberto Dragone, allora capo del gruppo socialista nel consiglio di Milano, pensa che l’Edilnord abbia pagato ai partiti coinvolti il 5-10 per cento dei profitti (18-19 miliardi) che si aspettava da Milano 2. (Qualche appartamento arredato pare sia stato dato gratis ad assessori e tecnici dc e socialisti. Certo è che questo regalo lo ha avuto un tecnico socialista che vive lì con una fotomodella). «II silenzio non ha prezzo, ecco il paradiso del silenzio », era scritto sulla pubblicità di questa residenza per alta e media borghesia. Ma il silenzio da principio non c’era. L’aeroporto di Linate è lì a un passo, ogni 90 secondi decollava un aereo, intollerabili le onde sonore, superiori a 100 decibel. Così l’Edilnord si muove a Roma, manovrando i ministeri, per ottenere il cambio delle rotte degli aerei. Approfittando della vicinanza di un ospedale, il San Raffaele, diretto da un prete trafficone e sospeso a divinis, don Luigi Maria Verzé, manda ai vari ministeri una piantina in cui la sua Milano 2 risulta zona ospedaliera e la cartina falsa verrà distribuita ai piloti (con su la croce, simbolo internazionale della zona di rispetto), così le rotte vengono cambiate spostando l’odioso inquinamento da rumore da Milano 2 alla sezione nord-est di Segrate che per anni protesterà invano: e il prezzo degli appartamenti viene subito triplicato. Altre notizie. Berlusconi sta mettendo in cantiere la sua nuova Milano 3 nel Comune di Basiglio a sud della città, con appartamenti di tipo “flessibile”, cioè con pareti che si spostano secondo le esigenze familiari. In settembre comincerà a trasmettere dal grattacielo Pirelli la sua Telemilano, una televisione locale con dibattiti sui problemi della città, un’ora al giorno offerta ai giornali (egli possiede il 15 per cento del “Giornale” di Montanelli). «Troppi sono oggi i fattori ansiogeni», dice, «la mia sarà una tv ottimista». Staff di otto redattori, più tecnici e cameramen, quaranta persone in tutto. E pare che in questo suo progetto sia stato aiutato dall’amico Vittorino Colombo, ministro delle Poste e della Tv. Berlusconi aveva anche pensato di fondare un circolo di cultura diretto da Roberto Gervaso; la sua idea preferita però era quella di creare un movimento interpartitico puntato sui giovani emergenti, ma per adesso vi ha soprasseduto. Gli sarebbe piaciuto anche diventare presidente del Milan, ma la paura della pubblicità lo ha trattenuto. Massima sua aspirazione sarebbe infine quella di candidarsi al Parlamento europeo. Ci tiene anche a coltivare al meglio la sua figura di padre, cercando di avere frequenti contatti coi suoi figlioletti. Quel che deplora è che dalle elementari di adesso sia stato esiliato il nozionismo: a lui le nozioni, in qualsiasi campo, hanno giovato moltissimo. Camilla Cederna.
1977: Berlusconi e la pistola. Il fotografo Alberto Roveri decide di trasferire il suo archivio in formato digitale. E riscopre così i ritratti del primo servizio sul Cavaliere. Immagini inedite che raccontano l'anno in cui è nato il suo progetto mediatico. Con al fianco Dell'Utri. E un revolver sul tavolo per difendersi dai rapimenti, scrive Gianluca Di Feo su “L’Espresso”. Formidabile quell'anno. È il 1977 quando il Dottore, come l'hanno continuato a chiamare i suoi collaboratori più intimi, diventa per tutti gli italiani il Cavaliere: il cavaliere del Lavoro Silvio Berlusconi. L'onorificenza viene concessa dal presidente Giovanni Leone all'imprenditore quarantenne che ha tirato su una città satellite, sta comprando la maggioranza del "Giornale" di Indro Montanelli e promette di rompere il monopolio della tv di Stato. È l'anno in cui il neocavaliere stabilisce rapporti fin troppo cordiali con il vertice del "Corriere della Sera" e in un'intervista a Mario Pirani di "Repubblica" annuncia di volere schierare la sua televisione al fianco dei politici anticomunisti. Fino ad allora lo conoscevano in pochi e soltanto in Lombardia: era il costruttore che aveva inventato Milano Due, la prima new town che magnificava lusso, verde e protezione a prova di criminalità. Il segno di quanto in quella stagione di terrorismo e rapine, ma soprattutto di sequestri di persona, la sicurezza fosse il bene più prezioso. E lui, nella prima di queste foto riscoperte dopo trentatre anni, si mostra come un uomo d'affari che sa difendersi: in evidenza sulla scrivania c'è un revolver. Un'immagine che riporta a film popolari in quel periodo di piombo, dai polizieschi all'italiana sui cittadini che si fanno giustizia da soli agli esordi pistoleri di Clint Eastwood. "Con una Magnum ci si sente felici", garantiva l'ispettore Callaghan e anche il Cavaliere si era adeguato, infilando nella fondina una piccola e potente 357 Magnum. È stato proprio quel revolver a colpire oggi il fotografo Alberto Roveri mentre trasferiva la sua collezione di pellicole in un archivio digitale: "Le stavo ingrandendo per ripulirle dalle imperfezioni quando è spuntata quell'arma che avevo dimenticato". Come in "Blow Up" di Antonioni, a forza di ingrandire il negativo appare la pistola: "All'epoca quello scatto preso da lontano non mi era piaciuto e l'avevo scartato". Roveri era un fotoreporter di strada, che nel 1983 venne assunto dalla Mondadori e negli anni Settanta lavorava anche per "Prima Comunicazione", la rivista specializzata sul mondo dei media: "Quando nel 1977 il direttore mi disse che dovevo fare un servizio su Berlusconi, replicai: "E chi è?". Lui rispose: "Sta per comprare il "Giornale" e aprire una tv. Vedrai che se ne parlerà a lungo"". Quella che Roveri realizza è forse la prima serie di ritratti ufficiali, a cui il giovane costruttore volle affidare la sua immagine di vincente. L'incontro avvenne negli uffici Edilnord: "Fu di una cordialità unica, ordinò di non disturbarlo e si mise in posa. Con mio stupore, rifiutò persino una telefonata del sindaco Tognoli". Il solo a cui permise di interromperlo fu Marcello Dell'Utri, immortalato in un altro scatto inedito che evidenzia il look comune: colletti inamidati e bianchi, gemelli ai polsini, pettinature simili. Sono una coppia in sintonia, insieme hanno creato una città dal nulla, con un intreccio di fondi che alimentano sospetti e inchieste. Una coppia che solo pochi mesi dopo si dividerà, perché Dell'Utri seguirà un magnate molto meno fortunato: Filippo Alberto Rapisarda, in familiarità con Vito Ciancimino. Tornerà indietro nel 1982, organizzando prima il colosso degli spot, Publitalia, e poi quello della politica, Forza Italia. La loro storia era cominciata nel 1974, trasformandosi da rapporto professionale in amicizia. Dell'Utri è anche l'amministratore di Villa San Martino, la residenza di Arcore. E dopo pochi mesi vi accoglie uno stalliere conosciuto a Palermo che fa ancora discutere: Vittorio Mangano, poi arrestato come assassino di Cosa nostra. Una presenza inquietante, che per la Procura di Palermo suggella le intese economiche con la mafia in cambio di tutela contro i sequestri. Nel 1977 però Mangano è già tornato in Sicilia. E Berlusconi tanto sereno non doveva sentirsi, come testimonia il revolver nella fondina. Ricorda il fotografo Roveri: "Dopo più di due ore di scatti mi invitò a pranzo ma prima di uscire tirò fuori da un cassetto due pistole, una per sé e una per l'autista. Di fronte alla mia sorpresa, si giustificò: "Ha idea di quanti industriali vengono rapiti?". Poi siamo saliti su una Mercedes che lui definì "blindatissima" per raggiungere un ristorante a soli 200 metri da lì". Sì, quelli in Lombardia erano anni cupi, prima che, grazie anche a Canale 5, alla nebbia di paura si sostituisse il mito luccicante della Milano da bere. Dall'archivio di Roveri ricompare il momento della svolta, quando si cominciano a materializzare i pilastri dell'impero del Biscione tra partiti, media e relazioni molto particolari. È la festa del 1978 che trasforma il Cavaliere in Sua Emittenza, con l'esordio di Telemilano nelle trasmissioni via etere. La politica ha il volto di Carlo Tognoli, sindaco socialista che per un decennio guida la metropoli mentre passa dagli scontri di piazza al jet set danzante della moda. Un personaggio defilato rispetto alla statura del grande sponsor di Berlusconi, quel Bettino Craxi che ne ha sorretto la crescita con decreti su misura, ricevendo in cambio spot e finanziamenti. Li univa la stessa cultura del fare che dà scarso peso alle regole, la stessa visione di una politica sempre più spettacolo, fino a plasmare la società italiana di oggi. In questa metamorfosi tutta televisiva la carta stampata ha avuto un ruolo secondario. All'epoca però l'attenzione era ancora concentrata sul "Corriere della Sera", la voce della borghesia lombarda. In questi scatti il direttore Franco Di Bella ammira soddisfatto il giovane Silvio. Rapporti letti in un'ottica molto più ambigua dopo la scoperta della P2: negli elenchi di Licio Gelli c'erano Di Bella, il direttore generale della Rizzoli Bruno Tassan Din e l'editore Angelo Rizzoli. E c'era pure il nome di Berlusconi, data di affiliazione gennaio 1978, anche se lui ha sempre negato l'iscrizione alla loggia delle trame. Sin da allora le smentite a qualunque costo sono un vizio del Cavaliere a cui gli italiani si sono abituati. Come i divorzi, che segnano la sua carriera professionale, quella politica e la vita privata. Nelle foto del party al fianco di Silvio c'è Mike Bongiorno, il testimonial della sua ascesa mediatica. Resteranno insieme tra alti e bassi fino al 2009: un altro legame chiuso con una rottura burrascosa. E c'è anche Carla Dall'Oglio che si offre ai flash sorridente, afferrando per il braccio un marito dall'aria distaccata. Lei ha 37 anni e da dodici è la signora Berlusconi: poco dopo, nel 1980, quella scena di ostentata felicità sarà spazzata via dal colpo di fulmine per Veronica Lario. Il divorzio è arrivato nel 1985, consolidato da una manciata di miliardi e da una decina di immobili: da allora Carla Dall'Oglio è scomparsa dalla ribalta, dove però sono sempre più protagonisti i suoi figli Marina e Piersilvio, i nuovi Berlusconi.
Contro Berlusconi la sinistra contrappone i suoi miti.
San Berlinguer martire e apostolo. È in atto la costruzione di un Mito, l'invenzione di un Grande. Serve a nobilitare il comunismo passato. A deprecare il presente renziano, scrive Marcello Veneziani su “Il Giornale”. San Berlinguer, il Terzo Santo. Dopo i film, i libri, gli inserti, ora un largo Berlinguer al centro di Roma e la canonizzazione proclamata da Napolitano in un libro-intervista, Quando c'era Berlinguer, curato da Veltroni. È in atto la costruzione di un Mito, l'invenzione di un Grande. A cosa serve? A nobilitare il comunismo passato. A deprecare il presente renziano. A rianimare un partito spaesato. A cercare nel vintage un titolo di nobiltà. A rifarsi le labbra col silicone moralista. A lanciare qualcuno per il Quirinale. Berlinguer non aveva la statura di Togliatti e, quanto a svolte, fu più ardito Occhetto, seppur col favore dei muri crollati. Berlinguer era modesto, per lunghi anni allineato anche ai più sordidi eventi, mestamente comunista, non lasciò tracce importanti, si oppose alla socialdemocrazia e la storia gli dette torto, considerò il Partito come l'Assoluto. Fu una persona onesta, per bene, ma basta la sua decorosa mediocrità per farne un santo con relativa agiografia? In realtà, tramite la copiosa apologetica su di lui, si vuol celebrare il popolo di sinistra. Berlinguer è un pretesto narrativo per santificare gli eredi. L'industria del santino che abbina il leader del Pci a Papa Francesco (Scalfari dixit) è all'opera. Rischiamo un pantheon di fuffa, tra finti eroi e finti geni, finti grand'uomini e palloni gonfiati, sfornati dalla Ditta Tarocco che produce falsi d'autore. Il P.C. oggi si traduce con Politically Correct. Finite le sciagurate illusioni, la sinistra passò all'illusionismo.
Peccato però che davanti ai soldi, così come al pelo, tutti si arrendono alle tentazioni.
Ci sono giornalisti che forse Tangentopoli la rimpiangono, del resto segnò la loro giovinezza, la travolgente eccitazione di un periodo rivoluzionario, fatto di personaggi straordinari, copie alle stelle, carriere in decollo: vien da pensarlo, scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”. Facciamo due esempi: 1) Il pm di Reggio Calabria voleva contestare a Scajola e agli altri arrestati anche l’aggravante mafiosa, ma il gip l’ha negata perché mancavano prove e anche solo indizi. L’ha confermato lo stesso pm su Libero di sabato, dunque era noto. Bene, ecco l’apertura di prima pagina del Corriere di domenica: «Scajola indagato per mafia»; testo di prima pagina: «La stessa ipotesi di reato sarà contestata a tutte le persone sospettate di aver favorito la latitanza di Amedeo Matacena». Un falso. Una notizia manipolata, nella migliore delle ipotesi. 2) Secondo esempio. Questa è l’apertura di prima pagina del Messaggero di domenica: «Appalto Expo, c’è la ’ndrangheta»; sottotitolo: «I pm di Milano: legami tra gli arrestati e le cosche"; testo di prima pagina: «La cupola di Frigerio, Greganti e Grillo avrebbe avuto legami anche con la ’ndrangheta». Ah sì? E allora perché l’aggravante non è stata neppure contestata? Risposta: perché non importa, l’aggravante mafiosa ormai è come una spezia per insaporire inchieste e resoconti. E poi scrivere, una tantum: uh, torna tangentopoli, magari.
Montanelli stronca Travaglio. In materia di giustizia Montanelli smentisce il capofila dei giornalisti forcaioli anche dall'oltretomba, scrive Alessandro Sallusti su “Il Giornale”. Il tintinnio di manette riaccende gli entusiasmi di Marco Travaglio, capofila dei giornalisti forcaioli tanto cari alle procure. Si è autonominato erede unico del pensiero di Indro Montanelli, del quale millanta (sapendo di non poter essere smentito) l'amicizia e la stima. Sarà, ma il vecchio Indro, che non ha mai amato presunti portavoce, lo smentisce anche dall'oltretomba. E che smentita. È contenuta in un articolo scritto su Il Giornale il 13 luglio dell'81. Il giorno prima Spadolini aveva ottenuto la fiducia del suo primo governo ma il Pci annunciava sfaceli perché il neopremier aveva posto con forza la questione della riforma di una giustizia già malata allora. Ecco come commentava l'accaduto Montanelli: «Riduciamo i termini all'osso. Ci sono state, per eccesso di garantismo istruttorie svogliatamente durate anni e concluse con assoluzioni poco meno che scandalose; mentre ci sono le manette per reati che non le comportano obbligatoriamente, seguiti da procedimenti penali che, anche quando si concludono col proscioglimento da ogni accusa, segnano la rovina materiale e morale di chi ne è stato bersaglio». E ancora: «Non è possibile andare avanti con queste invasioni di campo della magistratura che sono arrivate a tal punto da rendere plausibile il sospetto che certi magistrati le pratichino non per ristabilire l'ordine ma per sovvertirlo, scatenando caccia alle streghe e colpendo all'impazzata». Aggiungeva Montanelli: «Questi magistrati sono inamovibili, impunibili, promossi automaticamente, pagati meglio di qualsiasi altro dipendente pubblico, incensati dai giornali di sinistra (cioè dalla maggioranza) e molto spesso malati di protagonismo». E ancora: «I comunisti non possono rinunciare alla magistratura com'è. Essa costituisce la più potente arma di scardinamento e di sfascio di cui il Pci dispone». E chiudeva: «Questa non è la magistratura, è solo il cancro della magistratura. Ma che è già arrivato allo stadio di metastasi». Trent'anni dopo siamo ancora lì. I giornali di sinistra (più Travaglio) a fare da addetti stampa a magistrati eversivi ed esibizionisti, noi de Il Giornale a puntare il dito sul «cancro della magistratura» che sta distruggendo il Paese. E siamo fermi anche nel puntare il dito contro ladri e mascalzoni. Ma contro tutti i mascalzoni (anche se di sinistra, anche se magistrati) e soprattutto se davvero ladri oltre ogni ragionevole dubbio.
Chissà qual è la verità tra tutte quelle propinate dai pennivendoli.
Esposito, da Antonio a Vitaliano: una famiglia di toghe tra gaffe e scivoloni, scrive “Libero Quotidiano”. Una famiglia spesso in prima pagina, e non sempre in buona luce. Quella degli Esposito è una storia fatta di toghe, giustizia, scivoloni e gossip. Il più famoso è ormai Antonio Esposito, presidente della sezione feriale della Cassazione (nonché alla guida dell'Ispi) che lo scorso agosto condannò Silvio Berlusconi al processo sui diritti tv Mediaset e che, pochi giorni dopo, anticipò le motivazioni di quella sentenza in una improvvida conversazione con un abile cronista del Mattino. Inevitabili il polverone delle polemiche e le accuse di parzialità del collegio giudicante, anche perché un testimone riferì di presunti commenti contro Berlusconi rilasciati in libertà dal giudice durante una cena. Pare probabile che il Csm voglia archiviare il caso senza procedere a sanzioni disciplinari. La figuraccia, in ogni caso, resta, con tanto di richiamo del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in quelle caldissime settimane di fine estate 2013, alla "continenza" per chi di mestiere fa il giudice. Le bucce di banana per la Esposito family non finiscono qui: l'ultimo a inciamparci è il figlio di Antonio, Ferdinando Esposito. Pubblico ministero a Milano, risulta indagato a Brescia e a Milano in seguito alle accuse di un suo amico avvocato, che sostiene di avergli prestato soldi e di essere stato "pressato" per pagargli l'affitto di casa. Prima ancora, era finito al centro del gossip per un incontro con Nicole Minetti (sotto processo per il Rubygate) avvenuto in un prestigioso ristorante milanese nel 2012. L'altro ramo della famiglia è altrettanto prestigioso: Vitaliano Esposito, fratello di Antonio, è stato Procuratore generale della Cassazione. Sempre sul finire dello scorso agosto è stato "paparazzato" in spiaggia nel suo stabilimento abituale ad Agropoli, nel Cilento. Piccolo particolare: lo stabilimento era abusivo. Foto imbarazzante, invece, per sua figlia Andreana Esposito, giudice alla Corte europea dei diritti dell'Uomo. Un po' di clamore aveva suscitato lo scatto da lei pubblicato sui social network (e poi cancellato in fretta e furia) in cui esibiva una maglietta decisamente inappropriata per una toga: "Beato chi crede nella giustizia perché verrà... giustiziato", slogan che aveva messo in allarme lo stesso Cavaliere, che di lì a qualche mese si sarebbe rivolto proprio alla Corte europea per vedere ribaltata la sentenza stabilita dallo zio di Andreana. Un corto circuito da barzelletta.
Quando gli attacchi al governo italiano vengono da fuori.
Usa, l'ex ministro del Tesoro: "Nel 2011 complotto contro il Cav". Le rivelazioni choc di Geithner, ex ministro del Tesoro Usa, nel saggio Stress test: "Alcuni funzionari europei ci contattarono con una trama per costringere Berlusconi a cedere il potere". Ma a Obama disse: "Non possiamo avere il suo sangue sulle nostre mani", scrive Andrea Indini su “Il Giornale”. Al G20 del 2011 funzionari europei chiesero agli Stati Uniti di aderire a un "complotto" per far cadere l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nel memoir Stress test, anticipato oggi dalla Stampa e dal Daily Beast, Timothy Geithner, ex ministro del Tesoro americano, aggiunge nuovi, inquietanti tasselli al golpe ordito contro il Cavaliere per cacciarlo da Palazzo Chigi e mettere al suo posto Mario Monti, un tecnico scelto ad hoc per far passare le misure lacrime e sangue imposte da Bruxelles e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. "Ma a Obama dissi: 'Non possiamo avere il suo sangue sulle nostre mani'", racconta ancora Geithner nel volume che ripercorre la disastrosa situazione finanziaria che spinse quei funzionari a progettare il "complotto". Le prime indiscrezioni su un golpe ai danni di Berlusconi sono state appena sussurrate. E, inevitabilmente, i media progressisti hanno fatto a gara per distruggerle. Oggi, invece, Geithner spazza via qualunque dubbio sul drammatico piano che il 12 novembre del 2011, con lo spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi artificiosamente pompato sopra i 470 punti, Berlusconi si dimise dopo l'approvazione della legge della stabilità alla Camera. Ebbene, dietro a quelle dimissioni c'è un vero e proprio piano ordito a Bruxelles per far cadere un governo eletto democraticamente e piazzarne uno tecnico e asservito ai diktat dell'Unione europea. "Ad un certo punto, in quell'autunno, alcuni funzionari europei ci contattarono con una trama per cercare di costringere il premier italiano Berlusconi a cedere il potere - svela oggi Geithner - volevano che noi rifiutassimo di sostenere i prestiti dell’Fmi all’Italia, fino a quando non se ne fosse andato". Dal 26 gennaio 2009 al 28 febbraio 2013 Timothy Geithner ricopre, infatti, l'incarico di segretario al Tesoro degli Stati Uniti durante il primo governo presieduto da Barack Obama. L'obiettivo degli innominati "funzionari europei" è quello di accerchiare Berlusconi, anche attraverso i ricatti del Fondo monetario internazionale, pur di farlo uscire di scena. Il golpe non viene organizzato su due piedi, ma iniziò a essere tessuto nell'estate del 2010, quando "i mercati stavano scappando dall'Italia e la Spagna, settima e nona economia più grande al mondo". Nel saggio Stress test Geithner scrive di aver consigliato più volte ai colleghi europei di essere prudenti: "Se volevano tenere gli stivali sul collo della Grecia, dovevano anche assicurare i mercati che non avrebbero permesso il default dei paesi e dell’intero sistema bancario". Ma all’epoca Germania e Francia "rimproveravano ancora al nostro West selvaggio la crisi del 2008" e rifiutavano i consigli del Tesoro statunitense che chiedeva di mobilitare più risorse per prevenire il crollo economico del Vecchio Continente. Nell’estate del 2011 la situazione precipita. "La cancelliera Angela Merkel insisteva sul fatto che il libretto degli assegni della Germania era chiuso - racconta l'ex segretario del Tesoro - non le piaceva come i paesi che ricevevano assistenza europea (Spagna, Italia e Grecia) stavano facendo marcia indietro sulle riforme promesse". Quando a settembre Geithner arriva in Polonia per partecipare all'Ecofin, propone ai Paesi dell'Eurozona di adottare un piano simile al Term asset-backed securities loan facility (Talf), il muro di protezione creato dalla Federal reserve e finanziato dal governo e soprattutto dalla banca centrale per impedire insieme il default dei Paesi e delle banche. Viene quasi insultato. "Gli americani, però - continua Geithner - ricevevano spesso richieste per fare pressioni sulla Merkel affinchè fosse meno tirchia, o sugli italiani e spagnoli affinchè fossero più responsabili". È proprio in questo quadro inquietante di supponenza tedesca e incompetenza europea che arrivano le prime pressioni per cambiare il governo italiano. A G20 di Cannes lo stesso governatore della Bce, Mario Draghi, gli promette "l'uso di una forza schiacciante". "Parlammo al presidente Obama di questo invito sorprendente - racconta Geithner - ma per quanto sarebbe stato utile avere una leadership migliore in Europa, non potevamo coinvolgerci in un complotto come quello". Nonostante il niet degli Stati Uniti, i "funzionari europei" riescono nell'intento: nel giro di poche settimane si dimette il premier greco George Papandreou, Berlusconi viene sostituito con Monti ("un economista che proiettava competenza tecnocratica") e in Spagna viene eletto Mariano Rajoy. A dicembre la Bce approva il piano per finanziare per le banche. Piano che viene accolto con euforia da Bruxelles che si fionda a dichiarare che l'Europa è uscita dal tunnel della crisi. "Io non la pensavo così", sottolinea l'ex segretario del Tesoro. E, infatti, nel giugno del 2012 la minaccia del default tornerà a mettere in ginocchio i mercati del Vecchio Continente.
Gli Stati Uniti: "Funzionari Ue ci chiesero di far cadere Silvio Berlusconi", scrive “Libero Quotidiano”. Non solo Monti. Non solo Napolitano. Non solo Prodi. Anche a Barack Obama fu chiesto da alcuni funzionari europei di prendere al complotto per far cadere Silvio Berlusconi. A fare pressioni sul presidente Usa furono alcuni funzionari europei, che proposero ad Obama un piano per far crollare l'esecutivo, nell'infuocato 2011. Gli Stati Uniti, però, si sottrassero al complotto: "Non possiamo avere il suo sangue sulle nostre mani". La fonte di tali rivelazioni? Niente meno che l'ex ministro del Tesoro, Timothy Geithner, che spiega quanto accaduto in un libro di memorie uscito lunedì, Stress Test, e anticipata dalla stampa. Dopo il il libro-rivelazione di Alan Friedman, Ammazziamo il gattopardo, che svelava le indebite e (troppo) preventive pressioni di Giorgio Napolitano su Mario Monti, ecco un nuovo pamphlet destinato a fare molto rumore politico. Geithner, uno degli uomini più potenti degli States, scrive: "Ad un certo punto in quell'autunno, alcuni funzionari europei ci contattarono con una trama per cercare di costringere il premier italiano Berlusconi a cedere il potere; volevano che noi rifiutassimo di sostenere i prestiti del Fmi all'Italia, fino a quando non se ne fosse andato". L'ennesima prova al fatto che l'Europa berlinocentrica voleva far fuori lo Stivale e il suo presidente del Consiglio. Geithener si riferisce ai mesi più difficili per l'Italia, alle prese con le bizze dello spread, nell'autunno 2011. In particolare le richieste agli Stati Uniti furono avanzate già a settembre 2011, prima che lo spread raggiungesse i massimi, quando in Polonia all'Ecofin ricevette richieste per "fare pressioni sulla Merkel affinché fosse meno tirchia, o sugli italiani e gli spagnoli affinché fossero più responsabili". Contestualmente, come detto, arriva anche la proposta di far cadere Berlusconi. Ma Geighner precisa che, per quanto gli Usa avrebbero preferito un altro leader, gli Stati Uniti preferirono evitare il complotto.
Angela Merkel pianse con Barack Obama: "Obbedisco alla Bundesbank", scrive Martino Cervo su “Libero Quotidiano”. Sul Financial Times è apparso uno degli articoli di giornale più appassionanti degli ultimi anni. L’intero testo si trova all’indirizzo goo.gl/p11UOo (necessaria una registrazione gratuita). È un lunghissimo retroscena sulla notte dell’euro, a firma Peter Spiegel, che della testata è corrispondente da Bruxelles. Un romanzo breve (5 mila parole), primo di una serie che il quotidiano dedica alla ricostruzione delle giornate che cambiarono per sempre l’Europa. L’interesse per il lettore italiano è doppio: il nostro Paese è, nel novembre 2011, lo spartiacque per la sopravvivenza dell’euro, e manca una ricostruzione non strumentale di cosa accadde in ore che costarono la caduta di due governi (Papandreou e Berlusconi), sotto il rischio concreto di una catastrofe finanziaria. Il racconto si apre con una scena difficile da immaginare: Angela Merkel è in una stanza di hotel con Obama, Barroso, Sarkozy, e piange. «Non è giusto», stritola tra i denti con le lacrime agli occhi, «Io non mi posso suicidare». Perché la signora d’Europa è ridotta così? Libero riassume l’articolo di Spiegel per i suoi lettori. Siamo, come detto, a inizio novembre 2011. L’estate si è conclusa avvolta dalle fiamme dello spread. La Grecia è sul filo della permanenza nell’euro. L’Italia è la prossima preda di chi scommette sull’implosione della moneta unica, lo spread vola a quota 500, il governo traballa sulle pencolanti stampelle dei «responsabili», Merkel e Sarko hanno appena sghignazzato in mondovisione alla domanda sull’affidabilità di Berlusconi. Il G20 di Cannes del 3-4 novembre diventa un appuntamento carico di tensione. Il premier greco Papandreou ha annunciato un referendum sull’uscita dall’euro. L’eventualità manda letteralmente nel panico soprattutto i paesi creditori. A 48 ore dall’inizio del vertice Sarkozy raduna tutti i protagonisti del redde rationem: il premier greco, la Merkel, il capo dell’eurogruppo Juncker (oggi candidato del Ppe alla guida della Commissione Ue), il capo del Fondo monetario Christine Lagarde, i capi dell’Unione José Barroso e Herman van Rompuy. Il dramma greco è affiancato a quello italiano. Roma, rispetto ad Atene, è «too big to bail». La Lagarde è durissima: «L’Italia non ha credibilità». Quel che si fa con la Grecia avrà una ricaduta immediata, ed esponenziale, sul nostro Paese. Con Papandreou c’è Venizelos, ministro delle Finanze. Sarkozy mette spalle al muro il premier ateniese, per evitare il referendum e costringerlo a prendere una decisione lì, sul posto: dentro o fuori. Qui si apre un retroscena nel retroscena: il Ft racconta che Barroso poche ora prima, all’insaputa di Merkel e Sarko (padrone di casa del G20), incontra il capo dell’opposizione greca Samaras, offrendogli sostegno istituzionale a un governo di unità nazionale a patto di abbattere il referendum. Poi inizia il vertice «vero». Senza che i premier sappiano dell’accordo Barroso-Samaras, il capo della Commissione Ue fa il nome di Lucas Papademos, vicepresidente della Bce, come possibile guida di un esecutivo di larghe intese ad Atene. «Dobbiamo ammazzare questo referendum», dice Barroso. Venizelos soppianta il suo premier e cancella il referendum con una dichiarazione ufficiale. Papademos diventerà premier sette giorni più tardi. La Grecia è «sistemata». A questo punto bisogna sollevare una barriera contro l’assedio dei mercati all’euro. La trincea si chiama Italia. Molti delegati sono sconcertati dalla presenza al tavolo di Obama, che in teoria non ha titoli per sedersi a una riunione informale sull’eurozona. Segno di debolezza delle istituzioni comunitarie? Della gravità globale di un possibile tracollo che rischia di far saltare un mercato decisivo per i prodotti Usa? Il nodo cruciale è il ruolo del Fondo monetario. Come più volte raccontato da Giulio Tremonti, l’Italia declina l’offerta di una linea di credito da 80 miliardi di dollari, accettando solo il monitoraggio del Fmi. «I think Silvio is right», dice Obama, buttando sul tavolo una carta nuova, che assegna a Berlino una posizione cruciale. Per aggirare i veti dei trattati che impediscono alla Bce di finanziare direttamente gli Stati, il presidente Usa - in accordo coi francesi, alla faccia del tanto sbandierato asse Merkozy raccontato in quei giorni - propone l’utilizzo del «bazooka» con un’ennesima sigla: SDR. Che sta per «special drawing rights» (diritti speciali di prelievo), un particolare tipo di valuta che il Fmi stesso usa come unità di conto della partecipazione finanziaria dei singoli Stati. Una strategia simile (usare la potenza di fuoco degli SDR contro la crisi) era stata usato nel post-Lehman. Qui si tratterebbe di riversare quelle risorse nel fondo salvaStati europeo in via di formazione. Quel che segue è il miglior esempio possibile per raffigurare il nodo della democrazia ai tempi della crisi, e investe in pieno il tema della famosa «indipendenza» delle Banche centrali. La gestione degli SDR è infatti in capo a queste ultime. E il capo della Bundesbank è Jens Weidmann, custode dell’ortodossia dell’austerity tedesca. Appena si diffonde il piano Obama-Sarko, il «falco» apre le ali e dice «nein» al telefono con i delegati tedeschi: la Germania non paga. La Merkel scoppia in pianto e pronuncia il suo: «Non è giusto, non posso suicidarmi. Non posso decidere io al posto della Bundesbank». Il dramma dell’euro è qui: quattro tra i più potenti governi democraticamente eletti del mondo si fermano davanti al veto (legittimo) di un banchiere. Obama vuole che la Germania alzi la quota degli SDR. La Merkel apre, purché l’Italia accetti di farsi commissariare dal Fondo. Tremonti e Berlusconi non mollano, Angela neppure, a causa di Weidmann. La tensione è totale. La riunione si scioglie con un nulla di fatto, salvo la richiesta al governo di Berlino di provare a smussare la Buba . «Non mi prendo un rischio simile se non ottengo in cambio nulla dall’Italia». Alla conferenza stampa dopo il G8 Berlusconi rivela l’offerta del Fmi e il «no» italiano. Pochi giorni dopo, il governo cade. Al supervertice non è successo nulla. Toccherà a Draghi tenere in piedi l’euro, e (anche) a noi pagare per il fondo salvastati.
Gli attacchi vengono anche dal'interno. L'accordo tra Fini e Napolitano per "eliminare" Berlusconi, scrive “Libero Quotidiano”. "Il golpe contro Silvio Berlusconi non è cominciato nell’estate del 2011 come scrive Friedman. Ma molto prima, nel 2009. E a muovere i fili furono il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e quello della Camera Gianfranco Fini". A tirare in ballo altri protagonisti del complotto anti Cav è Amedeo Labboccetta. In una intervista al Tempo, l'allora braccio destro di Fini, racconta le ambizioni dell'ex presidente della Camera che ha giocato di sponda con il Quirinale per fare le scarpe al leader azzurro con l'obiettivo di prendere il suo posto a Palazzo Chigi. "Fini me lo disse in più circostanze. 'Ma tu credi che io porterei avanti un’operazione del genere se non avessi un accordo forte con Napolitano?!", rivela Labboccetta a Carlantonio Solimene che racconta anche di come nacqua il feeling tra Fini e il Colle: "Quando nel 2008 Berlusconi diventa premier e il leader di An va alla presidenza della Camera, i rapporti con Napolitano diventano strettissimi. Si sentono al telefono praticamente ogni giorno". E lui, dice, di essere testimone di quelle chiamate essendo in quel periodo in una posizione privilegiata. All'inizio, prosegue l'ex deputato del Pdl, Fini giustificò il suo controcanto al Cavaliere come normali reazioni agli attacchi de Il Giornale. Lui e Dell'Utri tentarono più volte di fargli cambiare idea. Berlusconi, secondo il racconto di Labboccetta, arrivò perfino ad offrirgli la segreteria del partito. Ma niente, Fini, non smetteva e alzava la posta chiedendo la testa dei ministri La Russa e Matteoli e del capogruppo al Senato Gasparri. "Mi disse che non avrebbe mai lasciato la terza carica dello Stato perché da lì poteva tenere per le palle Berlusconi', continua Laboccetta secondo il quale l'obiettivo di Fini era di "eliminare politicamente Berlusconi". "Quando lo costrinsi a spiegarmi con quali numeri e appoggi voleva farlo", rivela, "mi confessò che Napolitano era della partita. Usò proprio queste parole. Aggiunse che presto si sarebbero create le condizioni per un ribaltone e che aveva notizie certe che la magistratura avrebbe massacrato il Cavaliere. "Varie procure sono al lavoro", mi svelò, "Berlusconi è finito, te ne devi fare una ragione". E aggiunse che come premio per il killeraggio del premier sarebbe nato un governo di "salvezza nazionale" da lui presieduto con la benedizione del Colle. Quando parlava di Silvio, Gianfranco era accecato dall’odio, sembrava un invasato. Una volta mi disse: "Non avrò pace fino a quando non vedrò ruzzolare la testa di Berlusconi ai miei piedi"». Labboccetta non raccontò mai a Berlusconi quello che Fini stava ordendo alle sue spalle, ma si giustifica sostenendo che si diede da fare perché quel piano saltasse: "Cercai di fargli capire che Fini era solo l’esecutore, ma i disegnatori erano altri. Magari con una regia extranazionale". "Me lo fece capire lo stesso Gianfranco, parlando tra le righe. Non va dimenticato che in passato era stato ministro degli Esteri, ed era stato bravo a tessere le giuste relazioni". Alla domanda di Solimente: "Ma perché dice queste cose solo oggi?" Labboccetta risponde: "All’epoca ho fatto di tutto per favorire una ricomposizione. In seguito, ho ritenuto che era meglio lasciare queste cose alle miserie umane. Ma adesso che la verità sta venendo a galla, è giusto che si sappia tutto di quegli anni".
Sallusti: "Dietro al complotto per far fuori Berlusconi c'è Clio Napolitano", scrive “Libero Quotidiano”. “Dietro al golpe del 2011 c'è Clio Napolitano". Alessandro Sallusti ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 aggiunge nuove elementi alle rivelazioni di Alan Friedman che parlano di una strategia chiara da parte del Colle per destabilizzare il governo Berlusconi nel 2011 e sostituire il Cav a palazzo Chigi con Mario Monti. Il direttore de Il Giornale punta il dito contro la moglie del Capo dello Stato e afferma: "Mi dicono che la moglie di Napolitano, la comunista Clio, odia Silvio, e ha molto peso sulle scelte del Quirinale. Dietro al complotto politico finanziario che ha fatto cadere Berlusconi, c'è Clio Napolitano". Insomma secondo Sallusti la mano occulta che guidò la caduta di Berlusconi nel 2011 appartiene a Clio Napolitano. Il direttore de Il Giornale però non risparmia critiche nemmeno agli ex alleati del Cav: "Sia Fini che Alfano sono stati cooptati da Napolitano per uccidere Berlusconi". Sallusti parla anche dello spread: "Fu creato ad arte ed il complotto contro Berlusconi ci fu". Infine l'annuncio poi confermato nel suo editoriale di oggi su il Giornale: "Se siamo in un Paese libero, mettiamo in stato d'accusa Napolitano".
Eppure son tutti uguali.
Expo, appalti e tangenti: la sinistra spunta ovunque. Nelle carte ci sono dozzine di nomi dell'area Pd tirati in ballo dagli arrestati. Da Bersani fino al sottosegretario Delrio e al portavoce del partito Guerini, scrive Enrico Lagattolla su “Il Giornale”. Lo dicevano spesso, quelli della cupola. «Copriamoci a sinistra». Nel Paese degli appalti truccati servono santi bipartisan. Di qua e di là. Ma di là - a sinistra - ce n'erano davvero parecchi. Realtà o millanterie, sta di fatto che nelle carte dell'inchiesta milanese su Expo e non solo ci sono dozzine di nomi dell'area Pd. Non è un caso, secondo una teoria dell'ex senatore Luigi Grillo. «L'ho visto anche ieri Pier Luigi (Bersani, che ha già smentito, ndr), io tengo sempre i rapporti - dice a Giuseppe Nucci, ex ad della Sogin - lo informo degli sviluppi. Sai, loro, i post-comunisti non sono diversi dai comunisti, cioè il dialogo lo accettano, sono anche garbati e sono simpatici. Poi quando c'è da stringere per questioni di potere preferiscono sempre il cerchio stretto». Ecco, gli affari sono affari. E per ogni torta sul grande tavolo degli appalti pubblici, sostengono i pm, una fetta doveva andare a sinistra. Attraverso le cooperative, che si aggiudicano i lavori. Attraverso Primo Greganti, che avrebbe fatto da tramite tra il partito, le coop e i manager di Stato, e che ieri è stato sospeso in via cautelare dalla sezione del Pd di Torino a cui era iscritto («Ma qui non l'abbiamo mai visto», racconta il segretario della sezione). E attraverso i mille canali - più o meno reali - che ciascuno degli interessati sostiene di poter smuovere per passare all'incasso. Greganti, per rendersi credibile, si «vende» anche il nome di Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo ed ex candidato alle primarie del Pd, il quale ha smentito un suo interessamento su Expo. «Io sono andato giù a Roma - dice Greganti il 6 marzo - ho incontrato anche Gianni Pittella... è il presidente del Consiglio europeo (Greganti si sbaglia, ndr)... grande... potere enorme... al posto di parlamentare europeo... nel Pd è considerato potente ecco...». Poi qualcuno bussa anche al ministero. Così, proprio Nucci racconta di aver incontrato Claudio De Vincenti, viceministro allo Sviluppo economico nel Governo Renzi. «Mi ha detto - racconta Nucci a Grillo - “io sono a disposizione per tutte le cose che voi c'avete da fare”, e dico “io voglio lavorare per il mio Paese”, lui ha detto “Ne parlerò col Gabinetto, col ministro, questa cosa mi piace molto”». Ma a lambire il governo Renzi c'è anche un riferimento - assai fumoso - a Graziano Delrio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. A parlare è l'ex Dc Gianstefano Frigerio. «Però Guerini è un buon... adesso non so se lo porta al governo ... forse lo lascia ... al partito i suoi giri ... uno è Delrio e l'altro Guerini». Decisamente più significativi altri passaggi che riguardano proprio Lorenzo Guerini, portavoce del Pd. Ancora Frigerio al telefono, parla con Sergio Cattozzo della Città della salute e degli appalti Sogin. «Devo parlarne a Guerini... a Lorenzo, devo parlarne... ». «Bisogno organizzare un incontro - suggerisce Cattozzo - io te e Guerini, così lo tiriamo dentro il Guerini. Stiamo parlando di sette miliardi di lavoro, ragazzi!». Tanti, tantissimi soldi. E gli appalti Sogin portano la cupola a cercare più sponde possibili. È in questo contesto che spuntano i nomi di Giovanni Battista Raggi, tesoriere del Pd in Liguria, e di Claudio Burlando, già ministro dei Trasporti e ora governatore ligure. Greganti avrebbe dovuto avvicinare Raggi e attraverso questi Burlando, per ottenere - si legge in un sms di Cattozzo del settembre scorso - «un po' di sponsorizzazione forte nazionale». Ma la cupola, secondo la Procura di Milano, era «glocal». Oltre alle coperture nazionali, infatti, cercava appoggi sul territorio. Ovunque c'era una gara milionaria, c'era da muoversi. Ed è così che si arriva in Sicilia, dove la cricca sta seguendo i lavori per l'ospedale di Siracusa. Frigerio, al telefono con Cattozzo, ragiona. «Sei amico di Enrico Maltauro (uno degli imprenditori arrestati, ndr) tieni conto che stiamo seguendo per lui un ospedale a Siracusa che dobbiamo parlare con Crocetta (Rosario Crocetta, governatore siciliano, ndr) per l'autorizzazione compagnia bella ma tu sei d'accordo... mah aspetta adesso ne parlo al mio consulente poi vediamo venerdì quando viene da me glielo dirà a Enrico, mi ha chiamato Foti (Luigi Foti ex parlamentare della Dc ora ritenuto vicino al Pd, ndr) vuole la mia copertura sulla Sicilia per l'ospedale di Siracusa». Ma alla fine, erano ganci reali o solo chiacchiere? Altro che balle, a sentire Stefano Boeri. Per l'ex assessore comunale Pd di Milano, era tutto vero. «Sono stato fatto fuori dalla partita Expo dalle lobby economiche, compresa la Lega delle Cooperative. Io costituivo un ostacolo», ha spiegato in un'intervista. A Boeri ha replicato l'assessore milanese Pierfrancesco Majorino. «Di Boeri si può pensare tutto e il suo contrario, ma il nesso è totalmente inventato». Al netto delle faide interne al partito, il dubbio resta.
Quelle larghe intese Cl-Coop per spartirsi affari e poltrone. Nelle carte della Procura le prove dell'asse tra cooperative rosse e aziende cielline. L'indagato Frigerio: "Anche Lupi è amico loro", scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. Altro che Peppone e don Camillo. Oggi i vecchi nemici fanno affari insieme. Nascosta nelle carte dell'indagine sugli appalti dell'Expo 2015 c'è una traccia che costringe a rivedere antiche certezze. E a prendere atto che quando oggi si parla dei colossi delle coop, lanciati alla conquista di fette sempre più grosse degli appalti pubblici, si parla di qualcosa di assai diverso dalle vecchie cooperative emiliane, tutte business e ideologia, che fanno parte della storia del Novecento italiano. Il grosso delle aziende aderenti alla Lega nazionale cooperative e mutue continua, ovviamente, a stare nell'orbita del Pd. Ma dentro la Legacoop cresce un nuovo partito di tutt'altra estrazione: uomini e aziende che vengono dalla storia di Comunione e liberazione, e dal suo braccio nell'imprenditoria, la Compagnia delle opere. Ex comunisti e ciellini convivono e collaborano. E si ritrovano, nelle carte dell'indagine, a godere di protezioni bipartisan. A spiegarlo chiaramente, tranquillizzando un interlocutore è Gianstefano Frigerio, l'ex parlamentare della Dc e di Forza Italia, arrestato mercoledì. Scrive la Guardia di finanza: «Frigerio dice che quelli che gli presenterà della Manutencoop (alti dirigenti) non sono di sinistra ma sono dei loro». Non è chiaro a chi si riferisca Frigerio. Ma il vecchio democristiano torna sul tema in un'altra conversazione: «Ieri ho parlato con Pellissero e gli ho raccomandato, guarda che la cosa migliore è Manutencoop e anche qualche sua azienda... “sì sì lo so anche se hanno fatto un po' di alleanze eccessive con i ciellini”». Un asse che può apparire singolare, quello tra i due mondi: ma che si basa su due pilastri comuni, la vocazione sociale e il pragmatismo imprenditoriale. Di fatto, Cdo e Legacoop si ritrovano da tempo alleate in un'opera di lobbismo comune e trasversale per ottenere leggi che tutelino l'imprenditoria sociale. Questo ha generato contiguità e alleanze. E anche intrecci di poltrone: il caso più noto è quello di Massimo Ferlini, ex assessore comunista a Milano, che oggi è uno dei principali esponenti della Compagnia delle opere ma siede anche nel consiglio di amministrazione di Manutencoop. Così, in nome di un comune sentire, si saldano intese un tempo impensabili. Ancora Frigerio: «Anche Maurizio Lupi (ministro delle Infrastrutture, ciellino doc) è amico di quelli di Manutencoop». Scrive la Finanza: «Frigerio sostiene di conoscere bene i legami che ci sono tra Manutencoop e i ciellini tanto che negli ultimi anni, con Formigoni, sempre a dire dell'indagato Manutencoop avrebbe già ottenuto importanti lavori». E d'altronde in Lombardia non è un mistero che dopo la caduta di Formigoni le aziende della Cdo, rimaste orfane di protezione politica, si stiano ulteriormente avvicinando alle coop rosse. «Parlando con Levorato lui è un vecchio comunista, io un vecchio democristiano, quindi sappiamo come si parla tra noi», dice Frigerio di Claudio Levorato, il manager di Manutencoop per cui la Procura aveva chiesto l'arresto: e in questa frase c'è dentro un bel ritratto di storie simili cresciute su sponde diverse. D'altronde, dice sempre Frigerio, «ti manderò il capo delle coop (...) copriamoci perché sono le coop rosse e corrono meno incidenti. Prendeteveli perché sono rossi» . E fin qui potrebbe sembrare un semplice calcolo di opportunità o un preaccordo di spartizione. Ma quello che raccontano le carte è qualcosa di più, una sorta si compenetrazione tra mondi solo apparentemente distanti. C'è una matrice forse cattocomunista: basta guardare il profilo Linkedin di Fernando Turri, altro manager coop che compare nell'inchiesta, a capo della Viridia: studi dai salesiani, ma alle spalle il Quarto Stato di Pellizza. E c'è soprattutto una consapevolezza che i tempi sono duri, la spending review ha tagliato gli appalti, e così se si vuole sopravvivere bisogna abbattere vecchi steccati. Frigerio: «Manutencoop, aldilà di quello che pensa Rognoni, è “così” con Cl».
LA DEMOCRAZIA SOTTO TUTELA: ELEZIONI CON ARRESTO.
Politica e criminalità organizzata. L’arresto di Scajola e lo scoperchiamento del potere italiano, scrive Gad Lerner. Tra Scilla e Cariddi, fra le due rive dello Stretto: da una parte Amadeo Matacena (finito per caso a destra in Forza Italia) e dall’altra Francantonio Genovese (finito per caso a sinistra nel Pd). In comune il business dei traghetti con la società Caronte, ma non solo. Sono capoclan locali che con la loro dote di preferenze ottengono facilmente candidature al parlamento nazionale, usano i partiti come strumenti intercambiabili, entrano in relazione con i vertici dello Stato, ne ottengono protezioni e complicità. E’ in questo meccanismo che rimane impigliato oggi Claudio Scajola, a suo tempo ministro degli Interni e massimo dirigente organizzativo di Forza Italia. Un politico di razza, vecchio navigatore democristiano, a sua volta radicato su un territorio come il Ponente Ligure dove la ‘ndrangheta calabrese ha messo radici da parecchio tempo. Non è un caso che la magistratura abbia intercettato le manovre di Scajola per favorire la latitanza di Matacena nel corso di altre indagini sui rapporti fra il tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, e alcune famiglie della malavita calabrese. Stiamo assistendo allo scoperchiamento di una parte rilevante del potere italiano, costituito dall’intreccio fra politica in cerca di consenso e interessi malavitosi bisognosi di protezione e riciclaggio. Sotto l’ombrello del berlusconismo (ma non solo, e non solo a destra) episodi come quello che ha portato all’arresto di Scajola sono numerosi. Guarda caso anche Matacena voleva scappare in Libano, come Dell’Utri. E Berlusconi che subito dichiara “non ne sapevo niente, povero Claudio”, non vi ricorda il proverbio secondo cui la prima gallina che canta ha fatto l’uovo?
In realtà sono rimasti identici solo i metodi dei magistrati e dei giornalisti, scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”. Forse non vi siete accorti che nell'inchiesta Expo i politici e i partiti praticamente non ci sono: sono sullo sfondo assieme a fisiologici referenti (tanti) che vengono consultati da un gruppetto di affaristi che intascava mazzette e pilotava appalti. È come se dei mazzettari professionisti avessero lasciato l'azienda e si fossero messi in proprio, col dettaglio che frattanto le aziende abbandonate sono fallite tutte: come i vecchi partiti, come quella politica che manca non perché sia virtuosa, ma perché non conta più nulla. Primo Greganti, ventun anni fa, disse che rubava per sé e non per il partito, e non era vero: ora invece lo è, perché la «cupola» non alimentava il finanziamento illegale della politica, alimentava le proprie tasche; e i politici ne escono perlopiù gabbati, usati per promuovere carriere. Lo scandalo è sufficientemente grave da essere analizzato nel suo specifico, non servono riflessi tipo «Come prima, più di prima» (Corriere) o «Ora e sempre tangentopoli» (Repubblica) con ridicole interviste al vecchio pool di Milano. Servirebbe chiedersi se le manette fossero tutte necessarie (quisquilie da garantisti) ma soprattutto chiedersi che accidenti c'entrino certe intercettazioni, quelle in cui vengono sputtanate persone che non c'entrano niente su questioni che non c'entrano niente. Ma pare che, tra gli appalti pilotati, ci sia anche quello della libera stampa a Beppe Grillo.
Manette a gogò. Magistrati scatenati alla vigilia del voto. Arrestati in 20 tra cui Greganti e Scajola Sospetti di corruzione per l'Expo. L'ex ministro accusato di aver aiutato un latitante, scrive Alessandro Sallusti su “Il Giornale”. Tecnicamente parlando si tratta di una manovra diversiva. Come arginare la verità fangosa che sta emergendo sulle porcate commesse dai magistrati, prima fra tutte quella sulle illegalità della Procura di Milano nell'inchiesta Ruby? Semplice, una bella retata all'alba. Anzi due, perché - come diceva Totò - meglio abbondare. Così in poche ore finiscono dentro in tanti, nomi eccellenti ovviamente, altrimenti addio titoloni. Da ieri mattina sono in carcere, tra gli altri, a Roma l'ex ministro degli Interni Claudio Scajola (accusato di intrattenere rapporti con la famiglia dell'ex deputato, oggi latitante, Matacena), a Milano, per tangenti, due ex politici (Stefano Frigerio e Primo Greganti, già coinvolti in Tangentopoli) e uno dei capi di Expo 2015. Pareva strano che il partito dei giudici si astenesse dal partecipare a questa campagna elettorale. E, infatti, eccoli, più decisi che mai: un colpo al Pd (Greganti), uno a Forza Italia (Scajola), insomma una secchiata di merda sui due partiti che stanno cercando di riformare il Paese. Grillo ringrazia e guadagna ancora qualche punto. Lui ai magistrati non fa paura, anzi, è lo strumento ideale per fermare l'asse Renzi-Berlusconi che ha già annunciato la riduzione degli stipendi d'oro dei magistrati e la riforma della giustizia. Le procure mandano a Renzi un segnale chiaro, in stile onorevole Antonio Razzi versione Crozza: «Amico, attento, te lo dico un'ultima volta: fatti li cazzi tuoi». Può essere, lo vedremo, che tra gli arrestati ci siano ladri e malfattori. Però mi fa strano il tempismo e il clamore, perché la verità sarà accertata solo a urne chiuse. E viste le tante inchieste spettacolo finite nel nulla, la cosa preoccupa perché falsa le regole del gioco democratico. Dicono che Bruti Liberati, capo della Procura di Milano, abbia le ore contate e sia al centro di una guerra tra le fazioni di pm che si contendono potere e successione a suon di accuse e controaccuse. Ieri un suo vice, Robledo, si è rifiutato di firmare gli ordini di arresto e non ha partecipato alla conferenza stampa. C'è il terribile sospetto che la resa di conti finale tra magistrati stia avvenendo sulla pelle di veri, presunti o falsi delinquenti. In un Paese normale, una procura così messa, delegittimata, divisa e incarognita, sarebbe già stata commissariata. Questi sono un pericolo vero, più pericolosi del più pericoloso tangentista.
La settimana terribile dell'Italia. Prima settimana di maggio 2014. Bacchiddu, Scajola, Expo, Nuova Tangentopoli, Genny 'a carogna. Il paese sprofonda inesorabilmente, senza la forza di cambiare davvero. Anche per colpa nostra, scrive Marco Ventura su “Panorama”. Una settimana da dimenticare sta finendo, specchio di una vecchia Italia. Un’Italia che non cambia. Che va in retromarcia. Che guarda indietro. Non è più questione di ricambio generazionale (quello finalmente un po’ c’è, anche se a ben vedere l’arroganza di certi giovani non è inferiore a quella di certi anziani). Il problema è nazionale. Siamo noi italiani, forse, che abbiamo qualche problema con la storia e con noi stessi. Non riusciamo a esser seri, a concentrarci sulle cose da fare, a renderci conto della gravità dell’emergenza che stiamo attraversando, a prendere coscienza del declino che ci sta portando verso il baratro, del grado di inciviltà che viviamo nelle nostre città. C’è qualche tarlo che ci corrode, qualche virus che non vuol saperne di abbandonare la presa. Come si spiega altrimenti l’escalation di notizie da paura degli ultimi giorni? Siamo alla terzultima settimana prima del voto del 25 maggio che servirà a ridisegnare il Parlamento europeo, tornata importante anche per la politica nazionale. Forse, ci si poteva aspettare che prendessero il sopravvento temi concreti e veri. Non so: l’economia, l’istruzione, l’Europa. Invece ci siamo dibattuti e abbiamo dibattuto sul “caso Bacchiddu”, sulle spacconate di Genny ‘a Carogna, su Greganti 2 la vendetta, la corruzione dietro l’Expo 2015 e le lotte fratricide tra i magistrati di Milano, per finire coi fischi di Grillo all’Inno di Mameli. Tutte robe che non ci cambiano la vita, che ci distraggono dai veri problemi, che peggiorano terribilmente l’immagine dell’Italia e di noi italiani in Europa. Che scoraggiano irrimediabilmente le persone per bene ed esasperano chi già non ne può più. La Lista Tsipras riesce a far parlare di sé solo perché il meccanismo dei media e della politica si tuffa sulla foto accattivante di una bella ragazza e una brava giornalista, Paola Bacchiddu, che in un clic di (auto)ironia posta su facebook una propria istantanea balneare con la motivazione scherzosa di voler usare ogni mezzo, ora che il giorno cruciale del voto si avvicina, e quindi invita a barrare la lista “L’Altra Europa con Tsipras”. Apriti cielo. Si scatena la polemica su “chiappetta rossa”, la gogna del web, l’assalto del branco (a sinistra, a destra), il groviglio di considerazioni femministe e/o machiste…
Ed a proposito di questo..."Siamo tutti puttane". Un titolo spiazzante quello che Annalisa Chirico, giornalista e compagna di Chicco Testa, politico di sinistra e dirigente industriale italiano, ha deciso di dare al suo ultimo libro, scrive “Libero Quotidiano”. Ma già se si legge il sotto titolo ci si potrebbe fare un idea del concetto che sta alla base della lettura: "Contro la dittatura del politicamente corretto". Un libro che ha come bersaglio i perbenisti di sinistra e le femministe alla "Se non ora quando". La Chirico rivendica il sacrosanto diritto di farsi strada nella vita come ognuno può e vuole, e quindi, anche diventando una puttana. Un femminismo pro sesso, pro porno e pro prostituzione, sia per le donne sia per i maschi. Un dibattito a suo avviso che "ha diviso il Paese tra un popolo di sinistra moralmente irreprensibile e uno di destra, gaglioffo e sciocco". In un'intervista a Formiche.net del 7 maggio, la stessa giornalista alla domanda "È Berlusconi ad averla ispirata?", non risponde esplicitamente, ma il riferimento è chiaro. "Ho seguito da cronista il processo Ruby - afferma Chirico - dove nel tribunale di Milano, non di Riad o della Kabul talebana, trentatré ragazze sono state vivisezionate nella loro vita privata in qualità di semplici testimoni, senza alcun capo di imputazione a loro carico. Quando una democrazia smette di distinguere tra peccato e reato, si getta al macero l'abc della civiltà giuridica". Dunque nulla di male. Le famose "Olgettine", da Via Olgettina, le ragazze indagate dalla Procura di Milano per il caso Ruby, non hanno, a suo parere, la colpa di aver "conosciuto Silvio Berlusconi, il tycoon d'Italia, il capo di un impero mediatico, il presidente del Consiglio italiano". Un'occasione ghiotta di farsi notare e farsi apprezzare, per entrare nel mondo dell'apparire, della tv e dell'estetica da vendere. "E' stato un pornoprocesso, un rito a elevato tasso moraleggiante, oltre che erotico". Poi dal porno si passa all'erotico e a quelle foto di Paola Bacchiddu, il capo comunicazione della lista L’Altra Europa con Tsipras, che qualche giorno fa ha pubblicato una foto in bikini suscitando clamore. "Mi è sembrata la trovata goliardica di una ragazza intraprendente. In Italia ne sono nate le solite polemiche perché va di moda l’idea boldriniana che il corpo vada nascosto in un sudario di pietra. Per cui i concorsi di bellezza che si fanno in tutto il mondo da noi andrebbero proibiti. La donna invece è un soggetto che decide come usare il proprio corpo, sono le pseudofemministe a rappresentarla come un oggetto". Poi attacca Barbara Spinelli, candida la paladina delle donne e della guerra contro la mercificazione del loro corpo per Tsipras. "E' un esemplare del livello di oscurantismo che caratterizza il femminismo nel nostro Paese. Sono le donne che strumentalizzano le altre donne. La campagna talebanfemminista Se non ora quando aveva l’unico obiettivo politico di colpire l’allora presidente Berlusconi, ci ha fatto credere che il suo indomito fallo fosse il principale assillo delle donne italiane". Infine la frecciatina a Renzi incalzata dalla giornalista di Formiche.net che gli chiede se la convince "il femminismo alla Renzi": "Non esiste un femminismo alla Renzi - ha risposto la Chirico - ma una strategia comunicativa renziana. il premier ha capito che la sinistra del presunto primato morale era perdente. Perciò si è abilmente smarcato dalla linea dei suoi predecessori. E li ha rottamati".
Tornando alla riflessione di Ventura...Poi, sabato, lo spettacolo immondo e barbarico di una sparatoria in piena Roma, con tifosi che si confrontano in un delirio di violenza finché dentro lo stadio un energumeno tatuato con maglietta che chiede la liberazione dell’omicida di un poliziotto alza il pollice fischiando di fatto l’inizio di una tristemente memorabile finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, sotto gli occhi e le bocche aperte, mute, delle più alte cariche di uno Stato ridicolizzato e impotente. Genny ‘a Carogna, imparentato con camorristi, detta legge. Le famigliole tremano. Renzi neanche s’accorge del tenore di quella maglietta insultante. E per finire, ecco l’ordalia giudiziaria come da copione: la raffica di arresti per presunte tangenti relative all’Expo 2015 di Milano accende i riflettori su un passato per nulla esaurito. Con l’aggiunta piccante di uno scontro interno alla magistratura per irregolarità additate dal procuratore aggiunto Robledo nell’assegnazione delle inchieste a chi non ne avrebbe avuto titolo. Come non bastasse, finisce in manette un ex ministro dell’Interno, Claudio Scajola. E Grillo si tuffa sugli arresti con la goduria del capobranco che assapora un punto in più il 25 maggio, perché la rovina dell’Italia significa la sua apoteosi. Un Grillo che si mette fra gli ultrà dello stadio dicendo che anche lui avrebbe fischiato l’Inno d’Italia e che mette in campo tutta la sua finezza di analisi affibbiando le solite trito-comiche etichette agli avversari, dal “pregiudicato Berlusconi” (dimentico d’esser lui stesso condannato in via definitiva per omicidio colposo, senza neppure esser vittima di chissà quale persecuzione giudiziaria) a “Renzi ‘a Menzogna” che evoca “Genny ‘a Carogna”. Questo, dopo avere ravvivato malamente la campagna elettorale con parabole che hanno per protagonisti gli ebrei della Shoah e i lager (riferimenti privi di qualsiasi pietà umana). Mamma mia, che Italia è questa. Che paura. Che futuro ci aspetta.
Dell'Utri. Sette anni di reclusione. Condanna confermata, scrive “Il Corriere della Sera”. Il verdetto della Cassazione per l’ex senatore Marcello Dell’Utri era atteso in serata del 9 maggio 2014. I giudici della Prima sezione penale si sono ritirati in Camera di consiglio per decidere se confermare o no il verdetto d’appello: 7 anni di reclusione, per concorso esterno in associazione mafiosa. Il Sostituto Procuratore Generale di Palermo Luigi Patronaggio ha già emesso un ordine di carcerazione per Dell’Utri. Il provvedimento verrà trasmesso al ministero della Giustizia che lo allegherà alla richiesta di estradizione alle autorità libanesi. Il caso giudiziario di Marcello dell’Utri dura da 20 anni. Era infatti il 1994 quando la Procura di Palermo avviò le indagini per mafia sull’ex senatore, che fu rinviato a giudizio nell’ottobre del 1996. Il primo processo, aperto il 5 novembre del 1997 davanti al Tribunale di Palermo, presieduto da Leonardo Guarnotta, era durato sette anni e si era concluso l’11 dicembre del 2004 con la condanna dell’imputato a nove anni per concorso esterno in associazione mafiosa, più due anni di libertà vigilata, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento per le parti civili, il Comune e la Provincia di Palermo. «Vi è la prova», aveva scritto il collegio nella motivazione, «che Dell’Utri aveva promesso alla mafia precisi vantaggi in campo politico e, di contro, vi è la prova che la mafia, in esecuzione di quella promessa, si era vieppiù orientata a votare per Forza Italia nella prima competizione elettorale utile e, ancora dopo, si era impegnata a sostenere elettoralmente l’imputato in occasione della sua candidatura al Parlamento europeo nelle file dello stesso partito, mentre aveva grossi problemi da risolvere con la giustizia perché era in corso il dibattimento di questo processo penale». Quel verdetto era stato parzialmente corretto in secondo grado, in un processo assai più rapido del primo, iniziato il 16 aprile del 2010 e conclusosi il 29 giugno dello stesso anno quando la Corte di Appello, presieduta da Claudio Dall’Acqua, aveva ridotto a sette anni la pena per Dell’Utri, a fronte di una richiesta di 11 anni formulata dal procuratore generale Antonio Gatto. I giudici avevano ritenuto provati i rapporti tra Dell’Utri e la mafia fino al 1992 mentre lo avevano assolto «perché il fatto non sussiste» per i fatti successivi. Aveva però retto l’impianto accusatorio, ribadito anche oggi dal Pg della Cassazione, secondo cui Dell’Utri avrebbe fatto da mediatore tra Cosa nostra e Silvio Berlusconi, e lo avrebbe tra l’altro convinto ad assumere come stalliere ad Arcore il boss Vittorio Magano, morto di cancro in carcere.
E poi.....Scajola: io non so se ci rendiamo conto. Rischio di essere ripetitivo ma il rischio vale la candela, scrive Giulio Cavalli su “L’Espresso”. Ogni volta che scriviamo, discutiamo e parliamo di criminalità organizzata, di programmi di protezione, di “utilizzo” di testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia o di un’appropriata legislazione antimafia non possiamo non tenere conto che Claudio Scajola (ma anche con ruoli comunque apicali Cosentino, Dell’Utri, la lista è lunga e folta) sia stato non un politico qualsiasi ma un Ministro dell’Interno di questa Repubblica. Quindi sarebbe veramente ora che si trovi una narrazione che funzioni, un vocabolario leggibile per raccontare le mafia fuori da Corleone, Platì o Scampia e che arriva sempre ai punti più alti dello Stato. Perché Scajola (quello che aiuta un latitante a trasferirsi in Libano) e i suoi sodali sono gli stessi che decidono se e come vanno presi in considerazione e protetti coloro che denunciano e quindi mi pare normale che chiunque provi ad “raccontare” il terzo livello (come lo chiamava Giovanni Falcone) non possa sentirsi sicuro in questo Paese. E dovremmo trovare il coraggio di insegnarlo nelle scuole, farne memoria tutti i santi giorni in tutti i santi posti che frequentiamo bucando questa coltre di presunto “allarmismo” che ci rovesciano addosso ogni volta che si alza il tiro contro la politica. Penso, oggi, a chi si ritrova in pericolo per avere denunciato il malaffare e legge l’arresto di un ex responsabile della propria incolumità. Non lo so, mi viene da pensare questa cosa qui, oggi, prima di tutte le valutazioni politiche. Questa ferita qui che sta più profonda di tutti gli editoriali di stamattina.
8 maggio 2014. Arrestato l'ex ministro Scajola. Avrebbe favorito la latitanza dell'ex parlamentare Amedeo Matacena, condannato a 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, scrive Raffaello Binelli su “Il Giornale”. L’ex ministro Claudio Scajola è stato arrestato dalla Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria. Tra le otto persone finite in manette figurano anche alcune persone legate al noto imprenditore reggino ed ex parlamentare Amedeo Matacena, colpito da provvedimento restrittivo insieme alla moglie Chiara Rizzo e alla madre Raffaella De Carolis. A seguito della condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa (giugno 2013) Matacena si è reso latitante. Perquisizioni effettuate in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia, oltre a sequestri di società commerciali italiane, collegate a società estere, per un valore di circa 50 milioni di euro. L'arresto di Scajola è avvenuto in un noto albergo della Capitale. Appresa la notizia Silvio Berlusconi, ai microfoni di Radio Capital, ha manifestato il proprio dolore: "Non so per quali motivi sia stato arrestato, me ne spiaccio e ne sono addolorato". Il Cavaliere ha tenuto a precisare che non aveva avuto alcun sentore dell'inchiesta, tale da giustificare la mancata candidatura alle Europee del politico ligure nelle liste di Forza Italia. "Avevamo commissionato un sondaggio su di lui che ci diceva che avremmo perso globalmente voti se lo avessimo candidato, ma abbiamo capito che la sua candidatura ci avrebbe fatto perdere punti". In serata, intervistato dal Tg1, ha detto di non credere che la vicenda avrà ripercussioni sui risultati di Forza Italia. Perché è stato arrestato? Come ha rivelato il procuratore di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho, l’ex ministro avrebbe aiutato l’ex parlamentare Matacena a sottrarsi alla cattura per l’esecuzione della pena. L’inchiesta è nata nell’ambito di una indagine su tutt’altro argomento, i presunti fondi neri della Lega Nord, in cui la figura chiave sarebbe il faccendiere Bruno Mafrici. Grazie a un’intercettazione gli inquirenti sono venuti a conoscenza di rapporti fra l’ex ministro e la moglie di Matacena, Chiara Rizzo. La donna, secondo quanto emerso, si sarebbe adoperata per ottenere l’aiuto dell’esponente politico ai fini del trasferimento del marito, in Libano. Dalle indagini sarebbe emerso il ruolo di un’altra persona che avrebbe lavorato al trasferimento di Matacena nel paese dei cedri. Si tratterebbe dello stesso personaggio che avrebbe avuto contatti con Marcello Dell’Utri ai fini di una sua fuga nel paese mediorientale. "Amedeo Matacena - ha detto il procuratore De Raho - godeva e gode tuttora di una rete di complicità ad alti livelli grazie alla quale è riuscito a sottrarsi all’arresto". Scajola, secondo l’accusa, avrebbe aiutato Matacena a sottrarsi alla cattura in virtù dei rapporti che ha con la sua famiglia. Matacena è un noto imprenditore, figlio dell’omonimo armatore, noto per avere dato inizio al traghettamento nello Stretto di Messina e morto nell’agosto 2003. La frase incriminata. Lo spostiamo in "un posto più sicuro e molto migliore, ma più vicino anche". È questa una delle frasi pronunciate da Scajola in una conversazione telefonica con Chiara Rizzo, moglie di Matacena. La telefonata risale al 12 dicembre del 2013 alle ore 12.12. Nella conversazione, sostiene il giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, emerge che "alcuni soggetti si stanno attivando per spostare Matacena da Dubai verso altro Stato". Dialoghi cifrati. "Poi ti racconto un po' di cose anch’io perché Daniele è andato a fare un viaggio sulle isole e ci sta fino al 28, è andato in giro, capito?". Così Scajola avrebbe informato la moglie di Matacena sugli spostamenti del marito, latitante dopo la condanna definitiva a cinque anni e quattro mesi. Il riferimento era, secondo gli investigatori, allo spostamento programmato per il 28 agosto dello scorso anno, data in cui Matacena è stato fermato a Dubai. Questa conversazione dimostrerebbe "la piena consapevolezza dello Scajola in merito agli spostamenti del latitante". In quegli stessi giorni si parlava ancora della vacanza di Daniele. La Rizzo chiedeva all’ex ministro "ma lì?", e lui rispondeva "per dieci giorni" "Daniele il mio amico, sai chi è Daniele?". E ancora: "E' andato in vacanza con Adele per dieci giorni a fare i bagni su.... Secondo il gip "si intuisce che è in difficoltà a parlare in quanto non vuole rivelare la località". A questo punto Chiara Rizzo esclamava "aaa ho capito! E tu glielo hai detto?". Scajola quindi rispondeva: "Nooo, no! Cercavo di dirlo a te in modo che tu lo sai che se dovesse mai farti venire qualche idea me lo dici, hai capito bene?". "Dite alla mia famiglia che sto bene, che sono tranquillo, la verità emergerà". Lo ha detto SCajola ai propri difensori, Giorgio Perroni ed Elisabetta Busuito. Gli inquirenti hanno perquisito a Imperia l’ufficio dell’ex ministro in viale Matteotti e la sua villa in via Diano Calderina. Si sarebbe interessata a Matacena anche la figlia di Amintore Fanfani, Cecilia. È quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di Reggio Calabria. Il nome di Cecilia Fanfani era sulla lista dei passeggeri del volo proveniente da Dubai e diretto a Nizza il primo agosto dello scorso anno. Nei suoi confronti, e anche a carico del fratello Giorgio Fanfani, è stata disposta una perquisizione. Proprio a Dubai il 28 agosto scorso è stato fermato Matacena. Il rampollo della famiglia di armatori era appena giunto negli Emirati Arabi dalle Seychelles. Lì, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si era recato per incontrarsi con alcuni legali del posto "i quali - si legge nell’ordinanza di custodia cautelare - interessando i competenti uffici amministrativi, lo avrebbero assistito nelle operazioni di rinnovo del visto necessario al prolungamento della sua permanenza alle Seychelles". Di questa strategia sarebbero stati informati anche Carlo Biondi, figlio del politico Alfredo Biondi, ed Elvira Tinelli. A Cecilia Fanfani viene attribuita la scelta e la possibilità di usufruire dell’appoggio di uno studio legale per risolvere "il problema". Il fratello Giorgio Fanfani avrebbe presentato a Chiara Rizzo, moglie di Matacena, un avvocato. I figli di Fanfani non sono indagati e vengono definiti, nel provvedimento della Dda, "soggetti di interesse investigativo risultati in contatto e in rapporti anche di affari con gli indagati", insieme ad altre sette persone pure perquisite senza essere indagate.
Il patto Scajola-Matacena così la ’ndrangheta fece crescere Forza Italia. “L’ex ministro dell’Interno favorì gli interessi dei boss”. Ecco perché i pm volevano arrestarlo anche per mafia, scrive Attilio Bolzoni su “La Repubblica”. Perché i magistrati della procura della repubblica di Reggio Calabria volevano arrestare anche per favoreggiamento mafioso Scajola Claudio, nato ad Imperia il 15/01/1948, ivi residente, ex ministro dell’Interno? «Perché dopo la sentenza di condanna per concorso esterno di Amedeo Matacena lui è diventato la proiezione politico-istituzionale- imprenditoriale del primo che consapevolmente agevolava gli interessi della ‘ndrangheta nella sua composizione unitaria». Così scrivono i pm calabresi nella loro richiesta di custodia cautelare contro Scajola, erede in qualche modo — secondo loro — del potere economico e criminale del latitante eccellente riparato negli Emirati Arabi e in fuga verso il Libano. Una coppia al servizio di consorterie e cosche, logge, circoli segreti. Prima sicuramente uno, poi probabilmente anche l’altro. La proposta dei pubblici ministeri è stata respinta dal giudice delle indagini preliminari «per mancanza di un supporto indiziario idoneo», ma nelle carte che hanno depositato ricostruiscono contro Scajola — oltre alle accuse di aver tentato di occultare il patrimonio di Matacena, di averlo soccorso nella sua dorata irreperibilità, di avere pianificato il suo spostamento da Dubai a Beirut — il “profilo” di Matacena, tutti i suoi affari e i suoi legami con l’ex ministro degli Interni e soprattutto una lontana vicenda che riporta alla nascita di Forza Italia. È nelle prime pagine del documento dei magistrati della procura firmato dal capo Federico Cafiero De Raho e dai sostituti Giuseppe Lombardo e Francesco Curcio, una mezza dozzina di fogli ripescati da un’indagine palermitana (la numero 2566/98 contro Licio Gelli + 13) finita nell’inchiesta sulla famigerata trattativa Stato-mafia e poi girata a Reggio. È il racconto di un pentito che ricorda un summit al santuario della Madonna dei Polsi — luogo sacro per la ‘ndrangheta, tutti i suoi capi ogni anno si riuniscono lì a settembre per stringere alleanze, dichiarare guerre, decidere strategie criminali — avvenuta qualche mese prima della fondazione di un nuovo partito. Siamo alla fine dell’estate del 1991, il pentito si chiama Pasquale Nucera, uno della ‘ndrina dei Iamonte di Melito Porto Salvo. Confessa Nucera: «C’è stata una riunione al santuario di Polsi nel comune di San Luca, nel corso del quale si parlò di un progetto politico...». C’erano tutti i capi più importanti della mafia calabrese. C’era Anche Amedeo Matacena, l’amico dell’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola. C’era anche un misterioso personaggio «che parlava italiano con un accento inglese o forse americano». È stato identificato come Giovanni Di Stefano, un affarista che negli anni passati ha provato a comprarsi gli studios della Metro Goldwyn Mayer, un sedicente avvocato (è stato denunciato poi anche per esercizio abusivo della professione) che comunque è riuscito a difendere in aula gente come Saddam Hussein, il suo braccio destro Tariq Aziz, Slobodan Milosevic, il leader paramilitare serbo Zeliko Raznatovic meglio conosciuto come la “Tigre Arkan”. Questo personaggio, finito nelle pieghe delle indagini siciliane sulle stragi, era presente al santuario di Polsi e fu lui a parlare per primo di «un “partito degli uomini” che doveva sostituire la Democrazia Cristiana in quanto questo partito non garantiva più gli appoggi e le protezioni del passato». Parole testuali del pentito Pasquale Nucera, che in un secondo momento si dichiarerà anche agente del Sisde, il servizio segreto civile italiano. In due interrogatori, ricorda uno per uno tutti i presenti al summit: «Seppure defilato, c’era anche Matacena, “il pelato”, appartato con Antonino Mammoliti di Castellace. Poi c’erano anche tutti i vari esponenti dei “locali” della ‘ndrangheta calabrese». Fa l’elenco: «Pasquale e Giovanni Tegano, Santo Araniti, uno dei Mazzaferro di Taurianova e uno dei Mazzaferro di Gioiosa Ionica, che abitava vicino al cimitero, Marcello Pesce, uno dei Versace di Africo, parente di un certo Giulio Versace, Antonino Molè, due dei Piromalli, Antonino Mammoliti ed altri…». I pm riassumono in una trentina di pagine le attività oscure di Matacena e i suoi rapporti con la ‘ndrangheta. Poi scrivono: «Emerge con univoca chiarezza dalle complessive acquisizioni, invero, che di tale rete di relazioni è membro di rilievo lo stesso Claudio Scajola, unitamente alle altre persone sottoposte ad indagine, il quale diviene funzionale nel complessivo panorama criminale oggetto di ricostruzione proprio in quanto interlocutore istituzionale proiettato verso una candidatura di rilievo alle prossime elezioni europee…». E riferendosi agli uomini e alle donne — compreso l’ex ministro degli Interni — che hanno protetto l’ex deputato latitante: «Nel caso in specie si comprende, quale dato di dirompente rilevanza, che l’attività di protezione svolta a favore del Matacena, finalizzata a preservarne la piena operatività, non è più rivolta a suo esclusivo vantaggio ma diviene il passaggio necessario a proteggere lo strumento indispensabile di agevolazione delle capacità economico-imprenditoriali del complessivo sistema criminale nella sua componente riferibile alla ‘ndrangheta reggina, di cui il politico/imprenditore (Matacena, ndr) è ormai componente essenziale e non sostituibile». Hanno favorito Amedeo Matacena e favorendo lui e il suo “sistema” hanno favorito tutta la ‘ndrangheta. Anche Claudio Scajola. Ecco perché i magistrati della procura della repubblica di Reggio Calabria volevano il suo arresto con l’aggravante dell’articolo 7. Dopo la decisione negativa del giudice, il procuratore capo Cafiero De Raho ha già annunciato appello.
Arrestato l'ex ministro Claudio Scajola: ha favorito la latitanza dell'ex deputato Pdl Amedeo Matacena. Dalle perquisizioni della Dda di Reggio Calabria emerge una potente associazione segreta internazionale di stampo massonico animata da figure come Amin Gemayel, capo dei falangisti libanesi e candidato alle presidenziali tenute a fine aprile. Nelle intercettazioni liti furiose con Giovanni Toti, scrive Gianfrancesco Turano su “L’Espresso”. Poco più di tre mesi dopo l'assoluzione per la casa romana comprata “a sua insaputa”, l'ex ministro Claudio Scajola finisce in carcere come regista della latitanza di Amedeo Matacena junior, amico e compagno di partito. Ordine di arresto anche per la seconda moglie di Matacena, l'ex modella Chiara Rizzo, e la madre Raffaella De Carolis. Dalle perquisizioni della Dda di Reggio Calabria emerge una potente associazione segreta internazionale di stampo massonico animata da figure come Amin Gemayel, capo dei falangisti libanesi e candidato alle presidenziali tenute a fine aprile. Fra i perquisiti ci sono Emo Danesi, storico piduista mai uscito di scena, due figli dello statista democristiano Amintore Fanfani, Giorgio e Cecilia, e l'imprenditore calabrese Vincenzo Speziali, 39 anni, nipote dell'omonimo senatore di Forza Italia, che, grazie al suo matrimonio con una nipote di Gemayel, fa la spola fra Roma e Beirut. Le indagini, in parte ancora secretate, evidenziano anche gli incontri tra i supporter di Matacena e l'eterno Luigi Bisignani, vero erede del suo maestro di loggia Licio Gelli. Secondo gli investigatori, il ruolo del protagonista spetta a Scajola. Tenuto sotto intercettazione per mesi, l'ex ministro dello Sviluppo economico si è prodigato per Matacena, arrivando a coordinare gli aspetti logistici e finanziari di una latitanza lussuosa e dispendiosa, che ha richiesto un impiego di fondi ingenti mossi dai conti bancari di Montecarlo, dove risiedeva Matacena, figlio omonimo dell'armatore napoletano che ha inventato i traghetti privati sullo Stretto di Messina e che ha avuto un ruolo importante nei moti per Reggio capoluogo del 1970-1971. Amedeo Matacena junior, deputato per due legislature ed ex coordinatore regionale di Forza Italia su indicazione proprio di Scajola, è in fuga dal giugno 2013, dopo che la Cassazione aveva confermato la sua condanna a cinque anni e quattro mesi per concorso esterno in associazione mafiosa con la famiglia Rosmini, una cosca fra le più potenti della 'ndrangheta reggina. In aggiunta, il cinquantenne Matacena ha anche una condanna in primo grado a quattro anni per corruzione. Scappato alle Seychelles, poi negli Emirati dove è stato arrestato in agosto e poco dopo rilasciato, Matacena stava per abbandonare Dubai. La metropoli araba era ormai insicura e i giudici sembravano orientati a concedere l'estradizione. La nuova meta di Matacena era Beirut, il porto franco dei latitanti mafiosi. La Direzione investigativa antimafia, coordinata dal sostituto procuratore di Reggio Giuseppe Lombardo e dal procuratore capo Federico Cafiero de Raho, è intervenuta prima che Matacena andasse a raggiungere il padre fondatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, che da Beirut attende la pronuncia della Cassazione sulla sua condanna associazione mafiosa il 9 maggio. Il senatore palermitano è stato arrestato il 12 aprile in un albergo di Beirut, in piena campagna elettorale per le presidenziali che ancora non hanno indicato un vincitore. Ma il nuovo presidente potrebbe negare l'estradizione di Dell'Utri per motivi politici. Gemayel, uno dei candidati, ha già occupato la poltrona presidenziale del paese dei cedri in uno dei periodi più drammatici della storia del Libano (1982-1988), succedendo al fratello Bashir e governando la fase della guerra civile. I legami di Amin Gemayel con l'Italia sono di antica data. Il capo dei cristiano maroniti è stato fra i primi a rendere omaggio, l'anno scorso, alla tomba di Giulio Andreotti, sepolto al cimitero del Verano. Due anni fa, i giornali locali hanno dato rilievo alla sua visita privata in Calabria, dove è stato ospite dell'allora senatore Speziali, uno dei maggiori imprenditori calabresi con interessi in varie regioni italiane. Più di recente Gemayel, che è vicepresidente dell'Internazionale democristiana ed è molto legato anche al segretario Udc Lorenzo Cesa, è stato in Italia per incontrare Silvio Berlusconi. L'appuntamento, preso a Roma, è stato spostato a Milano all'ultimo momento suscitando le ire del politico falangista, il suo rientro in Libano e una sua piccata smentita quando Berlusconi ha dichiarato che Dell'Utri si era recato a Beirut per assistere Gemayel nella sua campagna elettorale. Le intercettazioni dell'inchiesta reggina rivelano retroscena di feroce contrapposizione politica tra i vecchi padri costituenti del berlusconismo e i rampanti della nuova Forza Italia. In particolare, ci sarebbero agli atti una serie di liti telefoniche furiose tra Scajola e l'astro nascente del forzismo, Giovanni Toti, alleato con le donne di Silvio nel bloccare o limitare gli accessi dell'ex ministro ligure e di Denis Verdini a palazzo Grazioli. Ma i vecchi avevano ancora molte carte da giocare, grazie alla solidità dei rapporti internazionali garantiti dalla rete massonica. Il collante dell'operazione “Matacena libero” è sempre quello della fratellanza fra liberi muratori. E qui è ancora da sviluppare appieno il ruolo di Emo Danesi, livornese di 79 anni, ex segretario del boss democristiano del Veneto Toni Bisaglia e sottosegretario alla Marina mercantile, espulso dalla Dc di Ciriaco De Mita e dal Grande oriente d'Italia in quanto iscritto alla loggia P2 (tessera 752). Dagli anni Ottanta, Danesi ha preferito il ruolo del burattinaio invisibile – Gelli docet – ed è emerso soltanto a tratti. Una prima volta nel 1996, in occasione della seconda Tangentopoli, come punto di riferimento del banchiere toscano-svizzero Chicchi Pacini Battaglia. Una seconda volta nel giugno del 2007, quando l'allora sostituto della procura di Potenza Henry John Woodcock ha tentato invano di incastrarlo per associazione segreta ex lege Anselmi insieme ad altri esponenti dell'Udc. Il prosieguo dell'inchiesta dirà se Danesi può essere considerato uno degli “invisibili”, un gruppetto ristretto che detta legge e i termini della politica internazionale usando clan mafiosi, servizi segreti e logge deviate. Su questa oligarchia potente e ristrettissima lavora da anni il pm reggino Lombardo. Di sicuro, Matacena a Beirut avrebbe ritrovato qualcosa di più di un compagno di partito. In una sua dichiarazione alla stampa in cui rivelava la delusione per essere stato estromesso dalle liste berlusconiane, il figlio dell'armatore affermava: “Ritengo di essermi comportato da amico con il presidente Berlusconi. Sono andato a Palermo a testimoniare al processo di Dell'Utri contro Filippo Alberto Rapisarda. Mi sono trascinato dietro altri testimoni che avevano perplessità a raccontare i fatti per come erano avvenuti. Ritengo che questa testimonianza sia stata fondamentale per smontare il teste Rapisarda. Poi su richiesta di Berlusconi sono andato a testimoniare a Caltanissetta contro la procura di Palermo”. Lo stesso favore gli è stato reso da Scajola che si è prodigato in testimonianze a favore dell'imputato Matacena durante il processo Olimpia. Oggi, fra Scajola, Dell'Utri e Matacena, l'unico a piede libero è proprio Matacena. Forse non per molto.
Da Scajola agli amici in Medioriente. Tutti i nomi dietro il "Circolo Matacena". Il decreto di perquisizione della Dda di Reggio Calabria mette in luce un doppio binario diplomatico-finanziario per garantire la fuga dell'ex deputato Amedeo Matacena. Con personalità che vanno dalla massoneria alla politica. E l'arresto del già titolare dell'Interno è solo la punta dell'iceberg, scrive Gianfrancesco Turano su “L’Espresso”. La rete di Amedeo Matacena è impressionante. L'ex ministro Claudio Scajola è soltanto l'uomo più in vista di un network che spaziava fra l'Italia, il principato di Monaco e il Medioriente. Nel decreto di perquisizione della Dda di Reggio Calabria emerge un doppio binario diplomatico-finanziario per mettere in sicurezza l'ex deputato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Ecco come la Procura di Reggio Calabria riassume la situazione: “Nel corso delle indagini sono emersi continui contatti e collegamenti fra i soggetti investigati e appartenenti a ambienti politici, istituzionali e imprenditoriali... La gestione di tali operazioni politiche, istituzionali ed economiche ha consentito alle persone sottoposte a indagini di diventare il terminale di un complesso sistema criminale, la gran parte di natura occulta e operante anche in territorio estero, destinato anche ad acquisire e gestire informazioni riservate fornite da numerosi soggetti in corso di individuazione”.Poco dopo le 11 l'ex ministro Claudio Scajola ha lasciato la sede della Dia di Roma per essere portato in carcere a Regina Coeli, dove è in arresto per aver favorito la latitanza dell'ex deputato Amedeo Matacena. All'uscita dell'edificio Scajola ha mostrato un momento di evidente sorpresa per la presenza delle telecamere e fotografi che lo attendevano nel breve tragitto verso l'auto delle forze dell'ordine. Insomma l'operazione conclusa all'alba dell'8 maggio con l'arresto di Scajola, della sua segretaria Roberta Sacco, della moglie di Matacena, Chiara Rizzo, e di altri cinque indagati è soltanto l'inizio. Indagato ma non arrestato risulta il trentanovenne Vincenzo Speziali junior, che in un colloquio con Scajola dice di sé: “io sono programmato per non sbagliare”. Speziali ha sposato la libanese Joumana Rizk, che risulta essere nipote di Amin Gemayel, ed è omonimo dello zio senatore ed ex presidente di Confindustria Calabria, oltre che presidente dell'aeroporto di Lamezia Terme su nomina di Giuseppe Scopelliti, governatore dimissionario e candidato Ncd alle Europee. Speziali senior è anche indagato per concussione all'Asp di Crotone. Molti degli amici del “circolo Matacena” sono semplicemente citati nei documenti della Dda reggina. Molti hanno cognomi storici o vicende giudiziarie alle spalle. Appena Matacena viene arrestato a Dubai, dove si è recato per rinnovare il visto di permanenza alle Seychelles nello scorso agosto, è Giorgio Fanfani, figlio di Amintore, ad attivarsi per trovare un legale italiano negli Emirati: Ottavia Molinari. La sorella Cecilia Fanfani è definita “buona amica” da Chiara Matacena. Al consulto legale partecipa anche Carlo Biondi, figlio dell'ex Guardasigilli e avvocato Alfredo. C'è poi Marzia Mittiga, moglie dell'armatore Manfredi Lefebvre d'Ovidio, anch'egli residente a Montecarlo come l'armatore Matacena. Marzia Lefebvre, secondo gli investigatori, ha prestato la sua mail per alcuni messaggi che Chiara doveva mandare al marito negli Emirati. Speziali junior è l'ufficiale di collegamento che organizza, l'11 febbraio 2014, l'incontro romano tra Chiara Matacena e Luigi Bisignani. Lo stesso giorno, Speziali pranza con un altro piduista, il livornese Emo Danesi, vicino all'Udc. Durante il pranzo, Speziali telefona a Scajola mentre l'ex ministro si trova al ristorante romano Le tamerici con Daniele Santucci e Giovanni Morzenti. Santucci, presidente dell'Agenzia italiana per pubbliche amministrazioni e socio di Pier Carlo Scajola, figlio di Claudio, sarà arrestato il 14 marzo 2014 con l'accusa di peculato per 7 milioni di euro. Bisignani finirà agli arresti il 14 febbraio, tre giorni dopo l'incontro per l'affaire Matacena, per gli appalti di Palazzo Chigi. Morzenti, ex presidente della Federazione italiana sport invernali (Fisi), è stato condannato in via definitiva per concussione nel febbraio 2013. Alla comitiva dell'11 febbraio di unisce a un certo punto anche l'ex deputata crotonese del Pd Marilina Intrieri. Ma l'aiuto più importante a Chiara Rizzo arriva sicuramente da Scajola. È lui che la moglie di Matacena chiama in lacrime alle 9 di mattina appena dopo l'arresto del marito a Dubai, il 28 agosto 2013, chiedendogli subito un incontro a Montecarlo. L'ex ministro glielo concede. Da lì in avanti le intercettazioni fra i due sono spesso criptiche, con il latitante che viene a volte indicato come “la mamma” oppure con il nome del figlio Athos. Quando poi, dopo una serie di incontri a Beirut e all'ambasciata romana del Libano, il circolo Matacena deciderà di tentare la carta dell'asilo politico sotto l'ombrello protettore di Amin Gemayel, Scajola parlerà al telefono di “scuola”. Peraltro, senza subito essere compreso da Chiara Matacena. Più complessa è l'articolazione del salvataggio economico. In previsione della fuga, Matacena organizza un reverse merger delle sue società (Amadeus con le sue tre motonavi, la finanziaria Solemar, la lussemburghese Xilo, la Mediterranea shipping, più le due liberiane Amshu e Athoschia) per evitare di essere coinvolto nel blocco dei beni. Anche la moglie subisce il blocco del suo conto al Monte dei Paschi di Siena per decisione della direzione a settembre del 2013. Il flusso di soldi, però, è proseguito.
Non solo Expo 2015, scrivono Emilio Randacio ed Attilio Bolzoni su “La Repubblica”. Primo Greganti, Gianstefano Frigerio, Angelo Paris e gli altri arrestati e indagati nell’inchiesta milanese gestivano appalti anche nella Sanità lombarda. Intanto emergono nuovi particolari nell’indagine che ha portato all’arresto dell’ex ministro di Forza Italia Claudio Scajola. E da Dubai, dove si trova da latitante, Amedeo Matacena dice a Repubblica: faccio il maître, non tornerò in Italia. Ieri sera la Cassazione ha confermato la condanna a 7 anni di reclusione per Marcello Dell’Utri. La «cupola» o la «cordata»: così nelle carte della procura viene indicato il gruppo di sette persone finite in carcere a Milano per associazione a delinquere all’alba di giovedì. Un «circuito deflagrante e perverso», scrive sempre la procura, pilotato dagli gli ex parlamentari Luigi Grillo e Gian Stefano Frigerio insieme al «compagno G» Primo Greganti. Quest’ultimo, alla vista dei militari che gli notificavano l’ordinanza diciannove anni dopo quella che lo portò in cella durante Tangentopoli, è scoppiato in lacrime. Insieme al direttore generale degli acquisti Expo Angelo Paris, all’ex segretario Udc ligure Sergio Mattozzo (al quale i militari hanno trovato in casa 12.500 in contanti nascosti), puntavano a mettere le mani su appalti per mezzo miliardo. La fetta più corposa erano gli oltre 300 milioni che vale il progetto della “Città della salute”, le cui buste con le offerte dovevano essere segrete e sono invece state rinvenute e sequestrate durante gli arresti.
Expo e sanità, il sistema spiegato da un factotum dell’ex dc Frigerio. L’accordo con Greganti. «Ragazzi, adesso c’è la Città della Salute», scrive Luigi Ferrarella su “Il Corriere della Sera”. Il manuale d’istruzioni della catena di montaggio degli appalti truccati, l’autopsia in diretta dei «delitti» compiuti nei lavori della sanità o delle opere pubbliche come Expo: il Virgilio che guida in questo girone infernale è, in una impagabile intercettazione ambientale nel circolo culturale milanese «Tommaso Moro» dell’arrestato ex dc ed ex parlamentare berlusconiano Gianstefano Frigerio, il suo factotum di fiducia: l’indagato Giovanni Rodighiero, orgoglioso il 31 luglio 2012 di magnificare il sistema a un non identificato dirigente sanitario tanto desideroso di esservi ammesso. «I primari, i medici che gareggiano, vengono e vanno dai politici perché la Sanità è gestita dai politici - esordisce Rodighiero - . Allora se tu hai il santo protettore», che nel contesto sarebbe Frigerio, «il santo protettore ne prende atto (delle tue esigenze ndr ), ti chiede il curriculum e poi va a parlare con chi di dovere... Se gli garantisce il direttore generale che lo porta quello là, questo si afferma... fa la gara e vince lui...». Il risultato è che «lui è riconoscente a Gianstefano» e «Gianstefano è riconoscente al direttore generale». E «dato che soldi non ce ne sono sempre», o «si rompe le scatole al direttore generale di dargli un po’ di soldi o di mettere questo cavolo di macchinario che serve... capito?». Si può così passare alla fase due: la gara d’appalto per il tipo di fornitura in questione, e cioè - riassume il gip Fabio Antezza - «i meccanismi tramite i quali si riesce a predeterminare l’aggiudicazione a favore delle imprese per cui opera l’associazione, in primo luogo con il confezionamento ad hoc di bandi di gara e capitolati». Anche qui lo spiega Rodighiero, che fa l’esempio di una gara da 40 milioni di euro nella ristorazione in ambito ospedaliero: «C’è il provveditore e c’è l’ingegnere che stanno preparando il tutto, l’ingegnere l’ho fatto conoscere all’azienda. Come è pronto il documento (lo schema del bando ndr ), viene dato a una persona fidata, va in azienda, glielo dà, lo guardano... “questo non va bene e questo va bene... c’è da aggiungere questo questo e questo... farla su misura a me”... Viene ridato, l’ingegnere mette dentro e toglie (quello che l’impresa aveva chiesto di aggiungere e levare ndr ), il provveditore e l’ingegnere sono in sintonia. E quando è pronto il capitolato, è stato fatto su misura a te e non ad altri». Terzo tempo: adesso c’è da concordare il prezzo per la corruzione. «Se hai vinto, c’è un accordo a monte, che tu devi riconoscere ics...». Anche con rateizzazioni della mazzetta: l’appalto «viene dato a te, perché si chiude con l’accordo a te e tu sei l’uomo che deve andare dal direttore generale a dargli i soldi, ogni anno... Subito tutti non li hai... hai un anticipo annuale alla firma. Quando hai vinto l’appalto, un ics... ti tieni la tua parte e il resto gliela dai a quello là... l’anno prossimo quando fanno i pagamenti gli dai la rata... per nove anni». Quarta e ultima fase: il mantenimento degli accordi. E qui, per quanto buffo possa sembrare nel contesto tangentizio, la credibilità è tutto. L’importante è che l’accordo sia osservato qualunque cosa succeda, perfino se quel determinato manager statale corrotto dovesse cambiare posto: «Lui va via? Vai avanti a dargliela, eh?... è sempre stato così». Perciò i componenti dell’associazione a delinquere temono come la peste quegli imprenditori che non siano puntuali nel rispettare la tabella dei pagamenti programmati. Lo si ascolta, in un’altra intercettazione, quando il 15 marzo 2013 uno dei mediatori che collaborano con Frigerio, Walter Iacaccia, gli esprime l’irritazione per un imprenditore che non sta onorando una rata di 50.000 euro, che Frigerio a sua volta attende di dover poi consegnare a un pubblico ufficiale: «Io gli ho semplicemente detto (all’imprenditore inadempiente ndr ): non devi farmi fare figure di cacca... perché se tu fai così, non sai cosa ti precludi... ma soprattutto non puoi più chiedere favori... Ma che persona sei? Io ci metto la faccia sempre... ma porca miseria, ma tu pensi veramente di poter lavorare senza di noi?». Ieri, intanto, dai politici evocati «de relato» nelle intercettazioni sono arrivate altre smentite. Dopo aver letto che Frigerio asseriva «devo mandare un biglietto a Maurizio Lupi con il nome di Antonio Rognoni (allora direttore generale uscente di Infrastrutture Lombarde ndr ) per suggerirlo come presidente Anas», l’alfaniano ministro delle Infrastrutture ieri ha dichiarato «con assoluta certezza di non aver mai ricevuto quel biglietto né alcun altro tipo di comunicazione». Di «illazioni o millanterie» aveva già parlato anche l’ex segretario pd Pierluigi Bersani, citato il 7 settembre 2012 da Frigerio che aggiornava Rognoni sul progetto della Città della Salute a Sesto San Giovanni, del valore di 323 milioni e con stazione appaltante proprio Infrastrutture Lombarde: «Ho sentito un po’ a Roma Bersani e poi gli altri sulla Città della Salute, tu devi cominciare a fare delle riflessioni, poi, senza responsabilità tue, mi dici come far partire un colosso macello perché è una cosa grossa... Poi Bersani mi ha detto “a sinistra cosa fate?”, bisogna che senta, se Rognoni mi dice Manutencoop per me va bene». Ma per Bersani questo discorso non c’è mai stato. Le buste sigillate con le offerte relative alla gara ancora da aggiudicare per la realizzazione della Città della Salute sono fra le carte che l’altro ieri gli inquirenti hanno sequestrato a margine dei 7 arresti: a detta del gip, per l’associazione capeggiata da Frigerio era «necessario coinvolgere da subito un grande pool di imprese», procedendo «in accordo con Primo Greganti» e spingendo sulla «Cooperativa Manutencoop» (il cui indagato amministratore Claudio Levorato è una delle 12 persone per cui il gip ha respinto l’arresto per carenza di esigenze cautelari) «in quanto la coop ha i necessari collegamenti» a sinistra, là dove Frigerio si ritiene «coperto» appunto da Greganti, il «compagno G» già arrestato in Mani pulite vent’anni fa. Sin dal settembre 2012, ritiene quindi il gip, «il sodalizio imposta la consueta strategia di individuazione delle opzioni anche politiche in grado di assicurare un intervento efficace, e degli imprenditori da favorire con avvicinamento e corteggiamento». Che le intercettazioni possano sempre avere più spunti di lettura, del resto, affiora persino nel caso di Rognoni, sul cui conto l’arrestato Sergio Cattozzo (ex segretario dell’Udc ligure e collaboratore di Frigerio) il 20 gennaio di quest’anno esprimeva delusione dopo un iniziale periodo di abboccamenti reciproci, concordando con Frigerio su quanto fosse invece il caso di investire meno su Rognoni e più sul successore Angelo Paris, general manager di Expo 2015 pure arrestato giovedì: «...perché fra poco c’è la Città della Salute, ragazzi!... E siccome Rognoni a noi non ha dato niente, non abbiamo nemmeno debiti nei suoi confronti». Greganti, per parte sua, appare molto interessato a ritagliarsi un ruolo nella realizzazione del padiglione della Cina (con la quale ha noti legami d’affari) all’Expo 2015. Il 21 marzo scorso, al telefono con il liquidatore di Tempi Moderni S.r.l., Greganti - annota il gip - «sottolinea che la Cina ha intenzione di predisporre l’intero padiglione in modalità self-built», cioè costruendoselo da sola, «tuttavia Greganti riferisce di aver comunque rappresentato l’importanza della sua mediazione», per la quale sembrerebbe tenere rapporti con l’ambasciata di Pechino e mandare una memoria in Cina. Intanto le comiche, come talvolta accade, fanno capolino al confine di cose serie. E così giovedì, durante le perquisizioni Gdf contemporanee all’arresto delle 7 persone, Cattozzo è quasi riuscito a far sparire davanti ai militari, strappandoli da una agenda e nascondendoli nelle mutande, alcuni post-it. I foglietti, una volta recuperati dall’imbarazzante nascondiglio, si sono rivelati annotazioni di cifre e percentuali e nomi: forse proprio la medesima contabilità delle tangenti su una gara di Expo 2015 che i pm Antonio D’Alessio e Claudio Gittardi avevano ascoltato in una intercettazione.
Caso Expo, Greganti e la pista cinese. Come per Mani pulite la Cina è il cuore del business dell'ex tesoriere Pci: il suo braccio operativo è la società Seinco, scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. Sindrome cinese: scavi nell'Expo di Milano e sbuchi in Cina. Negli affari di Primo Greganti, il «compagno G» tornato in cella a ventun anni da Tangentopoli, riaffiora prepotentemente la potenza asiatica. Di Cina l'ex tesoriere del partito comunista torinese aveva già parlato nel 1993, quando aveva cercato di convincere i pm milanesi che i 621 milioni incassati da Panzavolta non erano destinati a Botteghe Oscure ma a cercare appalti nella Repubblica Popolare. E di Cina si torna a parlare nelle carte della retata che l'altro ieri rispedisce in carcere Greganti insieme al suo coevo dell'altra sponda, l'ex dc Gianstefano Frigerio.A stimolare l'interesse di Greganti è il padiglione che il governo di Pechino deve realizzare per l'esposizione universale milanese del 2015. Business di «grande interesse», secondo l'ordine di custodia, per il «compagno G», che tiene rapporti con l'Ambasciata cinese in Italia e manda memorie in Cina. «Beh i cinesi li abbiamo incontrati, li ho incontrati a Milano», dice Greganti in una intercettazione, «fanno fare tutto giù in Cina, qui c'è solo un problema di montaggio (...) Perché c'è un rapporto con le Istituzioni, con l'Amministrazione, un rapporto con le altre imprese che lavorano lì». «Comunque - aggiunge - in ogni caso, gli abbiamo detto noi siamo qua (...) che se avete bisogno noi ci siamo, insomma, vi assistiamo in tutto, voi state tranquilli, definiamo prima quali sono i costi, voi sicuramente risparmiate, accelerate i tempi e noi vi diamo una mano». D'altronde «la Cmc già c'ha un ufficio in Cina a Shangai». L'ultima affermazione è interessante, perché riporta a uno degli assi conduttori dell'inchiesta su Expo: il rapporto tra Greganti e le cooperative rosse, il ruolo del «compagno G» nell'assicurare alle coop fette rilevanti della torta milanese. Secondo la Procura, il braccio operativo di Greganti è una società torinese che si chiama Seinco. È a nome della Seinco, per esempio, che l'11 dicembre scorso Greganti telefona a Riccardo Casale, amministratore delegato di Sogin, il colosso pubblico dello smaltimento nucleare: «Sono della società Seinco, gli dica Primo Greganti, lui si ricorderà probabilmente». Oggi, negli uffici della Seinco i telefoni suonano a vuoto, la mail è irraggiungibile. Ma fino a pochi mesi fa la Seinco era pienamente operativa, il sito vanta appalti in Cina, a Cuba, lavori per le cooperative e per il gruppo Ferruzzi (sarà ancora la consulenza dei 621 milioni?). Per il giudice preliminare Fabio Antezza la Seinco è lo scherma dietro cui viaggiano le tangenti: «Il documento in oggetto - scrive il gip commentando uno scambio di mail tra Greganti e un dirigente della cooperativa Cmc - conferma il sovente (sic) utilizzo da parte degli associati di fittizi contratti di consulenza come mezzo attraverso cui giustificare la percezione delle indebite dazioni di denaro». Il confine tra consulenza e tangente può risultare esile: e proprio su questa linea è facile prevedere che si attesterà Greganti, quando dopodomani si troverà faccia a faccia col giudice che lo ha arrestato. Anche a lui, come vent'anni fa a Di Pietro, il tarchiato ex cassiere del Pci spiegherà di non essere un collettore di mazzette ma un semplice, scrupoloso cucitore di rapporti commerciali. D'altronde, anche a leggerle una per una, è impossibile trovare nelle intercettazioni una sola frase in cui Greganti si sbilanci. Mentre Frigerio ne dice di cotte e di crude, Greganti è sempre lui: attento, preciso, taciturno. È innocente, o ha semplicemente imparato la lezione?
C'è il compagno G, D'Alema si scopre garantista. L'ex premier freddo sull'inchiesta. E Lupi si difende sul pizzino di Frigerio: mai ricevuto, scrive Giannino della Frattina su“Il Giornale”. Dopo i sette arresti dell'alba di giovedì e le 80 perquisizioni in 15 città che hanno decapitato i vertici dell'Expo con il general manager Angelo Paris finito a San Vittore, Massimo D'Alema si riscopre garantista. Sarà perché questa volta alle patrie galere sono state associate anche due vecchie conoscenze di Mani pulite come l'allora segretario della Dc Gianstefano Frigerio e il cassiere del Pci Primo Greganti e quello erano tempi in cui «Baffino» era giovane e sognava per sé un futuro ben più radioso di quanto sia poi stato. O forse perché quando l'inchiesta cominciò a occuparsi delle tangenti rosse al Pci-Pds, fu proprio D'Alema a definire con disprezzo il pool «soviet di Milano». In realtà un soviet che si occupò di tutti fuorché dei comunisti, spianando loro la strada verso un potere che mai avrebbero conquistato. Son passati gli anni ed ecco D'Alema a difendere (forse per gratitudine) il «compagno G», quel «militante di scarsa fama, ma di sicura fede» che, arrestato nel '93, tenne testa ai magistrati negando che una tangente da 1,2 miliardi di lire fosse destinata al suo partito. Risparmiando così qualche guaio ai «rossi», ma arrecandone parecchi al nostro sventurato Paese. «Sono molto prudente a parlare di vicende giudiziarie che non conosco», ha detto ieri D'Alema presentando il suo Non solo euro al Salone del libro di Torino con il direttore del Tg3 Bianca Berlinguer. Tanto per non andare troppo lontano. «Ho imparato - ha assicurato iper garantista - che il 40-45 per cento delle persone accusate vengono prosciolte». Dicendosi perciò scettico sulla «smania di pronunciare sentenze su istruttorie parziali». E assicurando che «oggi sono finiti i partiti ma non la corruzione che è un fattore endemico nella società italiana». A Roma, intanto, un «biglietto» galeotto fa tremare il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi che nella sfida dell'Expo si è buttato a capofitto. Perché molti lavori e finanziamenti sono di sua competenza, ma anche perché sogna di correre tra due anni per diventare sindaco di Milano dove fu assessore nella giunta Albertini. Allora formigoniano di ferro, oggi in rampa di lancio per prendere il suo posto al vertice di quella galassia ciellina da cui sta cercando di estromettere il Celeste, ormai troppo invischiato nelle vicende giudiziarie per essere un buon testimonial del nuovo corso dell'Ncd alfaniano. «Leggo che nell'ordinanza per gli arresti dell'indagine sugli appalti di Expo - si legge in una nota di Lupi - vengo citato da Gianstefano Frigerio. Il quale, il 29 aprile dell'anno scorso, affermava: Devo mandare un biglietto a Maurizio Lupi con il nome di Antonio per suggerirlo come presidente Anas. Posso dire con assoluta certezza di non aver mai ricevuto quel biglietto né alcun altro tipo di comunicazione». A parlare del biglietto è il gip di Milano Fabio Antezza nell'ordinanza di custodia cautelare, mentre l'Antonio di cui si parla è quel Rognoni arrestato un mese fa nell'inchiesta su Infrastrutture Lombarde. A Milano, intanto, il giorno dopo le manette il sindaco Giuliano Pisapia e il governatore Maroni spingono per accelerare al massimo la nomina del sostituto di Paris. «Purtroppo - dice Maroni - Paris faceva tutto e deve essere sostituito immediatamente con una persona che abbia due requisiti: grande competenza e professionalità e, visto questo rigurgito di Tangentopoli, magari se viene da fuori e non ha avuto rapporti con questi ambienti è meglio». Fretta e condizioni che sembra non siano piaciute al commissario Expo Giuseppe Sala a cui spetta la decisione. E martedì a Milano arriva il premier Matteo Renzi.
Come prima, più di prima, scrive Gian Antonio Stella su “Il Corriere della Sera”. Per piacere: evitateci lo stupore scandalizzato, «chi se lo immaginava?», «non l’avrei mai detto...». Tutto sono, gli arresti di ieri per l’Expo 2015, tranne che una clamorosa sorpresa. Perché, ferma restando l’innocenza di tutti fino alle sentenze, le cose stavano procedendo esattamente come era andata troppe altre volte. Il solito copione. Recitato per i Mondiali di nuoto, le Universiadi, la World Cup di calcio, l’Anno Santo... Anni perduti nei preliminari, discussioni infinite sui progetti, liti e ripicche sulla gestione e poi, di colpo, l’allarme: oddio, non ce la faremo mai! Ed ecco l’affannosa accelerazione, le deroghe, il commissariamento, le scorciatoie per aggirare lacci e lacciuoli, le commesse strapagate, i costosissimi cantieri notturni non stop. Sono sei anni, dal 31 marzo 2008, che sappiamo di dovere organizzare l’Expo 2015. E anni che sappiamo, dopo i trionfi di Shanghai 2010 dove il nostro padiglione fece un figurone, che l’impresa è difficile se non temeraria. Eppure solo Napolitano, all’ultimo istante, si precipitò alla grandiosa esposizione cinese per ricevere il passaggio del testimone e mettere una toppa sulle vistose assenze del nostro governo. Dopo di allora, tanti proclami, annunci, rassicurazioni... Mentre cresceva, nonostante l’impegno generoso di tanti, la paura di non farcela. È una maledizione, la fretta. E ci caschiamo sempre. O forse è peggio ancora: c’è anche chi scommette sui ritardi e sulla accelerazione febbrile col cuore in gola. Quando il rischio che salti tutto fa saltare le regole che erano state fissate e i prezzi schizzano sempre più su, più su, più su. Proprio come previde nel 2010 la presidente degli architetti milanesi denunciando «perplessità in merito al rispetto delle scadenze per il completamento dei lavori, alla trasparenza delle procedure e alle modalità che saranno utilizzate per affidare gli appalti». Già la prima di quelle gare, del resto, fu un’avvisaglia: vinse un’impresa con un ribasso enorme da 90 a 58 milioni ma l’anno dopo già batteva cassa per averne 88. Per non dire delle infiltrazioni nei subappalti di imprese in odore di mafia: il capo della polizia Pansa, mesi fa, comunicò che 23 aziende erano state escluse. Lo stesso sindaco Pisapia, però, spiegò d’essere sulle spine: troppi, sei mesi di analisi burocratiche, per verificare la serietà di una ditta. Tanto più se la fretta si fa angosciosa. L’unica sorpresa, nella retata di ieri che segue il fermo un mese fa del direttore generale di Infrastrutture Lombarde Giulio Rognoni, sono i nomi di alcuni degli arrestati. Già tirati in ballo vent’anni fa, nella stagione di Mani pulite, come se non fosse cambiato niente. Dal costruttore Enrico Maltauro all’ex pci Primo Greganti fino all’ex dicì Gianstefano Frigerio, poi candidato da Forza Italia (lifting anagrafico...) col nome d’arte di Carlo. Ma come, direte: ancora? Ancora, accusano i magistrati. E parlano d’«una cupola» che «condizionava gli appalti» in favore di «imprese riconducibili a tutti i partiti». Cosa significa «tutti»? Mancano solo un paio di settimane alle elezioni europee. E un anno all’apertura dell’Expo: i dubbi su quello che è oggi il più grande investimento nazionale e rischia di trasformarsi da vetrina della speranza e del rilancio in una vetrina infangata devono essere spazzati via in fretta.
Romanzo criminale bipartisan, scrive Marco Lillo su “Il Fatto Quotidiano”. Gli arresti di Reggio Calabria nei confronti di Claudio Scajola (per aver favorito nella latitanza l’ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena) e quelli nei confronti di due ex democristiani passati a Forza Italia, Gianstefano Frigerio e Luigi Grillo, per gli appalti dell’Expo di Milano, insieme al compagno Primo Greganti, fotografano due momenti di un unica storia iniziata venti anni fa. Se le accuse saranno confermate non sarà poi tanto esagerato parlare di un ‘romanzo criminale’ che affianca e spesso si intreccia con la storia ufficiale del partito fondato e tuttora guidato nei fatti da Silvio Berlusconi. Claudio Scajola è stato arrestato, con l’accusa di avere favorito l’ex parlamentare calabrese di Forza Italia Amedeo Matacena nella sua latitanza. L’ex parlamentare calabrese che ha avuto un momento di gloria quando testimoniò in favore di Marcello Dell’Utri al suo processo, è stato condannato a 5 anni per i suoi rapporti con le cosche di Reggio. Voleva andare in Libano da Dubai dove era stato localizzato ed era in attesa di estradizione. Nella sua ordinanza, il gip scrive che le investigazioni “vedono Scajola in pole position nell’impegno volto all’individuazione di uno Stato estero che evitasse per quanto possibile l’estradizione di Matacena o la rendesse quantomeno molto difficile e laboriosa. Tale Stato Scajola lo individuava nel Libano, impegnandosi con personaggi esteri di rango istituzionale per ottenere tale appoggio per tramite di importanti amicizie”. La storia è intrigante perché c’è un punto di connessione tra la fuga di Dell’Utri e quella del suo vecchio amico degli inizi di Forza Italia. Secondo il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho: “C’è qualche identità personale in relazione alle due indagini. Si tratta di un personaggio destinatario di perquisizione che ci risulta protagonista nella vicenda Dell’Utri, Speziali”, cioé Vincenzo Speziali, nipote e omonimo dell’ex senatore del Pdl, sarebbe lui l’uomo che aveva un gancio con l’ex presidente del Libano Gemayel, candidato alle prossime elezioni e in buoni rapporti con Silvio Berlusconi. L’indagine della Dia di Reggio Calabria racconta quindi che un ex ministro dell’interno nonché ex coordinatore del partito di Silvio Berlusconi, avrebbe favorito un condannato definitivo per concorso esterno con la ’ndrangheta nella sua fuga. Non solo. Ci racconta che la destinazione finale e il gancio della fuga di Matacena a Beirut sarebbero comuni con quella appena avvenuta del fondatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri. L’immagine di Scajola, ministro dell’Interno che guidò il Viminale nel triste momento del G8 di Genova nel 2001, che viene portato negli uffici della Dia di Roma e poi nel carcere di Regina Coeli è certamente inquietante ma almeno appartiene ormai al passato dell’Italia berlusconiana. Come anche l’immagine di Marcello Dell’Utri trattenuto in ospedale a Beirut o quella di Matacena, per ora libero di circolare a Dubai. L'altra indagine, quella di Milano sugli appalti delll’Expo, invece è molto più inquietante perché riguarda l’oggi. Non solo nel campo del centrodestra ma anche in quello del centrosinistra. L’ordinanza di arresto di Milano ha colpito quella che sembra, secondo la ricostruzione dell’accusa, una sorta di cupola bipartisan degli appalti. Sono stati infatti arrestati Primo Greganti, il compagno G simbolo del coinvolgimento del Pci nell’indagine Mani Pulite nel 1992 da un lato e Gianstefano Frigerio, simbolo della continuità tra le mazzette della prima repubblica e la politica della seconda repubblica, dall’altro lato. Frigerio infatti, nato nel 1939 a Cernusco sul Naviglio, è stato condannato definitivamente a tre anni e nove mesi per le mazzette sulle discariche lombarde (corruzione) e a due anni e undici mesi in altri due processi della Tangentopoli milanese. Era il capo della Dc a Milano ed è diventato deputato di Forza Italia grazie a Berlusconi nel 2001. Primo Greganti, classe 1944, divenne famoso per il suo silenzio con i magistrati ai tempi di Tangentopoli. Il primo marzo 1993 venne arrestato su richiesta del pm Antonio Di Pietro, con l’accusa di corruzione, per aver ricevuto in Svizzera, tra il 1990 e il 1992, 621 milioni dal gruppo Ferruzzi per appalti Enel. Denaro che, secondo la magistratura, rappresentava la prima delle due quote riservate al Pci-Pds delle tangenti concordate con il sistema dei partiti (l’1,6 per cento sul valore delle commesse). Il compagno G. negò sempre ogni addebito e continuò a ripetere che si trattava di consulenze personali. Alla fine Greganti patteggiò solo una pena di 3 anni poi ridotta di sei mesi. Tra gli arrestati di ieri c’è anche un vecchio democristiano ligure, Luigi Grillo, poi passato a Forza Italia e decisivo nella nascita del primo Governo Berlusconi nel 1994. Grillo parlava al telefono con l’ex ministro della difesa del primo Governo Berlusconi. Non dei bei tempi del 1994 ma della nomina di un manager pubblico, Giuseppe Nucci, che aspirava a una nomina a Terna. Previti parla con Grillo dell’argomento Nucci e quest’ultimo parla con Greganti. Insomma, se Frigerio, Greganti e Grillo sono personaggi del passato. Gli affari di cui si occupavano sono quelli di oggi, dell’expo di Milano. In carcere è finito infatti anche il direttore dell’ufficio contratti dell’Esposizione di Milano, Angelo Paris. I pm contestano un’associazione a delinquere per pilotare bandi. In carcere è finito anche il genovese Sergio Catozzo, ex Cisl, ex Udc infine berlusconiano. Ai domiciliari Antonio Rognoni, direttore generale di Infrastrutture Lombarde, già arrestato due mesi fa per presunte irregolarità negli appalti delle opere pubbliche. E’ indagato anche il ras della Manutencoop Claudio Levorato. Al presidente della cooperativa bolognese rossa, come si diceva una volta, i magistrati contestano l’associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d’asta e al traffico di influenze. L’uomo della Manutencoop Levorato e l’amico di Berlusconi, Gianstefano Frigerio, sono stati intercettati il 7 novembre 2013 mentre parlavano dell’appalto della Città della Salute. Frigerio propone, mentre una cimice della Dia registra le sue parole, a Levorato di usare i suoi appoggi politici nel Governo di centrosinistra (allora guidato da Letta) per favorire la nomina di Antonio Rognoni, allora presidente della società Infrastrutture Lombarde che si occupa degli appalti dell’Expo, alla guida dell’Anas. Frigerio dice: “io gli ho detto che una mano gliela do, per quello che posso fare io , della parte di Governo con cui ho rapporti io. Questa è una carta che può servire anche a lei perché un pezzo di Govemo ce l’ha anche lei … forse anche di più”. Frigerio suggerisce di piazzarlo al posto di direttore dell’Anas e Levorato non si scandalizza. In una conversazione intercettata c’è anche una telefonata del febbraio scorso in cui Frigerio sostiene di volersi mettere in contatto con Lorenzo Guerini, il nuovo portavoce della segreteria, il volto nuovo del Pd di Matteo Renzi. Il 24 febbraio scorso Frigerio dice all’amico Cattozzo “devo parlarne con Guerini” e Cattozzo replica: “devo organizzare un incontro con te e Guerini così lo tiriamo dentro, stiamo parlando di sette miliardi di lavoro”. Ma Lorenzo Guerini dice al Fatto: “Non li ho mai visti né sentiti. Non so chi sia questo Cattozzo”. Anche Pierluigi Bersani è tirato in ballo da Frigerio. L’ex parlamentare berlusconiano racconta di avere parlato con lui degli appalti dell’expo. Bersani al Fatto dice: “Pura millanteria non ho mai incontrato questa persona. Non mi sono mai occupato di queste questioni”.
La giustizia è e rimane la vera questione politica in Italia, scrive Fabio Camilleri su “La voce di New York”. Gli ultimi “clamorosi arresti” quali monotone variazioni sul tema. E mettere la testa sotto la sabbia non serve, a meno di non volerla perdere. A Milano arrestano l’Expo, a Reggio Calabria arrestano l’ex ministro Claudio Scajola e, per non restare indietro con la campagna elettorale, arresta pure la Camera dei Deputati, autorizzando i ceppi per Francantonio Genovese, deputato del partito Democratico, già sindaco di Messina. Per una volta, provo a ritenere che siano stati raccolti sufficienti indizi di colpevolezza in ciascuno di questi casi. Solo che rinchiudere in prigione prima del processo, lo sanno ormai anche i muri, dopo ventidue anni di ManiPulite Continua, è possibile se ricorrono uno o più dei “pericoli” per il processo medesimo: e cioè che l’inquisito si dia alla macchia, oppure che ricada nel peccato, o, infine, che provi a strappare le carte del Pubblico Ministero. Gli stessi muri di prima sanno che queste ultime generalmente sono tutte previsioni (di legge) che si autoavverano. In concreto, il pericolo c’è se chi accusa lo afferma. Perciò non ci resta che giurare in verba magistri: se li hanno arrestati, evidentemente un motivo c’era. Così va in Italia e così, per una volta, vorrei provare a ritenere anch’io. Solo che la mia buona volontà Legge e Ordine viene subito messa alla berlina. Già Scajola ristretto (in via cautelare) perché avrebbe aiutato un condannato per un reato di dubbia oggettività (“vicinanza”, “sostegno intermittente”, “contatti” “conoscenze” e via enumerando da una secolare coscienza, si dice per dire, inquisitoria) a fuggire, da uno stato in cui era legittimamente libero (gli Emirati Arabi Uniti, che avevano rigettato le richieste italiane) ad uno (il Libano) in cui è invece possibile l’arresto (come per Dell’Utri), qualche scossone alle mie buone intenzioni lo dà subito. Ma il vero tormento viene da Milano. Perché il Procuratore Aggiunto Robledo ha formalmente espresso il suo dissenso sull’indagine Expo, e non ha controfirmato, come gli altri, l’ordinanza di custodia cautelare? Perché il Procuratore Capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati ha ribadito che “Robledo non ha condiviso l’impostazione dell’inchiesta e non ha vistato gli atti”? Prima, possibile, risposta. Sono cosucce, miserie burocratiche; allora la conferenza stampa risulterebbe una tribuna vistosamente sproporzionata per una bega interna. Seconda, possibile, risposta. No, in effetti non sono proprio cosucce, tanto è vero che si è aperto un conflitto pure innanzi il Consiglio Superiore della Magistratura; allora non è chiaro in che cosa consista “l’impostazione dell’inchiesta”. Se le manette hanno fondamento, allora è grave che un alto magistrato, con funzioni direttive, faccia mancare la sua approvazione in un momento così delicato, qual è la presentazione al pubblico, sia pure al pubblico-bue dei risultati di un’indagine preliminare così significativa. Se è fondata l’opposizione, allora è grave che un altro alto magistrato con funzioni direttive abbia chiesto la custodia cautelare, nonostante un così incisivo dissenso sui contenuti dell’indagine. C’è una terza ipotesi, però. Che il contrasto non sorga realmente dai contenuti dell’indagine, ma che riduca questi ad un semplice sfondo spendibile sul piano formale, su cui possano ergersi maestose le supreme ragioni del “riparto dei fascicoli”. Sarebbe l’ipotesi peggiore, se possibile. Significherebbe la manifesta e totale strumentalità delle indagini rispetto a vicende di rango, se così si può dire, eminentemente personale. E le persone in galera? E noi che osserviamo? Insisto: se gli arresti per la vicenda Expo sono fondati, cioè vi sono elementi sufficienti di colpevolezza e così via, non si può discettare di “impostazione dell’inchiesta” e inscenare un improbabile aventino procuratorio; se, invece, “l’impostazione dell’inchiesta” non è questione di “incompetenza per scrivania”, ma è locuzione che tradisce verità contenutistiche, rimaniamo col dubbio che la libertà personale di un certo numero di persone sia stata impropriamente mutilata, senza però, che ci si spinga oltre una sorta di arbitrato interno, eretto, con regale indifferenza, su carne viva. E sorvolo sul timing. Questa ulteriore espressione di eccellenza istituzionale e civile dovrebbe interessare anche il Governo in carica. Invece, la custodia permessa nei confronti dell’On. Genovese, quanto al Partito Democratico, olezza di viltà preelettorale. L’indagine che lo riguarda è aperta da anni; ha già attinto alla moglie, amici, collaboratori e vari altri soggetti; aveva ripetutamente espresso l’autodafè contemporaneo (“dichiaro la mia piena fiducia nell’operato della magistratura”, o formula equivalente), gli indizi sono acquisiti e stanno ormai macerando come neanche i mosti d’annata; dunque, l’arresto preventivo serve per “comunicare”. Ignorare le implicazioni allusive delle “indagini sensibili” non serve, caro Renzi. Significherebbe riconoscere di essere sotto tutela. Se vuole fare qualcosa di nuovo, di veramente politico e nobile, il Presidente del Consiglio deve intestarsi la questione giustizia e calarvi con la scure di Gordio: carriere, CSM, responsabilità civile, nuovi codici, soprattutto, nuovo Ordinamento Giudiziario, non a carriera “automatizzata”: altrimenti, può già preparare il collo; e la testa non la salva nemmeno se la ficca cinque metri sotto la sabbia dell’ignavia. L’annunciato trionfo elettorale, se non agisce in questa direzione, servirà solo ad amplificare il tonfo della caduta.
Ancora manette in favore di tv. L'arresto di Scajola e l'agghiacciante parabola di questi 20 anni. Da Renzi ci si aspetta il segno di una riforma intellettuale e morale, Fabrizio Rondolino su “Europa Quotidiano”. Il nostro codice di procedura penale, all’articolo 274, è molto chiaro: le «esigenze cautelari», cioè l’obbligo di arresto, necessitano di tre requisiti essenziali: il rischio di inquinamento delle prove («purché si tratti di pericolo concreto e attuale»), il rischio di fuga dell’imputato, il rischio di reiterazione del reato. È molto difficile ravvisare nell’arresto di Claudio Scajola la presenza anche di un solo requisito richiesto dal codice. Scajola non stava fuggendo (e, nel caso, sarebbe bastato ritiragli il passaporto come per esempio è accaduto con Berlusconi), non inquinava nessuna prova perché al momento prove contro di lui non ce ne sono, né tantomeno era in procinto di reiterare il reato. Già, il reato. Di che cosa è accusato l’ex ministro? Secondo la Dia di Reggio Calabria, Scajola avrebbe intrattenuto rapporti “sospetti” con Chiara Rizzo, la moglie dell’ex parlamentare del Pdl Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa (un reato a sua volta di assai incerta definizione), e avrebbe “interessato” un faccendiere italiano con interessi in Libano – lo stesso implicato nella fuga di Dell’Utri – per favorirne la latitanza. La parabola di questi vent’anni è agghiacciante. Nel fuoco di Tangentopoli un isolato deputato missino agitò le manette nell’aula di Montecitorio e fu, giustamente, subissato di critiche. E molti, se non tutti, si scandalizzarono alle immagini di Enzo Carra, allora portavoce di Forlani, ammanettato come un assassino colto in flagrante. Oggi la galera ha sostituito l’avviso di garanzia, fra gli applausi della plebe urlante (che spesso e volentieri magari passa col rosso, non paga le tasse e devasta gli stadi) e di mezzo sistema politico. Non era necessario arrestare Scajola, e tanto meno era necessario allestire una gogna pubblica, chiamando giornalisti, fotografi e telecamere come se si trattasse di una conferenza stampa o di un reality show. E non era neppure necessario richiedere l’arresto di Francantonio Genovese, il deputato del Pd coinvolto nell’inchiesta della procura di Messina sui finanziamenti alla formazione professionale: eppure la Giunta per le autorizzazioni, con il voto decisivo di un Pd evidentemente spaventato dalla campagna elettorale, ha concesso senza batter ciglio ciò che i pm chiedevano. Lasciamo da parte, per favore, la solita stucchevole retorica sulla presunzione d’innocenza e sulla piena fiducia nell’operato dei giudici. In Italia da molti anni non è così, le sentenze si emettono prima dei processi (mentre spesso i processi si concludono con un nulla di fatto) e vale invece, sempre, la presunzione di colpevolezza, tanto più se sei un politico. I politici, come per esempio sostengono ormai apertamente Travaglio o Grillo, si dividono in inquisiti e non ancora inquisiti. Ai primi le manette in favore di telecamera, ai secondi il sospetto incancellabile. Può andare avanti un paese così? No, non può. Non si cura la rabbia con la vendetta, non si placa l’indignazione (spesso giustificata) con l’esemplarità del gesto inquisitorio. Succede invece l’esatto contrario, in una spirale di rancore e di rivalsa dalla quale, alla fine, nessuno può sperare di salvarsi. Soprattutto, nessuno può sperare che così si ricostituisca una civiltà giuridica ormai dispersa e si gettino le basi di una nuova, indispensabile etica pubblica. Da Matteo Renzi, che alla sua ultima Leopolda prima di diventare segretario del Pd e presidente del consiglio aveva pronunciato parole importanti e impegnative sulla giustizia, ci si aspetta non una battuta più o meno polemica né tantomeno una guerra ideologica e personalissima “a la Berlusconi”, ma il segno di un cambiamento culturale, psicologico, emotivo – di una riforma intellettuale e morale.
La bufala della "giustizia a orologeria": nel 2014 almeno 27 fra condanne, arresti, indagini e prescrizioni, scrive Claudio Forleo su “International Business Times”. Ecco, puntuali come un orologio rotto che segna l'ora giusta solo due volte al giorno, arrivare i commenti dei soliti fenomeni che vedono negli arresti di oggi non una classe politica marcia fino al midollo, ma il solito complotto ordito dalle toghe politicizzate. E' la colossale balla della "giustizia ad orologeria", quella che si farebbe viva solo prima delle Elezioni, allo scopo di condizionare il voto. Lo sostiene Elisabetta Gardini, candidata alle Europee nel partito di Berlusconi: "Avvenimenti come l'arresto di Scajola impediscono di parlare di ciò che preme alla gente". Le fa eco su Twitter Bruno Vespa, uno che ama solo i processi 'alla Cogne', non quelli ai politici. "Arresti eccellenti in campagna elettorale. Giusto per rendere il clima più sereno e trasparente". Chiaro, no? Se un ex ministro dell'Interno, fino all'altro ieri in corsa per un posto alle Europee, viene accusato di aver aiutato la latitanza di un condannato per mafia, chi se ne frega! Se si vota ogni anno (Politiche, Europee, Comunali, Regionali) e se la classe dirigente si fa arrestare, condannare o indagare almeno una volta al mese, è ovviamente colpa dei magistrati che fanno politica e che avvelenano il clima. Teoria riciclata anche quando le elezioni non sono alle porte. Qualsiasi arresto, sentenza o apertura di indagine è sempre 'a orologeria', che sia Ferragosto o Natale una 'spiegazione' si trova sempre. Purtroppo per questi teorici del complotto di serie Z notizie del genere sono le più frequenti quando si parla di politica in Italia, voto o non voto. Da gennaio ad oggi contiamo almeno 3 condanne, 6 rinvii a giudizio, 6 arresti o richieste di arresto (compresi i casi Scajola, Greganti e Frigerio) 10 aperture di indagini e 2 prescrizioni.
Parlamentari, ministri, candidati, consiglieri regionali, membri di spicco dei partiti (presenti e passati). Ecco il dettaglio:
2 maggio: Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, poi senatore del PD, condannato a otto anni di carcere per appropriazione indebita. Avrebbe intascato 25 milioni di euro.
16 aprile: Maurizio Gasparri, ex ministro e vicepresidente del Senato, rinviato a giudizio per peculato. Si sarebbe appropriato di una somma pari a 600mila euro dell'allora gruppo PDL per intestarsi una polizza sulla vita.
11 aprile: richiesta d'arresto per Marcello Dell'Utri. Il braccio destro di Silvio Berlusconi che, pur non facendo più politica attiva, resta il padrino di Forza Italia che riscrive la Costituzione con Renzi. Ma la "persona perbenissimo" (copyright dell'ex premier) fugge a Beirut. La richiesta di estradizione è di 48 ore fa.
3 aprile: nuovo arresto per Nicola Cosentino, già reduce da svariati mesi a Secondigliano (solo dopo aver perso il seggio da parlamentare), poi tornato a fare politica attiva con Forza Campania e ad incontrarsi con Denis Verdini nei giorni che precedono la nascita del governo Renzi. L'accusa è di concorrenza sleale ed estorsione con metodo mafioso.
1° aprile: chiusa indagine sulle spese pazze nella Regione Campania e notifica dell'atto, che in genere precede la richiesta di rinvio a giudizio, per Umberto Del Basso De Caro (PD, sottosegretario alla Sanità), Domenico De Siano ed Eva Longo (senatori di Forza Italia). Per tutti l'accusa è di peculato.
31 marzo: Silvio Berlusconi incassa l'ennesima prescrizione, la settima della sua 'carriera', nell'ambito del procedimento Fassino-Consorte. Dopo la condanna in primo grado ad un anno per rivelazione di segreti d'ufficio, la Corte d'Appello di Milano dichiara il reato estinto.
27 marzo: il governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, da poco passato con il NCD di Alfano, viene condannato a sei anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per aver firmato falsi bilanci all'epoca in cui era sindaco di Reggio Calabria, Comune poi sciolto per infiltrazioni mafiose, il primo capoluogo di provincia nella storia d'Italia a subire questo provvedimento. Scopelliti, che avrebbe comunque dovuto lasciare la carica per effetto della legge Severino, non fa una piega, come il ministro degli Interni e leader del suo partito: candidato alle Europee.
27 marzo: l'ex tesoriere dell'UDC Giuseppe Naro è condannato ad un anno di reclusione per concorso in finanziamento illecito ai partiti: avrebbe intascato dall'imprenditore Di Lernia una tangente da 200mila euro.
26 marzo: Lorenzo Cesa, segretario dell'UDC e candidato alle Europee, è indagato per finanziamento illecito nell'inchiesta su tangenti e fondi neri che coinvolge Finmeccanica e il SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti mai entrato in funzione.
19 marzo: richiesta d'arresto per il deputato del Partito Democratico Francantonio Genovese, re delle preferenze alle parlamentarie PD, ras di Messina e dintorni. portatore di conflitti di interesse e soprattutto re della formazione professionale in Sicilia. Lui si 'autosospende' dal partito, in compenso i colleghi della Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio se la prendono comoda: Genovese resterà al suo posto almeno fino a dopo le Europee. Ma guai a parlare di 'ritardi ad orologeria', sono solo molto scrupolosi.
3 marzo: l'ex presidente della Regione Lombardia, oggi presidente della Commissione Agricoltura nonchè 'diversamente berlusconiano', il Celeste Roberto Formigoni, viene rinviato a giudizio. per associazione a delinquere e corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla Sanità: la sua Giunta, nel corso degli anni, avrebbe adottato provvedimenti favorevoli ad aziende private, in cambio di viaggi e regali di varia natura.
Marzo: al sottosegretario alla Cultura Francesca Barraciu, già indagata per peculato in Sardegna, vengono contestati altri 40mila euro di rimborsi non giusitificati ottenuti all'epoca in cui era consigliere regionale. La posizione della Barraciu si aggrava nonostante le rassicurazioni arrivate dal PD sul chiarimento che il sottosegretario avrebbe offerto ai magistrati.
28 febbraio: il ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi è indagato per concorso in abuso di atti d'ufficio per la nomina all'Authority di Olbia di un ex deputato del PDL, Fedele Sanciu, il quale non avrebbe i titoli per ricoprire tale incarico.
27 febbraio: Filippo Penati, accusato di concussione a Monza nell'inchiesto sulle tangenti del cosiddetto 'sistema Sesto' incassa la prescrizione nonostante avesse più volte dichiarato di volerci rinunciare.
21 febbraio: l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e l'ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini sono indagati per finanziamento illecito relativamente ad una provvista di denaro di 25mila euro, che sarebbe stata "realizzata con false fatture di Accenture e destinata ad un falso sondaggio sulla qualità dei servizi scolastici".
28 gennaio: Nunzia De Girolamo, ex ministro delle Politiche Agricole, viene iscritta nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta sulle nomine all'ASL di Benevento.
23 gennaio: Silvio Berlusconi è iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano nel terzo filone di inchiesta sul caso Ruby (per cui ha già ricevuto una condanna in primo grado a sette anni). Per lui e gli avvocati-parlamentari Longo e Ghedini l'accusa è di corruzione in atti giudiziari.
16 gennaio: richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e per altri 39 consiglieri regionali. L'inchiesta è ancora sul grande scandalo delle spese pazze.
14 gennaio: Davide Faraone, membro della segreteria PD, è indagato nell'ambito dell'inchiesta sulle spese pazze nella Regione Sicilia.
Una lista infinita, e abbiamo considerato solo l'anno in corso. Ma condanne, imputazioni o indagini a carico non limitano la carriera dei politici o dei manager che orbitano nella stessa galassia. Nonostante il rinvio a giudizio per la strage di Viareggio (disastro colposo plurimo), Mauro Moretti è stato scelto dal governo Renzi come AD di Finmeccanica. Paolo Scaroni ha guidato l'ENI per un decennio nonostante una condanna ricevuta durante Mani Pulite e altre indagini a carico. Come dimenticare le liste dei partiti per le prossime Europee, piene di impresentabili, come abbiamo riassunto nell'articolo dello scorso 17 aprile. Quella della giustizia ad orologeria è una bufala, mentre una bella indagine a carico, meglio ancora una condanna, fa curriculum.
Da Ruby a Tangentopoli bis: a Milano
inchieste col trucco.
Dalle carte del Csm sullo scontro tra Bruti e il suo vice Robledo spuntano
anomalie anche per assegnare il caso Expo. Le nuove accuse del pg Minale. E il
procuratore capo attacca i pm. Scomparsa gli indagati per mafia dal fascicolo
sull'esposizione 2015, scrivono Michelangelo Bonessa e Luca Fazzo su “Il
Giornale”. Che fine hanno fatto le accuse di associazione mafiosa che Ilda
Boccassini ha utilizzato per conquistare la gestione dell'inchiesta sugli
appalti dell'Expo? Di queste accuse, nell'ordine di custodia eseguito l'altro
ieri mattina, quello che ha portato in carcere tra gli altri Primo Greganti e
Gianstefano Frigerio, non c'è più traccia. E così anche di questo dovrà
occuparsi il Consiglio superiore della magistratura, che la prossima settimana
interrogherà tra gli altri proprio la Boccassini: e dovrà capire se lo scontro
in corso a Milano sia figlio di protagonismi personali e di «populismo
giudiziario», come sostiene ieri il procuratore Bruti Liberati. O se invece,
come afferma il principale accusatore di Bruti, il procuratore aggiunto Alfredo
Robledo, a Milano una ristretta cerchia di magistrati, tutti più o meno legati a
Magistratura Democratica, si impadronisca di tutti i fascicoli più delicati in
violazione delle regole della stessa Procura. Nelle carte già in mano al Csm ci
sono già alcuni dati di fatto da cui sarà impossibile distaccarsi. Sono i punti
fermi che ha messo Manlio Minale, l'anziano procuratore generale, spiegando al
Csm che in almeno due casi non è stata attivata la «necessaria interlocuzione»
con Robledo, modo ostico per dire che il procuratore aggiunto è stato
scavalcato, e che nell'inchiesta sulla Serravalle, che lambiva il Comune di
Milano, il ritardo di Bruti nell'avviarla «ha pregiudicato le indagini». Ma
davanti al Csm, Minale ha parlato anche di Expo, e qui le cose si fanno ancora
più interessanti. Al Csm, Robledo aveva denunciato come una plateale anomalia il
fatto che una inchiesta per reati di corruzione non fosse coordinata da lui,
competente per questi reati, ma da Ilda Boccassini, ovvero dal pool antimafia.
Ed ecco quanto dichiara Minale: «Robledo era portatore di un convincimento
assoluto, che in quel procedimento ci fossero solo reati contro la pubblica
amministrazione» e che dunque lui «fosse stato ingannato e messo da parte (...)
tant'è che anche ultimamente ho detto: Guarda che io voglio essere tranquillo,
mi sono fatto dare le iscrizioni e risultano iscritti alcuni indagati per 416
bis», cioè per associazione mafiosa. Così, con la presenza anche di un filone
mafioso dell'indagine su Expo, si giustificherebbe la presenza della Boccassini
nell'inchiesta. Ma l'altro ieri vengono eseguiti gli arresti, e nell'ordine di
cattura non c'è traccia di accuse di mafia. Nella retata dell'Expo si parla di
appalti, di tangenti, di politica, ma non di Cosa Nostra né di 'ndrangheta. E
allora, che fascicolo venne fatto vedere a Minale, con le accuse di associazione
mafiosa? Forse i vecchi fascicoli sulla penetrazione 'ndranghetista in
Lombardia, da cui ufficialmente scaturisce l'inchiesta Expo. Ma è una parentela
assai remota, passata per mille passaggi successivi. Non era certo di quei
filoni, che Robledo si sentiva spodestato per scarsa affidabilità politica.
Proprio ieri, per andare al contrattacco Bruti Liberati sceglie un convegno
all'università Statale. E lì afferma esplicitamente che il «populismo
giudiziario è un virus endemico nei corridoi delle Procure della Repubblica, ma
da noi a Milano ha potenti antidoti». La frase di Bruti parte da una citazione
di un libro di Luigi Ferrajoli, padre fondatore di Magistratura Democratica, che
si riferiva soprattutto a Antonio Ingroia, capofila di quei pm che «cercano di
costruire un consenso popolare non solo alle proprie indagini ma anche per la
propria persona». Ma questo, per Bruti, è anche il caso di Alfredo Robledo. E
quei «potenti antidoti» di cui parla ieri Bruti sembrano voler dire che il
procuratore è convinto di uscire vincente dallo scontro, in cui si sente
attaccato non in nome della trasparenza ma del «populismo» e dell'ambizione
personale.
Stefania Craxi: "Ora l'Italia chieda scusa a mio padre". La figlia dello statista socialista accusa i metodi da «Mani pulite»: "Una vergogna le modalità dell'arresto di Scajola e i processi aperti sulla stampa per Expo 2015", scrive Paola Sacchi su “Panorama”. «In questo paese sarebbe venuta l’ora di chiedere scusa a Bettino Craxi….». Dopo l’ondata di arresti di giovedì 8 maggio 2014, che hanno resuscitato stili e metodi spettacolari da «Mani pulite» e che hanno fatto parlare di «una nuova Tangentopoli», Stefania Craxi in questa intervista a Panorama.it invita ad andare a rileggersi il celebre e inascoltato intervento dello statista socialista alla Camera nel luglio 1992.
Ora quelle parole cadute nel vuoto perché tornano secondo lei più che mai attuali?
"In un coraggiosissimo discorso di fronte al parlamento e alla nazione Craxi denunciò la degenerazione alla quale era arrivata la società italiana e chiamò la politica del tempo a porvi un rimedio. Ma seguì un vile silenzio. In questi vent’anni hanno fatto come le scimmiette: non vedo, non parlo, non sento. Il degrado è andato avanti di pari passo con una Giustizia che utilizza spesso due pesi e due misure. Due fenomeni che sono andati a braccetto. Certi magistrati dalla tentazione golpista, favoriti anche da una politica imbelle, hanno fatto avanzare la corruzione. Se prima c’era qualche corrotto, ma la politica era forte, ora non conta più la politica, contano solo le lobby e gli affari. L’Italia somiglia sempre più a un paese del Sudamerica che non a un paese moderno e occidentale".
Che effetto le ha fatto rivedere le stesse scene di vent’anni fa e le paginate dei giornali che ricalcano gli stessi schemi del processo mediatico? Da una lato, l’ex ministro Claudio Scajola, arrestato di fronte a una marea di telecamere e fotografi, si dice avvisati per tempo, dall’altro ondate di verbali di intercettazioni riversate sulla stampa, da Scajola all’inchiesta Expo 2015…
"Il metodo dell’arresto di Scajola è una vera vergogna. E la vergogna di processi che avvengono prima sulla stampa che nell’aula di tribunale continua. Anche un colpevole ha diritto a non avere la gogna. E poi i contorni dell’inchiesta Expo sono pochi chiari perché tutto avviene all’interno di uno scontro di potere dentro la mitica Procura di Milano".
Che opinione si è fatta?
"I tempi e i modi di questi nuovi arresti non sono estranei a questo scontro dove c’entrano protezioni, coni d’ombra. Tutto si consuma in una contrapposizione dove è emersa con molta chiarezza la voglia da parte di certi magistrati di protagonismo e di avere assegnate le inchieste di grido. Questa è la novità".
Gli arresti dell’8 maggio avvengono a meno di due settimane dal voto europeo. La tempistica fa sempre riflettere?
"Avvengono come al solito a pochi giorni dalla elezioni. C’è un uso improprio della custodia cautelare, che è anche un costo sociale abnorme per le nostre carceri e i cittadini. A leggere i giornali italiani sembra la sceneggiatura della stessa telenovela, con le medesime formule giornalistiche, tipo la cupola, la cupola massonica internazionale…Ma dove è?".
Che impatto politico avranno questi nuovi arresti?
"Questo spettacolo indecente è chiaro che favorirà Beppe Grillo che è un sintomo anche grave di un sistema malato. La sinistra ha sparso il morbo giustizialista che è entrato nelle vene dell’elettorato italiano mischiandosi a un impasto di invidia sociale e odio verso i potenti, aggravato da una politica che non ha saputo dare risposte. Nella Prima Repubblica i difetti c’erano, non a caso mio padre parlò di Grande Riforma già nel 1979, ma c’erano anche le regole, a cominciare dall’articolo 68 della Costituzione sull’immunità parlamentare, ora invece sono rimasti i difetti ma sono saltate le regole".
È un fatto che la giornata degli arresti avviene dopo che Silvio Berlusconi è tornato centrale per fare le riforme, non a caso è stata Forza Italia a salvare Matteo Renzi al Senato. Che ne pensa?
"Da un lato c’è un giustizialismo che ha offuscato le menti e generato mostri, e poi c’è sempre una regia da parte di poteri neppure tanto dichiarati. Quelle di Renzi sono riformicchie, riforme fatte un tanto al chilo, ma è chiaro che quello che è successo è volto a far saltare il banco. Questo premier che sembra uscito dalla penna di Collodi elude la riforma della Giustizia. E intanto il Pd l’altro giorno in commissione ha votato contro la responsabilità civile dei magistrati".
L’ITALIA DEI PAZZI. UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SULLA BUROCRAZIA. CANCELLATE 10 LEGGI, NE NASCONO 12.
La Battaglia persa contro la burocrazia. Troppe leggi paralizzano l’Italia. Cancellate 10, ne nascono 12. Varati soltanto 462 decreti attuativi dei 1.277 necessari per mettere in moto i provvedimenti dei governi Monti e Letta. La percezione, unanime, è che il Paese si sia auto-avviluppato in una miriade di lacci e lacciuoli, come il Lemuel Gulliver di Swift, scrive Sergio Rizzo su “Il Corriere della Sera” con l’inchiesta l’Italia delle complicazioni. Per ogni 10 leggi che vengono cancellate, ne nascono 12. C’è evidentemente qualcosa che non va in Italia nella macchina delle semplificazioni. ”Una cosa simile forse – scrive Sergio Rizzo sul Corriere della Sera – non potrebbe accadere nemmeno nell’isola di Atrocla, parto della fantasia del geniale scrittore polacco Alexander Moszkowsky, dove la burocrazia è talmente opprimente da tenere occupata tutta la popolazione per l’intera giornata e metà della notte a compilare moduli”. In Italia, invece, succede tutti i momenti che un trasporto eccezionale deve andare via terra da una parte all’altra della penisola: ogni volta che si attraversa una frontiera regionale, si deve chiedere il permesso compilando gli appositi formulari. Rigorosamente tutti diversi, ovvio, da Regione a Regione. Come se l’Italia non fosse da un secolo e mezzo uno Stato unitario, ma una somma di staterelli qual era ai tempi di Cecco Beppe. Ed è già tanto che l’autista non debba pagare ogni volta «un fiorino», come capita nel film «Non ci resta che piangere» a Roberto Benigni e Massimo Troisi, catapultati nel Medioevo, alle prese con un ottuso doganiere. Una cosa simile forse non potrebbe accadere nemmeno nell’isola di Atrocla, parto della fantasia del geniale scrittore polacco Alexander Moszkowsky, dove la burocrazia è talmente opprimente da tenere occupata tutta la popolazione per l’intera giornata e metà della notte a compilare moduli. In Italia, invece, succede tutti i momenti che un trasporto eccezionale deve andare via terra da una parte all’altra della penisola: ogni volta che si attraversa una frontiera regionale, si deve chiedere il permesso compilando gli appositi formulari. Rigorosamente tutti diversi, ovvio, da Regione a Regione. Come se l’Italia non fosse da un secolo e mezzo uno Stato unitario, ma una somma di staterelli qual era ai tempi di Cecco Beppe. Ed è già tanto che l’autista non debba pagare ogni volta «un fiorino», come capita nel film «Non ci resta che piangere» a Roberto Benigni e Massimo Troisi, catapultati nel Medioevo, alle prese con un ottuso doganiere. Fra le perle che in tre mesi e mezzo di audizioni ha collezionato la commissione parlamentare bicamerale per la Semplificazione presieduta da Bruno Tabacci, eccone una particolarmente brillante. Simbolo non soltanto delle follie burocratiche, ma anche di come siamo riusciti a complicarci la vita scimmiottando il federalismo. Folgorante è la metafora, contenuta nella relazione conclusiva approvata lunedì sera all’unanimità dai presenti, che paragona l’Italia al Gulliver di Jonathan Swift, imprigionato a terra dai tanti fili sottilissimi dei Lillipuziani. I quali, argomenta il rapporto, vanno sciolti uno ad uno se si vuole far ripartire il Paese. Una immagine, peraltro, a cui ricorreva frequentemente anche l’ex ministro dell’Economia Tommaso Padoa-Schioppa. La battaglia contro la burocrazia ha presentato in passato risvolti grotteschi, e risultati inesistenti. Se è vero che dal 1994 al 2008 a 5.868 misure di semplificazione hanno replicato 6.655 misure di complicazione, vale a dire 787 in più, sono servite a ben poco le norme successivamente varate nel tentativo di ridurre l’enorme macigno delle nostre leggi (già vent’anni fa Sabino Cassese sosteneva che fossero 150 mila, contro le 7.325 della Francia e le 5.587 della Germania). Per Alessandro Pajno, che ha studiato a lungo la faccenda, «la riduzione dello stock normativo, che pure era un obiettivo importante, ha mostrato i suoi limiti e ha assunto un valore prevalentemente spettacolare ma non di sostanza riducendosi all’eliminazione di norme che non risultavano in concreto più applicate». La tagliola è dunque calata inutilmente su 67.872 atti normativi di varia natura, già inutili. Decisamente più importante è quello che continua a verificarsi tuttora. Chi ha ancora negli occhi l’immagine della catasta di «350 mila leggi inutili» bruciate quattro anni fa in una caserma dei Vigili del fuoco con il lanciafiamme dall’ex ministro Roberto Calderoli, dovrebbe sapere che oggi, secondo i dati forniti dalla Corte dei conti alla commissione Tabacci, per ogni dieci norme abrogate ne entrano in vigore dodici nuove di zecca. Senza che molte di esse, però, riescano mai a diventare operative: causa il gioco perverso dei decreti attuativi regolarmente dimenticati. Si racconta nella relazione di cui stiamo parlando che al 4 febbraio scorso erano stati varati appena 462 adempimenti dei ben 1.277 necessari per mettere in moto le leggi approvate durante i governi di Mario Monti ed Enrico Letta. Poco più di un terzo. Il problema, dice il sottosegretario alla Presidenza Giovanni Legnini, è spesso legato alla previsione, contenuta nella norma uscita dal Parlamento, che quei decreti vengano emanati «di concerto» fra vari ministeri. Previsione che molte volte «si rivela strumentale a rendere difficoltosa o impossibile l’adozione dell’atto, vanificando così tutte quelle norme che si limitano a rimandare a un successivo atto la definizione di determinate misure». Insomma, una tela di Penelope smontata senza neppure essere tessuta. L’ex premier Romano Prodi ha ricordato un mese fa a Bologna che ci sono provvedimenti di liberalizzazione del primo pacchetto Bersani approvati nel 1997 che aspettano ancora le disposizioni essenziali per attuarle. «Le norme sempre più dettagliate, lungi dal rivelarsi efficaci», aggiunge la relazione della commissione Tabacci, «sono state fertile terreno di coltura per un contenzioso giurisdizionale arrivato a livelli insostenibili quando non di diffusi fenomeni corruttivi». Mentre «la complicazione normativa ha consentito alla struttura burocratica di sviluppare una efficace strategia difensiva per le responsabilità penali, trovando rifugio nella copertura legislativa». Il tutto alla mercé anche di un regionalismo spesso dagli aspetti assurdi, come testimonia appunto il caso dei trasporti eccezionali. Referenti diversi, procedure diverse, perfino moduli diversi. Lo sportello unico delle imprese, per dirne una. «Istituito nel 1998 e non ancora pienamente efficace», ha denunciato il direttore generale della Banca d’Italia Salvatore Rossi, indicandolo come esempio di «tortuosità e lentezza dei processi di riforma». A cui contribuisce l’insensata frammentazione delle competenze, che determina anche costi e handicap competitivi astronomici per le imprese. Con lo sportello unico pienamente funzionante, tutte le pratiche di un intero anno a carico del sistema produttivo si potrebbero risolvere con meno di dieci milioni, a fronte delle diverse centinaia spese oggi. La Federdistribuzione ha calcolato che l’1,15% del fatturato del commercio si volatilizzi ogni anno per spese di burocrazia: 1,4 miliardi l’anno. Mentre l’associazione dei trasportatori Confetra ha rammentato che secondo l’Ocse sono necessari in Italia mediamente 19 giorni per un’operazione di export, contro i 10 di Francia e Spagna, i 9 della Germania e addirittura i 7 dell’Olanda. Ma non crediate che siano tutte rose e fiori quando invece le competenze regionali risultano meno coinvolte. Perché se quelle hanno certo complicato (e non poco) la vita di strumenti quali lo sportello unico, anche l’arretratezza tecnologica dell’amministrazione ci mette del suo. Su questo terreno si è perso un sacco di tempo per cose insensate: basta considerare che in vent’anni si è cambiato per ben quattro volte il nome dell’organismo pubblico che se ne deve occupare. Dall’Aipa, Autorità per l’informatica, si è passati al Cnipa, Centro nazionale per l’informatica, alla DigitPa, e infine all’Agenzia per l’Italia digitale. La conseguenza è un confronto avvilente nella qualità della nostra infrastruttura con quella dei nostri concorrenti. Mentre l’agenda digitale, che avrebbe dovuto rivoluzionare i rapporti di cittadini e imprese con la controparte pubblica, per esempio mettendo in rete tutte le amministrazioni consentendo l’archiviazione di tutti i documenti solo in formato elettronico, è sostanzialmente al palo. A un anno di distanza, dice un monitoraggio del Servizio studi della Camera, sono stati adottati solo 17 dei 55 adempimenti necessari. Inutile allora stupirsi di quanto ha denunciato davanti alla commissione Tabacci il presidente della Confindustria Giorgio Squinzi, rammentando come già nel 2011 fosse stata «adottata una norma che sanciva il principio dell’acquisizione d’ufficio» dei documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni. «Peccato che, salvo lodevoli eccezioni», ha concluso, «la prassi degli uffici non si sia uniformata a questo principio».
C’è una grande imputata in questa stagione di aspettative di ripresa dell’economia, della produzione e dell’occupazione: la burocrazia a tutti i livelli di governo, dai ministeri agli enti locali, scrive “Blitz Quotidiano”. È la burocrazia, si sente dire, che frena sulle riforme, sulla lotta agli sprechi, sulla semplificazione necessaria per restituire efficienza agli apparati, alleggerire cittadini ed imprese da adempimenti inutili eppure costosi, se non altro in termini di tempo. È veramente così? È la burocrazia, del Ministero dell’economia e delle finanze, in particolare i vertici della Ragioneria Generale dello Stato, che ostacola l’innovazione opponendo costantemente eccezioni sotto il profilo della copertura delle leggi di spesa o delle riforme che comportano oneri a carico del bilancio dello Stato? Diciamo subito che la burocrazia ha le sue colpe. Non ha puntato sulla semplificazione delle procedure facendosi essa stessa promotrice delle riforme capaci di limitare gli adempimenti richiesti a quelli effettivamente necessari per decidere, autorizzare cittadini ed imprese, in una parola per rendere servizi efficienti all’altezza di uno stato moderno. La burocrazia ha percorso la strada della moltiplicazione delle posizioni organizzative, dirigenziali e non, per acquisire migliori trattamenti economici e gratificazioni, spesso attraverso inutili denominazioni di funzioni. Abbondano i dirigenti di prima e seconda fascia, come abbondano nelle amministrazioni militari generali pluristellati. Situazioni di ipertrofia organizzativa che appesantiscono le strutture e le procedure: ogni nuova struttura determina una ulteriore parcellizzazione degli adempimenti. È tutta colpa dei burocrati, degli alti burocrati? In parte. Perché in buona parte l’inefficienza è responsabilità della politica che per accrescere il proprio potere ha seguito l’antica regola del divide et impera senza tener conto che, se si comanda meglio a piccoli reparti diretti da un dirigente con scarso potere, si ottiene anche l’effetto negativo della inefficienza. I burocrati, dunque, condividono le responsabilità dell’attuale stato di cose con la politica perché sono i politici, in veste di governanti o di legislatori, che fanno le leggi, anche quelle che prevedono plurimi regolamenti spesso difficili da definire, occorrendo il concorso delle regioni che si ottiene solo attraverso una defatigante istruttoria preliminare ed una pesante trattativa in sede dei Conferenza Stato Regioni. È vero, come si legge spesso, che anche i politici, in sede governativa e/o parlamentare subiscono l’influenza dei burocrati dei ministeri, quelli che conoscono leggi e regolamenti che è necessario cambiare. Ma è certo anche che è mancata negli anni una direzione politica autorevole, capace di stringere sulle riforme da fare e sui tempi della loro definizione. Diamo, dunque, a ciascuno il suo. Dispiace, peraltro, per chi ha dedicato tempo, molto tempo, a studiare l’organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione, constatare che è mancato da parte della burocrazia, che annovera professionisti di valore in tutti i campi, l’iniziativa per una autoriforma che avrebbe confermato l’elevata preparazione tecnica della burocrazia statale e pubblica e la capacità che un tempo le era riconosciuta. Occorre, dunque, uno scatto di orgoglio della categoria dei dirigenti, che si scrollino di dosso il peso della sindacalizzazione e dell’ossequio interessato alla politica per fare carriera, ricordando che, come si esprime la Costituzione, “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98), avendo premesso che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore” (art. 54, comma 2). Un quadro normativo che esprime il ruolo di una classe amministrativa formata da professionisti che altrove, penso alla Francia ma anche alla Spagna, al Regno Unito e alla Germania, assicura l’efficienza del potere pubblico nell’interesse dello stato, dei cittadini e delle imprese.
Semplificazione amministrativa fallita, scrive Lorena Cacace su “NanoPress”. Altro che semplificazione amministrativa, in Italia la burocrazia riesce a complicare tutto nonostante i proclami della politica. Stando ai dati del rapporto della Corte dei Conti fornito alla Commissione Parlamentare bicamerale sulla Semplificazione, presieduta da Bruno Tabacci, per dieci leggi che vengono abrogate ne nascono dodici nuove. I dati, elaborati da Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, sono impressionanti: solo per fare un esempio sono stati varati solo 462 decreti attuativi dei 1.277 necessari per avviare i provvedimenti dei governi Monti e Letta. Gli esempi finiti sul tavolo della commissione sono altrettanto spaventosi: una spirale di leggi statali e regionali che avvolgono ogni processo produttivo del Paese di fatto paralizzandolo. Tra gli esempi ricordati da Rizzo che sono finiti davanti alla Commissione, c’è il caso dei trasporti speciali via terra. Ogni volta che si cambia regione, bisogna compilare un permesso apposito, ovviamente diverso da regione a regione. Mentre a livello europeo le frontiere cadono, in Italia ogni Regione è stata in grado di alzare nuove barriere a suon di scartoffie. Non a caso il rapporto finale della commissione paragona il nostro Paese a Gulliver, il personaggio creato da Jonathan Swift, grande e grosso ma reso impotente dai mille piccoli fili dei Lillipuziani che lo legano a terra. Eppure, la battaglia contro la burocrazia è uno dei temi cari a tutti i governi, di destra e di sinistra: dal 1994 al 2008 sono state varate 5.868 leggi sulla semplificazione a cui sono seguite 6.655 misure di complicazione. Ci si è accaniti in questi anni sull’enorme corpus legislativo italiano, tagliando 67.872 atti normativi che erano però già inutili. L’ultimo atto eclatante era stato il “rogo della semplificazione” dell’allora ministro Roberto Calderoli quattro anni fa, quando vennero bruciati faldoni interi con “350mila leggi inutili”. Bene, a tutto questo non è seguito nulla di fatto se è vero, come lo è, che per ogni 10 leggi abolite ne nascono dodici nuove e di queste neanche tutte riescono a entrare in vigore. La Commissione punta il dito non solo sulla falsa semplificazione ma anche sulle colpevoli dimenticanze della politica: degli oltre 1.200 decreti attuativi che servono per far partire le leggi dei due governi precedenti, ne sono stati fatti solo 462. Questo accade perché si prevede che i decreti vengano emanati “di concerto” tra i vari ministeri, come ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza Giovanni Legnini, ma all’atto pratico si rivela una soluzione inutile e impossibile: insomma, non ci si mette d’accordo tra i vari rami interessati dai decreti attuativi, rendendo le leggi carta straccia. Rizzo ricorda le parole dell’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, di un mese fa: alcuni provvedimenti sulle liberalizzazioni del primo pacchetto Bersani, risalenti al 1997, non possono essere attuati perché mancano le disposizioni. Gli esempi non mancano. Lo Sportello Unico per le Imprese è stato creato nel 1998 e non è ancora efficace, come ha denunciato il dg della Banca d’Italia Salvatore Rossi. Secondo Federdistribuzione l’1,15% del fatturato del commercio, pari a 1,4 miliardi l’anno, viene speso in burocrazia. L’associazione dei trasportatori Confetra ricorda che, dati Ocse alla mano, in Italia servono 19 giorni per un’operazione di export, mentre in Francia e Spagna 10, 9 in Germania, 7 in Olanda. Non si può non citare l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione: in vent’anni è cambiato 4 volte l’organismo che doveva occuparsene, dall’Aipa al Cnipa, arrivando alla DigitPa e all’attuale Agenzia per l’Italia digitale. Si ricomincia ogni volta dall’inizio, mentre i documenti sono ancora lì, in forma cartacea, rendendo a volte impossibile e sempre tortuoso e dispendioso il rapporto tra aziende, privati e pubblico. Tutto fermo o quasi: dopo un anno, secondo il Servizio studi della Camera, sono stati adottati 17 dei 55 adempimenti necessari per far partire la “rivoluzione digitale”. I “professionisti della burocrazia” creano norme sempre più intricate e dettagliate che non sono bloccano lo sviluppo ma “sono state fertile terreno di coltura per un contenzioso giurisdizionale arrivato a livelli insostenibili quando non di diffusi fenomeni corruttivi”, come indica la relazione della commissione Tabacci. Le norme complicate hanno permesso alla struttura burocratica di essere immune “per le responsabilità penali, trovando rifugio nella copertura legislativa”. Insomma, una sorta di legge dell’autoconservazione: invece che semplificare si complica, si mantengono solide posizioni da burocrati e si manda in rovina tutto il resto.
Ma tutta questa burocrazia cosa genera? Corte Strasburgo, a Italia record negativo indennizzi. Violazioni diritti: nel 2013 Italia condannata a pagare 71 milioni, scrive “L’Ansa”. L'Italia nel 2013, a causa delle violazioni dei diritti dei propri cittadini riscontrate dalla Corte di Strasburgo, è stata condannata a versare indennizzi per più di 71 milioni di euro, la cifra più alta tra tutti i 47 Paesi aderenti al Consiglio d'Europa. Lo si legge nel rapporto sulle esecuzioni delle sentenze della Corte. E' il secondo anno consecutivo, in base a quanto emerge dal rapporto reso noto oggi dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che il dato italiano sull'ammontare degli indennizzi spicca per il primato negativo stabilito. Pur avendo infatti quasi dimezzato l'importo rispetto al 2012, quando si raggiunse la cifra record di 120 milioni di euro, l'Italia nel 2013 è stata condannata a pagare una cifra pari a quella di tutti gli altri 46 Stati membri del Consiglio d'Europa messi assieme. Il secondo Paese per ammontare d'indennizzi da pagare per il 2013 è l'Ucraina, con quasi 33 milioni di euro, la metà di quanto accumulato dall'Italia. Dal rapporto approvato oggi dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa si rileva che il record italiano deriva dalla continua violazione del diritto di proprietà dei propri cittadini, in particolare è dovuta agli espropri condotti da diversi comuni italiani negli anni '80. L'altro dato che emerge dal rapporto è l'alto numero di sentenze per cui il governo italiano non è in grado di fornire informazioni sui pagamenti delle cifre fissate dalla Corte di Strasburgo a titolo di indennizzo. Per l'Italia non risultano pagati gli indennizzi relativi a 94 sentenze, tra cui la Torreggiani, la decisione con cui i giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia per il sovraffollamento delle carceri. L'Italia è anche uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa con il più alto numero di sentenze la cui esecuzione è sottoposta a "procedura potenziata" di monitoraggio dal comitato dei ministri dell'organizzazione. Il nostro Paese è settimo per numero di sentenze sottoposte a questa procedura, dopo Turchia, Russia, Ucraina, Bulgaria, Romania e Moldova. Oltre alla questione del sovraffollamento delle carceri, che il governo a tempo fino alla fine di maggio per risolvere, e quella connessa sull'inadeguatezza delle cure mediche per alcuni detenuti, la quasi totalità delle sentenze sotto sorveglianza riguardano la durata dei processi (civili, amministrativi e penali) e problemi legati ai pagamenti dovuti in base alla legge Pinto. Ma il comitato dei ministri sorveglia in modo particolare anche l'esecuzione di altre quattro sentenze: quella relativa alla condanna dell'Italia per l'impossibilità di Centro Europa 7 di trasmettere la sentenza Costa Pavan che ha stabilito inadeguatezza della legge che regola la procreazione medicalmente assistita, la sentenza Di Sarno e altri con cui la Corte ha condannato l'Italia per l'incapacità nel gestire adeguatamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in Campania, e infine la sentenza M. C. ed altri con cui la Corte ha stabilito che l'Italia deve pagare a tutti gli infettati da trasfusioni di sangue o prodotti derivati l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 210/1992.
Giustizia e politica “Made in Sud”, scrive Giuseppe Mele su “l’Opinione”. È vero, come ricorda Giacalone, che negli ultimi decenni hanno governato uomini e donne del Nord. Non è una novità. In un secolo e mezzo, poche sono state le eccezioni (Moro, Nitti, Crispi, De Mita, Leone, D’Alema, Segni, Orlando, Salandra, Cossiga). D’altro canto, l’impressione che lo Stato e la sua burocrazia siano ampiamente meridionalizzati e borbonici è una solida realtà. La partitica apicale è nordista, ora come agli inizi di Cavour, Rattazzi e Ricasoli. La mentalità dello Stato nelle sue branche centrali e locali è, invece, meridionale. Simbolo e vertice di questa mentalità è la giustizia, dove la maggioranza dei 10mila togati proviene da sotto il Tevere. Dopo un lungo periodo di mitizzazione, in cui la magistratura è apparsa rivestire i superpoteri dei fumetti della Marvel, questa leadership è stata consacrata al secondo ruolo istituzionale del Paese. Tale secondo potere, meridionale, del Paese, conduce con successo, da un trentennio, una guerra interna, dall’alto di una sorte di opricnina, un governo a latere, svincolato dal resto dell’ordinamento. Forte di questa indipendenza, ha promosso al massimo grado tutti i difetti intellettuali, che da un certo punto di vista sono tradizionalmente caratteristici proprio della borghesia mediterranea, dall’azzeccagarbuglismo all’amore per le grida spagnole, dall’istigazione alla litigiosità spicciola, dall’ampio familismo all’interpretazione di tutta la vita sociale secondo i canoni delle regioni più arretrate dell’arretrato Sud, alla consuetudine della pluralità di incarichi, al controllo totale della gestione burocratica della grazia e della giustizia, oltre che delle carceri. Ogni anno i vertici togati a livello centrale e periferico con piacere sarcastico snocciolano i dati di un triste fallimento. Lo fanno con foga e passione, come se la gestione e dunque la responsabilità non fosse loro. La giustizia è di per sé tra le macchine pubbliche meno costose, anche per il numero limitato di personale coinvolto. I magistrati erano nel 1980 quasi 7mila e oggi sono quasi 9mila (con un picco di 9200 nel 2011), gli onorari sono 4mila, i giudici di pace 2300 (dopo il picco del 2002 di 4200). A questi 15mila si aggiungono 40mila secondini (nel 1980 erano 14mila) e 47mila impiegati (23mila nel 1979, con un picco di 54mila nel 2001). Centomila addetti per una giustizia che costa 7 miliardi (2013), l’1,30% del bilancio rispetto allo 0,85% del 1980 (con un picco di quasi 9 miliardi nel 2009). La Francia spende la metà, la Germania il doppio. Invece sulle carceri l’Italia spende il doppio dei due Paesi europei, malgrado che la quota relativa di spesa sia scesa dalla metà al 40%. I detenuti d’altra parte sono raddoppiati, da 30mila a 66mila, soprattutto per l’aumento esponenziale di quelli in attesa di giudizio. Prima i condannati erano 27mila, la grande maggioranza; ora lo sono solo 38mila detenuti. Il 43% della popolazione carceraria non è ai sensi di legge colpevole. Il disastro massimo sta nei processi in corso, non smaltiti, 2,7 milioni civili e 5 milioni penali, in trent’anni cresciuti di tre volte dai 1,3 e 1,3 milioni del 1980. Processi della durata di 8 e 5 anni medi, secondo una prudente ricostruzione degli uffici del Senato, molto più lunghi secondo i dati europei. Com’è noto sul settore giustizia l’Italia viene sistematicamente condannata, sia per le violazioni dei diritti degli accusati che per l’uso del carcere come strumento di tortura; le condanne sono saldate in termini di miliardi, sia come risarcimento a detenuti che come multe a Bruxelles, dall’erario. Le uniche giustificazioni plausibili a questo status disastroso stanno nel naturale alto tasso di litigiosità, il cui record è diviso tra Roma e Madrid e nel limitato numero di togati, inclusi i non professionisti, che sono in Italia 16 ogni 100mila abitanti, 55 in Francia e 154 in Germania. D’altro lato, negli altri Paesi europei la conciliazione è un’alternativa effettiva e cogente rispetto al tribunale, che invece in Italia resta l’unico sbocco reale delle controversie. La malandata situazione nei decenni ha prodotto tentativi di riforma, polemiche politiche al calor bianco e referendum anti-toga. Per parte propria l’associazione nazionale togata si è asserragliata nel fortino catilinario dell’etica, con intercambiabili alleati sia di sinistra che di destra, dando più volte l’assalto alla partitica, addirittura con un proprio partito delle procure, giungendo nei momenti di maggiore difficoltà ad appellarsi anche all’Onu per i “progetti di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che vogliono sminuirne l’indipendenza”. Neanche si trattasse di una minoranza etnica o repubblica autonoma. Mai un dubbio che lo “sfacelo giustizia” sia conseguenza delle modalità di gestione e, in ultima analisi, della stessa visione economica e sociale della vita del Paese. Non c’è aspetto e attore economico, industriale, istituzionale, finanziario, tecnologico, sindacale, politico che non sia stato in questi decenni pesantemente influenzato, artefatto, sconvolto, drogato, salvato, cancellato dall’indipendenza togata, al punto che per controbilanciarne gli effetti ci vorrebbe un apposito Antitrust. L’assolutismo togato, sciolto da qualunque limite, sorse quasi per caso, sullo scalino della scaletta che doveva portare l’ultimo re in esilio. Non fu la Repubblica, né la Resistenza e neppure il primissimo ministro di Giustizia nel II e del III Governo De Gasperi, il comunista Fausto Gullo per il quale l’obbligo era mandare assolte le vendette di Bube e fratelli. L’assolutismo togato fu un regalo, un bon bon regale del “re di maggio”, probabile padre dell’attuale monarca quirinalizio. L’ultimo e unico atto legislativo di Umberto, consumatosi il 31 maggio del 1946, fu la legge delle guarentigie, che vennero estese, oltre al Papa ed ai Vescovi, anche ai magistrati, resi inamovibili e indipendenti dal relativo ministero. Un caso unico in Europa. All’epoca, si volle considerare il provvedimento come una rivalsa anticipata alla grande amnistia attuata un mese dopo, che mandò liberi mandanti e autori della mattanza dei 50mila in odore di fascisti. Si immaginava che la Costituente avrebbe cassato la strana norma che poneva 20mila dipendenti dello Stato su un altro pianeta. Cattolici e comunisti non avevano una buona opinione dei togati, né della loro associazione che, anche se sciolta dal fascismo, appariva una congrega massonica, governativa, conservatrice, meridionale, impegnata in una guerra civile meridionale di cui i maxi processi antimafia erano caratteristica costante da quelli di Viterbo del 1912 (e poi del 1952). In fase di redazione, a difendere la drole de loi fu uno capi dei laici, il leader repubblicano Conti, che aveva passato gli anni del regime da un cielo a scacchi all’altro ed era uno degli ultimi per i quali “Repubblica” era sinonimo di eversione al sistema. La Malfa senior, invece, aveva passato gli anni fascisti con Mattioli da direttore dell’ufficio studi della Banca Commerciale ed in Treccani da seguace dell’ideologo, mezzo rosso e mezzo nero, del corporativismo Spirito. Siciliano, La Malfa aveva seguito l’oro dei consigli materni, che l’aveva indirizzato al disprezzo per le terre natali e alla carriera di successo nella finanza al nord. Di fronte al collega di partito Conti (che dopo la prodezza scomparve dalla storia patria) e alle sue vere stimmate carcerarie, il repubblicano siciliano tacque. Così il partito più filoamericano italiano si rese responsabile di sostenere le ubbie corporative di quelle terre meridionali, temute come un gorgo passatista capace di risucchiare in sé ogni progresso. Questa è stata d’altronde la storia degli uomini più intelligenti, più preparati, più autorevoli; dei laici, da Croce a La Malfa, dai liberali agli azionisti, fino ai Bobbio ed al partito Repubblica; la storia del continuo tradimento del proprio campo naturale, la storia della guerra alla parte migliore del Paese e ai programmi più evoluti. Una storia rovesciata che tutt’oggi rimpiange d’essere stata “ingenua” e di non essere riuscita “tra il 1992 e il 1994, con 1408 condanne definitive, ad estirpare dal potere la corruzione”. Parola del già senatore casertano Ds e Pd (2006 e 2008) Gerardo D’Ambrosio, magistrato tra il 1957 ed il 2002, capace di assolvere la polizia per il malore attivo dell’anarchico Pinelli, il Pci per il terrorismo rosso ed i finanziamenti, Pisapia dall’ex comunismo ma non Freda e Ventura, non Calvi, non la Parenti che indagava sul tesoriere Pds, non Mastella, reo di indulto nel luglio 2006 e di calcoli sbagliati (uscirono 25mila detenuti e non 12mila). Condoglianze a D’Ambrosio, testé deceduto, simbolo di un’epoca, di una generazione e di un potere che perpetua i suoi difetti, contraddittoriamente ossessionato dal disinteresse per la terra natia e da un improbabile atlantismo di sinistra, dalla fede nell’opulento occidentalismo e nell’oscuro dirigismo austero e sparagnino dell’anticapitalismo della burocrazia e dell’usura. Che mantiene stile, buona educazione e distinzione. Senza che ciò basti, come ricordano gli imputati suicidi e gli attori economici travolti, ad ottenere un titolo di galantuomo.
BUROCRAZIA E DISSERVIZI. IL SUPPLIZIO DEGLI ITALIANI.
Italia. Il supplizio quotidiano degli italiani? La burocrazia e i disservizi.
Rabbia e dolore per Eddy panettiere morto di burocrazia. Il fratello del commerciante suicida: "Camorra più clemente dello Stato".
«La camorra avrebbe dato più tempo a mio fratello per pagare. Il mio Stato, quello a cui pago le tasse, gli ha dato 24 ore. Devo pensare che la camorra tutela più dello Stato». Parole dure, dal sapore della provocazione, quelle pronunciate in piazza Primavera a Pomigliano d'Arco a una manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle, da Arcangelo De Falco, fratello di Eddy, il panettiere che si è tolto la vita dopo la multa dell'Ispettorato del lavoro, lasciando moglie e tre figli piccoli, scrive Stella Cervasio su “La Repubblica”. Ha sostenuto, in una intervista, che il verbale non era per la presenza di mia cognata, e che quest’ultima percepiva 10 euro al giorno. Ma dove sono queste cose nel verbale – chiede mostrando il documento – qui c’è anche l’ultimatum che hanno dato ad Eddy, 24 ore. De Falco annuncia anche che domani sarà aperto un conto corrente per chi volesse aiutare economicamente la cognata e i suoi tre figli: “Domani comunicheremo il numero del conto corrente, c’è bisogno di un aiuto concreto. I figli di Eddy hanno bisogno di mangiare, studiare, pagare le bollette. Mia cognata non può rischiare che le levino i figli dopo aver perso il marito”. "Il paragone mi indigna. Non si possono mettere a confronto Stato e camorra", replica a distanza il dirigente dell'Ispettorato, Renato Pingue. Posso solo ribadire che ciò che è accaduto non è in funzione del fatto che i miei ispettori hanno trovato al lavoro la moglie del panettiere. Con lei c'era una persona che lavorava al nero e un'altra che è scappata. Anzi, paradossalmente se invece della moglie ci fosse stata solo la persona che ha dichiarato di lavorare al nero per 10 euro al giorno dal mese di aprile 2013, la normativa non avrebbe previsto la chiusura del locale e la sanzione". Il fratello del titolare del negozio di Casalnuovo invece accusa: "Il capo dell'Ispettorato non ha avuto rispetto per Eddy, poteva aspettare 24 ore prima di dire che era un evasore. In un'intervista dice, mostrando il verbale ha sostenuto che la multa non era per mia cognata e che lei percepiva 10 euro al giorno. Ma dove sono queste cose nel verbale? C'è però l'ultimatum che hanno dato a mio fratello: 24 ore". Arcangelo De Falco ha annunciato che sarà aperto un conto corrente per aiutare la cognata e i nipotini: "Non lasciate morire mio fratello per la seconda volta". Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle ha proposto un fondo costituito con parte degli stipendi dei suoi colleghi deputati per istituire sportelli di consulenza e microcredito in ogni provincia d'Italia. "Conoscevo Eddy - ha raccontato Di Maio - mi aveva contattato due anni fa per un'idea di consegna di latte e pane a chilometro zero con le biciclette. Ma mi disse che dovevamo far nostra la sua idea perché lui lavorava come un somaro. Era uno tosto, significa che se siamo a un punto tale che anche i duri possono cedere. In Italia c'è un'enorme evasione fiscale, ma il sistema sembra avere maglie strette sui deboli e larghe per i forti. Potremmo creare anche un fondo con consiglieri regionali e parlamentari della zona che hanno uno stipendio enorme come il mio per nuovi sportelli e solidarietà". Ed è proprio alla politica che si rivolge il capo degli ispettori: "Con tutto il rispetto per i 5 stelle e il presidente di Confartigianato che ci attaccano: mi sta bene tutto, ma è come dire agli organi di controllo non controllate più. Si può discutere se la sanzione è eccessiva, ma non possiamo addebitarlo all'ispettore. So per esperienza che la situazione è grave, lo Stato può fare solo un ragionamento: le pene vanno inasprite o si vuole tollerare, ma questa è una scelta politica, che non si può lasciare nelle mani di dipendenti dello Stato. Questo dramma crea interrogativi rispetto ai quali tutti dovrebbero fare attenzione, in primis la politica. Quello che è accaduto agli ispettori potrebbe capitare anche al vigile urbano o al finanziere che controlla lo scontrino. Ci riempiamo la bocca sul fatto che va eliminato il lavoro nero e gli industriali sono i primi a sostenerlo. Ma oggi queste voci non si sono levate protesta Pingue E neppure quelle dei magistrati, che di solito si fanno sentire. Io vorrei dire a tutti: guardate che gli ispettori difendono i lavoratori, compresi quelli che guadagnano 10 euro al giorno da un anno. Vorrei chiarire sottolinea Renato Pingue che mi spiace di non poter parlare con la famiglia, volevo anche andare al funerale ma ho rispettato il loro dolore. Sono pronto però a dar loro tutti i chiarimenti possibili quando vorranno. Ci sono cose che vanno approfondite. Anch'io sto vivendo giorni terribili, certamente non paragonabili a quelli della moglie, dei figli e del padre di Eddy De Falco, ma sono combattuto tra la sponda istituzionale e quella sociale del dramma di Casalnuovo. Come tutti, rimango sconfitto da questa situazione sociale".
La moglie gli dava una mano in negozio: multa da duemila euro per "lavoro nero". E il negoziante angosciato si toglie la vita, scrive Giuseppe Marino “Il Giornale”. Uno a posto, uno equilibrato, «nu bravo guaglione». A Casalnuovo di Napoli ieri lo descrivevano tutti così «Eddy» il panettiere, e in questi casi si sa, è quasi un copione. Ma in fondo non è questo che importa. Importerebbe di più sapere cosa pensava lui ieri mattina quando è salito sull'auto alla solita ora, ha messo in moto non per andare al lavoro ma per morire, respirando a fondo i gas di scarico che riempivano l'abitacolo. Morire per sfuggire all'incubo di una multa. Come tanti, in questi mesi, Edoardo De Falco, che a 43 anni gestiva una piccola panetteria di paese, aveva la testa piena di pensieri su come conquistare la fine del mese, tenere al sicuro la propria famiglia dall'angoscia dei soldi. E come tanti, per mesi, avrà sentito la tv che raccontava le consultazioni per formare un governo, gli scazzi tra Renzi e Grillo e ancora prima gli annunci di mirabolanti programmi per il Paese: Impegno Italia, Destinazione Italia, Salva Italia, gli sgravi alle famiglie, gli aiuti alle piccole imprese. Ma per il panettiere di Casalnuovo la politica raccontata dai telegiornali doveva apparire, negli ultimi giorni, come una fiction. Lo Stato, quello vero, ha bussato alla porta del suo negozio nei panni degli ispettori del lavoro. E non erano venuti a vedere come aiutarlo a tener su la claire del suo «Speedy pizza», a risolvere il puzzle di conti e bollette, a continuare a dar da mangiare alla famiglia. Anzi la sua famiglia, dopo quella visita, è diventato il problema. Perché, raccontano amici e rappresentanti locali delle associazioni di categoria, quei zelanti funzionari gli avevano contestato la presenza in negozio della moglie che gli dava una mano a servire i clienti senza, pare, un regolare contratto da dipendente. Risultato: un verbale da duemila euro di multa. L'ispettorato del lavoro ieri non ha rilasciato commenti, ma per quanto incredibile la cosa è verosimile. Nello stesso Paese in cui si tollerano centinaia di lavoratori cinesi schiavizzati in capannoni industriali ridotti a lager, farsi dare una mano da un familiare senza un contratto, un permesso, una carta bollata, è infrazione da cartellino rosso. Del resto, se anche la moglie fosse stata «in regola», il panettiere avrebbe potuto essere multato perché non aveva bagni separati per la dipendente donna, non importa se è la moglie e a casa usano lo stesso bagno. È la burocrazia, bellezza. Chissà se gli ispettori del lavoro che hanno multato un panettiere hanno mai sentito parlare della tassa sul macinato di Quintino Sella e delle rivolte che provocò nell'Italia da poco unita. Ma quella era un'altra Italia. Oggi si può morire di fisco, di burocrazia, o semplicemente soffrirne in silenzio. Come ha fatto Eddy che era ossessionato da quella multa, diceva che avrebbe dovuto pagare subito o gli avrebbero fatto chiudere il negozio. Lui ne aveva parlato con i familiari che avevano capito la sua angoscia e avevano cercato di rassicurarlo, perfino il fratello cassintegrato alla Fiat di Pomigliano aveva promesso di dargli una mano. Ma ha vinto l'angoscia. E oggi ci saranno le comprensibili lacrime dei parenti per cercare di consolarsi. Ci sarà qualche comunicato ufficiale per spiegare, per precisare. Ci sarà la rabbia dei commercianti del paese e del sindaco, che hanno annunciato proteste e una serrata. Ma tutto rimbalzerà contro un muro di gomma, come sempre. Fino alla prossima vittima.
Malaburocrazia, due anni per un documento, scrive “Il Giornale”. “Maledetto il giorno che ho deciso di aprire un’attività”. Giuseppe C., 52 anni, non lavora da maggio 2012. Da allora ha accumulato così tanta rabbia e così tanta frustrazione che è impossibile non percepirle, quasi vengono fuori dalla cornetta del telefono. Lui ci ha provato, ma si è scontrato con la burocrazia e l’inefficienza delle amministrazioni comunali e degli uffici competenti. Siamo a Palermo. Nel dicembre 2009 Giuseppe firma il contratto di affitto e rileva un locale. Vorrebbe dar vita a una piccola discoteca con agibilità per 150 persone e inizia a portare avanti la pratica per avere il certificato di agibilità provvisoria da parte degli organi predisposti. Sarà un calvario. Per prima cosa succede che dal gennaio 2010 la commissione provinciale non ha più competenze e tutto passa nella mani del Comune. “Il responsabile della mia pratica dice che il locale non è commerciale e deve avere un cambio di destinazione d’uso”, mi spiega Giuseppe. Ed è qui che arriva il “bello”. Perché il settore dell’edilizia privata del Comune di Palermo impiega 18 mesi per fare un cambio di destinazione d’uso su carta. “Non ha chiesto lavori né messa in sicurezza, il progetto è marcito per tutto questo tempo negli uffici comunali. Anzi, se non mi fossi recato in Comune con i miei ingegneri dopo tre mesi, la pratica sarebbe rimasta chiusa a chiave nell’archivio in cui era stata relegata”, tuona l’imprenditore. Che continua: “Come se non bastasse, una volta concessa l’agibilità, la Prefettura si è presa altri sei mesi per effettuare il sopralluogo nel locale. Tutto questo perché non ha riconosciuto la validità della legge che prevede che per i locali con capienza inferiore a 200 persone il sopralluogo venga sostituito da una relazione tecnica di un professionista e lo stesso vale per il parere sul progetto, sostituibile da una relazione tecnica”. Ricapitolando: 24 mesi di attesa per poter finalmente aprire il locale. Ma cosa è successo in questo lasso di tempo?
- È successo che Giuseppe ha pagato 2.200 euro al mese di affitto per il locale. Totale 59.400 compresi tre mesi di caparra.
- Altri 27mila euro pagati per il cambio di destinazione d’uso.
- Altri soldi spesi per bolli, raccomandate, certificati, macchinari, arredi, ingegneri.
Alla fine, il 15 dicembre 2011 (esattamente due anni dopo), Giuseppe può aprire il locale. Ma dura solo 4 mesi perché è costretto a chiudere per sovraindebitamento. “Fino a quando non ci sarà una legge che stabilirà che le pratiche devono essere espletate entro e non oltre una determinata data, qui non ci sarà speranza”. C’è da indignarsi o no?
Imprese e burocrazia: dieci anni per un permesso. E le piastrelle emigrano in Tennessee, scrive Alberto Crepaldi su “Il Fatto quotidiano”. È arrivata ieri una notizia che rappresenta l’ultimo smacco, in ordine di tempo, alla già ridotta credibilità di un paese che è sempre meno accogliente con le imprese e con chi vuole investire. Perché mentre da noi si affoga di burocrazia anche chi desidera aprire semplicemente un bar, in altri paesi, in pochi mesi, aprono i battenti addirittura stabilimenti industriali. Non alludiamo a nazioni in via di sviluppo, verso le quali, negli ultimi anni, si è orientata la fuga dall’Italia, a volte disperata, in tanti altri casi furbesca, di nostre aziende. Stiamo parlando degli Stati Uniti D’America. Qui, per l’esattezza nello Stato del Tennessee, è stato infatti inaugurato ieri, dopo appena dieci mesi dalla presentazione di un progetto di insediamento produttivo, il nuovo stabilimento dell’industria ceramica Del Conca. Si pensi che la stessa azienda attende invece da ben dieci anni l’approvazione di una variante al piano regolatore per riuscire ad ampliare il proprio sito a San Clemente, località dell’entroterra riminese. Se per un allargamento della capacità produttiva i tempi sono così lunghi, immaginatevi cosa avrebbe significato, non solo da un punto di vista dell’attesa, aprire una fabbrica da 30mila metri quadri come quella che la Del Conca ha insediato in America: montagne di carte, un mare di adempimenti preliminari, migliaia di ore spese in colloqui con consulenti specializzati nelle più disparate arti di mediazione con la burocrazia italica, progetti da rifare una dozzina di volte, una cinquantina di modelli da compilare, apertura di molteplici tavoli di discussione, attese di mesi per la convocazione della conferenza dei servizi, muri di gomma in ognuno degli enti coinvolti nell’istruttoria, uno stillicidio ossessivo di sopralluoghi e verifiche di ogni genere compiuti dal momento della posa del primo mattone a quello del posizionamento dei pc sulle scrivanie. Aprire un capannone da 30mila metri quadrati in Italia sarebbe stato, insomma, un autentico delirio. Nel quale chi ha un’impresa in questo paese si imbatte tragicamente anche per le cose apparentemente più innocue di questo mondo. Come l’allargamento degli spogliatoi del personale, la modifica delle altezze delle finestre, la variazione della posizione del lavello della cucina di un ristorante. E tutto questo accade, come sentiamo dire dagli stessi governanti di turno, perché il rapporto tra istituzioni e imprese è tremendamente malato, condizionato com’è da una mole abnorme e senza senso di normative, un groviglio di leggi tra di loro non di rado in contraddizione a causa di una relazione perversa tra i diversi enti e livelli istituzionali coinvolti. La ceramica Del Conca, dalle istituzioni del Tennessee, ha addirittura avuto a disposizione un assistente dedicato e pronto a risolvere ogni nodo burocratico che potesse presentarsi lungo il cammino per la costruzione dello stabilimento. In Italia c’è invece un esercito di funzionari che trovano decisamente più gustoso, in una sorta di ricerca di piacere che sfiora autoerotismo, tirare fuori ogni sorta di cavillo per ostacolare il percorso di nascita e la stessa vita delle imprese. Il dramma vero è che le semplificazioni, le sburocratizzazioni, gli sforbiciamenti, la necessità che la burocrazia sia “amica” delle imprese, ossia tutta una serie di concetti che sentiamo evocare da un ventennio, sono rimasti lettera morta. Ed allora fanno ancora più riflettere e male le parole che un ingegnere della ceramica Del Conca ha pronunciato in occasione dell’inaugurazione del sito statunitense: «chi investe è visto come colui che porta qualcosa di positivo sul territorio, quindi le istituzioni si adoperano con determinazione per agevolarlo, non danno dollari ma crediti fiscali, servizi e perfino infrastrutture, che vengono finanziate e costruite dalle autorità locali: la Del Conca Way – la strada che porta allo stabilimento, costruita dal Dipartimento Trasporti dello Stato del Tennessee – è l’esempio più eclatante».
Oggi in piazza 40mila imprenditori. Ecco perché noi siamo con loro. L'idea di base è che imprenditori, partite Iva, siano lestofanti o cretini e che dunque la burocrazia, cioè lo Stato, debba controllare, normare, legiferare, bollinare, scrive Nicola Porro 18/02/2014 su “Il Giornale”. Fino alla primavera scorsa un'azienda con meno di dieci dipendenti poteva autocertificare «la valutazione dei rischi», dal primo giugno occorre rivolgersi ad un'azienda specializzata. Già prima dell'orario di convocazione, Piazza del Popolo si è riempita di manifestanti. Dall'inizio di quest'anno le imprese sono obbligate a far valutare lo stress a cui sottopongono i propri collaboratori. Un contadino che usa il gasolio agricolo ha un gradino in più nella trafila. Un barista che voglia assumere un apprendista deve riempire scartoffie da avvocato per il percorso formativo e poi, se dopo tre anni non lo assume, deve pagare una tassa per licenziarlo come se fosse un dipendente della Fiat. A Milano, se si dispone di un giardinetto condominiale, è necessaria una certificazione (ovviamente da parte di un'azienda specializzata) sulla de-zanzarizzazione. Mentre nella buca sulla strada prospiciente, le larvette fanno festa. Un iscritto ad un albo professionale è obbligato a partecipare a dei corsi formativi (in genere fatti da colleghi che arrotondano) per rimanere nel medesimo albo. Che peraltro è obbligatorio per esercitare la professione. Un estetista deve sottoporsi a 118 procedure amministrative per aprire la sua attività, se invece l'officina è meccanica ne servono 84. È una lista disordinata, ma possiamo continuare all'infinito. Viene da chiedersi come mai ci siano ancora imprenditori in Italia. L'idea di base è che imprenditori, partite Iva, siano lestofanti o cretini e che dunque la burocrazia, cioè lo Stato, debba controllare, normare, legiferare, bollinare. In Italia c'è un imprenditore ogni quattro famiglie. E per il 95 per cento dei casi, si tratta di piccoli e medi. Veniamo trattati come dei minus habens. Ciò che non viene prelevato dalle tasse, viene concesso ai burocrati, che rispondono a leggi fatte da essi stessi. Il ministro dell'Economia uscente, Saccomanni, che è un burocrate, due giorni fa ha detto: «L'Italia ostaggio della burocrazia? Una balla». E be' certo: mica poteva autodefinirsi un rapinatore. L'Italia è spaccata in due. C'è chi fa e chi regola. Il primo viene pagato dal suo lavoro e dai suoi successi, e il secondo pure: cioè viene pagato dal lavoro e dai successi del primo. Oggi ci saranno in piazza 40mila imprenditori raccolti da Rete Imprese Italia per urlare (con la consueta educazione) la loro insofferenza per una classe dirigente che a parole, e sotto elezioni, fa finta di capirli e in Parlamento gli vota contro. Noi siamo con loro.
Dis-servizi pubblici. Gli italiani nella trappola delle bollette, della burocrazia, delle inefficienze nei trasporti, nelle banche e nella pubblica amministrazione. Il Rapporto di Cittadinanzattiva conferma il supplizio quotidiano dei consumatori per colpa di chi non rispetta i loro legittimi e sacrosanti diritti, scrive “Le novae”. Italiani ostaggio dei servizi, telecomunicazioni in testa. Insomma, per i consumatori del Belpaese i problemi legati alle utenze telefoniche e dell’energia, ai conti bancari, ai servizi di trasporto e via discorrendo sono diventati un vero e proprio calvario. A dimostrazione che lungo la penisola non basta la fatica di arrivare alla fine del mese, ma a complicarci la vita ci si mettono anche la burocrazia, le procedure farraginose per fare un documento, le estenuanti file agli sportelli, la reticenza di taluni uffici a dare le più elementari informazioni. A dirla lunga in materia è il rapporto di Pit Servizi-Cittadinanzattiva dal titolo “Consumatori: servizi e diritti in stallo”, da cui emerge che il 2010 è stato un anno nero per qualità dei servizi in quasi tutti i settori. Quasi a segnare un peggioramento nei rapporti tra pubblico e privato. Alla faccia della semplificazione e dei diritti del consumatore. Il primato dei reclami va alle telecomunicazioni (21% di lamentele arrivate all’associazione), seguito da servizi pubblici locali (17%). Al terzo posto, a pari merito, banche ed energia (16%). Ma nella classifica dei settori che danno filo da torcere ai nostri connazionali ci sono anche la pubblica amministrazione (12% di segnalazioni) e i trasporti (10%). Ultimi della lista, ma che comunque non lesinano grattacapi, compaiono le poste (4%), le assicurazioni (3%), i beni e i contratti (1%). Di cosa si lamentano gli italiani? I diritti più violati riguardano la qualità dei servizi resi (il 19% dei casi, due punti percentuali in più rispetto al 2009), la trasparenza (16% contro il 14% del 2009) e la tutela (13%, era 11% un anno prima). Telecomunicazioni. Telefonia mobile e fissa vincono la maglia nera, con il 21% dei reclami, un quinto del totale. Di cui circa la metà (il 48%) spetta alla telefonia fissa soprattutto per problemi legati al cambio gestore (che può arrivare ad attese di 90 giorni) e alle bollette dove spesso e volentieri vengono addebitate voci di costo non dovute. Ma anche internet è nel mirino con il 12% di segnalazioni da parte degli utenti. A seguire telefonia mobile e tv. Sul banco degli imputati? L’operatore più contestato per il telefono fisso è Telecom seguito da Teletù/Teledue. Per la telefonia mobile invece la palma va a Tim e H3G. Infine, i “disservizi” televisivi: svettano in cima alla lista le Pay tv (64% di reclami) e il digitale terrestre (36% di critiche). Servizi pubblici locali. Rifiuti (guarda un po’!), acqua e spostamenti casa-lavoro. I servizi pubblici locali compaiono al secondo posto per disagi arrecati agli utenti (17% delle contestazioni). In particolare, segnala il rapporto, il capitolo immondizia e dintorni si becca il 30% delle ire dei consumatori (caro tariffe della relativa tassa imposta dai Comuni tra i principali motivi), il servizio idrico si distingue con il 28% dei reclami (specialmente per via delle interruzioni del flusso d’acqua dai rubinetti), mentre continua incessante la via crucis dei pendolari (13% di contestazioni) costretti a subire ritardi e disservizi sia sulle tratte locali ferroviarie sia con gli autobus. Mutui e prestiti. Qui la situazione documentata dal Pit è roba da far accapponare la pelle: una famiglia su quattro non ce la fa a pagare regolarmente la rata del mutuo, mentre per quasi la metà dei nuclei familiari un terzo del proprio reddito va tutto per le spese di casa (incluse le varie bollette). Difficoltà dal settore bancario sono segnalate soprattutto per la rinegoziazione dei mutui che spesso richiede tempi biblici o per ottenere la cifra iniziale del mutuo. Tante nubi anche sul fronte dei prestiti e finanziamenti. Un dato per tutti: nel 2010 i crediti da recuperare per rate e bollette non pagate ammontano a quasi 31 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2009 quando si era registrato un vero boom pari a 29 miliardi di euro mentre erano 19,5 miliardi nel 2008. Sul fronte delle denunce da parte dei cittadini i finanziamenti e la trasparenza delle condizioni (31%,+6% rispetto al 2009), la banca dati dei cattivi pagatori (28%, +14%), il sovraindebitamento (22%,-9%) e i tassi elevati dei prestiti (19%,-4%). Infine, il famigerato conto corrente, preso di mira sempre più di frequente dalle sigle dei consumatori. Con il 23% delle segnalazioni crescono dell’11% rispetto al 2009 le criticità relative a questo tipo di rapporto bancario. Qual è il principale neo? Le elevate commissioni di massimo scoperto (22%, +7%), che continuano ad essere applicate in modo illegittimo e oltre i tassi previsti. Energia. Con il 16% delle segnalazioni, il settore dell’energia è a pari merito con le banche per fastidiosi contrattempi arrecati agli utenti. Imputato numero uno: luce e gas, anche se si mantengono stabili rispetto ai dati del 2009 pari al 17%. Per il 68% (-6%) le lamentele si concentrano sull’energia elettrica, per il 32% (+6%) sul gas. Nel caso dell’elettricità il nodo più critico rimane la bolletta (36% delle segnalazioni) con anomalie legate per lo più a errori nel conguaglio, alla scarsa trasparenza delle voci in fattura e all’errata fatturazione, e il cambio di fornitore, fonte di disservizi per pratiche commerciali illecite, mancata fatturazione, recesso e pratiche commerciali aggressive. La Pubblica Amministrazione. E’ al quarto posto nella classifica degli ambiti più criticati, con circa il 12% del totale dei reclami. Sempre le stesse sono inoltre le criticità, che affliggono i sei macro ambiti della PA a danno dell’utente: il fisco si guadagna il 35% delle segnalazioni, le multe il 20%, il welfare il 17%, le pratiche amministrative sono al 13%, in coda ambiente e scuola rispettivamente col 9% e col 4%. In crescita del 6% rispetto al 2009, il fisco è la voce che figura maggiormente tra le segnalazioni dei cittadini, che denunciano vessazioni dalla PA che pretende tasse non dovute o comunque considerate ingiuste.
LO STATO DELLA CASTA: COME EVADE LE TASSE E COME TRUFFALDINAMENTE SI FINANZIA.
Tasse, ecco come la Casta si è dimezzata l'aliquota. Con un trucchetto, grazie a un lavorìo rimasto sempre sotto traccia, è passata la riduzione al 18,7 delle tasse sulla busta paga di deputati e senatori, scrive Stefano Livadiotti su “L’Espresso”. I partiti politici italiani se le sono date di santa ragione per favorire a colpi di leggi i loro rispettivi bacini elettorali. Ma su un fronte hanno lavorato tutti insieme appassionatamente. L’obiettivo era quello di garantire un trattamento fiscale di straordinario privilegio ai loro rappresentanti in parlamento (ma le stesse regole sono previste anche per gli onorevoli regionali). Ed è stato perfettamente centrato, con un lavorìo rimasto sempre sotto traccia. Pochi lo sanno: l’indignazione dei cittadini per i costi della politica si è finora concentrata sui benefici economici e pensionistici degli onorevoli. Ma quelli fiscali sono ancora più scandalosi: la retribuzione complessiva di chi siede alla Camera in rappresentanza del popolo italiano è sottoposta a un’aliquota media Irpef del 18,7 per cento. Ecco come funziona, documenti ufficiali alla mano (ricavati dal sito istituzionale della Camera). Prendiamo un parlamentare che non svolge altre attività ed è talmente ligio da non saltare mai una seduta di Montecitorio. La voce più pesante della sua busta paga è l’indennità mensile, oggi ridotta a 10.435 euro, pari a 125.220 euro l’anno. Dall’importo vengono sottratte ritenute previdenziali per 784 euro al mese (9.410 euro l’anno) come quota di accantonamento per l’assegno di fine mandato, che è esentasse, come vedremo (e come d’altronde è scritto nero su bianco nella relazione al 31 dicembre 2011 su Attività e risultati della Commissione Giovannini sul livellamento retributivo Italia-Europa). L’onorevole subisce poi una ritenuta mensile per il trattamento pensionistico di circa 918 euro (11.019 euro l’anno). Dall’indennità parlamentare viene infine detratta una ritenuta mensile di 526 euro (6.320 euro l’anno) per l’assistenza sanitaria integrativa. Il trattamento del deputato è però arricchito da altre quattro voci con il segno positivo, tutti benefit esentasse. La prima è la diaria, una sorta di rimborso per i periodi di soggiorno a Roma, che ammonta a 3.503 euro al mese (42.037 l’anno) e viene decurtata di 206 euro per ogni giorno di assenza. La seconda è il rimborso delle spese per l’esercizio del mandato, pari a 3.690 euro al mese (44.280 l’anno), che per il 50 per cento va giustificato con pezze d’appoggio (per certe voci) e per il restante 50 per cento è riconosciuto a titolo forfettario. La terza voce non è perfettamente quantificabile e deriva dal fatto che il deputato è fornito di una serie di tessere per volare, prendere treni e navi e viaggiare in autostrada senza sborsare un soldo (ai fini della nostra simulazione abbiamo ipotizzato che ciò gli consenta di risparmiare 5 mila euro tondi l’anno) e un rimborso forfettario delle spese di trasporto (ma non viaggia già gratis?) di 3.995 euro a trimestre (15.980 l’anno). La quarta voce è rappresentata da una somma a forfait mensile di 258 euro (3.098 euro l’anno) per le bollette telefoniche. Il pallottoliere dice che il totale fa 235.615 euro. Che, dedotte le ritenute previdenziali e assistenziali e i rimborsi spese documentati, si riduce a 189.431 euro. Ma per l’onorevole, come per magia, grazie ai trattamenti di favore architettati dal parlamento stesso, la base imponibile ai fini Irpef è di soli 98.471 euro e comporta il pagamento di tasse per 35.512 euro. Che corrisponde in concreto a un’aliquota media, appunto, di appena il 18,7 per cento. Qualunque altro cittadino italiano, un manager per esempio, che percepisse la stessa somma a titolo di stipendio e di benefit di analoga natura, si ritroverebbe con una base tassabile ai fini dell’imposta sul reddito di 189.431 euro e dovrebbe mettere mano al portafoglio per 74.625 euro di Irpef (con un’aliquota media del 39,4 per cento). L’onorevole paga dunque solo il 47 per cento di quello che toccherebbe a un cittadino comune (e per semplicità non si è tenuto conto degli ulteriori benefici di cui gode sulle addizionali regionale e comunale) e risparmia ogni anno qualcosa come 39 mila euro d’imposta (vedere la tabella nella pagina a fianco). A consentire questa incredibile iniquità è un’interpretazione alquanto generosa, da parte del parlamento, dell’articolo 52, comma 1, lettera b del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), in base al quale non concorrono a formare il reddito le somme erogate a titolo di rimborso spese ai titolari di cariche elettive pubbliche (parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali) e ai giudici costituzionali, «purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi». Il rispetto dei principi di capacità contributiva e il divieto di disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti imporrebbe la limitazione dell’esenzione fiscale ai soli rimborsi spese effettivi, quelli cioè strettamente legati alle funzioni pubbliche svolte e corredati di documentazione. Ma il parlamento ha deciso diversamente. Costringendo altri uffici pubblici a fare i salti mortali per non doverne censurare le scelte. Basti pensare che il Gruppo di lavoro sull’erosione fiscale, costituito a suo tempo da Tremonti per tagliare la spesa pubblica e presieduto da Vieri Ceriani, non avendo altri criteri di rilievo costituzionale per giustificare le ragioni di tali benefici fiscali ha dovuto classificarli tra le misure a rilevanza sociale, cioè alla stregua di quelle a favore delle Onlus e del terzo settore e di quelle che aiutano l’occupazione. Poi dice l’antipolitica. Ma non è finita. Siccome pagare l’Irpef al 18,7 per cento a Lorsignori doveva sembrare ancora poco e per non farsi mancare proprio nulla, i parlamentari hanno pensato bene di trovare un escamotage per mettersi in tasca pulito pulito l’assegno di fine mandato, che dovrebbe invece essere sottoposto a tassazione in base all’articolo 17, comma 1, lettera a del Tuir (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Ecco come hanno fatto. Ogni mese, lo abbiamo appena visto, l’onorevole subisce, proprio in vista dell’assegno di fine mandato, una ritenuta sull’indennità parlamentare di 784 euro. Trattandosi di contributi previdenziali, la somma viene dedotta annualmente dal reddito da tassare, nel presupposto che ciò avverrà poi al momento della consegna dello chèque. L’articolo 17, comma 1 del D.P.R. 917/86 prevede, come per il Tfr dei lavoratori, una tassazione separata dell’assegno di fine mandato, per evitare che si sommi al reddito dell’anno in cui viene incassato, facendo così scattare un’aliquota fiscale più alta. Ma c’è un’altra disposizione (contenuta nell’articolo 19, comma 2 bis del Tuir) che riguarda il metodo di tassazione separata dell’indennità spettante ai dipendenti pubblici (buonuscita per gli statali) e agli assimilati (soci lavoratori delle cooperative, sacerdoti e parlamentari): dice che la base imponibile dell’assegno va determinata in funzione del peso del contributo a carico del datore di lavoro sul totale del contributo previdenziale. Per capire meglio, prendiamo un caso concreto. Quello di un dipendente pubblico, la cui indennità di buonuscita è alimentata da un contributo obbligatorio a carico del lavoratore nella misura del 2,5 per cento e da contributi a carico del datore di lavoro del 7,10, per un totale del 9,60 per cento. Il contributo pubblico del 7,10 per cento corrisponde al 73,96 del 9,60 per cento. Quindi al travet verrà tassato il 73,96 per cento della buonuscita. Non avviene così nel caso dei parlamentari. Disciplinando da soli il sistema di rappresentazione contabile della loro busta paga, gli onorevoli hanno creato un meccanismo perfetto, che rispetta formalmente la legge, ma consente di non pagare un euro bucato di tassazione separata sull’assegno di fine mandato. Il trucco è tanto banale quanto efficace: mentre per il dipendente pubblico, come abbiamo visto, il 73,96 per cento dell’accantonamento è a carico del datore di lavoro; nel caso del parlamentare la quota da accantonare per l’indennità di parlamentare è tutta figurativamente imputata a lui. E così non deve pagare. Non è certo da questi politici (a parte qualche lodevole eccezione) che ci si può aspettare una seria guerra ai ladri di tasse. Testo tratto dal saggio di Stefano Livadiotti “Ladri - Gli evasori e i politici che li proteggono” (Bompiani).
Finanziamento Pubblico. Staderini svela il bluff: si rischia la legge truffa. Il Disegno di legge elimina solo alcune norme mentre il finanziamento ai partiti resta pubblico, scrive Fabrizio Marino su “L’Inchiesta”. Il Consiglio dei ministri ha da poco approvato il disegno di legge sull’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ma già scattano le prime polemiche. Tra i primi sulle barricate è salito il segretario dei radicali Mario Staderini, che dal suo profilo twitter ha commentato così la decisione del Cdm: «smettete di dire che il governo abolisce il finanziamento pubblico ai partiti. Cambia solo il modo di prendere i soldi dalle nostre tasche...».
Segretario perché questo tweet?
«Innanzitutto bisogna fare chiarezza sul significato di finanziamento pubblico. Questo avviene quando le tasse dei cittadini finiscono direttamente agli apparati di partito. In questo disegno di legge ci si è limitati soltanto ad abrogare le vecchie norme. E’ vero che il ministro Quagliarello ha detto che questo finanziamento va abolito, ma di fatto non è stata invertita la rotta rispetto a quando il sistema vincente era quello in cui le tasse dei cittadini finivano ai partiti. Si continua infatti su questa strada modificando soltanto alcune modalità che si è cercato di rendere, almeno nelle intenzioni, meno scandalose».
Cosa cambia quindi con questo disegno di legge?
«Cambiano la modalità del rimborso perché si passa da un fondo fisso calcolato in base ai voti, a un fondo in parte scelto dalle indicazioni dei contribuenti. Mettiamola così, questo finanziamento rimane un finanziamento pubblico perché comunque viene preso dal bilancio dello stato, solo che adesso i cittadini possono esprimere una loro preferenza. Se poi fosse, come sembra, simile al modello dell’8xmille - e cioè che anche chi non esprime una preferenza è costretto a finanziare i partiti - sarebbe una truffa clamorosa».
Secondo lei quale sarebbe la soluzione più adatta per riformare il sistema attuale?
«Noi siamo per un sistema in cui i partiti si fanno finanziare da donazioni private fatte esclusivamente dai cittadini, persone fisiche intendo, con tetto limitato e non dalle persone giuridiche o dalle società. L’unica cosa che deve garantire lo Stato sono i servizi alla politica e non solo ai partiti. Questo modello, che poi è quello che gli italiani avevano scelto con il referendum del 1993, non è stato scelto. Tuttavia si è optato comunque per un finanziamento pubblico che, si spera, abbia modalità meno scandalose».
Neppure la progressiva diminuzione dei finanziamenti nel tempo la convince?
«Non è serio mantenere per quattro anni il sistema attuale con piccole riduzioni. Noi siamo convinti che si debbano riconoscere solo le spese sostenute in campagna elettorale, perché possono essere rendicontate, il resto non deve essere dato. E non è tutto perché sono sicuro che il già debole disegno di legge verrà stravolto in parlamento. Proprio per questo domani ci incontreremo a Roma per un’assemblea referendaria, con il comitato cambiamonoi.it, in cui proporremo una serie di referendum tra cui quello che abolisce definitivamente il finanziamento pubblico ai partiti».
La truffa del finanziamento pubblico ai partiti. La notizia dell’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti è falsa. Con questa legge i partiti costeranno al contribuente da 30 a 60 milioni, poco meno di quanto costano ora, scrive Roberto Perotti su “La Voce.info”. (Questo articolo è stato modificato alle ore 21:30 di sabato 14 dicembre 2013, un’ora dopo la prima pubblicazione. La modifica riflette un’ incertezza nell’ interpretazione della legge. Questa nuova versione assume che il decreto legge – che al momento di scrivere questo articolo non è disponibile su alcun sito ufficiale – abolisca il cofinanziamento del 50 percento delle elargizioni ai partiti. La versione precedente assumeva che il cofinanziamento sia ancora presente, e portava a una stima dei costi più alta).
GLI ANNUNCI DEL GOVERNO SONO UNA COSA LA REALTA’ UN’ALTRA.
Il governo ha annunciato che il finanziamento ai partiti sarà abolito interamente a partire dal 2017. La realtà è ben diversa: i partiti continueranno a pesare sul contribuente, da 30 milioni a 60 milioni, poco meno di quanto costano ora. Il motivo è nascosto tra le pieghe della legge approvata dalla Camera il 18 ottobre e riproposta nel decreto legge del governo del 13 dicembre. Con la legislazione vigente, i partiti avevano diritto a un massimo di 91 milioni di euro all’anno: 63,7 milioni come rimborso spese elettorali, e 27,3 milioni come cofinanziamento per quote associative ed erogazioni liberali ricevute. Inoltre, il 26 percento delle erogazioni liberali ai partiti erano detraibili dall’ imposta dovuta.
LE NOVITA’ PRINCIPALI DELLA LEGGE.
1) elimina i rimborsi delle spese elettorali dal 2017 (li riduce del 25 percento ogni anno fino ad arrivare a zero nel 2017).
2) innalza dal 26 al 37 percento la detrazione per le erogazioni liberali fino a 20.000 euro (la stragrande maggioranza).
3) consente al contribuente di destinare a un partito il 2 per mille della propria imposta.
L’ interpretazione universale è che, dal 2017, i partiti non prenderanno più un euro dallo Stato, e dovranno sopravvivere solo con contributi privati. Questa interpretazione è falsa: vediamo perché.
QUANTO RICEVERANNO ORA I PARTITI?
La prima cosa da notare è che i soldi ricevuti dai partiti attraverso il 2 per mille non sono un regalo deciso da privati: sono a carico di tutti i contribuenti. Il motivo è che il 2 per mille è di fatto una detrazione al 100 percento dall’ imposta dovuta. Se lo stato raccoglieva 10.000 euro in tasse per pagare sanità e pensioni, e ora un contribuente destina 1 euro a un partito attraverso il 2 per mille, tutti i contribuenti nel loro complesso dovranno pagare 1 euro di tasse in più per continuare a pagare pensioni e sanità.
L’ art. 12, comma 12 della legge autorizza una spesa massima per il 2 per mille ai partiti pari a 45 milioni dal 2017. E’ plausibile che venga toccato questo tetto? Gli iscritti totali ai partiti sono probabilmente circa 2 milioni (nel 2011 gli iscritti al PdL erano 1 milione, quelli al PD mezzo milione). Non tutti gli iscritti ai partiti pagano l’ Irpef, e non tutti sceglieranno il 2 per mille. Tuttavia, dall’ esperienza analoga dell’ 8 per mille sappiamo che, quando il costo è zero, una percentuale notevole dei contribuenti esercita la scelta. Una stima prudenziale suggerisce quindi che il gettito del 2 per mille potrebbe essere tra i 20 e i 30 milioni.
L’ art. 11 della legge, comma 9, prevede che le detrazioni per erogazioni liberali siano di circa 16 milioni a partire dal 2016. Si noti che la legge consente di detrarre anche il 75 percento (!) delle spese per partecipazioni a scuole o corsi di formazione politica. Nella colonna 1 della tabella sottostante assumo uno scenario prudenziale: le detrazioni saranno la metà del previsto, cioè solo 8 milioni, e il gettito del 2 per mille di 20 milioni. Il costo totale per il contribuente sarà di quasi 30 milioni. Nella colonna 2 assumo uno scenario intermedio: la previsione del governo sulle detrazioni, 16 milioni, è rispettata, e il gettito del 2 per mille è di 30 milioni. Il costo al contribuente è in questo caso è di circa 45 milioni. Nella colonna 3 assumo uno scenario normale: la previsione del governo sulle detrazioni, 16 milioni, è rispettata, e il gettito del 2 per mille è di 45 milioni. Il costo al contribuente è in questo caso è di circa 60 milioni!
IL TETTO MASSIMO DEL 2 PER MILLE.
C’è poi un meccanismo molto complicato, ed egualmente insensato (e quasi certamente non compreso neanche da chi ha scritto e votato la legge). Per il comma 11 dell’ art. 11, se le detrazioni per elargizioni liberali sono inferiori a 16 milioni, la differenza verrà aggiunta al tetto di spesa per il 2 per mille. Quindi di fatto in questo caso il tetto massimo del 2 per mille può arrivare a 61 milioni invece di 45. Poiché non sappiamo come reagiranno i contribuenti alla opzione del 2 per mille, questo è un modo per assicurarsi che, se c’è molta richiesta per il 2 per mille e poche elargizioni liberali, la richiesta del 2 per mille non vada “sprecata” dal tetto di 45 milioni.
Si noti infine che le detrazioni per erogazioni liberali sono pratica comune, ed esistono già anche in Italia. Ma i partiti si sono elargiti detrazioni quasi doppie di quelle consentite, per esempio, per le erogazioni a università e centri di ricerca (che sono al 19 anzichè al 37 percento). Inoltre questa legge, senza che questo sia stato notato da nessuno, innalza l’aliquota di detraibilità già presente nella legge Monti.
Secondo Wikipedia, nel 2007 il 43 percento dei contribuenti ha effettuato una scelta ed il 37 percento ha scelto la Chiesa Cattolica, anche se la percentuale di praticanti è molto inferiore; lo 0.89 percento dei contribuenti ha scelto la Chiesa Valdese, quindi presumibilmente quasi la totalità dei contribuenti valdesi. E’ quindi probabile che la quasi totalità degli iscritti sceglierebbe di destinare il 2 per mille al loro partito, visto che il costo è 0. Per prudenza, diciamo 1,7 milioni. Di questi, non tutti pagheranno l’ Irpef. Supponiamo dunque che 1,3 milioni di iscritti ai partiti paghino l’ Irpef e destinino il 2 per mille al partito. Supponiamo che 700.000 simpatizzanti non iscritti facciano lo stesso. Nel 2011 l’ imposta Irpef netta è stata di 152 miliardi, con 31,5 milioni di contribuenti. Se i 2 milioni di contribuenti che destinano il 2 per mille ai partiti hanno la stessa composizione media dell’ universo dei contribuenti, il gettito del 2 per mille sarebbe di quasi 20 milioni. Se a devolvere il 2 per mille saranno 3 milioni, il gettito sarà di circa 30 milioni.
"Questa legge è una presa in giro sfacciata e colossale, scrive sul suo blog Beppe Grillo. Passata sulla stampa di propaganda del governo come "Abolizione del finanziamento pubblico", significa invece: "Continuerete a pagare, come prima e persino più di prima".
Cosa ancora più grave, questa legge consegna ufficialmente la politica nelle mani dei grandi potentati economici, delle lobby e persino delle associazioni criminali che sono sempre alla ricerca di nuovi e più redditizi canali di riciclaggio del denaro sporco. Ecco come funziona:
1 - Non sono tutti uguali. Ci sono partiti che possono iscriversi nell'apposito registro e accedere al finanziamento e partiti o "movimenti politici" che non possono (indovinate chi? Per fortuna, dei soldi ce ne infischiamo).
2 - A pagare continua a essere lo Stato. Entrando in vigore nel 2014, i partiti continuano a ricevere dallo Stato 91 milioni di euro il prossimo anno; 54milioni 600mila nel 2015; 45milioni e mezzo nel 2016 e circa 36milioni 400mila nel 2017. A queste somme si aggiungono le donazioni dei cittadini così si fa "stecca para pé tutti".
3 - I cittadini possono devolvere il 2 per mille dell'Irpef ai partiti. Anche in questo caso pagano tutti, perché le minori entrate nelle casse dello Stato devono essere coperte da quelli che non "donano" con le solite tasse. Non solo: lo Stato istituirà un "fondo apposito" che coprirà tutte le "donazioni" che i cittadini si guarderanno bene dal fare. Sia mai che i partiti ci rimettano!
4 - Il Paese in mano alle lobby: 300mila euro all'anno per le persone fisiche e 200mila euro annui per le persone giuridiche sono i tetti per le donazioni liberali. Sanzioni se si supera tale limite? Una multa. Se non la si paga, il partito perde il gettito del 2 per mille per i tre anni a seguire (sai che danno...). I partiti possono donare quanto vogliono ad altri partiti, così le "coalizioni" diventano patti d'acciaio firmati sugli assegni.
5 - I benefici si allargano alla platea di partiti che si riferiscono a un gruppo parlamentare già costituito: così, chi fonda un partito oggi a elezioni avvenute (avete qualche idea? noi sì) o partitucoli di voltagabbana avranno comunque garantiti i vostri quattrini.
6 - Trasparenza e sanzioni per irregolarità? Dimenticate. Non presentano il bilancio? Succede nulla. Niente verbali e relazioni? Nulla. Dove vanno a finire i nostri soldi ai partiti? Ancora e sempre nel misterioso buco nero.
7 - Chi effettua donazioni ai partiti può beneficiare di sgravi fino al 52%. E chi copre queste minori entrate per le casse dello Stato? Cominciate a tirar fuori i portafogli." M5S Camera
"I finanziamenti ai partiti sono stati introdotti nel 1974. In 40 anni il contributo ha assunto decine di nomi differenti, ma la sostanza non è mai cambiata: si tratta sempre di soldi dei cittadini italiani andati a finire nelle tasche dei politici e nelle casse dei partiti! Si tratta sempre dei nostri soldi. In barba alla volontà popolare espressa con il referendum del 1993. Noi abbiamo chiesto l'abolizione totale del finanziamento pubblico ai partiti sin da subito e la restituzione integrale delle somme percepite dal '97 ad oggi, con possibilità di intervento, in caso di diniego, da parte della Magistratura tramite sequestri dei beni e delle liquidità appartenenti ai partiti. Tre semplici emendamenti che avrebbero portato immediatamente nelle casse dello Stato 2 miliardi e mezzo di euro! Sono stati tutti bocciati! I fatti parlano chiaro: il pd di Renzi è a favore del finanziamento pubblico ai partiti, così come Forza Italia e tutte le altre forze politiche. Restituite subito i 2 miliardi e mezzo di euro che avete rubato agli italiani!" Maurizio Santangelo, capogruppo M5S Senato
LO SPRECO DELLA CARTA PARLAMENTARE.
I parlamentari spendono ogni anno 7 milioni in carta. La voce più grande è la spesa per la stampa degli atti parlamentari. Ogni anno mettere a disposizione dei deputati copie cartacee di leggi, decreti ed emendamenti ci costa oltre 5 milioni di euro, scrive Emanuele Bellano di inforeportime.it su “Il Corriere della Sera”. Ottantottomila seicento euro: tanto ha speso nel 2013 la Camera dei Deputati per acquistare giornali e riviste per il collegio dei questori. Si tratta di un esercito di lettori, si potrebbe pensare. In realtà no, il collegio è composto da tre persone: Stefano Dambruoso di Scelta Civica, Paolo Fontanelli del Partito Democratico e Gregorio Fontana di Forza Italia. Sono 29.500 euro a testa ogni anno, ovvero 82 euro al giorno, solo in quotidiani e periodici. La cifra, nero su bianco, i tre questori l’avranno vista di sicuro dato che sono proprio loro a elaborare il bilancio della Camera e a controllare che alla fine non ci siano spese folli. Non stupisce quindi che non abbiano notato nemmeno quanto spende la Camera ogni anno per le letture dei loro colleghi parlamentari. A carico dei contribuenti ci sono infatti anche i quotidiani e le riviste che finiscono tutti i giorni sulle scrivanie degli altri deputati: in totale 165 mila euro. Forse la produttività del Parlamento è così scarsa perché gli onorevoli passano tutta la giornata a leggere giornali? Questa spesa tuttavia è poca cosa rispetto a quanto la Camera spende ogni anno per la carta. Sommando tutte le voci di bilancio la cifra nel 2013 arriva a 6 milioni di euro; dentro ci sono 388 mila euro per i vari tipi di carta e per materiali di cancelleria, e 30mila euro solo per consulenze su come stampare o rilegare i documenti. La voce più grande però è la spesa per la stampa degli atti parlamentari. Ogni anno mettere a disposizione dei deputati copie cartacee di leggi, decreti ed emendamenti ci costa oltre 5 milioni di euro. Eppure, per facilitare l’uso di documenti in formato digitale e ridurre le copie cartacee, il parlamento ha messo a disposizione di senatori e deputati un fondo per l’acquisto di tablet, computer e altre attrezzature informatiche: 2.500 euro a legislatura per ogni deputato, 4.000 euro per i senatori, in totale 2,7 milioni di euro. I parlamentari però non devono ancora avere grande dimestichezza tecnologica. Per Stefano Fassina del Partito Democratico, non si può lavorare senza carta e penna. “Non sono sicuro che siano completamente sostituibili perché a volte è necessario scrivere sui documenti. Io quando studio un provvedimento di legge prendo appunti, scrivo, metto in mezzo gli emendamenti. Non è proprio la stessa cosa”. In effetti, scrivere un appunto o un emendamento su un tablet è cosa diversa…bisognerebbe saperlo usare. Se Montecitorio spende, qualcuno ovviamente incassa. La stampa degli atti parlamentari è affidata dalla Camera dei Deputati agli Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo. Nel 2013 la Tipografia Colombo per questo servizio ha ricevuto 5 milioni 139 mila euro a cui si sono sommati altri 2 milioni 700 mila euro per il servizio di digitalizzazione degli stessi documenti. In totale la tipografia Colombo riceve ogni anno dalla Camera 7 milioni 800 mila euro. Ma come è stata scelta la società? “Abbiamo fatto una domanda scritta per capire come è stato assegnato l’appalto – ha detto Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle. Non ci hanno ancora risposto. Le posso dire che finora a queste domande relative ad altri ambiti ci hanno sempre detto che la gara è stata assegnata direttamente. Diciamo che al 90 per cento l’appalto è stato dato ad assegnazione diretta”. I rapporti tra la Tipografia Colombo e la Camera dei Deputati non si limitano alla stampa dei documenti. Tra gli immobili presi in affitto dalla Camera c’è l’edificio di via Uffici del Vicario dal numero 9 al numero 15 e un ufficio in via Campo Marzio al numero 69. Il primo è di proprietà della Cosarl Srl, il secondo della Immobiliare Centro Storico Srl. Entrambe le società appartengono alla famiglia Colombo che così ogni anno riceve dalla Camera altri 1,2 milioni di euro. Un legame che dura da più di vent’anni. Sul primo contratto di locazione risalente al 1987 viene puntualizzato: “la Cosarl ha ottenuto dal Comune di Roma l’autorizzazione per lavori di consolidamento, modifiche interne e manutenzione straordinaria” dell’edificio in via Uffici del Vicario. Chi ha pagato la mega ristrutturazione? Il gruppo Colombo proprietario dell’edificio? Ovviamente no, l’affittuario: la Camera dei Deputati.
IL PAESE DELLE STAZIONI FANTASMA.
#Pendolando, il Paese delle stazioni fantasma. Progetti faraonici mai aperti, biglietterie chiuse, nemmeno i bagni. Mentre si spendono centinaia di milioni di euro per rilanciare gli scali delle metropoli con ristoranti, librerie e servizi, fuori dalle città le piccole e medie stazioni sono praticamente abbandonate. Ecco cosa risulta dalle vostre segnalazioni al nostro database, scrive Michele Sasso su “L’Espresso.
L’ABBANDONO DELLE STAZIONI. Oltre ai binari, l’incuria. Progetti faraonici per scali ad alta velocità mai aperti, biglietterie chiuse da anni, bagni rotti e zero servizi: le cattedrali nel deserto della mobilità sono lo specchio di come, per tagliare i costi, centinaia di stazioni sono destinate al lento degrado. Mentre si spendono centinaia di milioni di euro per rilanciare gli scali delle metropoli con ristoranti, librerie e servizi pensati per i viaggiatori, fuori dalle città è meglio non guardare. Dalla Campania a Padova è una discesa negli inferi di sale d’aspetto sbarrate, nessun confort per chi parte e arriva e senza tetto che trovano riparo.
L’ALTA VELOCITA' È UN MIRAGGIO. Il caso-limite è la stazione fantasma dell’alta velocità di Afragola, a Nord di Napoli. Faceva parte di un disegno strategico più ampio: era destinata a diventare una sorta di hub del trasporto ferroviario, il nodo cruciale del collegamenti fra Nord e Sud, con le evidenti ricadute sulla piccola cittadina. Disegnata dall’archistar Zaha Hadid, costata 170 milioni, posata la prima pietra nel 2010 dall’ex ministro azzurro Altero Matteoli con la promessa dell’entrata in servizio nel 2011, oggi è ancora un cantiere. Una carcassa di ferro, cemento e polvere, piloni che si perdono nel vuoto, strade sterrate e impalcature ovunque che lasciano intuire il destino dell’ennesima incompiuta napoletana. Il sogno di macinare treni e passeggeri avvicinando la sterminata periferia a Napoli e Roma è ancora lontano. Ora per arrivare nella capitale ci vogliono più di due ore. E i tempi di consegna dell’infrastruttura continuano ad allungarsi: un altro anno e mezzo, arrivando al 2015 per completare finalmente lo snodo, ha annunciato il sindaco a dicembre.
OLTRE IL GRA L’OBLIO. Edifici distrutti dal tempo, mancanza di parcheggi di scambio, scali diventati dormitori e ogni possibile disagio. Ecco la caduta nell’oblio della Capitale, appena superati i confini del Grande Raccordo Anulare, nel racconto di Patrizia: «I collegamenti con l’aeroporto di Fiumicino sono un disastro sotto tutti gli aspetti: le fermate sono diventate spesso un bivacco per senza tetto, pensiline corte e attese senza riparo dalla pioggia, annunci incomprensibili, cartelli inesistenti. Alla stazione poi non ci sono le panchine per i passeggeri, idem per l’orologio, annunci in un inglese risibile. E la presenza di due treni, uno per i ricchi (il Leonardo Express) e l'altro (il regionale) per i poveracci dove regna la confusione con gli stranieri sempre disorientati». L’elenco di quello che non funziona continua nelle altre fermate della città eterna: «Non ci sono biglietteria ed erogatrici, non ci sono servizi di ristoro, né tantomeno personale ferroviario e servizi igienici nella stazione Nomentana della linea locale, frequentatissima e situata in un'area densamente abitata della città». Ancora più degradata è la condizione della stazione Due Ponti, sulla linea gestita dall’Atac che porta a Viterbo. I pendolari che ogni giorno l’affollano meriterebbero rispetto, ma invece non sanno neanche quando quella nuova (ormai pronta) sarà aperta.
SENZA BIGLIETTERIA FIOCCANO LE MULTE. I paradossi di tanta incuria diventano evidenti. Come testimonia Rocco nel suo viaggio tra Eboli e Salerno: «In tutta la Regione Campania non esistono nelle stazioni le locandine con l'orario di apertura dei punti vendita nelle vicinanze, e nemmeno un distributore. Impossibile comprare il biglietto. Risultato? Salito sul treno il controllore mi ha multato pur avendo fatto diritto al rilascio del ticket a bordo, senza sovrapprezzo. Dopo mesi l’amara sorpresa: ho ricevuto una raccomandata da Trenitalia che mi ingiunge il pagamento di 107,37 entro 15 giorni. Ho presentato ricorso al Giudice di Pace». Spesso i controllori non vogliono sentire ragione. Di chi è la colpa? In Veneto stesso irragionevole disservizio. Alle porte di Padova, sulla traffica linea Milano-Venezia, è stata costruita la fermata ferroviaria di Ponte di Brenta invasa da centinaia di pendolari al giorno. C’è però un particolare: mettersi in regola con il biglietto è impossibile. Ecco come si presenta: «L’obliteratrice si trova in mezzo a una giungla, sotto le scale, dopo la casetta mezza distrutta dai vandali. Ovviamente non era non funzionante. Detto ciò non ho avuto modo di obliterare e non essendoci personale e nemmeno una biglietteria sono salita con due biglietti andata e ritorno. Fermata dal controllore sono stata multata di 50 euro con pagamento anticipato di 30. Durante il ritorno, oltre il danno la beffa: due clienti sono senza biglietto e il controllore lo oblitera e gli ricorda che dovevano farlo prima di salire. Perché queste differenze?».
IL PARLAMENTO DEI POMPINI E DELLE BOTTE DA ORBI.
Senato, 5 giorni di sospensione per Barani e D’Anna: «Gesti osceni». La decisione dell’ufficio di presidenza del Senato. «Da questo momento nessuna deroga al principio di correttezza verrà tollerato in Aula», ha annunciato Grasso, scrive Valentina Santarpia su “Il Corriere della Sera” il 5 ottobre 2015. Cinque giorni per ciascuno di sospensione dai lavori dell’Aula del Senato sono stati comminati ai senatori Lucio Barani e Vincenzo D’Anna dal Consiglio di Presidenza di palazzo Madama: la sospensione partirà da oggi. L’ufficio di presidenza, chiamato ad esaminare il gesto sessista in Aula venerdì scorso, ha lavorato per oltre tre ore, esaminando tutti i filmati della seduta, per prendere una decisione. Gli episodi accaduti nella seduta di venerdì scorso in Senato sono stati «di tale gravità» che «hanno offeso persone e senatori» ed hanno «minato la credibilità delle istituzioni», ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, annunciando in aula le sanzioni decise per il caso Barani. E un giorno di sospensione è stato inflitto al Cinque Stelle Alberto Airola, accusato di aver insultato alcuni esponenti del governo e della segreteria d’Aula. Il Consiglio di presidenza ha inoltre comminato la sanzione della censura nei confronti del capogruppo M5S Gianluca Castaldi e nei confronti dell’intero gruppo della Lega nord e ha deciso di riconvocarsi per valutare altri episodi verificatisi in quella seduta. «Da questo momento nessuna deroga al principio di correttezza verrà tollerato in Aula», ha annunciato Grasso. «Siamo stati condannati in contumacia, senza alcuna prova. Il presidente del Senato è solo chiacchiere e distintivo, è incapace. Può fare il magistrato non la politica», è la reazione di D’Anna, intervistato a La zanzara. «Grasso consente da due anni che i Cinque Stelle offendano le istituzioni. E poco prima hanno dato della prostituta alla Boschi. Vogliamo che siano esaminati tutti i video, tutti. Grasso non tiene l’aula - dice ancora D’Anna alla Zanzara - che è diventata un far west per colpa dei grillini. L’ho informato che avevo mimato un gesto fatto dalla senatrice Lezzi ma lui se ne è lavato le mani come Ponzio Pilato, facendo punire i due senatori fetenti». La decisione è arrivata dopo le denunce delle colleghe del Movimento Cinque Stelle, Barbara Lezzi e Paola Taverna: i filmati confermano i gesti osceni all’indirizzo delle colleghe pentastellate. «Finalmente si è ripristinata un po’ di verità, perché sia Barani che D’Anna in questi giorni hanno mentito spudoratamente. Si vede che in presidenza i video girati in Aula hanno dimostrato come stavano le cose, e che i gestacci sessisti denunciati non li avevamo certo immaginati»: è il commento a caldo di Barbara Lezzi, la senatrice M5S a cui erano diretti i gesti dei due colleghi verdiniani di Ala. «Noi ora, come gruppo parlamentare - prosegue la senatrice grillina, al quinto mese di gravidanza - vorremmo superare questa vicenda, lasciarcela alle spalle». La senatrice Taverna però insiste: «Mi aspetto scuse, dovute, quando rientreranno in Aula». Secondo la capogruppo dei Conservatori e riformisti Cinzia Bonfrisco si è trattato invece una «decisione troppo timida». E anche la senatrice questore Laura Bottici ritiene si tratti di una sanzione troppo leggera: «Per un fatto così grave non ha senso, è assurdo, non c’è più una scaletta». Il senatore Vincenzo D’Anna, che ha imitato il gesto incriminato, continua invece a difendersi: «La prima a fare un gestaccio in aula al Senato è stata la senatrice 5 Stelle Barbara Lezzi, proprio quella che ora si atteggia a vergine e a martire». «Noi stavamo ascoltando il senatore Falanga che parlava, mentre il gruppo 5 stelle faceva intemperanze e boccacce, in primis a comportarsi così era proprio la senatrice Lezzi. Ecco qual è la dinamica, non è che Barani è psicopatico». Però a quel punto Barani il gestaccio lo ha fatto. «Dicono. Vedremo se c’è il filmato, ma se ci fosse lo avrebbero già trovato». Lei è accusato di aver fatto un gesto simile. «No, io ho indicato la Lezzi con il dito dicendo che aveva fatto un gestaccio», ha precisato D’Anna a Radio2. Indignato dalla decisione dell’ufficio di presidenza anche Airola: «È una squallida rappresaglia contro il Movimento 5 stelle» mentre su Barani e D’Anna «sono stati pietosi». «C’è uno squilibrio totale», dice Airola.
Eva contro Eva, oggi, a Villa Arzilla! Scrive “Dagoreport” Dietro la lieve condanna dei due verdiniani sessisti, Barani e D'Anna, c'è la dolce mano delle 5 senatrici Pd che fanno parte dell'ufficio di presidenza. Mentre la questora a Cinque Stelle, Laura Bottici, e la capogruppo dei fittiani, Cinzia Bonfrisco, partivano lancia in resta contro la volgarità maschilista dei due esponenti di Ala, pretendendo una severa condanna, le 5 gentili democratiche (2 vicepresidenti e 3 segretarie, praticamente un terzo dei 16 componenti dell'ufficio di presidenza, Grasso escluso) facevano quadrato intorno ai reprobi, chiedendo piuttosto, per par condicio, l'incriminazione dei grillini che in aula avevano dato della ... ehm ehm... "prostituta" al ministro Boschi, e non solo a lei, nelle più svariate occasioni. La loro requisitoria è stata respinta dal presidente Grasso, che da magistrato ha invocato prove (video e/o verbali) del presunto fattaccio e nell'attesa si è attenuto rigidamente al processo in corso. Il processo, come si sa, è poi finito con una sentenza molto mite: 5 giorni di sospensione ai due sessisti (e uno al grillino, Airola, che in aula si scalda troppo). Vale la pena di notare che a spendersi a muso più duro contro le proteste femministe delle colleghe Bottici e Bonfrisco non sono stati i maschi, più o meno di centrodestra, ma le due vicepresidenti Pd. Tutt'e due renziane, casualmente di ferro, i cui mariti, altrettanto casualmente, frequentano molto palazzo Chigi. Una è Valeria Fedeli, ex Cgil, moglie di un sindacalista ex senatore Pd, Achille Passoni, che oggi è capo della segreteria tecnica del sottosegretario Minniti a palazzo Chigi. L'altra è l'eterna Linda Lanzillotta, ex Margherita, ex Scelta Civica, oggi Pd, moglie dell'ex presidente di Cdp, nonché ex parlamentare ed ex ministro Franco Bassanini. Bassanini, guarda caso, oggi è consigliere economico di Renzi a Palazzo Chigi. E' inutile ricordare che al suddetto Renzi stanno molto a cuore i voti dei senatori verdiniani per riuscire a portare a casa la sua gigantesca supercazzola costituzionale, e che una sospensione troppo lunga dei due gli avrebbe creato non pochi grattacapi. Ora i grattacapi non ce li ha più. Un bacino alle donne del Pd.
La doppia morale grillina: il vaffa è giusto, i gestacci no. Scandalizzate contro Barani le senatrici più volgari del Parlamento, scrive Brunella Bolloli su “Libero Quotidiano”. BIOGRAFIA: Alessandrina, vivo a Roma dal 2002. Ho cominciato a scrivere a 15 anni su giornali della mia città e, insieme a un gruppo di compagni di liceo, mi dilettavo di mondo giovanile alla radio. Dopo l'università tra Milano e la Francia e un master in Scienze Internazionali, sono capitata a Libero che aveva un anno di vita e cercava giovani un po' pazzi che volessero diventare giornalisti veri. Era il periodo del G8 di Genova, delle Torri Gemelle, della morte di Montanelli: tantissimo lavoro, ma senza fatica perché quando c'è la passione c'è tutto. Volevo fare l'inviata di Esteri, ma a Roma ho scoperto la cronaca cittadina, poi, soprattutto, la politica. Sul blog di Liberoquotidiano.it parlo delle donne di oggi, senza filtri. Da donna dovrei scandalizzarmi all'inverosimile e dire che il senatore Lucio Barani è un losco personaggio, misogino e volgare, che non merita di mettere più piede a Palazzo Madama. Invece non lo dirò, non perché io voglia difendere il senatore non più in età adolescenziale, che neppure conosco e che comunque è stato un pollo e ha sbagliato, ma perché bazzicando spesso il Parlamento penso che non sia lui il solo protagonista delle onorevoli oscenità che si vedono in giro. Fa quasi ridere, poi, che a fomentare il coro delle indignate siano esponenti della truppa dei miracolati grillini che si sono fatti largo nella casta a suon di Vaffa, grida isteriche, insulti verso tutti e palate di dito medio alzato contro gli avversari politici. Una su tutte: la simpatica borgatara Paola Taverna, che è passata da gentilezze tipo: <Io a quello je sputo>, riferito all'allora ex premier Berlusconi, a sproloqui al limite della querela contro Renzi e altri del Pd, ma fossero anche Ncd o Fi poco importa: l'importante è fare casino. E dal casino al bordello, agli insulti sessisti, è un attimo: non erano forse gli onorevoli colleghi del Movimento Cinquestelle ad avere dato delle <pompinare> alle deputate Pd nel momento in cui non erano così sensibili al bon ton come oggi, ma si mostravano in tutta la loro infantile aggressività di novizi della politica. I quali, non sapendo come si fa nel Palazzo e quali strategie politiche usare contro gli odiati partiti per farsi notare, sono partiti di insulto libero, gestacci e assalti ai banchi del governo, per non parlare delle palate di minacce e improperi della Rete (filogrillina) contro la Boldrini accusata di faziosità nella gestione dei lavori d'Aula a Montecitorio. Ecco, adesso che sono diventati "casta" anche loro, i Cinquestelle in versione lord inglesi fanno le vittime. Ce ne ricorderemo alla prossima battuta sessista di Grillo e al prossimo gestaccio dei suoi.
Ieri lo schifoso gesto di Barani, che dimostra la profondità di pensiero e parole dei verdiniani. Prima, insulti e diti medi rivolti ai grillini alla Camera. E le sciocchezze dell'onorevole grillino De Rosa, denunciato per ingiurie, scrive “Next Quotidiano”. Ieri abbiamo ammirato in che modo i verdiniani di ALA siano pronti a far parte del treno delle riforme del Partito Democratico grazie all’elegante gesto del senatore Lucio Barani, che ha mimato una fellatio all’indirizzo della senatrice del MoVimento 5 Stelle Barbara Lezzi. Per Barani le sanzioni vanno dal semplice richiamo all’interdizione, non superiore ai 10 giorni, dai lavori d’Assemblea. Ad un paio d’ore dal caos innescato dal suo gesto, il capogruppo di ALA ha provato a giustificarsi. “Sono veramente dispiaciuto di ciò che sta accadendo in ragione di un equivoco ingenerato da alcuni miei gesti istintivi”, ha esordito spiegando come “con la mano rivolta verso il mio stesso volto invitavo quanti impedivano l’intervento del senatore Falanga ad ingoiare i fascicoli che tanto veementemente stavano sventolando”. Diversa, invece, l’interpretazione di chi ha visto, e stigmatizzato con veemenza già in Aula, Barani mimare un gesto che, secondo quanto raccontato da diversi senatori, in particolare del M5S e Lega, faceva chiaro riferimento a un rapporto di sesso orale. E’ l’articolo 67 del Regolamento del Senato, invece, a prevedere che , nel caso un senatore “trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità”, il presidente del Senato possa proporre all’ufficio di Presidenza l’esclusione dall’Aula per non più di dieci giorni. Il senatore, prevede lo stesso articolo, può fornire le proprio spiegazioni all’Ufficio di presidenza ma la decisione di questo organismo non può essere discussa dall’Aula. Nelle prossime ore le telecamere che riprendono quanto accade in Aula saranno visionate e le immagini potrebbero anche essere valutate dall’ufficio di presidenza di lunedì, proprio come accade in occasione della protesta delle ‘mani nere’ inscenata dal M5S durante la discussione dello Sblocca Italia. Mentre più di un senatore, nei minuti del caos in Aula, fa notare in Transatlantico come quello di Barani non sia stato un ‘unicum’, ricordando, ad esempio, il “dito medio” mostrato da alcuni esponenti dell’opposizione al ministro Maria Elena Boschi. C’è poi questo video pubblicato a settembre dal M5S della Camera che mostra Luciano Agostini (Pd) mentre rivolge parole offensive, accompagnate da un gestaccio (il classico dito medio), rispondendo a qualcuno in aula. E non finisce mica qui. «Voi donne del Pd siete qui perché siete brave solo a fare i pompini», disse nel gennaio 2014 Massimo Felice De Rosa del Movimento 5 Stelle alle colleghe democratiche in Commissione giustizia alla Camera. Parole che hanno spinto alcune deputate a querelarlo per ingiuria. Tutto è accaduto nella serata del 29 gennaio, quando alle 21 era stata convocata la commissione “per la discussione e votazione sugli emendamenti al decreto 146/13″, che riguarda i “diritti fondamentali dei detenuti e la riduzione controllata della popolazione carceraria”. Le parlamentari che hanno sporto denuncia hanno spiegato ai pubblici ufficiali che “i deputati del Movimento 5 Stelle impedivano il regolare svolgimento dell’attività parlamentare, bloccando i lavori della Commissione e occupando l’aula stessa”. Lui all’epoca replicava così: “Dicono il falso. Ho detto che qua dentro [in commissione, ndr] sono entrati solo perché conoscevano qualcuno di importante o avevano fatto qualche favore sessuale. Mi riferivo a tutti: uomini e donne. Non mi riferivo a nessuno in particolare, neanche alla Moretti”. De Rosa parlò anche con le Iene ammettendo di aver detto la frase, e spiegando anche nell’occasione che era rivolta a uomini e donne e da intendersi in senso metaforico. Della denuncia non si è più saputo nulla.
Dopo l’immonda sceneggiata di qualche giorno fa a Palazzo Madama il senatore Vincenzo D’Anna spiega che il gesto del pompino che lui ha rivolto verso i banchi dell’opposizione è stato male interpretato:
Lei ha fatto un gestaccio in Aula e Barani si è esibito in un atto ancora più volgare.
«Ho invitato Barani a scusarsi, perché il suo gesto è stato malamente interpretato. Ma è difficile chiedere scusa a chi usa parole da trivio».
Allude ai cinquestelle?
«Fanno una gazzarra indegna, ci danno dei poltronari e parassiti sociali. Il gestaccio lo ha fatto la Lezzi a Barani e io l’ho mimato. Le cosiddette signore fanno ben peggio di noi e Grasso lo consente». Lei non rispetta neanche il presidente del Senato? «Se invece di fare il finto tonto ponesse dei limiti, non spunterebbero cartelli e non si griderebbero licenziose offese. Non padroneggia l’assemblea e la gente finisce per irritarsi».
I senatori fanno gli ultrà e la colpa è dell’arbitro?
«La bagarre nasce sempre con Grasso o Lanzillotta, mai con Gasparri o Calderoli. Su quello scranno serviva un politico, non un giudice antimafia». Voi verdiniani avete varcato il limite della decenza? «Siamo fatti di carne e ossa anche noi senatori. E poi ormai gli organi sessuali sono diventati interpunzioni nel linguaggio di tutti».
Voi siete padri costituenti…
«Certo! Anche quando la Taverna chiama prostituta la Boschi, o quando Castaldi mi dà del parassita sociale. Io dichiaro 750 mila euro, lui non arriva a 15 mila… I parassiti sono loro. Pupi nelle mani di Grillo e Casaleggio».
Insulti sessisti, Pini: «Quelli grillini altrettanto gravi». Nel 2014 De Rosa accusò le colleghe del Pd di essere in parlamento solo grazie a dei favori sessuali. Pini: «Il Movimento non prese le distanze», scrive Gabriele Lippi su "Lettera 43”. Indignati e arrabbiati, a urlare e puntare il dito contro il senatore di Ala Lucio Barani, tutti a invocare il rispetto per le donne e le scuse per un bruttissimo gesto misogino. Il Movimento 5 stelle è apparso così, venerdì 2 ottobre 2015, in Senato: compatto nel condannare l’insulto rivolto alla loro collega Barbara Lezzi da Barani. Eppure tra le file grilline c’è un deputato che in un passato recente ha rivolto lo stesso genere di insulti alle colleghe del Partito democratico. Era il 29 gennaio 2014, in commissione Giustizia alla Camera si discuteva degli emendamenti al decreto 146/13, un testo sui diritti dei detenuti e la riduzione della popolazione carceraria. Il Movimento 5 stelle era impegnato in una delle sue azioni di ostruzionismo, tentò di occupare l’aula, e il deputato Massimo Felice De Rosa accusò tutte le colleghe dem di essere lì solo perché «brave a fare i pompini». Per quella frase, De Rosa è stato querelato. Tra le firmatarie della denuncia c’è anche l’onorevole Giuditta Pini, modenese classe 1984: «Barani è una persona poveretta se è vero ciò di cui è stato accusato», ha commentato a Lettera43, ma «non è la prima volta che il dibattito dentro il parlamento si riduce a insulti da tifoserie di terza categoria. Succede quotidianamente». Per fortuna, aggiunge, «non sono quotidiani gli insulti sessisti, ma quel giorno, mi ricordo bene, De Rosa disse che gli uomini del Pd erano lì perché mafiosi e le donne perché brave a fare i pompini». Il deputato pentastellato smentì le circostanze, o meglio, precisò di aver parlato di favori sessuali senza far distinzione tra uomini e donne. Ma l’onorevole Pini puntualizza: «Inizialmente confermò tutto, solo dopo ritrattò, forse consigliato dai suoi avvocati». E il Movimento 5 stelle? «Non prese le distanze». Da questo nuovo caso, da questa indignazione sollevata dal gesto di Barani, Pini si augura che si possa trarre insegnamento: «Nessun insulto è accettabile, a prescindere da chi lo fa e chi lo subisce. I loro insulti non sono meno gravi. Speriamo, al ritorno in parlamento, di non sentirci ancora definire mafiosi e ladri dai colleghi del Movimento 5 stelle».
Quel vizio grillino della doppia morale. Gli M5s si indignano per Barani. Ma il leader ritwitta insulti omofobi a Vendola, scrive Paolo Madron su “Lettera 43”. La senatrice grillina Barbara Lezzi giustamente si indigna, e con foga invita il malcapitato a scusarsi e il presidente Grasso a prendere provvedimenti. Il malcapitato è Lucio Barani, ex socialista arruolatosi poi con le truppe berlusconiane, e approdato di recente con i transfughi verdiniani di Maiala (omen, nomen), acronimo derivante dalla fusione tra il Movimento italiano degli Italiani all'Estero e l'Ala, l'Alleanza Liberalpopolare per le Autonomie. Barani, in piena bagarre per la riforma del Senato, con Palazzo Madama trasformato in un ring dove i contendenti se le suonavano a colpi di insulti e citazioni pecorecce, rivolto alla rappresentante del Movimento 5 Stelle avrebbe mimato il gesto di un rapporto orale, come a volerla invitare a fare un uso della bocca altro rispetto al proferir parola. Usiamo il condizionale perché il rubizzo senatore ha giurato e spergiurato che con le sue movenze voleva significare tutt’altro. A dirimere la controversia ci penseranno i competenti organi di Palazzo Madama magari, come accade per le manifestazioni sportive, visionando più volte l’episodio alla moviola. Dopo di che sapremo se si tratta di mossa intenzionale o di scellerato fraintendimento. Per amor di cronaca, alcuni dei testimoni non hanno dubbi a sposare la prima interpretazione: trattasi di mimesi di fellatio, quindi l’indignazione delle donne grilline destinatarie di quell’oscenità è sacrosanta. Accade però che quasi in contemporanea alla raffinata performance del Barani, il sommo capo dei 5 stelle retwittasse gli altrettanti raffinati post contro Nichi Vendola che qui riproduciamo: e che come oscenità compete a buon diritto con il gesto dell’esponente di Maiala. Non è la prima volta che Grillo e qualcuno dei suoi si lascia andare a commenti sessisti o omofobi. C’è insomma nel movimento un irresistibile richiamo alla volgarità, una reiterata tendenza a combattere l’avversario politico colpendolo nella sua fisicità (il povero Brunetta ne sa qualcosa) o prendendo di mira le sue tendenze sessuali. Il post è stato poco dopo cancellato, e qualcuno si è subito affrettato a dire che il retweet non veniva dalla mano del capo ma da qualcuno dello staff che gli cura la comunicazione. Il quale, immaginiamo, verrà subito rimosso dall’incarico e cacciato con ignominia. Con tanto di scuse da parte di Grillo, visto che un capo risponde in solido di quel che fanno i suoi sottoposti. Ci piacerebbe che Barbara Lezzi indirizzasse la stessa giusta veemenza con cui si è scagliata contro Barani verso il collega di partito che ha avvallato le gravi offese al leader di Sel. Altrimenti bisognerà dedurne che la doppia morale, retaggio della tradizione comunista, ha contaminato anche la loro pur breve storia politica.
Grillo, l'omofobia, il metodo Boffo e la "macchina del fango" contro Wil, scrive Marco Pratellesi su "L'Espresso". Quando Umberto Eco fu insignito della laurea honoris causa dall'Università di Torino tenne una lezione che fece molto parlare. Soprattutto per il passaggio in cui lo studioso, dopo aver elencato i meriti di internet affermava che “d'altro canto fa sì che dà diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo tre bicchieri di rosso e quindi non danneggiavano la società”. Lo sfogo contro gli “scemi del villaggio” che oggi hanno “lo stesso diritto di parola di un premio Nobel”, ha occupato per giorni il dibattito sui media con interventi, fra gli altri, del sociologo americano Richard Sennett (“La stupidità c'è sempre stata. Però i social media hanno accresciuto l'aggressività”) e del filosofo Maurizio Ferraris (“Non è che nella Roma antica i cretini fossero in proporzione meno di oggi, è che non lasciavano traccia”). Ma siamo sicuri che il problema di internet e dei social media siano gli “scemi del villaggio” o non piuttosto l'uso demenziale, scorretto, inquinato, offensivo che spesso ne fanno quelli che si sentono dall'altra parte della barricata, quelli che “so-tutto-io”, “ora-vi spiego-come-stanno-le-cose”, rappresentanti delle istituzioni e della società civile che vorrebbero dare l'esempio e non perdono occasione per dare il cattivo-esempio (salvo poi lamentarsi per gli “scemi del villaggio”). Prendiamo il caso che ha infiammato la rete nel fine settimana e che ha coinvolto Wil Nonleggerlo. Per chi non lo conoscesse Wil fa una rassegna stampa su Twitter molto seguita e ha una rubrica sull'Espresso, carta e online: lo Stupidario, dove ogni settimana raccoglie le amenità e in alcuni casi gli scivoloni di cui sono prodighi i nostri politici in rete e sui media tradizionali. Ma veniamo al caso. Wil ha subito un tentativo di “linciaggio” sui social da chi lo ha accusato di aver lanciato una sorta di “metodo Boffo” in rete. La sua colpa? Aver rilanciato su Twitter alcuni retweet omofobi di Beppe Grillo sul “baby pensionato” Nichi Vendola. Per farla breve, Grillo, invece di abbandonarla al suo triste destino, ha rilanciato sui social media roba di questo tipo: “#BabyVendola vaffanculo... ah no, ti piacerebbe!!!” (Lamberto Zingarini); “#BabyVendola noi ci rompiamo il culo fino a forse 63 anni di operato, mentre c'è chi si gode a farsi rompere il culo!!”. Ovviamente, Grillo, resosi conto dello scivolone, ha pensato bene di fare sparire i suoi retweet. Errore grave in rete: quando fai uno sbaglio in rete, molto meglio chiedere scusa perché anche se cancelli ci sarà sempre qualcuno che avrà fatto in tempo ad immortalare il tuo sbaglio. Da quel momento sono partite le accuse. Ma non nei confronti dell'omofobia imperante anche tra i notri politici, macché, oggetto del tentativo di sputtanamento è diventato Wil accusato da alcuni fanatici del Movimento 5 Stelle nell'ordine: di aver “fabbricato” ad arte il contenuto (per attaccare Grillo?); di prendere ordini da questo e quell'editore; di essere un “servo di Matteo Renzi”; di essere a libro paga di Nichi Vendola e tanto altro ancora. Ma, cosa ben più grave, qualcuno ha perfino pensato di creare un account fake di Wil dove ha pubblicato tweet a suo nome per poi rilanciare sul social le presunte scuse di Wil: “Guardate, @nonleggerlo si è scusato e poi ha cancellato!”. Un salto di qualità nel dibattito (?) politico non indifferente e non privo di conseguenze: un conto è infatti il classico “chi ti paga?”, altro la fabbricazione di contenuti fasulli per minare la credibilità di una persona. Beppe Grillo avrebbe potuto evitare la pessima figura a se stesso e ai suoi seguaci più fedeli, semplicemente ammettendo l'errore e chiedendo scusa. E invece niente. Anche dai parlamentari del Movimento silenzio assoluto. Ad arrampicarsi sugli specchi il vice presidente della Camera Luigi Di Maio che in un'intervista alla Stampa ha detto che “magari si è trattato di un errore di battitura”. Ma non erano loro, i grillini, che volevano cambiare la politica anche attraverso l'uso della rete? Niente di nuovo, purtroppo, le vecchie abitudini sopravvivono, purtroppo, anche alle migliori intenzioni. Per fortuna il tentativo di delegittimare Wil, per difendere il capo, si è infranto sul flusso, assai più ampio, di solidarietà di chi è sceso in campo a fianco del giornalista lanciando l'hashtag #jesuisnonleggerlo: cittadini, più o meno noti, ma tutti egualmente nauseati da certi metodi, dall'odio, dai comportamenti intimidatori di certi invasati del web. Ecco perché il problema di internet non sono gli “scemi del villaggio”, ma personaggi che apparentemente stanno molto più in alto. Tanto in alto. Perfino in Parlamento. E' il loro esempio che inquina la rete, non chi, pur non essendo un Nobel, ha finalmente trovato un media che permette a tutti di esprimere le proprie idee.
La politica è volgare, proprio come noi, scrive Diego Minonzio su “La Provincia di Como”. E poi dicono che la politica non parla più alla società civile. Non la capisce. Non la ascolta. Non la considera. Non la rappresenta. Pensa, decide e si comporta seguendo traiettorie, codici e linguaggi del tutto altri rispetto a quelli consoni a noi gente qualunque. Ma è vero il contrario. Mai i parlamentari sono stati così identici ai loro elettori e l’episodio di venerdì in Senato – triviale, grottesco, circense – ne ha sancito in via definitiva, plastica l’ormai perfetta sovrapposizione. Noi uguali a loro. Loro uguali a noi. Questa sì che è vera democrazia. Il gesto osceno, dalla mimica straordinariamente sessista, rivolto dal verdiniano Lucio Barani alla grillina Barbara Lezzi mentre stava concludendo il suo intervento, per quanto ancora ipotetico, supposto, favoleggiato e già mitizzato ma non ancora comprovato da video, foto, selfie e droni, segna un punto di svolta definitivo nell’immaginario collettivo del potere. Ora sì che ci sentiamo veramente rappresentati. Ora sì che il palazzo è diventato una casa di vetro. Trasparente. Specchiato. Popolare. Ora sì che abbiamo rottamato per sempre gli arzigogoli democristiani, le leopardiane complessità comuniste, i doppi binari, i doppi forni, le convergenze parallele, le sante dorotee, le subordinate, i lo dico ma non lo penso, lo penso ma non lo dico, gli amici, i compagni, i pontieri, le balene bianche, i fattori k, le contraddizioni del sistema. Tutto un vocabolario finito in cantina. Ora Fellini, o forse meglio il Bagaglino, si è impossessato del potere e ne mostra la faccia laida e granguignolesca e insulti e sputi e sghignazzi e battute da trivio e machismi e dialettismi e meteorismi e taccododicismi. Chiunque potrebbe essere lì al posto loro – un molesto da bar, un ultras della curva, una sciampista con la terza elementare, un analfabeta di andata e pure di ritorno, un seguace di Frank Matano – davvero chiunque. E chiunque di loro potrebbe animare le nostre serate di provincia al bar della Pesa a straparlare del mondo, che alla fine della fiera un rigorino alla Juve lo danno sempre e che i negri e i cinesi sono dietro a invaderci per portarci via il lavoro e stuprare le nostre donne. Adesso, dopo il fattaccio, è tutto un coro di alti lai e di altissime indignazioni su quanto sia inaccettabile questo gesto e che sconcio nel consesso più nobile della nazione e scandalo e vergogna e ire funeste e sanzioni esemplari e quote rosa e lotte sempiterne contro la discriminazione sessuale. Ma perché, crediamo forse che la sceneggiata del Senato sia un caso incidentale legato al sordido livello degli infami verdiniani e che riguardi solo quel mondo lì, di gente pronta a vendersi un tanto al chilo e a dileggiare le donne con il peggiore degli insulti? Siamo davvero così ingenui? Tanta strada si è fatta dal mitico cappio anti-Craxi del 1992, passando per l’altrettanto mitica mortadella anti-Prodi del 2008, per arrivare fino alla caserma dei giorni nostri. La nostra società è pervasa dalla volgarità, dal maschilismo e dal sessismo. E questo alla faccia delle dichiarazioni d’intenti trombonesche che ci sorbiamo di tanto in tanto, quando la cronaca riporta a galla il peggio di una cultura stratificata, capillare, inscalfibile. E suona davvero spassoso, se non fosse diabolicamente ipocrita, come una parte politica ben definita – la nostra meravigliosa sinistra da salotto, regina della doppia morale – abbia passato i migliori anni della sua vita nel tentativo di rovesciare tutta questa schifezza sulla parte avversa e abbia perseguito scientemente la costruzione di un’iconografia di politiche di destra come un peristilio di cubiste, spogliarelliste, escort, femminazze, vaiasse, pitonesse e mantidi religiose a fronte delle politiche di sinistra, tratteggiate invece a guisa di un seminario di stilite, amanuensi, madonnine infilzate, eroine della cooperazione internazionale, sante, beate, cherubine, serafine, madriterese e metafore della bontà e dell’altruismo. Per essere però prontamente punita – nella vita c’è sempre qualcuno più doppiomoralista di te - dai neobarbari grillini, che qualche tempo fa hanno sottolineato che le deputate del Pd siedono in Commissione giustizia solo perché particolarmente virtuose nella pratica così efficacemente mimata dal senatore Barani. Con l’aggiunta di una gaffe atomica del loro vate Beppe Grillo, che per denunciare lo scandalo del lauto vitalizio intascato da Nichi Vendola, ha ritwittato un aforisma da milord di un tale che discettava su come i gay usano il loro didietro. Tutto vero. Chissà che ne pensa la Lezzi…E suona ancor più spassoso che la lezione ai politici cialtroni arrivi dal mondo dei media, notoriamente uno degli ambienti più maschilisti del pianeta terra, perché solo chi ha messo piede nella redazione di un giornale - soprattutto quelli nazionali, ma non solo - può capire il livello di sessismo che giganteggia da quelle parti, come se fossimo negli anni Cinquanta, in un romanzo di Sciascia o in un film di Germi. Ma forse è meglio così. Forse questa ultima schifezza aiuterà tutti quanti a spazzare via la demagogia stracciona del politico da votare perché è come noi. Niente affatto. Il politico non deve essere come noi. Non deve parlare come noi. Non deve pensare come noi. E , soprattutto, non deve comportarsi come noi, con i nostri parcheggi in tripla fila, le nostre evasioni fiscali, le nostre finte malattie, le nostre piaggerie, la nostra culturetta da quattro soldi, i nostri ideali da Maria De Filippi, il nostro maschilismo e i nostri colloqui di lavoro in minigonna e zatteroni che così magari mi danno il posto. Loro dovrebbero essere diversi. Migliori. Superiori. Più colti. Più coraggiosi, più saggi, più degni. Non è affatto vero che la gente sia una cosa bella, perché troppo spesso degrada in trivio, suburra, popolo bue, assalto ai forni. Il senatore Barani, con la sua mimica da Rocco Siffredi, siamo noi. La prossima volta, evitiamo di votarci, per favore.
Quegli insulti a senso unico che non indignano la sinistra. Da Berlusconi alla Carfagna, da anni gli esponenti del centrodestra vengono offesi nei modi più volgari ma Napolitano non ha sentito il dovere di difenderli, scrive Andrea Cuomo su “Il Giornale”. Mettiamola così: la barbarie non è uguale per tutti. Ci sono offese come quelle dei grillini contro Laura Boldrini che sollevano l'indignazione (sacrosanta, intendiamoci) delle vergini immacolate di cui è sempre piena la sinistra italica. E altre derubricate a quisquilie, equivoci. E so' ragazzi. Parliamo di offese alle donne, no? Ebbene negli ultimi anni ce ne sono state tante contro quelle del Pdl senza che mai dal Colle rotolasse non diciamo il masso dello sdegno ma nemmeno il sassolino del fastidio. Prendete Mara Carfagna. Di lei Sabina Guzzanti disse, in una pubblica piazza: «Tu non puoi mettere alle Pari Opportunità una che sta là perché ti ha succhiato l'uc...lo!». La comica romana fu condannata a un risarcimento di 40mila euro ma sul piano dell'immagine non pagò pegno. Sempre la Carfagna si beccò un «la signora ha usato il suo corpo per arrivare dove è arrivata» da Carla Corso, rappresentante delle lucciole, quando firmò un ddl che inaspriva le pene contro la prostituzione. Napolitano brillò per il suo silenzio allora e quando Maria Luisa Angese scrisse su Sette di Giorgia Meloni che «con quella faccia da ET sarebbe indicata per scrivere una fenomenologia dei buchi neri». E quando Lidia Ravera nel 2004 sull'Unità fece le seguenti notazioni fisiognomiche su Condoleeza Rice, segretaria di Stato Usa: «Con quelle sue guancette da impunita è la lìder maxima delle donne-scimmia». Ancora donne insultate e abbandonate: quelle del Pdl se ne sentirono dire di tutti i colori l'11 maggio 2013 durante una manifestazione a Brescia da parte di militanti di Sel. Richiesta di un cenno di solidarietà, la Boldrini, che con Vendola è stata eletta a Montecitorio, fece la gnorri. Le ragazze del Rubygate, interrogate con domande intime oltre ogni necessità investigativa da Ilda Boccassini. Francesca Pascale, definita lesbica da Michelle Bonev in una puntata di Servizio Pubblico di ottobre scorso che non rappresentò la pagina più alta della carriera giornalistica di Michele Santoro. L'atleta russa Elena Isinbayeva, che per avere goffamente difeso le leggi anti-gay di Putin si beccò questo augurio da parte di un esponente del Pd sardo: «Per me possono anche prenderti e stuprarti in piazza». Né sono mai state considerate barbare le prese in giro di malattie, handicap o difetti fisici. Umberto Bossi ne sa qualcosa, le conseguenze del suo ictus sono state spesse ridicolizzate: Beppe Grillo ad Annozero ne parodiò la parlata affannata. Renato Brunetta non è stato risparmiato per la sua statura, né Giuliano Ferrara per la sua stazza. Anche di Berlusconi si è preso spesso di mira l'aspetto fisico, giustificando tutto come salubre espressione di satira. Sarà. Ma certo non furono satiriche le parole di Umberto Eco nel 2011 a Gerusalemme: «Berlusconi come Mubarak e Gheddafi? No, intellettualmente parlando il paragone potrebbe essere fatto con Hitler: anche lui giunse al potere con libere elezioni». Agghiacciante. E a proposito di paragoni indecenti c'è quello inventato di nuovo da Grillo dopo un colloquio Napolitano-Berlusconi: «È come se Herbert Hoover, presidente degli Usa negli anni Trenta, avesse invitato Al Capone per discutere del mercato degli alcolici». Ah, a proposito: il settimanale tedesco Spiegel nel 2003 dedicò al Cav una copertina con il titolo: «Il Padrino». Come si dice in tedesco barbarie?
Grillini contro la Bignardi Svelata la barbarie degli intoccabili alla Sofri. La conduttrice finisce nel mirino del Movimento per le domande sul padre fascista di Di Battista. Ma il caso del suocero resta tabù, scrive Maurizio Caverzan su “Il Giornale”. Questione di barbarie. Più o meno barbariche. Più o meno rozze, ingenue e viscerali. Oppure, astute e suadenti. Barbarie glamour, ci sono anche quelle. Lo scontro tra il Movimento Cinque Stelle e il mondo dell'informazione, oltre che delle istituzioni, non accenna a placarsi, anzi, in un'escalation vertiginosa e un tantino deprimente. Ieri ci ha pensato Rocco Casalino che lavora alla comunicazione pentastellata a gettare benzina sulla fiamma della polemica. «Cara Daria Bignardi», ha scritto Casalino in una lettera aperta pubblicata sul blog di Grillo, «come sarebbe per te se ti invitassi a una trasmissione tv e le domande fossero: come si sente tuo figlio a scuola ad avere il nonno mandante di un assassino? Come è l'aver sposato il figlio di un assassino? E se insistessi su questa domanda come hai fatto tu per il padre ex fascista di Di Battista?». Nella sua lettera, l'ex concorrente del primo Grande Fratello peraltro condotto proprio dalla Bignardi, Casalino chiede cosa penserebbe se, dopo averla avuta come ospite invitasse «uno scrittore che invece di parlare del suo libro raccontasse di cosa è stato Lotta Continua e di cosa pensa di te? E se questo scrittore utilizzasse il suo tempo non per parlare del suo libro ma per denigrare te che, oltretutto, saresti impossibilitata a difenderti?». Domande di carta vetrata, alle quali la conduttrice ha preferito non rispondere. Ma alle quali, ha invece sorprendentemente replicato da Doha, dove si trova in missione, il premier Enrico Letta stigmatizzandole come «frasi folli», esempio di «una barbarie senza fine». Il fatto è che di barbarie ce ne sono di diversi tipi. Grevi, intollerabili e indigeribili come quelle uscite in questi giorni dalle bocche dei cosiddetti «cittadini» di militanza grillina. Il «boia» con cui si è etichettato il presidente Napolitano. «I pompini» la cui arte di saperli fare avrebbe spalancato alle deputate Pd le porte del Parlamento. E il video su «Cosa fareste soli in auto con la Boldrini?» che ha scatenato i peggiori insulti in Rete. Rozzezze che si squalificano da sole. Poi c'è un genere di barbarie, più sottili e sofisticate e rivendicate anche nei titoli dei talk show che fanno tendenza. Trucchi giornalistici, trappole e faziosità che non vengono avvertite come tali proprio perché realizzate col marchio del conduttore o del giornalista doc. Barbarie barbariche, invasioni barbariche, interviste barbariche. Alcune più e alcune meno, a seconda della simpatia, dell'antipatia, dall'empatia. Se c'è da intervistare Carlo Cracco che fa figo, prego faccia come fosse nel ristorante suo. Se tocca conversare con Barbara D'Urso, conduttrice e collega pop, via libera alle strizzatine d'intesa. Con Alessandro Di Battista detto "Dibba", possibile candidato premier del Cinquestelle, zero complicità. Con il demonio del momento, la barbarie barbarica indossa il guanto di velluto. «Non posso non parlarne - premette Bignardi - visto che è uscita in tantissimi siti, se ne parla tanto in Rete. Avrà visto che c'è questa intervista in cui suo padre Vittorio Di Battista si dice orgoglioso di dichiararsi fascista, di indossare la camicia nera, di essere un camerata... Non è in imbarazzo?». «Mio padre è mio padre e io sono io», replica Di Battista. Ma la Bignardi non molla: davvero niente imbarazzo? «Siamo diversi, ma sono fiero di essere figlio di mio padre. Un uomo onesto...». Non basta. «Ma visto che lei è in politica suo padre non poteva evitare di dire di essere un fascista?». Signora mia. Alla fine, congedato Di Battista, se non fosse stato ancora chiaro, ci ha pensato Corrado Augias a esplicitare la presunta e latente accusa di continuità tra fascismo e grillismo. Ma qui siamo all'esercizio intellettuale e la barbarie diventa capziosa. Quel che invece è chiaro è che le colpe dei padri ricadono sempre sui figli. Soprattutto se stanno dalla parte sbagliata. Mentre ricordare quelle di suoceri e nonni che stanno dalla parte giusta, quella sì sarebbe vera barbarie. O no?
E' intervenuto addirittura il presidente del Consiglio in difesa di Daria Bignardi. Ha definito "barbarie" quella frase pronunciata dal grillino Rocco Casalino, ex gieffino ("Come ti senti ad aver sposato il figlio di un assassino?") contro la giornalista legata sentimentalmente a Luca Sofri, figlio di Adriano, condannato in Cassazione per essere stato il mandante dell'assassinio del commissario Luigi Calabresi. L'attacco del grillino era in qualche modo una piccola vendetta per la domanda che Daria, durante la sua Intervista Barbarica" aveva fatto al pentastellato Alesaandro Di Battista sul fatto che suo padre fosse fascista. Sul caso è intervenuto anche il direttore di Libero Maurizio Belpietro che, nel suo editoriale, punzecchia la Bignardi chiedendole e chiedendosi in cosa consiste l'offesa. Scrive: "Non è forse vero che Adriano Sofri, padre di Luca e compagno di Daria Bignardi, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per l’omicidio del commissario milanese? Del caso si sono occupati tutti i giudici possibili e per l’ex capo di Lotta continua si è riaperto il processo e si è spostato il giudizio dalla sua sede naturale, come mai è successo: neppure a Berlusconi. E però, alla fine, la Cassazione ha confermato la condanna e dunque Sofri è da ritenersi a tutti gli effetti il mandante dell’assassinio. Dunque, se Daria chiede al grillino i trascorsi del babbo (che non ha ucciso nessuno ma semplicemente simpatizzava per i fascisti), perché qualcuno non può chiedere alla conduttrice sempre così politicamente corretta dei trascorsi del suocero che esultò alla notizia dell’agguato al poliziotto? Dove sta la barbarie di cui parla Letta?".
Gli insulti e le volgarità targati 5 Stelle – scrive Marco Travaglio – sono noti e arcinoti, anche perché giornali e tv non perdono l’occasione per amplificarli e, talvolta, ingigantirli. O, quando non ci sono, inventarli. Molto meno noti sono gli insulti, le volgarità, le falsità e le calunnie subiti dai 5 Stelle, che passano quasi sempre sotto silenzio.
L’editoriale sul Fatto Quotidiano: Eccone una succinta antologia, a campione. Fascisti. “Grillo mi ricorda Mussolini” (Giampaolo Pansa, l'Espresso, 16-9-2007). “Berlusconi e Grillo uniti sotto spoglie diverse in un unico disegno… In un impeto suicida la festa dell’Unità ha aperto le porte all’appello squadristico di Grillo” (Mario Pirani, Repubblica, 20-9-07). “Anche i fasci di combattimento fascisti, nel 1919, si proponevano di mandare a casa tutta la vecchia classe politica democratica e poi fondare nuovi partiti: ne fondarono uno solo e proibirono gli altri” (Eugenio Scalfari, Tv 7, 22-9-07). “Un movimento potenzialmente eversivo… Si può paragonare Grillo a Mussolini? Con molte cautele, sì. Mussolini ha usato il manganello e l’olio di ricino, Grillo la volgarità” (Giuseppe Tamburrano, Unità, 21-9-07). “Benito Grillo” (Tony Damascelli, il Giornale, 26-4-08). “Il Grillo che aizza le piazze è uno squadrista che fa paura” (Giuliano Ferrara, il Giornale, 24-2-12). “Il camerata Grillo” (Repubblica, 29-8-12). “Grillo è un fascista del web” (Pier Luigi Bersani, 25-8-12). “Nel discorso di Grillo si trovano tracce di ‘ linguaggio fascista’” (Luigi Manconi, Unità, 7-9-12). “Il Duce Beppe” (Libero, 12-12-12). “Antifascismo, Grillo attacca la Costituzione. In questo Paese spesso si tenta di negare il fascismo come esperienza terribile. Purtroppo il comico è in buona compagnia” (Carlo Smuraglia, presidente Anpi, l ’ Unità, 15-1-13). “Quelle tracce destrorse, dalle nozze gay a Casa Pound” (Toni Jop, l ’ Unità, 8-2-13). “L’elettorato di Grillo è di destra populista” (Giuseppe Fioroni, 20-2-13). “‘ Il popolo italiano – nella sua parte migliore – si è dato un governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento’. Molto probabilmente Beppe Grillo non ha mai letto queste parole. Si tratta di Benito Mussolini in un famoso discorso del 1922” (Claudio Tito, Repubblica, 8-6-13). “Il no al voto segreto sul Cav? Pd e Grillo copiano il Duce” (il Giornale, 17-10-13). “Grillo squadrista contro l’Unità” (Unità, 7-12-13). “Quale differenza passa tra Beppe Grillo e Benito Mussolini? In apparenza nessuna” (Giampaolo Pansa, Libero, 2-2-14). Nazisti. “Grillo mi ricorda i fascisti, anzi i nazisti: ha la violenza verbale di Göbbels. Un fascio-comunista” (Guido Crosetto, Fratelli d’Italia, 27-4-12). “Grillo ha una logica vicina al nazismo” (Antonio Pennacchi, Corriere, 28-8-12). l dottor Gribbels” (Giuliano Ferrara, il Foglio, 2013-14). “Grillo parla come Hitler, con lui scappiamo all’estero” (Riccardo Pacifici, comunità ebraica di Roma, il Giornale, 23-3-13). “Grillo si metta il cuore in pace: non sarà lui a riuscire dove fallirono fascisti e nazisti, Mussolini e Hitler, Starace e Göbbels” (Oreste Pivetta, Unità, 29-3-13). “Adele Gambaro si è svegliata di colpo, bruscamente: ‘ Questo è una specie di nazismo informatico’” (Tommaso Ciriaco, Repubblica, 20-6-13. Lo stesso giorno la Gambaro avverte sulla sua pagina facebook: “L’intervista apparsa oggi su Repubblica che mi riguarda non è mai stata rilasciata. È totalmente inventata”). “La politica di Beppe Grillo usa le forme, i modi e i contenuti che questo Paese ha conosciuto nel ventennio più buio, che non è quello di Berlusconi come ci siamo abituati a ripetere con colpevole leggerezza, ma quello di Mussolini e delle camicie nere, delle squadracce coi manganelli e l’olio di ricino… Non ci sono solo i picchiatori, gli uomini forti dal pugno facile: ci sono anche i suggeritori, le spie, i delatori, quelli che il 16 ottobre ‘ 43 indicavano ai nazisti chi erano e dove abitavano gli ebrei del ghetto di Roma” (Luca Landò, Unità, 7-12-13). Alba dorata. “Grillo vuol costruire un ‘ movimento 12 stelle ’ con Alba dorata e simili. Pronto il tour europeo” (Michele Di Salvo, Unità, 24-7-13. La notizia è destituita di ogni fondamento). “Grillo e Casa-leggio non sono stati ancora circoscritti e ben identificati. È vero che non sono Alba Dorata ma, in un certo senso, sono peggio perché lì almeno funziona la profilassi ideale e culturale, come è sinora accaduto in Francia con Le Pen. Mentre qui c’è una complicità diffusa e una sottovalutazione, come fossero solo troll del web e non teppisti pericolosi, goliardi ingenui e non eversori malati, comici e non drammatici… I capi sono miei coetanei inaciditi che innescano, danno fuoco alle polveri e nella black list dove oggi stanno i giornalisti domani metteranno i manager, gli artisti, le figure pubbliche… sino a quando non arriveranno al vicino di casa” (Francesco Merlo, Repubblica, 10-12-13). Lepenisti. “Le Pen: Beppe, incontriamoci. La destra xenofoba tifa 5 Stelle” (Toni Jop, Unità, 3-4-13).”Il telefono di Le Pen e il Duce in cucina” (Toni Jop, Unità, 9-4-13). “Grillo va a lezione di destra. I 5 Stelle incontrano la Le Pen. Prove d’intesa Grillo-Le Pen: asse a destra per le Europee. La testimonianza: ‘ Un deputato del Front national in visita segreta a Casaleggio’. Contatti tra parlamentari” (Giornale, 2-12-13). “Populisti di tutta Europa uniti. E Lady Le Pen corteggia Grillo. ‘ Contatti ’ sarebbero intercorsi tra Marine Le Pen e Beppe Grillo” (Unità, 13-11-13. Nessun incontro né contatto è mai avvenuto fra il partito di Le Pen e il movimento 5 Stelle. Marine Le Pen, anzi, ha spregiativamente definito Grillo “tribuno sfiatato” e i 5 Stelle “un’eruzione cutanea”). Berlusconiani. “Incarnazione post-berlusconiana spacciata per novità” (Ezio Mauro, Repubblica, 23-5-12). “Grillo come Silvio” (Toni Jop, l ’ Unità, 21-12-12). “Grillo, con tutto il suo populismo, trasversalismo ideologico, ‘ casapoundismo’, antisindacalismo e antiparlamentarismo, il culto della persona, le nuotate nello Stretto fiume giallo, con tutto il suo ciarpame di rete e i suoi stracci da pataccaro internauta, i suoi argomenti da bar, la sua ‘ cacolalia’… è l’erede di Berlusconi… È il Berlusconi dopo Berlusconi” (Francesco Merlo, Repubblica, 27-1-13). “Patto Grillo-Berlusconi per fermare il cambiamento” (Unità, 28-3-13). “Grillo fa la lista nera dei giornalisti: obiettivo la sinistra” (Toni Jop, l ’ Unità, 5-6-13. Infatti i telegiornalisti più faziosi per i commentatori sono Giovanni Toti del Tg 4 e Bruno Vespa). “Nasce lo strano asse Forza Italia-Grillo” (Libero, 6-12-13). “Asse tra il Cav e Grillo” (Unità, 8-12-13). “Berlusconi e Grillo col forcone” (Unità, 11-12-13). “La marcia degli eversori. Berlusconi minaccia, asse con Grillo contro il Quirinale” (Unità, 13-12-13. Finora gli unici patti con B. li hanno siglati il Pd per rieleggere Napolitano, Enrico Letta per il governo e Renzi per la legge elettorale. Leghisti. “Grillo e la Lega alleati: via l’euro” (Unità, 10-9-12). “Lo strano corteggiamento tra Lega e Cinque Stelle” (Unità, 28-8-13). Montiani. “Grillo sbraita, ma aiuta solo Monti” (Magdi Cristiano Allam, Giornale, 11-2-13). Lettiani. “Aria di soccorso grillino per il governo (Letta, ndr)” (Libero, 8-1-14) Disabili. “Buuu… dategli il foglio giusto… buuu!” (cori di insulti dai banchi della maggioranza Pd-Sc-Pdl mentre parla alla Camera il M 5 S Matteo Dall’Osso, che ogni tanto si interrompe in quanto affetto da sclerosi multipla, 25-7-13). Pedofili. “Grillo raschia il fondo e va a caccia di minorenni” (Libero, 30-5-13) Terroristi. “Che accadrebbe se un mattino qualcuno, ascoltati gli insulti di Grillo, premesse il grilletto?” (Mauro Mazza, direttore Tg 2, 9-9-2007). “Grillo dalle 5 stelle alle 5 punte” (Libero, 3-1-12). “Grillo avvocato dei terroristi anti tasse” (Giornale, 3-1-12). “La sinistra eversiva ha scelto: ‘ Votate 5 Stelle’. Il Carc esce allo scoperto: ‘ È l’unico modo per sviluppare la ribellione’” (Giornale, 23-2-12). “Grillo ammazzerà i partiti. E poi l’Italia” (Giampaolo Pansa, Libero, 20-5-12). “Populismo eversivo” (Eugenio Scalfari, Repubblica, 4-11-12). “Omicidio, Bin Laden e Islam: quello che non si dice di Grillo” (Annamaria Bernardini de Pace, Giornale, 8-11-12). “Grill Laden sgancia missili su Israele” (Francesco Borgonovo, Libero, 26-6-12). “La linea politica è fissata con i comunicati che il famous comedian mette in rete con la numerazione progressiva, come le Br” (Francesco Merlo, Repubblica, 12-11-12) “Volevano il morto e Grillo sta con loro” (Giornale, 15-11-12). “No global, anti Tav, violenti: così Grillo prepara il ‘ golpe’” (Giornale, 16-11-12). “Grillo porta in Parlamento i black bloc” (Silvio Berlusconi, 22-2-13). “La sinistra eversiva ha scelto: ‘ Votate 5 Stelle’. Amici dei brigatisti” (Giornale, 23-2-13). “Golpe grillino: Parlamento occupato” (Giornale, 10-4-13). “Cinque stelle rosse. Echi, slogan, sogni di rivoluzione. C’è un filo che porta da Grillo agli anni Settanta. Da Toni Negri a Rossanda. Dai Cobas ai no global” (Espresso, 25-4-13). “Il paragone che mi sento di fare è ad esperienze della nostra storia recente, quando cioè Nar e Br realizzavano precisi volantini con foto, nomi e indirizzi, e semmai professione, dei bersagli da abbattere, generando così un diffuso senso di terrore e avvertimento mafioso a chiunque avesse idea di schierarsi apertamente contro. E spesso bastava, e non serviva nemmeno poi gambizzare… Oggi Grillo fa la stessa cosa” (Michele Di Salvo, Unità, 11-12-13). Comunisti. “Grillo sta con i comunisti” (Alessandro Sallusti, Giornale, 2-11-12). “Democrazia dal basso da Corea del Nord” (Giuliano Ferrara, Foglio, 12-12-12). “Sembra il Pcus di Stalin. Quelli scelti dall’ex comico sono i metodi in voga nell’Unione sovietica degli anni 30. Il grillusconismo è veterobolscevico” (Luca Telese, Pubblico, 13-12-12). “Chi vota Grillo si ritrova falce e martello” (Alessandro Sallusti, Giornale, 9-2-13). “Il segreto di Grillo. Sotto le cinque stelle la falce e il martello. Ex Psiup, No Tav, Cobas e nostalgici del Pci” (Giornale, 9-2-13). “Tra i grillini monta la rabbia: ‘Come nel Kgb’” (Stampa, 15-5-13). “Quando Beppe urlava: votate falce e martello” (Giornale, 24-2-12). “Il M 5 S è demagogicamente di sinistra” (Piero Ostellino, Corriere, 27-2-13). “Beppe come Ceausescu” (Libero, 20-6-13). “Pericolo: governo demogrillino. Pronto il ribaltone rosso per scaricare il Pdl e dare vita all’esecutivo più a sinistra della storia” (Maurizio Belpietro, Libero, 16-6-13). “Asse Pd-Grillo sulle nozze gay” (Franco Bechis, Libero, 19-12-13). Massoni. “Grazie a Casaleggio i massoni votano M 5 S” (Libero, 28-3-13). Yankees. “Beppe l’amerikano. ‘ Dietro il fenomeno M 5 S ci sono Cia e Goldman Sachs’. Bisignani rivela i dispacci del 2008 dell’ambasciatore Spogli a Casa Bianca e 007: ‘ Per noi è credibile’. Sull’agenzia di rating: ‘ Si tradì con gli elogi’. I soldi di Soros” (Libero, 29-5-13). Castali. “I grillini ci costano come la Casta. Privilegi a 5 stelle: dicono di non volere soldi, ma da onorevoli incasseranno per legge 30 milioni l’anno” (Giornale, 1-11-12). “Grillo candida portaborse e trombati” (Giornale, 9-12-12). “Grillo epuratore è peggio dei partiti” (Maria Giovanna Maglie, Libero, 13-12-12). “Portaborse e No Tav. Ecco i candidati di Grillo” (Libero, 15-2-13). “I grillini acchiappa poltrone: ‘ Posti pronti per i trombati’” (Libero, 20-3-13). “I grillini duri e puri sedotti (come tutti) da soldi, tv e poltrone” (Giornale, 8-5-13). “Grillo controlla la Rai” (Giornale, 6-6-13). “Bossi, Berlusconi, Grillo: i nemici della casta sono i suoi migliori amici” (Curzio Maltese, Venerdì di Repubblica, 27-12-13). “Voi 5 Stelle siete la Parentopoli e venite a darci lezioni: ma vaffanculo” (Pina Picierno, Pd, 25-9-13). “L’opinione pubblica prova ormai disgusto nei confronti dei partiti ‘ arraffoni ’ (compresi, come si è visto in Emilia Romagna, i nuovi arrivati, anch’essi famelici, del M 5 S)” (Pierluigi Battista, Corriere, 13-12-13. Falso: il consigliere dell’Emilia Romagna coinvolto nello scandalo dei rimborsi è un “ex”, fuoriuscito dal gruppo M 5 S, mentre i parlamentari M 5 S han rinunciato ai rimborsi elettorali; ma questo Battista non lo dice). Matti. “Grillo è fuori di senno o è un demagogo” (Eugenio Scalfari, Espresso, 7-6-12). “Disturbati” (Scalfari, Repubblica, 4-11-12). “Luci spente e benzina vietata. Ecco cosa accadrà a chi sceglie Grillo” (Giornale, 10-2-13). “Una setta di mezzi matti” (Giuliano Ferrara, Repubblica, 26-2-13). “Grillo e Casaleggio intendono abolire le auto, ridurre lavoro e stipendi, chiudere le banche e le carceri, rivalutare Karl Marx. Le case? In bambù. E quanto al sesso…” (Maurizio Belpietro, Libero, 21-3-13). “Masnada di dementi” (Giuliano Ferrara, Foglio, 23-3-13). “Un mio amico di cui non farò il nome ha avuto occasione di pranzare con Casaleggio… Gli poneva domande politiche… Il suo commensale rispondeva con poche parole, ma tra una portata e l’altra guardava il suo modernissimo telefonino seguendo un programma di videogiochi… Il suo interlocutore per uscire da un crescente disagio… gli chiese che cosa fosse quel videogioco… La risposta fu finalmente cordiale: ‘ Il tema è quello della distruzione dell’Universo. Venga a vedere’. Infatti. È un gioco americano che insegna ai giocatori come si può ottenere la distruzione delle singole stelle, dei loro pianeti, delle costellazioni e delle galassie usando alcuni gas, alcune particelle elementari e alcuni campi magnetici… Vince chi realizza la distruzione totale nel minor tempo possibile… Dio ce la mandi buona, ma temo il peggio se avremo nella stanza dei bottoni un governo che avrà come ideologia un videogioco di quel genere” (Eugenio Scalfari, Espresso, 19-3-13. Replica Casaleggio: “Scalfari colleziona una serie di panzane degne dell’avanspettacolo. Devo precisare che non amo i videogiochi, non ho un modernissimo telefonino, ma un antiquato apparecchio iPhone 3 G di qualche anno fa e rispetto i miei interlocutori”). Nemici di Martin Mistère. “Martin Mistère contro Grillo. Provocazioni: il creatore del celebre fumetto e il pantheon esoterico dei Cinque Stelle. Andate oggi a (ri) vedervi il video di Casaleggio. La democrazia si distrugge con la democrazia” (Alfredo Castelli, creatore di Martin Mistère, Corriere-Letture, 28-4-13). Brutti. “Sono mediamente brutti, malvestiti secondo le regole basilari degli abbinamenti cromatici, con pettinature da carcerati o da sfigati di provincia, parlano un italiano da balera misto a burocratese, leggono solo il blog di Grillo e avallano dietrologie complottistiche da tara psichica, si muovono in branco, non hanno un pensiero” (Filippo Facci, Libero, 31-1-14). Lombrosiani. “Un telefilm Usa: quel serial killer che somiglia al leader 5 Stelle” (Libero, 12-5-13). Fannulloni. “Incapaci e lavativi. Crolla il mito del M 5 S” (Libero, 22-3-13). “Beppe santifica i fannulloni a 5 Stelle. I suoi deputati e senatori sono tra i più improduttivi” (Panorama, 22-1-14). Vigliacchi. “Calabraghe a 5 stelle” (Vittorio Feltri, Giornale, 20-3-13). “Il vigliacco qualunquismo di Beppe” (Luigi Cancrini, Unità, 15-12-13). Coglioni. “Mezzo coglione, mo ’ se non te ne vai t’appizzo un pugno che t’ammazzo” (Angelo Cera, Scelta Civica, al deputato M 5 S Angelo Tofalo, 19-6-13). “Coglione intero” (Cera ad Alessandro Di Battista, 19-6-13). In tournée. “Il leader torna showman: tournée in Australia” (Corriere, 13-6-13. Della tournée in Australia non si troverà mai alcuna traccia). “La missione di Grillo Oltreoceano: pronta una tournée in America” (Repubblica, 1-7-13. Anche della tournée americana non si avrà più notizia). Cancronesi. “Si continua con il ‘ Cancronesi ’ con cui Grillo, paladino della cosiddetta ‘ cura Di Bella’, bollò con disprezzo Umberto Veronesi, accusato di boicottare non meglio precisate cure alternative nella guerra contro i tumori” (Pierluigi Battista, Corriere, 4-3-13. Falso: Grillo disse Cancronesi in polemica con la difesa a spada tratta fatta dell’illustre oncologo degli inceneritori, che emettono nanoparticelle cancerogene). Ladri. “Grillo è un personaggio di brutale avidità” (Ernesto Galli della Loggia, Corriere, 25-9-2007). “A Grillo 10 milioni in nero per la festa dell’Unità” (Giovanni Guerisoli, ex Cisl, Radio 24 e Giornale, 30-8-12. Segue smentita del segretario Raffaele Bonanni, con tanto di ricevuta e scuse). “Lady Grillo prende casa a Malindi. I lussi della signora anti-Casta imbarazzano il comico” (Libero, 18-11-12). “Considerato ciò che si legge sulla stampa su società off shore, investimenti e strane operazioni finanziarie in paradisi fiscali, inseriti nella black list, sarebbe opportuno che Grillo chiarisca cosa sa e come lo riguardino certe iniziative e in che modo siano compatibili con la trasparenza che tanto predica e con i principi sulla base di quali si presenta al paese e al Parlamento” (Davide Zoggia, Pd, 8-3-13. Il riferimento è alla copertina dell’Espresso “L’autista, la cognata e il Costarica” su 13 società aperte in Costarica dall’autista di Grillo, Walter Vezzoli, e dalla sua compagna, cognata di Grillo. Ma l’investimento totale è risibile: 20. 220 dollari. E Vezzoli ha abitato e lavorato in Costarica per una decina d’anni, gestendo una discoteca, aprendo un negozio di prodotti biologici e tentando invano di costruire un resort. Grillo non c’entra nulla, avendo visto il Costarica solo in cartolina). “Voti Grillo, incassa Beppe. Beppegrillo. it visitato da 5 milioni di utenti ogni mese. Il comico genovese guadagna a ogni clic” (Panorama, 20-3-13). “Gli affari di Casaleggio & C.: tu vai sul blog, loro incassano. L’esperto: ricavi milionari” (Giornale, 25-3-13). “Così guadagna il partito-azienda di Grillo” (Michele Di Salvo, Unità, 4-4-13. In realtà il blog di Grillo è stato in perdita, come la Casa-leggio Associati, fino al 2012, quando – grazie a piccole pubblicità – la società di Casaleggio ha registrato un utile di 69. 500 euro). “Grillo: ‘ Restituiti i finanziamenti, ma non so dove sono finiti’” (Repubblica, 21-6-13. Falso: i surplus non spesi di diarie e indennità dei parlamentari M 5 S – circa 2, 5 milioni a trimestre – vengono depositati su un conto per il microcredito alle imprese in difficoltà). “Vacanze a scrocco. I viaggi regalo della Valtur sono uno spaccato dell’Italia che vive di favori. E, tra politici e vip, negli elenchi dei ‘ favoriti ’ spunta a sorpresa Beppe Grillo” (copertina Panorama, 3-7-13). “Cinque stelle al prezzo di una. Beppe scroccone. E poi fa il moralista” (Libero, 27-6-13. In realtà, diversamente dai politici, le vacanze in questione si riferiscono ad anni precedenti il 2007, quando Grillo era solo un comico e soggiornava con lo sconto in cambio di spettacoli nei villaggi Valtur). “Nasce la tv di Grillo: il decoder costa 60 euro” (Michele Di Salvo, Unità, 10-9-13. Mai nata una tv di Grillo col decoder da 60 euro). Affamatori del popolo. “Pagamenti alle imprese: per il M 5 S è una ‘ porcata’” (Unità, 27-3-13. Falso: anzi, proprio grazie a una mozione M 5 S vengono sospese le cartelle esattoriali per le imprese in credito con lo Stato). “Grillo contro i terremotati” (Unità, 22-6-13). “Perde Grillo, l’Emilia respira” (Unità, 23-6-13). “Il cinismo del guru… il vergognoso ostruzionismo del gruppo Cinque stelle ha rischiato di far cadere importanti norme e finanziamento a favore delle popolazioni colpite dai terremoti di Emilia e Abruzzo” (Claudio Sardo, Unità, 23-6-13. Falso, anzi i 5 Stelle devolvono ai terremotati dell’Emilia i 420 mila euro avanzati dai contributi raccolti in campagna elettorale). “Ostruzionismo M 5 S, può tornare la seconda rata Imu” (Repubblica, 29-1-14). “5 Stelle, ostruzionismo sul decreto Imu”, “Barricate grilline: torna il rischio Imu” (Unità, 29-1-14. Falso: l’ostruzionismo dei 5 Stelle riguarda il regalo di 4, 5 miliardi alle banche, non la seconda rata dell’Imu, infilata in maniera incostituzionale dal governo nello stesso decreto). Plebei. “Il V-Day? Un carnevale plebeo e volgare … sentimenti beceri e forcaioli” (Sergio Romano, Corriere, 13-9-07). Vespisti. “La parabola del buffon prodigo … Rasputin Casaleggio sta trattando con Vespa” (Francesco Merlo, Repubblica, 27-1-13. Poi Grillo non va né da Vespa né in nessun’altra tv). Razzisti. “Grillo anche razzista: schiaffi ai marocchini. In Rete un video del 2006 in cui dà consigli ai carabinieri su come sistemare i migranti. Niente di nuovo: ce l’ha con gli zingari” (Toni Jop, l ’ Unità, 4-9-12). “Grillo esorta a trattare con ‘ due schiaffetti ’ in caserma, lontano da occhi indiscreti, ‘ i marocchini che rompono i coglioni’” (Pierluigi Battista, Corriere, 4-3-13. Falso: Grillo denunciava alcuni poliziotti che avevano preso a botte un immigrato). “Omofobi e razzisti, i ‘ 5 Stelle ad honorem ’ di Londra” (l ’ Unità, 6-6-13). Antidemocratici. “Chi inneggia al ‘ Vaffanculo ’ partecipa consapevolmente a quelle invasioni barbariche… Mi viene la pelle d’oca: dietro al grillismo vedo la dittatura” (Eugenio Scalfari, Repubblica, 10-9-07). “Il brutto ghigno antidemocratico dietro la farsa dei ‘ soliti ignoti ’ di Grillo” (Paolo Cirino Pomicino, Foglio, 5-3-13). “Casaleggio & Grillo neoscuola dei dittatori” (Bruno Gravagnuolo, Unità, 26-6-13). “Con Grillo usciamo dalla democrazia” (Pier Luigi Bersani, 21-2-13). “È l’Hugo Chávez di casa nostra” (Pierluigi Battista, Corriere, 5-11-12). Epuratori. “Grillo si traveste da Robespierre: taglia le teste e grida al complotto” (Giornale, 13-12-12). “Grillo-epurator. Chi vi ricorda?” (Toni Jop, Unità, 4-1-13). “Scatta la ghigliottina” (il Giornale, 1-5-13). “Scatta la purga” (il Giornale, 12-6-13). “La purga” (Libero, 13-6-13). “Minculpop 5 Stelle” (Giornale, 13-6-13). “Epurazioni. Quando la politica non tollera il dissenso. Una vecchia pratica di partito che si aggiorna con la lapidazione a colpi di ‘ post’” (Francesco Merlo, Repubblica, 20-6-13). “Da Silla a Stalin la sindrome del ‘ purificatore’” (Repubblica, 20-6-13). “Inquisizione” (Repubblica, 18-6-13). “Grillo ordina il repulisti” (Repubblica, 19-6-13). “Fobie, paranoie e gogne online: la sfida politica diventa mobbing” (Repubblica, 19-6-13). “La fatwa di Grillo” (Repubblica, 13-12-12). “Grillo vara la purga” (il Giornale, 20-6-13). Impostori. “Grillo non è un comico: è un grosso impostore… Fa la guerra… annuncia il bagno di sangue” (Adriano Sofri, Repubblica, 22-2-13) Menagramo. “Se Casaleggio fosse più iettatore che guru?” (M. N. Oppo, Unità, 23-7-13). Stercorari. “Scarabei stercorari” (Filippo Facci, Giornale, 11-11-2008). Impotenti. “Grillo fa dichiarazioni da puttaniere, dimostra di avere un pisello piccolo” (Giuliano Ferrara, Twitter, 16-7-12) Sfigati. “I suoi veri elettori sono pochi sfigati” (Filippo Facci, Libero, 17-5-12) Maiali. “Grillo urla, emette grugniti al posto di pensieri” (Nichi Vendola, 2-5-12). Menateli pure. “(Il questore Stefano Dambruoso che ha picchiato la M 5 S Loredana Lupo, ndr) ha esercitato una forza legittima. Bravo Dambruoso… Se blocchi una che sta facendo una cosa violenta puoi non controllare il gomito” (Pierluigi Battista, Twitter, 30-1-14). Rottinculo. “Ciao rottinculo” (saluto dei deputati Pdl ai colleghi M 5 S, testimonianza della deputata Patrizia Terzon, 2013). “Vi faccio un culo così” (Mario Ferrara di Gal a Vincenzo Santangelo e Paola Taverna di M 5 S, Montecitorio, 22-11-13). Merde & C. “Stronzo, coglione, venite fuori, quattro pezzi di merda, moralisti del cazzo” (deputati Pd e Pdl ai 5 Stelle, Montecitorio, 10-9-13) Finti morti. “Se trovassimo Grillo steso per terra, penseremmo: guarda cosa deve fare per tirare a campare un povero professionista del ridicolo” (Francesco Merlo, Repubblica, 4-9-12). In galera. “Grillo è un fuorilegge della democrazia, parassita malato delle polemiche… Dovrebbe essere bandito dalla scena pubblica con metodi rigorosi ed estremi… È un mostro antidemocratico di volgarità e di menzogna… un’infusione di bestialità… Deve essere eliminato dal finto gioco delle regole e delle parti” (Giuliano Ferrara, Foglio, 3-2-14). Bagasce. “Ciao bagascia” (due deputati del Pdl alla collega Paola Pinna del M 5 S, 30-6-13).
Oh sì, davvero inqualificabile il comportamento dei parlamentari grillini. Si sono addirittura lanciati col bavaglio contro i banchi del governo, e qualcuno sotto lo scranno più alto della Camera ha insultato la presidente Laura Boldrini, scrive Marco Ventura su “Panorama”. Come se a Montecitorio non ci fossero mai stati insulti, risse, lanci di oggetti. Mio nonno era deputato dc, degasperiano, anni ’50-60. Conservo una sua foto mentre tiene alta sulla testa una sedia (oggi sarebbe impossibile, è tutto inchiavardato come sulle navi in tempesta), pronto a scagliarla contro il comunista Giancarlo Pajetta che scavalcava gli scranni verso lo scontro fisico. Francamente, prima delle intemperanze degli ultimi giorni in aula e sul web, mi hanno scandalizzato l’intervento della parlamentare grillina che chiedeva di commemorare il kamikaze di Nassiriya, e la bandiera italiana e i fantocci dei nostri soldati bruciati nelle manifestazioni dell’estrema sinistra. Ma anche, in modo diverso, le bugie sulle tasse nelle conferenze stampa a Palazzo Chigi. Non mi piace, ma non mi scandalizza, la prova muscolare del Movimento 5 Stelle a Montecitorio, se è vero che nel paese c’è ben altra angoscia, ben altra violenza che cova. Guardiamoci intorno, ogni giorno vedremo questa violenza strisciante, e l’ingiuria volante e la maleducazione imperante, per strada, sui luoghi di lavoro, in tv, sul web. È la volgarità di un paese che vive di livore. Che non riesce a guardare avanti con serenità. Ma la colpa è dei grillini? Loro esprimono il furore di cittadini mal governati che scivolano ogni giorno di più nella povertà. Il teatrino della politica è esasperante. La perdita di tempo nelle Camere è un insulto peggiore dei video rimossi dal blog di Grillo. Il sabotaggio delle riforme, del cambiamento, è smaccato in quella fascia di popolazione che è arroccata in privilegi non più difendibili mentre i giovani, le partite IVA, i pensionati al minimo, gli imprenditori sono costretti a scappare all’estero, chiudere i battenti, scendere a patti con le raccomandazioni. Sì, questo è scandaloso. Come l’incapacità di guardare la realtà di un ceto medio che soffoca e s’immiserisce, da parte di chi continua a introitare cifre fuori dal mondo per pensioni, indennità e stipendi d’oro garantiti (che, quelli sì, sono un insulto).
Porte sbarrate, spintoni, occupazioni: un’altra giornata convulsa in Parlamento, scrive Online News. E l’ufficio della presidente della Camera Laura Boldrini sbarrato. Prosegue la protesta M5S, a Montecitorio, dopo il caos scoppiato mercoledì sul decreto Imu-Bankitalia per la «ghigliottina» all’esame del provvedimento messa dalla presidente della Camera, Laura Boldrini. I grillini hanno annunciato ricorso alla Corte costituzionale per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della presidente della Camera e dei presidenti delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.Obiettivo: ottenere l’annullamento delle ultime votazioni su dl Bankitalia, legge elettorale e dl Carceri. Boldrini replica: «Mi sono assunta una responsabilità derivante da comportamenti altrui, da rigidità contrapposte di diverso segno che hanno scaricato l’onere di una decisione assai difficile sulla Presidenza della Camera». Il tutto mentre i deputati del M5S presentano la loro richiesta di impeachment a Napolitano, con il Colle che commenta: «Lo stato d’accusa? Faccia il suo corso». La giornata è iniziata con la Commissione Giustizia che non è riuscita neanche ad iniziare la seduta convocata per le 8.30 al quarto piano di Montecitorio perché il deputato di M5s, Vittorio Ferraresi, si è fatto trovare seduto ai banchi della presidenza: ha spiegato alla presidente Donatella Ferranti che non se ne sarebbe andato fin quando non ci fossero state le dimissioni di Laura Boldrini e del questore Stefano Dambruoso accusato dai grillini di aver preso a schiaffi una parlamentare. Netta la posizione del segretario del Pd, Matteo Renzi: «Ieri i grillini, anziché cercare di lavorare per il bene del Paese, hanno trasformato il Parlamento in un ring, facendo ostruzionismo e bloccando la democrazia».Il tutto mentre viene reso noto che il M5S non prenderà parte ai lavori dell’Aula del Senato ora incentrati sulla discussone generale del dl Delega fiscale. La vicenda degli schiaffi in Aula continua a far discutere. La deputata del Movimento Cinque Stelle Loredana Lupo in Aula ha chiesto le dimissioni del Questore e collega Dambruoso che l’ha schiaffeggiata per impedirle di salire sui banchi del governo durante la bagarre in Aula (qui la fotosequenza) . Da parte di Dambruoso è arrivato un accenno di scuse: «Non mi riconosco in quell’immagine. Chiedo scusa per quel gesto che è stato percepito come un gesto di violenza, io non lo avevo inteso così».Ma Lupo replica: «Non ho ricevuto una telefonata e neppure una parola di scuse, né da lui né dalla presidenza della Camera».La deputata ha sporto denuncia e si dice delusa anche dalle altre forze politiche. «Mentre Dambruoso mi ha alzato le mani, un collega del Pd urlava addirittura: «Ha fatto bene, fascista!».I colleghi del Movimento si sono presentati nel pomeriggio in conferenza stampa con i cartelli «via i picchiatori». E, intanto, il Movimento 5 Stelle ha formalmente depositato, in entrambi i rami del Parlamento, la denuncia per la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Lo ha annunciato in Aula il capogruppo di Palazzo Madama, Maurizio Santangelo. L’atto è stato notificato dal presidente del Senato Grasso alla presidente della Camera Laura Boldrini ed ha iniziato il suo iter. Durante una conferenza stampa in Sala Nassiriya al Senato Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, ha difeso l’operato dei colleghi e ha spiegato le ragioni dell’impeachment (qui il testo presentato dai Cinque Stelle) . «Napolitano da arbitro è diventato giocatore, i vertici di maggioranza ormai si fanno al Quirinale», ha dichiarato Di Maio. Nei confronti di Napolitano, viene ipotizzato l’alto tradimento per la grazia concessa a Joseph Romano militare Usa condannato per il caso Abu Omar. E il presidente è anche accusato di ingerenze nei confronti della magistratura e della procura di Palermo. «Ben tornati ai tempi di Luigi XIV, sul regno di Luigi XIV non calava mai il sole», invece su questa «monarchia presidenziale sembra calare qualche ombra inquietante» ha chiosato Paola Taverna (peccato che il regno a prova di ombra fosse quello di Carlo V d’Asburgo, conquistatore delle Americhe (di qui la frase immortale, che per l’appunto fa riferimento alla diversità di fuso orario) e regnante dal 1516 al 1555. E ancora strascichi di polemiche arrivano dal Pd. Saranno tredici le querele nei confronti del deputato M5S Massimo De Rosa, che nel parapiglia che ha animato mercoledì sera la commissione Giustizia si è rivolto alle parlamentari Democratiche con un: «Siete arrivate qui solo perché sapete fare bene i p…». Dichiarazione che le deputate Pd non hanno affatto gradito: «Ha offeso la dignità delle donne del Pd e delle donne italiane – sottolinea la responsabile Giustizia dei Democratici Alessia Morani – Stanno impedendo l’esercizio delle democrazia». «Vanno oltre il diritto della minoranza», ha aggiunto la democratica Maria Chiara Gadda. E Morani ha proseguito: «Si può dissentire ma non impedire il lavoro del Parlamento». «È evidente che questo è un tentativo di ostacolare la legge elettorale – ha sottolineato ancora Gadda – hanno paura di una politica che inizia a fare».
Noi, insultate a Montecitorio, scrive Michela Marzano su “La Repubblica”. All’Ansa alcune parlamentari Pd mostrano la denuncia per ingiuria presentata contro De Rosa. Doveva essere una sera come tante. Una seduta notturna in Commissione Giustizia per lavorare al decreto sui diritti dei detenuti e il sovraffollamento carcerario. Due volumi pieni di emendamenti ostruzionistici presentati dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, cui però ormai si è fatta l'abitudine. E invece è andato tutto per traverso. Gli emendamenti, la seduta, i voti, il dibattito. Perché invece di discutere, si è finito con il litigare. Invece di votare, si è occupata l'aula della commissione. Invece di licenziare il provvedimento, si sono licenziati l'educazione e il rispetto. Le cose hanno cominciato a mettersi male fin dall'inizio. Quando la Presidente Ferranti ha aperto la seduta e i deputati del M5S hanno cominciato ad accalcarsi davanti la porta. A differenza di quanto accade di solito, anche chi non fa parte della commissione pretende di assistere ai lavori, e non accetta che per ragioni di sicurezza non sia possibile entrare in un'aula già stracolma. Mentre la Presidente cerca una soluzione, il malcontento aumenta. C'è chi sbuffa esasperato dalla giornata interminabile. C'è chi provoca. C'è chi rincara la dose. E pian piano è solo una grandissima confusione. Tutti parlano. Ci si accusa reciprocamente di intolleranza e di violenza. Nessuno ascolta. "Noi rappresentiamo i cittadini", urla un collega del M5S. "E noi chi rappresentiamo invece, nessuno? E i nostri elettori?", risponde uno del Pd. "E la violenza contro la collega Lupo?". "E gli insulti contro la Boldrini?". Ma è solo l'inizio. Prima dell'arrivo di altri grillini, prima del "voi del Pd siete il male", prima dei "fascisti" gridati che volano da una parte e dall'altra della sala, prima dei commessi che cominciano a temere per l'incolumità generale. È a questo punto che la Presidente, nonostante le proteste della Lega e del M5S, decide di annullare la seduta e di riconvocarla per l'indomani mattina. Massimo De Rosa è uno tra gli ultimi ad andarsene. A "me non fa né caldo né freddo essere chiamato fascista" dice sbattendo la porta. Poi ci ripensa. Ma quando sta per entrare di nuovo con in mano il casco della moto, un commesso lo blocca. "Voi del Pd siete tutti collusi", urla allora. Poi, rivolto a noi donne, aggiunge con scherno: "E voi siete qui solo perché siete brave a fare i pompini". De Rosa è paonazzo, ma sembra finalmente contento. Io smetto per qualche secondo di respirare. Poi mi volto e vedo occhi sgranati e sguardi vuoti. Siamo tutte senza parole. Con gli insulti, è sempre così. Lasciano di stucco, almeno in un primo momento. È per questo che i filosofi del linguaggio ne parlano come di una forma di hate speech, discorso dell'odio. Quando si insulta una persona, non si cerca né di dialogare, né di manifestare il proprio disaccordo. Quando la si insulta, si cerca solo di farla tacere. Che cosa si può mai rispondere quando qualcuno ci insulta d'altronde? Che non si è d'accordo? Che chi ci insulta sta sbagliando? Che non è affatto vero che le donne del Pd sono "brave solo a fare pompini"? Chi insulta lo sa. Ed esulta dell'umiliazione che provoca, proprio come uno schiaffo in pieno viso che continua a far male anche dopo molto tempo. Allora sì, l'altra sera anche io sono rimasta ammutolita. Silenziosa e impotente di fronte agli insulti di De Rosa, nonostante questa storia dell'hate speech la insegni da anni ai miei studenti per spiegare come nel momento in cui si insulta un interlocutore non è più una questione di diversità di idee o di opinioni, ma sempre e solo un gesto di violenza. Quando ci si trova di fronte alla violenza, tutto è più complicato. Molto più complicato delle teorie. Ecco perché, con le altre colleghe, ci abbiamo messo un po' prima di reagire, prima di fare comunicati e dichiarazioni, prima di andare al commissariato e sporgere querela. Ora però è fatta. E anche se De Rosa non si è nemmeno degnato di chiedere scusa, noi ci siamo riappropriate della nostra parola. Anche se sui social network c'è chi rimette in discussione quanto accaduto ("avete registrato?" "qualcuno è testimone?" "non starete mica inventando tutto, vero?") e c'è persino chi osa rincarare la dose - spiegando che è proprio così, e che è evidente che De Rosa dice ciò che pensano tutti - , noi abbiamo rivendicato il rispetto della nostra dignità. Basta con la violenza nei confronti delle donne. Basta con gli insulti. Ma basta con gli schiaffi. Perché se De Rosa ha mostrato che il "nuovo" può anche essere terribilmente "vecchio", il questore Dambruoso, con lo schiaffo alla deputata del M5S Lupo cui va tutta la mia solidarietà, ha mostrato che per molti, oggi, è veramente difficile meritare quell'"onorevole" di cui si dovrebbe invece cercare di essere fieri.
Parolacce ed insulti, calci e spintoni, bagarre tra i banchi della politica. Non solo cattivo gusto e risonanza mediatica, a volte qualcuno si è fatto male.
Quando l'aula diventa un ring. Le risse in 60 anni di Repubblica, scrive “La Repubblica”. L'aggressione del senatore Tommaso Barbato al collega Nuccio Cusumano é soltanto l'ultima aggressione avvenuta nelle aule del Parlamento. Una lunga serie di episodi delle stesso genere ha costellato i 60 anni di storia della Repubblica. Dal 1949 al 2008 le aule parlamentari si sono più volte trasformate in un ring, dagli occhiali rotti di Sgarbi alla sospensione per dieci sedute di 14 deputati della Lega.
18 marzo 1949 - Alla Camera si vota l'adesione dell'Italia alla Nato. Quando il presidente dell'assemblea Giovanni Gronchi proclama l'esito del voto, il deputato del Pci Giuliano Pajetta (fratello del più noto Giancarlo) si lancia "a catapulta" (come si legge nel resoconto parlamentare) contro un collega, dando inizio a una rissa che vede anche un cassetto volare nell'emiciclo.
1 aprile 1952 - Il deputato Dc Albino Stella, coltivatore diretto, si getta contro il monarchico popolare Ettore Viola, agricoltore, colpendolo con un pugno.
29 marzo 1953 - La "legge truffa" viene approvata dal Senato ma in aula succede di tutto. In una rissa senza precedenti volano cassetti e banchi, il ministro Randolfo Pacciardi rimane ferito e l'opposizione abbandona compatta l'aula.
4 dicembre 1981 - Durante la discussione sullo scioglimento delle associazioni segrete (P2) il radicale Tessari attacca un questore del Pci e scoppia una rissa tra parlamentari dei due gruppi. Vola qualche calcio e i commessi intervengono per separare i contendenti. Il radicale Cicciomessere spicca un salto sul banco del governo ma cade a terra e i commessi riescono a respingere alcuni deputati del Pci, che volevano aggredirlo.
20 novembre 1991 - Mentre la Camera discute i provvedimenti di attuazione del pacchetto per l' Alto Adige, il missino Giuseppe Tatarella si alza e si avvicina all'esponente della Svp Johann Benedikter, che sta parlando, strappandogli di mano i fogli del suo intervento e gettandoli in aria.
16 marzo 1993 - Durante il dibattito sulla questione morale, il leghista Luca Leoni Orsenigo espone in aula un cappio da forca, agitandolo verso i banchi del governo. Alcuni deputati cercano di raggiungere i banchi della Lega Nord e solo un fitto cordone di commessi impedisce il contatto fisico.
19 maggio 1993 - Durante la discussione della riforma Rai, il deputato missino Teodoro Buontempo cerca di parlare in aula con un megafono e, all'ordine di consegnarlo, scappa per le scale dell'emiciclo rincorso dai commessi. Il vicepresidente lo richiama e poi lo espelle insieme al collega di partito Marenco che ha urlato "ladri-ladri" e altro.
21 settembre 1994 - Il progressista Mauro Paissan, relatore del decreto "salva-Rai", è interrotto da un boato di proteste provenienti soprattutto dai banchi di Alleanza Nazionale. Un gruppo di deputati di An travolge il muro di commessi piazzati nell'emiciclo e ad avere la peggio è Francesco Voccoli, Prc, messo ko da un pugno mentre faceva scudo a Paissan. Anche un commesso deve ricorrere alle cure dell'infermeria.
2 agosto 1996 - Scambi di insulti e strattoni tra deputati di Polo e Lega nella discussione sul finanziamento dei partiti. Il leghista Cavaliere salta un banco e cerca di raggiungere il deputato Giovine e altri esponenti di Forza Italia. Rotti gli occhiali a Vittorio Sgarbi.
17 novembre 1997 - Rissa alla Camera con fascicoli bruciati, portaceneri rotti, insulti, urla e scontro fisico evitato per pochissimo. Gli incidenti avvengono in Transatlantico tra Enrico Cavaliere, Mario Borghezio e Luciano Dussin della Lega da un lato e Famiano Crucianelli (Comunisti Unitari), Ugo Boghetta e Ramon Mantovani di Prc dall'altro.
29 aprile 1998 - Uno scontro verbale su Juventus-Inter tra il deputato di An Gramazio e l'ex calciatore e deputato Ds Massimo Mauro si trasforma in scontro fisico. Gramazio scatta verso i banchi della maggioranza, Mauro cerca di allontanare con un calcio l'avversario, che intanto lo strattona e cerca di colpirlo. Gran lavoro dei commessi per sedare la rissa.
9 luglio 2003 - Durante la seduta della Camera, alcuni leghisti mostrano t-shirt con la scritta "io non sto con Abele" e "Caino sconti la pena". Il presidente Casini richiama due volte il capogruppo Alessandro Cè, Dario Galli, Luciano Dussin, Andrea Gibelli, Sergio Rossi e Luciano Polledri e poi li espelle. Un esponente del Carroccio si strattona da solo fingendo una sorta di colluttazione con uno dei commessi: "Sì, sto facendo anch'io resistenza. Da qui non mi sposto...".
31 luglio 2004 - Dopo un alterco per alcune battute su Tangentopoli e "nani e ballerine" con alcuni socialisti dei due schieramenti, Davide Caparini (Lega) tenta di sfondare il cordone dei commessi e di avvicinarsi a Roberto Giachetti (Margherita). Per Caparini scatta l'espulsione. Renzo Lusetti (Margherita) finisce in infermeria.
14 giugno 2007 - I deputati leghisti si siedono nei banchi del governo sventolando il titolo della Padania: "Governo fuori dalle balle". Seduta sospesa, poi l'occupazione, per circa un'ora, con i leghisti che urlano slogan e insulti alla maggioranza e quindi la rissa con i deputati del centrosinistra. L'ufficio di presidenza sospende 14 deputati della Lega per dieci sedute. Un record per Montecitorio.
15 novembre 2007 - Un senatore di Forza Italia cerca di prendere a testate un parlamentare del centrosinistra che viene circondato dai colleghi e portato in salvo fuori dall'emiciclo dal presidente della commissione Giustizia Cesare Salvi. Dai banchi di Forza Italia parte anche un sonoro "vaffanculo".
Onorevoli deputati: 65 anni di risse in Aula. Sia a Montecitorio che a Palazzo Madama sono diversi gli episodi che hanno portato senatori e deputati alle mani. Eccoli, scrive “Libero Quotidiano”. La rissa scoppiata in Aula ieri può aver fatto dire a molti frasi del tipo: "Cose mai viste". In realtà non è così. Da quando si è insediato il Parlamento ad oggi, sia la Camera che il Senato si sono trasformate in un ring. Ecco una lista degli episodi più significativi raccolti dall'archivio di Repubblica (fino al 2007): si va dagli occhiali rotti di Sgarbi alla sospensione per dieci sedute di 14 deputati della Lega, dalla litigata per la partita Juve-Inter ai documenti bruciati nell'emiciclo.
18 marzo 1949 - Alla Camera si vota l'adesione dell'Italia alla Nato. Quando il presidente dell'assemblea Giovanni Gronchi proclama l'esito del voto, il deputato del Pci Giuliano Pajetta (fratello del più noto Giancarlo) si lancia "a catapulta" (come si legge nel resoconto parlamentare) contro un collega, dando inizio a una rissa che vede anche un cassetto volare nell'emiciclo.
1 aprile 1952 - Il deputato Dc Albino Stella, coltivatore diretto, si getta contro il monarchico popolare Ettore Viola, agricoltore, colpendolo con un pugno.
29 marzo 1953 - La "legge truffa" viene approvata dal Senato ma in aula succede di tutto. In una rissa senza precedenti volano cassetti e banchi, il ministro Randolfo Pacciardi rimane ferito e l'opposizione abbandona compatta l'aula.
4 dicembre 1981 - Durante la discussione sullo scioglimento delle associazioni segrete (P2) il radicale Tessari attacca un questore del Pci e scoppia una rissa tra parlamentari dei due gruppi. Vola qualche calcio e i commessi intervengono per separare i contendenti. Il radicale Cicciomessere spicca un salto sul banco del governo ma cade a terra e i commessi riescono a respingere alcuni deputati del Pci, che volevano aggredirlo.
20 novembre 1991 - Mentre la Camera discute i provvedimenti di attuazione del pacchetto per l' Alto Adige, il missino Giuseppe Tatarella si alza e si avvicina all'esponente della Svp Johann Benedikter, che sta parlando, strappandogli di mano i fogli del suo intervento e gettandoli in aria.
16 marzo 1993 - Durante il dibattito sulla questione morale, il leghista Luca Leoni Orsenigo espone in aula un cappio da forca, agitandolo verso i banchi del governo. Alcuni deputati cercano di raggiungere i banchi della Lega Nord e solo un fitto cordone di commessi impedisce il contatto fisico.
19 maggio 1993 - Durante la discussione della riforma Rai, il deputato missino Teodoro Buontempo cerca di parlare in aula con un megafono e, all'ordine di consegnarlo, scappa per le scale dell'emiciclo rincorso dai commessi. Il vicepresidente lo richiama e poi lo espelle insieme al collega di partito Marenco che ha urlato "ladri-ladri" e altro.
21 settembre 1994 - Il progressista Mauro Paissan, relatore del decreto "salva-Rai", è interrotto da un boato di proteste provenienti soprattutto dai banchi di Alleanza Nazionale. Un gruppo di deputati di An travolge il muro di commessi piazzati nell'emiciclo e ad avere la peggio è Francesco Voccoli, Prc, messo ko da un pugno mentre faceva scudo a Paissan. Anche un commesso deve ricorrere alle cure dell'infermeria.
2 agosto 1996 - Scambi di insulti e strattoni tra deputati di Polo e Lega nella discussione sul finanziamento dei partiti. Il leghista Cavaliere salta un banco e cerca di raggiungere il deputato Giovine e altri esponenti di Forza Italia. Rotti gli occhiali a Vittorio Sgarbi.
17 novembre 1997 - Rissa alla Camera con fascicoli bruciati, portaceneri rotti, insulti, urla e scontro fisico evitato per pochissimo. Gli incidenti avvengono in Transatlantico tra Enrico Cavaliere, Mario Borghezio e Luciano Dussin della Lega da un lato e Famiano Crucianelli (Comunisti Unitari), Ugo Boghetta e Ramon Mantovani di Prc dall'altro.
29 aprile 1998 - Uno scontro verbale su Juventus-Inter tra il deputato di An Gramazio e l'ex calciatore e deputato Ds Massimo Mauro si trasforma in scontro fisico. Gramazio scatta verso i banchi della maggioranza, Mauro cerca di allontanare con un calcio l'avversario, che intanto lo strattona e cerca di colpirlo. Gran lavoro dei commessi per sedare la rissa.
9 luglio 2003 - Durante la seduta della Camera, alcuni leghisti mostrano t-shirt con la scritta "io non sto con Abele" e "Caino sconti la pena". Il presidente Casini richiama due volte il capogruppo Alessandro Cè, Dario Galli, Luciano Dussin, Andrea Gibelli, Sergio Rossi e Luciano Polledri e poi li espelle. Un esponente del Carroccio si strattona da solo fingendo una sorta di colluttazione con uno dei commessi: "Sì, sto facendo anch'io resistenza. Da qui non mi sposto...".
31 luglio 2004 - Dopo un alterco per alcune battute su Tangentopoli e "nani e ballerine" con alcuni socialisti dei due schieramenti, Davide Caparini (Lega) tenta di sfondare il cordone dei commessi e di avvicinarsi a Roberto Giachetti (Margherita). Per Caparini scatta l'espulsione. Renzo Lusetti (Margherita) finisce in infermeria.
14 giugno 2007 - I deputati leghisti si siedono nei banchi del governo sventolando il titolo della Padania: "Governo fuori dalle balle". Seduta sospesa, poi l'occupazione, per circa un'ora, con i leghisti che urlano slogan e insulti alla maggioranza e quindi la rissa con i deputati del centrosinistra. L'ufficio di presidenza sospende 14 deputati della Lega per dieci sedute. Un record per Montecitorio.
15 novembre 2007 - Un senatore di Forza Italia cerca di prendere a testate un parlamentare del centrosinistra che viene circondato dai colleghi e portato in salvo fuori dall'emiciclo dal presidente della commissione Giustizia Cesare Salvi. Dai banchi di Forza Italia parte anche un sonoro "vaffanculo".
26 ottobre 2011 - La seduta è stata sospesa dal Presidente di turno, On.Bindi, a seguito di scontri “fisici” tra parlamentari leghisti e parlamentari di Futuro e liberà, il tutto di fronte alle scolaresche in visita a Montecitorio che dalle balconate hanno assistito incredule all’accaduto.
15 Dicembre 2011 - Seduta sospesa alla Camera per le proteste della Lega che hanno esposto alcuni cartelli contro la manovra. Il presidente della Camera Gianfranco Fini ha espulso Gianluca Bonanno e Fabio Rainieri, che li hanno alzati davanti al banco del Governo.
E alla fine fu sdoganata anche la parola “pompino”, scrive Francesco Maria del Vigo su “Il Giornale”. Con grandissima disinvoltura. Ora almanaccano tutti di fellatio. Buttarlo lì quel termine, biasimando la volgarità dei seguaci di Grillo, è diventato quasi (radical) chic. Se ne parla ovunque: in tv, nei siti web dei quotidiani e sui loro genitori cartacei. Il dizionario di Youporn ha invaso l’opinione pubblica. Non si parla d’altro. Da quando i grillini hanno accusato le donne democratiche di occupare i loro scranni in virtù di irriferibili doti orali, politici, opinionisti e giornalisti fanno a gara per parlarne. La sempre composta ed elegante Alessandra Moretti, una delle donne ferite dagli strali grillini, ha ripetuto la frase in diretta tv su la7 di fronte alla stupita Lilli Gruber. Ovviamente il video impazza in rete. Ma il meglio lo mette in pagina la Repubblica di oggi. Il barbuto quotidiano, solido bacchettatore di ogni sguaiatezza, si lancia in un’acrobatica intervista al non particolarmente onorevole Massimo De Rosa, il parlamentare che avrebbe insultato le deputate dem. “Non gli ho dato delle pompinare”, attacca lui. “Ha definito pompinare le deputate del Pd”, lo incalza il giornalista. Lui ci riprova: “A un certo punto ho detto, rivolgendomi a tutti e non alla Moretti: la gente entra qui dentro perché conosce qualcuno o ha fatto un pompino a qualcuno”. Il giornalista non molla: “Si deve scusare”. De Rosa, spericolato, insiste nella sua autolesionista linea difensiva: “Mi scuso per quell’insulto. Mi dispiace, era una giornata faticosa e hanno iniziato loro a insultare. Ma voglio che sia chiaro che facevo un ragionamento generale, non è vero che gli ho dato delle pompinare. Ci mancherebbe”. Quattro volte in cinquanta righe. Un piccolo record. Ma ormai l’argine è rotto. Così la deputata piddina Giuditta Pini twitta ironica: “ho preso 7100 preferenze in 3 giorni. mi fa ancora male la mascella”. Che i grillini non fossero degli azzimati nipotini di Lord Brummel lo sapevamo già. Ma che quella roba lì avesse libera circolazione nella fascia protetta del pensiero e della cronaca politica è l’ultima novità di un Paese bizzarro. Per carità, lungi da me, nessun intento moralisteggiante, anche perché questa storia non ha i tratti di una tragedia ma, piuttosto, di una commedia all’italiana. Di quelle con gli spioncini delle porte violati da occhi voraci e le maestre che durante le lezioni fanno sbucare il reggicalze dalla gonna. Che è sempre meglio dell’Italia di certe pellicole tristemente (e sinistramente) pensose… Ps1. Gli insulti a sfondo sessuale sono sempre diretti alle donne. Come se il sesso fosse loro esclusivo appannaggio. Come se gli uomini, in questo caso i parlamentari, fossero degli anacoreti che hanno rinunciato ai piaceri della carne. Come se in Parlamento, come in qualunque posto di lavoro, non arrivassero uomini per raccomandazione, scambi politici, inconfessabili sotterfugi e, perché no, favori sessuali. Ps2. Quando Sabina Guzzanti, su un palco in una pubblica piazza, imbucò le medesime accuse all’indirizzo dell’allora ministro Carfagna, nessuno si stracciò le vesti. Probabilmente era un giorno di sciopero delle superstiti femministe da modernariato.
Filippo Facci: Fa-sci-sti. Urlano, insultano, spintonano. E poi sono brutti, ignoranti, complottisti: voi come chiamereste quelli del Movimento 5 Stelle? Ignorano i regolamenti e i galatei anche minimi, hanno quest’aria severa da ottusi convinti, fiaccano i dibattiti televisivi con sparate generiche di bassa demagogia, nell’emiciclo fanno gestacci tipo «emendami questo», dicono «boia» al Capo dello Stato, provocano, interrompono, urlano, spingono, strattonano, colpiscono e graffiano i questori, fanno i pagliacci con bavagli e striscioni, fanno ripresine in aula, inventano aggressioni dopo averle fatte, bloccano i lavori parlamentari, si avventano sui tavoli delle presidenze, occupano aule e commissioni, ne impediscono l’ingresso, disertano il Senato, costringono la Boldrini a chiudersi a chiave in ufficio, gridano «siete solo merda» ai parlamentari e «sapete solo fare pompini» alle parlamentari, interrompono i colleghi mentre rilasciano dichiarazioni alle telecamere, accusano come niente di «assassinio» e gridano «la mafia è nello Stato» anche si sta discutendo di cipolle, inoltre - scusate, ma è vero - sono mediamente brutti, malvestiti secondo le regole basilari degli abbinamenti cromatici, con pettinature da carcerati o da sfigati di provincia, parlano un italiano da balera misto a burocratese, leggono solo il blog di Grillo e avallano dietrologie complottistiche da tara psichica, si muovono in branco, non hanno un pensiero e sono servi di un ex comico che non è mai stato in Parlamento. Come vorreste chiamarli?
Grillo non ha inventato nulla: le risse sono nel
dna dell'Aula. Niente di nuovo tra i banchi del Parlamento: dal 1949
intemperanze e violenza sono una costante. Ma oggi il risultato è assicurato: si
finisce in tv e sui giornali, scrive Paolo Guzzanti su “Il Giornale”. Se la
rivoluzione non è un pranzo di gala, come diceva Lenin, neanche la vita
parlamentare è roba per stomaci deboli: pugni, schiaffi, insulti, corse su e giù
per i banchi inseguiti dai commessi, parolacce da mercati generali, risse
violente e qualche mal represso impulso omicida fanno parte della tradizione
italiana. È ormai mezzo secolo che frequento il Parlamento, quarant'anni come
giornalista e una decina come senatore e deputato, poi di nuovo come ex. Ed è
mezzo secolo che sono testimone delle piccole e grandi turpitudini e violenze
nelle aule parlamentari. Dico l'opinione che mi sono fatto. Gli italiani si
dividono in due: parlamentari e antiparlamentari e tutte e due le categorie
detestano il Parlamento. Non che in Francia, Germania, Regno Unito o Svizzera
non scoppino delle risse e non volino gli stracci insieme alle parolacce, ma
quel che è sempre successo da noi da un secolo in qua (mettiamoci anche
l'Italietta giolittiana e poi le sanguinose risse fra fascisti, socialisti e
comunisti) non si è visto quasi mai in altri Paesi di lunga tradizione e anche
di antico patriottismo parlamentare. Non ricordo risse ed epiteti da banco del
pesce al Congresso americano, alla Camera dei comuni o al Bundestag tedesco,
dove pure le urla non mancano.
Quando nel 1949 fu votata l'adesione alla Nato, presiedeva la Camera Giovanni
Gronchi, futuro inquilino del Quirinale. Volarono per la prima volta insieme
agli insulti anche gli schiaffi quando Giuliano Pajetta, fratello del più noto e
sanguigno Giancarlo, si precipitò come un ariete contro un collega dando inizio
a una rissa. Il vecchio Pci di Palmiro Togliatti rispettava la democrazia
parlamentare e le sue regole, ma lo faceva a corrente alternata non dimenticando
mai la tradizione rivoluzionaria e anche manesca, come facevano del resto i
neofascisti del Msi che scendevano dai loro banchi per rafforzare con la forza
dei pugni le loro opinioni. Del resto si faceva a botte anche sulle piazze del
Paese: gli studenti si picchiavano nelle università, i lavoratori in sciopero
facevano a botte con la Celere del ministro Scelba e il Parlamento, specialmente
la Camera era prima di tutto un luogo di scontro e propaganda. Facendo un salto
in avanti di quasi trent'anni ricordo Aldo Moro (che sarebbe stato rapito,
imprigionato ed ucciso di lì a poco) gridare con voce ferma che «la Dc non si
farà processare nelle piazze» (si riferiva allo scandalo Lockheed) e ricordo i
furori di comunisti e socialisti, ma anche missini. I presidenti della Camera
erano quasi tutti politici di lungo corso, alcuni dei quali salirono poi al
Quirinale, come il già citato Gronchi, Leone e Pertini: sapevano governare le
assemblee con mano ferma, come del resto Ingrao, Jotti, Violante, tutta gente
cresciuta nel Pci. Il clima in quei decenni era spesso rancoroso (non meno di
oggi) ma molto più composto. Parlavano sempre e soltanto i capi, i leader,
grandi vecchi di tutti i partiti della Prima Repubblica al cui passaggio nel
salone detto Transatlantico si aprivano le ali dei giornalisti obbligati ad
indossare - come i deputati del resto - giacca e cravatta e a mantenere un
atteggiamento discreto e sottomesso. Certo, all'occorrenza scorreva anche il
sangue, ma erano quattro gocce per le grandi occasioni come quelle che
sgorgarono dalla fronte di Randolfo Pacciardi al momento dell'approvazione della
«legge truffa» (una sorta di Porcellum dell'epoca) colpito da cassetti e
tavolini divelti nella bagarre. Se si va su internet si scoprono tracce di
antiche scazzottature non passate alla storia, come quella con robusto ceffone
che si beccò il pacifico deputato monarchico nonché agricoltore Ettore Viola,
raggiunto dal democristiano Albino Stella. Ma tutto il lungo periodo della
guerra fredda, quasi calda, che va dal 1948 agli anni Ottanta, fu una stagione
di insulti feroci, postribolari, assalti bloccati dai commessi i quali si
prendevano la loro dose di botte. Arrivarono poi i radicali e non dettero prova
di pacifismo gandhiano. Le questioni roventi della P2 e delle associazioni
segrete spinsero il radicale Cicciomessere a saltare olimpionicamente sul banco
del governo, salvo mancarlo e accasciarsi sul pavimento dove alcuni deputati del
Pci accorsero non per aiutarlo ma per riempirlo di calci. Il pestaggio fu
bloccato dai commessi, che ebbero la loro parte di calci e gomitate, mentre il
deputato Tessari, radicale anche lui partiva in quarta contro un questore del
Pci accendendo un altro focolaio di rissa. Fra i ricordi personali, quello della
lunga notte in aula dopo una contestazione di noi di Forza Italia contro il
presidente del Senato Marini (quello che poi fu silurato dai «democrats» durante
la votazione per il Quirinale) quando partimmo come schegge verso la Presidenza
che secondo noi usava il regolamento con due pesi e due misure. Il senatore
Lucio Malan, con lancio preciso, fece atterrare una pesante copia del
regolamento sul tavolo del presidente del Senato e si scatenò l'inferno. I
commessi intervennero e noi rivoltosi occupammo l'aula per qualche ora dopo la
chiusura. Gli episodi di intemperanza, maleducazione, violenza verbale e il
lancio di insulti gravissimi - gli stessi che si usano d'abitudine sotto il
semaforo - non fanno notizia. Anzi, proprio la necessità di «fare notizia» fu
oggetto di accurate ricerche di tecnica della comunicazione specialmente da
parte dei radicali nel momento del loro primo fulgore - Pannella imbavagliato, i
cartelli subito rimossi da commessi - e poi dai leghisti. Si vide che qualsiasi
violazione dei regolamenti commessa attraverso le immagini e non soltanto con le
urla, diventava telegiornale e giornale. La scena è sempre la stessa: i deputati
(più raramente i senatori) entrano in aula nascondendo l'armamentario
prestabilito (cartelli, oggetti, indumenti...) e al segnale convenuto li
estraggono. I commessi ogni volta sono già avvertiti e corrono stancamente per
sequestrare il materiale mentre il presidente di turno interrompe i lavori. I
fotografi scattano, i cameramen riprendono e il gioco è fatto. L'indomani siamo
su tutti i giornali e telegiornali, magari anche sulla stampa internazionale
sempre famelica di vicende italiane: dopo gli spaghetti-western, lo
spaghetti-Parlamento. I più grandi successi di happening di questo genere, più
vicini alla pop art che alla pratica democratica, sono stati i famosi cappi
della Lega: ecco Luca Leoni Orsenigo agitare il nodo del boia sotto il naso del
governo, mentre una pattuglia di deputati di maggioranza scatta al suo
inseguimento. Ed eccone un altro memorabile: quello del missino Teodoro
Buontempo che scappa urlando «ladri-ladri» in un megafono introdotto di
contrabbando, inseguito dai commessi per essere poi espulso insieme al suo
camerata Marenco. Una vera rissa con groviglio umano? Quella del 23 luglio 2004
quando scesero sul ring dell'emiciclo Davide Caparini della Lega, che puntò
Roberto Giachetti della Margherita, bloccato dal solito cordone dei commessi,
cosa che non impedì lo scontro fisico con successivo ricovero di alcuni deputati
in infermeria, fra cui Renzo Lusetti. Anche il «vaffanculo politico» non è
un'invenzione di Grillo: il 15 novembre 2007 questo fu l'invito rivolto da
alcuni senatori di Forza Italia al presidente della commissione Giustizia Cesare
Salvi, dopo uno scontro a testate fra opposte fazioni e ossa craniche. Si
potrebbe continuare. Poco c'è di nuovo sotto la luce del sole, come si vede,
salvo le accuse alle deputate renziane di fare carriera attraverso il sesso
orale, per sua natura accuratamente distinto dal sesso scritto.
"Servo", "cornuto", "cretina": 65 anni di insulti a Palazzo. Un libro raccoglie le cadute di stile e le scene peggiori della Repubblica. A destra e a sinistra, passando per la Lega, tutte le volte che il confronto è diventato triviale, scrive “Il Giornale”. Epiteti irripetibili, degni di una caserma o di un bar di quart'ordine. La storia della Repubblica è fin troppo ricca di dimostrazioni delle cadute di stile degli «onorevoli» eletti. E non manca l'antologia, raccolta da Sabino Labia. Si chiama Tumulti in aula. Il presidente sospende la seduta (Aliberti editore, 2009). Sottotitolo: «Da De Gasperi a Berlusconi, da Togliatti a Prodi sessant'anni di risse in Parlamento». Sulla copertina subito l'esempio degli insulti rivolti da un senatore a un collega in Aula: «Sei un cesso corroso! Sei una merda! Sei una merda! Sei una merda!». Eccone altri, tratti dal libro.
«Comunisti! Bastardi!»: Alfredo Covelli ai colleghi dell'Assemblea costituente, 3 dicembre 1947. Rispondono dai banchi del Pci: «Fascisti! Tornate nelle fogne!».
«Voi sapete in quale campo manovrare: fra i pregiudicati e le sgualdrine!»: Umberto Tomba ai colleghi della sinistra, 9 giugno 1948 alla Camera.
«Assassini!»: Giorgio Almirante rivolto ai colleghi comunisti, 12 ottobre 1948 alla Camera. I deputati comunisti rispondono: «Cacciatelo! Carogna! Traditore! Servo dei tedeschi!».
«Portatelo via con quattro carabinieri e fatelo uscire dalla porta delle latrine!»: Giancarlo Pajetta rivolto ad Almirante, 12 ottobre 1948 alla Camera.
«Cerruti non cerrutare!»: Albino Donati a Carlo Cerruti, 29 marzo 1953 al Senato. Cerruti risponde: «Non faccia interruzioni così villane».
«Venduto! Mascalzone! Vattene! Vattene! Servo dei gesuiti! Porco!»: comunisti e socialisti rivolti a Meuccio Ruini, 29 marzo 1953 al Senato. Ancora dai banchi della sinistra: «Canaglia! Venduto! Sudicione!».
«Dopo il voto avrete un nuovo Piazzale Loreto!»: Velio Spano a Giulio Andreotti, 29 marzo 1953 al Senato.
«Sei un pezzo di merda, checca!»: Vincenzo Zaccheo a Mauro Paissan, 20 ottobre 1994 alla Camera.
«Sporco bastardo, maiale!»: Francesco Marengo a Paissan, 20 ottobre 1994 alla Camera.
«Quella checca di Paissan mi ha graffiato con le sue unghie laccate di rosso, io non l'ho toccato! Vi sfido a trovare le mie impronte digitali sul suo culo!»: Francesco Storace a Paissan, 20 ottobre 1994 alla Camera.
Rincarano Teodoro Buontempo: «Io non gli ho fatto niente, perché non mangio i finocchi!» e Stefano Morselli: «Paissan, fai bene a farti scortare. Porco, pederasta e busone! Guardate, è un pusillanime, gli ho dato del porco e non ha avuto nemmeno il coraggio di reagire!».
«Ma avete visto che la Bindi gridava "A me, a me", ma nessuno ha avuto il coraggio di saltarle addosso?»: Pietro Di Muccio a Rosy Bindi nella stessa seduta della Camera. Rispondono Sandra Bonsanti: «I topi sono usciti dalle fogne!» e Fabio Mussi: «Già, sono tornati al naturale: cioè fascisti!».
Storace continua con le barzellette: «Lo sapete perché il Ppi rimane piccolo? Perché lo ha in mano Rosy Bindi!». Conclude la giornata Maurizio Gasparri: «Io alla rissa non c'ero, ma posso dichiarare lo stesso che Paissan è una testa di cazzo!».
«Buffone a chi? Ma chi cazzo sei? Sei uno stronzo! Tu sei un buffone! Pezzo di merda! Anche tu sei stato pagato dalla Fiat!»: Domenico Gramazio a Massimo Mauro, 29 aprile 1998 alla Camera.
«Ma stai zitta, cretina»: Ugo Parolo a Chiara Moroni, 24 giugno 2004 alla Camera.
«Sei un pezzo di merda! Fatti i cazzi tuoi, bastardo! Faccia di culo!»: Alessandro Cè a Roberto Giachetti, 24 giugno 2004 alla Camera.
«Puttana, ladri socialisti!»: Cè alla Moroni. E lei: «Aiuto, questo mi ammazza!», 24 giugno 2004 alla Camera. Il povero Renzo Lusetti ha paura e urla: «Chiamate la polizia!», poi si prende un pugno e aggiunge: «Questi sono matti! Proprio a me che non ho mai fatto a botte, neppure da ragazzo!».
«Sei un cesso corroso e frocio! Sei una merda! Sei una merda! Sei una merda!»: Nino Strano a Nuccio Cusumano, 24 gennaio 2008 al Senato. E ancora: «Sei un frocio mafioso! Sei una checca! Sei una checca! Sei una checca squallida! Venduto!».
«Cornuto! Sei un cornuto e venduto! Pezzo di merda!»: Tommaso Barbato sempre a Cusumano, 24 gennaio 2008 al Senato. È il giorno del prosecco e delle fette di mortadella. Il presidente Franco Marini sbotta: «Togliete via quella bottiglia, non siamo mica all'osteria!».
MAI DIRE MAFIA: IL CALVARIO DI ANTONIO GIANGRANDE.
Guerra aperta contro alcuni magistrati di Taranto: denuncia per calunnia e diffamazione alla Procura di Potenza, richiesta di ispezione ministeriale al Ministro della giustizia e richiesta di risarcimento danni per responsabilità civile dei magistrati al Presidente del Consiglio dei Ministri.
«Non meditar vendetta! Ma siedi sulla riva del fiume e aspetta di veder passare il corpo del tuo nemico! Ed io ho aspettato…..affinchè una istituzione, degna dell’onor di patria, possa non insabbiare una mia legittima ed annosa aspettativa di giustizia. Perché se questo succede a me, combattente nato, figuriamoci a chi è Don Abbondio nell’animo. Già che sono in buona compagnia. Silvio Berlusconi: "Venti anni di guerra contro di me. In Italia giustizia ingiusta per tutti" ». Così afferma il dr Antonio Giangrande, noto saggista di fama mondiale e presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Associazione fuori dal coro e fuori dai circuiti foraggiati dai finanziamenti pubblici.
«Puntuale anche quest’anno è arrivato il giorno dedicato all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un appuntamento che, da tempo immemore ripropone un oramai vetusto ed urticante refrain: l’aggressione virulenta ai magistrati portata da tutti coloro che non fanno parte della casta giudiziaria. Un piagnisteo continuo. Un rito liturgico tra toghe, porpore e carabinieri in alta uniforme. Eppure qualche osservazione sulle regole che presidiano e tutelano l’Ordine giudiziario italiano dovrebbe essere fatta. Faccio mie le domande poste da L’Infiltrato Speciale su Panorama. Quale sistema prevede una “sospensione feriale” per 3 mesi filati? Quale organizzazione non prevede un controllo sul tempo effettivo trascorso in ufficio ovvero regola e norma ogni forma di…telelavoro da casa? Quale altro ruolo istituzionale prevede l’impunità di fatto per ogni atto compiuto nell’esercizio del proprio magistero? Quale altro organo dello Stato è il giudice di se stesso? Ma, soprattutto, può il dovere di imparzialità del giudice sposarsi con lo svolgimento di vera e propria attività politica entro le varie “correnti” interne alla magistratura? Qualcuno potrà negare che diversi esponenti di magistratura democratica abbiano rivendicato apertamente le radici nel pensiero marxista leninista della propria corrente? Dico questo senza alcun pregiudizio e, anzi, con il rispetto che devo ad amici e magistrati che stimo ed ai quali questa percezione, che non credo sia mio esclusivo patrimonio, non rende il giusto merito.
Detto questo premetto che la pubblicazione della notizia relativa alla presentazione di una denuncia penale e alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato costituisce lecito esercizio del diritto di cronaca. La pubblicazione della notizia relativa alla presentazione di una denuncia penale e alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, oltre a non essere idonea di per sé a configurare una violazione del segreto istruttorio o del divieto di pubblicazione di atti processuali, costituisce lecito esercizio del diritto di cronaca ed estrinsecazione della libertà di pensiero previste dall'art. 21 Costituzione e dall'art 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche se in conflitto con diritti e interessi della persona, qualora si accompagni ai parametri dell'utilità sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4603).
Ed allora ecco alcuni brani dell’atto presentato alle varie istituzioni.»
"Si presenta, per fini di giustizia ed a tutela del prestigio della Magistratura oltre che per tutela del diritto soggettivo dell’esponente, l’istanza di accertamento della responsabilità penale ed amministrativa e richiesta di risarcimento del danno, esente da ogni onere fiscale, in quanto già ammesso al gratuito patrocinio nei procedimenti de quo. Responsabilità penale, civile ed amministrativa che si ravvisa per i magistrati nominati per azioni commesse da questi in unione e concorso con terzi con dolo e/o colpa grave. Elementi costitutivi la responsabilità civile dei magistrati di cui alla Legge 13 aprile 1988, n. 17:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
PER IL PRIMO FATTO
L’Avv. Nadia Cavallo presenta il 10/06/2005 una denuncia/querela nei confronti di Antonio Giangrande, sottoscritto denunciante, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in unione e concorso con Monica Giangrande, con denuncia-querela presentata all’A.G., incolpato Cavallo Nadia Maria del reato di truffa e subornazione, pur sapendola innocente. La denuncia di Cavallo Nadia Maria è palesemente calunniosa e diffamatoria nei confronti di Antonio Giangrande in quanto la denuncia di cui si fa riferimento e totalmente estranea ad Antonio Giangrande e non è in nessun modo riconducibile ad egli.
Insomma: la denuncia a firma di Antonio Giangrande non esiste.
Pur mancando la prova della calunnia, quindi del reato commesso, comunque inizia il calvario per il dr. Antonio Giangrande.
La dott.ssa Pina Montanaro apre il fascicolo n. 5089/05 R.G. notizie di reato. Non espleta indagini a favore dell’indagato, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., e nel procedimento Gip n. 2612/06, pur non supportato da alcuna prova di accusa, in quanto la denuncia contestata in capo ad Antonio Giangrande non esiste, chiede comunque in data 20 aprile 2006 il rinvio a giudizio di Antonio Giangrande in concorso ed unione con Monica Giangrande.
Il Dr Ciro Fiore nel procedimento Gip n. 2612/06, pur non supportato da alcuna prova di accusa in quanto la denuncia contestata in capo ad Antonio Giangrande non esiste, dispone comunque in data 02 ottobre 2006 il rinvio a giudizio di Antonio Giangrande in concorso ed unione con Monica Giangrande.
Il processo a carico di Antonio Giangrande in concorso ed unione con Monica Giangrande contraddistinto con il n. 10306/10 RGDT si apre con l’udienza del 06/02/07 presso il Tribunale di Manduria – Giudice Monocratico, sezione staccata del Tribunale di Taranto, ma la posizione di Antonio Giangrande è stralciata per vizi di notifica.
Il Dr Pompeo Carriere il 28/04/2010 riapre il procedimento Gip n. 2612/06, dopo lo stralcio della posizione di Antonio Giangrande rispetto alla posizione di Monica Giangrande per vizi di forma della richiesta di rinvio a giudizio. Su apposita richiesta della difesa di Antonio Giangrande di emettere sentenza di non luogo a procedere per il reato di calunnia ove ritenga o accerti che ci siano degli elementi incompleti o contraddittori riguardo al fatto che l'imputato non lo ha commesso, il dr. Pompeo Carriere, il 19 luglio 2010, disattende tale richiesta e dispone nei confronti del Pubblico Ministero l’ulteriore integrazione delle indagini e l’acquisizione delle prove mancanti per sostenere l’accusa in giudizio contro Antonio Giangrande. All’udienza dell’8 novembre 2010, il Pubblico Ministero non ha svolto le indagini richieste, anche a favore dell’indagato, e non ha integrato le prove necessarie. Ciononostante in tale data il dr. Pompeo Carriere, pur non supportato da alcuna prova di accusa, in quanto la denuncia contestata in capo ad Antonio Giangrande non esiste, dispone comunque il rinvio a giudizio di Antonio Giangrande per il reato di calunnia.
Il nuovo processo a carico di Antonio Giangrande contraddistinto con il n. 10346/10 RGDT si apre con l’udienza del 01/02/11 presso il Tribunale di Manduria – Giudice Monocratico, sezione staccata del Tribunale di Taranto. In quella sede ai diversi giudici succedutisi, in sede di contestazioni nella fase preliminare, si è segnalata la mancanza assoluta di prove che sostenessero l’accusa di calunnia.
Solo in data 23 gennaio 2014, nonostante l’assenza alla discussione con l’arringa finale dell’imputato (in segno di palese protesta contro l’ingiustizia subita) e del suo difensore di fiducia e senza curarsi delle richieste del Pubblico Ministero togato, che stranamente per questo procedimento è intervenuto di persona, non facendosi sostituire dal Pubblico Ministero onorario, ed a dispetto delle richieste dell’imperterrita presenza della costituita parte civile, l’avv. Nadia Cavallo, che ne chiedeva condanna penale e risarcimento del danno, il giudice Maria Christina De Tommasi, pur potendo dichiarare la prescrizione non ha potuto non acclarare l’assoluzione di Antonio Giangrande per il reato di calunnia per non aver commesso il reato, in quanto non vi era prova della sua colpevolezza. Per la seconda accusa dello stesso procedimento penale riguardante la diffamazione, ossia per il capo B, la De Tommasi ha pronunciato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nonostante avesse anche qui dovuto constatare che il fatto non era stato commesso, per la mancanza di prove a carico di Antonio Giangrande, in quanto l’articolo incriminato era riconducibile a terze persone, sia come autori, che come direttori del sito web.
Declaratoria di NON AVER COMMESSO IL REATO. Dopo 8 anni, un pubblico Ministero, due Giudici per l’Udienza Preliminare, tre Giudici monocratici, di cui una, dr.ssa Rita Romano, estromessa con istanza di ricusazione, sostituita dalla dr.ssa Vilma Gilli ed a sua volta sostituita da Maria Christina De Tommasi.
Rita Romano ricusata per essere stata denunciata da Antonio Giangrande proprio per la sentenza di condanna adottata nei confronti di Monica Giangrande. Sentenza del 18/12/2007 con processo iniziato il 06/02/07. Esito velocissimo tenuto conto dei tempi medi del Foro. Nel processo nato a carico di Antonio Giangrande e Monica Giangrande su denuncia di Nadia Cavallo e poi stracciato a carico di Monica Giangrande, la stessa Monica Giangrande era accusata con Antonio Giangrande di calunnia per aver accusato la Cavallo Nadia di un sinistro truffa. Monica Giangrande affermava nella sua denuncia che la stessa Avv. Nadia Cavallo accusava lei, Monica Giangrande, di essere responsabile esclusiva del sinistro. In effetti Rita Romano stracciava la posizione di Antonio Giangrande per difetto di notifica del rinvio a giudizio e dopo l’espletamento del processo a carico di Monica Giangrande condannava l’imputata. Ciononostante lo stesso giudice riconosceva nelle sue motivazioni che la stessa Giangrande Monica accusava la Nadia Cavallo sapendola colpevole, perché proprio lo stesso giudice riconosceva tal Nigro Giuseppa come responsabile di quel sinistro che si voleva far ricondurre in capo alla Giangrande Monica, la quale, giustamente negava ogni addebito. L’appello contro la sentenza a carico di Monica Giangrande è stata inspiegabilmente mai impugnata dai suoi difensori, pur sussistendone validi motivi di illogicità della motivazione.
L’inimicizia dei magistrati di Taranto nei confronti di Antonio Giangrande è da ricondurre al fatto che lo stesso ha denunciato alcuni magistrati del foro tarantino, anche perché uno di loro, il sostituto procuratore Salvatore Cosentino, ha archiviato una denuncia contro il suo ufficio, anziché inviarlo alla Procura di Potenza, Foro competente. Inoltre l’avv. Nadia Cavallo è molto apprezzata dai magistrati Tarantini e da Salvatore Cosentino, ora alla procura di Locri. In virtù della sentenza di condanna emessa contro Monica Giangrande l’avv. Nadia Maria Cavallo ha percepito alcune decine di migliaia di euro a titolo di risarcimento del danno morale e oneri di difesa. Evidentemente era suo interesse fare la stessa cosa con il dr. Antonio Giangrande, con l’aiuto dei magistrati denunciati, il quale però non era di fatto e notoriamente autore del reato di calunnia, così come era falsamente accusato. Innocenza riconosciuta ed acclarata dal giudice di merito, però, dopo anni.
PER IL SECONDO FATTO
In questo procedimento risultano esserci due querelanti e quindi due persone offese dal reato:
Dimitri Giuseppe querela in data 19/07/2004 Corigliano Renato perché si ritiene vittima di Falsa Perizia giudiziaria. Corigliano Renato controquerela Dimitri Giuseppe per calunnia e diffamazione per aver pubblicato la querela, in cui si producevano le accuse di falsa perizia contro il Corigliano ledendo il suo onore e la sua reputazione. Corigliano Renato non querela Antonio Giangrande. Dimitri Giuseppe per la diffamazione subita dal Corigliano controquerela Antonio Giangrande, pur non avendo il Dimitri Giuseppe legittimità a farlo, non essendo egli persona offesa.
Insomma: la querela di diffamazione da parte della persona offesa contro Antonio Giangrande non esiste.
Pur mancando la prova della diffamazione, quindi del reato commesso, comunque inizia il calvario per il dr. Antonio Giangrande.
Il Dr. Enrico Bruschi apre il fascicolo n. 3015/06 R.G. notizie di reato. Non espleta indagini a favore dell’indagato, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., e decreta egli stesso la citazione a giudizio saltando l’Udienza Preliminare.
Il processo a carico di Antonio Giangrande contraddistinto con il n. 10244/10 RGDT si apre con l’udienza del 05/10/2010 presso il Tribunale di Manduria – Giudice Monocratico, sezione staccata del Tribunale di Taranto, ma la posizione di Antonio Giangrande è inviata al Giudice per le Indagini Preliminari per l’Udienza di Rito.
Il Dr Pompeo Carriere il 26/11/12 apre il procedimento Gip n. 243/12. Sostenuto dalla richiesta del PM Enrico Bruschi il dr. Pompeo Carriere, ciononostante non vi sia la querela di Corigliano Renato contro Antonio Giangrande e pur non supportato da alcuna prova di accusa, in quanto la denuncia contestata in capo ad Antonio Giangrande non esiste, dispone comunque il rinvio a giudizio di Antonio Giangrande per il reato di Diffamazione.
Il nuovo processo a carico di Antonio Giangrande contraddistinto con il n. 10403/12 RGDT si apre presso il Tribunale di Manduria – Giudice Monocratico, sezione staccata del Tribunale di Taranto. In quella sede ai diversi giudici succedutisi, in sede di contestazioni nella fase preliminare, si è segnalata la mancanza assoluta di prove che sostenessero l’accusa di Diffamazione.
Solo in data 18 aprile 2013 Corigliano Renato è stato sentito ed ha confermato di non aver presentato alcuna querela contro Antonio Giangrande. Corigliano Renato e Dimitri Giuseppe hanno rimesso la querela, il primo perché non l’aveva presentata e comunque non aveva alcuna volontà punitiva contro Antonio Giangrande, il secondo non aveva addirittura la legittimità a presentarla. Il giudice Giovanni Pomarico non ha potuto non acclarare il non doversi procedere nei confronti di Antonio Giangrande per remissione delle querele.
Declaratoria di NON DOVERSI PROCEDERE PER REMISSIONE DI QUERELA. Ma di fatto per difetto di legittimazione ad agire. Dopo 4 anni, un pubblico Ministero, un Giudice per l’Udienza Preliminare, tre Giudici monocratici, di cui una, dr.ssa Rita Romano, estromessa con istanza di ricusazione perchè denunciata da Antonio Giangrande, sostituita dalla dr.ssa Frida Mazzuti ed a sua volta sostituita da Giovanni Pomarico.
L’inimicizia dei magistrati di Taranto nei confronti di Antonio Giangrande è da ricondurre al fatto che lo stesso ha denunciato alcuni magistrati del foro tarantino, anche perché uno di loro, il sostituto procuratore Salvatore Cosentino, ha archiviato una denuncia contro il suo ufficio, anziché inviarlo alla Procura di Potenza, Foro competente.
PER IL TERZO FATTO
L’avv. Santo De Prezzo, in data 06 novembre 2006, denuncia e querela il dr. Antonio Giangrande per violazione della Privacy per aver pubblicato sul sito web della Associazione Contro Tutte le Mafie il suo nome, nonostante il nome dell’avv. Santo De Prezzo fosse già di dominio pubblico in quanto inserito negli elenchi telefonici, anche web, e nell’elenco degli avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, anche web.
La dr.ssa Adele Ferraro, sostituto procuratore presso il Tribunale di Brindisi apre il proc. n. 9429/06 RGNR, non espleta indagini a favore dell’indagato, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., ed il 1° ottobre 2007 (un anno dopo la querela) decreta il sequestro preventivo dell’intero sito web della Associazione Contro Tutte le Mafie, arrecando immane danno di immagine. Il Decreto è nullo perché non convalidato dal GIP ed emesso il 19 ottobre 2007, successivamente al sequestro. Il decreto è rinnovato il 09/11/ 2007 e non convalidato dal giudice Katia Pinto. Poi ancora rinnovato il 28/12/2007 e convalidato da Katia Pinto il 26/02/2008, ma non notificato.
La dr.ssa Katia Pinto apre il proc. n. 1004/07 RGDT e il 19/09/2008, dopo quasi un anno dal sequestro del sito web con atti illegittimi dichiara la sua incompetenza territoriale e trasmette gli atti a Taranto, ma non dissequestra il sito web.
In questo procedimento non risulta esserci il fatto penale contestato eppure si oscura un sito web di una associazione antimafia e si persegue penalmente il suo presidente, Antonio Giangrande.
Insomma: il fatto non sussiste. Pur mancando la prova della violazione della privacy, quindi del reato commesso, comunque inizia il calvario per il dr. Antonio Giangrande.
Il Dr. Remo Epifani sostituto procuratore presso il Tribunale di Taranto apre il fascicolo n. 8483/08 RGNR, non espleta indagini a favore dell’indagato, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., e decreta il rinvio a giudizio per ben due volte: il 23/06/2009 e difetta la notifica e il 28/09/2010, rinnovando il sequestro preventivo del sito web, mai revocato.
Il Dr. Martino Rosati, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Taranto apre il proc. n. 6383/08 GIP e senza indagini a favore dell’indagato, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., dispone con proprio autonomo decreto il 14/10/2008 il sequestro preventivo del sito web.
Il processo a carico di Antonio Giangrande contraddistinto con il n. 10329/09 RGDT, si apre il 03/11/2009, ma viene chiuso per irregolarità degli atti. Il nuovo processo contraddistinto con il n. 10018/11 RGDT si apre il 01/02/2011.
Solo in data 12 luglio 2012 lo stesso Pm dr. Gioacchino Argentino chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste ed in pari data il giudice dr.ssa Frida Mazzuti non ha potuto non acclarare l’assoluzione di Antonio Giangrande perché il fatto non sussiste. Il Dissequestro del sito web www.associazionecontrotuttelemafie.org non è mai avvenuto e l’oscuramento del sito web è ancora vigente.
Declaratoria di ASSOLUZIONE PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE. Dopo 6 anni, due pubblici Ministeri, un Giudice per l’Udienza Preliminare, tre Giudici monocratici, di cui una, dr.ssa Rita Romano, estromessa con istanza di ricusazione perchè denunciata da Antonio Giangrande, sostituita dalla dr.ssa Frida Mazzuti.
L’inimicizia dei magistrati di Taranto nei confronti di Antonio Giangrande è da ricondurre al fatto che lo stesso ha denunciato alcuni magistrati del foro tarantino, anche perché uno di loro, il sostituto procuratore Salvatore Cosentino, ha archiviato una denuncia contro il suo ufficio, anziché inviarlo alla Procura di Potenza, Foro competente.”
«Pare evidente la tricotomia della responsabilità penale: il movente, il mezzo, l’opportunità. Per questo si chiede la condanna per reati consumati, continuati, tentati, da soli o in concorso con terzi, o di altre norme penali, con le aggravanti di rito, e attivazione d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme amministrative. Altresì si chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato in via equitativa dal giudice competente, per la sofferenza che si è riservata al sottoscritto ed alle persone che mi stimano per la funzione che io occupo e l’umiliazione e, soprattutto, per il dolore difficilmente immaginabili da parte di chi non vive l’incubo di essere accusato di calunnie tanto ingiuste quanto infondate. Nessuna Autorità degna del mio rispetto ha tutelato la mia persona. Le mie denunce contro queste ed altre ingiustizie sono state sempre archiviate. E’ normale allora che io diventi carne da macello penale. E’ normale che io sia lì a partecipare da 16 anni all’esame forense, sempre bocciato, se poi i magistrati, commissari di esame, contro di me fanno questo ed altro.»
E LA CHIAMANO GIUSTIZIA. CHE CAZZO DI INDAGINI SONO?
Il perito non capisce il dialetto: tre anni in cella da innocenti. A causa di intercettazioni mal interpretate due fratelli pugliesi vengono scambiati per mafiosi e sbattuti in carcere. Ora chiedono allo Stato un milione di risarcimento, scrive Peppe Rinaldi su “Libero Quotidiano”. In Italia puoi essere sbattuto dentro e restarci tre anni perché il consulente incaricato di analizzare le intercettazioni è di Bologna e, non capendo il dialetto delle tue parti, interpreta fischi per fiaschi. In Italia puoi esser agguantato d’improvviso insieme a tuo fratello perché «promotori di un sodalizio mafioso» che ti costerà 36 e passa mesi di cella. È possibile questo e pure altro, tanto non accadrà nulla a nessuno: tranne che a te, alla tua famiglia e al tuo lavoro. Vecchia storia, solita storia. La stessa capitata ai fratelli Antonio e Michele Ianno, di San Marco in Lamis (Foggia) che un bel mattino si sono visti ammanettare dalla Dda di Bari. Saranno detenuti «cautelarmente» tre anni uno e tre anni e mezzo l’altro, salvo accorgersi poi che non c’entravano niente, che quel clan non l’avevano mai costituito e che il duplice omicidio in concorso di cui erano accusati non lo avevano compiuto. E neppure un altro tentato omicidio, il porto d’armi illegale, niente di niente. Insomma, si trattava di un gigantesco abbaglio giudiziario. Nel giugno del 2004 il gip del tribunale di Bari firma la richiesta di custodia cautelare del pm della Dda per Antonio e Michele Ianno, poco meno che 40enni all’epoca, di professione «mastri di cantiere», cioè piccoli imprenditori edili formatisi a botte di secchi di calce sulle spalle. Sono considerati promotori di una compagine malavitosa facente capo alle famiglie Martino-Di Claudio, operante nel contesto della così detta mafia garganica. Associazione mafiosa (il “mitico” art. 416 bis), concorso in tentato omicidio e in duplice omicidio, porto illegale di armi, il tutto con l’aggravante di voler favorire i clan. Una gragnuola di accuse da svenire solo a leggerne i capi d’imputazione, un fulmine che incendia la vita dei due. E non solo. La difesa, rappresentata dal prof. avv. Giuseppe Della Monica, prova a spiegare che stavano prendendo un granchio ma quando le cose prendono una certa piega raddrizzarle è impresa titanica. Sarà così tutto un crescendo di ricorsi e controricorsi, un supplizio di “calamandreiana” memoria. In queste storie, in genere o c’è un «pentito» che si ricorda di te oppure, intercettando a strascico in una certa area sensibile, si rischia di scambiare lucciole per lanterne. Se di sbagliato poi c’è anche la relazione di un consulente del pm che - chissà perché scovato a Bologna - fraintende il dialetto pugliese ecco che la faccenda si complica, fino a farsi kafkiana grazie a un’altra ordinanza che colpirà i fratelli, per giunta per gli stessi reati più un’estorsione che prima non c’era: un modo come un altro per mandare a farsi benedire il ne bis in idem. Negli atti si legge un po’ di tutto oltre al sangue versato: appalti del comune di San Marco in Lamis di esclusivo appannaggio degli Ianno mentre invece l’ente attesterà che non era vero esibendo l’elenco delle opere pubbliche; oppure il pericolo di fuga a giustificazione dell’arresto: per la Dda i due s’erano dati alla macchia per evitare lo Stub (il guanto di paraffina) ma la difesa riuscirà a provare che non era così perché un vigile urbano li aveva identificati su un cantiere per le proteste di un vicino disturbato dai rumori proprio il giorno del reato contestato. Siamo nel 2006, due anni sono già trascorsi intanto. La seconda ordinanza viene annullata totalmente in udienza preliminare e il giudice ordina la scarcerazione «se non detenuto per altro motivo». L’altro motivo, però, c’era ed era la prima ordinanza, i cui effetti erano ancora in itinere dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia. Per farla breve, i giudici alla fine si accorgeranno dell’errore della procura e scarcereranno prima Michele e poi Antonio, a distanza di sei mesi uno dall’altro. Inutile dire delle conseguenze dirette ed indirette patite. Risultato? Lo stato prepari un bell’assegno circolare da un milione di euro: tanto hanno chiesto nel 2010 - quando tutto è passato in giudicato - cioè il massimo previsto dalla legge (500mila euro cadauno) per tanta gratuita tragedia. Ovviamente ancora aspettano.
Ed ancora. Correva l’anno 2006. Il 29 settembre, per l’esattezza, scrive di Walter Vecellio su “Libero Quotidiano”. Il luogo: Ruvo del Monte, comune, informano i manuali di geografia, in provincia di Potenza, «situato a 638 metri sul livello del mare, nella zona Nord Occidentale della Basilicata, ai confini con l’Irpinia». A Ruvo del Monte vivono circa milleduecento persone; è da credere si conoscano tutti. E più di tutti, i locali carabinieri, che con il locale sacerdote, evidentemente sono a conoscenza di tutto quello che accade, si fa, si dice. Dovrebbero, si suppone, anche conoscere due fratelli gemelli, Domenico e Sebastiano. Dovrebbero conoscerli bene, perché in paese non deve certo essere sfuggito il fatto che patiscono gravi ritardi mentali. Quando il 29 settembre del 2006 i carabinieri, frugando nella casa dei due fratelli trovano una rivoltella, hanno evidentemente fatto il loro dovere, sequestrandola. Ed è quello che prescrive la legge, quando viene redatto un rapporto che riassume l’accusa in un paio di righe: «Detenzione illegale di arma». I carabinieri si suppone conoscano le armi; se sostengono che si tratta di una pistola fabbricata prima del 1890, si suppone sappiano quello che dicono. E cosa si fa, in casi del genere? Si istruisce un processo; un processo per detenzione di arma illegale che si conclude nel 2012. La sentenza: «Non luogo a procedere». E come mai, nel 2006 la detenzione illegale di arma sei anni dopo diventa «non luogo a procedere»? Come mai, nei fatti e in concreto, il giudice di Melfi assolve pienamente i due fratelli? Perché la pistola non è una pistola; perché non si può detenere illegalmente un’arma che non è un’arma. Perché la pistola che si diceva «fabbricata prima del 1890» in realtà è una pistola giocattolo. I due fratelli l’avevano detto con tutto il fiato che avevano in gola: «Non è un’arma, è un giocattolo». Niente da fare. «Detenzione di arma illegale». Bastava guardarla, quell’«arma illegale»: «Si vedeva subito che era finta, con quella foggia bizzarra che ricalca quelle strette alla cintura dei conquistadores spagnoli del ‘500». Per i carabinieri era «un’arma illegale». I carabinieri come mai erano entrati a casa dei due fratelli? Cercavano oggetti sacri rubati al cimitero del paese. Qui si può immaginare la scena: chi può introdursi in un cimitero per rubare? Degli spostati. E in paese, tutti lo sanno, i due fratelli con la testa non ci sono del tutto. Allora andiamo da loro. Si bussa alla porta, loro aprono. «Si può?». «Prego, accomodatevi». Ecco. E lì, in bella vista «l’arma illegale». Subito in caserma, per l’interrogatorio di rito. Poi l’avviso di garanzia. Passano i giorni, le settimane e i mesi, e arriva l’imputazione: articolo 687 del codice di procedura penale, che punisce appunto la detenzione illegale di armi: dai tre ai dodici mesi, 371 euro di ammenda. Si chiudono le indagini preliminari, c’è il rinvio a giudizio. Finalmente qualcuno pensa di rivolgersi a un perito. Naturalmente è l’avvocato dei due fratelli, non ci pensano né i carabinieri né il Pubblico Ministero. Racconta l’avvocato: «All’apertura della busta contenente la presunta arma idonea a offendere, presenti io, il giudice e il perito tutto si è risolto in una risata. Non c’è stato nemmeno bisogno di una analisi approfondita: una colata unica, un simulacro da bancarella».
Ed Ancora. "Aspettavo questo momento da 36 anni". Giuseppe Gulotta, accusato ingiustamente di essere l'autore del duplice omicidio dei carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, avvenuto nella casermetta di Alcamo Marina il 27 gennaio 1976, lascia da uomo libero il tribunale di Reggio Calabria dove dopo esattamente 36 anni dal giorno del suo arresto (21 gli anni trascorsi in cella) è stato dichiarato innocente. Un nuovo macroscopico caso di malagiustizia, scrive “Libero Quotidiano”. Alla lettura della sentenza, al termine del processo di revisione che si è svolto a Reggio Calabria, Gulotta è scoppiato in lacrime, insieme alla sua famiglia. Accanto a lui c'erano gli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini che lo hanno assistito durante l'iter giudiziario. "Spero - ha dichiarato l'uomo parlando con i giornalisti - che anche per le famiglie dei due carabinieri venga fatta giustizia. Non ce l’ho con i carabinieri - ha precisato - solo alcuni di loro hanno sbagliato in quel momento". Giuseppe Gulotta, nonostante la complessa vicenda giudiziaria che lo ha portato a subire nove processi più il procedimento di revisione, non ha smesso di credere nella giustizia. "Bisogna credere sempre alla giustizia. Oggi è stata fatta una giustizia giusta", ha però aggiunto. Un ultimo pensiero va all’ex brigadiere Renato Olino, che con le sue dichiarazioni ha permesso la riapertura del processo: "Dovrei ringraziarlo perché mi ha permesso di dimostrare la mia innocenza però non riesco a non pensare che anche lui ha fatto parte di quel sistema". Il 26 gennaio 1976 furono trucidati i carabinieri Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo. Ad accusare Gulotta della strage fu Giuseppe Vesco, considerato il capo della banda, suicidatosi nelle carceri di San Giuliano a Trapani, nell'ottobre del 1976 (era stato arrestato a febbraio). Gulotta, in carcere per 21 anni, dal 2007 godeva del regime di semilibertà nel carcere di San Gimignano (Siena). Venne arrestato il 12 febbraio 1976 dai militari dell'Arma dopo la presunta confessione di Vesco. Nel 2008 la procura di Trapani ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di sequestro di persona e lesioni aggravate alcuni carabinieri, oggi in pensione, che nel 1976 presero parte agli interrogatori degli accusati della strage di Alcamo Marina: il reato contestato agli agenti è quello di tortura nei confronti degli interrogati.
Dall’altra parte ci troviamo al paradosso. Il killer ha confessato 30 delitti e ha fatto luce su altri 50. Pentitosi di essere diventato un collaboratore di giustizia ha ricominciato dedicandosi allo spaccio di droga. Per questo era stato riammanettato e condannato a 20 anni di galera, scrive Peppe Rinaldi su “Libero Quotidiano”. C’è un signore che ha confessato trenta omicidi e ha fatto luce, con dichiarazioni ad hoc, su altri cinquanta. Era un «pentito» di camorra che, pentitosi del pentimento, ricominciò alla grande sbarcando in Emilia Romagna per dedicarsi alla spaccio internazionale di droga. Ovviamente, in associazione (a delinquere) con altri. Lo stesso signore, riammanettato e condannato a 20 anni nel secondo grado del nuovo giudizio, invece che starsene in gattabuia circola liberamente per le strade di Afragola, popoloso centro dell’hinterland napoletano celebre per essere anche la città d’origine di Antonio Bassolino. Si chiama Mauro Marra, è tecnicamente un libero cittadino perché i suoi giudici naturali non hanno trovato il tempo di rifargli il processo come aveva loro intimato la Corte di Cassazione: sono scaduti i così detti «termini di fase», non c’è più nulla da fare, se riuscite a fargli nuovamente il processo che spetta a ogni cittadino italiano indipendentemente dal reato commesso (si chiama civiltà giuridica) bene, altrimenti Marra deve starsene a casa, come per ora già sta facendo. È una storia incredibile ma vera, neanche tanto originale se si considera lo stato comatoso del servizio giustizia nel Paese. Ne ha scritto ieri il più antico quotidiano italiano, il Roma. Quando parli di Mauro Marra non ti appare il ragazzotto di Scampia, imbottito di cocaina scadente e pronto a sparare anche per 200 euro. No, parli di uno che non solo ha ucciso trenta avversari del clan nemico, non solo era nei programmi strategici per fare altrettanto con ulteriori 50 persone (cosa che si verificò) ma addirittura di uno dalla cieca fede in Raffaele Cutolo (l’ultimo, vero, padrino) e braccio destro di Pasquale Scotti, latitante da 28 anni che difficilmente qualcuno, ormai, prenderà. Sempre che sia vivo. Marra, poi, è ancora molto altro: è il super killer della Nco (Nuova camorra organizzata) che sbugiardò gli accusatori di Enzo Tortora aprendo uno squarcio su una delle punte massime del disonore del sistema giudiziario. «Hanno accusato un innocente» disse in aula il 25 settembre 1985, riferendosi alle «visioni» dei vari Barra, Melluso, Auriemma, Catapano, Pandico e Dignitoso. Anche grazie a quella presa di posizione per l’ex presentatore televisivo fu possibile risalire la china ed ottenere -diciamo- giustizia. Scansata la matematica sfilza di ergastoli grazie alla legge sul pentitismo, dopo una ventina d’anni riprese a delinquere e finì incarcerato nel 2006 mentre era in una località protetta del Nord. Il 26 marzo 2009 la I sezione penale lo condanna a 18 anni; in secondo grado la IV Corte d’Appello di Napoli gli aumenta la pena a venti. Siamo nel dicembre 2011. Il 21 novembre scorso la Cassazione ribalta tutto rinviando gli atti a Napoli per una nuova sentenza: i tre anni entro cui i magistrati avrebbero dovuto rendere definitiva la pena (i termini di fase) sono trascorsi vanamente e, pertanto, Marra deve essere scarcerato. Ovviamente il lavoro minuzioso di ricostruzione degli avvocati (Antonio Abet e Giuseppe Perfetto) è stato determinante. Da una settimana il pluriomicida è libero. Aspetta che la sentenza diventi definitiva. Non è scritto però da nessuna parte che i giudici di II grado lo condannino, così come è altrettanto probabile che ricorra, eventualmente, ancora in Cassazione. E il tempo passa. Ma sarà senz’altro colpa dei cancellieri che mancano, degli stenografi che non si trovano o della carta per fotocopie che scarseggia.
IL SEGRETO DI PULCINELLA. LA MAFIA E’ LO STATO.
"Le istituzioni ci hanno abbandonato", sostiene l'ex boss del clan dei Casalesi e collaboratore di giustizia a “Sky tg 24”. E poi: le terre del Sud sono state avvelenate, "il vero affare del clan è il traffico dei rifiuti dal Nord e dall'Europa". "Se potessi tornare indietro non mi pentirei. Sono pentito di essermi pentito e non lo farei più perché le istituzioni ci hanno abbandonato. Quando non sono riusciti ad ammazzarmi materialmente, hanno cercato di distruggermi economicamente, moralmente”. Queste le parole di Carmine Schiavone, ex boss di camorra del clan dei Casalesi, intervistato in esclusiva da SkyTG24. Collaboratore di giustizia per 20 anni, dal 1993, a luglio ha terminato il suo programma di protezione. Ha ordinato l'esecuzione di centinaia di omicidi e con le sue rivelazioni ha permesso le condanne definitive all'ergastolo per i boss e gregari del clan imputati nel processo Spartacus e ha fornito importanti informazioni anche sul vero business dei Casalesi: quello dello smaltimento dei rifiuti tossici. "Ero uno dei capi della cupola, ma mi sono pentito davvero perché altrimenti quelle carte lì non le avrei mai scritte. Il mio guaio - aggiunge Schiavone - è stato proprio quello di essermi pentito veramente perché in Italia non c’era una giustizia, una legge, un politico che sappia capire questo. Chi me lo ha fatto fare di vivere in questo mondo di cani rognosi perché è vero che noi abbiamo sparato, ma i ministri, i carabinieri, i magistrati, i poliziotti sono più responsabili di me perché hanno permesso questo. Io ho sbagliato nella mia vita e ho cercato di rimediare quando la mia coscienza si è ribellata a certi soprusi commessi da altri. Tutti quanti hanno fatto facile carriera sulla mia pelle”. Schiavone, nel corso dell’intervista a SkyTG24, parla anche dei rifiuti tossici interratti dal lungo mare di Baia Domizia fino a Pozzuoli. E aggiunge: "La mafia non sarà mai distrutta perché ci sono troppo interessi, sia a livello economico sia a livello elettorale. L’organizzazione mafiosa non morirà mai".
Camorra, parla il pentito Schiavone: "Abbiamo ordinato oltre 500 omicidi". Intervista a Sky Tg24 del feroce ex boss dei Casalesi, testimone di giustizia dal '93: "Ministri, carabinieri, magistrati, poliziotti sono più responsabili di me perché hanno permesso questo". "La mafia non sarà mai distrutta, ci sono troppo interessi", scrive Conchita Sannino su “La Repubblica”. "Chi me lo ha fatto fare di vivere in questo mondo di cani rognosi. Sì, lo dico: sono pentito di essermi pentito". Così parla Carmine Schiavone, l'ex capo killer e super-ragioniere del gotha dei Casalesi, in un'intervista concessa a Sky Tg 24. E' l'assassino (per almeno 53 volte) che con le sue fluviali dichiarazioni rese ai magistrati antimafia nei primi anni Novanta, aprì alla giustizia il primo varco nel bunker degli impenetrabili segreti della mafia casertana. Ed è anche il cugino del famoso ed omonimo boss Francesco Schiavone, quel Sandokan tuttora rinchiuso al 41 bis sotto il peso di numerosi ergastoli, il padrino che non ha mai voluto seguire l'esempio di Carminiello. Ora Carmine recrimina sul suo rapporto con lo Stato. E premette: "Io ho sbagliato nella mia vita e ho cercato di rimediare quando la mia coscienza si è ribellata a certi soprusi commessi da altri. Tutti quanti hanno fatto facile carriera sulla mia pelle". Schiavone è stato accusato di aver dato l'assenso o partecipato complessivamente a 53 omicidi. Lui fa spallucce rispetto a quel numero. "Io coinvolto in 53 omicidi? Molti di più, ci sono 500 e rotti omicidi fatti (il riferimento è alle varie faide consumate tra opposte fazioni). Ma non è che li ho proprio ordinati tutti io, è che ero uno dei capi della cupola". Poi , nel corso della stessa intervista, firma la facile profezia secondo cui finché le mafie sposteranno i voti "l'organizzazione non finirà mai". Spiega: "Noi spostavamo 70-80mila voti, significava la differenza tra la vittoria di un partito e un altro". E dà la pagella a quelle divise, o magistrati o politici comprati o corrotti proprio da quelli come lui. Schiavone affronta anche il tema dei rifiuti tossici interrati, dal lungomare di Baia Domizia fino a Pozzuoli. "La mafia - conclude - non sarà mai distrutta perché ci sono troppo interessi, sia a livello economico sia a livello elettorale. L'organizzazione mafiosa non morirà mai". Vero è che Carmine Schiavone ha dato una spallata consistente al lavoro dei pubblici ministeri antimafia. Ha collaborato alla prima costruzione di quel super processo che avrebbe spazzato in carcere tutti i vertici dei casalesi: Spartacus I e Spartacus II. Ma, superata anche la boa dei settant'anni, ora riserva l'ennesima confessione choc. "Se potessi tornare indietro non mi pentirei - dice - Io mi sono pentito davvero, se no tutte quelle carte non le avrei date. Ma qui non siamo in America. Io mi sono pentito veramente, quello è stato il guaio. Perché non c'è un politico che sappia guardare davvero un pentito, non siamo negli Stati Uniti. E non lo farei più : perché qui le istituzioni ci hanno abbandonato. Quando non sono riusciti ad ammazzarmi materialmente, hanno cercato di distruggermi economicamente, moralmente". Poi spara a zero su politici, divise e magistrati inquinati. "Noi mantenevamo una buona parte delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia. A me alla sera mi veniva portata la striscetta dalla polizia, con le operazioni che avrebbero fatto il giorno successivo". E in cambio, cosa offriva l'organizzazione criminale? "Gli davamo ogni tanto qualcuno, qualche piccolo spacciatore, per fargli fare carriera". E aggiunge: "Noi sì, è vero che abbiamo sparato. Però un ministro, un magistrato, un carabiniere e un poliziotto, che si sono venduti, sono più responsabili di noi". Irascibile, amante delle iperboli, ma sempre stratega. Carmine Schiavone è colui che rivelò, fin dalle sue prime dichiarazioni, il concepimento di un vero e proprio Stato Mafia da parte dell'organizzazione criminale del casertano. "Noi avevamo la nostra idea. Dovevamo formare, per la fine del millennio, i nostri giovani come degli infiltrati dentro lo Stato: quindi dovevano diventare magistrati, poliziotti, carabinieri e perché no, anche ministri e presidenti del Consiglio. Per avere i nostri referenti nelle istituzioni". Lo stesso Schiavone , non più di qualche mese fa, in un'aula di giustizia, proclamava a voce alta, nello scontro verbale con un avvocato di parte avversa: "Ma io non sono mai stato un camorrista. Io ero un uomo d'onore". Così come aveva destato scalpore un altro racconto reso in aula, secondo cui don Peppino Diana, noto parroco antimafia ucciso da una fazione dei casalesi avversa agli Schiavone a Casal di Principe nel 1994, avrebbe aiutato più volte durante le elezioni i "candidati politici vicini agli Schiavone, tra cui Nicola Cosentino", l'ex deputato del Pdl oggi agli arresti domiciliari e imputato in due processi a Santa Maria Capua Vetere. Violento, e vendicativo. Sembra che la sua vita di cittadino sotto copertura in località segreta gli sia sempre stata strettissima, procurandogli non pochi dispiaceri familiari. Finì a processo persino quando suo figlio fu arrestato per la detenzione di un vero e proprio arsenale nel periodo in cui lui era già pentito e doveva dimostrare di non saperne nulla: un ispettore di polizia raccontò, in aula, che quel ragazzo voleva sparare a suo padre. "Aveva un sacco di problemi, quel figlio veniva seguito anche dall'assistenza sociale. Non aveva mai perdonato al padre di essersi pentito e di aver perso potere, denaro, rispetto e riconoscibilità sui loro territori".
Tirato fuori dopo decenni, giovedì 31 ottobre 2013 il documento che denuncia la collusione dello Stato con le organizzazioni mafiose. In data 31 Ottobre il Parlamento ha fatto ciò che non ha mai voluto fare in passato, scrive “News You-ng”. Tutti i governi, di destra e di sinistra, dal 1997 in poi non hanno mai tolto il segreto di stato posto 16 anni fa sul verbale di 63 pagine concernente le dichiarazioni e le prove che il boss mafioso Carmine Schiavone, appartenente alla “Cosa Nostra Campana” (cioè il clan dei casalesi), ha consegnato ai giudici e ai parlamentari presenti nella Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Il boss noto come il “cugino di Sandokan“, non solo ha indicato tutti i siti in cui sono stati intombati i rifiuti, ma ha anche sottolineato più e più volte che quei rifiuti prima o poi “uccideranno tutta la povera gente“. In un’intervista di venerdì scorso a Le Iene (in onda su Italia Uno), Schiavone descrive con disprezzo la reazione del governo, dell’amministrazione locale e di tutti coloro che avrebbero dovuto predisporre le bonifiche dicendo: “Mi sono sentito dire che non hanno i soldi, in nome dei soldi lasciano che tutta questa gente muoia…“. “Da che pulpito viene la predica” verrebbe da dire, anche perché a sotterrare quei rifiuti è stata proprio la Cosa Nostra Campana che lucra maggiormente col traffico di droga e il traffico dei rifiuti tossici e nucleari e che oggi potrebbe voler lucrare sulle bonifiche. Ma Carmine Schiavone non ci sta a queste dietrologie, lui dice che si è pentito “per un fatto di coscienza”, una coscienza che dovrebbe pesargli tanto dopo aver ucciso con le sue stesse mani di “50 o 70 persone”… Non riesce nemmeno a contarle ma afferma che “però erano tutti colpevoli perché appartenevano ai clan avversari“. Una personalità davvero sui generis quella del boss pentito, che però consegna nomi, cognomi e numeri di targa anche dei camionisti e delle ditte di trasporti che si sono occupati nella propria vita del trasporto di rifiuti. Almeno quelli che conosce lui, uno dei massimi esponenti della mafia casertana. Perché di mafia si tratta, Schiavone ci tiene a precisare che il clan dei casalesi non è “Camorra” come Saviano ha tentato di insegnarci, ma “Mafia” affiliata a quella siciliana di cui parla anche con un certo disprezzo. Infatti quando il giornalista gli chiede: “Ma chi ha ucciso il giudice Giovanni Falcone?”, Schiavone risponde pesando molto bene le parole: “Materialmente chi può essere, solo quell’ignorante di Riina o quel pecoraio di Provenzano. I giudici si corrompono, non si ammazzano, non si fa un allarme sociale di questo genere, solo che loro non volevano essere corrotti e allora li hanno uccisi“. Fubini continua: “Ma allora chi li ha uccisi?” e Schiavone risponde: “Loro materialmente, ma gli ha detto di ammazzarli?“. Il giornalista incalza: “Chi?“. A quel punto Schiavone dice una cosa che fa rabbrividire: “Vuoi che ci prendiamo una denuncia per calunnia io e te o vuoi essere ammazzato da qualcuno qui fuori? Ma tu che pensi: i segreti di Stato… lo sai quanti ce ne stanno sepolti?“. Ha consegnato allo Stato particolari scottanti che valgono molto, ma ha consegnato anche 2500 miliardi di beni e ha fatto arrestare 1500 persone, ha fatto condannare persone per centinaia e centinaia di anni di galera ed è grazie a lui se son stati sentenziati un centinaio di ergastoli. In pratica Schiavone si vanta di aver distrutto la Mafia “sia a livello internazionale, sia nazionale”. Lui in compenso però si è fatto 10 anni e mezzo e basta, perché è un pentito. Carmine Schiavone è quello che non si stupisce della Trattativa Stato Mafia, infatti ha detto che “la Mafia fa parte dello Stato“, solo che è un braccio nascosto di questo sistema. Non c’è da stupirsi insomma, soprattutto quando si parla di continuità o di trattativa tra Stato e Mafia. Non c’è niente da stupirsi soprattutto se lo Stato sapeva che sarebbero morti tutti con i rifiuti nucleari sepolti, intombati sotto la falda acquifera. Sarebbe bastato che si abbassasse la falda acquifera per portare i danni di questi rifiuti a decine e decine di chilometri di distanza. Il bacino imbrifero si reticola per chilometri. Per dare l’idea di quanto sia pericoloso porre dei rifiuti vicino alla falda acquifera, facciamo l’esempio dell’Irpinia che oggi combatte contro le compagnie petrolifere che vorrebbero trivellare per l’estrazione di petrolio. Premesso che le trivellazioni provocano terremoti come hanno sostenuto in questi anni molti scienziati e premesso che gli acidi perforanti sono composti da sostanze altamente tossiche di cui non si conosce la composizione perché coperte dal segreto industriale, è stato stimato che l’inquinamento delle falde acquifere in Irpinia potrebbe portare danni fino a Reggio Calabria. Ma in Campania l’inquinamento delle falde acquifere interessa moltissimi siti: da Pianura ad Acerra, da Caserta a Somma Vesuviana, da Terzigno a tutta l’area Nord della città partenopea, dall’agro nolano ad Orta di Atella dove si è formato un vero e proprio lago grazie ai barili chimici discioltisi nelle acque sotterranee. Con quelle stesse acque gli agricoltori innaffiano pomodori e peperoni e tutte le colture dei vari vegetali che arrivano sulle tavole locali ma che vengono appaltate anche da prestigiose aziende dell’agroalimentare e quindi distribuite in tutta Italia e, in alcuni casi, anche in Europa. Una popolazione ingannata quindi non solo dalla Mafia e dalla Camorra, ma anche dallo Stato. Servivano davvero 16 anni per desecretare queste 63 pagine? Ed ora che sono state rese note cosa ne sarà del registro tumori il cui finanziamento fu bloccato nel settembre 2012 proprio dal governo monti che impugnava la legge regionale del 19 Luglio dello stesso anno in cui la giunta Caldoro (PDL) disponeva il finanziamento del registro per 1,5 milioni? Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano era Ministro dell’Interno all’epoca delle dichiarazioni. Sapeva tutto sulla sua città natale, Napoli. Come poteva non sapere delle dichiarazioni rilasciate alla Commissione parlamentare d’inchiesta sui rifiuti? Oggi che le dichiarazioni sono state desecretate dopo ben 16 anni, si sono espressi tutti su questo piccolo ma significante particolare. Le dichiarazioni più addolorate sono quelle di Antonio Marfella, Presidente dell’Isde Medici per l’Ambiente, il quale si è sfogato su Facebook con queste parole: “Scoprire che Giorgio Napolitano era il Ministro dell’interno all’epoca delle dichiarazioni secretate di Schiavone è una notizia che mi da un dolore profondo, insopportabile, veramente una pugnalata in petto. Ve lo giuro. Non me lo aspettavo….”. Lo stesso Giorgio Napolitano chiamato a testimoniare per il processo sulla Trattativa Stato Mafia, lo stesso Giorgio Napolitano per cui venne ordinata la “distruzione dei nastri delle intercettazioni usate come prove per la Trattativa”. Perchè una simile disposizione? Cosa c’era in quei nastri? ”Per le bonifiche non ci sono soldi” dicono le amministrazioni locali, ma quando questi soldi usciranno l’unica speranza è che non vadano a quei criminali che hanno ucciso decine e decine di migliaia di persone in questi 30 anni di avvelenamento.
Rifiuti, la Camera rende pubblica la deposizione di Carmine Schiavone: «Quei camion dal nord» (da Il Mattino – 31.10.2013), scrive Chiara Graziani. Il pentito dei Casalesi nel ’97 indicò i luoghi degli sversamenti: «Fra vent’anni lì moriranno tutti di tumore. Per ogni fusto tossico 500mila lire a noi, due milioni a chi doveva smaltire». Cade il segreto sulla deposizione del pentito dei Casalesi Carmine Schiavone, deposizione rilasciata nel remoto ’97 davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti. All’epoca parve tanto deflagrante da richiedere la segretazione. Oggi, una decisione dell’ufficio di presidenza della Camera, presa all’unanimità, ci restituisce la verità di Carmine Schiavone. Una verità detta, ormai, 16 anni fa. Dalla viva voce del pentito dei Casalesi torna la descrizione di anni impuniti e criminali: alcune cose già note, altre tutte da scandagliare. Schiavone, ad esempio, elenca i luoghi dove finivano i rifiuti tossici dalla Germania e dall’Italia del centro nord, portati con i camion nelle discariche. Dice di aver già detto tutto “all’autorità giudiziaria”, di avere accompagnato sui luoghi gli investigatori. Racconta che sopra i veleni, appena ricoperti di terra, poi qualcuno ci allevava le bufale. Il tutto in un clima descritto come di generale collaborazione per cui, secondo i ricordi di Schiavone, «la discarica autorizzata faceva scaricare là, attraverso i clan». I rifiuti partivano da fuori la Campania, racconta, inviati da altre amministrazioni e con destinazione discariche autorizzate. Finivano, invece, smaltiti nel terreni dei clan, racconta il pentito. Ricostruzioni già note, in gran parte. Ma la forza del documento sta nell’essere così remoto e così attuale. E di svelarci la mentalità “statale” della camorra, totalmente indifferente ai destini delle persone. Perfino burocratica e banale. Così è stata devastata la Campania. Da persone così. Col registro sottobraccio. Fra le altre cose dal documento emerge il completo controllo dei Casalesi sui subappalti per le opere stradali. Controllo che dava loro la gestione di tutti gli scavi. Per questo sarebbe stato proposto a Schiavone, si legge nella deposizione, lo smaltimento di fusti tossici fin nel 1988. Lui, a quel punto, si sarebbe accorto che “qualcuno”, però, aveva già iniziato a sfruttare l’affare ma che teneva per sè i proventi. Circa 700 milioni al mese. Segue l’affermazione scioccante: «Arrivavano camion di fanghi nucleari (sic) dalla Germania. E hanno scaricato nelle discariche». Ad un certo punto Carmine Schiavone ha un lapsus che fa innervosire il presidente Scalia che lo interroga. Spiega che, secondo lui, «mio cugino (Francesco Schiavone) , Mario Iovine e Bidognetti», già prima del ’90 avrebbero fatto attività di smaltimento illegale di rifiuti, senza versare però nelle casse del clan. «Fino al ’90 – sentenzia quasi sdegnato – hanno rubato . Poi hanno iniziato a versare soldi nella casse dello Stato..(…) Era un clan di Stato, mi sono confuso». Alla protesta di Scalia (“Il vostro Stato!”) Schiavone non si scompone e dice: «La mafia e la camorra non potevano esistere se non era (sic) lo Stato». Così parlava 16 anni fa l’uomo che teneva il registro sotto il braccio e si arrabbiava se qualcuno faceva la cresta mentre lui teneva la contabilità dei fusti tossici, prezzo di smaltimento 500mila lire l’uno. Veleni gettati nei campi, nelle falde acquifere (“Le bucavamo, ci passavamo attraverso, avevamo il controllo totale di tutti gli scavi”). E lui prendeva nota e faceva la somma. Cinquecentomila a noi, e voi ve ne mettete in tasca due milioni secchi a fusto. Da registrare lo stupore nel quale procede l’interrogatorio, nel remoto ’97. Domanda del presidente, che quasi non trova le parole:«Lei è in grado di fare una stima..Quante tonnellate..quanti camion..». Preciso, l’uomo del registro risponde: «Qui si parla di milioni, non di migliaia…Si tratta di milioni e milioni di tonnellate». Ma è la storia dei fanghi nucleari che non può restare sospesa, mostruosa, lugubre. Può dirci qualche cosa di più, chiede Scalia? «So solo che questi fanghi arrivavano in cassette di piombo da 50, un po’ lunghe. Ma mica andavo a vedere l’immondizia di notte..», No, non c’era bisogno che Schiavone seguisse l’affare di notte. Ci pensava il “sistema militare” messo su per gestire il territorio ed il flusso dei rifiuti. Incensurati, con il porto d’armi, con l’auto di dotazione. Pattuglie che, all’occorrenza, potevano usare palette e divise di carabinieri, polizia, finanza. Le forze dell’ordine dei Casalesi. Con un “coordinamento un po’ massonico, un po’ politico”. Laura Boldrini, presidente della Camera, si è detta molto soddisfatta: «Esprimo grande soddisfazione – ha detto Boldrini – per la decisione di togliere il segreto sui contenuti dell’audizione che il collaboratore di giustizia Carmine Schiavone svolse nell’ottobre 1997 alla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti». «Si tratta della prima volta che la presidenza della Camera – senza che questo sia richiesto dalla magistratura – decide di rendere pubblico un documento formato da commissioni di inchiesta che in passato lo avevano classificato come segreto».
“La mafia e la camorra non potevano esistere se non era lo Stato … Se le istituzioni non avessero voluto l’esistenza del clan, queste avrebbe forse potuto esistere?….All’epoca tenevo ancora il relativo registro, in cui figurava che per l’immondizia entravano 100 milioni al mese, mentre poi mi sono reso conto che in realtà il profitto era di almeno 600-700 milioni al mese….Sono inoltre al corrente del fatto che arrivavano dalla Germania camion che trasportavano fanghi nucleari, che sono stati scarica nelle discariche, sulle quali sono stati poi effettuati rilevamenti aerei tramite elicotteri: da qualche verbale dovrebbe risultare che ho mostrato quei luoghi…..Vi erano fusti che contenevano tuolene, ovvero rifiuti provenienti da fabbriche della zona di Arezzo: si trattava di residui di pitture.…I rifiuti venivano anche da Massa Carrara, da Genova, da La Spezia, da Milano….Vi sono molte sostanze tossiche, come fanghi industriali, rifiuti di lavorazione di tutte le specie, tra cui quelli provenienti da concerie….. è diventato un affare autorizzato, che faceva entrare soldi nelle casse del clan. Tuttavia, quel traffico veniva già attuato in precedenza e gli abitanti del paese rischiano di morire tutti di cancro entro venti anni; non credo, infatti, che si salveranno: gli abitanti di paesi come Casapesenna, Casal di Principe, Castel Volturno e così via avranno forse venti anni di vita!….Qui si parla di milioni, non di migliaia. Se lei guarda l’elenco che le ho consegnato, vedrà che ci sono 70-80 camion di quelli che smaltivano dal nord, tra i quali vi era anche un mio camion. Si tratta di milioni e milioni di tonnellate. Io penso che per bonificare la zona ci vorrebbero tutti i soldi dello Stato di un anno…..Fino al 1992 noi arrivavamo nella zona del Molise (Isernia e le zone vicine), a Latina … Non so cosa è accaduto dopo. Se vogliono, possono arrivare anche a Milano ….In tutti i 106 comuni della provincia di Caserta. Noi facevamo i sindaci, di qualunque colore fossero. C’è la prova … Io, ad esempio, avevo la zona di Villa Literno e sono stato io a fare eleggere il sindaco. Prima il sindaco era socialista e noi eravamo democristiani. Dopo la guerra con i Bardellino… Ci avrebbe fatto piacere anche se fosse rimasto socialista, perché era la stessa cosa. Per esempio, a Frignano avevamo i comunisti. A noi importava non il colore ma solo i soldi, perché c’era un’uscita di 2 miliardi e mezzo al mese. Posso raccontare un aneddoto, anche perché è già stato verbalizzato ed i protagonisti sono agli arresti, tranquilli. A Villa Literno, che era di mia competenza, ho fatto io stesso l’amministrazione comunale. Abbiamo candidato determinate persone al di fuori di ogni sospetto, persone con parvenze pulite ed abbiamo fatto eleggere dieci consiglieri, mentre prima ne prendevano tre o quattro. Un seggio lo hanno preso i repubblicani, otto i socialisti ed uno i comunisti (un certo Fabozzo). La sera li abbiamo riuniti e ne mancava uno. Io li ho riuniti e ho detto loro: “tu fai il sindaco, tu fai l’assessore e via di questo passo. Mi hanno detto: “ma manca un consigliere per avere la maggioranza”. All’epoca c’era Zorro, il quale era capo zona e dipendeva da me; ho detto: andate a prendere Enrico Fabozzo e lo facciamo diventare democristiano. Infatti, lo facemmo assessore al personale. La sera era comunista e la mattina dopo diventò democristiano. E così che si facevano le amministrazioni. Il patto era che gli affari fino a 100 milioni li gestiva il comune, oltre i 100 milioni, con i consorzi, ci portavano l’elenco dei lavori e noi li assegnavamo. Ai comuni dicevamo che sui grandi lavori avrebbero trattato direttamente con noi al 2,50 per cento. C’era una tariffa: 5 per cento sulle opere di costruzione e 10 per cento sulle opere stradali. Perché le strade si debbono rifare ogni anno? Perché non venivano fatte bene, perché se il capitolato stabiliva che vi dovessero essere sei centimetri di asfalto, in realtà ne venivano messi tre, perché il cemento utilizzato non era quello previsto, e così via. Il sistema generale era così. Speriamo che cambi….Il mercato dei rifiuti in Italia è uno solo e veniva tutto gestito da poche persone. Poi i clan si sono intromessi e hanno detto (come hanno fatto per le strade): noi vi facciamo passare i camion, non ve li distruggiamo, ma ci dovete dare tanto. Poiché era più conveniente dare ai clan che lavorare di nascosto … Ma per poter fare ciò serviva gente che entrasse in queste associazioni culturali, quindi gente intelligente, che studiava…..” Carmine Schiavone - audizione dell’ottobre del 1997 davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo di rifiuti.
Carmine Schiavone, l’esperto di finanza del clan dei Casalesi, l’uomo che muoveva i miliardi degli affari illeciti dell’associazione camorristica si apre alle telecamere di Sky Tg24 e alla maniera sua avverte che ancora tanta gente è destinata a morire a causa dei rifiuti tossici che giacciono nel sottosuolo del basso Lazio e Campania, finanche nella loro stessa terra, Casal di Principe. Esce dal processo Spartacus dove come pentito ha svelato i movimenti economici dell’intero clan ma avverte pure che le mafie sopravviveranno e che nessuno sarà in grado di sconfiggerle (e sembra non sia una minaccia quanto una promessa). L’intervista dura 9 minuti e è agghiacciante per due motivi: per il messaggio che manda alle istituzioni, ovvero che non sono migliori della camorra e perché avverte che una bomba a orologeria di veleni e scorie nucleari è destinata a esplodere a breve nel basso Lazio a Latina dove nelle cave sono interrati fusti con rifiuti nucleari. Il che già ha scatenato le reazioni di tutti quei movimenti che da tempo lottano nella Terra dei Fuochi per essere ascoltati proprio da quelle istituzioni che Schiavone non esita a definire corresponsabili con la camorra. E ne spiega il perché: Ci sono forti interessi a livello economico a livello elettorale e noi spostavamo 70 mila 80 mila voti da un partito all’altro e questo faceva la differenza nelle elezioni. Ma si stanno a rendere conto che ci stanno 5 milioni di persone a morire? Abbiamo scelto basso Lazio e Campania perché facevano parte dei Casale. Era terra nostra. Caso ha voluto che proprio il giorno prima su Avvenire don Maurizio Patriciello il prete di Caivano che si batte contro l’omertà e la strage nella Terra dei fuochi scrivesse: Vedere morire i figli è qualcosa di orrendo, insopportabile. Soprattutto se si poteva evitare. Il popolo semplice non riesce a capire il motivo di tanti ritardi e omissioni, di questo lasciar mano libera a chi viola la legge, a chi uccide. E comincia a serpeggiare il pensiero che, in realtà, non si voglia proprio intervenire. Che sia in atto una strategia per non arrivare a soluzioni. Che si voglia nascondere qualcosa o qualcuno. Che questa situazione «faccia comodo» a tanti. Non ha tutti i torti, la povera gente. Si sente presa in giro. I verbi coniugati da chi comanda sono sempre al futuro: faremo, diremo, provvederemo. Calato il sipario dell’occasione pubblica, resta solo un silenzio angosciante. E la gente muore, di cancro. E la Campania ancora non ha un registro tumori. E il nuovo ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ancora non viene a vedere con i suoi occhi che cosa sta accadendo in questa regione bella e disgraziata. E si fanno illazioni… Qui si agonizza e si lotta tra fuochi e fumi assassini, e chi ci governa e ci rappresenta ancora pronuncia parole come fumo leggero. Queste morti sono sempre più dolorose e insopportabili. Si muore per motivi vergognosi ed evitabili. Per silenzi omertosi. Per denaro e per potere. Ma chi se non lo Stato, nel quale continuiamo caparbiamente a credere e a sperare, deve prendere di petto la situazione?
Come risponderanno, se risponderanno, politica e istituzioni?
«Esprimo grande soddisfazione per la decisione di togliere il segreto sui contenuti dell’audizione che il collaboratore di giustizia Carmine Schiavone svolse nell’ottobre 1997 alla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti’»: così Laura Boldrini, sulla decisione dell’Ufficio di Presidenza. «Si tratta della prima volta che la Presidenza della Camera - senza che questo sia richiesto dalla magistratura - decide di rendere pubblico un documento formato da Commissioni di inchiesta che in passato lo avevano classificato come segreto». «Lo dovevamo in primo luogo - ha proseguito la presidente della Camera - ai cittadini delle zone della Campania devastate da una catastrofe ambientale cosciente e premeditata, come ho avuto modo di dire anche recentemente a Pollica, per la commemorazione dell’assassinio del sindaco Angelo Vassallo: cittadini che oggi hanno tutto il diritto di conoscere quali crimini siano stati commessi ai loro danni per poter esigere la riparazione possibile. Troppo spesso, nella storia del nostro Paese, il segreto è stato infatti invocato non a tutela non dei diritti di tutti ma a copertura degli interessi di alcuni. La fiducia nelle istituzioni - ha sottolineato Laura Boldrini - si rinsalda anche facendo luce su zone d’ombra immotivate e perciò inaccettabili all’opinione pubblica».
Ecomafia, la profezia del boss Schiavone: "Gli abitanti del Casertano moriranno di cancro". Le parole del pentito del clan dei Casalesi nel 1997: "C'erano camion con sostanze tossiche". Poi l'accusa alla cosca: "Aveva affari milionari", scrive “Libero Quotidiano”. "Entro venti anni gli abitanti di numerosi comuni del Casertano rischiano di morire tutti di cancro". Furono queste le parole che il pentito del clan dei Casalesi, Carmine Schiavone, profetizzò nel corso dell'audizione dell'ottobre del 1997 davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta su mafia e rifiuti tossici. Verbali che solo oggi, dopo la rimozione del segreto, sono diventati pubblici: "un segnale di trasparenza e attenzione da parte dell'ufficio di presidenza della Camera nei confronti delle popolazioni della Campania, colpite dal dramma dei rifiuti tossici", come ha sottolineato Valeria Valente, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati. La profezia - "Quel traffico veniva già attuato in precedenza. Gli abitanti del paese rischiano tutti di morire di cancro entro vent'anni; non credo infatti che si salveranno: gli abitanti di paesi come Casapesenna, Casal di Principe, Castel Volturno e così via, avranno, forse, venti anni di vita", ribadiva Schiavone sedici anni fa, per poi spiegare: "C'erano camion che arrivavano dalla Germania, camion che trasportavano fanghi nucleari, che sono stati scaricati nelle discariche, sulle quali sono stati poi effettuati rilevamenti tramite elicotteri. Lì ci sono i bufali e non cresce più l'erba. C'erano rifiuti anche da Genova, Massa Carrara, La Spezia e Milano. Erano sostanze tossiche, come fanghi industriali, rifiuti di ogni tipo di lavorazione". Il pentito del clan dei Casalesi raccontava anche degli affari milionari della cosca: "Con i soldi del traffico di rifiuti - diceva - si pagavano i mensili agli affiliati, le spese per i latitanti, gli avvocati, circa due miliardi e mezzo di lire al mese, comprese le spese extra. Per l'immondizia entravano nelle casse del clan dei Casalesi circa 600-700 milioni di lire al mese". Le ecomafie - Carmine Schiavone, durante l'audizione del '97, ricostruiva la genesi dell'ecomafia del Casertano: "A cominciare furono mio cugino Sandokan e Francesco Bidognetti". Poi, ecco spuntare Cerci e Chianese: "Il potere del clan crebbe anche perché gestivano il ciclo di smaltimento dei rifiuti". "In tutti i 106 comuni della provincia di Caserta noi facevamo i sindaci, di qualunque colore fossero. C'è la prova. Io ad esempio avevo la zona di Villa Literno e sono stato io a far eleggere il sindaco. Prima era socialista e noi eravamo democristiani. A Frignano avevamo i comunisti. A noi non importava il colore ma solo i soldi, perché c'erano uscite di due miliardi e mezzo al mese".
Il traffico illegale delle scorie pericolose, i fusti tossici interrati nelle cave, le coperture politiche e massoniche, la maledizione del cancro, scrivono Antonio Castaldo e Antonio Crispino su “Il Corriere della Sera”. L’anno è il 1997, il collaboratore Carmine Schiavone aveva già raccontato tutto. È l’audizione davanti alla commissione parlamentare sulle Ecomafie del pentito che con le sue confessioni ha fatto crollare il clan dei Casalesi. L’operazione Spartacus risale a due anni prima. Di rifiuti interrati e di rischi per la salute non si parlava ancora. E non se ne parlò neanche negli anni successivi, perché le dichiarazioni del cugino di Francesco «Sandokan» Schiavone sono rimaste secretate per oltre 16 anni. La Camera ha deciso di renderle pubbliche giovedì 31 ottobre 2013. «Entro venti anni gli abitanti di numerosi comuni del Casertano rischiano di morire tutti di cancro», affermò Schiavone, con un tono profetico che purtroppo è stato confermato dai fatti. Le ricerche del Cnr e del Pascale, fatte proprie dal ministero della Salute, descrivono un’impennata della mortalità per tumori nelle province di Napoli e Caserta. Riferendosi al traffico illegale di rifiuti nocivi, Schiavone spiegò che divenne un business «autorizzato» per il clan dei Casalesi nel 1990. «Tuttavia - riferì il pentito - quel traffico veniva già attuato in precedenza. Gli abitanti rischiano tutti di morire di cancro entro 20 anni; non credo infatti che si salveranno: gli abitanti di paesi come Casapesenna, Casal di Principe, Castel Volturno e così via, avranno, forse, venti anni di vita». Nel corso della sua audizione, Schiavone cita i nomi dei referenti del clan per gli affari nello smaltimento illegale dei rifiuti. Cita Cipriano Chianese, a capo della Resit, e il suo socio Gaetano Cerci. Ovvero gli stessi imprenditori che continueranno a fare affari con lo Stato negli anni successivi, quando l’emergenza rifiuti diventerà incontrollabile. E che ora sono sotto processo. «Chianese - aggiunse Schiavone - aveva introdotto Cerci in circoli culturali ad Arezzo, a Milano, dove aveva fatto le sue amicizie. Attraverso questi circoli culturali entrò automaticamente in un gruppo di persone che gestiva rifiuti tossici. Lavorava a Milano, Arezzo, Pistoia, Massa Carrara, Santa Croce sull’Arno, La Spezia. Cerci si trovava molto bene con un signore che si chiama Licio Gelli». A proposito dei profitti enormi ottenuti smaltendo i rifiuti tossici, oltre 600 milioni di lire al mese, Schiavone aggiunge particolari sulle coperture ai più alti livelli garantite all’organizzazione criminale: «Il nostro era un clan di Stato... La mafia e la camorra non potevano esistere se non era lo Stato... Se le istituzioni non avessero voluto l’esistenza del clan, questo avrebbe forse potuto esistere?». Schiavone ricostruì anche la genesi delle ecomafie casertane: «A cominciare furono mio cugino Sandokan e Francesco Bidognetti». Il potere del clan crebbe anche perché gestivano il ciclo di smaltimento dei rifiuti: «In tutti i 106 comuni della provincia di Caserta noi facevamo i sindaci, di qualunque colore fossero. (...) socialisti, democristiani, ma anche comunisti se serviva». Rifiuti tossici sono stati interrati lungo tutto il litorale Domitio e sversati anche nel lago di Lucrino, specchio d’acqua nell’area flegrea. Schiavone raccontò che erano coinvolte diverse organizzazioni criminali - come mafia, `ndrangheta e Sacra Corona Unita - tanto da fare ipotizzare che in diverse zone di Sicilia, Calabria e Puglia, le cosche abbiano agito come il clan dei Casalesi. Il collaboratore di giustizia si soffermò sulle modalità di smaltimento. «Avevamo creato un sistema di tipo militare, con ragazzi incensurati muniti di regolare porto d’armi che giravano in macchina. Avevamo divise e palette dei carabinieri, della finanza e della polizia. Ognuno aveva un suo reparto prestabilito». Schiavone citò una serie di località nell’hinterland di Napoli: «Pure a Villaricca abbiamo fatto scaricare 520 fusti tossici in una cava che fu scavata nel terreno tramite Mimmuccio Ferrara. Durante lo scarico un autista rimase cieco». Ma anche luoghi molto frequentati, a due passi dai centri abitati: « A Casal di Principe, dietro il campo sportivo e nei pressi della superstrada (recentemente è stato fatto un sopralluogo e non è stato trovato nulla ndr)». I camion delle ecomafie imperversavano poi lungo il litorale domizio: «Nel 1992 c’erano 10mila ettari di terreni che costeggiavano tutta la Domitiana, tutti per l’Eurocav e tutto scavato a 30, 40 e 50 metri. Le draghe estraevano sabbia e le buche venivano sistematicamente riempite. Se lei guarda l’elenco che le ho consegnato vedrà che ci sono 70-80 camion di quelli che smaltivano dal nord. Si tratta di milioni e milioni di tonnellate. Io penso che per bonificare la zona ci vorrebbero tutti i soldi dello Stato in un anno». Sotto terra sono finite anche scorie nucleari: «Sono al corrente che arrivavano dalla Germania camion che trasportavano fanghi nucleari che sono stati scaricati nelle discariche. Alcuni dovrebbero trovarsi in un terreno sul quale oggi vi sono i bufali e su cui non cresce più erba». Come avveniva l’interramento? «Di notte i camion scaricavano rifiuti e con le pale meccaniche vi si gettava sopra un po’ di terreno. Tutto questo per una profondità di circa 20-30 metri nella zona di Parete o di Casapesenna, in cui la falda acquifera è più bassa vi sono punti che si trovano a 30 metri».
I verbali del pentito Schiavone. "In Puglia le discariche della camorra". Le rivelazioni dell'uomo dei casalesi all'Antimafia: "Per tutti gli anni Ottanta la camorra ha usato alcune pattumiere. Una si chiamava Puglia", scrive Giuliano Foschini su “La Repubblica”. La camorra per tutti gli anni '80 ha usato alcune pattumiere. Una si chiamava Puglia. Lo ha raccontato nel 1997 il pentito Carmine Schiavone alla commissione parlamentare antimafia in un verbale che soltanto giovedì è stato dissecretato. Ma lo hanno confermato anche le indagini più recenti in tema di mafia e di rifiuti, come ha spiegato in audizione di alcuni mesi fa l'ex procuratore di Bari, Antonio Laudati. "Parlavamo spesso di Puglia - spiega il pentito - c'erano discariche nelle quali si scaricavano sostanze che venivano da fuori, in base ai discorsi che facevamo negli anni fino al 1990-1991". Schiavone parla di "Salento, ma sentivo parlare anche delle province di Bari e Foggia". Pochi i riferimenti precisi anche perché, dice, "il nostro era un discorso "accademico" interno che facevamo, dicendo: mica siamo solo noi, lo fanno tutti quanti". Il traffico riguardava "sostanze tossiche, fanghi industriali, rifiuti di lavorazione, rifiuti radioattivi ". Tutto materiale che veniva nascosto metri e metri sotto terra, dove ancora oggi è probabilmente conservato. È bene ricordare che in alcune zone del Salento si registrano percentuali di malattie oncologiche assai superiori alla media. Quei dati sono stati oggetto nei giorni scorsi di una riunione all'Istituto superiore di Sanità nella quale l'Arpa Puglia e il ministero hanno previsto un percorso comune: l'anomalia nei numeri c'è, ed è importante. Bisogna trovare ora le cause. I rifiuti interrati potrebbero essere uno dei problemi. Tornando alle dichiarazioni di Schiavone, il pentito ha parlato anche del "supporto" logistico dei clan locali: "In effetti - ha messo a verbale . in Puglia, la Sacra corona unita non è mai stata nessuno. Era sorta inizialmente insieme al gruppo della Nuova camorra organizzata di Cutolo, e poi fu staccata. C'erano gruppi che operavano con noi e con i siciliani. Nel Brindisino operava un certo Bicicletta, un certo D'Onofrio che stava con Pietro Vernengo, il suo capozona. Con me operavano un certo Tonino 'o Zingaro e Lucio Di Donna, che era di Lecce". Le parole di Sandokan sono però state integrare e in parte superate dal quadro tracciato nei mesi scorsi dal procuratore Laudati sempre in commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. È stato il magistrato a parlare del legame tra i casalesi e il foggiano. "Se io devo smaltire un frigorifero e lo butto a Savignano Irpino - ha detto - rischio l'arresto nella flagranza, se mi sposto di un chilometro e mezzo, se mi va male prendo una contravvenzione. Dove butta il frigorifero la criminalità organizzata? ". Le indagini stanno verificando anche in questo caso "sinergie" criminalità locale e Casalesi. Ma c'è altro. Alcune aziende, "anche a partecipazione pubblica - ha detto Laudati - hanno avuto forme di condizionamento dalla criminalità organizzata sul modello di quello che è successo in Campania".
«Forse sbaglia persona. Io sopralluoghi con Schiavone non ne ho mai fatti. Non è che non rammento, ne sono abbastanza sicuro». E di quel filone d’inchiesta «non ho memoria che uscisse qualcosa riferibile alla Puglia». Il prefetto Nicola Cavaliere, uomo di Stato d’altissimo lignaggio, con una pluridecennale carriera che l’ha portato in posizioni apicali in Polizia e nel servizio segreto per la sicurezza interna (Aisi), nonché cittadino onorario di Mesagne, nel Brindisino, dove ha vissuto molto a lungo, puntualizza a Marisa Ingrosso su “La Gazzetta del Mezzogiorno” alcune dichiarazioni di Carmine Schiavone che lo chiamano in causa e che riguardano la Puglia, come territorio in cui sarebbero stati sepolti rifiuti illecitamente. L’ex camorrista e collaboratore di giustizia, infatti, fu ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Era il 7 ottobre del 1997 e soltanto ora quei verbali sono stati desecretati e pubblicati sul web. In essi Schiavone spiega che esisteva una «cupola» che si occupava di smaltire illecitamente nel Sud Italia i rifiuti speciali e tossici provenienti soprattutto delle grandi aziende del Nord ed europee, Germania in testa. Della «cupola» dei veleni facevano parte insospettabili, i «colletti bianchi». Gente che aveva agganci con alcuni «circoli culturali» e - secondo il pentito - con esponenti della Massoneria dell’epoca, come lo stesso «venerabile », Licio Gelli. Secondo quanto dice Schiavone, per alcuni anni la criminalità organizzata era stata tagliata fuori dal business. Ma poi la «cupola» decise di coinvolgere anche i clan, ottenendone aiuto logistico e coperture, in cambio di alcuni miliardi di lire. Schiavone dice d’essere entrato nell’affaire alla fine degli anni Ottanta: «La vicenda è iniziata nel 1988; all’epoca mi trovavo ad Otranto», afferma in audizione al presidente della Commissione Massimo Scalia. Secondo l’ex boss, «fusti e casse » sono stati tombati in «scavi abusivi». Afferma: «Ricordo di aver accompagnato i rappresentanti della Criminalpol, dello Sco (con Nicola Cavaliere) nei luoghi di quelle che non erano cave ma scavi che poi sono stati chiusi». Scavi profondi «circa 20-24 metri» che arrivavano alla falda sotterranea dell’acqua «sui quali - dice Schiavone - esiste un’ampia documentazione che credo sia in possesso dello Sco, della Criminalpol (all’epoca c’era Cavaliere)». Epperò, sentito in proposito dalla «Gazzetta», il prefetto chiarisce molto bene questi passaggi. «Schiavone - dice Nicola Cavaliere - non l’ho mai conosciuto, né mai mi sono interessato direttamente dell’inchiesta». «Si tenga conto che - asserisce il superpoliziotto - nel periodo 1990-1994 ero a capo della Mobile Roma (lì contribuì allo smantellamento della Banda della Magliana; ndr) e che nel periodo 1994-1997 ero alla Criminalpol di Roma». «Quindi, io non mi sono mai interessato. Forse sbaglia persona. Io sopralluoghi con Schiavone non ne ho mai fatti. Non è che non rammento, ne sono abbastanza sicuro».....
Bene, allora cari italiani: TUTTI DENTRO, CAZZO??? QUASI TUTTI!!!!
Circola in Italia una strana idea di legalità, scrive Antonio Polito su “Il Corriere della Sera”. I suoi cultori chiedono alle Procure di esercitare il ruolo improprio di «controllori» ma non appena possono premiano l'illegalità, per demagogia o per calcolo elettorale. È il caso di Napoli, città-faro del movimento giustizialista visto che ha eletto sindaco un pm, dove è stata appena approvata, praticamente all'unanimità, la sanatoria degli occupanti abusivi delle case comunali. Nel capoluogo partenopeo si tratta di un fenomeno vastissimo: sono circa 4.500 le domande di condono giunte al Comune per altrettanti alloggi. Per ogni famiglia che vedrà legalizzato un abuso, una famiglia che avrebbe invece diritto all'abitazione secondo le regole e le graduatorie perderà la casa. Non c'è modo migliore di sancire la legge del più forte, del più illegale; e di invitare altri futuri abusivi a spaccare serrature e scippare alloggi destinati ai bisognosi. Ma nelle particolari condizioni di Napoli la sanatoria non è solo iniqua; è anche un premio alla camorra organizzata. È stato infatti provato da inchieste giornalistiche e giudiziarie che «l'occupazione abusiva di case è per i clan la modalità privilegiata di occupazione del territorio», come ha detto un pubblico ministero. In rioni diventati tristemente famosi, a Secondigliano, Ponticelli, San Giovanni, cacciare con il fuoco e le pistole i legittimi assegnatari per mettere al loro posto gli affiliati o i clientes della famiglia camorristica è il modo per impadronirsi di intere fette della città; sfruttando le strutture architettoniche dell'edilizia popolare per creare veri e propri «fortini», canyon chiusi da cancelli, garitte, telecamere, posti di blocco, praticamente inaccessibili dall'esterno e perfetto nascondiglio per latitanti, armi e droga. Non che tutto questo non lo sappia il sindaco de Magistris, che a Napoli ha fatto il procuratore. E infatti ha evitato di assumersi in prima persona la responsabilità di questa scelta. L'ha però lasciata fare al consiglio comunale, Pd e Pdl in testa, difendendola poi con il solito eufemismo politico: «Non è una sanatoria. Io la chiamerei delibera sul diritto alla casa». E in effetti è una delibera che riconosce il diritto alla casa a chi già ce l'ha, avendola occupata con la forza o l'astuzia.
Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
DELINQUENTE A CHI?
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
"Noi avevamo la nostra idea. Dovevamo formare, per la fine del millennio, i nostri giovani come degli infiltrati dentro lo Stato: quindi dovevano diventare magistrati, poliziotti, carabinieri e perché no, anche ministri e presidenti del Consiglio. Per avere i nostri referenti nelle istituzioni".
Bene, allora cari italiani: TUTTI DENTRO, CAZZO??? QUASI TUTTI!!!!
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI.
Nell'agosto 2011, molto prima che gli venisse assegnato il verdetto della Corte dei Cassazione sul Cavaliere, il giudice Antonio Esposito, presidente della sezione feriale della Suprema Corte, durante una cena si è sfogato con i commensali: "Berlusconi mi sta sulle palle. Se lo incrocio gli faccio un mazzo così". A raccontare l'aneddoto è stato il Giornale raccogliendo la testimonianza di un imprenditore calabrese, Massimo Castiello, che aveva invitato nella sua villa a San Nicola Arcella, sul Tirreno, la toga. A tavola c'era anche l'attore Franco Nero che oggi conferma le parole del suo ospite. Chiamato al telefono Libero ha confermato che da parte di Esposito non c'era un atteggiamento sereno nei confronti di Berlusconi.
"Se becco Berlusconi gli faccio un mazzo...". Spunta un'altra imbarazzante cena (con testimoni) in cui il magistrato dichiarava il suo pregiudizio scrive Stefano ZurloIl Giornale «Berlusconi mi sta proprio sulle palle. Se mi dovesse capitare a tiro gli faccio un mazzo così». Parlava a ruota libera il giudice Antonio Esposito davanti ai commensali stupiti. Sono passati due anni da quella cena, ma il padrone di casa, Massimo Castiello, si ricorda ancora molto bene quelle parole. «Ce l'aveva col Cavaliere, i suoi non erano giudizi affrettati, si capisce che coltivava proprio un'antipatia profonda. Non lo sopportava. E non si faceva problema nel comunicarlo a chi gli stava intorno». È l'agosto del 2011. Castiello, piccolo imprenditore sessantottenne con interessi nel mondo immobiliare, organizza una serata fra amici nella sua villa con vista Tirreno di San Nicola Arcella, in Calabria. «Io e Esposito ci conosciamo da una vita. Esposito faceva il pretore a Scalea, in provincia di Cosenza, non lontano da San Nicola Arcella, il mio paese. Insomma, sia pure a salti, con le intermittenze della vita, ci siamo frequentati. Anche se poi ci siamo persi per un certo periodo. Comunque, per l'occasione allargo gli inviti, anzi nella mia testa quel piccolo evento serve per far incontrare Esposito e un altro mio amico, anzi l'unico mio vero amico, Franco Nero». Sì, il grande attore, l'interprete di tanti film indimenticabili. «Ho scoperto - riprende Castiello - che Esposito è un fan scatenatissimo di Nero, ha visto quasi tutti i suoi film, cita a memoria scene e battute, meglio di uno sceneggiatore, e insomma l'occasione è ghiotta. Nero in quell'agosto di due anni fa è ospite a casa Castiello ed Esposito, come d'abitudine, trascorre il periodo estivo a Sapri che non è molto lontana». Il menu d'ordinanza prevede pasta, patate e provola. «Un piatto delizioso, accompagnato da un buon vino locale». Il tutto nella cornice meravigliosa di una terrazza porticata a strapiombo sulle acque del Tirreno. Una cena da cartolina. «Dunque a tavola siamo in sette: io e mia moglie Sandra, Esposito e la sua signora, altre due persone e lui, il mito. Franco Nero». Si parla e si sorride, ma è chiaro che la star della serata è Nero. Esposito s'informa e a un certo punto il discorso cade su un film che gli spettatori italiani non hanno mai visto: L'escluso, in cui Franco Nero è diretto dal figlio Carlo e recita insieme alla moglie Vanessa Redgrave. «È la storia di un avvocato italoamericano che fa di tutto per far assolvere il proprio cliente. La trama è ambientata negli Stati Uniti e la pellicola è stata girata negli Usa, alle porte di New York. In Italia però non è mai arrivata». Pare che i diritti siano stati acquistati, combinazione, da Mediaset, comunque L'escluso qui da noi è un fantasma. «Ora non ricordo bene - prosegue Castiello - ma forse, proprio a partire dal film il discorso è scivolato su Berlusconi. Sento ancora le parole del magistrato che mi hanno ferito non una ma due volte. La prima perché io ho sempre avuto simpatie berlusconiane, la seconda, molto più importante, perché chi parlava era il presidente della seconda sezione della Cassazione». Un magistrato autorevolissimo, un giudice, che in teoria, avrebbe pure potuto trovarsi un giorno faccia a faccia con l'imputato Silvio Berlusconi». Come poi puntualmente è avvenuto tre settimane fa quando la Suprema corte, presieduta da Esposito, ha condannato il Cavaliere a 4 anni di carcere per frode fiscale, al termine del processo Mediaset. Due anni fa nessuno poteva prevedere che quello sarebbe stato il finale e però Esposito - se sono veritiere le affermazioni di chi lo invitò quella sera - avrebbe dovuto frenare. E invece il giudice, davanti a una tavolata composita, con persone che in parte conosceva e in parte no, e con un personaggio famosissimo seduto vicino a lui, si lascia andare a briglia sciolta: «Berlusconi mi sta proprio sulle palle». Niente male per chi dovrebbe essere un monumento all'imparzialità, alla terzietà, alla riservatezza e via elencando. Ma questo è solo l'antipasto, poi Esposito, almeno a sentire Castiello, ingrana la quinta: «Quello, Berlusconi, si salva sempre, grazie ai suoi avvocati... la prescrizione... ma se mi dovesse capitare a tiro gli faccio un mazzo così». Testuale. Alla faccia della serenità della giustizia. Gli esperti parlerebbero di pregiudizio, insomma se quella frase così ruvida, inammissibile per un magistrato, fosse stata recapitata a Berlusconi prima del verdetto fatale, sarebbe stata probabilmente motivo più che sufficiente di ricusazione. Esposito avrebbe dovuto passare la mano, la corte avrebbe avuto un altro presidente e la sentenza, chissà, forse avrebbe avuto un altro esito. Ma quella notte la frase, anzi le frasi riverniciate di antiberlusconismo militante, restano fra le mura di quel terrazzo porticato, affacciato sul Golfo di Policastro. Esposito parla sempre con Nero, ma già che c'è tira pure un pesantissima stoccata a Wanna Marchi, immancabile come un mantra nei suoi incontri conviviali. I lettori del Giornale avranno già capito: Stefano Lorenzetto ha raccontato su queste pagine una cena, con successiva premiazione, in cui incrociò lo scintillante giudice. Siamo nel marzo 2009 e ci troviamo a Verona, all'hotel Due Torri, a centinaia di chilometri di distanza da San Nicola Arcella, ma a quanto pare le ossessioni di Esposito sono sempre quelle. Il Cavaliere e Wanna Marchi. Esposito si dilunga sul Cavaliere, fa sfoggio delle sue presunte intercettazioni a luci rosse, si diffonde sui testi in cui il Cavaliere avrebbe dato i voti alle prestazioni erotiche di due deputate del Pdl. E la Marchi? Quel giorno manca poco, pochissimo alla sentenza e Esposito anticipa a Lorenzetto il verdetto che leggerà di lì a poche ore: la condanniamo. La teletruffatrice non sta simpatica al presidente di Cassazione e lui fa di tutto per trasmettere questi sentimenti all'ex vicedirettore del Giornale. Come si vede, il copione si ripete un paio d'anni dopo. In Calabria. La sentenza Marchi è ormai in archivio, ma Esposito la condensa, sempre secondo Castiello, in modo efficace: «C'era qualcosa prescritto, ma abbiamo fatto finta di niente». Il plurale rimanda alla corte, composta da cinque membri, e dunque va preso con le pinze perché sarebbe la firma su una scorrettezza gravissima. Forse il presidente ha sintetizzato in modo brutale quel che è avvenuto nel segreto della camera di consiglio e l'ha in qualche modo volgarizzato. Non è chiaro. Per la cronaca Wanna Marchi è stata sepolta sotto una pena di 9 anni e 6 mesi di carcere e sempre per la cronaca l'ex venditrice, dopo aver letto i documentatissimi articoli di Lorenzetto, ha annunciato, attraverso l'avvocato Liborio Cataliotti, che ricorrerà alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. E che, se dovesse vincere devolverà i soldi dell'indennizzo alle sue vittime. Ma quella è un'altra storia. Sono i toni aspri dell'antiberlusconismo in salsa Esposito a rimanere impressi nella mente di Castiello. Il banchetto si chiude lì, anzi Esposito riceve pure un piccolo omaggio che lo riempie di gioia: la videocassetta dell'introvabile film di Nero, L'escluso. Poi, ed è cronaca recente, accade l'impensabile. Esposito, come presidente della sezione feriale, si trova a tiro il Cavaliere. E conferma la sentenza d'appello. Poi s'infila da solo nei guai, concedendo una spericolata intervista al Mattino in cui, fra una battuta in italiano e una in napoletano, anticipa le motivazioni che non sono ancora state depositate. È abituato a chiacchierare, Esposito. E non si tiene nemmeno in quella circostanza. Come aveva fatto a cena, a Verona, e a san Nicola Arcella. Il banchetto del 2009 è stato ricostruito da Stefano Lorenzetto, adesso sappiamo che davanti al Tirreno e alla pasta con la provola Esposito emise la sua sentenza definitiva. Irrevocabile: «Berlusconi mi sta sulle palle».
TUTTO IL POTERE A TOGA ROSSA.
Tutto il potere a Toga Rossa. Magistratura democratica e Movimento per la giustizia da tempo condizionano tribunali e procure grazie a una collaudata organizzazione del consenso. E ora puntano all’unificazione scrive Maurizio Tortorella in collaborazione con Annalisa Chirico su “Panorama”. Non mollano. Non demordono, nemmeno dopo la condanna definitiva dell’Avversario; non si rilassano nemmeno un po’. Era la sera del 1° agosto 2013, Silvio Berlusconi era appena stato giudicato colpevole dalla Cassazione. Avrebbero potuto festeggiare il risultato raggiunto. Invece è bastato che il presidente della Repubblica, appena mezz’ora dopo, dichiarasse: «Auspico che adesso possano aprirsi condizioni più favorevoli per l’esame in Parlamento dei problemi relativi all’amministrazione della giustizia». E subito Magistratura democratica è saltata su, come un tappo: «La sentenza dimostra che i giudici sanno fare il loro mestiere, nonostante tutti i tentativi di condizionarli», mentre «parlare di riforme della giustizia è un segnale negativo». Così, ancora una volta, ha parlato la massima corrente della sinistra giudiziaria, attraverso il presidente di Md Luigi Marini (ex pm torinese, oggi in Cassazione) e il segretario generale Anna Canepa (pm genovese). Durissimi, contro Giorgio Napolitano e contro tutti. La loro dichiarazione è lunga, ma merita la citazione proprio per quanto è minacciosa: «I richiami alla necessità di riforme della giustizia suonano come risposte alla prova d’indipendenza che la magistratura ha saputo dare, a dimostrazione che una parte consistente (quanto consistente vedremo) della politica considera quell’indipendenza un pericolo e intende andare alla resa dei conti». A seguire, un corollario d’accuse: contro chi cerca di «addomesticare» i magistrati; contro i politici «in malafede»; contro i continui «tentativi di condizionamento»…
È l’unione delle toghe rosse. Più forte di un partito politico. Più dura di un sindacato. Più potente di un esercito. Da anni Berlusconi sostiene di esserne perseguitato: a giudicarlo, in effetti, spesso sono stati giudici dichiaratamente di sinistra. Tra i cinque giudici che il 1°agosto lo hanno condannato in Cassazione nel processo Mediaset, per esempio, il presidente Antonio Esposito, finito nei guai per l’intervista in cui ha anticipato le motivazioni del verdetto, passa per simpatizzante di Movimento per la giustizia, l’altra corrente di sinistra. Mentre Ercole Aprile nel 2007 si era candidato all’Anm proprio nelle liste di Mpg (incidentalmente in lista con Caterina Interlandi, il giudice milanese che lo scorso maggio ha condannato Giorgio Mulè, direttore di Panorama, a 8 mesi di reclusione senza condizionale per omesso controllo su un articolo ritenuto diffamatorio). L’unione delle toghe rosse si articola in queste due organizzazioni: Md, forte di 800-900 iscritti, e Mpg, con altri 400. Insieme, raccolgono appena un settimo dei 9 mila magistrati italiani. Però riescono a coagulare un terzo dei consensi di categoria e contano come fossero la maggioranza. Federati nel cartello elettorale Area, alle ultime elezioni del febbraio 2012 per l’Associazione nazionale magistrati, un po’ il sindacato di categoria, Md e Mpg hanno preso 2.271 preferenze su 7.200 voti validi. Rispetto alle precedenti elezioni del novembre 2007, dove si erano presentati divisi, hanno perso 300 consensi e un seggio nel comitato centrale, da 13 a 12 su 36. Ma grazie a un’alleanza con la corrente «mode-rata» di Unicost hanno ottenuto il segretario dell’Anm: Maurizio Carbone (Mpg). Mentre al Consiglio superiore della magistratura, che regola le carriere e giudica sui procedimenti disciplinari della categoria, dal 2010 hanno 6 consiglieri togati su 16. E anche qui fanno il bello e il cattivo tempo.
Bruno Tinti, ex procuratore aggiunto di Torino (e anche lui iscritto a Md negli anni Sessanta), dal suo ritiro in pensione è il grande critico delle correnti giudiziarie: «Sono solo centri di potere» dice «che cercano di ottenere posti rilevanti per gli iscritti. Md e Mpg giurano di essere diversi: sbandierano carte dei valori, pretendono purezza e integrità morale. Ma poi fanno esattamente come gli altri». Se lo dice Tinti, che è azionista e collaboratore del Fatto quotidiano, c’è da credergli. Del resto, alcuni mesi fa è arrivata una conferma dalla vicenda-simbolo svelata da un’email sfuggita a Francesco Vigorito (Md), giudice romano e consigliere del Csm: finita su una mailing list aperta, la lettera manifestava dubbi su una nomina al Tribunale di sorveglianza di Salerno, dove Area aveva sostenuto con forza una magistrata solo perché appartenente alla corrente, e preferendola ad altri colleghi «forse più meritevoli» soltanto per «le pressioni interne».
Il caso ha acceso grandi polemiche, presto tacitate in nome della disciplina di partito. Le rivelazioni via email sono state spesso una spina nel fianco della sinistra giudiziaria, tanto che si è fatto di tutto per renderle inaccessibili. In passato, infatti, alcune incursioni giornalistiche nel circuito degli iscritti hanno scoperchiato clamorose partigianerie e faziosità. Quando per esempio nel dicembre 2009 uno squilibrato ferì al volto Silvio Berlusconi lanciandogli contro una statuetta del Duomo di Milano, in Md si accese il dibattito. E prevalse chi giustificava: «Ma siamo proprio sicuri che quanto accaduto sia un gesto più violento dei respingimenti dei clandestini in mare, del pestaggio nelle carceri di alcuni detenuti o delle terribili parole di chi definisce “eversivi” i magistrati?».
Due anni fa, quando il centrodestra cercò d’impostare l’ennesima riforma della giustizia, le email violate di Mpg segnarono nuove impennate di avversione: «Lo zietto Berlusconi deve togliere al più presto il disturbo» scrisse un pm. Altri suggerirono la chiamata a difesa di tutta la sinistra e del sindacato: «La nostra corporazione da sola non può reggere uno scontro politico, se non gioca politicamente». Certo, Md e Mpg hanno preso posizione su ogni sospiro della politica italiana e, soprattutto, sulle leggi approvate dal Parlamento.
Livio Pepino, uno dei maggiori esponenti di Md, postulò del resto la necessità che «il magistrato si ponesse come contropotere». Più forti di un partito politico, più dure di un sindacato, più potenti di un esercito, le toghe rosse hanno così sparato a zero sul potere legislativo: censurando tante norme, da quelle anticlandestini («Si introduce un reato inutile, profondamente iniquo e discriminatorio: non si può trasformare un fenomeno sociale in fenomeno criminale») fino alla legge Biagi («La celebrata riforma del mercato del lavoro, lungi dal provocare il benefico effetto di un’emersione del “nero”, accresce la precarizzazione dei rapporti e l’arretramento della sicurezza»). La verve censoria in luglio ha riguardato anche il governo Letta, contro la legge svuota-carceri: «Sconfortante il balletto di reati ora sottratti alla carcerazione preventiva, ora inclusi, ora oggetto di ripensamenti».
La capacità di condizionare la politica è elevata. In questo agosto, sul Fatto quotidiano, due alti esponenti di Md hanno massacrato le tesi appena un po’ garantiste del nuovo responsabile giustizia del Pd, Danilo Leva: prima Vittorio Teresi, procuratore aggiunto a Palermo, poi Gian Carlo Caselli, procuratore di Torino, hanno affossato le sue tesi come «inquietanti», «strampalate», «stravaganti»... Una cassazione preventiva: così, tanto per frenare un compagno che sbaglia. Mentre in maggio Beppe Fioroni, deputato del Pd in quel momento candidato alla presidenza della commissione Giustizia, aveva raccontato in un’intervista delle telefonate ricevute dall’Anm per garantire proprio quel posto a Donatella Ferranti, già magistrato di Md ed ex segretario del Csm. Fioroni aveva dichiarato alla Repubblica: «Io ovviamente ho obbedito ai magistrati, mica al Pd».
Poi aveva smentito, ma alla fine il risultato è stato quello: Ferranti for president. Va detto che, là dove Md ha nel Pd la sua evidente sponda partitica, l’altra corrente ha meno legami diretti: quelli di Mpg a tratti sembrano vicini al Movimento 5 stelle, a tratti a Sinistra ecologia e libertà, a volte a nessuno dei due. Questo, malgrado siano in minoranza nel cartello elettorale di Area, non impedisce che spesso prevalgano i loro candidati nelle primarie per il voto al Csm o all’Anm. È stato così, a sorpresa, nel 2010: nella circoscrizione della Cassazione, dove Aniello Nappi (Mpg) ha prevalso su Giovanni Diotallevi (Md). Due anni dopo, Nappi è uscito dal gruppo di Area (che al Csm ha altri due consiglieri: Paolo Carfì, il giudice del processo berlusconiano Imi-Sir oggi in Corte d’appello a Milano; e Roberto Rossi, il pm barese che ha indagato sul ministro del Pdl Raffaele Fitto) rivendicando maggiore indipendenza.
Ma sono screzi da poco, l’unità della sinistra giudiziaria non è mai posta in discussione: «Di recente» dice Nappi «ho chiesto l’iscrizione anche a Md». E uno dei leader storici di Mpg, il procuratore aggiunto di Milano Armando Spataro, dichiara a Panorama: «Francamente, io proprio non capisco perché siamo ancora separati». Anche Antonella Magaraggia, giudice veneziano e dal gennaio 2011 presidente di Mpg, dice di guardare oltre il cartello elettorale: «Area» dichiara «è un progetto politico-culturale aperto anche ai non iscritti, verso il superamento delle correnti. A unirci con Md è molto, quasi tutto. Sì, forse Md in passato è stata più ideologica, ma noi oggi siamo debitori per tutte le sue conquiste. Noi di Mpg siamo più attenti all’organizzazione, all’efficienza del lavoro. Però l’ambito ideale è lo stesso, dividerci è impossibile».
Betta Cesqui, alta esponente di Md, è d’accordo: «Qui, semmai, dobbiamo allargare la nostra base». Da giugno Area tende dichiaratamente alla fusione, con un comitato di coordinamento fatto da 7 magistrati: 2 a testa sono di Md e di Mpg, e 3 indipendenti eletti in un’assemblea a Roma. Il giudice veneziano Lorenzo Miazzi (ex Md) è uno dei 7: «Vogliamo creare un’associazione liquida» spiega a Panorama «sul modello di Libera, l’organizzazione di don Ciotti contro le mafie. Anche perché vogliamo che idee, tesi e linea escano non più dai vertici, ma dalla base». Queste istanze orizzontali un po’ ricordano la «democrazia del web», tanto cara a Beppe Grillo. Con molta trasparenza in meno, però: sia Magaraggia sia Edmondo Bruti Liberati, procuratore di Milano e uno dei massimi leader di Md, confermano a Panorama che l’elenco dei circa 1.250 iscritti alle due correnti «non è pubblico», anche se entrambi «a titolo personale» si dicono favorevoli a rendere note le liste. Il risultato, comunque, è una grave anomalia: nessun cittadino può sapere se a inquisirlo o giudicarlo sia un magistrato schierato a sinistra, di Md o di Mpg (nel 2002 ci provò per le vie legali Cesare Previti, l’ex ministro della Difesa imputato a Milano, ma ottenne un secco no). Non è un bene. Anche perché non è un mistero che i magistrati aderenti alle due correnti siano spesso importanti, esposti, attivi in ruoli chiave. Negli anni Settanta e Ottanta, Md era presente soprattutto nei «ranghi bassi»: pretori d’assalto, giudici istruttori. Oggi, con i colleghi di Mpg, la sinistra giudiziaria è presente ovunque, soprattutto nelle procure, e arriva fino in Cassazione.
Non bastasse la capacità politica espressa in Italia, la sinistra giudiziaria ha poi una sua casa europea. Da anni Md e Mpg aderiscono a Medel, Magistrats européens pour la démocratie et les libertés: da Strasburgo l’organizzazione propugna il diritto di azione collettiva dei magistrati, la «diffusione della cultura giuridica democratica» e ha tra gli obiettivi «la difesa dei diritti delle minoranze, con particolare riguardo a quelle dei migranti e dei poveri». Medel oggi riunisce 19 correnti delle toghe di sinistra ed estrema sinistra, come l’Unión progresista de fiscales in Spagna e Syndicat de la magistrature in Francia, per oltre 17 mila iscritti. Molto influente presso la Commissione europea e le Nazioni unite, Medel risponde alle parole d’ordine della sinistra più oltranzista: ha appena preso posizione contro i tagli allo Stato sociale dettati dalla crisi finanziaria; critica ogni tentativo di introdurre il minimo principio di responsabilità civile nell’attività giudiziaria; attacca ogni censura (anche istituzionale) che vada a colpire un magistrato «democratico». Insomma, se mai servisse, è una superlobby a difesa degli interessi della categoria. Più forte di un partito politico. Più dura di un sindacato. Più potente di un esercito. E poi ridono quando dicono che un giudice si butta a sinistra…
GIUDICI IMPUNITI.
I giudici impuniti: risarcito un innocente su 100. Quattro detenuti su dieci, nelle 206 carceri italiane, sono «in attesa di giudizio»: sono in cella per un ordine di custodia cautelare, quello che prima della riforma del codice del 1989 si chiamava più onestamente «ordine di carcerazione preventiva». Per l’esattezza, calcola l’associazione Antigone, i reclusi che non sono ancora stati processati sono 26.804 su un totale di 66.685. Nessun Paese europeo ha statistiche così elevate e sconvolgenti: la media generalmente non supera il 10-15 per cento.
Su 400 cause intentate dal 1988 per ingiusta detenzione l’errore è stato riconosciuto soltanto 4 volte. Solo l'1 per cento dei ricorsi contro i magistrati per ingiusta detenzione si risolve con una condanna della toga , scrivono Gian Marco Chiocci e Pier Francesco Borgia su “Il Giornale”. Se si vuole parlare concretamente della responsabilità dei giudici e degli errori giudiziari partiamo dai numeri: solo l’1% dei giudizi ha visto lo Stato «pagare» i danni del lavoro del giudice. Insomma la «montagna» della cosiddetta legge Vassalli, che ha introdotto a partire dal 1988 la responsabilità dei magistrati come richiesto dalla stessa Costituzione (articolo 24), ha partorito un «topolino». A offrire un bilancio dei primi 23 anni della legge è la relazione presentata in Commissione giustizia della Camera da Ignazio Caramazza, Avvocato generale dello Stato. In buona sostanza soltanto l’1% dei ricorsi contro magistrati per ingiusta detenzione si è risolto con una condanna della toga. «Dai dati raccolti dall’Avvocatura dello Stato - si legge nella relazione - risultano proposte poco più di 400 cause. Di queste 253 sono state dichiarate inammissibili, 49 sono in attesa di pronuncia sull’ammissibilità, 70 sono in fase di impugnazione di decisioni di inammissibilità e 34 sono state dichiarate ammissibili». Solo in 4 di queste si è arrivati alla condanna dello Stato. Insomma la percentuale è veramente bassa. Quattro condanne su 406 casi. E con un grande lavoro del filtro dell’ammissibilità che ne ha rigettate subito 253 (62%). Secondo l’Avvocatura dello Stato «emerge una eccessiva operatività» di questo «filtro». Questo «difettoso funzionamento della legge» porta, secondo Caramazza, a una abrogazione sostanziale di parti qualificanti della norma che ne stravolgono il senso. L’audizione dell’Avvocato generale dello Stato in Commissione giustizia porta quindi un nuovo punto di vista sulla legge Vassalli e sulla necessità di riformulare la normativa che dà un senso compiuto all’indirizzo proposto dalla stessa Carta costituzionale nell’articolo 24. Vale forse la pena di ricordare, a questo punto, quanto scritto nel comma 4: «La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». E non solo per colpa grave o dolo. Quindi anche un errore di interpretazione normativa può recare danni a chi viene sottoposto a giudizio. E il senso dell’emendamento proposto dal leghista Gianluca Pini non solo intende rispondere ai desiderata della Costituzione ma anche ai diktat dell’Unione Europea. L’emendamento chiama i giudici a rispondere per «ogni manifesta violazione del diritto». Lo stesso Caramazza auspica una riforma in tal senso e ricorda che il nodo a una equa applicabilità della legge Vassalli è proprio l’articolo 2 della stessa legge che spiega come «nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme». Più prudente il parere espresso dai vertici del Consiglio nazionale forense nel corso di una conferenza stampa. Guido Apa, presidente del Cnf mette le mani avanti: «Dobbiamo ancora capire in che modo il principio dell’emendamento è conforme ai principi costituzionali e se il giudice possa in questo modo applicare serenamente la legge». Situazione per così dire paradossale. Da un lato c’è l’Avvocatura generale dello Stato che, chiamata a esprimersi dalla Commissione giustizia, dà un suo pur prudente assenso. Dall’altro ci sono gli avvocati che, con il loro temporeggiare, sembrano ancora incerti sul valore dell’emendamento. Eppure sarà la prima a difendere i magistrati nelle cause mentre saranno i secondi ad assistere i singoli nelle azioni contro lo Stato.
La vera anomalia italiana: l'impunità di tutti i giudici. Un referendum promosso dai radicali punta a riconoscere la responsabilità civile dei magistrati: in vent'anni sono stati ritenuti colpevoli per danni ai cittadini appena 4 volte, scrive Andrea CuomoIl Giornale Attualmente i magistrati in Italia sono praticamente irresponsabili da un punto di vista sia civile sia penale per i danni arrecati al cittadino nell'esercizio delle loro funzioni. In realtà un referendum del 1987 aveva abrogato gli «articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443» introducendo il principio della responsabilità civile. Ciò in seguito all'onda emotiva sollevata dalla incredibile vicenda di Enzo Tortora, vittima del più clamoroso (ma non dell'unico) errore giudiziario del dopoguerra. La volontà popolare si espresse forte e chiara in quell'occasione: votò il 65,10 per cento del corpo elettorale e i «sì» vinsero con l'80,20 per cento anche grazie all'impegno dello stesso Tortora, che da parlamentare radicale si impegnò in prima persona perché ad altri non toccasse quello che era capitato a lui per un'incredibile somma di equivoci, casualità e leggerezze. Un successo, quello del referendum di 26 anni fa, sbianchettato da una legge confezionata in fretta e furia: la legge Vassalli, varata il 13 aprile 1988 (un mese prima della morte di Tortora) e tuttora in vigore, che formalmente ammette il risarcimento per il cittadino vittima di malagiustizia, ma di fatto lo rende una chimera. La legge Vassalli, infatti, ammette che chiunque abbia «subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia» possa agire per vedersi riconosciuto un risarcimento, ma agendo non contro il magistrato bensì contro lo Stato, che può poi rivalersi a sua volta contro il magistrato colpevole nella misura di un terzo. Non può però dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, ciò che di fatto esclude gran parte delle fattispecie. In pratica si può dar luogo a risarcimento solo in casi eccezionali (dolo o colpa grave), ciò che rende di fatto non esercitabile l'azione risarcitoria da parte dei cittadini. Il mancato riconoscimento della responsabilità civile dei giudici è tra l'altro costata all'Italia anche le censure della Corte di Giustizia dell'Ue. La questione è da anni oggetto di un dibattito acceso tra i fautori della responsabilità, che vedono in questo principio un inderogabile segnale di civiltà, e coloro che invece vedono come il fumo negli occhi la possibilità che un magistrato che sbagli possa rimborsare il cittadino vittima della sua negligenza. Il «partito dei giudici» vede infatti il referendum come l'ennesima minaccia all'indipendenza del potere giudiziario e fa notare come in molti Paesi, come la Gran Bretagna, la magistratura goda di totale immunità. In coda alla precedente legislatura un emendamento alla legge del 13 aprile 1988 che intendeva allargare il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio nelle funzioni giudiziarie anche ad alcuni casi di «interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove» (come quando ci si trova di fronte a negligenza inescusabile che porta all'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento) non fece in tempo però a terminare felicemente il suo iter parlamentare, lasciando in vita un'anomalia tutta italiana.
Adesso andiamo a “mettere il naso” in casa dei
magistrati: il Csm, Consiglio superiore della magistratura. Il Csm si occupa
anche di sanzionare disciplinarmente i magistrati che violano le regole e la
legge. Una sorta di “organo interno” per i “colleghi che sbagliano”. Vediamo dal
sito del Csm cosa prevede l’azione disciplinare. La legge ha introdotto,
infatti, l’applicazione del criterio tale crimen talis poena, come
conseguenza doverosa della tipizzazione degli illeciti.
Le varie sanzioni previste dalla legge sono:
a) l’ammonimento, che è un richiamo all’osservanza dei doveri del magistrato;
b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo;
c) la perdita dell’anzianità, che non può essere inferiore a due mesi e non superiore a due anni;
d) l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, che non può essere inferiore a sei mesi e non superiore a due anni;
e) la sospensione dalle funzioni, che consiste nell’allontanamento dalla funzioni con la sospensione dello stipendio ed il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura;
f) la rimozione, che determina la cessazione del rapporto di servizio.
Vi è poi la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio che il giudice disciplinare può adottare quando infligge una sanzione più grave dell’ammonimento, mentre tale sanzione ulteriore è sempre adottata in taluni casi specificamente individuati dalla legge. Il trasferimento d’ufficio può anche essere adottato come misura cautelare e provvisoria, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza. Secondo l’Anm, l’Associazione nazionale magistrati, l’Italia sarebbe tra i primi posti a livello europeo in termini quantitativi di provvedimenti disciplinari, con 981 casi in nove anni dal 1999 al 2008. Il dato viene confortato dalla ricerca del CEPEJ che dice che il numero delle sanzioni disciplinari applicate ogni 1000 magistrati in Italia è 7,5. Al secondo posto dopo l’Austria con un fattore 8. A parte che questo significa che i nostri magistrati sono quelli che a questo punto sbagliano più di tutti, il CEPEJ non dice il resto. Così come furbescamente non lo dice l’Anm.
E noi adesso lo diremo. Lo stesso rapporto dell’Anm dice all’interno (badando bene da non riportare il dato nei comunicati stampa) che sì, è vero che il Csm ha vagliato 981 posizioni in nove anni, ma di queste le condanne sono state solo 267 (il solo 27%). Praticamente solo tre magistrati su dieci sono stati “condannati” dal Csm. Già questo dovrebbe far ridere o piangere a secondo il punto di vista. Ma non finisce qui.
Di quei 267 condannati dal Csm:
a) 157, quasi il 59%, sono stati condannati alla sanzione minima dell’ammonimento (vedi capo a dell’elenco dei provvedimenti disciplinari)
b) 53, il 20% circa, alla censura (vedi capo b dell’elenco dei provvedimenti disciplinari)
c) 1 solo, lo 0,4 % circa, alla incapacità
(temporanea) delle funzioni direttive (vedi capo d dell’elenco dei provvedimenti
disciplinari)
d) 9 soltanto, il 3% circa, sono stati rimossi (vedi capi e-f dell’elenco dei
provvedimenti disciplinari)
Il resto sono al capo c o semplicemente trasferiti d’ufficio. Ma l’Anm, anche se i dati sono sconfortanti, non la dice tutta. Dagli studi di Bianconi e Ferrarella sui dati del 2007 e del 2008 esce un dato a dir poco “offensivo” per il comune senso della giustizia. Prima di giungere sul tavolo di Palazzo dei Marescialli, sede del Csm, la “pratica disciplinare” passa per altre vie. L’esposto di chi vi ricorre viene presentato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione che vaglia la posizione e se ravvisa fondati motivi nell’esposto passa la pratica al Csm, che poi prende l’eventuale provvedimento. Bene, anzi male: nel 2007 la Cassazione ha ricevuto 1.479 esposti e ne ha passati al Csm solo 103, poco meno del 7%. Stessa musica nel 2008. Dei 1.475 fascicoli presentati in Cassazione, solo 99 passano al Csm, circa il 7%. Quindi prendere ad esempio i dati del CEPEJ sic et simpliciter è improprio, per due motivi: se i dati fossero analizzati (e non lo sono) sulla base del rapporto tra fascicoli aperti e condanne, il risultato sarebbe impietoso per l’Italia; secondo: all’estero non esistono sanzioni disciplinari come l’ammonimento o la censura, bensì si passa dalla sanzione di rimozione in alcuni paesi (inclusa una sanzione pecuniaria rilevante e il pagamento dei danni morali e materiali alle vittime) sino alla condanna in carcere in alcuni altri.
Ma non è ancora finita. Il periodo 1999-2008 è stato un periodo “di comodo” perchè il meno peggiore, e inoltre i numeri non sarebbero veritieri per come riportati dall’Anm. Secondo un’analisi di Zurlo, mai contraddetta, i casi vagliati dal Csm dal 1999 al 2006 sono stati 1.010, di cui 812 sono finiti con l’assoluzione e solo 192 con la condanna (il 19% circa). Di queste “condanne”:
- 126 sono stati condannati con l’ammonimento (circa il 66%!)
- 38 sono stati condannati con la censura (circa il 20%)
- 22 sono stati condannati con la perdita da 2 mesi a due anni di anzianità (circa l’11%)
- 6 sono stati espulsi dall’ordine giudiziario (il 3%)
- 2 sono stati i rimossi (l’1%)
Ora, che cosa si evince? Una cosa semplice. Un magistrato, specie inquirente, può consentirsi quello che vuole e commettere ogni tipo di errore o abuso, tanto cosa rischia? Vediamolo in numeri semplici:
- oltre 9 volte su 10 può contare sul fatto che l’esposto presentato contro di lui presso la Procura generale della Cassazione non venga passato al Csm;
- qualora anche passasse al vaglio del Csm può contare sul fatto che dalle 7 alle 8 volte su 10 verrà assolto dal Csm stesso;
- qualora anche venisse condannato dal Csm rischierebbe 9 volte su 10 solo un “tirata d’orecchie” o “una lavata di capo”.
Insomma ha solo dalle 7 alle 8 possibilità su mille di venire cacciato dalla magistratura, senza contare che per lui le porte del carcere non si apriranno mai. Potremmo dire: ho visto giudici trattati con così tanto riguardo che voi normali cittadini non potreste nemmeno immaginarvi.
Il rapporto 2012 del Cepej (Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa) condanna il nostro sistema giudiziario. Da noi occorrono 493 giorni per un processo civile in primo grado, contro i 289 della Spagna, i 279 della Francia e i 184 della Germania. Milioni e milioni di procedimenti pendenti, scrive “Il Giornale”. La situazione viene ben descritta da Stefano Livadiotti,una delle firme più note di “L’Espresso” nel suo libro “Magistrati-l’Ultracasta”, dive svela particolari e retroscena inquietanti su quelle toghe che da sempre detengono il potere in Italia. Vostro Onore lavora 1.560 ore l’anno, che fanno 4,2 ore al giorno. Gli esami per le promozioni? Una farsa per il giornalista. Che racconta come i giudici si spartiscono le poltrone e riescono a dettare l’agenda alla politica. Merita pure di essere sottolineato che l’attuale normativa prevede che dopo 27 anni di servizio, tutti i magistrati – indipendentemente dagli incarichi e dai ruoli – raggiungano la massima qualifica di carriera possibile. Solo sulla base della “anzianità”, quindi. I verbali del Consiglio superiore della magistratura dimostrano che dal 1° luglio 2008, al 31 luglio 2012, sono state fatte, dopo l’ultima riforma delle procedure, che avrebbe dovuto renderle più severe, 2409 valutazioni sotto questo aspetto. Quante sono state giudicate negative? Tre. I magistrati del Belpaese guadagnano più di tutti i loro colleghi dell’Europa continentale, e al vertice della professione percepiscono uno stipendio pari a 7,3 volte quello dei lavoratori “medi”. Gli inquirenti tedeschi si accontentano di un multiplo più ragionevole: 1,7. Ma quanto costa la macchina giudiziaria agli italiani? Per tribunali, avvocati d’ufficio e pubblici ministeri, 73 euro per abitante all’anno (dato pubblicato nel 2010 dal Cepej), contro una media europea di 57,4. Perché così tanto? Eppure i quattrini ci sono. Peccato, però, che come tutto il resto, i “piccioli” vengano gestiti male. Da noi ci sono 2,3 Palazzi di Giustizia ogni 100 mila abitanti; in Francia uno. Ogni togato dispone di 3,7 addetti tra portaborse e presunti factotum dei quali si potrebbe tranquillamente fare a meno. In Germania, 2,7. Uno in meno quindi. Non pagano né civilmente né penalmente, come già detto. Ma almeno rischiano sanzioni disciplinari? No, spiega Livadiotti, neanche quelle. Cane non mangia cane. Qualunque esposto venga rivolto contro un magistrato, passa prima al filtro preventivo della Procura Generale della Cassazione, che stabilisce se c’è o no il presupposto per avviare un procedimento. Ebbene, tra il 2009 e il 2011 sugli 8.909 magistrati in servizio, sono pervenute 5.921 notizie di illecito. Quante ne avrà mai potute archiviare il PG? Ben 5.498, cioè il 92,9%. Numeri imbarazzanti. Ma non basta. Quanti giudici sono stati sanzionati? Nessuno. Tra il 2001 e il 2011, il giornalista spiega che i giudici ordinari destituiti sono stati appena 4. Sì, esattamente, quattro. Lo 0,28%. Quelli rimossi negli ultimi 11 anni dal Csm? 8 in totale. E la legge sulla responsabilità civile che permette a chi subisca un errore giudiziario di essere risarcito? In poche parole, va a farsi benedire. E’ la norma 117 dell’88, scritta dal ministro Vassalli. Nell’arco di 23 anni sono state proposte in Italia 400 cause di richiesta di risarcimento danni per colpe specifiche dei togati. Di queste, 253, pari al 63%, sono state dichiarate inammissibili con provvedimento definitivo. Solo 49, cioè il 12%, sono in attesa di pronuncia. 70, pari al 17%, sono in fase di impugnazione. 34, ovvero l’8,5%, sono state dichiarate ammissibili. Di quest’ultime, 16 sono ancora pendenti e 18 sono state decise. Peccato che lo Stato abbia perso solo 4 volte. Ma quanto guadagnano, in definitiva, i giudici? Un consigliere Csm, sommando stipendi base, gettoni, rimborsi e indennizzi, lavorando 3 settimane su 4 dal lunedì al giovedì, guadagna 2.700 euro per ogni giorno effettivo di impiego. Su questi dati, Livadiotti non è mai stato smentito. Né con i fatti, né con le parole. Ebbene sì, tutto questo è lo scandalo degli scandali. La macchina della giustizia dovrebbe cambiare in tutto e per tutto, essere rivoltata come un calzino. I veri privilegiati, anche in tempo di crisi, sono loro, i magistrati. La vera grande colpa di Berlusconi è quella di non aver mai introdotto, in 10 anni di governo, una legge che prevedesse almeno in parte la responsabilità dei giudici. Questa, nel 2013, ancora non è prevista. E tutti, politici compresi, in Italia sono costretti a sottostare al potere incontrastabile dei magistrati. Prigionieri di una casta che rifiuta di autoriformarsi per conservare privilegi, poteri e un’immunità che non ha pari al mondo.
PERCHE’ I REFERENDUM ABROGATIVI SONO UNA STRONZATA.
Ogni anno in Italia si chiede la firma a sostegno di alcuni referendum per abrogare leggi, o parte di esse. Leggi avversate da questa o quella parte politica. Tale attività extra parlamentare è solo una “stronzata”, ossia una presa in giro per gli italioti. Spiego immediatamente il perché.
I REFERENDUM. L’ordinamento giuridico italiano prevede 3 tipi di referendum. Quello confermativo che permette agli elettori in ambito extraparlamentare di confermare la norma costituzionale che nella doppia votazione parlamentare non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Quello propositivo, ma solo per la modifica di circoscrizioni territoriali. Quello abrogativo, che, appunto, abroga leggi, o parti di esse, già in vigore.
I PROMOTORI. I Promotori del referendum abrogativo, quasi sempre, sono gli stessi parlamentari che siedono in Parlamento e che, spesso, hanno la maggioranza per modificare la legge che vogliono abrogare. Questi signori, quando devono trattare norme in tema di Giustizia o in tema di riforme che collidono con gli interessi di casta o di lobby, per codardia non hanno il coraggio di legiferare, specie contro gli interessi ed i privilegi della magistratura. In questo caso promuovono il referendum delegando agli italioti la responsabilità di cambiare le loro sorti.
I COSTI. Sono centinai i milioni di euro spesi per una attività propria del Parlamento, che già di per sé costa una cifra sproporzionata rispetto alla sua utilità.
ESITO. L’esito della consultazione popolare, spesso, si traduce in un flop, ossia in un vero e proprio fallimento. Questo perché l’elettorato, sulla falsariga delle elezioni politiche, diserta i seggi, non avendo più alcuna fiducia nei loro pseudo rappresentanti politici. Resistono gli irriducibili nostalgici sinistroidi che votano sempre e comunque chi, dalla loro parte gli si presenta da votare. Quando, invece, la consultazione raggiunge il quorum ed è valida, allora la legge o parte di essa è abrogata. In questo caso si resuscita una legge stravecchia, se esistente o, addirittura si lascia sguarnita giuridicamente una questione delicata.
ESEMPIO. REFERENDUN ABROGATIVO SULLA RESPONSABILITA’ DEI MAGISTRATI.
Promotore è Marco Pannella con il Partito Radicale. Quel Marco Pannella che, proprio a difesa dei Magistrati, si operò contro il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che come capo del CSM non esitò a mandare i carabinieri a circondare il CSM stesso proprio per il rispetto della Legalità. Eppure Pannella denunciò il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Appoggiano il referendum i Berlusconiani che hanno un solo interesse, a detta dei loro detrattori, ossia da 20 anni legiferare leggi ad personam a tutela del loro leader Silvio Berlusconi e contro i magistrati di sinistra. Berlusconiani che prima votano la legge Severino sulla decadenza dei condannati e poi per Berlusconi ne pretendono l’incostituzionalità. Dall’altra parte si scontrano con i paladini degli interessi e dei privilegi dei magistrati, ossia i sinistroidi. Sinistroidi che cercano di far passare i magistrati di italica cooptazione per Potere (che è solo del popolo) quello che è solo un Ordine di funzionari dello Stato. Nessuno, al Parlamento, che si interessi dei problemi dei cittadini: carceri piene di innocenti o presunti tali (oltre il 40% secondo Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati), o dell’impunità dei Magistrati e dello strapotere di cui spesso e volentieri abusano. D'altronde i radicali già presentarono nel 1987 la richiesta di tre referendum per ottenere la responsabilità civile dei magistrati, l'abrogazione della Commissione inquirente e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, come risposta ai sempre più frequenti problemi della giustizia. Bene. I referendum abrogativi dell'8 novembre 1987 si conclusero con una netta affermazione dei «sì», che di media nei 5 quesiti totali raggiunsero circa l'80% delle preferenze. Da quella vittoria ne uscì un obbrobrio. Dopo la scelta degli italiani circa la responsabilità civile dei giudici, il Parlamento approvava la Legge 13 aprile 1988 n. 117 sul "Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", nota come «legge Vassalli», (votata da Pci, Psi, Dc) il cui disposto, secondo i Radicali, si allontanava decisamente dalla decisione presa dagli italiani nel referendum, facendo ricadere la responsabilità di eventuali errori non sul magistrato ma sullo Stato, che successivamente poteva rivalersi sullo stesso, ma solo entro il limite di un terzo di annualità dello stipendio. Dall'epoca della sua entrata in vigore, nessuna sentenza di condanna è mai stata pronunciata sulla base di tale legge. Comunque i magistrati hanno stipulato per se stessi una polizza di responsabilità civile. Il premio annuo, per ciascun Assicurato ammonta ad € 113,50 lordo – solo RC. Per dire, la controparte togata, ossia gli avvocati, sono obbligati per legge ad assicurarsi e pagano, in convenzione, un importo più che il doppio per danni infinitesimali inferiori rispetto ai danni che i magistrati causano allo Stato ed ai singoli. In ogni modo se passasse il referendum abrogativo della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, si tornerebbe allo stato anti obbrobrio e quindi al niente. Basta legiferare con onestà, coscienza e nell’interesse del cittadino rappresentato, prevedendo anche un organismo esterno alla corporazione per verificare errori e responsabilità, anziché rompere le balle ai cittadini, facendoli, oltretutto passare per fessi. Non solo. Nei dibattiti in tv o sui giornali chi si invita a sproloquiare in relazione al referendum di fronte ad inermi e assoggettati avvocati e ignavi politici? Le toghe rosse, ossia i magistrati iscritti a Magistratura Democratica o al Movimento per la giustizia e quando va bene a rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati, anch’essi di quella parte politica. Magistrati che non potranno fare altro, dall’alto della loro influenza, difendere le loro prerogative e suggestionare gli spettatori sulla bontà ed autorevolezza della loro opinione.
Questo per dire quanto sono una stronzata i referendum, quanta disinformazione interessata vi è in giro e quanto questa gente prenda in giro gli italioti con l’anello al naso.
Italioti che, invece stufi di questa mattanza, dovrebbero usar le matite sulle schede elettorali come forconi da infilar dal di dietro a questa gentaglia, che tradisce il mandato di rappresentanza elettorale.
C’E’ UN GIUDICE A BERLINO!
"C'è un giudice a Berlino" è un vecchio modo di dire nato dalla vicenda di un poveraccio, in Germania, rimasto senza mulino ma che alla fine ebbe giustizia, scrive Umberto Eco su “L’Espresso”, alla cui dotta enucleazione si sono stracciate le smancerie antiberlusconiane. "Ci deve pur essere un giudice a Berlino" è espressione che, anche quando se ne ignora l'origine, molti usano per dire che ci deve essere una giustizia da qualche parte. Il detto è così diffuso che l'aveva citato anche Berlusconi (noto estimatore delle magistrature), quando nel gennaio 2011 aveva visitato la signora Merkel con la curiosa idea di interessarla ai suoi guai giudiziari. La signora Merkel (con un tratto di humour che una volta avremmo definito all'inglese - ma anche i popoli si evolvono) gli aveva fatto osservare che i giudici ai quali lui pensava non erano a Berlino ma a Karlsruhe, nella Corte Costituzionale, e a Lipsia nella Corte di Giustizia. Come nasca e come si diffonda la storia del giudice a Berlino è faccenda complessa. Se andate su Internet vedrete che tutti i siti attribuiscono la frase a Brecht, ma nessuno dice da quale opera. Comunque la cosa è irrilevante perché in tal caso Brecht avrebbe semplicemente citato una vecchia vicenda. I bambini tedeschi hanno sempre trovato l'aneddoto nei loro libri di lettura, della faccenda si erano occupati vari scrittori sin dal Settecento e nel 1958 Peter Hacks aveva scritto un dramma ("Der Müller von Sanssouci"), di ispirazione marxista, dicendo che era stato ispirato da Brecht, ma senza precisare in qual modo. Se proprio volete avere un resoconto di quel celebre processo, che non è per nulla leggenda, come molti siti di Internet, mendaci per natura, dicono, dovreste ricuperare un vetusto libro di Emilio Broglio, "Il Regno di Federico di Prussia, detto il Grande", Roma, 1880, con tutti i gradi di giudizio seguiti per filo e per segno. Riassumendo, non lontano dal celebre castello di Sanssouci a Potsdam, il mugnaio Arnold non può più pagare le tasse al conte di Schmettau perché il barone von Gersdof aveva deviato certe acque per interessi suoi e il mulino di Arnold non poteva più funzionare. Schmettau trascina Arnold davanti a un giudice locale, che condanna il mugnaio a perdere il mulino. Ma Arnold non si rassegna e riesce a portare la sua questione sino al tribunale di Berlino. Qui all'inizio alcuni giudici si pronunciano ancora contro di lui ma alla fine Federico il Grande, esaminando gli atti e vedendo che il poveretto era vittima di una palese ingiustizia, non solo lo reintegra nei suoi diritti ma manda in fortezza per un anno i giudici felloni. Non è proprio un apologo sulla separazione dei poteri, diventa una leggenda sul senso di equità di un despota illuminato, ma il "ci sarà pure un giudice a Berlino" è rimasto da allora come espressione di speranza nell'imparzialità della giustizia. Che cosa è successo in Italia? Dei giudici di Cassazione, che nessuno riusciva ad ascrivere a un gruppo politico e di cui si diceva che molti fossero addirittura simpatizzanti per un'area Pdl, sapevano che qualsiasi cosa avessero deciso sarebbero stati crocifissi o come incalliti comunisti o come berlusconiani corrotti, in un momento in cui (si badi) persino la metà del Pd auspicava una soluzione assolutoria per non mettere in crisi il governo. Alla fine questi giudici hanno condannato Silvio Berlusconi, che anela, ancora, un Giudice a Berlino.
IL PAESE DEL GARANTISMO IMMAGINARIO.
Il Paese del garantismo immaginario. Le vanterie sull'Italia patria di Beccaria? Sono sciocchezze: la cultura manettara è egemone, scrive Alessandro GnocchiIl GiornaleViviamo in una società garantista? Il garantismo è pensiero corrente, se non egemone? No, è la risposta secca di Non giudicate, il saggio di Guido Vitiello edito da Liberilibri. Un giro in libreria, scrive Vitiello, a caccia di tomi che propugnino ideali garantisti, si risolverebbe in una ricerca senza frutto. Al contrario, gli scaffali sono ben riforniti di libri firmati da «magistrati-sceriffo impegnati sulla frontiera delle mille emergenze nazionali» o da «reduci gallonati di Mani pulite» o da giudici «scomodi» ma non al punto da non trovare frequente ospitalità nei vari talk show serali. La tivù è la tribuna da cui levano doglianze sui paletti alle indagini posti dai politici in nome del «garantismo» (quasi sempre «peloso», nota Vitiello). Basta dare un'occhiata alle cronache dei quotidiani per rendersi conto che gli avvisi di garanzia sono percepiti come sentenze della Cassazione; e che spesso l'odio (ma anche l'amore) per l'inquisito o il condannato di turno fa velo alla valutazione dei fatti. Il pensiero supposto egemone si rivela «solitario», e paga il conto anche ai «falsi garantisti» che si sono mescolati ai veri, «finché la moneta cattiva ha scacciato la buona e reso sospetti tutti i commerci». Insomma, la reputazione «ben poco commendevole» del garantismo in parte, ma solo in parte, è meritata: c'è stata poca chiarezza nel distinguere casi personali e questioni di principio. La tesi di Vitiello comunque è limpida: «L'imbarbarimento giudiziario italiano è sotto gli occhi di chiunque abbia voglia di vederlo, e non abbia interessi di bottega tali da suggerirgli una cecità deliberata. Basta gettare uno sguardo, anche distratto, sul punto di caduta o di capitolazione - le carceri di un sistema che è in disfacimento fin dalla testa, per arrossire quando sentiamo ripetere quelle insulse vanterie sul Paese di Beccaria». L'originalità del saggio consiste nel farci vedere i principi incarnati in quattro ritratti di garantisti doc: Mauro Mellini, Domenico Marafioti, Corrado Carnevale, Giuseppe Di Federico. Sono pagine nate sulle colonne del Foglio (l'introduzione è di Giuliano Ferrara) ampliate e arricchite da un carteggio fra Mellini ed Enzo Tortora. E proprio la vicenda di Tortora, insieme con Marco Pannella e le battaglie dei Radicali, lega tutti i protagonisti di Non giudicate. Tocca a Mellini, avvocato di conio liberale, leader radicale e deputato per svariate legislature, introdurre il lettore all'abbecedario garantista, cioè alle parole di cui diffidare perché sventolate al fine di giustificare l'indebito allargamento dei poteri della magistratura. Emergenza: «cela il proposito di passar sopra a certe fisime per instaurare una giustizia di guerra»; giustizia d'assalto: «ha dato la stura a innumerevoli interventi di magistrati ritenuti o autodefinitisi provvidenziali, di cosiddette supplenze e vicarianze di altri poteri»; esemplare: è una sentenza «che punisce con esagerata severità in un determinato momento, quindi una sentenza esemplarmente ingiusta». Domenico Marafioti, avvocato e letterato, è l'uomo delle profezie inascoltate: nel 1983 pubblicò La Repubblica dei procuratori. Sottolineava, scrive Vitiello, «i prodromi dell'integralismo giudiziario, dell'esondare della magistratura, specie di certe sue avanguardie, dalle dighe che legge e Costituzione le assegnano»; criticava il modello inquisitorio del processo; segnalava la nascita del giudice pedagogo, che vuole redimere il prossimo. Corrado Carnevale, presidente della Prima sezione penale della Cassazione dal 1985, è noto come l'ammazzasentenze, nomignolo affibbiatogli da una campagna stampa denigratoria iniziata dopo l'annullamento dell'ergastolo ai mandanti dell'omicidio di Rocco Chinnici. La corporazione non si levò certo in sua difesa (lo fece Pannella). Più volte finito sotto processo, sempre assolto, Carnevale illustra cos'è «l'astratto formalismo» che gli veniva imputato: osservanza scrupolosa della legge scritta. «Quando il giudice si considera legibus solutus e piega le leggi al suo fine, foss'anche per intenti nobili, mette lo Stato sullo stesso piano delle organizzazioni criminali». Carnevale rifiuta l'appellativo di garantista: «E nel fare giustizia il garantismo che c'entra? Non esiste per il giudice qualcosa di diverso dall'applicazione corretta, intelligente della legge». Giuseppe Di Federico ha fondato il Centro studi sull'ordinamento giudiziario dell'università di Bologna. È lui a sollevare un altro insieme di questioni: la separazione delle carriere, l'assenza di un valido sistema di valutazione dell'operato dei giudici, il tabù dell'obbligatorietà dell'azione penale. Questi sono i limiti non solo, per così dire, ideologici del sistema ma anche gli ostacoli all'efficienza della macchina. Se vi sembra che queste idee siano moneta corrente nel nostro Paese «garantista»...
I GIOVANI VERGINELLI ATTRATTI DAL GIUSTIZIALISMO.
Come è possibile che i giovani siano attratti dal pensiero giustizialista? Cronaca della presentazione del libro “Non giudicate” di Guido Vitiello su “Zenit”. L’opera, con la prefazione di Giuliano Ferrara, raccoglie le voci di alcuni “veterani del garantismo” italiano, scrive Antonio D’Angiò. Sabato 27 ottobre 2012 è stato presentato alla Camera dei deputati, in occasione della quarta edizione delle “Giornate del libro politico a Montecitorio”, il “libretto” (così definito dallo stesso autore) di Guido Vitiello intitolato “Non giudicate” edito da liberilibri. Vitiello, nato trentasette anni fa a Napoli, è docente all’Università di Roma La Sapienza e collabora, tra gli altri, con il “Corriere della Sera” e “Il Foglio”. Per una fortuita coincidenza temporale, all’interno dell’opera è raccontato quanto avvenuto precisamente dieci anni fa, cioè il 30 ottobre 2002, quando il Presidente di Cassazione Corrado Carnevale è stato assolto, con formula piena, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa (accusato di aver “aggiustato” alcuni processi di mafia e da alcuni pentiti di essere un referente dei boss) dopo circa un decennio di vicende processuali. Iniziamo da questa “ricorrenza temporale” per parlare del libro di Guido Vitiello, perché Corrado Carnevale, con Mauro Mellini, Domenico Marafioti e Giuseppe Di Federico è uno dei quattro veterani (tutti ultraottantenni all’epoca dell’intervista e, peraltro, tutti meridionali) che l’autore ha incontrato per discutere del garantismo in Italia e successivamente dare vita a questa pubblicazione. Ma soprattutto perché Carnevale è l’unico dei quattro che oltre a discutere, descrivere, documentare, applicare i temi e i commi della legislazione, è stato sia giudice che imputato e come recita la terza di copertina, è stato “esemplare garante del giusto processo, per questo ha subìto una persecuzione mediatico-giudiziaria, uscendone vittorioso”. Una serata (nell’affollata sala Aldo Moro del Parlamento) dove le riflessioni di giovani come Guido Vitiello e Serena Sileoni (Direttore Editoriale di liberilibri, coordinatrice dell’evento) si sono ben integrate nei toni e nei contenuti con quelle di tre maestri del giornalismo italiano: Pierluigi Battista, Massimo Bordin e Giuliano Ferrara, quest’ultimo autore della introduzione all’opera. Scrivendo e parlando della giustizia, non poteva non essere posta in relazione la giustizia degli uomini con quella di Dio (o amministrata per conto di Dio), in particolare nelle assonanze con alcune ritualità tra inaugurazione degli anni giudiziari e i “riti basilicali”; in alcune forme sceniche dei processi che ricordano in Italia più i tribunali dell’inquisizione in confronto con quelle della legge britannica (dove l’imputato è al centro e in alto rispetto alla corte giudicante); nonché con quel “non giudicate” che fa proprio uno dei passaggi del discorso della Montagna di Gesù Cristo o, infine, nel riferimento a Ponzio Pilato o al bacio di Giuda. Così come è stata più volte ripresa, per i cultori del diritto, la conseguenza che comporta sui processi la combinazione, tipicamente italiana, tra l’obbligatorietà dell’azione penale, la carcerazione preventiva, la limitata responsabilità civile dei magistrati e l’assenza della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Oppure, per gli appassionati di vicende processuali, i racconti su alcuni processi, come quelli nei confronti di Enzo Tortora o di Scattone e Ferraro (questi ultimi accusati dell’omicidio della studentessa Marta Russo) che fanno emergere quanto, questi processi, abbiano rappresentato un’occasione mancata per una più ampia riflessione sul sistema giudiziario, prima che il termine garantismo fosse abbandonato da chi lo aveva nel suo patrimonio culturale e politico e fosse acquisito (l’autore dice “sputtanato”) da neofiti in virtù di un’interpretazione forzatamente privata, “ad personam”, di questioni comunque universali. Infine, i riferimenti letterari a Sciascia, Borges, Kafka, Pasolini, Dostoevskij, Gide, Anatole France, Gadda, Dante Trosi, rappresentano un vero e proprio elenco di consigli per la costruzione di una biblioteca del garantismo nella quale cercare le motivazioni più profonde sull’essenza del giudicare. L’avvocato e politico radicale (e anticlericale) Mellini, lo scrittore e avvocato Marafioti (di formazione repubblicana, deceduto pochi mesi dopo l’intervista), il professore di diritto Di Federico, il cattolico magistrato di Cassazione Carnevale, aiutati dalla prefazione di Giuliano Ferrara, tendono a spiegare quello che Vitiello rende immediatamente percepibile con una domanda. Come è stato possibile che i giovani, gli studenti (che peraltro lui incontra nelle aule universitarie) siano stati attratti dal pensiero giustizialista con quell’incarognimento che li ha portati a parlare di legalità, manette, intercettazioni con sillogismi feroci? E allora, per chiudere, pensiamo che le parole finali della conversazione con Corrado Carnevale in un certo qual modo possano spiegare il senso più profondo del libro e lasciare a credenti e non credenti il cercare di comprendere se e quanto ampio, in tema di giustizia, sia oggi la distanza tra cultura radicale, liberale e cristiana, per provare a indicare una nuova direzione alle giovani generazioni. “Ecco, ho sempre cercato di giudicare il mio simile nel modo più umano possibile, senza eccessi di moralismo. Non mi sono sentito diverso e migliore anche dal peggior delinquente che talvolta mi è capitato di dover giudicare.” Suona come una variante del precetto evangelico che abbiamo scelto come titolo per questo libro, “Non giudicate”, nel quale Sciascia credeva dovesse radicarsi la missione stessa del giudice. Qualcosa di non troppo diverso intende Carnevale: “Benedetto Croce diceva che non possiamo non dirci cristiani, e aveva ragione. Il Cristianesimo ha degli aspetti che non dovrebbero essere trascurati. Io sono credente. Ma grazie al cielo il Cristianesimo non è una corrente associativa.”
MAGISTRATI? SI', COL TRUCCO!!
La legge è uguale per tutti? No! I concorsi pubblici evidenziano il merito? No!
Ed allora…? Ed allora, niente. Questi italiani sono troppo coglioni per cambiare le cose. Per loro meglio adeguarsi che lottare.
"Quando si cerca di indicare la luna la politica ti porta a cercare il dito..." rivisitazione personale di un noto proverbio che trovo alquanto educativo. Ho sempre ammirato il modo in cui la politica e le stesse istituzioni riescono a distrarre l'attenzione degli italiani dai veri problemi del paese per focalizzarla, invece, sui piccoli scandali di bunga bunga, case a Montecarlo etc. etc.... In tal modo, e solo così si riesce, ahimè, ad evitare un'insurrezione di massa...distrarre la gente per la sopravvivenza della casta! Scusate signori ma io non ci stò. Ed allora ricominciamo a portare a galla gli scandali istituzionali più seri, sperando di riaccendere il sentimento nazionale. Cominciamo dai concorsi pubblici; quello di magistratura.
ANNO 1992. Si diffuse la notizia che anche i concorsi per diventare magistrati venissero truccati col beneplacito del Ministero di Grazia e Giustizia e degli apparati di vigilanza: "Verbali sottoscritti da gente che non c'era, fascicoli spariti, elaborati inidonei quando non lo erano affatto". Ci vollero tredici anni per venire a sapere tramite un articolo del Corriere della Sera del 2005 che i gravi fatti del 1992 non avevano trovato alcuna soluzione nelle aule di giustizia.
ANNO 2002. Un magistrato di Cassazione con funzioni di sostituto P.G. presso la Corte d'Appello di Napoli, membro di commissione, cercò di favorire la figlia di un ex componente del Csm sostituendo durante la notte la prova giudicata negativa ma venendo "tradita" dall'incorruttibile fotocopiatrice utilizzata che, ripartendo al mattino successivo, iniziò a "vomitare" fiumi di pagine contraffatte dalla commissaria-giudice.
ANNO 2008. Il caso della Fiera di Milano-Rho in occasione del concorso Nazionale per uditore Giudiziario. Fra i 5600 partecipanti per 500 posti si scopre che c'è che può tranquillamente introdurre telefonini, appunti, codici irregolari ed addirittura libri di testo. SI consideri che in queste prove la selezione del materiale avviene nei giorni antecedenti le prove con un rigore che dovrebbe essere assoluto! Decine di candidati in piedi che iniziano ad urlare "vergogna!"
Morale della favola? Poco dopo è lo stesso C.S.M. (organo di autogoverno della magistratura) a richiedere con voto a maggioranza l'archiviazione del caso!!! La Procura di Milano (cui si erano rivolti alcuni candidati inferociti) archiviò il tutto senza disporre alcuna indagine! Si apprese in seguito che la 9° commissione richiese al C.S.M. l'apertura di un fascicolo con l'obbiettivo di "avere cognizione oggettiva dello svolgimento delle prove concorsuali e assumere le opportune iniziative in difesa del prestigio e credibilità della magistratura la cui prima garanzia è riposta nell'assoluta affidabilità della procedura di selezione"...ARCHIVIATO IL 19 DICEMBRE!
Potremmo andare avanti così per ore...
E poi, ancora con gli accademici professori universitari.
La Procura di Bari, con un fascicolo aperto nel 2008, indaga 22 docenti e 11 città italiane per manipolazione illecita di dieci concorsi in tutta Italia, dal 2006 al 2011. Una vera lobby di docenti organizzata e ramificata in tutto il Paese. Ma non è tutto. Emergono, infatti, particolari che potrebbero aggravare la posizione degli indagati. Perché, oltre ai concorsi truccati, i docenti avrebbero esercitato pressioni “anti-riforma” sull’allora Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, allo scopo di ostacolare la tanto contestata riforma universitaria, poi approvata nel dicembre 2010. Tramite intercettazioni telefoniche, la Guardia di Finanza avrebbe smascherato una rete nazionale tra colleghi docenti, unanimemente decisi a convincere il Governo di rivedere la riforma. Il testo di riforma contestato dai docenti, include, tra i tanti provvedimenti, nuove procedure di valutazione e di inserimento per professori di prima e seconda fascia e ricercatori, introducendo criteri di sorteggio e l’adozione di un codice per evitare incompatibilità e conflitti di interesse per parentele all’interno dello stesso ateneo. Il che potrebbe spiegare, laddove le indagini si rivelassero attendibili, la ragione di volere impedire, all’epoca dei fatti, l’approvazione della riforma. Dunque una lobby anti codice etico, pro familismo e parentopoli universitaria. Intanto dopo l’avviso di garanzia ricevuto lo scorso anno, sui docenti gravano reati di associazione a delinquere finalizzata a corruzione, abuso d’ufficio e falso ideologico.
Accordi, scambi di favori, sodalizi e patti di fedeltà: così, secondo la procura di Bari, sono stati pilotati dal 2006 i concorsi pubblici per docenti di prima e seconda fascia di diritto costituzionale, ecclesiastico e diritto pubblico applicato in alcune università italiane, scrive “Blitz Quotidiano”. A decidere in anticipo quelli che dovevano essere i risultati delle prove per conquistare le cattedre di ordinario e associato sarebbe stata un’associazione per delinquere composta da professori universitari. Per questo nell’inchiesta dei pm baresi Renato Nitti e Francesca Romana Pirrelli si ipotizza il reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, al falso e all’abuso d’ufficio. Ventidue i docenti di 11 facoltà italiane indagati per aver manipolato ”l’esito di molteplici procedure concorsuali pubbliche bandite” attraverso una rete criminale che la Guardia di finanza di Bari ritiene di aver individuato dopo due anni di indagini. Proprio per cercare ulteriori riscontri sull’esistenza del gruppo criminale, militari del nucleo di polizia tributaria hanno compiuto perquisizioni in uffici universitari e studi professionali dei docenti delle università di Milano, Bari, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Piacenza, Macerata, Messina, Reggio Calabria e Teramo. Nel capoluogo lombardo hanno subito perquisizioni Giuseppe Ferrari, ordinario di diritto pubblico e comparato dell’Università Bocconi, e i professori Giuseppe Casuscelli e Enrico Vitali, entrambi docenti di diritto canonico ed ecclesiastico all’Università statale. Quattro i prof indagati a Bari: Aldo Loiodice, docente di diritto costituzionale alla facoltà di giurisprudenza; Gaetano Dammacco, ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico alla facoltà di scienze politiche; Roberta Santoro docente aggregato della facoltà di Scienze politiche e Maria Luisa Lo Giacco, ricercatrice di diritto ecclesiastico. L’indagine è stata avviata nel 2008 ed avrebbe quasi subito svelato l’esistenza di alcuni concorsi pubblici truccati attraverso un meccanismo di accordi e scambi di favori. Come aveva già evidenziato un’altra indagine, sempre della procura di Bari, che nel giugno 2004 portò all’arresto di cinque docenti di cardiologia. Sei anni dopo gli arresti e otto anni dopo l’avvio dell’indagine, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio degli indagati, accusati di aver gestito un sistema criminale dei concorsi nazionali per ordinario, associato e ricercatore di cardiologia nelle facoltà di Bari, Firenze e Pisa. Per il lungo periodo trascorso, alcuni reati sono già caduti in prescrizione e tutti gli altri saranno prescritti tra non molto tempo.
Questi, signori, sono i veri scandali, queste le "porcate" che devono destare l'opinione pubblica. Qua non si parla dell'appaltino (sempre importante) truccato...qua si parla della formazione dei principali poteri dello Stato. Qua si parla di soggetti che domani saranno chiamati a spiegare al cittadino cosa sia la giustizia! E' interesse di tutti, spero, sapere di andare in Tribunale e trovarsi di fronte all'autorità di un giudice che serenamente ha superato un concorso pubblico.
Ancor più scandaloso che nessuno ne risponda! Qualcosa è successo, qualcuno ha fatto il furbetto, eppure nessuno viene indagato, processato o condannato! Tutto bene, tutto normale, tanto l'importante è guardare il dito...
Vogliamo presentare un breve excursus dal 1992 ad oggi dei casi più salienti, per vedere cosa è stato fatto e se realmente qualcosa è cambiato, scrive “Avvocati senza Frontiere”. Con il primo articolo del 2007 apparso sul tema un nostro anziano avvocato si domandava di quale credibilità potesse ancora godere la magistratura italiana se gli stessi concorsi per entrare a farne parte continuavano ad apparire poco trasparenti, come denunciato nei decenni precedenti da molteplici candidati, senza che si sia mai fatta piena luce sui diversi episodi di brogli e corruzione emersi in ogni parte d’Italia.
Correva l’anno 1992, quando trapelò per la prima volta che anche i concorsi per magistrati venivano truccati col beneplacito del Ministero di Giustizia e degli apparati di vigilanza: “Verbali sottoscritti da gente che non c’era, fascicoli spariti, elaborati giudicati “idonei” quando non lo erano affatto“. Passarono poi ben 13 lunghi anni prima di venire a sapere tramite un articolo di denuncia del Corriere della Sera, pubblicato nel 2005, che i gravi fatti del 1992 non avevano ancora trovato alcuna soluzione nelle aule di giustizia amministrativa italiana né tantomeno sanzione penale.
Nel 2005, nonostante l’autorevole denuncia di Silvio Pieri, ex Procuratore Generale del Piemonte, e le diverse interrogazioni parlamentari sul tema, la scandalosa vicenda del concorso truccato del 1992, risultava finita nel porto delle nebbie, così come ogni altra successiva denuncia del genere. Vale la pena qui ricordare il suggestivo episodio della fotocopiatrice integerrima che smascherò il broglio di una componente della commissione esaminatrice della sessione del marzo 2002 e al contempo magistrato di Cassazione con funzioni di sostituto P.G. presso la Corte d’ Appello di Napoli, la quale cercò di favorire la figlia di un ex componente del Csm, della corrente di Unicost, sostituendo clandestinamente durante la notte la prova giudicata negativa della sua protetta, ma venendo tradita dall’eccesso di zelo dell’incorruttibile copiatrice, utilizzata nottetempo dall’alto magistrato, che ripartendo al mattino misticamente vomitava fiumi di copie delle pagine contraffatte dalla giudice Dr.ssa Clotilde Renna.
Negli anni successivi, neppure l’agguerrito Ministro Alfano, al pari del Guardasigilli di centro-sinistra Mastella, provava a scalfire l’impenetrabile muro di gomma eretto dalla casta e dalle massomafie che la proteggono, sui criteri e le procedure che governano l’accesso alla magistratura. L’argomento, evidentemente troppo scottante anche per i falsi neoliberisti e i rampanti filoberlusconiani che sulla corruzione giudiziaria hanno prosperato, costruendo la loro fortuna economica e politica, continua così ad essere un tabù di cui nessuno si occupa.
Correva l’anno 2008, quando scoppia il nuovo caso della Fiera di Milano-Rho, in occasione dell’ennesimo Concorso Nazionale per Uditore Giudiziario truccato. Tra i 5600 aspiranti magistrati per soli 500 posti si scopre che c’è chi si può permettere di introdurre impunemente telefonini, appunti, codici “irregolari“, rispetto alle norme dettate dal concorso e addirittura libri di testo, tanto da scatenare un vero e proprio putiferio. Mentre decine di candidati urlavano in piedi “vergogna!“, un altro gruppo esprimeva il proprio sdegno chiedendo di annullare la prova.
Ma “more solito” tutto vien presto messo a tacere e il livello di preparazione e di moralità dei giudici italiani e la conseguente disponibilità a “non lasciarsi ammorbidire dal potere“, restano quelli che tutti abbiamo avanti agli occhi ogni giorno nelle aule d’udienza: aperto favoreggiamento dei più forti, nepotismo, corporativismo, prepotenza e arroganza mischiate spesso ad aperta ignoranza ed assenza di rispetto nei confronti di avvocati e soggetti più deboli. (C’è persino chi scrive durante la prova riscuotere con la “q”, chi confonde la Corte dell’Aja con la «Corte dell’Aiax», o un maturo Presidente di sezione di Corte d’Appello civile a Milano che alle soglie della pensione non conosceva neppure la differenza tra un reclamo in corso di causa ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. proposto al collegio da uno ex art. 669 septies c.p.c. proposto allo stesso giudice di merito).
La casta corrotta al pari della classe politica si protegge per autoriprodursi. Ma la cosa che più fa scalpore nel caso del concorso di Rho è il fatto che, messi a parte i dissidi tra il Guardasigilli Alfano e il C.S.M., è lo stesso organo di autogoverno della magistratura a richiedere con voto a maggioranza la frettolosa archiviazione del caso. Tutto normale anche per il Ministero di Giustizia, nonostante le molteplici denunce inquietanti di tanti candidati che segnalavano con dovizia di particolari come durante la prova milanese fossero saltate tutte le regole del gioco e che rampolli figli di noti magistrati avessero potuto fruire del tutto indisturbati di materiale vietato. Circostanza veramente anomala tenuto conto che il concorso per magistrati è ritenuto l’esame più controllato nel nostro Paese. I testi a disposizione dei candidati prima di venire ammessi e introdotti in aula vengono preventivamente verificati e timbrati da un’apposita commissione esaminatrice. Un cancelliere di Tribunale controlla siano realmente dei codici, che non vi siano nascosti appunti o fogli volanti e che siano conformi al bando. I nuovi brogli di Milano-Rho non potevano quindi venire liquidati, ancora una volta, laconicamente e senza alcuna indagine, per coprire le solite spinte corporative e gli oscuri interessi di chi controlla e manipola nell’ombra l’accesso in magistratura, prediligendo le logore logiche di nepotismo e di clientelismo, da cui si alimentano solo le massomafie, il malaffare e non di certo la legalità. Le molteplici proteste dei candidati della prova svoltasi alla Fiera di Milano-Rho per cui dovette persino intervenire la Polizia Penitenziaria per proteggere la commissione esaminatrice cieca, sorda e complice, non sono quindi ancora una volta servite a nulla.
La complicità della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Una cinquantina di candidati si recò in Procura a Milano per denunciare la gravità dei fatti di cui erano stati diretti testimoni, percependo che la Commissione intendesse mettere tutto a tacere per favorire i soliti raccomandati. Ma il procedimento, come di rito, viene frettolosamente archiviato, nonostante la quantità delle denunzie e la convergenza delle testimonianze, tutte acclaranti gravi irregolarità. Ciò, peraltro, senza disporre alcuna accurata necessaria indagine, seppure l’indignazione avesse inondato i siti web, estendendosi agli stessi consiglieri togati del Movimento per la giustizia e Magistratura Democratica che chiedevano un’inchiesta del Csm sulle innumerevoli irregolarità denunciate dai candidati.
Dai media si apprende della richiesta di apertura di un fascicolo da parte della 9° Commissione di Palazzo dei Marescialli con l’obiettivo di “avere cognizione oggettiva dello svolgimento delle prove concorsuali e assumere le opportune iniziative in difesa del prestigio e credibilità della magistratura la cui prima garanzia è riposta nell’assoluta affidabilità della procedura di selezione“. Ma, come denunciato, il 19 dicembre il C.S.M. definiva con una frettolosa archiviazione, eludendo ogni accertamento sullo svolgimento delle prove scritte del concorso indetto con D.M. 27/2/2008, svoltesi a Milano nei giorni 19/21 novembre 2008. La pratica era stata aperta da “I Giovani Magistrati”, all’indomani delle inquietanti notizie fornite da stampa e televisione, in ordine alle modalità di espletamento del concorso. Dal sito movimentoperlagiustizia.it si apprende che nel corso della discussione plenaria, i consiglieri del Movimento per la giustizia chiesero invano il ritorno della pratica in Commissione per l’espletamento di ulteriore attività istruttoria, già inutilmente da loro richiesta anche in sede di Commissione, non condividendo la circostanza che la Commissione avesse voluto frettolosamente portare all’attenzione del plenum del C.S.M. una delibera monca, articolata sulla base di un’attività istruttoria carente, costituita essenzialmente dall’acquisizione delle sole relazioni del presidente della commissione di concorso (17, 20, 22 nov. e 1.12.08) e del direttore generale direzione magistrati del Ministero (25.11 e 9.12), nonché dalle audizioni dei commissari di concorso e di altri funzionari del Ministero di giustizia e della Procura Generale di Milano. “Nessun cenno nella delibera in esame del contenuto delle 19 missive, pervenute alla 9° Commissione anche via e-mail, delle quali più della metà regolarmente sottoscritte da candidati che segnalavano disfunzioni gravi o meno gravi riguardanti soprattutto il ritardo verificatosi il 19 novembre nella dettatura della traccia di diritto amministrativo e la presenza in loco di testi non consentiti”. Per saperne di più, in relazione alla dinamica degli eventi, i tre consiglieri dissidenti aggiungono di avere inutilmente richiesto l’audizione di alcuni dei candidati firmatari degli esposti. Nessun cenno nella delibera del C.S.M. del contenuto della risposta del Ministro della Giustizia all’interrogazione parlamentare che, peraltro, si era sviluppata nel senso di una presa di distanza dall’operato della commissione di concorso. Il sito dei giovani magistrati del Movimento per la giustizia denuncia poi di avere sostenuto con forza che non vi fosse alcuna urgenza di definire, in tempi così brevi, una pratica dai risvolti talmente delicati, con una delibera che, agli occhi dell’opinione pubblica, avrebbe corso il rischio di essere additata (come in effetti, poi, accaduto) “come una risposta corporativa e sostanzialmente “a tutela” dell’operato della commissione di concorso“. Per di più, in una situazione in cui era in corso di indagini preliminari il procedimento aperto presso la Procura di Milano (iscritto a mod. 45), a seguito delle citate denunce pervenute dai candidati. Del resto, diversi sono gli aspetti inquietanti mai chiariti dal C.S.M. e dalla Procura di Milano, le cui archiviazioni hanno proceduto di pari passo per mettere tutto a tacere. Secondo quanto affermato nella relazione del Presidente Fumo sarebbero stati “schermati” i settori riservati ai candidati onde evitare comunicazioni telefoniche. Questo assunto, come si legge nel sito dei giovani magistrati, è stato smentito dal Direttore generale del Ministero, dott. Di Amato, che ha ammesso la mancanza di schermatura elettronica nei padiglioni ove si svolgeva il concorso, riscontrata peraltro dal sequestro di apparecchi telefonici che risultavano funzionanti all’interno dei locali. È appena il caso di rilevare che, come si legge nella relazione ministeriale, la “possibilità di una schermatura elettronica non ipotizzabile per la sede di Roma” era stata una delle ragioni che avevano condotto l’autorità competente alla scelta di Milano quale sede esclusiva di concorso. Quanto all’identificazione di circa 5.600 candidati con tesserini privi di fotografia e alla carenza di controlli anche dei testi e dei codici all’ingresso delle sale di esame (almeno 28.000 volumi), inutilmente proseguono i giovani magistrati di avere fatto richiesta di acquisizione di notizie più in dettaglio sui controllori (250 persone per ogni turno dislocate su 26 postazioni). Del pari, inutilmente hanno fatto richiesta di notizie sui 23 funzionari di segreteria e sui 750 addetti alla vigilanza durante le prove, che avrebbero potuto portare ad accertare le ragioni della discrasia tra l’enorme numero di addetti al controllo e gli insufficienti effetti del controllo medesimo. Accertamenti che avrebbero dovuto quindi trovare ingresso quantomeno in sede penale, onde poter escludere che l’indifferenza della commissione alle clamorose proteste dei candidati abbia inteso favorire i soliti raccomandati e che la prova invero “non fosse solo la solita farsa“.
Quanto allo svolgimento delle prove non ha poi convinto la scelta di non sorteggiare le materie nei diversi giorni di esame. “È vero che non vi era obbligo di legge in tal senso, ma è pur vero che ragioni di opportunità e trasparenza avrebbero dovuto indurre la commissione di concorso a procedere al sorteggio, così come le stesse ragioni inducono da anni il CSM a sorteggiare l’individuazione dei commissari di concorso”. Ma soprattutto, ciò che non ha convinto i giovani magistrati è stato l’indisturbato allontanamento del commissario, prof. Fabio Santangeli (poi dimessosi il 25.11), il giorno 19, che è stato la principale causa dell’abnorme ritardo nella dettatura della traccia di “diritto amministrativo”, avvenuta alle h.14. Parimenti, non hanno per niente convinto in particolare le giustificazioni fornite sul punto dal Presidente della Commissione, secondo il quale non sarebbe stato in alcun modo possibile trattenere nella sala il professore, senza chiarire la ragione perché non fosse stata approfondita sin dal primo momento la disponibilità di tempo del professore, evitando che partecipasse all’elaborazione dei testi. Cosa che poi provocava la ripetizione dell’operazione di individuazione /elaborazione delle tre tracce da sorteggiare, con l’ulteriore conseguenza della dettatura di una traccia ambigua, che ha causato ulteriori problemi di ordine pubblico, a causa delle diverse letture possibili. L’esistenza di queste accertate disfunzioni ed il mancato chiarimento di aspetti essenziali ai fini di un regolare e sereno svolgimento delle prove di esame avrebbero consigliato, secondo gli esponenti del Movimento per la giustizia, maggiore cautela nell’adozione di una delibera di archiviazione da parte del CSM. In definitiva, non si è compreso che solo una adeguata istruttoria avrebbe dissipato tutti i dubbi e reso trasparente l’operato della Commissione. Il nostro voto contrario, conclude il sito dei magistrati dissidenti, è determinato esclusivamente dall’esigenza di accertamento della verità. Esso non significa e non può significare “condanna”, ma rappresenta una decisa presa di distanza da una logica di “tutela” preventiva ed incondizionata in favore di tutti i protagonisti istituzionali della vicenda, troppo frettolosamente ritenuti attendibili, pur in difetto di quel “contraddittorio” con le voci dissonanti dei candidati, come da noi richiesto e ribadito. “Il voto contrario non significa quindi che si ritiene sussistere i presupposti per l’annullamento del concorso in via di autotutela, ma testimonia il nostro disaccordo su una risposta istituzionale del tipo “tout va très bien madame la marquise!“. Ne deriva che ”Madama la Marchesa” dovrebbe trovare del tutto preoccupante e scandaloso che anche l’ennesima indagine sui concorsi truccati in magistratura condotta dalla Procura di Milano sia stata frettolosamente archiviata in breve tempo, trascurando i molteplici riscontri probatori, che avrebbero dovuto indurre il P.M. a svolgere più accurate indagini, il quale senza neppure ascoltare le persone informate sui fatti e i candidati parti lese, prendeva invece per “oro colato” la relazione presidenziale e le sole fonti istituzionali. E’ quindi lecito dubitare che gli inquirenti al pari dei politici e dei membri del C.S.M. abbiano agito seguendo quel profondo senso di giustizia che dovrebbe animare coloro a cui è affidata la sorte della legalità.
E comunque, nella puntata di Report del 15 maggio 2011 sono stati svelati tutti i segreti che ci sono dietro ai concorsi per diventare notai, primari di ospedale o professori universitari. Forse abbiamo scoperto le modalità con cui vengono truccati alcuni concorsi ma che in Italia funzionasse così lo sapevano già tutti, non era certo un segreto che il figlio di un operaio potesse diventare notaio..neanche se molto meritevole. Interessantissima comunque l’indagine presentata da Milena Galbanelli, forse non abbiamo scoperto l’acqua calda ma il fatto che quello che succede venga raccontato apertamente in televisione è come una piccola ricompensa per chi queste cose le ha subite. L’argomento “raccomandati” è di moda nel nostro paese e lo dimostra anche il successo del film al cinema: C’è chi dice no.. Purtroppo la “raccomandazione” non serve solo per posti di lavoro molto ambiti come quelli trattati da Report, anche per lavori molto più umili occorre bussare la porta giusta o essere parenti di qualche personaggio di rilievo.. E’ inutile girarci molto intorno, l’Italia è proprio questa, programmi come Report possono però dare un piccolo aiuto a sensibilizzare la nostra mentalità sbagliata.
In questa curiosa Italia dove la legge è uguale per tutti ma per qualcuno è più uguale, dove le norme devono essere «interpretate» prima di venire «applicate, e dove la lotteria del ricorso al Tar è sinonimo di certezza del diritto, si riesce regolarmente ad aggirare perfino uno dei pilastri fondamentali del vivere civile sancito dalla Costituzione, scrive Sergio Rizzo su “Il Corriere della Sera”. Più chiaro di così, l'articolo 97 della Carta non potrebbe essere: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Negli anni, però, la nostra creatività ha scovato mille modi per far prevalere su questo sacrosanto principio parentele, amicizie e legami d'altro genere. Il caso classico è quello delle assunzioni per chiamata diretta nelle società controllate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali. Ricordate lo scandalo delle municipalizzate romane, rimpinzate di raccomandati da politici e sindacalisti? Qualche anno fa si è poi scoperto che il Consiglio regionale della Campania aveva centinaia di dipendenti in pianta stabile senza avere mai indetto un concorso pubblico dal 1971, quando la Regione era nata. Assunti da società pubbliche, erano stati distaccati presso gli uffici consiliari e poi «stabilizzati» con qualche leggina regionale. Ma non stupitevi: la pratica della «stabilizzazione» per legge, spesso votata di notte pochi giorni prima delle elezioni, è diventata ormai una regola comune in quasi tutte le Regioni. Ma c'è un mezzo ancora più odioso per evitare l'obbligo del concorso. È il concorso stesso. Non passa giorno senza che arrivi la segnalazione di qualche presunto abuso nelle valutazioni, di regole studiate ad hoc per favorire questo o quel candidato, di esclusioni paradossali dalle selezioni pubbliche, di commissioni d'esame costruite in modo sospetto. Addirittura di ricorsi al Tar che inspiegabilmente si bloccano, mentre ricorsi gemelli procedono speditamente fino a spalancare a chi li ha presentati, di solito giovanotti dal nome eccellente, la strada di una prova d'appello spesso risolutiva. Certi concorsi pubblici assomigliano moltissimo a certi appalti pubblici nei quali si sa già in partenza chi sarà il vincitore. Le cronache sono sempre più piene di casi sconcertanti. Come quello del famoso chirurgo Mario Lanzetta, un luminare della ricostruzione della mano, al quale per nove anni è stata negata la cattedra di ortopedia, nonostante cinque sentenze a lui favorevoli. Oppure quello del cardiochirurgo diventato professore dopo aver superato l'esame davanti a una commissione composta da due igienisti e tre dentisti: ma era figlio del rettore di una grande università nella quale già insegnavano moglie e figlia. O ancora quello di un certo ateneo meridionale dove l'autorità Anticorruzione allora guidata dall'ex prefetto Achille Serra aveva scoperto che «frequenti rapporti di parentela, affinità o coniugio legano nel 50 per cento dei casi il corpo docente con personalità del mondo politico, forense o accademico». E non succede soltanto nelle università. Giuseppe Oddo ha raccontato martedì sul Sole 24 ore di un concorso per dirigenti della Regione Lombardia «mai apparso in Gazzetta ufficiale», vinto da 31 persone: molte delle quali, guarda caso, appartenenti al movimento di Comunione e liberazione «il cui esponente più noto», ha sottolineato il giornalista, «è il presidente della Regione Roberto Formigoni»: fra di loro anche il nipote di un vescovo e il biografo del fondatore di Cl don Alberto Giussani. Un concorso poi dichiarato illegittimo tanto dal Tar quanto dal Consiglio di Stato, ma grazie a un cavillo quei 31 restano al loro posto. Per non parlare delle autorità indipendenti, oggi una delle poche occasioni che si offrono ai nostri giovani di entrare a far parte di una classe dirigente «tecnica» di livello europeo. Basta dare uno sguardo agli elenchi di chi ci lavora. Si scopriranno innumerevoli coincidenze con illustri cognomi. Naturalmente hanno tutti superato un concorso. Magari anche molto selettivo, ne siamo assolutamente convinti. Peccato che talvolta ci sia una discrezionalità forse eccessiva (e difficilmente controllabile) nel giudizio di certi requisiti. Facciamo un esempio? Per essere ammessi a un recente concorso bandito da un'authority si assegnavano fino a 14 punti su un massimo di 50 per le esperienze post laurea. In che modo? Quattro punti per le esperienze ritenute «sufficienti», otto per quelle «buone», dodici per le «ottime» e quattordici per le «eccellenti». Ma perché un'esperienza dovesse essere considerata soltanto «sufficiente», piuttosto che «eccellente», non era specificato. Nello stesso concorso venivano attribuiti al massimo quattro punti su 50 per la conoscenza delle lingue. Così da non penalizzare chi non sapeva una parola d'inglese o spagnolo? Boh...C'è un posto di lavoro, ma che tu non potrai mai avere anche se studi e fai sacrifici per migliorare la tua preparazione perché è già prenotato da chi ha qualche santo in paradiso: è il messaggio più odioso che si possa mandare ai giovani. Toglie loro anche le residue possibilità di sperare, oggi che la speranza è così poca. È ora di dire basta ai concorsi truccati, falsati, pilotati. Un Paese che ha la meritocrazia nella Costituzione, ma poi non assicura ai suoi figli parità di condizioni, che Paese è?
Magistratura, avvocatura, notariato. La truffa dei concorsi. Considerazioni di Paolo Franceschetti a margine dell’esame da avvocato.
1. Il problema dei concorsi nel mondo del diritto. 2. Considerazioni. 3. Le ragioni dell’attuale sistema di illegalità.
1. Il problema dei concorsi nel mondo del diritto. Esce oggi il risultato della Corte di appello di Roma relativo all’esame da avvocato. I risultati sono sempre i soliti: meno del 20 per cento di promossi. Normalmente, tra le persone, sono passati i più mediocri, mentre i migliori non riescono a passare (questo osservando il risultato tra circa una settantina di miei allievi, ove riscontro questo curioso trend nel rapporto preparazione/superamento esame). Qualche tempo fa l’ineffabile Fatto Quotidiano (il giornale che non perde occasione per incensare il peggio del peggio del sistema che abbiamo – lodi all’Unione Europea, lodi ai magistrati più delinquenti, e ultimamente anche lodi alla massoneria con inviti ad iscriversi rivolti alla magistratura nel suo complesso – ; il giornale che riduce tutti i problemi italiani a due soli: la mafia e Berlusconi) ha pubblicato un articolo lodando la politica del Ministero della Giustizia in fatto di concorsi. Infatti di recente sono stati annullati due concorsi per l’accesso alla magistratura del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale (cosiddetto TAR) per irregolarità; è stato annullato un concorso notarile per palesi irregolarità. E’ il segno, secondo il quotidiano, che si tenta di fare pulizia in questo campo. In realtà è il segno che si sta facendo pulizia, sì, ma in senso completamente diverso. Spieghiamoci meglio. Fino a qualche tempo fa il concorso in magistratura e quello notarile erano considerati “puliti”. Circolava voce tra i candidati che queste prove fossero infatti tra le più pulite nel mondo dell’amministrazione pubblica. All’esame da avvocato, al contrario, le porcherie dell’amministrazione sono state effettuate sempre a cielo aperto. Il famoso caso di Catanzaro del 2001 fu la prova provata, lampante, eclatante, delle irregolarità di massa effettuate all’esame: la magistratura infatti – a seguito di una denuncia di tre candidati, che segnalarono il fatto che la commissione aveva dettato le soluzioni delle tre prove a tutti – aprì un’inchiesta che coinvolse tutte le migliaia di candidati presenti all’esame, oltre ai membri della commissione, ma il risultato fu che venne tutto messo nel dimenticatoio e archiviato. Le irregolarità sono continuate; e il sud continua a sfornare percentuali altissime di vincitori, a fronte della bassa percentuale dei candidati del nord, ove regolarmente vengono trombati i migliori e fatti passare i peggiori. Al concorso in magistratura, invece, le cose erano sempre andate diversamente. In realtà in questi anni anche il mito della pulizia di questo concorso è stato sfatato in modo palese. E’ dal 2003 infatti che le irregolarità al concorso in magistratura sono sempre più eclatanti. In quell’anno scoppiò il famoso caso Clotilde Renna, ovverosia il caso di un magistrato di Cassazione sorpreso a truccare un elaborato; successivamente la commissione avallò il comportamento del magistrato sostanzialmente ammettendo le irregolarità, ma non venne preso alcun provvedimento. Negli anni successivi c’è stato poi lo sfascio totale del concorso, con i candidati che portavano in aula testi non ammessi, le persone sorprese a copiare che non venivano espulse, ecc... Anche il concorso notarile sta seguendo, a quanto pare, il trend degli altri concorsi, mostrando apertamente le irregolarità commesse. Il motivo per cui è stato sospeso il concorso di recente, infatti, non è un motivo banale e secondario, ma un motivo gravissimo, che dimostra platealmente una precisa volontà di non seguire le procedure da parte della maggioranza dei commissari (precisamente furono assegnate – contrariamente a quanto dice la legge – delle tracce che erano già state assegnate pubblicamente in una scuola notarile romana).
2. Considerazioni. Che anche i concorsi per magistratura e notariato fossero truccati, in realtà, è sempre stato noto a chi lavora nell’ambiente. Ricordo perfettamente, ad esempio, che anni fa un magistrato della Corte Costituzionale, scambiandomi per un massone a causa dell’incarico importante che rivestivo (incarico da cui mi buttarono fuori dopo pochi giorni), mi propose di fare il concorso al TAR anche se non ne avevo i titoli, che tanto “ci avrebbero pensato loro”. Così come ricordo che un mio conoscente con cui facevo ogni settimana il viaggio Napoli-Roma, figlio di una importantissima famiglia romana, vinse il concorso notarile pur avendo sbagliato la soluzione e pur non riuscendo a cogliere la differenza tra usufruttuario di un bene e amministratore di un bene (secondo lui erano la stessa cosa perché l’usufruttuario ha anche l’amministrazione del bene), e superò anche l’esame da avvocato pur non avendo con sé i codici durante le tre prove, tranne quello di procedura penale (perché secondo lui il diritto civile e penale li conosceva, quindi il codice non gli serviva, e il codice di procedura penale invece lo aveva portato a tutte e tre le prove perché – cito testualmente – “può sempre servire”). La differenza dei concorsi in magistratura e notarile rispetto all’esame da avvocato era che le irregolarità erano molto più raffinate e nascoste rispetto a quelle dell’esame da avvocato (che sono sempre state commesse a cielo aperto) ed erano evincibili dai dati e si riusciva a captarle solo se si aveva una conoscenza approfondita del sistema. La gran differenza rispetto agli anni scorsi è unicamente che, da dieci anni a questa parte, il sistema ha deciso di rendere note a tutti le irregolarità. Oggi tutti le hanno potute constatare e raccontare. Resta da chiedersi il perché. Il sistema ha sempre nascosto le notizie che non voleva fossero conosciute, dando all’esterno l’immagine che sceglieva di avere. E’ ovvio allora che le irregolarità di questi ultimi concorsi, e l’accentuazione di quelle effettuate all’esame da avvocato, sono volute. Sono infatti troppo evidenti, e troppo stupide, per poter essere casuali. Far entrare dei candidati che portavano con sé testi non ammessi, sì che tutti attorno potessero constatare il fatto, e per giunta espellere in alcuni casi le persone che protestavano proteggendo colui che stava commettendo il reato, nonché ammettere pubblicamente le irregolarità, come fece in TV la commissione del concorso in magistratura nel 2003, assegnare a 5000 candidati delle tracce palesemente illegittime, significa perseguire una precisa volontà di esternare a tutti i candidati la situazione. Significa dire a tutte le migliaia di candidati: vedete? Noi commettiamo irregolarità! Questi concorsi sono truccati. Sappiatelo. E significa esternare tutto ciò in modo sfacciato, sicuri dell’impunità. Allora, lungi dal vedere in ciò un segno positivo del sistema, occorre vedere un segno di altro tipo. Occorre cioè domandarsi: perché il sistema ha deciso di uscire allo scoperto, rendendo palesi certe irregolarità? Il motivo a mio parere è sociale e psicologico.
3. Le ragioni dell’attuale sistema di illegalità. Il motivo è da ricercare nel trend dell’attuale situazione politica. Tutti abbiamo notato che in questi anni c’è un decadimento della politica. Si sono abbassati i contenuti della lotta, e i personaggi che dominano la scena sono privi di spessore e cultura. La politica insomma è diventata un caos. L’istruzione, dalle scuole elementari all’università, peggiora la qualità dei servizi sfornando gente sempre più ignorante. Nell’ambito della giustizia si è fatta la stessa cosa. Perché il sistema attuale possa funzionare, dobbiamo avere leggi pessime e farraginose, magistrati ignoranti e demotivati, e avvocati dello stesso livello. Non a caso lo sfascio a cielo aperto del sistema giustizia comincia dal 2001, anno in cui viene nominato come Ministro della Giustizia un ingegnere. La nomina di un ingegnere come Ministro della Giustizia non è casuale. Apparentemente può sembrare un’anomalia come tante nel nostro panorama politico. Un’anomalia grave, ma in fondo simile a quella di tanti altri ministeri, ove si avvicendano alla sanità persone che di medicina non capiscono nulla, all’istruzione persone incolte, ecc. Ma in realtà la scelta non è affatto casuale. Ogni ministro, e ogni ruolo che ricopre, infatti, serve anche a dare un segnale politico e a trasmettere messaggi simbolici che possono essere colti solo da chi è “iniziato” a tale linguaggio. Era quello il segnale politico che doveva essere distrutto il sistema in modo sistematico. Nel 2001 abbiamo lo scandalo di Catanzaro. Nel 2003 lo scandalo Renna. In una discesa allo sfascio che ormai non conosce più ostacoli. Le ragioni? Demotivare i migliori. Far andare avanti prevalentemente i raccomandati, gli stupidi, quelli che il sistema non lo capiscono veramente. Gli altri, quelli che capiscono, scelgono di lavorare altrove. Abbandonano. Si demotivano. Perché non possono continuare a lavorare in un sistema dove vengono premiati i peggiori e in cui le irregolarità sono all’ordine del giorno, sotto gli occhi di tutti, e vengono commesse sia nelle piccole cose che nelle grandi. Il 2001, insomma, è l’anno cruciale per il sistema giudiziario. La nomina di Castelli all’esecutivo è l’ordine – dato in termini simbolici – di dare il via alla danza dell’irregolarità conclamata. Le ragioni delle scelte ministeriali in tema di esame da avvocato e concorsi, insomma, è la stessa che sta alla base di tutte le altre scelte politiche. Sfasciare. Demotivare. Ordo ab chao, il motto massonico.
La vicenda dei compiti non corretti nel concorso del 1992. «NON INSABBIATE LO SCANDALO DEL CONCORSO». L'ex pg del Piemonte: colpiti anche i magistrati onesti. TORINO. Così, il giorno dopo le rivelazioni de «La Stampa» sul concorso per uditori giudiziari, parla l'ex procuratore generale del Piemonte, Silvio Pieri. L'alto magistrato non usa mezzi termini: «Quanto è accaduto è gravissimo. Ho avuto modo di verificare l'intera documentazione raccolta dall'avvocato Berardi. Ho fotocopiato tutti gli atti, uno per uno. Credo che, a un certo punto, questa situazione si potesse risolvere subito, con decisione, con la necessaria trasparenza. Ma il ministero ha pervicacemente rifiutato, sino all'ultimo istante, di affrontare in modo diretto quanto era accaduto, quanto era sotto gli occhi di tutti. Con il risultato di mettere a pregiudizio le posizioni anche di quei magistrati che svolsero, in allora, i temi in modo corretto. Ma non credo assolutamente che si possano ulteriormente ignorare i verbali sottoscritti da gente che non c'era, la storia dei fascicoli spariti, degli elaborati giudicati "idonei" quando non lo erano affatto». Non solo. Contro il muro di gomma opposto dal ministero di Grazia e Giustizia (a proposito del concorso per uditori giudiziari del 20, 21, 22 maggio 1992, ora sotto accusa per aver trasformato in «idonei» decine di candidati autori di prove molto discutibili) erano già rimbalzate, nel corso degli anni, ben 13 interpellanze parlamentari, firmate quasi tutte da Nicky Vendola di Rifondazione Comunista, ma anche da esponenti di An e di altri partiti. Morale: nessun risultato. Acqua fresca. I vari governi «prendevano atto», e tutto ricadeva nel silenzio. Adesso, in attesa dei risultato del ricorso presto in discussione al Consiglio di Stato per ottenerne l'annullamento, emergono nuovi e sconcertanti aspetti di quelle prove d'esame, che hanno poi regolarmente trasformato in magistrati 275 candidati su 2244. I «promossi» di allora rischiano il posto, anche se le sentenze e le decisioni emesse in questi anni non perderanno la loro validità. L'avvocato penalista Pierpaolo Berardi è riuscito - dopo un'estenuante ed epica battaglia con il ministero - ad avere visione dei temi giudicati «idonei». «Uno choc -racconta ora, nel suo studio, nel centro di Asti - perchè le irregolarità erano così palesi da rasentare il ridicolo». I temi sono contrassegnati da numeri, in modo da non rivelare l'identità del candidato alla commissione. Dunque, tra i promossi, il 624 non conclude il tema; il 1050 utilizza solo settori del protocollo, lasciandone una parte in bianco, così come il 525 e l'848, che usa una facciata sì e una no; il 1053 fa di più: cambia più volte la calligrafia; il 791 è un tipo strano. Un tema lo scrive tutto in stampatello, il secondo e il terzo in corsivo; il 210 ha un singolare rapporto con le C. In alcune compare un vezzoso, insistito, ben sottolineato, «ricciolino». In molte altre C, però, niente. Ancora: il 1440 «copia interi brani, e i temi sembrano, anzi sono, l'esatta fotocopia di testi giuridici»; il 2006 cambia la grafia, come se un vento tempestoso soffiasse sulle linee verticali delle T, delle P, delle Q. Ogni tanto piegano a destra, ogni tanto a sinistra, ogni tanto ritornano al centro. Abbastanza da far impazzire un grafologo. «...Sistemi, anche rozzi, solo per farsi "riconoscere". Ma sono solo un esempio. C'è anche il 1457, che scrive in un modo assolutamente illeggibile. Come hanno fatto altri», spiega l'avvocato, che spera «di avere, prima o poi, giustizia», non solo dal Consiglio di Stato, ma anche dal gip di Perugia, che dovrà decidere proprio in questi giorni sulla sparizione dall'archivio del ministero dei tre temi del candidato, attuale magistrato, Francesco Filocamo, e sui misteriosi verbali di quella commissione, le cui firme conclusive, all'altezza dello spazio riservato al segretario, portano talvolta questa curiosa dizione: «Apposta per errore». Appunto, errori su errori. «Ho avuto molte prove di solidarietà, in queste ore. Decine di telefonate. Professori universitari, avvocati da tutta Italia. E soprattutto numerosi magistrati. Mi hanno detto di continuare questa battaglia, di non farmi intimidire da nessuno, che è giusta, che difende la professionalità e l'integrità morale dei magistrati, la maggioranza, che il concorso lo hanno vinto con onestà, dopo anni di studi e sacrifici. No, non me lo aspettavo», dice l'avvocato. Nel corso dell'interminabile iter, il Tar impose tra l'altro che le prove di Berardi fossero riesaminate. «Ma i miei temi finirono sotto gli occhi della stessa commissione che mi aveva già dichiarato inidoneo. Il buon senso avrebbe voluto che fossero nominati altri, nuovi, esaminatori. Come avrebbero potuto, i primi, sconfessare il loro primo giudizio? Lo confermarono. E stop. Solo un magistrato, Giovanni Bellagamba, si dimise con una lettera. Spiegando che quella procedura non era corretta nei miei confronti». Il dossier raccolto dall'avvocato di Asti sarà oggetto di nuove interpellanze parlamentari. Con la speranza che non vadano a morire, come le altre, perdute nel porto delle nebbie. Tratto da "La Stampa", 10 settembre 2004.
"Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi . L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali, che cominceranno fra un mese, vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori. Il che sta scatenando una serie di ricorsi che, insieme con l'inchiesta penale aperta dopo la scoperta dello scandalo della fotocopiatrice di cui il Corriere ha già scritto e con la denuncia di un giudice indignato che ha chiesto a Ciampi l'annullamento della prova, rischiano di far saltare tutto. Sia chiaro: alla larga da ogni tentazione anti-meridionalista. Moltissime delle vittime di questa «anomalia», come provano le email furibonde inviate ai siti Internet specializzati quali www.sarannomagistrati.it, sono giovani laureati meridionali certi d'avere subito un sopruso. Meridionali (e napoletani «sfortunati») sono molti dei firmatari degli esposti al Tar. E ancora meridionale è l'avvocato Giovanni Pellegrino, già senatore della sinistra, al quale sono state affidate una cinquantina di denunce. Un esempio solo: in tutta la Sardegna coloro che hanno superato sia la «preselezione informatica» sia gli scritti, sono stati 6. Uno ogni 266 mila abitanti dell'isola. Contro una media nazionale (alzata dall'impennata partenopea: uno ogni 43 mila) di un promosso ogni 137 mila che senza la Campania sale a uno ogni 187 mila. Tutti tonti, i bocciati? Mah... Forse vale la pena di ripartire dall'inizio. E cioè dalla mattina del 24 settembre 2002 in cui i laureati in giurisprudenza che sognano di entrare in magistratura partendo dal ruolo di uditore giudiziario vengono convocati alla selezione preliminare, un test su una scelta di alcune decine di quiz presi dai 15.743 pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale. Le sedi d'esame sono quattro: Torino (tutti i candidati del Nord, tranne l'Emilia), Roma (tutti quelli del Centro, più l'Emilia-Romagna, la Campania e Reggio Calabria), Bari (tutti quelli della Puglia, della Basilicata e di Catanzaro) e Palermo (tutti i siciliani). I convocati sono 25.204, dei quali 1.236 di Roma e del Lazio, 1.008 del distretto di Corte d'Appello di Napoli (tutta la Campania, meno Salerno), 414 di quello di Milano e della Lombardia occidentale (Bergamo, Mantova e Cremona stanno con Brescia). Alla preselezione, in realtà, si presentano in 10.153. Dei quali circa un quinto (1.952, più gli emiliani dirottati alla sede d'esame di Roma) delle regioni settentrionali. Una quota molto bassa, rispetto alla popolazione che, Emilia-Romagna compresa, rappresenta il 44% della popolazione italiana. Prova provata che la toga non gode, al Nord, del fascino che esercita sui giovani del centro ma soprattutto del Sud della penisola. Una disaffezione grave. Accentuata, diciamo così, tra i membri della commissione esaminatrice, presieduta da Michele Cantillo, a lungo presidente della commissione tributaria di Salerno e poi di una sezione della Cassazione. Commissione che vedeva la presenza di 11 giudici (6 delle regioni settentrionali tra i quali Francesco Saverio Borrelli) del Centro-Nord, in rappresentanza del 66% per cento della popolazione italiana, e 13 del Sud, dei quali 7 di Napoli o Salerno, in rappresentanza del restante 34%. Ma ancora più anomala era la composizione della fetta accademica della commissione: su 8 professori, infatti, uno veniva da Teramo e tutti gli altri dagli atenei del defunto Regno delle Due Sicilie, con una preponderanza straripante di docenti napoletani: cinque su otto. Tutto regolare, per carità. Tutto regolare. Ma non è questo un metodo geniale per portar acqua al mulino di quei razzisti nostrani che ragliano di una «giustizia terrona»? Non sarebbe stata più saggia, moralmente e politicamente, una scelta meno squilibrata? Certo è che il cammino del concorso è stato fin dall'inizio accidentato. In plateale contrasto con le regole più ovvie previste per un concorso che doveva assumere 350 persone nel ruolo e nel settore più delicati della pubblica amministrazione, per esempio, i fogli consegnati per la prova scritta agli esaminandi non erano firmati dal presidente o da un suo incaricato ma solo timbrati. E furono distribuiti così disordinatamente che moltissimi sono stati portati a casa dai candidati (e se fu possibile portarli fuori è ipotizzabile che qualcuno avesse potuto anche portarli dentro, magari già compilati) per finire come prova delle irregolarità nei fascicoli delle denunce alla magistratura. Alla diffidenza seminata tra i giovani con questo andazzo un po' arruffone per una prova così delicata, fu aggiunta una scheda elettronica con i quiz, tipo la nuova patente di guida, non sorteggiata ma nominale: a Mario Rossi i quiz destinati a Mario Rossi, a Luigi Bianchi i quiz destinati a Luigi Bianchi, con tanto di fototessera dell'aspirante uditore. Viva la fiducia, ma non sarebbe stato meglio evitare anche il sospetto che il raccomandato Tizio Caio avesse avuto i suoi 90 quiz accuratamente scelti tra i più facili? Non bastassero le polemiche, ecco arrivare infine lo scandalo fatto esplodere dalla «fotocopiatrice legalitaria e giustizialista». Ricordate? Una delle toghe della commissione, la napoletana Clotilde Renna, chiese ai colleghi come fosse andata una sua protetta. Ricostruzione del giornale online Diritto e giustizia edito dalla Giuffrè: «I colleghi mostrano il risultato: respinta, c'erano alcune lacune che non consentivano un giudizio favorevole. "Ma come - chiede il magistrato-commissario - è una ragazza molto brava". "Sarà - rispondono - ma la prova non va bene". Il giudizio era già stato verbalizzato, non c'era più niente da fare». A quel punto la donna, decisa comunque ad averla vinta, si introdusse di notte nella sala dov'erano custoditi i compiti, aprì la busta con l'esercizio della raccomandata, infilò un nuovo foglio con alcune correzioni che avrebbero permesso alla sua coccola di fare ricorso al Tar contro la bocciatura. Non contenta, per dimostrare quanto aveva fatto a chi le aveva chiesto un occhio di riguardo per la pulzella, tentò di fare una copia del falso. Al che la fotocopiatrice si ribellò e, grazie all'errore d'impostazione nella programmazione delle copie, cominciò a sfornarne per ore e ore, a centinaia e centinaia. Col risultato di smascherare l'imbroglio e di far scattare la denuncia, l'inchiesta, la rimozione di Clotilde Renna dalla commissione. «Se irregolarità vi è stata, e questo sarà oggetto di accertamento», avrebbe dichiarato la donna poco prima di essere sospesa, «tengo a precisare che la serenità della commissione non può essere in alcun modo messa in discussione e così i lavori da essa compiuti». Grazie, ex-giudicessa: se ce lo garantisce lei! Macché: per niente rassicurati dalla serenità della visitatrice notturna, i giovani laureati non ammessi agli orali hanno preso a tempestare Internet di domande. Come faceva la Renna a chiedere notizie di un nome, qualunque fosse, se i temi devono per legge restare anonimi fino al momento in cui tutti (tutti) sono già stati corretti? E come potevano i colleghi della commissione risponderle che la sua protetta era stata trombata se anche per loro ogni compito doveva essere anonimo? E chi diede alla magistrata nottambula le chiavi della stanza dove stavano gli scritti? E come fece la falsaria a individuare la busta giusta se questa doveva essere priva di segni di identificazione? Insomma: siamo sicuri che noi cittadini stiamo assumendo come magistrati tutte persone perbene e non anche qualche furbetto che ha mischiato le carte per indossare la toga? Il ministero e il Csm hanno niente da dire? Ma non è finita. Alla lista dei dubbi, infatti, se n'è aggiunto un ultimo. Messo chiaro e netto in questi giorni in un esposto a Carlo Azeglio Ciampi, Roberto Castelli e Virginio Rognoni dal giudice onorario Carlo Michele Mancuso. Il quale, forte di un cognome siciliano che da solo spazza via ogni ipotesi di polemica anti-meridionalista o bossiana, non solo si richiama a tutte le perplessità già riassunte («pare certo che la correzione degli scritti non è avvenuta in modo collegiale» e senza «alcuna garanzia di eguaglianza, imparzialità e legalità nei confronti di tutti») ma chiede di annullare il concorso anche per lo strabiliante trionfo dei candidati campani: «E' difficile pensare a una percentuale così alta di candidati appartenenti a un solo distretto giudiziario». Mancuso parla espressamente di «provato favoritismo». Altri, più benevoli, citano la mitica tradizione giuridica napoletana. Oppure la preparazione fornita dalle grandi scuole partenopee quali quella di Rocco Galli, così famosa e così frequentata che i corsi ormai si tengono solo a Roma in ampie sale da centinaia di posti quali il cinema «Nazionale» o il teatro «Sistina». O ancora la preponderanza tra gli aspiranti giudici di giovani meridionali, preponderanza che fatalmente porterebbe ai risultati di oggi. Tutto vero. I numeri, però, danno da pensare: è mai possibile che gli ammessi agli orali dei distretti di Napoli e Salerno (un 25° dei candidati, inizialmente) siano 132 e cioè il doppio di tutte le regioni del Nord che messe insieme (tolta l'Emilia Romagna) arrivano stentatamente a 74? Possibile che i ragazzi laziali passati ai preliminari e agli scritti siano stati il 3,7% e quelli campani (tolta Salerno) addirittura il 12%? Possibile che la Campania abbia poco più degli abitanti della Sicilia ma il quadruplo (132 contro 36) dei quasi-giudici e tre volte la popolazione della Sardegna ma 22 volte più geni del diritto? Per non parlare del rapporto con alcune regioni settentrionali come il Veneto e il Friuli, che insieme fanno più abitanti della Campania ma si ritrovano con una dote di futuri magistrati otto volte più bassa: 17 contro 132. Tutti mona? Domanda: c'entra qualcosa, in queste eccentriche coincidenze, un pizzico di campanilismo, familismo, favoritismo? A meno che non sia una domanda impertinente... Gian Antonio Stella (La Stampa 10 09 04 - tratto dal Corriere della Sera)
"Durante la prova scritta una commissaria, magistrato di Cassazione, avrebbe favorito una candidata, correggendo il suo compito «Indagate sul concorso truccato dei giudici» Il Tar chiede al Guardasigilli di far luce su presunte irregolarità degli esami"; di Massino Martinelli (Da Il Messaggero, 7 ottobre 2004). Il ministero della Giustizia dovrà avviare una ispezione sulla regolarità del concorso per magistrato, tuttora in svolgimento. A sollecitare l'attività dell'Ispettorato è stato il Tar del Lazio, dopo che alcuni candidati esclusi dalla prova orale avevano avanzato dubbi sulla trasparenza dei criteri per la correzione dei compiti. A provocare la polemica è stata la scoperta, lo scorso luglio, del tentativo di una commissaria d'esame, consigliere di Cassazione, di correggere il compito di una candidata sua amica. Il magistrato è stata indagata e sospesa dalle funzioni e dallo stipendio, ma adesso molti dei 25 mila candidati chiedono di ripetere le prove. Il Tribunale amministrativo del Lazio, prima di pronunciarsi sul ricorso di alcuni esclusi, chiede "accertamenti" al Guardasigilli «Concorso dei magistrati, il ministro indaghi». La candidata favorita da una commissaria, interviene il Tar: serve un'ispezione. Adesso nessuno potrà far finta di niente, nei corridoi del ministero della Giustizia. La patata bollente del concorso truccato per entrare in magistratura dovrà essere presa in mano, sbucciata e servita ben aperta a chi deve decidere se quei 25mila ragazzi che sognavano la toga dovranno ricominciare tutto daccapo oppure no. Con una decisione che ha pochi precedenti, il Tar del Lazio ha infatti "invitato" il ministero della Giustizia ad avviare una ispezione formale sull'accaduto. E' come se un controllato chiedesse al controllore di darsi una mossa per scoprire chi, e perché, e come, ha commesso una grave irregolarità. Eppure, su questa vicenda che vede come protagonista un (ormai ex) alto magistrato di Salerno, il consigliere di Cassazione Clotilde Renna, si sono già mossi in tanti. La Procura di Roma l'ha indagata per falso e abuso in atti d'ufficio; il Csm l'ha sospesa in via cautelare dalle funzioni e dallo stipendio. Ma il ministero, niente. «Evidentemente, temono che una ispezione formale possa rallentare il concorso, o peggio, bloccarlo - sussurra un alto funzionario del ministero che chiede l'anonimato - E di questi tempi, sarebbe davvero negativo rinunciare ai nuovi magistrati». Eppure, il Tar del Lazio, questa ispezione la chiede ufficialmente. Anzi la "ordina", come si legge nell'ordinanza del 25 settembre scorso. E assegna anche un termine al Capo dell'Ispettorato: 45 giorni. Al termine dei quali dovrà essere depositata una relazione che risponda ad una serie di quesiti indicati nell'ordinanza. La storia è nota. Il sostituto procuratore generale di Salerno, Clotilde Renna, da trent'anni in magistratura, già componente della commissione d'esame di quel concorso, è accusata di aver sostituito alcune parti di un compito scritto che era già stato corretto e giudicato insufficiente. L'aggiunta, che tecnicamente gli inquirenti chiamano "falso per addizione" sarebbe servita ad una giovane candidata, per ricorrere contro l'esclusione. Il pm incaricato degli accertamenti, Pietro Giordano, ha già convocato l'alto magistrato per contestargli i reati; e la Renna sarebbe pronta a presentarsi la prossima settimana, assistita dal professor Alfonso Stile. Le indagini della Procura hanno ricostruito tutti i passaggi della vicenda, a cominciare dalla curiosa circostanza che portò alla scoperta del fattaccio: la Renna avrebbe fatto alcune fotocopie del compito corretto e la macchina si sarebbe inceppata per esaurimento della carta; la mattina dopo, una volta ricaricata, avrebbe ricominciato a sfornare copie del compito riveduto e corretto, tra lo stupore degli altri commissari d'esame. E' stata identificata anche la candidata che avrebbe goduto del falso compito: si tratta di una ragazza che l'alto magistrato conosce e alla quale è legata da un legame affettivo. Questa verifica ha permesso di escludere l'ipotesi della corruzione: se effettivamente la commissaria si adoperò per sostituire il compito della giovane candidata, questo non avvenne dietro pagamento di denaro. Ma il Tar del Lazio, che non ha poteri investigativi ma deve basare le sue decisioni sugli accertamenti svolti da altri, ha deciso di chiedere al Csm il fascicolo sul caso Renna e di mobilitare il ministero per conoscere una serie di circostanze ancora dubbie. Ad esempio: l'alto magistrato continuò a correggere compiti anche dopo l'episodio della fotocopiatrice? E come faceva a sapere qual'era il compito della sua protetta se gli elaborati erano contrassegnati solo da un numero e la lista dei candidati con il numero di riferimento doveva essere segreta a tutti? E ancora, come sono state formalizzate le dimissioni della dottoressa Renna dalla commissione d'esame, visto qualcuno parla di una lettera di dimissioni con la data lasciata in bianco? Insomma, il Tar del Lazio vuole sapere se qualcuno, in seno alla Commissione, abbia cercato di tenere tutto nascosto anche dopo la scoperta del fattaccio. Intanto, i cinquanta candidati che, con l'assistenza del professor Giovanni Pellegrino, si sono rivolti al Tar, aspettano fiduciosi. Chiedono che i compiti siano corretti di nuovo da una commissione al disopra di ogni sospetto. E sembra che il Tar abbia intenzione di accontentarli.
MANETTE FACILI, IDEOLOGIA ED OMICIDI DI STAMPA E DI STATO: I PROCESSI TRAGICOMICI.
Ai funerali di Pietrino Vanacore, intorno alla sua bara, assorta nel silenzio con la rabbia ed il dolore, c’era la gente che gli voleva bene. Una donna ha avuto il coraggio di dare voce alla sua comunità: «applaudite, hanno ottenuto quello che volevano!!!» La frase era rivolta a coloro, che, per deformazione professionale e culturale, non hanno una coscienza. Intanto, intorno alle sue spoglie gli sciacalli hanno continuato ad alimentare sospetti. La sua morte non è bastata a zittire una malagiustizia che non è riuscita a trovare un colpevole, ma lo ha scelto come vittima sacrificale. A zittire una informazione corrotta che lo indicava come l’orco, pur senza condanna. Non poteva dirsi vittima di un errore giudiziario, come altri 5 milioni di italiani in 50 anni. Per venti anni è stato perseguitato da innocente acclamato. Voleva l’ultima parola per dire basta. Non l’hanno nemmeno lasciata. Pure da morto hanno continuano ad infangare il suo onore. Accuse che nessuna norma giuridica e morale può sostenere. Accanimento che nessuna società civile può accettare. La sua morte è un omicidio di Stato e di Stampa. Non si può, per venti anni, non essere capaci di trovare un colpevole e continuare a perseguitare un innocente acclamato. Non si può, per venti anni, continuare ad alimentare sospetti, giusto per sbattere un mostro in prima pagina. Ferdinando Imposimato, il “giudice coraggio” delle grandi inchieste contro il terrorismo e la delinquenza organizzata, ha provato sulla propria pelle l’amarissima esperienza di star sul banco degli imputati. Egli conclude, come un ritornello inquietante: “E’ più difficile talvolta difendersi da innocenti che da colpevoli”. Parola di magistrato.
Manette facili e ideologia. Che processi tragicomici.
Oltre quarant'anni fa, le commedie all'italiana avevano colto le degenerazioni del sistema giudiziario. Quasi nulla è cambiato, scrive Claudio SiniscalchiIl Giornale L'editoria cinematografica italiana è stata dissanguata prima dagli ideologi di sinistra, poi dal dominio della scrittura oscura di semiologi e psicoanalisti, o presunti tali. Ormai trattasi di un corpo tenuto in vita da una macchina artificiale. Ci vorrebbe, per rianimarlo, un miracolo. O, almeno, un po' di sangue fresco. Buona linfa scorre all'interno di una linea di ricerca sul cinema italiano avviata dall'editore calabrese Rubbettino, guidata dal giovane universitario Christian Uva, all'insegna di una complementarità: cinema e storia. L'ultimo tassello è In nome della legge. La giustizia nel cinema italiano, a cura di Guido Vitiello. Il volume, raccolta di molti saggi, suscita alcune considerazioni. Dagli anni Trenta del secolo passato ad oggi, cioè dal fascismo alla democrazia, la commedia è stata il genere principe del cinema italiano. Nel Ventennio la macchina da presa s'è tenuta alla larga dai tribunali. Nel dopoguerra invece ci si è buttata per cogliere il tratto comico della giustizia. L'immenso Vittorio De Sica con la toga da avvocato (versione aggiornata dell'azzeccagarbugli manzoniano), folti capelli candidi, gesti da mattatore, eloquio da senatore (del Regno non della Repubblica), ridicolizzato dalla perdita della memoria. Totò e Peppino, grandissimi falsi testimoni. L'Albertone nazionale alla sbarra imputato di essersi bagnato nella marana senza vestiti. Il giudice Adolfo Celi che non ammette repliche alla sua autorità e competenza equestre. Insomma, in aula si ride. Pensate ora all'americano Codice d'onore (1992) di Rob Reiner. Il giovane Tom Cruise in doppiopetto blu con bottoni d'oro, avvocato della marina, assistito da Demi Moore, impegnato ad incastrare davanti alla corte marziale un mastino gallonato del corpo dei marine, Jack Nicholson. Non è uno scontro generazionale, di temperamenti, ma di visioni del mondo. Persino di attori. Il processo qui è anche spettacolo. Un grandioso spettacolo. Serissimo. Certo l'impianto giuridico americano rispetto a quello italiano agevola la drammatizzazione cinematografica. Per questo il cinema hollywoodiano ha un genere specifico dedicato ai tribunali, il courtroom drama o legal film. La commedia all'italiana, però, non è stata soltanto un contenitore di risate. Ha saputo anche cogliere e indicare questioni cruciali. Ad esempio la denuncia dell'arbitrarietà della carcerazione preventiva. L'odissea giudiziaria (e carceraria) che tocca ad Alberto Sordi in Detenuto in attesa di giudizio (1971) di Nanni Loy è un capolavoro dal sorriso amaro. Lo stritolamento dello sfortunato e innocente geometra mette a nudo l'arretratezza del sistema giudiziario e carcerario italiano. Siamo all'inizio degli anni Settanta, e sembra la storia di oggi. E come dimenticare l'istantanea sull'ideologizzazione progressista della magistratura scattata da Dino Risi nel suo In nome del popolo italiano (1971)? Il giudice Ugo Tognazzi non riesce a contenere l'odio di classe nei confronti dell'imprenditore di successo Vittorio Gassman. Quest'ultimo incarna il male del capitalismo italiano del boom economico: corrotto e corruttore. Quindi va eliminato, anche bruciando le prove della sua innocenza. La condanna non deve essere giudiziaria ma ideologica e morale. Infatti il procuratore, che mostra con disinvoltura una copia dell'Unità, non ce l'ha solo con i ricchi. Vorrebbe chiudere in cella anche capelloni, maoisti, anarchici, obiettori di coscienza, giovani scansafatiche. Da un figlio dei fiori redarguito si becca un insulto e l'accusa di essere fascista. Del resto nello stesso periodo la magistratura viene raffigurata come il braccio armato del potere (spesso occulto, antidemocratico, fascistoide), sia nel genere popolare «poliziottesco», sia nel filone di «ricerca impegnata», da Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) e Todo Modo (1976) di Elio Petri a Cadaveri eccellenti (1976) di Francesco Rosi. Il cinema italiano si suicida tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Nelle macerie dell'ultimo trentennio si salva poco o niente. L'inchiesta Mani pulite poteva diventare un serbatoio infinito di sceneggiature ma la poltrona della sala cinematografica è stata sostituita dal divano di casa. La magistratura saliva al cielo grazie al piccolo schermo. La grande popolarità di Antonio Di Pietro, il più teatrale dei magistrati, comincia con la televisione. E con la televisione si chiude. Non regge all'urto della cannonata sparatagli da Milena Gabanelli. Col tubo catodico era schizzato tra le stelle. Col plasma è tornato sulla terra.
LA VERITA’ NON E’ UGUALE PER TUTTI.
Così il linciaggio della verità trasforma vittime in colpevoli. Dalla politica alla giustizia, ecco come la sinistra è maestra nel rovesciare la realtà. E se il Cav denuncia la persecuzione dei pm è descritto come un eversore da far fuori, scrive Stefano Zurlo su “Il Giornale”. Cominciò tutto vent'anni fa, quando IlSabato pubblicò su Antonio Di Pietro il più iconoclasta dei dossier. Pagine e pagine che grondavano prestiti in denaro, telefonini garçonnière, Mercedes e cavalli. La grande stampa, invece di andare a verificare le crepe aperte nel monumento nazionale, sbadigliò ed emise un verdetto lungo appena una parola: veleni. Era tutto vero, o quasi, ma questo non interessava. Pigrizia e ipocrisia vanno a braccetto e tutte e due poggiano su una grande piattaforma lessicale da cui si possono pescare facilmente formule politically correct per umiliare l'avversario. Se il Giornale denuncia l'esasperante lentezza di un magistrato che deve ancora scrivere le motivazioni della sentenza di condanna di uno stupratore ed è stato invece rapidissimo nello spiegare la condanna del Cavaliere, quella è la macchina del fango. Se tre pentiti prendono le difese di qualche leader del centrodestra, allora siamo agli schizzi di fango. Parenti stretti della macchina del fango. Se invece un gip dispone di interrogare tutti i collaboratori di giustizia che potrebbero sapere qualcosa delle frequentazioni mafiose di Renato Schifani, questo non è accanimento giudiziario ma, controllo di legalità. Ci mancherebbe. L'Italia è divisa in due. E per entrare dalla parte che conta, ci vuole anche un passaporto linguistico. Bisogna usare i codici, gli stilemi e le parole passepartout dei soloni della Repubblica e del Fatto quotidiano e dell'Unità e di tutti quelli convinti di essere gli eredi di Indro Montanelli e prima di lui di Gramsci, di Gobetti, di Mazzini e pure dell'Illuminismo. Perché gli altri, quelli che più o meno razzolano nel perimetro di quel ghetto chiamato centrodestra, sono l'Italia alle vongole, l'Italia cafonal e caciarona in bilico fra rumorosi e goffi picnic anni Cinquanta e feste fuori misura alla fratelli Vanzina. Ha ragione Francesco Merlo su Repubblica: «Oggi l'eversione è l'inversione dei significati più semplici». Il problema è capire chi ha capovolto il mondo e ha trasformato il vocabolario in un tapis roulant su cui corrono le bugie. Antonio Esposito fa a pugni con la lingua italiana in un'intervista spericolata che sarebbe un pezzo cult per Techetechetè. Niente: resta per i giornali e le tv il giudice impermeabile, austero, tutto d'un pezzo. Se la casta non l'avesse portato quasi in cima alla piramide degli ermellini l'avrebbero abbattuto come un albero malato. Il suo italiano zoppo, il suo andirivieni fra Roma e Sapri, i suoi affarucci nella microuniversità, con tanto di numero del cellulare ben esposto in bacheca, ne avrebbero fatto un bersaglio ideale. Il prototipo di quegli italiani col piede più veloce di Maradona nel correre da una scarpa all'altra, alla Scilipoti. Del resto quelli che hanno compiuto il percorso da sinistra a destra, i Razzi e gli Scilipoti, sono diventati, nella lingua comune, quasi dei proverbi, più che macchiette maschere vere e proprie della commedia dell'arte. Gli altri, quelli che da destra sono andati a sinistra, hanno acquistato il profilo di politici inquieti, pronti a perdere tutto pur di non smarrire la libertà e uscire finalmente dalla cappa soffocante del partito di plastica. Il partito padronale del Cavaliere. I giudici che condannano Berlusconi ascendono in automatico: Marco Travaglio disegna le tavole di un'epopea e attribuisce a Esposito «un coraggio da leoni». Il leone di Sapri, dopo la Spigolatrice. Se Berlusconi denuncia le troppe inchieste è un eversore, il Caimano. Le parole, a seconda di come le si torce, certificano la gogna o sono lo scivolo giusto per atterrare sulla sabbia della standing ovation. Se il governo balbetta di voler scrivere una norma sulle intercettazioni, allora siamo alla legge bavaglio, allora suonano le campane dell'indignazione e Repubblica colora di giallo lo spazio dell'informazione a rischio. Se i pm si mettono di traverso ad una nuova norma e la boicottano quella è difesa della legalità contro la voglia di impunità. Se un giudice spedisce alla Consulta una norma è per smascherare qualche legge ad personam, se invece si solleva il tema dell'incostituzionalità della Severino, vuol dire che si sta cavillando per tirarla in lungo. Così il linguaggio rivernicia antiche frustrazioni e si chiude come una saracinesca sulla realtà.
PARLIAMO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESCO COSSIGA: TRA GLI ITALIOTI UOMO SOLO CONTRO LO STRAPOTERE DELLA MAGISTRATURA.
Quando Cossiga mandò i carabinieri al Csm (con l'appoggio del Pci). Accadde nel '91, il 14 novembre, quando il presidente-picconatore ritirò la convocazione di una riunione del plenum nella quale erano state inserite cinque pratiche sui rapporti tra capi degli uffici e loro sostituti sull'assegnazione degli incarichi. Cossiga riteneva che la questione non fosse di competenza del plenum e avvertì che se la riunione avesse avuto luogo avrebbe preso «misure esecutive per prevenire la consumazione di gravi illegalità». I consiglieri del Csm si opposero con un documento e si riunirono. In piazza Indipendenza, alla sede del Csm, affluirono i blindati dei carabinieri e due colonnelli dell'Arma vennero inviati a seguire la seduta. Ma il caso fu risolto subito, perché il vicepresidente, Giovanni Galloni, non permise la discussione. Sono le 17,20 del 14 giugno 1991, quando, del tutto inaspettata, l'Alfa 164 blindata di Cossiga si presenta al portone del Consiglio superiore della magistratura, scrive Franco Coppola su “La Repubblica”. Un consigliere in maniche di camicia incontra il presidente in attesa dell'ascensore. Un po' di imbarazzo, un rapido saluto e il capo dello Stato raggiunge al terzo piano, proprio a fianco all'aula Bachelet, la sua stanza, quella di cui aveva chiesto la disponibilità, senza però mai occuparla, alla fine dell' '89, dopo averla lasciata per anni al comitato di presidenza. In quella stanza lo hanno preceduto e ora lo aspettano i mobili nuovi, arrivati proprio in mattinata, divani e poltrone damascate, segnale inequivocabile di una occupazione nello stesso tempo concreta e simbolica, di un volersi riappropriare del ruolo anche se, negli auspici di Cossiga esternati nel plenum di mercoledì, si fa strada l'ipotesi della provvisorietà della cosa. E' la seconda volta in ventiquattr'ore che Cossiga varca il portone di palazzo dei Marescialli. E questa mattina ci sarà una terza volta. Lo attende una seduta del tribunale dei giudici, quella sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che, mercoledì, comunicando ufficialmente di voler sostituire il vicepresidente Giovanni Galloni a tutto campo, il capo dello Stato ha deciso di presiedere. E la visita di ieri va messa in relazione proprio a questo impegno. E' entrato nel suo studio, ne ha verificato l'arredamento, si è messo a studiare gli atti relativi ai processi disciplinari previsti per oggi, si è aggirato per i corridoi, ha chiesto spiegazioni ai funzionari addetti alla sezione, si è incontrato con l'ex presidente della corte costituzionale Antonio Saja, ha convocato i componenti la disciplinare per oggi alle 9,15, mezz'ora prima dell'inizio della seduta. Non commettere errori procedurali. Si tratta di studiare i processi, ma soprattutto di non commettere errori procedurali. Infatti, la decisione del capo dello Stato di presiedere anche la disciplinare trascina con sé, inevitabilmente, un carico di problemi. Proprio di fronte al più delicato di questi, Cossiga ha ceduto di un passo, permettendo che Galloni presieda uno dei processi in calendario ed evitando così un immediato e pericoloso braccio di ferro. Il primo problema faceva riferimento al fatto che, secondo le norme, se un processo è stato già incardinato, il collegio giudicante non può essere cambiato. All'ordine del giorno di oggi sono iscritte sette pratiche, quattro processi e tre camere di consiglio, cioè decisioni da prendere senza una preventiva discussione pubblica. Uno dei processi, quello contro il consigliere della corte d'appello di Genova Vincenzo Ferraro, è segnato a ruolo in prosecuzione della seduta del 13 maggio 1991. Quella seduta era presieduta, come sempre, da Giovanni Galloni. Oggi, la pratica avrebbe dovuto essere rinviata a nuovo ruolo oppure si sarebbe dovuto annullare quanto già fatto e ricominciare tutto daccapo. Cossiga ha preferito farsi da parte e così Galloni presiederà quell'unico processo. Il secondo problema, il meno importante, lo sottolinea Franco Coccia, consigliere eletto su indicazione del Pds, che della disciplinare è vicepresidente: I ritmi di lavoro della disciplinare appaiono difficilmente conciliabili con le incombenze ordinarie del presidente della Repubblica. Lunedì scorso, la sezione è stata impegnata per circa dodici ore e le sue sedute, generalmente, sono molto impegnative. Anche l'ordine del giorno della prossima seduta è assai denso. Legittimità costituzionale Terzo problema: non più tardi di undici mesi fa, nel primo dei due messaggi sulla giustizia (il secondo è di febbraio) inviati alle Camere, Cossiga scriveva: Per quanto riguarda la presidenza della sezione disciplinare da parte del presidente della Repubblica, l'articolo 18 della legge del 1958 sul Csm attribuisce al capo dello Stato la facoltà di convocare e presiedere la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno. Questa norma non può non apparire quanto meno sospetta sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, dato che consente di alterare la composizione di un collegio che esercita funzioni giurisdizionali senza che, a fondamento di tale modifica della composizione, vi siano oggettive esigenze o soggettive incompatibilità normativamente predeterminate, ma tutto lasciando ad una scelta discrezionale del presidente della Repubblica. E allora? La sezione disciplinare potrebbe sollevare la questione di costituzionalità, proprio sulla base delle obiezioni di Cossiga. O l'iniziativa potrebbe essere presa da Cossiga in persona. Sul conflitto, o bisticcio che dir si voglia, che separa Cossiga da Galloni si saprà qualcosa di più mercoledì prossimo, quando le clamorose conseguenze minacciate dal capo dello Stato dopo l'intervento del suo vice in difesa dell'indipendenza della magistratura dovranno concretizzarsi. Il presidente vorrebbe risolvere il problema insieme con il Consiglio tutto, che, benché una volta tanto incolpevole, rischia di pagare a duro prezzo le incomprensioni tra i due. La linea emersa tra i consiglieri è semplice: siamo solidali con Galloni, ma i contrasti insorti tra lui ed il capo dello Stato non ci riguardano e non possono costituire motivo di scioglimento. E' nel potere di Cossiga di assumere direttamente la presidenza, è stato detto ma se poi per altri impegni non può essere sempre presente, che non addossi a noi la colpa di un eventuale scarso funzionamento, per poi considerarlo motivo di scioglimento del Consiglio.
Qualche anno fa nel corso di una delle periodiche aspre polemiche fra alcuni partiti politici ed il Consiglio superiore della magistratura Francesco Cossiga con un'un'intervista invitava senza mezzi termini il capo dello Stato ad intervenire: "Come feci io", scrive “Il Velino”. Il 5 dicembre del 1985, quando stava per essere votata una mozione di censura del presidente del Consiglio dell'epoca, Bettino Craxi, aveva inviato una lettera al vice presidente del Csm, (Giancarlo De Carolis) nella quale l'allora inquilino del Colle, esprimeva la ''ferma opinione sulla inammissibilità di un dibattito o intervento del consiglio su atti, comportamenti o dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri''. Dibattito sollecitato da alcuni magistrati di Milano "a difesa" in relazione alle polemiche sul processo per l'omicidio di Walter Tobagi e sulla condanna di alcuni esponenti socialisti querelati dal sostituto procuratore di Milano, Armando Spataro, che in quel processo fu pubblico ministero. "Io minacciai - raccontava Cossiga nell'intervista - di recarmi di persona al Csm e di estrometterlo com'era mio diritto dalla presidenza e, se avesse opposto resistenza, dall'aula; di rifiutarmi di porre l'argomento all'ordine del giorno, ritenendolo inammissibile, e dove fosse ammesso, cancellarlo, dopo avere espulso tre o quattro membri del plenum. E se avessero per protestato occupato l'aula, avrei fatto sgombrare il Palazzo dei Marescialli. A tal fine, avuta l'intesa del procuratore della Repubblica di Roma e del ministro dell'Interno (Oscar Luigi Scalfaro), feci schierare un battaglione mobile di carabinieri in assetto antisommossa, al comando di un generale di brigata". Cossiga raccontava ancora: "Avevo l'appoggio del Pci. Giunsero al Quirinale il giudice della Corte costituzionale Malagugini e il presidente dei senatori comunisti Perna a dirmi che avevo perfettamente ragione e che non mollassi: Altrimenti quelli lì ci travolgono tutti". Nella storia repubblicana con Giuseppe Saragat e Sandro Pertini, è stato il presidente che più ha tentato di arginare lo strapotere del Csm. Uno strapotere che da presidente emerito ancora qualche che anno fa così denunciava: "Il CSM continua imperterrito nel cercare di affermarsi pericolosamente quale terza Camera del Parlamento nazionale, non elettiva, non democratica, ed anche nel cercare di affermarsi quale organo Costituzionale, posto al vertice del potere giudiziario. E su questa strada, chiaramente più che incostituzionale, in realtà potenzialmente eversiva. Il Consiglio è sostenuto da costituzionalisti democratici, un tempo largamente rappresentati, ahinoi, anche nella Corte Costituzionale e ... da non pochi elementi della sinistra giudiziaria dell'Unione prodiana" . Nel corso dei suoi quasi sette anni al Quirinale, Cossiga non soltanto minacciò l'intervento dei carabinieri per far si che il plenum non trattasse ordini del giorno da lui non approvati, ma con Giovanni Galloni, nel '91, ricorse perfino alla sospensione temporanea della delega a presiedere i lavori del Csm e a Cesare Mirabelli, vicepresidente del Csm un anno prima di Galloni, ribadì che l'Organo di autogoverno non era un "potere dello Stato" come invece lo intendevano già settori della magistratura e le correnti più politicizzate dell'Anm.
Citazioni Celebri di Francesco Cossiga:
I sardi rimangono amici anche se uno commette reati.
Lo Stato è in ritardo.
L'Italia è sempre stato un Paese "incompiuto": il Risorgimento incompleto, la Vittoria mutilata, la Resistenza tradita, la Costituzione inattuata, la democrazia incompiuta. Il paradigma culturale dell'imperfezione genetica lega con un filo forte la storia dello sviluppo politico dell'Italia unita.
Sono certo che questa circostanza della riunione della Gran Loggia potrà offrire alla massoneria italiana l'opportunità di confermare e consolidare il nobile impegno, sempre testimoniato dal Grande Oriente, per l'elevazione spirituale dell'uomo, condotta attraverso la difesa e la promozione dei valori di libertà, di giustizia e di solidarietà.
Sono depresso: nessuno intercetta le mie telefonate.
So tutto su Gladio: come era fatta e come non era fatta. Per filo e per segno. E quindi, quando ne parlo, ne parlo con perfetta cognizione di causa. E mi sono immediatamente sbracciato per garantire che era una cosa perfettamente lecita, anzi doverosa, e senza doppi fondi, esponendomi in prima persona.
Si potrebbe fare un libro con i nomi dei sovrani inglesi decapitati per aver attentato alla Costituzione. Magari aggiungendoci Francesco Cossiga, perché ha firmato il decreto di arruolamento per Gladio.
Se ho i capelli bianchi e le macchie sulla pelle è per questo. Perché mentre lasciavamo uccidere Moro, me ne rendevo conto. Perché la nostra sofferenza era in sintonia con quella di Moro.
I gladiatori sono stati additati al pubblico ludibrio dei patrioti. Brava gente che qualcuno ha tentato di confondere con stragisti. e questa è un'altra delle vergogne nazionali.
Di questa questione della P2 non mi sono mai impicciato, non so di cosa si tratti, non mi sento vincolato dalle risultanze della commissione parlamentare di tre legislature fa, così come non mi sento vincolato dalla commissione parlamentare sui fatti di Lissa e dell'ammiraglio Persano. Rispetto molto di più gli uomini, le persone, il principio della certezza del diritto, la presunzione d'innocenza e sono in attesa di conoscere i giudizi definitivi della magistratura su questo problema. Io non so se alcune persone che sono state messe nelle liste ci fossero o no, io ho detto semplicemente che alcune di quelle persone le conosco, sono dei grandi galantuomini e per i servizi che hanno reso, essendo io al governo del paese, sono dei patrioti.
Craxi è un balente, da "balentia", che in sardo significa coraggio, sposato con la capacità e l'abilità, e con il senso dell'onore.
[Sulle proteste degli studenti universitari] Lasciarli fare. Ritirare le forze di polizia dalle strade e dalle università, infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto, e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e fuoco le città.[...] Dopo di che, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri. [...] Nel senso che le forze dell'ordine dovrebbero massacrare i manifestanti senza pietà e mandarli tutti in ospedale. Non arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli a sangue e picchiare a sangue anche quei docenti che li fomentano.
Se fossi ministro dell'interno darei incarico ai servizi segreti di controllare l'Anm in base alla legge sull'associazione eversiva.
Di Pietro dice che è tornata tangentopoli? Lui è un famoso cretino e gli voglio molto bene perché voglio bene ai cretini e lui è sempre più cretino. Però ora sta diventando presuntuoso, crede di essere diventato anche un politico. Ha aumentato i consensi? Quando dissero a Churchill che c'erano cretini in Parlamento, lui rispose "meno male, è la prova che siamo una democrazia rappresentativa". Vuol dire che i cretini in Italia, cioè quelli che votano l'Italia dei... disvalori, è bene che emergano.
Veltroni si intende di cinema e Africa. Non costringiamolo a capire anche questa cosa. Lui è il ma anche, è per il giustizialismo e l'antigiustizialismo, per il freddo e per il caldo.
[Perché le piace tanto D'Alema?] Perché come me per attaccare i manifesti elettorali è andato di giro nottetempo con il secchio di colla di farina a far botte. Perché è un comunista nazionale e democratico, un berlingueriano di ferro, e quindi un quasi affine mio, non della mia bella nipote Bianca Berlinguer che invece è bella, brava e veltroniana. E poi è uno con i coglioni. Antigiustizialista vero, e per questo minacciato dalla magistratura.
Veltroni è un perfetto doroteo: parla molto, e bene, senza dire nulla.
Noi galantuomini stiamo con la Pompadour.
Era il 1974, io ero da poco ministro. Passeggiavo per Roma con il collega Adolfo Sarti quando incontrai Roberto Gervaso, che ci invitò a cena per conoscere un personaggio interessante. Era lui [Silvio Berlusconi]. Parlò per tutta la sera dei suoi progetti: Milano 2 e Publitalia. Non ho mai votato per Berlusconi, ma da allora siamo stati sempre amici, e sarò testimone al matrimonio di sua figlia Barbara. Certo, poteva fare a meno di far ammazzare Caio Giulio Cesare e Abramo Lincoln.
In Italia i magistrati, salvo qualcuno, non sono mai stati eroi.
Io relativizzo tutto quello che non attiene all'eterno.
Totò Cuffaro è stato condannato per un reato ridicolo.
Nominare Di Pietro Ministro della Giustizia, altrimenti arrestano anche la moglie del Presidente del Consiglio.
[Rivolgendosi al segretario dell'Associazione nazionale magistrati Luca Palamara] I nomi esprimono la realtà. Lei si chiama Palamara e ricorda benissimo l'ottimo tonno che si chiama Palamara. [...] Io con uno che ha quella faccia e che ha detto quella serie di cazzate non parlo. Maria, fai tacere quella faccia da tonno.
La Nunziatella, oltre ad essere un luogo di formazione militare, è un luogo di grandissima formazione culturale e civile. Qui è racchiusa la storia di tutto il nostro Paese. Io credo che l'Italia Repubblicana deve far tesoro di tutte quelle che sono le grandi tradizioni militari e per ciò stesso civili che si sono formate in tutto il paese anche quando questo non aveva raggiunto l'unità politica. La mia presenza alla Nunziatella vuol dire dunque onorare l'Italia in tutta quella che è la sua storia.
[In risposta ad una dichiarazione della Bruni] Anche noi italiani siamo ben lieti che Carla Bruni non sia più italiana, anzi siamo addirittura felici. Chissà che un giorno Carla Brunì non sia costretta dalla sua burrascosa vita a richiedere la cittadinanza italiana.
Un'efficace politica dell'ordine pubblico deve basarsi su un vasto consenso popolare, e il consenso si forma sulla paura, non verso le forze di polizia, ma verso i manifestanti[...]l'ideale sarebbe che di queste manifestazioni fosse vittima un passante, meglio un vecchio, una donna o un bambino, rimanendo ferito da qualche colpo di arma da fuoco sparato dai dimostranti: basterebbe una ferita lieve, ma meglio sarebbe se fosse grave, ma senza pericolo per la vita[...]io aspetterei ancora un po' e solo dopo che la situazione si aggravasse e colonne di studenti con militanti dei centri sociali, al canto di Bella ciao, devastassero strade, negozi, infrastrutture pubbliche e aggredissero forze di polizia in tenuta ordinaria e non antisommossa e ferissero qualcuno di loro, anche uccidendolo, farei intervenire massicciamente e pesantemente le forze dell'ordine contro i manifestanti.
Non accetto lezioni di etica politica dalla Bindi: è brutta, cattiva e cretina.
[Parlando di sé] Italiano per volontà come sono tutti i sardi.
[A proposito del caso Visco-Speciale] Cosa sarebbe l'Italia senza Arlecchino e Pulcinella.
[Sull'11 settembre] Tutti gli ambienti democratici d'America e d'Europa, con in prima linea quelli del centrosinistra italiano, sanno ormai bene che il disastroso attentato è stato pianificato e realizzato dalla Cia americana e dal Mossad con l'aiuto del mondo sionista per mettere sotto accusa i Paesi arabi e per indurre le potenze occidentali ad intervenire sia in Iraq sia in Afghanistan.
Il Vaticano è filoarabo perché ha necessità di tutelare gli spazi e l'esistenza dei propri fedeli che risiedono in quei paesi. Del resto la vecchia tradizione popolare cattolica è sempre stata intrisa di antiamericanismo, ed ha disprezzato innanzitutto ciò che sapeva di protestantesimo.
Fra Prodi e i DS scelgo cento volte i DS, perché i DS so chi sono, Prodi non so chi è.
Dopo le famiglie distrutte da mani pulite senza nessun contributo alla moralizzazione del Paese, ora con gli stessi attori non avremo grazie a calciopoli nessuna moralizzazione: o se la danno i club o non sarà certamente Borrelli a darla loro. E corriamo il rischio di avere un'altra sequela di suicidi, tentati suicidi e famiglie distrutte. I ragazzi della nazionale stanno reggendo a questa persecuzione psicologica ed hanno retto anche al dolore per la vicenda di Pessotto. Per questo dico loro bravi.
Di Pietro ha le qualità morali per andare al Quirinale.
Di Pietro è un ottimo investigatore e un buon politico. Vedrei bene per lui un seggio in Parlamento.
I magistrati di Mani Pulite hanno e avranno il mio appoggio.
Rovinerò Bossi facendogli trovare la sua automobile imbottita di droga; lo incastrerò. E quanto ai cittadini che votano per la Lega li farò pentire: nelle località che più simpatizzano per il vostro movimento aumenteremo gli agenti della Guardia di Finanza e della Polizia, anzi li aumenteremo in proporzione al voto registrato. I negozianti e i piccoli e grossi imprenditori che vi aiutano verranno passati al setaccio: manderemo a controllare i loro registri fiscali e le loro partite Iva; non li lasceremo in pace un momento. Tutta questa pagliacciata della Lega deve finire.
[Gianfranco Fini] È il migliore. Porta avanti il suo gioco politico con una buona lucidità. Ma è privo dei supporti dottrinari. Non so se legga qualche libro. So che mischia un po' tutto: Evola e il liberismo, la conservazione e il libertarismo.
Nel 1993 in Italia c'è stata una rivoluzione inutile, anzi un colpo di Stato. Purtroppo la DC non capì o sottovalutò la situazione, impegnata com'era a dare giudizi sul mio presunto stato mentale. Oggi direi che Di Pietro potrebbe essere un bravo dirigente di squadra mobile, uno di quelli a cui si perdonano certi eccessi. Quanto alla morale, se io alla sua età, quando ero sottosegretario alla Difesa, avessi accettato denaro da amici... cosa mi sarebbe successo?
Le intercettazioni hanno ormai il posto che avevano prima i pentiti. Ma i primi mafiosi stanno al CSM. [Sta scherzando?] Come no? Sono loro che hanno ammazzato Giovanni Falcone negandogli la DNA e prima sottoponendolo a un interrogatorio. Quel giorno lui uscì dal CSM e venne da me piangendo. Voleva andar via. Ero stato io a imporre a Claudio Martelli di prenderlo al Ministero della Giustizia.
La battaglia contro la magistratura è stata perduta quando abbiamo abrogato le immunità parlamentari che esistono in tutto il mondo e quando Mastella, da me avvertito, si è abbassato i pantaloni scrivendo sotto dettatura di quell'associazione tra sovversiva e di stampo mafioso che è l'Associazione nazionale magistrati.
Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio.
Craxi e Martinazzoli avrebbero dovuto riconoscere che la DC e il PSI sono i soci fondatori di Tangentopoli.
Gesù è chiamato, nella tradizione musulmana, il "Soffio di Dio nella Madonna", ma l'aspetto temporale della nascita di nostro Signore è una donna che dice Fiat!
Alla mia veneranda età accade di dover essere alle prese con i medici. Ma la malattia finisce per essere una cosa bellissima, quando aiuta ad allontanare la tentazione della politica.
Vorrei sapere quanti omicidi devono compiere i pentiti per essere credibili.
I magistrati fanno bene quando da pubblici ministeri fanno i pubblici ministeri e non i poliziotti o i giudici; quando da giudici fanno i giudici e non i pubblici ministeri o i poliziotti; quando rimangono indipendenti ed evitano anche di non apparirlo; quando rispettano gli altri poteri dello Stato e non cercano vie pseudogiudiziarie a discutibili riforme politiche; quando difendono la loro indipendenza, ma non camuffano da indipendenza i loro interessi corporativi; quando agiscono su, fatti e non su teoremi.
Io non sono, comunque, uno di quelli che crede che la giustizia sia estranea alla cultura, tanto meno alla cultura politica.
L'uomo viene ucciso più dal cibo che dalla spada, ma le istituzioni vengono uccise dal ridicolo.
L'esercizio delle funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario, giudice e pubblico ministero incide così profondamente e talvolta irreversibilmente su i diritti della persona e sulla sua stessa vita psichico-fisica che particolare equilibrio mentale e specifiche attitudini psichiche debbono essere richieste per la assunzione della qualità di magistrato e per la permanenza nella carriera.
Il Csm è il braccio armato, il killer dell'Associazione nazionale magistrati.
Lo sciopero (dei magistrati) che si terrà domani è un vero e proprio atto di eversione contro la Costituzione cui purtroppo nè noi, nè il governo, nè il Parlamento abbiamo finora voluto e saputo reagire.
Cosa direbbe Cossiga del circo giudiziario allestito dalla Boccassini, si chiede Alessandro Nardone su “L’Intraprendente”. Non sono mai stato un ultrà berlusconiano e, anzi, dalla nascita del PdL in poi, non ho di certo lesinato critiche all’ex premier. Perché? I motivi sono essenzialmente due, inscindibili e consequenziali: il primo riguarda il sostanziale fallimento (per altro da lui stesso ammesso) della realizzazione di quello che veniva presentato come il vero e proprio “core business” dell’esperienza di governo del centrodestra, ovvero la rivoluzione liberale. La seconda ragione che, poi, a mio modestissimo avviso, è la madre della prima, riguarda i criteri – certamente non meritocratici – di selezione della classe dirigente del suo partito. Questi, però, non sono certo argomenti in nome dei quali gettare il bambino con l’acqua sporca, cascando nel trappolone di un antiberlusconismo becero e aprioristico, negando la realtà di una leadership – quella del Cav. – ancora in grado di calamitare una fetta importantissima di consensi. Operazione folle e suicida se vista da sinistra, figuriamoci per chi, come noi, ha in animo di ricostruire il centrodestra. Insomma, credo che chiunque si assuma l’onere di rappresentare una visione realmente onesta intellettualmente, non possa assolutamente permettersi di essere obiettivo ad intermittenza. Tutto questo per dire che mi fanno sorridere coloro i quali, anche a fronte degli accadimenti degli ultimi anni, si ostinano a non ravvisare un disequilibrio tra il potere politico e quello della magistratura. Ce lo spiega benissimo il compianto Presidente Cossiga che, in un libro – intervista di Andrea Cangini (Fotti il potere, Aliberti Editore) ci spiega, con il suo consueto modo assai esplicito, alcuni passaggi a mio avviso fondamentali per meglio mettere a fuoco una questione che, prima o poi, qualcuno dovrà farsi carico di risolvere. Ve li riporto di seguito. Buona lettura.
L’ideale dei magistrati è che le leggi le facciano loro.
Dal potere, informale, della massoneria, al potere a volte arbitrario della magistratura. Organo nei confronti del quale il Presidente nutre un’istintiva diffidenza figlia di quel primato della politica cui ama spesso richiamarsi. È così diffidente, Francesco Cossiga, che non appena gli si chiede del potere dei giudici sulle cose della politica cita Carl Schmitt: “Il quale scrisse che l’invenzione della Corte costituzionale era una solenne sciocchezza, nonché un pericolo perché un giudice che può giudicare le leggi è, di fatto, un organo politico. Di più: è un organo politico superiore all’organo politico per eccellenza, il Parlamento. Non a caso i due Paesi che nel Novecento per primi si diedero una Corte costituzionale furono tutti e due travolti: prima l’Austria della dittatura antitedesca ma patriottica del fascista Eglebert Dollfuss, poi la Germania di Weimar, sulle cui ceneri nacque il Terzo Reich. La gente non sa che negli Stati Uniti vi è una durissima polemica contro la Corte Suprema, e i più critici sono i cattolici teocon, gli ebrei praticanti, i battisti e gli altri evangelici che fanno capo alla rivista First Think. Ambienti diversi, ma accomunati dalla preoccupazione per un organismo giustamente accusato di emettere sentenze “politiche”. Personalmente, ho sempre sostenuto che la Corte costituzionale italiana è un organo di arbitraggio politico esercitato in finta forma giurisdizionale”. Tutto questo, ragionando in termini generali. Ma secondo Cossiga il caso particolare italiano è anche peggiore dei casi di scuola. È peggiore perché “da noi la magistratura s’è arbitrariamente trasformata da ordine in potere”. La conversione risale ai tempi di Mani Pulite e gli elementi che l’hanno resa possibile sono due: “La conclamata crisi del sistema politico della cosiddetta Prima Repubblica ed il fatto che buona parte del Pci/Pds fece da sponda a quell’operazione ritenendo di trarne vantaggi politici”. Ma la responsabilità di tutto questo, naturalmente, è a monte. Quando un ordine o un potere tracimano e invadono gli spazi vitali dei poteri limitrofi è sempre perché gli argini hanno ceduto. E in questo caso gli argini sono rappresentati dalla politica. I politici erano deboli, i partiti annichiliti e i magistrati ne hanno dunque invaso i territori con facilità. “Oggi” dice Cossiga, “l’ideale dei magistrati è che le leggi le devono fare loro. Devono farle loro perché loro sono i migliori. Punto e Basta. Cos’era, del resto, il proclama del pool di Milano, “ribalteremo l’Italia come un calzino”, se non un programma politico?”. Le avvisaglie, però, ci furono per tempo. Ma come spesso accade non furono colte. Per Francesco Cossiga il primo “segnale emblematico” fu quel che accadde nel ’73 durante l’iter parlamentare della legge Breganzone. “Quella legge che” spiega, “previde l’avanzamento in carriera dei magistrati per pura anzianità “senza demerito”. Senza demerito, capisce? Il merito non conta e l’eventuale demerito del magistrato puo’ essere rilevato solo da altri magistrati, cosa che di conseguenza non accade. Beh, ricordo che alla Camera parlarono contro solo il repubblicano Reale, l’onorevole Ricci, poi sequestrato in Sardegna e ucciso, Peppino Gargani e io. Ricci, Gargani e io, tutti democristiani, fummo immediatamente convocati al gruppo parlamentare del partito, dove un membro della Direzione ci ingiunse di votare a favore e di tacere “perché se no – disse esibendo i polsi – ci arrestano tutti”. Non si piegarono. Il repubblicano e i tre sparuti democristiani furono gli unici a votare contro. “Ma ciò nonostante” sorride il Presidente, “fummo tutti arrestati lo stesso”. Il problema è che da allora la politica non ha più trovato un equilibrio col potere giudiziario: non si è corretta, ne è riuscita a imporsi. “Oggi tocca infatti a Silvio Berlusconi: un outsider, per i poteri forti del Paese; una staffetta del grande corruttore Bettino Craxi, per i giudici. Dunque, una preda due volte ghiotta. Ma è bene non dimenticare che è storia recente la crisi di un governo (quello presieduto nel 2008 da Romano Prodi) innescata da un’inchiesta giudiziaria (quella contro il guardasigilli Clemente Mastella). Per non dire dell’imbarazzo del Viminale di fronte a una sentenza del Consiglio di Stato che, se non fosse stato ritirato il ricorso, avrebbe seriamente messo in discussione la data delle scorse elezioni politiche. Per tutelare il diritto di uno pseudo partito dello 0,2 per cento, la Democrazia cristiana di Giuseppe Pizza, si sarebbe così irrimediabilmente danneggiato l’interesse generale incidendo sui tempi, e dunque sul risultato, di quello che della la democrazia è il momento supremo: le elezioni, appunto. Giochetto recentemente riproposto nel Lazio in occasione delle elezioni regionali…”. “Vicende ai limiti del golpe”, è il commento del Presidente.
Sarebbe uno scontato eufemismo dire che Cossiga non lascia un buon ricordo a Palazzo dei Marescialli, scrive Paolo Menghini su “Il Corriere della Sera”. Ma anche quello secondo cui il Capo dello Stato non verserà lacrime di commozione nel separarsi da molti dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, ai quali è apparso legato in questi anni da "profonda disistima". Nessun altro organismo istituzionale è mai riuscito a mandarlo fuori dai gangheri come ha fatto il Consiglio superiore della magistratura e nessun governo dei giudici si è mai lamentato tanto del suo presidente. Insomma un'incompatibilità di fondo che si è manifestata in frizioni continue, guerre di nervi, fragili tregue, molti scontri plateali. Si lasciano, il Consiglio e il suo presidente, cui i temi della giustizia sono stati particolarmente a cuore e ne ha fatto oggetto di due messaggi al Parlamento, proprio col ricordo fresco di un ennesimo "corpo a corpo" avvenuto una settimana fa: alcuni consiglieri annunciano di voler disertare la seduta dedicata al caso Sicilia, presente il Capo dello Stato, Cossiga s'infuria, dice che il Csm "e' una delle ultime sacche di socialismo reale del nostro paese", e ai protagonisti dello sgarbo dà dei "maleducati". Record, questo tormentato rapporto ne ha battuti parecchi. Non era mai successo che un componente del Csm si dimettesse per protestare contro il Presidente della Repubblica: Elena Paciotti, di "Magistratura democratica" se ne andò nel giugno del 1990 dopo che Cossiga aveva accusato il Csm di volersi assumere compiti non suoi. Non era mai successo che venisse revocata dal Capo dello stato al vicepresidente del Csm la delega conferita al momento dell'elezione. Non era mai successo che un presidente "sconvocasse" una seduta del Consiglio perchè la maggioranza dei componenti aveva deciso di inserire all'ordine del giorno cinque pratiche giudicate da Cossiga fuori dalla competenza del plenum. Non si era mai sentita infine tanta durezza di linguaggio nell'affrontare i contrasti scoppiati tra Quirinale e Palazzo dei Marescialli. Eppure le premesse sembravano le migliori. Il Presidente della Repubblica, nella sua qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura, non aveva esitato a sottoscrivere, all'atto del suo insediamento, una delega più ampia di quella concessa dai suoi predecessori al vicepresidente del Csm. A Giovanni Galloni, dunque, piena fiducia. Quando, poi, dopo gravi incomprensioni, si riappropriò delle sue prerogative, lo ha fatto in maniera clamorosa e dirompente per sottolineare in maniera anche "scenografica" tutto il suo disappunto. Un camion partito dal Quirinale, un pomeriggio del giugno 1991, consegnò a Palazzo dei Marescialli un arredo completo per lo studio di Cossiga che aveva deciso di installarsi nel suo ufficio dopo aver ovviamente ritirato la delega a Galloni anche per la normalissima amministrazione. Alcune date scandiscono le tappe più importanti della storia del Csm e del suo presidente. Dicembre 1985: il plenum vuole replicare all'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi che aveva criticato alcuni giudici. Cossiga lo impedisce E cominciano i contrasti sull'interpretazione da attribuire alle funzioni del Csm. Il Capo dello Stato segue la corrente di pensiero secondo cui l'organo di autogoverno dei giudici debba svolgere funzioni di alta amministrazione mentre altri, soprattutto i togati, difendono il ruolo anche politico e di indirizzo generale di palazzo dei Marescialli. Marzo 1990: Cossiga blocca la discussione sulla mancata promozione di un giudice bolognese iscritto ad una loggia massonica. Luglio 1990: il presidente rinnova i suoi dubbi sui poteri del Csm e non partecipa alla elezione di Galloni. Novembre 1990: anche il "caso Casson", il giudice che aveva chiesto la testimonianza di Cossiga per Gladio, diventa motivo di contrasto: può il vicepresidente del Csm porre in discussione argomenti senza il previo assenso del presidente? Il quesito diventa pressante e nel febbraio 1991 il Capo dello Stato decide di affidare ad una commissione di studio, presieduta dall'ex presidente della Corte costituzionale Livio Paladin, il compito di valutare eventuali correttivi alle regole sul funzionamento del Consiglio. Una data storica è sicuramente giugno 1991. I rapporti precipitano. Il Quirinale giudica offensive una serie di dichiarazioni di Galloni. Il vice aveva polemizzato con Cossiga che aveva deplorato l'abitudine di mandare contro la criminalità organizzata i giudici ragazzini sostenendo invece che bisognava essere grati a quei giovani. E poi a Vasto, al congresso nazionale dei magistrati, Galloni aveva affermato che non si era mai dato il caso di rivoluzioni guidate dai vertici delle istituzioni. La rabbia di Cossiga sale a mille. Parla di "demagogia eversiva" e di "inaudito attacco personale al Capo dello Stato". E chiude minaccioso: "L' episodio non rimarrà senza conseguenze". La lite si conclude con la revoca della delega e con l'attesa, vana, da parte di Cossiga delle dimissioni di Galloni. Successivamente, anche per interventi esterni al Consiglio, il dissidio viene sanato ma i contrasti non tardarono a riaffacciarsi sul medesimo tema: chi al Consiglio ha il potere di formare l'ordine del giorno. Una volta, per bloccare una seduta, Cossiga non esitò a minacciare il Csm: "Mando i Carabinieri".
La prima volta mi fece chiamare al telefono dell’Espresso dalla Batteria del Viminale, che era il febbraio o il marzo del ’68, e io e Scalfari eravamo appena stati condannati dal Tribunale di Roma per aver diffamato il generale Giovanni De Lorenzo attribuendogli il tentativo di eversione del “Piano Solo”, scrive Lino Jannuzzi su “Il Foglio”. Dopo la sentenza, Scalfari aveva pubblicato sull’Espresso una durissima lettera aperta al presidente del Consiglio Aldo Moro, accusandolo di aver nascosto la verità ai giudici cancellando con i 71 omissis le denunce dell’inchiesta del generale Manes. Francesco Cossiga era sottosegretario alla Difesa e al telefono fu secco e perentorio: “Devi dire a Scalfari che sbaglia a prendersela con Moro. Gli omissis li ho messi io, Moro non capisce niente di queste questioni, e, fosse stato per lui, avrebbe messo in piazza i segreti più delicati della Repubblica”. Un anno dopo, nel frattempo io e Scalfari eravamo stati eletti in Parlamento, ed era stata costituita la commissione d’inchiesta sui fatti dell’estate del ’64 Cossiga venne a pranzo da me, in via della Croce, e si vantò due volte: “Io li ho messi, gli omissis, quando ho mandato il rapporto Manes al tribunale, e io li ho tolti, ora che ho rimandato il rapporto alla commissione. Ma questo non servirà a dare ragione a te e a Scalfari”. In effetti, la relazione di maggioranza della commissione ci trattò benissimo, riempiendoci di elogi per le nostre qualità di grandi giornalisti, ma in sostanza confermò l’assoluzione di De Lorenzo. E Cossiga non ha mai più cambiato idea. In occasione del suo settantasettesimo compleanno, nel luglio del 2005, quando lo intervistai e annunciò che dal primo gennaio 2006 si sarebbe ritirato dalla politica e fece un rapido bilancio di cinquant’anni di vita, gli chiesi: “Se un giornalista riprendesse e rilanciasse oggi la famosa inchiesta di quarant’anni fa sul ‘colpo di stato’ del generale De Lorenzo, riscenderebbe in campo per difendere il generale e l’allora presidente della Repubblica Antonio Segni, suo conterraneo e maestro?”. E lui: “Certamente, e accuserei quel giornalista di essersi inventato tutto… Il che non mi impedirebbe di diventare suo amico e di rimanerlo per quarant’anni, e di levarmi a parlare in Senato, riscuotendo la solidarietà di tutti i settori, in sua difesa, quando lo volessero arrestare per le sue sacrosanti critiche ai professionisti dell’antimafia…”. Per l’occasione, Cossiga fece di più. Quando mi condannarono e il Tribunale di sorveglianza decise che avrei dovuto trascorrere in carcere due anni e quattro mesi, affittò un aereo per venirmi a prendere a Parigi, dov’ero per una riunione del Consiglio d’Europa: “Ti riporto io a Roma e ti accompagno fino a Regina Coeli…”. Non ero entusiasta della generosa proposta, e per fortuna mi tolse d’imbarazzo la grazia concessami dal presidente Ciampi, appena in tempo. L’ultimo suo anno al Quirinale, mi chiamava alle sette del mattino perché andassi a far colazione da lui e, di solito, mi anticipava le sue “picconate”. Come quella volta che doveva andare al Palazzo dei Marescialli a presiedere il Csm e mi recitò, mentre si faceva la barba, il discorso che avrebbe fatto ai pm. Il Consiglio aveva posto all’ordine del giorno una “censura” al presidente del Consiglio dei ministri, che era Craxi, che si era permesso di criticare i magistrati che non avevano indagato a sufficienza sull’assassinio del giornalista Tobagi. Cossiga tolse la delega a presiedere la riunione del Csm al vicepresidente e preannunciò che ci sarebbe andato lui. Mentre si faceva la barba, fece chiamare il comandante dei carabinieri del Quirinale e gli ordinò di precederlo e di “circondare” con i suoi uomini il Palazzo dei Marescialli e di “tenersi pronti a intervenire” se, dopo il suo discorso, il Consiglio non avesse tolto dall’ordine del giorno la minacciata “censura” a Craxi. Ce l’aveva con tutti Cossiga, e non lo mandava a dire, ma ce l’aveva soprattutto coi magistrati. Undici anni dopo quella volta dei carabinieri al Csm, si ripassava dinanzi allo specchio, sempre facendosi la barba, il discorso che avrebbe fatto al Senato per dimettersi da senatore a vita “per difendere il potere del Parlamento, minacciato dall’arrendevolezza e debolezza della classe politica nei confronti della cosiddetta “magistratura militante”, dell’Associazione nazionale dei magistrati e dello strapotere del Consiglio superiore della magistratura…”. Ci tenne a spiegarmi la differenza con la storia dei carabinieri al Csm di undici anni prima: “Allora protestavo direttamente contro i pm e bloccai lo strapotere del Csm. Oggi, che sono solo un senatore a vita, senza patria e casa politica e che non ho alcuna forza politica accanto, vado in Senato per l’ultima volta a protestare contro i ‘politici’, quei politici arrendevoli che non sono stati capaci di arginare lo strapotere dei magistrati militanti, come feci io allora”. E’ la cosa che maggiormente Cossiga rimproverava ai governi di Silvio Berlusconi, quella di polemizzare tanto a parole con i magistrati e di promettere e preannunciare di continuo le riforme della giustizia, ma in pratica di non riuscire a concludere niente, mentre il potere abnorme della magistratura e il suo sconfinamento sui poteri del governo e del Parlamento non facevano che aumentare. E spesso, anche negli ultimi tempi, mi ricordava di una cena che avevo organizzato a casa mia tra lui e Silvio Berlusconi, qualche mese prima che il Cavaliere annunciasse ufficialmente la sua discesa in campo. Per tutta la cena Cossiga non fece altro che sconsigliarlo: “La politica è una cosa maledettamente seria, diceva, e non è per Lei, la faranno a pezzi…”. Berlusconi lo guardava sorridente e rispettoso, ma si capiva che ormai aveva deciso e che non avrebbe tenuto in nessun conto i suoi consigli. Quando, il 27 novembre del 2007, presentò veramente in Senato le sue dimissioni da senatore a vita, Cossiga, più che con i magistrati, se la prese con “quel losco figuro del capo della polizia che si chiama Gianni De Gennaro”, definendolo “un uomo insincero, ipocrita, falso”, e “un personaggio cinico e ambiguo che usa spregiudicatamente la sua influenza”: “Un uomo che è passato indenne da manutengolo dell’Fbi americana, che è passato indenne dalla tragedia di Genova, è passato indenne dopo aver confezionato la polpetta avvelenata che ha portato alle dimissioni di un ministro dell’Interno…”. Passarono settanta giorni senza che nessuno, a cominciare dal presidente del Consiglio e dal ministro dell’Interno, che era Giuliano Amato, rispondessero pubblicamente a Cossiga, finché, il 31 gennaio del 2007, il Senato mise all’ordine del giorno le dimissioni di Cossiga e il senatore a vita dimissionario si alzò dal suo banco nell’Aula, al tavolo delle commissioni, e disse: “Soltanto ieri il ministro dell’Interno ha risposto per iscritto e credo che egli, per quello che sa, abbia detto la verità. A motivo del contenuto della risposta del ministro dell’Interno ritengo mio dovere politico e morale chiedere pubblicamente e formalmente scusa al prefetto Gianni De Gennaro per le dure critiche o accuse da me più volte rivoltegli in quest’Aula e fuori di quest’Aula”. Poi ha confermato le sue dimissioni, che furono respinte a maggioranza. Ma nessuno ha mai saputo, da allora, che c’era scritto in quella misteriosa lettera del ministro dell’Interno, e che ha indotto Cossiga a fare le sue scuse a De Gennaro. Tra tanti misteri, veri o presunti, che Francesco Cossiga si sarebbe portato nella tomba, questo è l’ultimo, ed è forse il più inquietante. A me, che glielo chiesi, rispose: “Ti posso solo dire che quello che mi ha scritto Amato è più grave e scandaloso di tutto ciò che ho rimproverato a De Gennaro”. L’ultima volta sono stato a casa sua a chiedergli di dire qualcosa su Giulio Andreotti,un breve contributo da inserire in un’intervista della Rai, nel programma “Big”, all’ex presidente del Consiglio, e ne disse più bene che male. Ci ripromettemmo di fare l’intervista anche a lui, per lo stesso programma. Non abbiamo fatto in tempo. Sulle questioni che si sono imposte alla cronaca e che non cessano di generare polemiche sia tra i poli sia tra uomini di governo e magistratura, il VeLino con Mauro Bazzucchi ha interpellato l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, i cui rapporti con il Csm, durante il suo mandato, hanno vissuto momenti di conflitto aperto, culminando, circa dieci anni fa, nell'ultimo sciopero proclamato dai magistrati prima di quello previsto per il prossimo 6 giugno. E Cossiga ha risposto da par suo, come un fiume in piena, prendendo spunto proprio dalla recente decisione dell'Anm per contestare la condotta della magistratura associata: "Penso sia una decisione eversiva - dice Cossiga - alla quale l'Anm è giunta anche per la tolleranza benevola di Ciampi e per la debolezza del Governo, aggravata dalle rodomontate del presidente del Consiglio Berlusconi e dalla benevolenza tollerante del presidente della Camera dei deputati Casini. È una decisione eversiva con la quale si vuole affermare, da parte della magistratura militante, che non si vuole rinunciare al potere politico indebitamente conquistato anche per colpa dell'ultima Democrazia Cristiana. La Dc dei Mancino e dei D'Elia, che credevano così di salvarsi dalla valanga giustizialista. Ad aggravare le cose c'è la richiesta di colloquio-confronto fatta dal presidente della Repubblica e dal presidente della Camera tra legislativo ed esecutivo da una parte (unica espressione della sovranità popolare) e la cosiddetta magistratura, che nient'altro è che un corpo di impiegati dello Stato cui un concorso vinto largamente per cooptazione da parte di nonni, padri, zii e cugini o correnti di magistrati non può conferire nessun titolo di sovranità. E allora perché non invitare al confronto-colloquio costruttivo con il legislativo e l'esecutivo la classe degli ufficiali per stabilire quale debba essere la nostra politica militare? Perché non sollecitare il confronto-colloquio costruttivo con la carriera diplomatica per stabilire quale debba essere la politica estera del Paese? E perché non sollecitare anche un summit tra le forze di polizia da una parte e mafia, camorra e 'ndrangheta dall'altra, per delineare la politica della giustizia?"
Su come si è giunti a questa decisione, Cossiga ha pochi dubbi: "La decisione dell'Anm è stata presa, come sempre, da un connubio tra la sinistra non garantista (quella che ha portato alla morte di Coiro e all'ingiusta incriminazione di Misiani, fondatore di Magistratura democratica, agli inizi bandiera del garantismo) e la magistratura corporativa (quella, per intenderci, dei Maddalena e dei Cicala), uniti dalla volontà di potere politico senza rischio elettorale. L'ordinamento giudiziario è antidemocraticamente inquinato da costoro, di fronte ad una stragrande maggioranza di magistrati seri, indipendenti e non da teatro. L'ordinamento giudiziario sono i giudici e i Pm e la sovrana funzione giudiziaria è affidata a ciascuno di loro (i quali infatti costituiscono un ordine e non un potere) e non alla 'magistratura' né tantomeno a quel modesto, piccolo consiglio d'amministrazione del personale che vuole scimmiottare il Parlamento che è il Csm". Le prerogative del Csm e le polemiche sulla riforma recentemente approvata evocano a Cossiga alcuni retroscena: "È una vergogna che si faccia passare per riforma contro l'indipendenza del Csm il ritorno al Csm come era prima che la dabbenaggine del Psi non imponesse alla Dc ("non opponetevi", disse un ministro democristiano a me e a Gargani, "altrimenti ci mandano tutti in galera!) il sistema proporzionale, che implicò l'aumento della composizione del plenum, il più numeroso di quelli esistenti in Europa. Le correnti - prosegue Cossiga - hanno corrisposto da un lato all'affermazione di una concezione giacobina o al limite leninista della giustizia e dall'altro alla fame corporativa di una parte dei magistrati, che la Dc ha creduto di comprare con l'introduzione degli automatismi della carriera e con impensabili livelli retributivi, perché non ci mettessero tutti in galera. Ma intanto in galera, nonostante i regali, molti di noi ci sono finiti lo stesso, da Carra a Gava, da Mannino a Mazzotta e, se avessero potuto, da Andreotti a Forlani. Dire di voler combattere per l'indipendenza della magistratura e poi difendere a spada tratta le legittimità delle correnti significa affermare cose contraddittorie o false, perché o le correnti sono piccole consorterie corporative che servono a spartirsi la torta dei posti e delle prebende, o sono gruppi ideali e quindi politici, ognuno portatore di una concezione della politica, della giustizia e dell'amministrazione di essa, e cioè di differenti concezioni politico-ideologiche che contraddicono l'indipendenza della magistratura, la quale postula l'unità di concezione della giustizia secondo le leggi approvate dal Parlamento". Cossiga ha qualche suggerimento da dare anche per le modifiche in discussione, come le riforme della sezione disciplinare e l'introduzione della Scuola della magistratura: "Per quanto riguarda la sezione disciplinare, l'unica riforma possibile è quella di far giudicare i magistrati da un'apposita sezione della Corte costituzionale, così come avviene in Germania, integrata da giudici disciplinari eletti dal Parlamento. Per la Scuola, penso che l'introduzione sarebbe un'utile cosa ma penso anche che questa dovrebbe essere sottratta al controllo e all'influenza dell'Anm, che ne farebbe scuola di arruolamento per la magistratura militante e corporativa. Perché ormai, se un giovane vuole avere successo in magistratura, deve prima iscriversi ad una corrente poi, con l'appoggio di questa, vincere il concorso e quindi, per far carriera, iscriversi all'Anm e fare il galoppino elettorale per i dirigenti delle correnti". Critico e ferocemente ironico il giudizio di Cossiga sulla politica del governo riguardo alla questione della separazione delle carriere: "Alla separazione delle carriere il Governo ha già rinunciato, e la proposta di separazione delle funzioni, a quanto capisco, consisterebbe nella diversificazione di wc per i giudici e per i Pm, pare anche senza differenza di sessi, per dare un carattere avanzato alla riforma.". I ritardi e le lungaggini del nostro sistema giudiziario danno lo slancio all'ex presidente per polemizzare ancora una volta col capo dello Stato: "Basta leggere le sentenze della Corte di giustizia di Strasburgo, dove siamo condannati, quando ci va bene, almeno due volte al giorno. D'altronde, l'Italia europeista, euroentusiasta e perfino eurofantastica di Prodi e Ciampi ha battuto il record di condanne e reprimende per la non applicazione dei principi europei. Un film della serie. 'Siamo europeisti, nessuno lo è più di noi, ma dell'Europa ce ne fottiamo'". Un ultimo fendente Cossiga lo riserva al ministro della Giustizia Castelli, sul cui operato preferisce, sarcasticamente, non pronunciarsi: "Chi se ne intende dice che è un buon fisico acustico".
Da Gladio alla Guerra del Kosovo. Cossiga è stato un Presidente contro tutte le ipocrisie della sinistra, scrive Carlo Panella su “L’Occidentale”. Incontrai Cossiga per la prima volta l’8 febbraio del 1992, in una serata gelida, a Udine, nel mio primo servizio politico per la televisione. Nella prefettura della città, il Presidente incontrò, formalmente, ufficialmente, tutti gli uomini di Gladio, di Stay Behind ancora in vita. Gesto provocatorio, schiaffo in faccia al Pds di Occhetto che, assieme a tutta la sinistra lo aveva formalmente messo in stato d’accusa aprendo la procedura di Impeachement il 6 dicembre del 1991. Un’azione clamorosa, basata su molte accuse fasulle, tra cui spiccava quella di avere sostenuto la piena legittimità della Organizzazione Gladio, la struttura Nato, assolutamente legittima, che aveva il compito di organizzare una resistenza democratica in caso di tentativo di sovversione da parte del Pci – largamente etero diretto e finanziato dall’Urss – ritenuta invece associazione sovversiva e illegale dalla sinistra (e dalla magistratura, in primis dal Pm Felice Casson, oggi non casualmente senatore del Pd). Uno ad uno, vidi uscire quegli anziani signori, tutti sorridenti e felici dell’onore che Cossiga aveva reso loro e parlando con loro, scoprii quel che tanti sapevano, ma che i media di sinistra e il Pds sprezzantemente ignorava. Quasi tutti loro erano stati partigiani “bianchi” della Divisione Osoppo (composta da militanti della Dc, del Partito d’Azione e del Psi) che durante la guerra e avevano combattuto sia i nazifascisti, che i “partigiani” di Tito del IX Corpus che intendevano annettere Trieste, Gorizia e Udine alla Yugoslavia, strappandole all’Italia dopo averle occupate manu militari. Il giorno dopo era prevista una visita alle malghe di Porzùs, dove Cossiga voleva rendere omaggio ai 20 partigiani della Osoppo che erano stati trucidati barbaramente dai partigiani titini, al comando del comunista italiano Mario Toffanin. Un eccidio spregevole, perché i titini si erano presentati alle malghe come amici, ma poi avevano ucciso a freddo, a tradimento, il comandante della Osoppo Francesco De Gregori, il Commissario Politico (del Partito d’Azione) Gastone Valente, Giovanni Comin e Elda Turchetti. Poi, avevano imprigionato gli altri 18 partigiani e per due giorni, li avevano maltrattati e posti di fronte all’aut aut: o passavano col IX° Corpus yugoslavo e combattevano per occupare e annettere le provincie giuliane e Trieste alla Yugoslavia, o li avrebbero fucilati. In 16 rifiutarono di tradire l’Italia e furono trucidati, tra loro Guido Pasolini, il fratello amatissimo di Pierpaolo, solo due accettarono di tradire e passarono con i titini, assassini dei loro compagni. In quella tragedia era nascosta nel modo più oscuro, violento, ma completo, inquietante la verità, il senso dello scontro politico che si sarebbe combattuto in Italia – per fortuna solo sul piano politico – tra le forze democratiche e un Pci legato a Mosca e alle sue mire, nonostante le mediazioni di Palmiro Togliatti. La tragedia dell’eccidio di partigiani democratici per mano di partigiani comunisti metteva in crisi la teoria di un Pci che si voleva egemone nella lotta di Liberazione in piena funzione nazionale, mostrava di quali veleni, di quali terribili militanti come Toffanin, era composta, anche, la storia dei comunisti italiani. Infatti di Porzùs, fino a quel 9 di febbraio del 1992 non si era mai più potuto parlare in Italia (tranne che nel processo, che si tenne nel 1952), era proibito, il Pci e la sua presa sui media erano riusciti non solo a occultarlo. Ma ora, i discendenti di quei comunisti (che continuavano a percepire i loro stipendi grazie all’”Oro di Mosca) arrivavano alla sfrontatezza di accusare Cossiga e il militanti della Gladio, cioè i partigiani della Osoppo, di avere tramato contro la Repubblica, col solido supporto dei magistrati alla Casson. Ma Cossiga non riuscì ad andare alle malghe di Porzùs, lo scandalo di quella “visita di Stato”, di quell’omaggio a quelle vittime del comunismo, era tanto grande che la ebbero vinta i suoi consiglieri che quasi gli imposero di rinunciare a quel gesto di verità. Capii, in quelle ore, quel che già avevo intuito subito dopo il rapimento Moro: Francesco Cossiga aveva la statura, la forza, la vivacità, ma anche le contraddizioni, le angosce dei grandi personaggi di Shakespeare. Ora era Banco, la vittima di Machbeth, ora re Lear, ora, di uno dei tanti re messi in scena a Stratford on Avon che incarnano il dramma del potere esercitato, della sofferenza nel condurre le trame cui l’esercizio del comando obbliga, follia inclusa. Francesco Cossiga era uscito distrutto, umanamente, dall’esperienza del rapimento Moro, perché aveva creduto di dover sacrificare la vita dell’amico, al superiore interesse dello Stato, aveva ceduto al diktat del Pci, che negava la trattativa. Poi, subito dopo, aveva scoperto che era stato solo un gioco sporco, che c’era qualcosa di profondamente oscuro nel sacrificare la vita di un uomo – e che uomo era Aldo Moro! – all’interesse dello Stato e il senso di quella tragedia lo ha perseguitato per tutta la vita, non ultima componente di quella atroce depressione di cui ha da allora sofferto e che ora l’ha portato alla morte. Disse, anni dopo: “Se ho i capelli bianchi e le macchie sulla pelle è per questo. Perché mentre lasciavamo uccidere Moro, me ne rendevo conto. Perché la nostra sofferenza era in sintonia con quella di Moro”. Ma Francesco Cossiga era un uomo retto e forte e, riprese le forze, si ributtò subito nell’agone politico: presidente del Consiglio nel 1979, poi presidente del Senato nel 1983, infine, nel 1985 Presidente della Repubblica (con voto unanime del Parlamento, il primo). E’ fondamentale oggi ricordare le accuse che il Pci e la sinistra gli lanciarono nel 1991 per chiederne l’Impeachement. E’ fondamentale proprio oggi, quando tanta parte dei media politically correct e del Pd menano tanto ipocrita scandalo per le polemiche contro il presidente Giorgio Napolitano che provengono dal Pdl. I firmatari delle mozioni di accusa (ovviamente cassata dal Parlamento nel 1993) – è bene ricordarlo, perché fu un episodio indegno - erano Ugo Pecchioli e Luciano Violante, i massimi responsabili del Pci per i “Problemi dello Stato” e la “Giustizia”, poi Marco Pannella (sì, proprio lui), Nando Dalla Chiesa, Giovanni Russo Spena, Sergio Garavini, Lucio Libertini, Lucio Magri, Leoluca Orlando, Diego Novelli.
Queste le accuse:
a) l'espressione di pesanti giudizi sull'operato della commissione di inchiesta sul terrorismo e le stragi;
b) la lettera del 7 novembre 1990 con la minaccia di «sospendersi» e di sospendere il governo onde bloccare la decisione governativa riguardante il comitato sulla Organizzazione Gladio;
c) le continue dichiarazioni circa la legittimità della struttura denominata Organizzazione Gladio benché fossero in corso indagini giudiziarie e parlamentari;
d) la minaccia del ricorso alle forze dell'ordine per far cessare un'eventuale riunione del consiglio superiore della magistratura, nonché del suo scioglimento in caso di inosservanza del divieto di discutere di certi argomenti;
e) i giudizi sulla Loggia massonica P2, nonostante la legge di scioglimento del 1982 e le conclusioni della commissione parlamentare d'inchiesta;
f) la pressione sul governo affinché non rispondesse alle interpellanze, presentate alla Camera nel maggio 1991 da esponenti del PDS;
g) l'invito ad allontanare il ministro Rino Formica dopo le sue dichiarazioni sulla Organizzazione Gladio;
h) la rivendicazione di un potere esclusivo di scioglimento delle Camere e la sua continua minaccia;
i) la minaccia di far uso dei dossier e la convocazione al Quirinale dei vertici dei servizi segreti;
l) il ricorso continuo alla denigrazione, onde condizionare il comportamento delle persone offese e prevenire possibili critiche politiche.
E’ questa una eccellente sintesi, non delle malefatte, ma, al contrario, dei grandi meriti della presidenza Cossiga, non solo nella difesa intransigente della appartenenza atlantica dell’Italia (che il Pci ha sempre contestato, nonostante le ambiguità di Berlinguer, anche perché finanziato dal Pcus sino alla caduta dell’Urss nel 1989), perché dimostrano che Cossiga aveva perfettamente colto il nodo della anomalia italiana che già si era raggrumato attorno allo strapotere politico di tanta parte della magistratura. La sua minaccia di inviare i Carabinieri per impedire al Csm di discutere un ordine del giorno che lui, che era presidente del Csm, aveva rifiutato (come era nei suoi poteri) e di procedere al suo scioglimento, dimostra che aveva compreso per primo che c’era un varco nel nostro assetto costituzionale che aveva permesso alla magistratura l’assunzione di poteri impropri, tanto dall’essere riuscita trasformare il Csm in una vera e propria “terza Camera”, che si arrogava e si arroga il diritto di fatto eversivo, di impedire alle altre due Camere di legiferare. Il tutto, nella chiara, esplicita, convinzione, che l’intero assetto politico, così come quello costituzionale, del paese fosse ormai inadeguato, che non rispondesse più alle esigenze dell’Italia, che andasse riformato, magari a colpi di piccone (a Cossiga piacque sempre la definizione di Picconatore che gli era stata affibbiata negli ultimi due anni della sua presidenza). Un solo errore – a nostro parere – commise in quegli anni: la sottovalutazione del ruolo eversivo di Mani Pulite. Quelle sue dimissioni anticipate non furono un gesto di correttezza istituzionale (erano motivate dal fatto che avrebbe dovuto formare un governo, subito dopo le imminenti elezioni politiche, in scadenza di mandato, condizionando così il suo successore), ma un gesto politico contro l’accordo che Bettino Craxi e Arnaldo Forlani avevano siglato, che lui non condivideva, e che avrebbe portato il primo alla presidenza del Consiglio e il secondo alla presidenza della Repubblica. Cossiga non comprese, in quel frangente, che quell’assetto di potere incardinato sui due forti leader del Psi e della Dc, sarebbe stato l’unico in grado di impedire alla Procura di Milano non già le indagini contro i corrotti della Prima Repubblica, bensì di ergersi a dominus del quadro politico, eliminando per via giudiziaria la Dc, il Psi, il Pri, il Psdi e il Pli, risparmiando però solo il Pci-Pds, che pure di quella corruzione era pienamente parte, come risultò plasticamente nel formidabile discorso che tenne Bettino Craxi alla Camera il 29 aprile del 1993: “I Partiti specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali e associative, e con essi molte e varie strutture politiche e operative, hanno ricorso e ricorrono all’uso di risorse aggiuntive in forma irregolare od illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno in quest’aula, responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo (ndr. nessuno si alzò): presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro”. Abbandonata per alcuni anni la vita politica, Francesco Cossiga intravide nel 1998 la possibilità di riprendere il grande schema di Aldo Moro, che auspicava la collaborazione della grandi forze nazionali di matrice “popolare” e di quelle della sinistra post comunista nella gestione del governo. Mise il suo prestigio e la sua straordinaria capacità di manovra, assieme a Mino Martinazzoli, al servizio del “ribaltone” che sottrasse parlamentari (guidati da Mastella e Rocco Buttiglione) dal Polo della Libertà che li aveva eletti e li portò a garantire quella maggioranza al governo di Massimo D’Alema che non aveva nella sinistra la forza parlamentare per ottenere la fiducia. Indicativa dell’uomo e della sua vocazione, fu la scelta del nome del partito che i transfughi formarono: Udr, Unione Democratica per la Repubblica. L’identica sigla del partito Udr fondato in Francia nel 1971 da Charles de Gaulle, la figura di leader europeo che più sentiva vicina e tra le più ammirate. Fu però un'esperienza effimera e rovinosa, la sua Udr ebbe vita confusa e grama (si trasformò nell’Udeur di Clemente Mastella, dall’inglorioso percorso), trascinata nel vortice di uno dei governi più scialbi, inconcludenti e rovinosi della storia repubblicana che si concluse dopo appena due anni nelle ingloriose dimissioni di Massimo D’Alema. Un obbiettivo però era stato colto dal genio politico del Picconatore: con quella spregiudicata manovra, Cossiga era riuscito ad evitare che il nostro paese provocasse una vera e propria crisi –vergognosa, per come si stava profilando – sul terreno internazionale. Per sua forte, determinata pressione, anche sul piano personale, Massimo D’Alema, obtorto collo, accettò di fare entrare l’Italia a pieno titolo (ma sempre con molte ipocrisie), nella guerra del Kosovo. Guerra in cui la sinistra non voleva assolutamente entrare (Fabio Mussi, capogruppo dei Ds alla Camera, riuscì a far firmare da ben 253 parlamentari della sinistra una mozione più che critica contro la nostra partecipazione bellica) e in cui una defezione italiana sarebbe stata sotto gli occhi del mondo a causa della collocazione strategica del nostro paese (gli aerei Nato decollavano da Aviano), provocando irrisione, irritazione e la ingloriosa fine, di fatto, della appartenenza atlantica dell’Italia. A differenza del Verde tedesco Joschka Fischer che ebbe la statura e la limpida forza di un leader della sinistra che rivendicava apertamente la necessità di inviare la Luftwaffe a bombardare Belgrado, Massimo D’Alema mandò sì la nostra aviazione nelle missioni contro la Yugoslavia, ma con indegna ipocrisia mentì al Parlamento e al paese e sostenne che avevano solo e unicamente un ruolo di ricognizione, mentre invece parteciparono direttamente alle operazioni belliche, bombardamenti inclusi. Chiusa quell’esperienza, Cossiga si ritirò definitivamente dall’agone politico, ma continuò a divertirsi (era fantastico cogliere il senso dell’ironia e dell’intelligenza nei suoi dissacranti sarcasmi), commentando episodi politici e dettando all’amico di sempre Paolo Guzzanti memorie dissacranti, quanto autentiche. Nelle ultime settimane, la “belva”, quella terribile depressione che l’ha sempre perseguitato, si è impadronita di lui, chiuso in se stesso e al mondo come non mai. Infine, l’ha preso, ha vinto, definitivamente e ci ha tolto un uomo, forse l’ultimo in Italia, a cui guardare per capire e capirsi. Con profonda, acuta, divertita, scanzonata “intelligenza” degli uomini e dei fatti. Chapeau! Presidente.
MENZOGNE DI STATO. DOVE VANNO A FINIRE I NOSTRI SOLDI?
Quello che la Stampa di regime non dirà mai.
Non è ora di dire basta a questo sistema politico istituzionale che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri? (art, 416 bis c.p.).
Siamo abituati ad ascoltare parole come “la corruzione ci costa 60 miliardi”, “l’evasione fiscale ci costa 120 miliardi”. Numeri aleatori impossibili da verificare ma che gettano fumo negli occhi alla massa credulona. In realtà i 620 miliardi di avanzo di bilancio 1992-2012 sono veritieri ed è il risultato di una precisa scelta politica: sono soldi sottratti veramente ai cittadini e scomparsi dalla circolazione.
La domanda che viene spontanea è: dove cazzo vanno a finire i nostri soldi? Una cosa è certa. In questa Italia di …… le tasse aumentano, cosi come le sanguisughe. I disservizi e le ingiustizie furoreggiano. Ma allora dove cazzo vanno a finire i nostri soldi se è vero, come è vero, che sono ancora di più gli italiani che oltre essere vilipesi, muoiono di fame? Aumenta in un anno l’incidenza della povertà assoluta in Italia. Come certifica l’Istat, le persone in povertà assoluta passano dal 5,7% della popolazione del 2011 all’8% del 2012, un record dal 2005. È quanto rileva il report «La povertà in Italia», secondo cui nel nostro Paese sono 9 milioni 563 mila le persone in povertà relativa, pari al 15,8% della popolazione. Di questi, 4 milioni e 814 mila (8%) sono i poveri assoluti, cioè che non riescono ad acquistare beni e servizi essenziali per una vita dignitosa.
Ed è con questo stato di cose che ci troviamo a confrontarci quotidianamente. Ed a tutto questo certo non corrisponde un Stato efficace ed efficiente, così come ampiamente dimostrato. Anzi nonostante il costo del suo mantenimento questo Stato si dimostra incapace ed inadeguato.
Eppure ad una mancanza di servizi corrisponde una Spesa pubblica raddoppiata. E tasse locali che schizzano all'insù. Negli ultimi venti anni le imposte riconducibili alle amministrazioni locali sono aumentate da 18 a 108 miliardi di euro, «con un eccezionale incremento di oltre il 500% ». È quanto emerge da uno studio della Confcommercio in collaborazione con il Cer (Centro Europa Ricerche) che analizza le dinamiche legate al federalismo fiscale a partire dal 1992.
Eppure nessuno si incazza. Dal 1992 al 2012 gli italiani hanno versato 620 miliardi di tasse superiori all’ammontare della spesa dello Stato: 620 miliardi di avanzo primario (o anche saldo primario). L’obiettivo di tanto sadismo? Entrare nei parametri di Maastricht (1992) ed essere dentro l’eurozona. Eppure, nonostante l’immane sforzo, il Debito Pubblico, è passato da 958 a 2 mila miliardi di euro.
Se in questi 20 anni non si fossero “rubati” 620 miliardi dalle tasche dei cittadini, avremmo un debito pubblico di 2.600 miliardi, quindi nel 2012 avremmo pagato circa 115 miliardi di interesse anziché una novantina. Tuttavia, va detto, in tutti questi anni avremmo avuto consumi superiori per 620 mld, che equivalgono ad un centinaio di miliardi di Iva, e poi Irpef, Irpeg, nuovi assunti, imprese che non avrebbero chiuso. Capitolo lungo, ad ogni modo si tratta di una base tra l’1 o al 2% del Pil, più l’effetto moltiplicatore, sottratta alla ricchezza degli italiani.
I 620 miliardi rubati agli italiani sono andati per il 43% all’estero (quasi tutte banche estere), quindi circa 250 miliardi sono espatriati; il 3,7% alla Banca d’Italia; il 26,8% ad istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni) italiane; il 13% (circa 80 miliardi) sono tornati direttamente nella disponibilità di privati cittadini italiani, ovviamente per lo più delle classi medio-alte.
La cronistoria di un'estorsione:
Nel 1992 gli italiani hanno pagato 14,5 miliardi di euro più di quanto lo Stato abbia speso per servizi. C’era il governo Amato, la super-finanziaria, della Dc e del Psi e Tangentopoli, tutte insieme.
Nel 1993, la cifra è salita a 21,5 miliardi, con Ciampi;
Nel 1994, con il primo governo Berlusconi 20,1 miliardi;
Quasi 40 miliardi nel 1995 con l’altro tecnico Lamberto Dini;
46 miliardi nel 1996 con l’Ulivo di Prodi;
Nel 1997: c’era da entrare in Europa coi conti in ordine, e gli italiani pagarono 69 miliardi di euro più di quanto lo Stato avesse loro concesso con i servizi (strade, sanità, scuole, giustizia, ordine pubblico, finanziamenti alle imprese, pensioni…);
Nel 1998, arriva da sinistra Massimo D’Alema con 55,6 miliardi a vantaggio dello Stato;
Nel 1999 torna Amato e si supera, altri 55 miliardi;
Nel 2000, altri 65,5 miliardi che dal settore privato nazionale entrano nelle tasche dello Stato;
Nel 2001, l’ultimo anno della lira con il Governo Amato, vede ancora 40 miliardi scomparsi dai portafogli di operai, imprenditori e studenti e finire nelle casse pubbliche;
Arriva l’euro: 35 miliardi “del nuovo conio” con il secondo governo Berlusconi nel 2002, 21,4 nel 2003, 16,7 nel 2004, 4,3 nel 2005;
Nel 2006 con il governo di sinistra Prodi: 19,3 miliardi nel 2006, ben 54 nel 2007;
37,7 miliardi 2008, con il terzo governo di Silvio Berlusconi. Nel 2009 11,8 miliardi. Nel 2010 356 milioni dallo Stato a favore dei cittadini. Nel 2011: altri 15,6 miliardi di euro. 44,9 previsti nel 2012.
Co il governo Monti previsti 63,8 nel 2013 e 71,8 nel 2014.
I Numeri dati sono il “Saldo Primario” dello Stato italiano dal 1992 al 2012, e la somma complessiva è di circa 620 miliardi di euro (escluse le previsioni future: si arriverebbe a 750 circa).
I numeri sono una cosa. Le cose tangibili sono un’altra.
Ognuno di noi, anche se non ha reddito, quando compra una cosa o un servizio, versa una parte di somma allo Stato. Raffrontate quello che pagate, sempre e comunque, con l’ospedale vicino che non avete più; con il Tribunale vicino che non avete più e con le tasse giudiziarie duplicate che vi inibiscono di accedere alla giustizia, anche se ingiusta e lontana. Guardate treni e strade e il rispetto che le istituzioni dedicano ai cittadini e poi fatevi una rendicontazione.
Siamo abituati ad ascoltare parole come “la corruzione ci costa 60 miliardi”, “l’evasione fiscale ci costa 120 miliardi”. Bene. 620 miliardi di euro non vi sembrano un “pizzo”, ossia una estorsione di Stato?
LA TRUFFA DEI CONCORSI PUBBLICI E DELLA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI.
Non solo concorsi truccati, ma anche concorsi ed assunzioni truffaldini.
Vincono il posto in centomila, ma per lo Stato sono invisibili, scrive Geraldine Schwarz su “La Repubblica”. Si bandiscono i concorsi e le assunzioni alla fine svaniscono. Le pubbliche amministrazioni devono chiedere due autorizzazioni: una per indire la prova l'altra per assumere i vincitori. Ma i vincoli di spesa impongono solo l'inserimento del 20 per cento del turn over. Chi è finito nella trappola rinfaccia i tanti discorsi sul merito da premiare che alla prova dei fatti si dimostrano chiacchiere. La Cgil: "Quello che succede è dovuto a un misto di discrezionalità, burocrazia e politica, unico e senza precedenti negli altri paesi dell'Unione Europea".
Vincitori ma vinti. Ferdinando, 39 anni di Aversa non lavora da allora o meglio si è buttato nel lavoro nero. Era il 2008 quando ha cominciato a studiare per il concorso da assistente amministrativo contabile bandito dal ministero dell'Interno. Nel 2011 escono le graduatorie; risulta idoneo. Cinque vincitori rinunciano e lui pensa è fatta, sono dentro. Invece no. Oggi disoccupato e senza famiglia, spiega con amarezza: "Ho perso la fiducia nello Stato. I dirigenti del ministero dell'Interno hanno gestito la faccenda come se fosse un'azienda privata". Michelangelo, romano di 38 anni, vincitore nel concorso bandito dall'ICE (Istituto commercio estero) nel 2010. "Ero felice quando è arrivata la raccomandata che ufficializzava il successo. Poi, dopo 5-6 mesi, hanno soppresso l'Ente, e da allora è una lotta burocratica: vivere in modo civile significa rispettare i patti. Ma se lo Stato, in questo caso la Pubblica amministrazione, non li rispetta, perché devo farlo solo io?". Sembra assurdo, paradossale. Ma nell'Italia delle truffe succede così. Viene bandito un concorso da un'amministrazione pubblica. Un giovane, legge i requisiti richiesti, il ruolo che viene ricercato per l'assunzione di un certo numero di posti nell'Ente indicato. Decide di partecipare e comincia a studiare le materie richieste, compra i libri, si prepara per mesi, affronta le prove dove si presentano migliaia di persone da tutta Italia. Supera i test di ingresso, poi anche le prove scritte spesso molto specialistiche, e infine arriva alla prova orale. Passa anche quella. Allora comincia a sperare. Che il sogno si avveri? Poi dopo mesi di attesa, a volte anni, arrivano le pubblicazioni delle graduatorie e la raccomandata dove si legge: Vincitore numero 95. È andata. Festeggiamenti, progetti, possibilità. Ma siamo in Italia. Vincere un concorso pubblico non è sinonimo di assunzione. Un esercito di 100 mila invisibili, vincitori e idonei di concorsi indetti da enti della P. A. non ha ancora mai visto quel posto di lavoro né ha mai visto riconosciuta la sua vittoria. E magari l'ente ha assunto altre figure in altri ruoli. In Sicilia, un caso record: 97 restauratori vincitori di un concorso all'assessorato dei Beni culturali della Regione siciliana aspettano da 13 anni di vedere riconosciuti i loro diritti. Alcuni di loro, nell'attesa, sono invecchiati. Le storie dei vinti, più che dei vincitori, hanno sigle diverse: gli invisibili popolano le graduatorie dei concorsi indetti da vari enti, ministero dello Sviluppo Economico, INPS, INAIL, ministero dell'Interno, Vigili del Fuoco, tanto per citarne alcuni. "È un'anomalia tutta italiana", spiega Michele Gentile, responsabile dipartimento Funzione Pubblica della CGIL, "quello che succede è dovuto a un misto di discrezionalità, burocrazia e politica, unico e senza precedenti negli altri paesi dell'Unione Europea". L'articolo 97 della Costituzione Italiana, (ultimo comma) recita: "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". "Ma questo non assicura nulla", continua Gentile, "perché nel nostro sistema c'è un vizio di procedura. Alcune pubbliche amministrazioni devono chiedere due autorizzazioni, una per bandire un concorso e l'altra per assumere e a volte vengono autorizzate a bandire un concorso per mettiamo 100 posti per contabili ma dopo non vengono autorizzate ad assumerli perché ci sono vincoli di spesa e ogni amministrazione può assumere solo fino al 20% del turn over. Quindi non c'è una politica programmatica sul fabbisogno ma tutto è determinato da un vincolo economico. È una seria priorità da affrontare, sarebbe necessario azzerare il turn over e riaprire una sana prospettiva occupazionale nelle P. A. che oggi non esiste altrimenti è inevitabile che le due categorie più deboli, precari e vincitori di concorsi entreranno presto in serio contrasto". "Questa è una storia che grida vendetta", spiega Alessio Mercanti, promotore e ideatore del Comitato XVII Ottobre (dalla data della prima protesta) che raggruppa tutti i Comitati di vincitori e Idonei di Concorsi della Pubblica amministrazione. "Purtroppo, però, grida sottovoce perché il vincitore idoneo non lavora, non è iscritto al sindacato e non vota le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e quindi come ci disse un segretario di sindacato, è politicamente perdente. Ma in un paese normale il nostro comitato non dovrebbe neanche esistere. Questa è un'ingiustizia colossale che va sanata. Ci hanno sempre detto di premiare il merito, e allora? Ci hanno detto, come recita la Costituzione, che alle Pubbliche amministrazioni si accede per concorso pubblico e quindi, che fanno ora regolarizzano i precari? La pazienza sta finendo, abbiamo sempre cercato di non fare muro contro muro ma se non dovessero alla fine arrivare garanzie anche per i vincitori e idonei scenderemo in piazza e faremo sicuramente qualche azione forte. Lo dobbiamo a questi ragazzi che ci credevano, che hanno studiato, che si sono messi in gioco e hanno vinto un concorso e come si fa oggi a chiamarli invisibili, è un'offesa alle brave persone e un'istigazione alla delinquenza". Sul tema, sono state presentate due proposte di legge una a firma di Cesare Damiano la 635 che ancora non è calendarizzata ed un'altra a firma dell'onorevole Baldelli. Damiano, ex titolare del Lavoro in sostanza propone il loro riassorbimento nelle Pubbliche amministrazioni e la proroga dell'efficacia delle graduatorie fino al 31 dicembre 2015 con conseguente impegno da parte delle amministrazioni ad assumere nel triennio 2013 2015 i vincitori e gli idonei secondo le graduatorie con principi di trasparenza e imparzialità.
Per i restauratori 13 anni di attesa. "Alla fine il lavoro si appalta a privati". "Quando ho superato il concorso avevo 28 anni", racconta Stefania Occhipinti, "avevo una grande passione per questo lavoro. Ora ho 42 anni. Questo paese sta sprecando le sue energie migliori, la mia generazione è stata tradita". Interrogazioni e polemiche sulla vicenda che riguarda l'assessorato regionale ai Beni culturali della Sicilia. Antonio Montellaro, 30 anni siciliano è stato costretto a lasciare la sua isola e ora cerca lavoro ad Udine. Sandra Olindo, siracusana, esperta di restauro archeologico si è reinventata consulente aziendale. Stefania Occhipinti, catanese, 42 anni restauratrice di reperti antichi da 16 anni, da quasi un anno cerca un'occupazione. Sono solo alcune delle storie dei 97 vincitori del concorso per assistente restauratore bandito dall'Assessorato ai beni culturali, ambientali e pubblica istruzione della Regione Sicilia il 24 aprile del 2000. Tredici anni dopo, i vincitori, aspettano. Un record negativo quello siciliano. Una vicenda kafkiana che come racconta Andrea Patti, portavoce del Comitato per la tutela dei beni culturali in Sicilia e marito di Stefania Occhipinti, una delle vincitrici, "si è cominciata a smuovere solo per la nostra lotta con la burocrazia". Indetto nel 2000, il concorso ha prodotto la prima graduatoria provvisoria soltanto nel novembre 2005. Sei anni dopo, nel 2011, a seguito di un ricorso al Tar, viene pubblicata quella definitiva. Ma il decreto - citando la legge regionale 25 del 2008 - precisa che non si potrà procedere alla dichiarazione dei vincitori a causa del blocco delle assunzioni fino al 2015. Anche se, come si legge nelle tre interrogazioni presentate negli ultimi mesi al governo regionale e rivolte al presidente Crocetta "nell'organico dell'assessorato si riscontra una grave carenza di restauratori ed assistenti restauratori in servizio", e ancora, "l'assunzione dei 97 restauratori farebbe risparmiare alla Regione una buona parte del costo per appalti affidati a terzi". "Quando ho superato il concorso avevo 28 anni - racconta Stefania Occhipinti - avevo una grande passione per questo lavoro, ora ho 42 anni e credo che non avendoci ancora preso, questo paese stia sprecando le nostre energie migliori, la mia generazione è stata tradita, qui in Sicilia ma forse anche altrove, ci dicevano al tempo di studiare Beni Culturali, Turismo, perché c'erano molti progetti e sono queste le professionalità che avrebbero cercato. Noi abbiamo studiato, tantissimi, qui in Sicilia, ci hanno creduto. Abbiamo vinto un concorso. E aspettiamo da 13 anni. Molti miei colleghi oramai fanno altro, lavorano nelle ditte edili, disbrigano pratiche, insegnano ai corsi. È uno spreco enorme tanto più per una regione come la Sicilia che dovrebbe valorizzare il patrimonio culturale che possiede. Preferisce tagliare i fondi. Come sta facendo". A sostegno della vicenda dei 97 vincitori del concorso siciliano sono state presentati nel mese di agosto due disegni di legge al Governo regionale uno a firma del deputato Ioppolo della lista Musumeci e un altro a firma di Marcello Greco, Presidente della Commissione Cultura che ha raccolto un'adesione trasversale di quasi tutti i gruppi politici rappresentati dell'ARS (Assemblea Regionale Siciliana). Inoltre sono state presentate 4 interrogazioni parlamentari. Si attende ora la risoluzione del Presidente Crocetta. "Aspettiamo, aspettiamo ancora - aggiunge Andrea Patti del Comitato dei vincitori del concorso - seguiamo l'evolversi dei fatti e speriamo che entro l'anno la vicenda possa risolversi con le assunzioni che 97 persone aspettano da 13 anni".
Una vera truffa al ministero degli Interni, prima la vittoria poi la revoca del posto". Nel 2008, Ferdinando Giglio partecipa alla prova come contabile. Dopo la rinuncia di 21 vincitori, comincia a sperare. Tre anni dopo la direttiva che i posti previsti sono destinati a persone di un altro concorso". "Con quale stato d'animo ci si rimette a studiare per l'ennesimo esame? Mi hanno fatto perdere fiducia nello Stato". "Il problema è il dopo. Con quale stato d'animo ci si può rimettere a studiare per un nuovo concorso? È impossibile. La verità è che questa vicenda mi ha fatto perdere la fiducia nello Stato. Lo Stato in Italia non è il popolo, sono i dirigenti. Quelli del ministero dell'Interno hanno gestito la vicenda come fosse un'azienda privata". Ferdinando Giglio ha 39 anni ed è di Aversa. Oggi è disoccupato. Nel 2008 partecipa ad un concorso per assistente amministrativo contabile del ministero dell'Interno. Cercano 115 addetti. "A quel tempo - racconta - lavoravo all'Ipercoop con contratti a termine, studiavo quando rientravo, nelle ferie e quando riuscivo. Erano materie assurde e molto specifiche come rendiconto generale dello Stato. Supero i test di ingresso, due prove scritte e l'orale e nel 2010 esce la graduatoria e mi classifico numero 118, terzo tra gli idonei. A parità di punteggio hanno dato il posto a chi aveva famiglia. Io con quello che guadagnavo non potevo mantenere una famiglia e quindi non l'avevo. Ma 21 persone dei 115 vincitori rinunciano. A quel punto penso: con lo scorrimento della graduatoria, tipico in ogni concorso, ce la faccio. Mi assumono. E festeggio. E certo del lavoro prossimo non accetto un'offerta dell'Ipercoop che ci proponeva di regolarizzarci". Poi nell'ottobre del 2011 arriva una lettera all'indirizzo di Ferdinando ad Aversa. "Diceva che a seguito di una direttiva a firma del Prefetto i rimanenti 21 posti dei rinunciatari non sarebbero stati coperti dallo scorrimento della graduatoria e che le 21 rinunce sarebbero servite a chiamare altre persone di un altro concorso, degli assistenti informatici." Da allora Ferdinando è senza lavoro ed è cominciata un'odissea di telefonate ai responsabili del personale del ministero, segretari, sindacati. Ottantatrè idonei si sono costituiti in Comitato. "Al ministero non ci hanno mai ricevuto o spiegato qualcosa, se chiamiamo ancora oggi ci dicono che è inutile insistere noi non abbiamo diritto. Come non abbiamo diritto? Non hanno bandito un concorso per 115 assistenti contabili? Io sono terzo nella graduatoria, 21 hanno rinunciato, io ho diritto. Perché no?". "Tra l'altro - come racconta ancora Ferdinando - i vincitori li hanno presi a scaglioni e nei primi 13 ci sono state rinunce e hanno fatto scorrimento sui vincitori, e la legge dice che se fanno scorrimento una volta devono farlo sempre". Ma così non è andata. Ferdinando oggi è senza lavoro e dice: "Qui al sud è un disastro io ci contavo su quel concorso, noi siamo disposti anche ad essere assorbiti da altre amministrazioni ma non ci possono lasciare così in questo limbo, non è giusto fingere che non esistiamo e parlare solo dei precari. Se nulla cambierà li citeremo in giudizio".
"Ci battiamo in nome del merito, siamo solo un'isola senza diritti". Alessio Mercanti, promotore del Comitato XVII ottobre che organizza i vincitori di concorso beffati: "E' una vicenda che grida vendetta. E' la più assurda forma di disoccuparti che un Paese sia mai riuscito a partorire". "Se entrano i precari devono entrare in misura uguale anche i vincitori idonei". La proposta: inserire un po’ di precari e un po’ di vincitori per assorbirli con il tempo. “È una vicenda che grida vendetta, ragazzi e ragazze di tutta Italia che hanno vinto un concorso e attendono da un tempo a volte molto lungo di essere assunti, è la più assurda forma di disoccupati che un Paese sia mai riuscito a partorire, un’offesa alla meritocrazia” secondo Alessio Mercanti, promotore del Comitato XVII Ottobre che dal 2010 raggruppa comitati di invisibili, vincitori e Idonei di concorsi pubblici, mai impiegati. “Tutto è cominciato per caso, io lavoro all’INAIL da dieci anni e mi sono imbattuto in alcune di queste storie che riguardavano il mio ente e allora ho cominciato a chiedermi: ma come è possibile? Se fosse capitato a me, visto che anche io sono entrato per concorso? Se capitasse a mio figlio che sta crescendo? E così in un impeto di coscienza civica ho fondato la pagina web e il comitato e poi su facebook e sono cominciate ad arrivare le adesione dei comitati che si erano già formati ma non avevano alcuna visibilità perché appunto la categoria è di invisibili, non aventi diritto.
Come vi muovete, che ruolo avete?
“Adesso siamo un punto di riferimento per la politica ci hanno convocato già in due commissioni Lavoro, abbiamo esposto la situazione e ne sono nate due proposte di Legge, una la 635 a firma di Cesare Damiano che abbiamo scritto insieme e un’altra a firma dell’onorevole Baldelli che non conosciamo ancora. Abbiamo anche cercato contatti con il ministro della Funzione pubblica D’Alia che ci ha risposto con una lettera e si è detto disponibile ad incontrarci. Il problema però è che non siamo politicizzati e quindi siamo un’isola. Anche i sindacati, un giorno ci sono, un giorno no. Del resto, il vincitore idoneo non lavora, non vota alla rappresentanze sindacali ed è politicamente perdente come ci ha detto un giorno un segretario di sindacato".
Quanti sono i vincitori idonei in Italia?
“Noi ci atteniamo alle stime di qualche anno fa che dicevano sui 100mila ma non ci sono dati recenti, potrebbero essere molti di più. Si tratta di una Waterloo sociale che riguarda tutte le amministrazioni, ministeri, sanità, enti locali, scuola, enti previdenziali, amministrazioni provinciali e comunali, forze armate, enti di ricerca e quindi un universo difficilmente stimabile. Oltretutto se la politica sapesse, dovrebbe agire e quindi meglio tenere tutto così senza dati precisi".
Oggi si parla molto di precari ma cosa si potrebbe fare per i vincitori idonei?
"I precari solitamente entrano per chiamata diretta e già lavorano, è giusto che abbiano delle possibilità ma non si possono dimenticare i vincitori idonei anche perché stando ai margini, tutte le loro competenze che avevano maturato con lo studio diventano obsolete, invecchiano. E poi hanno diritto, hanno vinto un concorso e alla P.A. come dice la Costituzione si accede per concorso. Se entrano i precari devono entrare in misura uguale anche i vincitori idonei è questa la nostra proposta, che siano miscelati, un po’ di precari e un po’ di vincitori e prima o poi andare ad assorbirli. Bisogna intervenire sui turnover e sulla spending review".
Le prossime mosse?
“Io mi aspetto che si dia seguito alle parole, Il ministro D’Alia aveva parlato di vincitori e idonei e spero che questo decreto li contempli, altrimenti la pazienza sta per terminare, non possiamo certo fare causa allo Stato, sarebbe un suicidio ma prepareremo manifestazioni di piazza in nome della meritocrazia di cui tanta gente si riempie la bocca. Perché questa è una storia che grida vendetta anche se ancora sottovoce".
Già. Si è fatto cenno ai precari della Pubblica Amministrazione.
Precari e pubblica amministrazione: chi sono, dove lavorano e cosa chiedono al governo Letta.
Tra 100mila e 150mila persone in tutto. Ecco l'esercito di dipendenti statali assunti con contratto flessibile che chiedono tutele all'esecutivo, scrive di Andrea Telara su “Panorama”. C'è chi dice siano150mila in tutto e c'è chi, invece, ha calcolato un numero inferiore: circa 110mila. Sono i lavoratori della pubblica amministrazione assunti con un contratto flessibile o precario, che rischiano ancora di perdere il posto.
Secondo le stime dell'Aran (l'agenzia nazionale del pubblico impiego), i dipendenti statali con un contratto flessibile sono oggi in totale circa 317mila. Tra questi, ben 203mila operano però nell'università e nella scuola (e sono dunque esclusi dagli attuali provvedimenti del governo). Il numero delle persone da salvaguardare non dovrebbe quindi oltrepassare le 114mila unità, di cui il 76% è rappresentato da impiegati con il contratto a termine, mentre il restante 24% si divide tra lavoratori socialmente utili e gli assunti con contratto di somministrazione o di formazione e lavoro (che un tempo esisteva anche nel settore privato e che invece oggi sopravvive soltanto nella Pa). Quasi il 60% delle assunzioni precarie del pubblico impiego si concentra negli enti locali, per lo più nel settore dei servizi sociali e assistenziali.
«Stiamo lavorando ad un pacchetto di norme sul lavoro pubblico che sono norme di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema della Pa, con particolare riferimento ai precari e ai vincitori di concorso. Su questo stiamo concentrando la nostra attenzione in questi giorni». Il ministro della Funzione Pubblica, Gianpiero D'Alia, su “Il Messaggero” torna sul tema del lavoro pubblico. «Sui precari la nostra intenzione è di intervenire prima della legge di stabilità sapendo che non ci sono risorse aggiuntive nè che possiamo fare procedure di stabilizzazione indiscriminate, ma sempre selettive dando uno sbocco e un percorso virtuoso che punti a chiudere la vicenda nel minor tempo possibile» spiega il ministro che nei giorni scorsi ha dovuto affrontare le proteste del Pdl. L’ex ministro Gelmini, il presidente della commissione Finanze Capezzone e il capogruppo nonché ex ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, hanno attaccato il progetto a cui sta lavorando D’Alia: «Lascia presagire un’immensa sanatoria nella Pubblica amministrazione della quale non si sente proprio il bisogno», è stato il motivo dominante delle contestazioni. Di parere opposto, invece, i sindacati della Funzione pubblica che, dopo l’estensione del blocco delle retribuzioni anche al 2014, spingono per ottenere una maggiore apertura sul versante della regolarizzazione dei precari. Come? Con l’ampliamento della quota di riserva del 50% già prevista in caso di nuovi concorsi per chi ha maturato almeno tre anni di contratti a termine negli ultimi cinque. D’Alia dovrà tenersi in equilibrio tra queste esigenze contrapposte. «É chiaro - aggiunge infatti il ministro interpellato dall’AdnKronos - che noi dobbiamo intervenire anche per evitare che si verifichino nuovi fenomeni di precariato e quindi intervenire per sanzionare quegli amministratori che fanno contratti che alimentano le sacche di precariato senza che rispondano di tasca propria».
Per il premier Enrico Letta: «Si è deciso di dare una soluzione definitiva al problema del precariato nella pubblica amministrazione e per evitare le scorciatoie che permettevano di eludere il concorso per entrare nell'impiego pubblico. Ci sarà una selezione per stabilizzare i precari e verrà fatto un censimento per tutte le situazioni di precariato nella Pubblica amministrazione».
Il problema è semplice: da un lato ci sono oltre 240 mila persone che hanno un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, dall’altro le norme volute dal ministro Fornero che limitano la durata complessiva di questi rapporti di lavoro e che prevedono un’interruzione sostanziale tra un periodo di collaborazione e il successivo. Di proroga in proroga i contratti sono ancora tutti in piedi.
Nel corso del Question Time tenutosi il 27 luglio 2011 nell’aula di Montecitorio, il deputato Mario Pepe (Gruppo misto) ha chiesto al ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta di adottare iniziative normative volte a destinare annualmente risorse per la stabilizzazione dei lavoratori ‘precari’ delle amministrazioni centrali dello Stato. «L’utilizzo delle forme contrattuali di tipo flessibile nella pubblica amministrazione - ha risposto Brunetta - non genera di per sé forme di cosiddetto ‘precariato’ ma è da considerarsi, se correttamente utilizzato per far fronte ad esigenze temporanee o sostitutive, strumento efficace ed economico. Diversamente va contrastato, con idonee misure preventive, l’utilizzo di tali tipologie contrattuali quale ordinaria modalità di acquisizione delle risorse umane, secondo procedure che non garantiscono il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e merito ed eludono le limitazioni finanziarie previste per le assunzioni a tempo indeterminato. È proprio questo abuso che ha determinato i ben noti disagi sociali segnalati dall’interrogante. Il ricorso a forme di stabilizzazione diffusa, sia pure programmata, non appare una soluzione percorribile. In primo luogo l’innalzamento dei livelli occupazionali a tempo indeterminato genera una spesa fissa a regime che il bilancio dello Stato, nell’attuale congiuntura economico-finanziaria, non è in grado di sostenere. La stabilizzazione di personale titolare di contratti temporanei, non sempre adeguatamente selezionato, oltre a incentivare l’utilizzo irregolare di contratti flessibili e a configurarsi come una sorta di “sanatoria” degli abusi fatti, si pone in palese contrasto con i principi dell’articolo 97 della Costituzione.»
Insomma: Il precariato è una criticità e la sua stabilizzazione fa venir meno i principi di buon andamento ed efficienza, che impongono il concorso pubblico per il reclutamento di personale.
Precari e non, le due “anime” del pubblico impiego, così, stanno insieme anche per un banale motivo aritmetico: il numero dei lavoratori con un contratto che possiamo per facilità definire “atipico” è comparabile, politicamente, a chi, tra il personale stabile, può essere messo fuori o attraverso la mobilità o con il prepensionamento. Sulla prima categoria si sa che a spanne, tolto il grande capitolo della scuola, nella pubblica amministrazione ci sono qualcosa come 114mila, come minimo. Secondo altre stime addirittura il doppio, però. Comunque sia, nel “Dl del Fare” vengono indicati in 200mila gli over 57 della pubblica amministrazione che possono essere messi nella "dirittura d'arrivo" del prepensionamento oneroso. Ma secondo la Ragioneria generale dello Stato, quelli con almeno 55 anni sono oltre 760mila, il 60% sono donne. A loro sarebbe ridotto il trattamento previdenziale del 10% rispetto a quello che prenderebbero a fine carriera. Senza contare che qualche migliaio in più possono uscire dall’azzeramento delle province (160mila addetti) e dall’unificazione dei piccoli comuni: infatti, se da una parte è prevista la ricollocazione, dall’altra c’è la prospettiva della mobilità per chi non accetta. Tuttavia, la “rivincita” dei precari, la cui stabilizzazione, però, non supererà i 50mila e, bene che vada, non comincerà prima del 2015 e sarà tutta subordinata ai tempi di indizione e svolgimento dei concorsi. Non si capisce bene, poi, se le migliaia di contratti a somministrazione e di collaborazione coordinata e continuativa siano nel calcolo o meno. Il ministro, infatti, nel definire la possibilità di una “quota riservata” ai precari nei concorsi pubblici, parla di contratti a tempo determinato di almeno tre anni (negli ultimi cinque). Ancora è incerta la sorte di tutti gli addetti, variamente collocati nei lavori socialmente utili, oppure, come è il caso della maggioranza di chi sta nel settore della ricerca, partite iva e incarichi come gli assegni di ricerca. C’è, inoltre, una categoria che può senz’altro definirsi come “gli ultimi tra gli ultimi”. Sono gli addetti dell’indotto privato della pubblica amministrazione. Si tratta di un settore che abbonda nella sanità e nella scuola (pulizie). Stiamo parlando di svariate decine di migliaia di persone. Che fine facciano questi nessuno lo sa nemmeno adombrare. E’ per questo motivo che Usb chiede che ci sia la sanatoria totale. Anche perché ricostruire i singoli percorsi è praticamente impossibile. In molti casi, fa notare Claudio Argentini, del coordinamento nazionale del Pubblico impiego, “le carriere contrattuali sono cambiate repentinamente sfociando in esiti tipo soci delle coop. Si può venire a capo ma con tempi biblici ma solo se si mettono insieme i dati dell’Inail con quelli dell’Inps”. Che sia in vista una estenuante lotta sui numeri lo dimostra il caso della scuola: il ministro Carrozza a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico è pronta a immettere in ruolo poco più di undicimila docenti, la Cgil risponde subito: “Sono del tutto insufficienti”. Anche in questo caso, la platea effettiva sarebbe almeno il doppio.
COSTITUZIONE ITALIANA: COSTITUZIONE MASSONICA.
Costituzione, Diritto al Lavoro e Sistema Massonico.
Rapporti tra costituzione italiana e massoneria, secondo Paolo Franceschetti.
Sommario. 1. Premessa. 2. La prima falla: gli organi costituzionali. 3. La seconda falla. Il sistema dei referendum. 4. La terza falla: la Corte Costituzionale. 5. La quarta falla: i valori massonici della costituzione. 6. Il cosiddetto "diritto al lavoro". 7. L'effettivo stato di cose. 8. Effetti della normativa a tutela dei lavoratori. 9. Considerazioni conclusive e di diritto comparato.
1. Premessa. La nostra Costituzione è considerata dalla maggior parte dei costituzionalisti come una legge molto avanzata, fortemente protettiva delle classi deboli e con un bilanciamento quasi perfetto tra i vari poteri. Rappresenta la legge fondamentale per la tutela dei diritti di qualunque cittadino, nonché il parametro di legittimità cui rapportare tutte le altre leggi. All’università questa era l’idea che mi ero fatta sui vari autori, Mortati, Martinez, Barile. Solo da qualche anno ho cominciato a riflettere sul fatto che qualcosa non va nel modo in cui tutti ci presentano la Carta Costituzionale. Vediamo cosa. In effetti la storia (quella vera e non quella ufficiale) ci insegna che la Carta Costituzionale fu voluta dalla massoneria. Oltre due terzi dei padri costituenti erano ufficialmente massoni (e sospetto anche quelli che non lo erano ufficialmente). E la massoneria rivendica a sé altre leggi importanti, come la dichiarazione dei diritto dell’Uomo. Dato che il fine ultimo della massoneria è il nuovo ordine mondiale, riesce difficile pensare che abbiano voluto consegnare ai cittadini, al popolo cioè, una legge che tutelasse davvero tutti, e che non fosse invece funzionale agli interessi massonici. Infatti, leggendo la Costituzione senza preconcetti, e sgombrando il campo da tutte le sciocchezze che ci insegnano all’università, è possibile farsi un’idea diversa della Costituzione. Essa è una legge illiberale, pensata apposta per opprimere i cittadini anzichè tutelarli. Però il punto è che è scritta così bene che è difficile capirne l’inganno. Apparentemente infatti sembra una legge progredita e che tutela i diritti di tutti. Ma la realtà è ben altra. E’ noto infatti che nessuno è così schiavo come quelli che pensano di essere liberi senza sapere di essere schiavi. Ora, la Costituzione è fatta apposta per questo: renderci schiavi, facendoci credere di essere liberi. Purtroppo per capirlo occorre essere molto esperti di diritto, e contemporaneamente conoscere anche la politica, la cronaca, l'economia, ecc.; una cosa impossibile finchè si è giovani, e quindi una preparazione universitaria non è sufficiente per individuare dove stanno le immense falle di questa legge – burla. Bisogna inoltre avere alcune conoscenze del sistema massonico. I laureati in legge quindi escono dall’università senza avere la minima conoscenza del sistema reale, ma avendo a malapena mandato a memoria i pochi libri che hanno letto per gli esami universitari. Vediamo dove stanno queste falle, iniziando dalle meno importanti. Per finire poi occupandoci della presa in giro più evidente, che non a caso è proprio quella contenuta nell’articolo 1 della costituzione.
2. La prima falla. Gli organi costituzionali. Anzitutto nella costituzione sono previste efficaci garanzie per tutti i poteri dello stato meno uno. Sono previste garanzie per il governo, parlamento, la Corte Costituzionale, la magistratura, ma non per i servizi segreti che, come abbiamo spiegato in un articolo precedente, sono l’organo dello stato più potente e il più pericoloso. Quindi i servizi segreti possono agire fuori da coperture costituzionali. Ciò ha una duplice valenza a mio parere, una giuridica e una psicologica. Dal punto di vista giuridico infatti questa mancanza consente ai servizi di operare nell’illegalità. Dal punto di vista psicologico, invece, tale omissione fa sembrare i servizi segreti quasi una sorta di organo secondario che svolge ruoli di secondo piano per il funzionamento della Repubblica; si dà al lettore, allo studioso di legge, e all’operatore del diritto in genere, l’impressione che essi non siano in fondo così importanti; allo stesso tempo ci si assicura che nessuno studente approfondirà mai la figura dei servizi dal punto di vista giuridico, cosicchè ogni laureato esce dall’università con un’idea solo immaginaria e fantastica di questo organo dello stato, quasi come fosse inesistente, da relegare nelle letture romanzesche dell’estate o dei film di James Bond, e non uno dei poteri più importanti del nostro stato, con un numero di dipendenti da far impressione a una qualsiasi altra amministrazione pubblica.
3. La seconda falla. Il sistema dei referendum. Un'altra mancanza gravissima è quella del referendum propositivo. Il referendum, che è un istituto importantissimo per la sovranità popolare, può solo abrogare leggi esistenti, ma non proporle. Il che, tradotto in parole povere significa che se con un referendum è stata abrogata una legge, il parlamento può riproporla tale e quale, oppure con poche varianti, solo per prendere in giro i cittadini a fingere di adeguarsi alla volontà popolare. Una presa in giro bella e buona.
4. La terza falla: la Corte costituzionale. Un’altra immensa presa in giro è il funzionamento della Corte Costituzionale. Tale organo dovrebbe garantire che le leggi siano conformi alla Costituzione, annullando le leggi ingiuste. Il problema è che il cittadino non può ricorrere direttamente contro le leggi ingiuste. E questo potere non ce l’hanno neanche i partiti o le associazioni di categoria. Per poter arrivare ad una dichiarazione di incostituzionalità di una legge infatti è previsto un complesso sistema per cui bisogna dapprima che sia instaurato un processo (civile o penale); dopodiché occorre fare una richiesta al giudice che presiede il processo in questione (che non è detto che la accolga). In gergo tecnico questo sistema si chiama “giudizio di rilevanza costituzionale effettuato dal giudice a quo”; in gergo atecnico e popolare potremmo definirlo “sistema per paralizzare la giustizia costituzionale”. Ne consegue che è impossibile impugnare le leggi più ingiuste, per due motivi:
1) o perché per qualche motivo giuridico non è possibile materialmente instaurare il processo (ad esempio: non è possibile impugnare le leggi che prevedono gli stipendi e le pensioni dei parlamentari; non è possibile impugnare le leggi elettorali; non è possibile impugnare le leggi con cui la Banca d’Italia è stata di fatto privatizzata);
2) o perché – anche quando le legge è teoricamente impugnabile - il cittadino non ha nessuna voglia di instaurare un processo per poi andare davanti alla Corte Costituzionale. Ad esempio; ipotizziamo che un cittadino voglia impugnare l’assurda legge che prevede che ogni professionista debba versare allo stato il 99 per cento del reddito dell’anno futuro, per incassi ancora non percepiti; in tal caso bisogna dapprima rifiutarsi di pagare (quindi commettere un illecito); poi occorre aspettare di ricevere la cartella esattoriale da parte dell’agenzia delle entrate con le relative multe e sovrattasse; e solo dopo queste due mosse si poi impugnare la cartella, peraltro senza nessuna certezza di vincere la causa. Se invece si volesse impugnare l’assurda legge sul falso in bilancio prevista dagli articoli 2621 e ss. Cc. (legge chiaramente incostituzionale perché rende di fatto non punibile questo reato, con la conseguenza che chi ruba una mela in un supermercato rischia diversi anni di galera, mentre chi ruba qualche milione di euro da una grande azienda non rischia quasi nulla), la cosa diventa praticamente impossibile, perché prima commettere il reato, poi occorre aspettare di essere processati per quel reato, e che in tale processo colui che impugna sia parte in causa. Una follia!
A tutto ciò occorre aggiungere i rilevanti costi di un giudizio davanti alla Corte, tali da scoraggiare qualunque cittadino con un reddito medio. La conseguenza è che la Corte Costituzionale si occupa in genere della costituzionalità delle leggi più stupide, ma i cittadini sono impotenti di fronte ai fatti più gravi. E il risultato finale è che la Corte Costituzionale sostanzialmente ha le mani completamente legate contro le leggi più ingiuste e più gravemente lesive dei diritti del cittadino.
5. La quarta falla: i valori massonici introdotti dalla Costituzione. Ci sono poi altre lacune molto gravi come quella relativa alla possibilità per lo stato di espropriare beni dei cittadini senza corrispondere il valore di mercato. Ma l’aspetto più grave della nostra Costituzione, e allo stesso tempo anche quello più difficile da percepire, è relativa ai valori tutelati dalla Costituzione. Ci raccontano sempre che la Costituzione tutela la persona umana. Ma è falso, perché in realtà a ben guardare essa mortifica la persona umana relegandola a poco più che uno schiavo. Vediamo perché.
6. Il cosiddetto diritto al lavoro. Il perché è in realtà sotto gli occhi di tutti, messo in modo plateale, bene evidenziato già nell’articolo 1 della Costituzione, ove è detto che: “la repubblica italiana è fondata sul lavoro”. Nessuno si sofferma mai a riflettere sull’assurdità logica, giuridica, e filosofica, di questa norma. Cosa significa che una repubblica è fondata sul lavoro? Nulla. Giuridicamente una repubblica si fonda su tante cose. Sulla legalità. Sulla giustizia. Sull’equilibrio dei diritti. Sul rispetto delle leggi. Sull’equilibrio tra poteri dello stato. Ma non si fonda, né dovrebbe fondarsi, sul lavoro. Non a caso credo che il nostro sia l’unico caso al mondo di una Costituzione che abbia messo il lavoro all’articolo 1, tra i fondamenti della Repubblica. Non a caso neanche repubbliche dittatoriali come la Cina o la Russia contengono una disposizione tanto demenziale. L’idea di uno stato fondato sul lavoro è infatti una sciocchezza per vari motivi. Prima di tutto perché ciò presuppone che il giorno che venga trovato un modo per far avere a tutti, gratuitamente, cibo e un tetto, e la gente fosse dispensata dal lavorare, lo stato dovrebbe crollare. Il che ovviamente è giuridicamente un non senso. Quindi il primo dei presupposti errati di questa norma è proprio quello giuridico. In secondo luogo perché se la repubblica fosse fondata sul lavoro, ne deriverebbe che i soggetti peggiori della società sarebbero i preti, i monaci e le suore di clausura, il Papa, il Dalai Lama, gli asceti, coloro che vivono di rendita, chi si dedica solo al volontariato, i politici (la maggior parte dei quali non ha mai lavorato in vita sua) ecc. L’articolo 1 della nostra Costituzione si apre insomma con un concetto assurdo, ma straordinariamente nessuno ne ha rilevato il non senso. Anzi, autori come Mortati (il costituzionalista più famoso) hanno addirittura plaudito a questo articolo. La nostra Costituzione poi prosegue con altri articoli dedicati al lavoro, e tutti inevitabilmente basati su presupposti teorici sbagliati. Il lavoro infatti è considerato un diritto. Ma riflettendoci bene, il lavoro non è un diritto.
Il lavoro è – o dovrebbe essere - una libera scelta per esplicare la propria personalità.
Il lavoro è un dovere per coloro che non hanno abbastanza denaro per vivere.
Il lavoro è poi una scelta di vita, in quanto dovrebbe essere l’espressione della personalità del soggetto.
Chi ama dipingere vivrà di pittura; chi ama la giustizia cercherà di fare il giudice o l’avvocato; chi ama i soldi cercherà di lavorare in banca e così via. Ma ben possono esserci scelte alternative altrettanto nobili. Basti ricordare che le più grandi religioni del mondo si basano sulla figura dei loro fondatori, che non erano certamente lavoratori e che i primi discepoli di queste persone tutto erano tranne che lavoratori. Cristo non era un lavoratore e i anche i discepoli non erano tali ; o meglio, lo erano proprio finchè non hanno incontrato Cristo. La stessa cosa vale per Budda e i suoi discepoli che erano dei mendicanti, e tutt’oggi i monaci buddisti vivono sempre di carità. Una persona che accudisce i propri figli e fa vita solo casalinga non fa una scelta meno nobile di un dipendente delle poste, o di un funzionario di banca, o di un magistrato o un avvocato (che spesso passa la vita a dirimere questioni condominiali e cause assicurative, cioè occupandosi di cose infinitamente meno nobili dell’educazione di un figlio). Ricordiamo poi che la maggior parte dei politici non ha mai lavorato in vita sua. D’Alema e Bertinotti, che difendono i diritti dei lavoratori, non hanno mai lavorato né hanno mai creato veramente lavoro (al di fuori di quello delle cooperative rosse che serviva e serve per mantenere i partiti di sinistra). Quindi il concetto del lavoro come diritto, e come fondamento della Repubblica, non sta in piedi né filosoficamente né giuridicamente, né dal punto di vista logico. E’ una delle balle giuridiche più colossali che ci abbiano mai raccontato. A questo punto occorre capire perché al lavoro è stata data un’importanza così grande, introducendo nella Costituzione dei concetti falsi e che non hanno alcune attinenza con la realtà.
7. L’effettivo stato di cose.
Il reale significato delle norme sul lavoro previste dalla nostra Costituzione
possono essere capite se si conosce il meccanismo effettivo con cui il nostro
sistema massonico funziona. Il sistema massonico funziona, effettivamente sul
lavoro. Il lavoro è infatti il grosso problema della società attuale. Se voi
chiedete a qualcuno qual è la più grande preoccupazione oggi, in Europa, vi
diranno: il lavoro. Non c’è lavoro. Cosa promette un politico in cambio di voti?
Un lavoro. Perché la mafia al sud è tenuta in considerazione più dello Stato?
Perché dà lavoro. Perché la maggior parte delle persone, oggi, è spinta ad
entrare in massoneria? Per cercare lavoro o per aumentare quello che ha.
Se non ti allinei alle direttive del sistema qual è la punizione più immediata
che subisci? La perdita del lavoro. Perché un magistrato copre un omicidio, un
poliziotto non indaga, un dipendente pubblico commette una scorrettezza, un
giornalista non pubblica una notizia importante? Perché altrimenti perdono il
lavoro. Perché si danno le mazzette per avere gli appalti? Perché altrimenti
l’appalto non ti viene assegnato (ovverosia non hai lavoro). Perché la maggior
parte della gente non sa cosa è il signoraggio, cosa sono le scie chimiche,
cos’è la massoneria? Perché la TV non informa su questo, per informarsi da soli
ci vuole troppo tempo, e la gente non ha tempo perché “deve lavorare”. In altre
parole, il lavoro, con i suoi perversi meccanismi per il suo mantenimento, è lo
strumento che viene usato dai poteri occulti e dalla politica per poter piegare
i cittadini. In tal senso, allora, l’articolo 1 è perfettamente coerente col
sistema attuale e allora acquista un senso. La repubblica (massonica) si fonda
sul lavoro. In altre parole l’articolo 1 dovrebbe più correttamente essere letto
in questo modo:
L’Italia è una repubblica massonica, fondata sul lavoro, e il potere massonico, per mantenersi, ha bisogno di gente che sgobbi 12 ore al giorno senza mai alzare la testa per pensare, altrimenti capirebbe l’inganno in cui la teniamo.
8. Effetti della normativa a tutela dei lavoratori. A questo stato di cose si sono aggiunte le leggi che proteggono il lavoratore a scapito del datore di lavoro. Queste leggi sono l’attuazione dell’articolo 4 della Costituzione, che dice espressamente che “la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che favoriscono il loro diritto”. Il risultato delle leggi che hanno promosso la condizioni che favoriscono i diritti dei lavoratori è sotto gli occhi di tutti: l’impossibilità per il lavoratore di licenziare in tronco il lavoratore sgradito (anche se ha rubato, se è un nullafacente, ecc.), nonché la nostra demenziale politica fiscale, che ci fa pagare tasse anche per l’aria che respiriamo, hanno prodotto lavoro in nero, stipendi ridicoli, e lo sfruttamento sistematico di intere categorie di lavoratori da parte dei datori di lavoro. Questa normativa ha raggiunto il risultato esattamente contrario a quello programmato dall’articolo 4; infatti danneggia il lavoratore, perché distorce il rapporto di forza tra lavoratori e datori di lavoro. Mi spiego. Il rapporto di lavoro dovrebbe essere basato sulla parità delle parti. Io lavoratore ho bisogno di lavorare per vivere; ma anche tu, datore di lavoro, hai bisogno del lavoratore altrimenti la tua azienda non funziona. Il sistema di leggi che riguardano il mondo del lavoro invece, tassando dissennatamente gli imprenditori, facendo mancare il lavoro ovunque grazie alla crisi, e impedendo il licenziamento arbitrario, ha prodotto come risultato un sistema in cui la gente va a mendicare il lavoro da datori di lavoro che il più delle volte lo concedono come se fosse un favore; favore di cui i lavoratori devono ringraziare, spesso facendosi umiliare pur di non perdere il lavoro, subendo ricatti sessuali e non, ecc. La corruzione nei concorsi pubblici, volta a selezionare non i migliori, ma i più corrotti e i più raccomandati in tutti i settori della vita pubblica, nella magistratura, in polizia, negli enti pubblici, ecc., ha portato come ulteriore conseguenza una classe di lavoratori demotivata; la maggior parte di essi infatti non hanno scelto il lavoro in base alle loro capacità, ma in base ai posti che ha reso disponibile il sistema. Il risultato di questa politica del lavoro durata nei decenni è la perdita di dignità di tutte le categorie di lavoratori, anche di quelle dirigenziali. Ovverosia:
- la maggior parte dei lavoratori fa lavori che non sono adatti a loro;
- la maggior parte dei lavoratori accetta di essere sottopagata;
- la maggior parte dei lavoratori pur di lavorare accetta anche umiliazioni e trattamenti disumani;
- spesso si sente dire “non ho lavoro, quindi non ho dignità”; i valori massonici del lavoro infatti hanno instillato nella gente l’idea che un disoccupato non abbia dignità: a ciò contribuisce anche il demenziale detto, accettato da tutti, che “il lavoro nobilita l’uomo”; brocardo che non so chi l’abbia inventato, ma certamente doveva essere un imbecille.
- poliziotti, carabinieri, magistrati, fanno il loro lavoro non per missione di vita, come dovrebbe essere, ma dando la prevalenza allo stipendio, ai problemi di mobilità, di avanzamento di carriera, ecc.
- i datori di lavoro sono costretti dalla dissennata legislazione italiana ad assumere lavoratori in nero, sottopagarli, ecc.
- Nella massa delle persone si instillano concetti distorti; ad esempio non è raro sentir lodare una persona con la frase “è un gran lavoratore, lavora tutti i giorni anche dodici ore al giorno” come se questo fosse un pregio. E ci si dimentica che chi lavora dodici ore al giorno non ha tempo per i figli, per riflettere, per evolvere. Anche Pacciani, infatti, per dare di sé un’immagine positiva, al processo sul mostro di Firenze disse che era “un gran lavoratore”. Tutto questo sistema fa si che il cittadino sia un docile e remissivo strumento del sistema in cui viviamo, ove la frusta è stata sostituita dallo spauracchio della perdita del lavoro.
9. Considerazioni conclusive e di diritto comparato. In conclusione, la nostra Costituzione è organizzata e strutturata in modo molto abile, per favorire l’illegalità e l’ingiustizia, grazie ai suoi principi e alle sue lacune, difficilmente riscontrabili ad una prima lettura. Tra i vari partiti politici e i costituzionalisti, non mi risulta che nessuno abbia mai rilevato questo stato di cose, ad eccezione della Lega Nord, che nel 1993 aveva fatto una proposta di modifica dell’articolo 1 per cambiarlo in: L’Italia è una repubblica democratica basata sul mercato e sulla solidarietà. Ovviamente la proposta è stata contestata dalla sinistra. Perché si sa. La sinistra è a favore di lavoratori. E infatti il risultato della politica di sinistra si è visto nei pochi anni in cui abbiamo avuto governi di questo colore. Uno sfascio se possibile anche peggiore di quello di destra, perché in effetti il più acerrimo nemico dei lavoratori, in questi decenni, non è stata la destra, ma la sinistra. In compenso, anche la costituzione del Sudafrica è più progredita della nostra, ove il diritto al lavoro non compare, ma compaiono invece la tutela della dignità umana e compare il diritto dei datori di lavoro. In altre parole l’Italia è seconda anche a stati che, culturalmente, in teoria dovrebbero essere più arretrati di noi. L’articolo 1 della Costituzione del Sudafrica (all. 4), molto più avanti del nostro, recita: La costituzione del Sudafrica provvederà all’istituzione di uno Stato sovrano, di una comune cittadinanza sudafricana e di un sistema di governo democratico, mirante a realizzare l’uguaglianza tra uomini e donne e fra genti di tutte le razze. Tra gli stati europei, invece, sarebbe sufficiente citare il caso della Spagna. La Spagna ha in gran parte mutuato dal nostro sistema i principi giuridici più importanti. Tuttavia, non a caso, l’articolo 1 della Costituzione spagnola non fa cenno al lavoro e dichiara di fondarsi – molto più intelligentemente di noi – su libertà, giustizia e uguaglianza. Infatti, mi disse un professore universitario di Lima, che aveva la docenza anche in Spagna, un certo Juan Espinoza Espinoza: in Spagna nessuno si prostituisce per avere un semplice posto da portiere o da cameriere, come da voi. Da voi occorre essere raccomandati anche per avere un lavoro a termine per sei mesi alle poste. Non a caso da loro il lavoro è collocato all’articolo 35, che dice il contrario di quanto dice la nostra Costituzione: tutti i lavoratori spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto alla libera scelta di una professione o di un mestiere. E non a caso nel campo di concentramento di Auscwitz compariva una scritta all’entrata: arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Più o meno lo stesso concetto contenuto nell’articolo 1 della nostra Costituzione.
APOLOGIA DELLA RACCOMANDAZIONE. LA RACCOMANDAZIONE SEMPLIFICA TUTTO.
«Una volta mi ha fatto impressione Galan che mi ha detto che, nelle sue tre legislature alla Regione Veneto, nessuno gli aveva chiesto una raccomandazione, e io mi sono impressionato perchè da noi te lo chiedono ogni secondo. - Lo dice Gianfranco Miccichè, sottosegretario alla Funzione Pubblica, ai microfoni de "La Zanzara" su Radio 24. - Nella mia vita ho fatto un sacco di raccomandazioni, assolutamente sì. Anche alla Regione, in una terra come la Sicilia dove vive una quantità infinita di gente che non campa e ti chiede aiuti di tutti i tipi. Non c’è nulla di male. Quando ho potuto farle – dice Miccichè – l’ho fatto. E poi la raccomandazione – spiega Miccichè – non significa assumere un amico senza merito. Spesso vuol dire aiutare una persona in difficoltà che ritiene di aver subito un torto. Io ho raccomandato quando era possibile solo gente disperata. Non è una questione culturale, chi lo dice è un razzista». Miccichè elogia la raccomandazione: semplifica tutto. Il quasi-ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianfranco Miccichè, ha riferito ai giornalisti che l’assediavano – essendo uscito dai “titoli” dei giornali per più di due settimane, era nata qualche preoccupazione – di avere raccomandato molte persone e non c’è alcun motivo per dolersi di questa attività. “Segnalare” calorosamente un amico alla persona giusta non è un peccato mortale né un anacronismo. Anzi. Non ha tessuto l’elogio della raccomandazione, ma è come se l’avesse fatto, scrive “Sicilia Informazioni”. Appena tornato a vele spiegate nel grande giro, grazie alla nomina a sottosegretario voluta da Silvio Berlusconi, Miccichè confessò di avere utilizzato “incentivi” diciamo così non proprio ortodossi per sopravvivere, facendo uso di stupefacenti, lasciando di stucco coloro che non sono abituati agli outing così audaci. La sua franchezza, dunque, è diventata proverbiale. Avendo scelto di dedicarsi alla semplificazione per mestiere, Miccichè ha indicato la strada maestra per sburocratizzare la pubblica amministrazione, magari senza averne piena consapevolezza. È questa la sensazione. La raccomandazione consente di cancellare il farraginoso iter dei concorsi pubblici, le defatiganti gare, aste, bandi, laboriose selezioni di candidati e così via. In un colpo solo, insomma, la metà del lavoro della pubblica amministrazione verrebbe cancellato, facendo guadagnare tempo prezioso a migliaia di burocrati. Da che mondo è mondo, le scoperte che fanno la storia dell’umanità, sono casuali. Anche la Penicillina, per esempio, è stata scoperta per caso, tanto per dire. Si può avere sotto gli occhi o nei pensieri qualcosa o un’idea, e non accorgersi di possedere un inestimabile tesoro da regalare all’umanità. E’ il caso della raccomandazione e di Gianfranco Miccichè? Sinceramente non lo sappiamo. Ma qualche considerazione possiamo spenderla a favore della sua esternazione. Il quasi ministro ha raccomandato più volte ed a più riprese nel corso della sua lunga carriera politica, magari sentendosi in colpa o credendo di trasgredire la stantia morale prevalente, mentre in effetti dava un contributo essenziale alla semplificazione. Ora si tratta di compiere il passo più importante, sdoganare la raccomandazione, cancellare la morale bavosa che la vieta e introdurre la consuetudine nella pubblica amministrazione. In una prima fase ci si può accontentare di raccomandare senza doversene vergognare, in una fase successiva, si può introdurre qualche comma nella normativa vigente. Step by step, insomma. L’elogio della raccomandazione abbatte un autentico tabù della società politica, è un autentico atto rivoluzionario. A differenza dell’uso di droghe, confessato da Miccichè, infatti, il quasi ministro non “si giudica” severamente, confidando nell’etica della responsabilità. Egli sostiene, infatti, che assumersi l’onere di una scelta regala vantaggi maggiori di concorsi e selezioni, evitando che alcuno trucchi le carte o utilizzi procedure che non premiano il merito. Se qualcuno è bravo, lo si capisce abbastanza presto, insomma. Quando si raccomanda qualcuno si risponde della bontà della scelta. Se hai raccomandato un cretino o un disonesto, un incompetente, paghi il fio, se hai sostenuto la candidatura di una persona per bene dotata delle conoscenze idonee per fare quel che deve, ne trai lustro. Tutto alla luce del sole. Se la realtà non fosse dura e arcigna, si sarebbe portati a dargli ragione su tutta la linea. Gianfranco Miccichè è il raccomandato più influente, dopo Angelino Alfano, di Silvio Berlusconi. Avendone combinato di tutti i colori – scissione compresa – possiamo in tutta onestà affermare che l’ex premier ne abbia tratto lustro? Di più: le raccomandazioni di Gianfranco Miccichè non sono state per niente fortunate: dalla Fondazione Federico II di Palermo alle assemblee legislative, ed alla direzione di enti pubblici i “raccomandati” del quasi ministro, non hanno brillato per nulla. Anzi, in qualche caso, sono stati una frana, e sono finiti dritti in galera. Questo dettaglio non inficia la validità della raccomandazione come strumento della semplificazione, ma qualche perplessità la fa sorgere.
E poi c’è quello che non ti aspetti.
Affari dei Templari leghisti Appalti dei Gran Maestri. Contratti con Asl, Pirellone, Comune di Brescia oltre ai ruoli nel partito: così la Suprema Militia piazza parenti e amici, scrive Leonardo Piccini su “Libero Quotidiano”. Chi sono e, soprattutto, quali sono gli scopi che si sono prefissati gli adepti alla organizzazione templare attiva in Lombardia e in tutta Italia, detta la “Suprema Militia”, composta come abbiamo visto nella prima puntata da uomini politici, prefetti, imprenditori? Persone decise ad assumere le vesti di epigoni del gran maestro Jacques de Molay, seguaci di quei cavalieri dispersi nel quattordicesimo secolo dalle persecuzioni dal Papa e dal re di Francia. A colpire sono soprattutto le implicazioni di rapporti cementati dall’appartenenza a un ambiente iniziatico ed esclusivo tra esponenti della pubblica amministrazione, della politica, dell’economia. In teoria questa “Suprema Militia Equitum Christi” dovrebbe promuovere un percorso, per i suoi adepti che assomiglia molto a un lavoro iniziatico di conoscenza e di approfondimento dei temi principali dell’esistenza, da perseguire mediante la carità, la beneficenza, il servizio ai diseredati. Ma al suo interno si trovano affiliati che si occupano di questioni molto mondane e pratiche: consulenze professionali, incarichi pubblici, politica, imprese, strategie delle multiutility lombarde. Senza contare poi la presenza di chi, per dovere istituzionale, è chiamato a rappresentare lo Stato, non ultimo, il prefetto di Pesaro e Urbino, Attilio Visconti, pronto a vestire i panni di cerimoniere e a occuparsi della formazione degli adepti e dei novizi di una cupola riservata. Ieri Visconti ha spiegato: «Ma quale loggia massonica o associazione segreta: la Suprema Militia Equitum Christi è una onlus che fa beneficenza, non politica. Non ha legami con la Lega, ed elenco degli iscritti e bilanci sono pubblici». Visconti s’è detto «onorato di far parte di questa associazione». Fatto sta che insieme a lui ci sono altri esponenti delle istituzioni, come il vicesindaco di Brescia Fabio Rolfi, l’assessore regionale Monica Rizzi, e il dirigente comunale Marco Antonio Colosio, l’ex consigliere regionale e, ora, vicepresidente dell’Aler bresciana, Corrado Della Torre. E che dire poi della presenza, in un gruppo di duri e puri del cattolicesimo più intransigente, di un massone, come Marco Belardi, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia, in forza alla Glri, la Gran Loggia Regolare d’Italia? A suscitare interrogativi è questo mix di rapporti e interessi profani e spirituali, trattati all’ombra di un gruppo coperto e lontano da occhi e orecchie indiscrete. È forse in virtù della comune militanza templare con il vicesindaco leghista, che l’ingegnere Belardi ottiene consulenze ben retribuite dal Comune di Brescia? Nel marzo del 2010, la sua società, la “Intertecnica Group” si vede assegnare un incarico per la ristrutturazione di impianti idrotermo-sanitari di una proprietà comunale; mentre nell’aprile del 2011, sempre la sua “Intertecnica” si aggiudica un incarico di progettazione e direzione lavori nell’area archeologica cittadina del Capitolium. Il vicesindaco Rolfi, da qualche mese anche segretario provinciale della Lega Nord, è censito come cavaliere dell’ordine templare già nel 2009 nella “Commanderia San Gottardo” di Brescia; almeno dallo stesso periodo risulta aver incrociato, a San Gottardo, proprio il “novizio” Marco Belardi, che proprio dall’ottobre del 2009 si insedia nella posizione delicata e prestigiosa di presidente dell’Ordine degli Ingegneri. È forse grazie a questa consorteria così profondamente annidata nel cuore della Lega Nord che Fabio Rolfi, fallito il primo tentativo di sistemare la moglie Silvia Raineri attraverso un concorso pubblico indetto dalla provincia di Brescia, la piazza all’Asl di Milano? Il concorso della provincia di Brescia aveva suscitato un clamore nazionale, perché delle sei vincitrici ben cinque erano leghiste e parenti di esponenti politici leghisti di primo piano del bresciano. Un tale clamore da rendere necessaria una commissione d’inchiesta e da indurre il presidente della provincia Molgora, pure leghista ma estraneo all’ambiente di Rolfi e dei cavalieri, a congelare le assunzioni. Così Rolfi si rivolge prima al gruppo leghista in regione Lombardia, che conferisce a Silvia Raineri un incarico, poi al leghista Giacomo Walter Locatelli, potente direttore generale dell’Asl di Milano: la Rainieri si piazza diciottesima in un concorso per l’assunzione di un solo impiegato, ma viene ugualmente assunta; si dimette dall’incarico in Regione, prende possesso dell’impiego all’Asl, ottiene immediatamente dal direttore generale un’aspettativa e riassume il suo incarico in Regione. C’è poi chi fa notare certe coincidenze: recentemente eletto alla carica di segretario provinciale della Lega Nord, Rolfi affronta il nodo di Montichiari, importante comune della provincia in cui la Lega governa dagli anni 90 e dove ha sofferto, in occasione delle ultime elezioni, una secessione che ha portato fuori dal partito tutto il gruppo dirigente locale, compreso sindaco e vicesindaco. Dopo anni la spaccatura viene ricucita e l’incarico di commissario della sezione leghista di Montichiari, tutt’ora percorsa da forti tensioni, va a Corrado Della Torre, il Grand Commandeur dei cavalieri di San Gottardo dei quali fa parte lo stesso Rolfi. Quel Della Torre che, intervistato da Marta Calcagno, su il Giornale del 09/10/2010, dichiarava che «nell’Ordine dei Templari ci sono vari gradi di cavalleria, che sono immutabili dal 1100. C’è una composizione sociale varia: dal generale dei carabinieri, a professionisti di diversi livelli, sino ad imprenditori e industriali». A San Gottardo non mancava mai un altro abitué del Tempio, il prefetto Attilio Visconti: nato a Benevento il 21 ottobre del 1961, per due anni, dal 1990 al 1992, presta servizio nel Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (Cesis). Nel 2006 è trasferito alla Prefettura di Brescia, dove gli viene conferito l’incarico di Capo di Gabinetto. Nel 2007 è chiamato a svolgere il ruolo di commissario straordinario per i Comuni di Offlaga, Travagliato e Borno. Il 12 dicembre del 2007 è nominato viceprefetto Vicario di Brescia. Nel giugno del 2008 è nominato commissario prefettizio del comune di Edolo (il paese di Bruno Caparini, il Gran Baylo dell’ordine templare in cui milita lo stesso Visconti). Poi l’incarico di viceprefetto vicario a Torino, l’arrivo a Caserta e la tanto agognata nomina a Prefetto di Urbino. In molti di questi incarichi, soprattutto in quelli di commissario prefettizio in comuni bresciani, Visconti è sempre accompagnato da due giovani leghisti: il fido Marco Antonio Colosio, presente nell’elenco dei templari bresciani, e l’architetto Franco Claretti, oggi sindaco leghista di Coccaglio, un paesone del bresciano. E l’amministrazione comunale di Brescia, in cui Fabio Rolfi è vicesindaco e dominatore assoluto, nomina entrambi dirigenti fin dal debutto della giunta di centrodestra. Il capo del gruppo lombardo è Bruno Caparini, cofondatore assieme a Bossi della Lega e attuale membro del consiglio di sorveglianza di A2A. Di lui, fino a poco tempo fa, Monica Rizzi, assessore regionale allo Sport (una adepta della loggia templare fino all’anno scorso, espulsa, forse, per la vicenda della finta laurea in psicologia, più credibilmente per incompatibilità con l’ambiente e gli altri cavalieri leghisti, ormai di stretta osservanza maroniana), conservava una foto in assessorato: abito nero con mantello bianco e croce templare rossa sul cuore, spada Carlo V e decorazione dell’ordine appesa al collo. Questa è la divisa del cavaliere della Suprema Militia.
LA STRATEGIA DELLA TENSIONE: TERRORISTICA E GIUDIZIARIA.
Il misterioso uomo della tensione, scrive Monica Zornetta su “L’Espresso”. Sconosciuto all'opinione pubblica grazie alla copertura dei servizi segreti, Berardino Andreola compare in tutti gli episodi misteriosi degli anni di piombo: dai delitti Calabresi e Feltrinelli fino a Piazza Fontana e alla morte di Pinelli. Un libro inchiesta rivela la sua storia. Ci sarebbe un unico uomo dietro a tanti dei misteri che hanno messo in ginocchio l'Italia negli anni Sessanta e Settanta. Dietro la strategia della tensione, i delitti Calabresi e Feltrinelli, la morte di Pinelli, il tentato sequestro dell'ex senatore democristiano Graziano Verzotto. Una abile spia dal passato troppo nero che a un certo punto, protetta dai Servizi segreti tedeschi, difesa da alcuni potenti rappresentanti delle istituzioni italiane e tutelata dal ricorso quasi schizofrenico a travestimenti e ad alias differenti, si sarebbe abilmente mescolata con il rosso al fine di depistare, insabbiare. E uccidere. Il suo nome è Berardino Andreola, nato a Roma nel 1928 e morto a Pesaro nel 1983, indagato varie volte - con le fittizie generalità, a seconda dei casi, di Giuseppe Chittaro, Umberto Rai, Günter, Giuliano De Fonseca - per le morti di Feltrinelli e di Calabresi e per la bomba alla questura di Milano; e infine condannato - con il nome autentico - per il solo tentativo di sequestro a scopo di estorsione dell'ex presidente dell'Ente minerario siciliano, il veneto Graziano Verzotto, compare d'anello del boss catanese Giuseppe Di Cristina. A collocare Andreola sotto una luce nuova e più articolata, svelandone l'incredibile storia, alcuni movimenti, collaborazioni, appartenenze e vicinanze inaspettate (l'Ufficio affari riservati,il vertice dell'Ufficio politico della questura di Milano, l'Aginter Press, il segretissimo gruppo Alpha, probabile mandante del delitto Calabresi), illustrandone i numerosi depistaggi e i raggiri e ipotizzando nuovi contatti, è lo studioso padovano Egidio Ceccato nella documentatissima inchiesta da poco pubblicata per Ponte alle Grazie, "L'infiltrato". Ceccato, tanto per cominciare: chi è Berardino Andreola. "E' un personaggio che ha più volte fatto capolino, con vari alias - penso a Giuseppe Chittaro Job, Giuliano De Fonseca, Umberto Rai, Günter, Francesco Miranda Sanchez, tanto per ricordarne qualcuno - in diverse inchieste di quegli anni, ma che alla fine è stato processato e condannato solo per aver diretto il tentato sequestro ai danni di Verzotto nel gennaio 1975. Proprio a seguito di questo fallito rapimento di natura politica - non estorsiva, come hanno invece stabilito le sentenze -, eseguito da tre soggetti probabilmente arrivati da Berlino, erano emersi per la prima volta il suo vero nome e la sua qualifica: "Agente segreto appartenente ad una organizzazione ideologica d'estrema sinistra (Gruppo Feltrinelli)". Agli sbigottiti inquirenti siciliani Andreola aveva spiegato, mentendo, di essere arrivato sull'isola per "infiltrarsi negli ambienti mafiosi" e per "studiare i sistemi operativi della mafia allo scopo di utilizzarli nell'ambito dell'organizzazione di cui faceva parte". In verità la spia era sbarcata in Sicilia un mese dopo i fatti accaduti alla questura di Milano: con ogni probabilità ci era arrivato per seguire il caso Verzotto, per impedire all'ex senatore padovano di rivelare segreti collegati all'assassinio di Mattei. A ogni modo Andreola (noto in questo caso come Chittaro, anarco-maoista friulano) viene indagato per l'attentato alla questura". Erede di una famiglia fascista con un padre maresciallo in servizio presso l'Ovra, l'ex brigata nera Berardino Andreola era stata addestrata nei campi delle Ss in Germania, dove aveva imparato un fluente tedesco. Finito per qualche tempo in carcere per reati legati alla criminalità comune, negli anni Sessanta l'uomo si era messo a professare idee "anarco-maoiste" e antiviolente, diventando il braccio destro di Feltrinelli nei Gap (con il nome fasullo di Günter); un informatore importante di Calabresi (con quello di Chittaro); avvicinandosi a Pinelli, a Valpreda e agli anarchici milanesi prima della strage di Piazza Fontana e facendo al contempo da tramite con la mafia nella fornitura e nel traffico di armi. Come si lega Andreola con le vicende milanesi, in particolare con la "madre" delle stragi: Piazza Fontana?"Alla fine di novembre 1969 Chittaro/Andreola aveva contattato dalla Francia per via epistolare il capo dell'ufficio politico della Questura di Milano, Antonino Allegra, presentandosi come un anarchico-maoista che prendeva le distanze dalle idee violente dei propri compagni. Ad Allegra aveva preannunciato nuovi fatti di violenza politica dopo la morte dell'agente Antonio Annarumma. La sera del 12 dicembre, dopo la scoppio della bomba alla Banca dell'Agricoltura, il capo dell'Ufficio politico lo contatta immediatamente e gli organizza per l'indomani un incontro con Calabresi nella vicina Svizzera. Il 13, perciò, il commissario lo incontra per tre ore a Basilea. Nessuna delle sue dichiarazioni viene tuttavia messa a verbale".
Andreola sembra essere l'anello che congiunge molti fatti terribili accaduti nel nostro Paese. E diversi documenti citati nel libro lo confermano. Eppure il suo nome è praticamente sconosciuto all'opinione pubblica. Perché?
"Per le fortissime coperture di cui ha goduto, innanzitutto. Penso alle indagini per la morte di Feltrinelli, coordinate dal giovane e inesperto magistrato Guido Viola, che non verbalizza le dichiarazioni rilasciate in proposito da Chittaro/Andreola ritenendole pure e semplici fantasie di un mitomane. Molto più probabilmente, però, la mancata verbalizzazione avviene perché dall'alto qualcuno gli consiglia di lasciarlo fuori dalle indagini. Questo non è l'unico episodio a presentare tali caratteristiche. Mi sono convinto, anche grazie a documenti che ho acquisito dopo l'uscita del libro, che Andreola fosse uno dei burattinai che muovevano i fili della strategia della tensione. Per comprendere questa torbida figura non si può infatti prescindere dal Piano Chaos della Cia e dai punti della guerra non ortodossa stabiliti nel maggio 1965 all'hotel Parco dei Principi a Roma. Di Andreola, legato a quella che io chiamo Internazionale nerazzurra - per i contatti con gli apparati americani della Nato - si è parlato in passato, senza che però fosse collocato in un contesto preciso e senza che venissero forniti alla sua figura quei collegamenti che io ritengo essenziali. Le indagini del tempo si erano concentrate sui singoli personaggi, sui suoi tanti alias. Uno separato dall'altro. Con "L'infiltrato", nato durante le mie ricerche per un saggio sulla morte di Mattei che dovrebbe uscire l'anno prossimo, ho cercato di dare un filo logico, di riunire tutto sotto la stessa persona: gli alias e gli episodi delittuosi. Gli importanti collegamenti con Milano, poi, sono potuti emergere grazie ad alcuni documenti forniti da un giornalista dell'Ansa, Paolo Cucchiarelli. Certo, non c'è la pistola fumante, che invece giace forse assieme ad Andreola, ma su chi è stato e su quanto ha fatto esistono riscontri ben precisi, capaci di riscrivere una nuova verità storica con cui la società, non solo italiana, dovrà per forza fare i conti".
Un Paese in preda al marasma senile, scrive Massimo Fini su "IlFattoQuotidiano".
Ho passato una ventina di giorni di vacanza all’estero. Un estero molto vicino: la Corsica (il luogo più vicino più lontano dall’Occidente, perché, soprattutto nell'interno, la vita si svolge secondo i ritmi rallentati delle società tradizionali). Comunque a sole quattro ore di traghetto, con il necessario “recul” (la distanza giusta per osservare un quadro), l’Italia offre di sé uno spettacolo impressionante. Non per i problemi economici. Quelli ce li hanno quasi tutti in Europa. L’Italia sembra in preda a una sorta di marasma senile. Gli ingranaggi si sono inceppati. È saltata la filiera di un ministero chiave come quello degli Interni: il capo non sa cosa fanno i suoi subalterni i quali, a loro volta, agiscono ognuno per conto proprio più o meno all’insaputa l'uno dell’altro (sempre che costoro abbiano dichiarato il vero, come temo, perché sarebbe preferibile che avessero detto delle menzogne che sono almeno un segno di vitalità). Subiamo le imposizioni dei kazaki, che si permettono di portar via, con un aereo privato due persone che stanno nel nostro Paese, che sono sotto la nostra giurisdizione e la nostra tutela. Emma Bonino, il clone ottuso di Pannella, eletta improvvidamente ministro degli Esteri, non è riuscita che a balbettare che l’intervento kazako è stato “intrusivo”. Abbiamo perso ogni credibilità internazionale. Dopo che una mezza dozzina di presidenti del Consiglio e di ministri della Giustizia avevano fatto i pesci in barile per non dispiacere gli americani, la Cancellieri, da Guardasigilli, si era decisa a spiccare mandato di arresto, via Interpol, contro Robert Lady il capetto della Cia a Milano, responsabile del rapimento di Abu Omar, condannato a nove anni di galera. E in effetti Lady è stato arrestato a Panama, ma il Paese centroamericano non ha nemmeno aspettato che ne chiedessimo l’estradizione, l’ha consegnato subito agli Stati Uniti, al sicuro. Un delinquente comune anzi "naturale” come lo ha definito il Tribunale di Milano (che è qualcosa di più di “delinquente abituale”, vuol dire che ce l’ha proprio nel dna) tiene in scacco il Paese e il governo. Basta un soffio perché crolli tutto il castello di carte. Nel frattempo il governo si tiene insieme solo perché, direi fisicamente, non può cadere. Una potente ‘family’, palazzinara e finanziaria, viene mandata al gabbio e il suo patriarca, Salvatore Ligresti, ai domiciliari nella sua bella villa nel quartiere di San Siro che, a suo tempo, aveva provveduto a sconciare in combutta con i sindaci socialisti. Ma Ligresti non era già stato condannato ai tempi di Tangentopoli? E che c’entra? Questi ritornano sempre. E se mai, una volta, si riesce a “innocuizzarli” in modo definitivo, è solo quando hanno potuto compiere ogni sorta di rapine ai danni della cittadinanza. Non c’è settore in cui la magistratura vada a mettere il dito dove non salti fuori il marcio purulento, un pus che corrode tutto e tutti: funzionari, impiegati pubblici, poliziotti, vigili urbani, preti e naturalmente politici di ogni risma e di ogni livello. Ma non c’è più nessuno, in Italia, che rispetti le sentenze dei Tribunali. E perché mai si dovrebbe? A meno che non si tratti proprio di stracci, di riffa o di raffa le sentenze non vengono mai applicate. Nel Paese dei Balocchi non c'è la certezza della pena, c'è quella dell'impunità. Tutti i valori su cui si sostiene una comunità, onestà, dignità, lealtà, assunzione delle proprie responsabilità, sono saltati, in una confusione generale cui contribuiscono gli Azzeccagarbugli dei giornali. Il Capo di questo Stato ha 88 anni. Nel marasma senile del Paese, si trova nel suo.
PROCESSO MEDIASET. LA CONDANNA DI SILVIO BERLUSCONI.
I tratti giovanili e insieme antichi del sostituto procuratore generale della Cassazione Antonello Mura non si scompongono nel momento del successo, scrive Giovanni Bianconi su “Il Corriere della Sera”. Professionale, s'intende. Quando il presidente della Corte Antonio Esposito la sera del 1 agosto 2013 legge nel dispositivo le parole «annulla limitatamente alla statuizione della condanna accessoria» e subito dopo «rigetta nel resto», è chiaro che ha vinto il rappresentante dell'accusa. Ma lui non lo dà a vedere. Non tradisce emozioni. Davanti a cinque giudici chiamati «supremi» perché oltre loro la giustizia umana non è previsto che vada, ha prevalso la tesi che Mura - per conto del suo intero ufficio, come ha ripetuto più volte nella requisitoria - ha sostenuto nella causa numero 27884/13 iscritta al ruolo con il numero 8, contro «Berlusconi Silvio +3». «Nessuno dei motivi di ricorso sulla configurazione del reato e sulla colpevolezza degli imputati ha fondamento giuridico» aveva detto con tono pacato in quattro ore di intervento, dopo l'ormai famosa premessa sulle «passioni e le aspettative di vario genere» che dovevano rimanere fuori dall'aula del «palazzaccio». Le ha lasciate fuori lui e le hanno lasciate fuori i giudici della sezione feriale della Cassazione, un collegio di magistrati istituito con criteri casuali nel mese di maggio, ancor prima che arrivasse il ricorso di Berlusconi contro la condanna a 4 anni di carcere nel processo chiamato «Mediaset». Dopodiché, di fronte alle carte di quella causa e alle ragioni esposte da accusa e difesa, i giudici hanno preso la loro decisione. Sulla base del dispositivo letto ieri sera dal presidente Esposito si può ben dire che hanno aderito quasi per intero all'impostazione della Procura generale. Tranne che su un punto: la rideterminazione dell'interdizione dai pubblici uffici, stabilita in cinque anni dalla Corte d'appello. Dovevano essere tre, aveva detto la Procura generale, perché deve applicarsi la legge speciale del 2000 anziché la norma generale; un ricalcolo che poteva fare direttamente la Cassazione, secondo il pg Mura, mentre la Corte ha ritenuto di non averne il potere. Perciò rispedirà il fascicolo a Milano, insieme alle motivazioni, affinché una nuova sezione della Corte d'appello si pronunci «limitatamente alla statuizione della pena accessoria». Per il resto le sentenze di primo e secondo grado, da considerarsi nel loro insieme, non presentavano vizi tali da farle annullare; l'aveva sostenuto l'accusa e l'ha ribadito la Corte, a dispetto dei 47 motivi di presunta nullità presentati dagli avvocati Franco Coppi e Niccolò Ghedini. Non sul piano della procedura, che è stata rispettata; non sul piano della efficacia probatoria, ché gli elementi a fondamento della condanna si sono rivelati coerenti e ben motivati; non sul piano del diritto, dal momento che i reati contestati erano quelli che bisognava contestare. Ogni altra valutazione non competeva ai giudici di legittimità. Il nocciolo del giudizio riguardava il secondo gruppo di lamentele avanzate dalla difesa: sotto il presunto «vizio di motivazioni» gli avvocati avevano ribadito che non c'era la prova che Berlusconi fosse colpevole di frode fiscale, poiché dal 1994 non riveste più cariche all'interno della Fininvest e di Mediaset e non si poteva condannarlo col criterio del «non poteva non sapere» ciò che facevano i suoi sottoposti. Anche il professor Coppi, aggregato dall'ex premier per quest'ultimo passaggio giudiziario, aveva insistito sulle «prove travisate» e mancanti, sul diritto di difesa negato, prima di immaginare un diverso tipo di reato. Ebbene, secondo i giudici tutto questo non è vero. I dibattimenti di primo e secondo grado si sono svolti nel rispetto delle regole del «giusto processo» e la responsabilità del proprietario di Fininvest e Mediaset non è legata al «non poteva non sapere», bensì al riscontro di una partecipazione diretta al sistema illecito individuato nelle sentenze di condanna. «Vi è la piena prova, orale e documentale che Berlusconi abbia direttamente gestito la fase iniziale dell'enorme evasione fiscale realizzata con le società off shore» aveva decretato la Corte d'appello. E dopo la cessazione dalle cariche sociali aveva affidato il sistema di cui continuava ad essere dominus, persone di sua stretta fiducia, che rispondevano solo a lui. Ora la Cassazione ha stabilito che i giudici di merito sono giunti a queste conclusioni senza violare alcuna norma di legge, senza contraddizioni o illogicità. Con «motivazioni solide», aveva detto il pg. Nemmeno il fatto che altri due giudici, a Roma e Milano, su questioni simili avessero prosciolto l'ex premier con sentenze confermate in Cassazione significa che in questo processo si dovesse giungere alle stesse conclusioni. «Sono decisioni che non toccavano la questione centrale di questo processo» secondo il pg e così deve aver ritenuto la corte. che non poteva sconfinare nella rivalutazione dei fatti. La sentenza è arrivata dopo oltre sette ore di discussione, nelle quali i cinque giudici «feriali» si sono confrontati per giungere a una conclusione che - vista con gli occhi della premessa condivisa anche dagli avvocati difensori, tranne Ghedini che non riusciva a staccarsi dalle «passioni» - sembra sancire una volta di più l a cosiddetta «autonomia della giurisdizione». E considerato chi l'ha pronunciata, si presta poco alle abituali letture sulla magistratura politicizzata, condizionata da questo o quel colore.
«Non farò la fine di Bettino Craxi». «Non mi faranno finire come Giulio Andreotti». Negli ultimi mesi, con frequenza significativa, Silvio Berlusconi esorcizzava il pantheon tragico dei suoi predecessori della Prima Repubblica tritati dalla macchina della giustizia, scrive Massimo Franco, sempre su “Il Corriere della Sera”. E senza volerlo, né saperlo, accostava la propria sorte alla loro. Il primo, ex premier socialista, morto contumace o esule, secondo i punti di vista, in Tunisia; il secondo, democristiano, assolto per alcuni reati e prescritto per altri dopo processi lunghi e tormentati. Ma comunque liquidato politicamente. Il ventennio berlusconiano cominciò all'inizio della loro fine. E adesso può essere archiviato da una sentenza della Corte di cassazione che conferma una condanna per frode fiscale e dilata il vuoto del sistema politico: un cratere di incertezza più profondo di quello lasciato dalla fine della Guerra Fredda. Puntellare la tregua politica sarà meno facile. Anche se tutti sanno che i problemi rimangono intatti e non esiste un'alternativa al governo di larghe intese di Enrico Letta. Il tentativo di stabilizzazione dell'Italia vacilla dopo un verdetto che riconsegna, irrisolto, il problema dei rapporti fra politica e magistratura. Mostra entrambe impantanate in una lotta che ha sfibrato il Paese; e che si conclude con una vittoria dei giudici dal sapore amaro: se non altro perché allunga un'ombra di precarietà su un'Italia bisognosa di normalità. E poi, una parte dell'opinione pubblica tende a percepire Berlusconi come una vittima e la sentenza rischia di accentuare questa sensazione: il tono del videomessaggio di ieri sera a «Porta a porta» è studiato e esemplare, in proposito. Certamente, non si tratta più del Cavaliere in auge che sugli attacchi e sugli errori altrui mieteva consensi e potere; che risorgeva da ogni sconfitta e sentenza sfavorevole per riemergere più agguerrito di prima, a farsi beffe della sinistra e dei «magistrati comunisti». Non è il Berlusconi del contratto con gli italiani stipulato davanti alle telecamere né il leader colpito in faccia da una statuetta scagliata da un fanatico nel dicembre del 2009 dopo un comizio in piazza Duomo, a Milano, che si issava sanguinante sul predellino dell'auto come per gridare: «Sono invincibile». Stavolta c'è un signore appesantito dagli anni, che ha perso oltre sei milioni di voti alle elezioni di febbraio e che lotta per la sopravvivenza. Continuando a inanellare sbagli, la sinistra gli ha dato un altro vantaggio nelle elezioni per il Quirinale. E non è escluso che la sentenza della Cassazione gli regali un ultimo, involontario aiuto. Ma la corsa è diventata affannosa da tempo. Da un paio d'anni, da quando l'illusione del berlusconismo «col sole in tasca» si è trasformato nell'incubo di un'Italia immersa nella crisi finanziaria e economica, la sua lotta ha velato il tentativo di salvarsi dai processi; e l'incapacità di liberarsi del passato e di preparare una nuova classe dirigente. Le immagini di Palazzo Grazioli, la sua residenza romana, ieri sera davano l'idea del bunker nel quale si discuteva l'ultima battaglia. Un'offensiva segnata stavolta dalla disperazione e dall'esasperazione, però, senza più certezze di vittoria. Il governo e la sua maggioranza anomala sono in attesa di sapere che cosa succederà: sebbene Berlusconi sappia che difficilmente potrebbe nascere una coalizione meno ostile al centrodestra; anzi, forse non ne potrebbe nascere nessuna. Fosse stato il 2008, anno della vittoria più trionfale, avrebbe messo in riga tutti in un amen. Ora non più: le tribù berlusconiane sono in lotta e lui fatica a tenerle unite. A frenare l'impatto della sentenza non basta l'annullamento della parte che riguarda la sua interdizione dai pubblici uffici, sulla quale dovrà pronunciarsi di nuovo la Corte d'appello di Milano. Né è stato sufficiente il capovolgimento della strategia processuale, attuato dal professor Franco Coppi: il tentativo tardivo di difendere Berlusconi nel processo e non dal processo, come avevano fatto i suoi legali eletti in Parlamento. L'impressione è che, accusando la magistratura di perseguitarlo, il Cavaliere abbia alimentato senza volerlo quello che chiama «l'accanimento» della Procura; e spinto la Cassazione a confermare le sue responsabilità senza grandi margini di interpretazione. Il contraccolpo che si teme è quello di radicalizzare le posizioni nel Pdl e nel Pd, nonostante i richiami del Quirinale a guardare avanti. Le opposizioni urlano di gioia, pregustando la destabilizzazione. Ma bisogna capire se nel centrodestra l'urto di chi vuole una crisi prevarrà davvero sul tentativo dell'ex premier di «tenere» su una linea di responsabilità. E, sul versante opposto, se il Pd resisterà o no alla pressione di quella sinistra che non ha mai digerito un'alleanza in nome dell'emergenza. Il videomessaggio diffuso da Berlusconi fornisce scarsi indizi. Sembra il sussulto drammatico di un leader che lega le vicende di Tangentopoli del 1992-93 alle proprie, additando una parte della magistratura come «soggetto irresponsabile». I fantasmi del passato lo tallonano, mettendogli in tasca non raggi di sole ma presagi di umiliazione. Lui reagisce promettendo il miracolo dell'ultima rivincita. Evoca Forza Italia e la ripropone per le elezioni europee del 2014. Ma è un ritorno al 1994: la parabola di un ventennio.
Vent'anni di persecuzione continua.
Cambiano accuse e processi, ma l'obiettivo della Procura di Milano è sempre lo stesso: il berlusconismo e l'impero del Cav, scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. E pensare che sarebbe bastato poco. Forse un po' di pazienza in più da parte di Silvio Berlusconi. Forse qualche oscillazione nei misteriosi, delicati equilibri di potere che governano la Procura milanese. Quattordici anni fa, la pace che avrebbe cambiato la storia del paese era a portata di mano: e non si sarebbe arrivati alla sentenza di oggi. Una domenica di maggio del 1999 Berlusconi salì nell'ufficio del pubblico ministero Francesco Greco e ci rimase tre ore. Con Greco e il suo collega Paolo Ielo si parlò ufficialmente di una accusa di falso in bilancio. Ma era chiaro a tutti - e il procuratore capo Gerardo D'Ambrosio lo rese esplicito - che quell'incontro era il segno di un tentativo di dialogo. Berlusconi faceva alcune ammissioni, concedeva - e lo mise per iscritto in una memoria - che l'«espansione impetuosa» del suo gruppo poteva avere creato «percorsi finanziari intricati». La Procura si impegnava ad evitare accanimenti, e a trattare Berlusconi alla stregua di qualunque altro imprenditore: con la possibilità di fuoriuscite soft come quelle concesse al gruppo Fiat. Sarebbe interessante capire ora, a distanza di tanti anni, dove si andò a intoppare il dialogo. Sta di fatto che rapida come era emersa, la strada si arenò. Il partito della trattativa si arrese. E riprese, violento come prima e più di prima, lo scontro senza quartiere. Da una parte un gruppo inquirente che ha dimostrato di considerare Berlusconi, nelle multiformi incarnazioni dei suoi reati, all'interno di quello che può in fondo essere letto come un unico grande processo, come la sintesi dei vizi peggiori dell'italiano irrispettoso delle leggi: il berlusconismo, insomma, come autobiografia giudiziaria della nazione. Dall'altra, il Cavaliere sempre più convinto di avere di fronte un potere fuori dalle regole, dalla cui riduzione ai binari della normalità dipende la sua stessa sopravvivenza. Da vent'anni Berlusconi e la Procura di Milano pensano che l'Italia sia troppo piccola per tutti e due. Ma da dove nasce, come nasce, questa contrapposizione insanabile? L'apertura formale delle ostilità ha, come è noto, una data precisa: 22 novembre 1994, data del primo avviso di garanzia a Berlusconi. Ma la marcia di avvicinamento inizia prima. Inizia fin dalla prima fase di Mani Pulite, quando il bersaglio grosso della Procura milanese è Bettino Craxi. E, passo dopo passo, i pm si convincono che Berlusconi - che pure con le sue televisioni tira la volata all'inchiesta - è la vera sponda del «Cinghialone», il suo finanziatore e beneficiario. Chi c'è dietro All Iberian, la misteriosa società che nell'ottobre 1991 versa quindici miliardi di lire a Craxi, e riesce anche a farsene restituire cinque? Dietro questa domanda, che diventa strada facendo una domanda retorica, i pm lavorano a dimostrare la saldatura tra Craxi e Berlusconi. Quando nell'aprile 1994 Berlusconi diventa presidente del Consiglio, per il pool la vicinanza Craxi-Berlusconi diventa anche continuità politica, perché da subito la battaglia craxiana contro il potere (o strapotere) giudiziario diventa uno dei cavalli di battaglia del nuovo premier. Dal Quirinale viene messo il veto alla nomina di Cesare Previti a ministro della Giustizia. Ma al ministero va Alfredo Biondi, che di lì a poco vara il decreto subito etichettato come «salva ladri», ritirato a furor di popolo dopo il pronunciamento del pool in diretta tv. È da quel momento che lo scontro compie il salto di qualità. Per la Procura milanese non c'è differenza sostanziale tra il Berlusconi imputato e il Berlusconi politico, perché il secondo è funzionale al primo: come dimostreranno poi le leggi ad personam, e, più di recente, la telefonata salva-Ruby alla questura di Milano. Le inchieste che si susseguono in questi vent'anni stanno tutte in questo solco, dentro la teoria della «capacità a delinquere» che diverrà uno dei passaggi chiave della sentenza per i diritti tv. Sotto l'avanzare degli avvisi di garanzia, Berlusconi si irrigidisce sempre di più, come ben racconta l'evoluzione delle strategie difensive: da un professore pacato come Ennio Amodio si passa all'ex sessantottardo Gaetano Pecorella, poi si approda alla coppia da ring, Niccolò Ghedini e Piero Longo. Le dichiarazioni di sfiducia di Berlusconi verso la serenità della giustizia milanese si fanno sempre più esplicite. Per due volte, nel 2003 e nel 2013, il Cavaliere chiede che i suoi processi siano spostati a Brescia, sotto un clima meno ostile. Per due volte la Cassazione gli dà torto. Eppure, fino alla condanna definitiva di oggi, nessuno dei processi era arrivato ad affossare Berlusconi. Assoluzioni con formula piena, prescrizioni, proscioglimenti. Il catalogo dei modi in cui l'asse Ghedini-Longo riesce a tenere l'eterno imputato al riparo da condanne definitive è ricco. Una parte nasce da leggi varate per l'occasione, ma altre assoluzioni danno atto dell'inconsistenza di accuse che la Procura riteneva granitiche. La si potrebbe leggere come una prova della tenuta di fondo del sistema giudiziario, dei contrappesi tra pubblici ministeri e giudici? Berlusconi non la pensa così. E la severità delle ultime sentenze, i giudizi sferzanti dei tribunali del caso Unipol, la batosta del risarcimento a De Benedetti, la decisione dei giudici del processo Ruby 2 di candidarlo a una nuova incriminazione per corruzione in atti giudiziari lo avevano già convinto definitivamente che la contiguità tra pm e giudici era arrivata livelli intollerabili. Guardia di finanza, All Iberian, Mills, Sme, Lodo Mondadori, diritti tv, Mediatrade, Ruby, il rosario delle pene giudiziarie del Cavaliere a Milano sembra interminabile. Cambiano i procuratori, cambiano alcuni dei pubblici ministeri, ma la linea non cambia. Eppure questa è la Procura dove due magistrati di spicco del pool, Antonio Di Pietro e Gerardo D'Ambrosio, hanno detto a posteriori di non avere condiviso la decisione dell'avviso di garanzia del 1994 (il procuratore Borrelli replicò a Di Pietro pacatamente, «Ha detto così? Beh, se si presenta in Procura lo butto giù dalle scale»). È la Procura dove, con Romano Prodi al governo, Francesco Greco andò a un convegno di Micromega ad accusare il centrosinistra, «questi fanno quello che neanche Forza Italia ha osato fare». È insomma la Procura dove la parte più pensante si rende conto che l'insofferenza di Berlusconi verso la magistratura è in fondo l'insofferenza di tutta la politica verso il potere giudiziario, e che non è affatto sicuro che il dopo Berlusconi porti alle toghe spazio e prebende. Ma per adesso lo scontro è con lui, con il Cavaliere. E i pochi giudici che in questi anni hanno disertato, in corridoio venivano guardati storto.
BERLUSCONI: CONFLITTO INTERESSI; INELEGGIBILITA’; ABITUALITA’ A DELINQUERE. MA IN CHE ITALIA VIVIAMO?
"Ci è stato negato il diritto di difenderci". L'avvocato Ghedini che assiste Berlusconi da 16 anni: "Superato ogni limite Ascoltati soltanto i testi dei pm, a noi ne hanno concessi appena 6", scrive Patricia Tagliaferri su “Il Giornale”. Avrebbe voluto parlare di più, almeno tre o quattro ore, ma l'invito del presidente Antonio Esposito a stringere i tempi lo ha spinto ad essere più breve. Veloce ma ugualmente efficace nel cercare di convincere i giudici della Cassazione che nel tessuto della sentenza della Corte d'Appello di Milano sui diritti Tv Mediaset «manca la prova che Berlusconi abbia partecipato al reato». Comincia da qui l'arringa dell'avvocato Niccolò Ghedini. Un processo che è diventato il «suo incubo notturno», senza un solo elemento probatorio contro il Cavaliere, condizionato dai tempi della prescrizione e dove sarebbero stati violati i diritti della difesa. E al pg Antonio Mura che martedì aveva chiesto di lasciare fuori dall'aula le passioni replica che è d'accordo con lui, ma che per gli avvocati non vale: «Nel nostro mestiere le passioni ci devono accompagnare». «Ci stato negato il diritto alla prova - attacca Ghedini - c'è un limite all'applicazione del codice ma in questa storia è stato ampiamente superato. Sono 16 anni che difendo il Cavaliere, sicuramente troppi, e da sempre sento dire che dobbiamo difenderci nel processo e non dal processo. Ma come facciamo a difenderci nel processo con il Tribunale che mi dice di concordare con il pm le domande per i testi?». Si sofferma a lungo sui testimoni negati, ridotti dai 171 richiesti inizialmente ai 6 effettivamente sentiti in 100 udienze, per di più comuni alle altre difese, mentre quelli della Procura sono stati citati dal primo all'ultimo. Ghedini ammette che inizialmente la loro lista testi fosse effettivamente «un po' entusiastica», ma poi quei nomi sono stati ridotti su invito dei giudici a 76. Eppure non è bastato. «Ce ne hanno concessi prima 22 - spiega il legale - poi 14, salvo dirci che erano lontani dal nucleo essenziale della questione. Ma come si fa a dire che David Mills o i dirigenti Mediaset che nel 2003 e nel 2004 si erano occupati degli ammortamenti fossero lontani dal nucleo dell'imputazione? E come è possibile non voler sentire i dirigenti della major? Gli unici testimoni ascoltati sulle asserite società fittizie hanno detto di aver sempre operato con il gruppo, quindi hanno smontato la tesi accusatoria e infatti non vengono neppure citati nelle sentenze». C'è poi il capitolo sulla responsabilità soggettiva di Berlusconi e qui la memoria deve tornare a quelle due sentenze «dimenticate», una proprio della Cassazione, in cui si esclude che l'ex premier avesse responsabilità nella gestione di Mediaset negli anni '90 e si afferma che fosse l'azienda a decidere gli ammortamenti. «Stavolta il concetto usato dall'accusa è stato più raffinato del non poteva non sapere - sostiene Ghedini - è stato detto che un buon imprenditore come Berlusconi non poteva non avvedersi che i ricavi erano gonfiati». La ricostruzione del Pg («Efficace e fantasiosa in alcune soluzioni tecnico giuridiche») viene contestata punto per punto. «Il pg - sostiene Ghedini - ha detto che per Berlusconi ci sarebbero state attività ulteriori oltre alla fatturazione. Quindi mi sarei aspettato delle integrazioni rispetto alle motivazioni della Corte d'Appello, in cui non c'è nulla a riguardo. Integrazioni che non ci sono state perché non ci sono attività ulteriori oltre la fatturazione». Le ultime parole sono per il ruolo di International Media Service, una delle società considerate scatole vuote. «Il pg non ha affrontato questo tema perché era il più debole. Ims era una società consolidata, che ha versato fino all'ultimo centesimo gli utili alla capogruppo e che aveva costi bassissimi. Faccio fatica a capire come possa essere considerata fittizia».
I fatti, così come li racconta Franco Coppi nell'aula Brancaccio della Cassazione, sono di una semplicità disarmante, scrive Anna Maria Greco su “Il Giornale”. Silvio Berlusconi non è colpevole di frode fiscale: il reato non c'è com'è stato configurato nelle due sentenze che lo hanno portato all'ultimo grado di giudizio, perché riguardano un comportamento «non penalmente rilevante». Con un'arringa che fa capire, anche ai più digiuni di diritto, perché merita appieno il titolo di principe dei cassazionisti, il legale del Cavaliere chiede l'annullamento della pronuncia d'appello, «frutto di un pregiudizio cementato dal collante del cui prodest» e di un «abnorme travisamento della prova», per descrivere il leader del Pdl come «il dominus di una catena truffaldina», mentre non gestiva più il suo impero dalla discesa in politica del '94 ( come dimostrerebbero altre sentenze, Mills e Mediatrade, mai acquisite). Solo in subordine, Coppi chiede l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello: se la sua tesi non venisse accolta il reato di frode fiscale andrebbe derubricato in quello di false fatturazioni. La pena sarebbe più bassa e, per i termini ridotti di prescrizione, sarebbe già estinto o a rischio di estinzione. «Berlusconi doveva essere assolto già in primo grado - dice l'avvocato - le prove sono state travisate e i fatti che gli vengono contestati non sono di rilevanza penale». Il professore parla con uno tono sempre misurato e più che rispettoso della corte, spesso si scusa per le ripetizioni di tesi già espresse dagli altri legali. Comincia a parlare alle 17 e 30, dopo Niccolò Ghedini e per oltre due ore inaugura, nella difesa di Berlusconi, uno stile tutto nuovo: spiega con garbo, argomenta con rigore, analizza, documenta e smonta le accuse con motivazioni che appaiono più che convincenti. Premette, citando il giurista Francesco Carrara, che «quando la politica entra dalla porta del tempio, la giustizia fugge impaurita dalla finestra». È solo con le ragioni del diritto che Coppi vuole vincere. Così, se nella prima parte dell'arringa entra nel merito delle sentenze, sempre sul piano della legittimità, nella seconda tira fuori l'asso nella manica e, con il sorriso sulle labbra, distrugge alla radice la ragione stessa del processo. In punta di diritto, il professore afferma che per questi fatti si poteva parlare semmai di «abuso di diritto» con finalità di «elusione» delle tasse, cioè solo di un illecito amministrativo e tributario. Che potrebbe avere conseguenze penali in una precisa circostanza qui assente: il contrasto con una disposizione antielusiva. Per Coppi, della legge 74 del 2000 sui reati tributari, va preso in considerazione l'articolo 2 (dichiarazione infedele) e non il 4 ( dichiarazione fraudolenta), com'è stato fatto per la condanna di Berlusconi. «Siamo fuori - spiega - dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 e della frode fiscale, che comporta fatture per operazioni inesistenti». Quelle per l'acquisto di diritti tv, sono invece operazioni reali, di società «non fittizie», con pagamenti «fatturati» e un rincaro di prezzo «giustificato». Cambia, dunque, la loro stessa «fisionomia». L'avvocato cita diverse sentenze della Cassazione civile, sezione tributaria, oltre a pronunce delle Sezioni Unite e verdetti come quello per gli stilisti Dolce e Gabbana. Alla sezione feriale, presieduta da Antonio Esposito che come gli altri segue con massima attenzione ogni sua parola, offre la possibilità di scrivere una pagina nuova nella giurisprudenza della Suprema Corte traendo conclusioni già implicite negli altri pronunciamenti.
L'avvertimento di Craxi a Berlusconi ai primi tempi dell'esilio ad Hammamet: "La macchina giudiziaria agirà anche contro di te", scrive Stefania Craxi su “Il Giornale”. L'avvertimento di mio padre a Berlusconi («La macchina giudiziaria agirà anche contro di te») risale ai primi tempi del suo esilio ad Hammamet. Craxi era rimasto molto impressionato dall'avviso di garanzia recapitato a Berlusconi, allora presidente del Consiglio, direttamente a Napoli dove stava presiedendo una conferenza internazionale sulla criminalità. Assurda l'accusa, ma ancora più straordinarie le modalità della consegna. L'avviso di garanzia fu infatti pubblicato a tutta pagina dal Corriere della Sera, e portato a conoscenza dell'allora capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, prima ancora di essere consegnato all'interessato. Craxi voleva capire. Voleva capire chi avesse dato il via alla Procura di Milano per l'attacco al Psi e agli altri partiti storici della democrazia italiana. Che Mani Pulite fosse una iniziativa del procuratore Borrelli, non lo credeva, e non lo avrebbe creduto nemmeno un bambino. Pensava che dietro alla Procura di Milano ci fossero i soldi che sempre accompagnano i sommovimenti politici. C'erano i soldi dietro Guglielmo Giannini e l'Uomo Qualunque, fin quando De Gasperi persuase l'allora presidente della Confindustria Cicogna a tagliare i finanziamenti; c'erano i soldi dietro Tambroni; recentemente, chissà se c'erano i soldi dietro il tentativo di Gianfranco Fini di disarcionare Berlusconi? Mio padre si arrovellava per capire l'origine dello tsunami che aveva distrutto la democrazia in Italia, e ora che la giustizia politicizzata si era rimessa in moto, avvertiva Berlusconi, facile profeta, dei guai che lo attendevano: «C'è un vero e proprio piano al massacro che procede con gradualità e per linee convergenti ma che ha al fondo un obiettivo, uno e uno solo, e cioè Silvio Berlusconi». È un vero scandalo che a più di vent'anni dai fasti di Mani Pulite non esista ancora non dico un libro, ma almeno un saggio che scavi a fondo la verità di Tangentopoli; è un vero scandalo che la giustizia politica imperversi ancora fino a condizionare lo svolgimento della vita politica del paese. È avvilente che la democrazia italiana debba ancora attendere con trepidazione un verdetto di giudici ormai impossibilitati ad essere imparziali. Ma io sono convinta che qualsiasi sia il verdetto della Cassazione, Berlusconi saprà dimostrarsi più forte dei suoi persecutori, un soggetto politico di primo piano pronto a mettere gli interessi della Nazione davanti ai suoi interessi personali.
Il Pd, prima Pci-Pds-Ds, che in questo ventennio ha fatto dell’antiberlusconismo il suo unico vero programma per tenere unite le anime più disparate. "Non si può pensare di eliminare l'avversario attraverso una legge": per battere Grillo e Berlusconi, il Partito democratico deve "tirare fuori le idee e non gli avvocati". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, a margine della cerimonia di chiusura dell'anno accademico della "Johns Hopkins University" di Bologna. "Pensare come ha fatto qualche parlamentare del mio partito che si possa sconfiggere Beppe Grillo facendo una legge per dire che il M5s non può partecipare alle elezioni è ridicolo - ha ribadito Renzi -. Non si può pensare di eliminare l'avversario attraverso una legge; puoi sconfiggerlo con le idee e le proposte". Questo, secondo il sindaco, "vale per Berlusconi esattamente allo stesso modo" pensando di sconfiggerlo "attraverso l'interpretazione di una norma". Per Renzi "non si può pensare dopo 19 anni di dire che Berlusconi è ineleggibile, perché se lo era, lo era anche prima. Per battere e mandare a casa Berlusconi e per battere Grillo il Pd deve tirare fuori le idee, non gli avvocati". Infine un riferimento all'Esecutivo. "Non si può sapere quanto durerà il governo Letta perché non è uno yogurt che ha indicata la scadenza sulla confezione. Se fa le cose va avanti, se non le fa va a casa" ha evidenziato Renzi. Renzi aveva già detto e riconferma: la speranza di sconfiggere il Cavaliere per via giudiziaria è «un errore» che la sinistra ha alimentato troppo a lungo. Detto questo, l'eventuale condanna di Berlusconi a quattro anni, tre coperti dall'indulto, rappresenta un unicum nella storia italiana per l'indiscutibile rilievo politico del personaggio. Ex premier per quattro volte, leader del Pdl, fama internazionale, si ritroverà a fare i conti con una pena che, anche se solo di un anno, cambierà profondamente la sua vita personale e pubblica. Né, per lui, potranno essere sovvertite le regole che valgono per i normali cittadini. Se alla pena si aggiungerà anche l'interdizione - 3 o 5 anni poco cambia - Berlusconi rischia di trovarsi anche senza la copertura parlamentare che comunque gli garantisce spazi più ampi di movimento.
Berlusconiani Vs Antiberlusconiani: solito spettacolo penoso, scrive Diego Fusaro su “Lo Spiffero”. Si è per l’ennesima volta riproposto l’osceno spettacolo che tiene da vent’anni prigioniera la politica italiana: quel penoso conflitto tra berlusconiani e antiberlusconiani che continua a ottundere le menti, illudendole che il solo vero problema del nostro Paese sia l’incarcerazione del Cavaliere o, alternativamente, la sua santificazione in terra. Uno spettacolo patetico e, insieme, disgustoso. Se mai è possibile, per i motivi che subito dirò, l’antiberlusconismo è più spregevole dello stesso berlusconismo. Il berlusconismo non è un fenomeno politico. È, semplicemente, l’economia che aspira a neutralizzare la politica, riconfigurandola – avrebbe detto von Clausewitz– come la continuazione stessa dell’economia con altri mezzi. Non ha nulla a che vedere con il fascismo, con buona pace della sinistra perennemente antifascista in assenza integrale di fascismo. Il berlusconismo è osceno, perché è di per sé oscena la dinamica, oggi dilagante, della reductio ad unum operata dalla teologia economica, ossia di quell’integralismo economico che aspira a ridurre tutto all’economia, alla produzione e allo scambio delle merci. Il berlusconismo ne rappresenta l’apice, aggiungendo a questa oscenità pittoreschi elementi da commedia all’italiana su cui è pleonastico insistere in questa sede. Ma l’antiberlusconismo è ancora più osceno. Nella sua intima logica, l’antiberlusconismo si regge su un’esasperazione patologica della personalizzazione dei problemi. Quest’ultima si rivela sempre funzionale all’abbandono dell’analisi strutturale delle contraddizioni: ed è solo in questa prospettiva che si spiega in che senso per vent’anni l’antiberlusconismo sia stato, per sua essenza, un fenomeno di oscuramento integrale della comprensione dei rapporti sociali. Questi ultimi sono stati moralizzati o, alternativamente, estetizzati, e dunque privati della loro socialità, inducendo l’opinione pubblica a pensare che il vero problema fossero sempre e solo il “conflitto di interessi” e le volgarità esistenziali di un singolo individuo e non l’inflessibile erosione dei diritti sociali e la subordinazione geopolitica, militare e culturale dell’Italia agli Stati Uniti. Grazie all’antiberlusconismo, la sinistra ha potuto indecorosamente mutare la propria identità, passando dall’anticapitalismo alla legalità, dalla lotta per l’emancipazione di tutti al potere dei magistrati e dei giudici, dalla questione sociale a quella morale, da Carlo Marx a Serena Dandini, da Antonio Gramsci alla Gabbanelli. La sinistra, muta e cieca al cospetto della contraddizione capitalistica, ha fatto convergere le sue attenzioni critiche su una persona concreta (il Cavaliere), presentandola come la contraddizione vivente. In tal maniera, ha potuto cessare di farsi carico dei problemi sociali e della miseria prodotta dal sistema della produzione, illudendo l’elettorato e inducendolo a pensare che il sistema, di per sé buono, fosse inficiato dall’agire immorale e irresponsabile di un’unica persona. Quest’ultima, lungi dall’essere – nonostante i deliri di onnipotenza del caso – la causa della reificazione globale, ne è un effetto: più precisamente, si presenta come l’esempio vivente dell’illimitatezza del godimento gravido di capitale, che travolge apertamente ogni limite e ogni barriera, ogni legge e ogni istituzione che non riconosca il plus ultra desiderativo come unica autorità e come sola legge. L’antiberlusconismo ha permesso alla sinistra di occultare la propria adesione supina al capitale dietro l’opposizione alla contraddizione falsamente identificata nella figura di un’unica persona, secondo il tragicomico transito dal socialismo in un solo paese alla contraddizione in un solo uomo. Come l’antifascismo in assenza integrale di fascismo, così l’antiberlusconismo ha svolto il ruolo di fondazione e di mantenimento dell’identità di una sinistra ormai conciliata con l’ordine neoliberale (si pensi alle penose rassicurazioni di Bersani circa l’alleanza del PD con i mercati e con il folle sogno dell’eurocrazia indecorosamente chiamata Europa). Ingiustizia, miseria e storture d’ogni sorta hanno così cessato di essere intese per quello che effettivamente sono, ossia per fisiologici prodotti dell’ordo capitalistico, e hanno preso a essere concepite come conseguenze dell’agire irresponsabile di un singolo individuo. Per la sinistra oggi essere antiberlusconiani è l’alibi per non essere anticapitalisti. Permettendo di riconvertire la passione anticapitalistica in indignazione morale, l’avversione per le regole sistemiche ingiuste in loro difesa a oltranza, l’antiberlusconismo ha, pertanto, svolto una funzione di primo piano nella celere e performativa sostituzione dell’identità precedente della sinistra con una nuova e indecorosa fisionomia, quella dell’adesione cadaverica alle leggi del mercato e del capitale. Se la sinistra smette di interessarsi alla questione sociale e, più in generale, alla galassia di problemi che, con diritto, potrebbero compendiarsi nell’espressione programmatica “ripartire da Marx”, con il ricco arsenale di passioni politiche che in tale figura si cristallizzano, è opportuno smettere di interessarsi alla sinistra. I recenti fenomeni di piazza ne sono l’esempio più tragico: mentre il popolo dei berlusconiani si scontrava con quello degli antiberlusconiani, le sacre leggi del mercato facevano il loro corso, sconvolgendo, ancora una volta, le nostre vite, erodendo i diritti sociali. La situazione è, una volta di più, tragica ma non seria. La prima mossa da compiere per tornare a pensare e a praticare la politica è uscire dal vicolo cieco del conflitto tra berlusconiani e antiberlusconiani.
GLI INNI DEI PARTITI ED I PENTITI DEL PENTAGRAMMA.
Il senso di Bersani per la musica non è mai stato granché felice, scrive Andrea Scanzi su “Il Fatto Quotidiano”. Qualche anno fa scelse Un senso di Vasco Rossi. Il testo recitava: "Voglio trovare un senso a questa storia/ anche se questa storia un senso non ce l'ha". Praticamente la recensione fulminante del Pd. Bersani, tramite Twitter, ha comunicato il nuovo inno. Che, con originalità guizzante, si chiama proprio Inno. È verosimile che, quando Bersani va al ristorante e gli chiedono che vino voglia bere, risponda: "Vino". Una sorta di eccesso didascalico proletario. L'autrice è Gianna Nannini, brava ma non esattamente un portafortuna: nel 1990, con Edoardo Bennato, interpretò Notti magiche per i Mondiali di Italia '90. Non aveva calcolato le uscite di Zenga (e gli Zenga fuori forma, nel centrosinistra, non mancano). Il rapporto tra musica e politica è conflittuale. Ieri Beppe Grillo ha lanciato sul blog l'inno elettorale dei 5 Stelle: L'urlo della rete, uno vale uno, di Leonardo Metalli e Raffaello Di Pietro: "Vita rubata dai cialtroni vestiti da buffoni che mangiano milioni". La destra, non avendo cantori di riferimento a parte Masini, Tony Renis e Umberto Smaila, si affida a rincalzi. Con effetti raggelanti, da Forza Italia a Menomale che Silvio c'è. In confronto, Valerio Scanu è Robert Plant. Ultimamente vanno di moda Mario Vattani, noto statista nazi-rock con un'idea lievemente sbarazzina di democrazia, e Gianluigi Paragone, che da un giorno all'altro si è messo in testa di strimpellare durante L'ultima parola. Le sue cover sono così personali e ad minchiam che, per contrasto, risultano quasi gradevoli. A sinistra, al contrario, l'affiliazione con i cantautori serve anche a ribadire la superiorità culturale. Giorgio Gaber, saccheggiato da chiunque (gli ultimi sono stati Pisapia e Renzi) per lo slogan "Libertà è partecipazione", ironizzava in Destra-sinistra: "Quasi tutte le canzoni son di destra/se annoiano son di sinistra". Difficilmente confutabile, pensando allo stereotipo un po' cimiteriale della canzone d'autore (Cantacronache, Nuovo Canzoniere Italiano, Vecchioni). Il centrosinistra, nel 1996, scelse La canzone popolare di Ivano Fossati. Portò fortuna, anche se il musicista in seguito parve pentirsi: quando gli chiedevano se avrebbe ridato il brano al centrosinistra, reagiva con lo stesso fastidio esibito all'ennesima domanda su La mia banda suona il rock. La seconda vittoria di Prodi, nel 2006, ebbe per colonna sonora Una vita da mediano di Ligabue. Veltroni, da navigato buonista ilare e sempre giovane, due anni dopo optò per Mi fido di te. Una delle canzoni migliori di Jovanotti. Nel 2008 circolò anche una versione tremebonda, ideata da alcuni militanti milanesi, sulla base di Ymca dei Village People (che reagirono malissimo e chiesero i diritti). Purtroppo per Veltroni, gli elettori non si fidarono di lui. È poi celebre il caso di Bettino Craxi. Adorava Viva l'Italia di Francesco De Gregori, al punto da citarne una strofa a Montecitorio: "L'Italia che soffre, che lavora e che resiste". De Gregori non gradì e, nel '92, si vendicò: "È solo il capobanda/ ma sembra un faraone/ si atteggia a Mitterand/ ma è peggio di Nerone". Craxi (e suo figlio Bobo, oggi amico del cantautore) ci rimasero male. Col tempo, De Gregori è diventato più morbido. Nel 2006 ha dichiarato: "Se ripenso a Craxi credo che intellettualmente sia stato superiore a tanti politici attuali". De Gregori conobbe Craxi. Si videro a Trastevere, nell'appartamento di Lucio Dalla (amico del leader Psi). Craxi continuò a chiedere come facesse quella canzone. De Gregori, recalcitrante, prese la chitarra ed eseguì Viva l'Italia. Ai cori, Bettino. Altri tempi. Forse migliori e forse no.
Francesco De Gregori intervistato da Aldo Cazzullo su “Il Corriere della Sera”.
Francesco De Gregori, sono sei anni, da quando in un'intervista al «Corriere» lei demolì la figura allora emergente di Veltroni, che non parla di politica. Che cosa le succede?
«Succede che il mio interesse per la politica è molto scemato. Ha presente il principio fondativo delle rivoluzioni liberali, "no taxation without representation?". Ecco, lo rovescerei: pago le tasse, sono felice di farlo, partecipo al gioco. Però, per favore, tassatemi quanto volete, ma non pretendete di rappresentarmi».
Cos'ha votato alle ultime elezioni?
«Monti alla Camera e Bersani al Senato. Mi pareva che Monti avesse governato in modo consapevole in un momento difficile. Sono contento di com'è andata? No. Oggi non so cosa farei. Probabilmente non voterei. Con questo sistema, tanto vale scegliere i parlamentari sull'elenco del telefono».
Dice questo proprio lei, considerato il cantautore politico per eccellenza? L'autore de «La storia siamo noi», per anni colonna sonora dei congressi della sinistra italiana?
«Continuo a pensarmi di sinistra. Sono nato lì. Sono convinto che vadano tutelate le fasce sociali più deboli, gli immigrati, i giovani che magari oggi nemmeno sanno cos'è il Pd. Sono convinto che bisogna lavorare per rendere i poveri meno poveri, che la ricchezza debba essere redistribuita; anche se non credo che la ricchezza in quanto tale vada punita. E sono a favore della scuola pubblica, delle pari opportunità, della meritocrazia. Tutto questo sta più nell'orizzonte culturale della sinistra che in quello della destra. Ma secondo lei cos'è oggi la sinistra italiana?».
Me lo dica lei, De Gregori.
«È un arco cangiante che va dall'idolatria per le piste ciclabili a un sindacalismo vecchio stampo, novecentesco, a tratti incompatibile con la modernità. Che agita in continuazione i feticci del "politicamente corretto", una moda americana di trent'anni fa, e della "Costituzione più bella del mondo". Che si commuove per lo slow food e poi magari, "en passant", strizza l'occhio ai No Tav per provare a fare scouting con i grillini. Tutto questo non è facile da capire, almeno per me».
Alla fine la sinistra si è alleata con Berlusconi.
«Questo governo non piace a nessuno. Ma credo fosse l'unico possibile. Ringrazio Dio che non si sia fatto un governo con Grillo e magari un referendum per uscire dall'euro. Se poi molti nel Pd volevano governare con Grillo e io non sono d'accordo non è un dramma. Ora il Pd è di moda occuparlo, prendere la tessera per poi stracciarla. Non ne posso più di queste spiritosaggini».
Apprezza Letta?
«Le ho detto che seguo poco. Se mi chiede chi è ministro di cosa, magari non lo so. Quando viaggio compro sei giornali, ma dopo dieci minuti li poso e comincio a guardare fuori dal finestrino...».
Colpa dei giornali o della politica?
«Magari è colpa mia. Mi sento, mischiando Prezzolini e Togliatti, un "inutile apota". Comunque nutro un certo rispetto per il lavoro non facile di Letta e di Alfano. Sono stufo del fatto che, appena si cerca un accordo su una riforma, subito da sinistra si gridi all'"inciucio", al tradimento. Basta con queste sciocchezze. Basta con l'ansia di non avere nemici a sinistra; io ho sempre avuto nemici a sinistra, e non me ne sono mai occupato. Ho votato Pci quando era comunista anche Napolitano. Ma viene il momento in cui la realtà cambia le cose, bisogna distaccarsi da alcune vecchie certezze, lasciare la ciambella di salvataggio ed essere liberi di nuotare, non abbandonando per questo la tua terra d'origine. Non ce la faccio più a sentir recitare la solita solfa "Dì qualcosa di sinistra". Era la bellissima battuta di un vecchio film, non può diventare l'unica bandiera delle anime belle di oggi. Proviamo piuttosto a dire qualcosa di sensato, di importante, di nuovo. Magari scopriremo che è anche di sinistra».
Di Berlusconi cosa pensa?
«Berlusconi è stato fondamentalmente un uomo d'azienda. Nel suo campo e nel suo tempo una persona molto abile, non un vecchio padrone delle ferriere. Ha fatto politica solo per proteggere i suoi interessi, senza avere nessun senso dello Stato, nessun rispetto per le regole e, credo, con alle spalle una scarsa cultura generale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. È imputato di reati gravi e si è difeso dai processi più che nei processi. Che altro vuole sapere? Aveva ragione l'Economist : Berlusconi era inadatto a governare l'Italia. Mi chiedo però anche se l'Italia sia adatta a essere governata da qualcuno».
Un premier non telefona in questura per far liberare un'arrestata dicendo che è la nipote di Mubarak, non crede?
«Certo. Andreotti non si sarebbe mai esposto così. Però, guardi, ho seguito con crescente fastidio e disinteresse l'accanimento sulla sua vita privata. Forse potevamo farci qualche domanda in meno su Noemi e qualcuna di più sull'Ilva di Taranto? Pensare di eliminare Berlusconi per via giudiziaria credo sia stato il più grande errore di questa sinistra. Meglio sarebbe stato elaborare un progetto credibile di riforma della società e competere con lui su temi concreti, invece di gingillarsi a chiamarlo Caimano e coltivare l'ossessione di vederlo in galera. Non condivido nulla dell'etica e dell'estetica berlusconiana, ma mi irrita sentir parlare di "regime berlusconiano": è una falsa rappresentazione, oltre che una mancanza di rispetto per gli oppositori di Castro o di Putin che stanno in carcere. E ho trovato anche ridicolo che si sia appiccicata una lettera scarlatta al sindaco di Firenze per un suo incontro col premier».
Renzi appare l'uomo del futuro.
«Renzi è uno che ha sparigliato. Se il Pd avesse candidato lui probabilmente avrebbe vinto. Ma la scelta del termine rottamazione non mi è mai piaciuta, mi è sempre parsa volgare e violenta. E poi non sono più disposto a seguire nessuno a scatola chiusa».
Quindi non crede in lui? E non voterà alle primarie?
«Il verbo "credere" non dovrebbe appartenere alla politica. Non basta promettere bene e saper comunicare. E poi penso di non votare alle secondarie, si figuri se voterò alle primarie. Il Pd sta passando l'estate a litigare. E magari anche Renzi ne uscirà logorato».
Aveva acceso speranze Grillo e l'idea della rete come veicolo di partecipazione.
«Ho trovato inquietante la campagna di Grillo, il suo modo di essere e di porsi, il rifiuto del confronto, le adunate oceaniche. Condivido i tagli ai costi della politica e la richiesta di moralizzazione che viene da molti e che Grillo ha saputo ben intercettare. Molti elettori e molti eletti del M5S sono sicuramente persone degne e capaci di fare politica. Ma questa idea della Rete come palingenesi e istituzione iperdemocratica mi ricorda i romanzi di Urania».
Con Veltroni avete fatto pace?
«Per quell'intervista mi saltarono addosso in molti, compresi alcuni colleghi cantanti. Qualcuno mi chiese addirittura "Chi ti ha pagato?". Con Veltroni ci siamo incontrati per caso un paio di mesi fa al Salone del Libro a Torino, abbiamo parlato qualche minuto e credo che questo abbia fatto piacere a tutti e due. È sempre una persona molto ricca sul piano umano. Ma non mi andava di essere catalogato tra i Veltroni Boys».
Non c'è proprio nessuno che le piaccia?
«Papa Francesco, la più bella notizia degli ultimi anni. Ma mi piaceva anche Ratzinger. Intellettuale di altissimo livello, all'apparenza nemico del mondo moderno e in realtà avanzatissimo, grande teologo e per questo forse distante dalla gente. Magari i fedeli in piazza San Pietro non lo capivano. Ma il suo discorso di Ratisbona fu un discorso importante».
Oggi non canterebbe più «Viva l'Italia»?
«Al contrario. Sono convinto che l'Italia abbia grandi chance per il futuro. E ogni volta che canto quella canzone sento che ogni parola di quel testo continua ad avere un peso. "L'Italia che resiste", ad esempio; e solo le anime semplici potevano pensare che c'entrasse qualcosa con lo slogan giustizialista "resistere resistere resistere". "L'Italia che si dispera e l'Italia che s'innamora". L'Italia che ogni tanto s'innamora delle persone sbagliate, da Mussolini a Berlusconi. Ma il mio amore per l'Italia, e per gli italiani, non è in discussione. Sono stato berlusconiano solo per trenta secondi in vita mia: quando ho visto i sorrisi di scherno di Merkel e Sarkozy».
Avete presente la storiella del corvo che si lamenta di quant'è nero il merlo? A tanti è venuta in mente ieri leggendo le dichiarazioni di tanti esponenti del Pd dopo che Francesco De Gregori, un'icona storica della sinistra, aveva detto al Corriere: «Non voto più, la mia sinistra si è persa tra slow food e No Tav».
De Gregori si iscrive al club degli artisti delusi dalla sinistra. Il cantante volta le spalle al Pd "perso tra slow food e No Tav", ma raccoglie solo critiche: "Incredibile, sei invecchiato così male", scrive Paolo Giordano su “Il Giornale”. Irritati, gli hanno mandato a dire: «Non possiamo credere che tu sia invecchiato così male». E poi lo hanno rassicurato (minacciosamente): «Conserveremo l'intervista, la ricorderemo come un errore e una critica eccessiva, tenendo a mente che non è da un calcio di rigore sbagliato che si giudica un giocatore». Mamma mia. In realtà il «calcio di rigore» è forse una delle più lucide e dolorose interviste di Francesco De Gregori negli ultimi anni, quello che con Il generale e La storia siamo noi si è conquistato nei decenni il rispetto di un'intera area politica. Parlando con Cazzullo, ha snocciolato tutti i mal di pancia di chi votava a sinistra e ora anche no. La sinistra? «È un arco cangiante che va dall'idolatria per le piste ciclabili a un sindacalismo vecchio stampo a tratti incompatibile con la modernità». Berlusconi? Oltre alle solite precisazioni anti Cav, ha sottolineato che «pensare di eliminarlo per via giudiziaria credo sia stato il più grande errore di questa sinistra». La quale, per intenderci, avrebbe fatto meglio a porsi «qualche domanda in meno su Noemi e qualcuna di più sull'Ilva di Taranto». Probabile che a far rabbrividire i piddini duri e puri siano state frasi come «sono stato berlusconiano solo per trenta secondi in vita mia: quando ho visto i sorrisi di scherno di Merkel e Sarkozy», oppure «trovo ridicolo che si sia appiccicata una lettera scarlatta a Renzi per un suo incontro con Berlusconi» o, infine quel gelido «ho trovato inquietante la campagna di Grillo» proprio poco dopo che il Pd di Bersani ha fatto di tutto per portarselo al governo. Insomma, dopo aver fatto suonare La storia siamo noi a tutti i congressi sin dai tempi della «gioiosa macchina da guerra», ora è la sinistra a farsele suonare dalla propria icona. Oltretutto la base Pd deve pure trangugiare quello che quasi tutti pensano: «Se il Pd avesse candidato Renzi, probabilmente avrebbe vinto». Insomma, la caporetto della salamella. Sarà per questo che le reazioni, specialmente quelle sui social network, sono arrivate al bivio: da una parte gli increduli, dall'altra (più numerosi) quelli che approvavano le parole di un artista nel quale si riconoscono sin dagli anni '70. Di certo, l'enfasi dei commenti legittima lo status di De Gregori ma non la novità delle sue parole. In realtà, seppur autorevolissima, è l'ultima di una sfilza di j'accuse di maestri della musica che parte da quel disco (e spettacolo) Polli d'allevamento di Giorgio Gaber che nel 1978 segnò la sua frattura con il movimento giovanile. Da allora è stato uno stillicidio di cannibalismo: artisti storicamente identificati con la sinistra che ne prendevano drasticamente le distanze, trasformando spesso con il senno del poi il sonno del prima. Nanni Moretti ad esempio. Oppure Francesco Guccini (La locomotiva è un must da lacrimoni di nostalgia per vetero comunisti) che non ha fatto giri di parole quando Prodi è stato trombato nell'ultima corsa al Quirinale. Dopotutto, sul sottile filo che dal disilluso Gino Paoli arriva al De Gregori di oggi, stanno in equilibrio della contestazione a sinistra anche Antonello Venditti («Il Pd è chiuso nel proprio apparato»), Pino Daniele quello che cantava «Questa Lega è una vergogna» e ora dice di «esser deluso dalla sinistra», Giovanni Lindo Ferretti (un genietto nato con un gruppo che si chiamava nientemeno che CCCP) e anche Lorenzo Jovanotti che ha semplicemente detto: «L'opposizione a un vuoto finisce per essere un altro vuoto». Molto bipartisan. Ma molto più doloroso per chi non accetta la cosiddetta autocritica perché, come diceva il pioniere Gaber, è sempre «più comunista degli altri».
Da De Gregori a Guccini: il Pd è rimasto senza voce. De Gregori è solo l'ultimo di una lista di soldati delusi dai generali democratici. Da Guccini a Samuele Bersani, da Jovanotti a Venditti e alla Mannoia: il Pd è rimasto afono, scrive Domenico Ferrara su “Il Giornale”. Il Pd è diventato afono. Le uniche voci rimaste sono quelle degli artisti, pronti a cantare la loro delusione. Sono finiti i tempi dei palchi, delle colonne sonore e del connubio tra musica e politica. Adesso, i democratici sono rimasti senza cantori. Francesco De Gregori è solo l'ultimo di una lista di soldati stufi dell'incapacità dei generali. Non resta che abbandonare il campo. Vuoi perché “la sinistra si è persa tra slow food e No Tav”, vuoi perché le ultime decisioni democratiche hanno fatto traboccare un vaso già pericolante. E così arrivano defezioni che non ti aspetti. Come quella di Francesco Guccini che, all'indomani della pugnalata inflitta dai falchi democratici al suo amico Romano Prodi, arriva a sentenziare affranto: “Non so se il Partito democratico sia ancora il mio partito”. O come quella di Antonello Venditti, che alla vigilia delle amministrative capitoline, suonò note caustiche: “Il Pd non sa che cos’è e che cosa vuole essere, è chiuso nell’apparato, non ascolta e non capisce più Roma”. Pd capoccia. E pensare che nel 2007 il cantautore si diceva convinto che “non credere nel Pd sarebbe come rinnegare me stesso, è la mia storia naturale. Non credo tanto nel partito, penso che il vero partito siamo noi''. Per Samuele Bersani è stato proprio uno spaccacuore. Il cantante riminese non ha avuto remore a esternare tutto il suo malumore davanti al pubblico pagante: “Non mi fido più del Pd, voterò Movimento 5 Stelle”, annunciò prima delle ultime elezioni politiche. Se prima avrebbe affidato le chiavi di casa a Walter Veltroni, adesso Jovanotti al Pd probabilmente non affiderebbe nemmeno un centesimo. “Questo governo fa male all'Italia, un accordo Pd-Pdl non mi sembra rispettoso dell'esito delle elezioni, non mi convince molto”. Cherubini rimane un nostalgico di Veltroni, ma una volta finito il suo progetto, ha dovuto ammettere che “nel Pd sono tornati a galla gli anziani D'Alema, Bersani, Bindi. Li rispetto, ma non si va da nessuna parte con loro”. Adesso non gli resta che puntare su Renzi, sperando di non rimanere l'unico a cantare: "Mi fido di te". Fiorella Mannoia, in tempi non sospetti, ha fatto coming out preferendo Ingroia: “Non ho votato Pd e non sono pentita. Sono di sinistra. È per questo che non li ho votati". Quelle che le donne dicono... L'ultima cantante che ha espresso parole positive nei confronti di un esponente del Pd è stata Gianna Nannini: “Complimenti per la scelta! Finalmente qualcuno che si intende di musica! Inno è il pezzo più bello che ho scritto negli ultimi 20 anni!”, disse la cantante commentando la scelta di Pier Luigi Bersani della nuova colonna sonora del Pd. Adesso il segretario è Epifani e quella musica non ha portato molto bene.
ED I 5 STELLE...STORIE DI IGNORANZA.
La sgangherata pattuglia pentastellata non conosce nemmeno il nome dei suoi eroi. La consueta gaffe, questa volta, ce la regala il senatore grillino Nicola Morra, capogruppo a Palazzo Madama. Prende la parola in aula, e nello sventolio di agendine rosse dei movimentisti seduti attorno a lui, ricorda la strage di via D'Amelio. Così Morra: "Dobbiamo ricordare Salvatore Borsellino...". Tra i suoi compagni di "movimento" nessuno dice una parola, nell'emiciclo si leva una voce: "Non sa nemmeno come si chiama...". Quindi prende la parola il presidente di Palazzo Madama, Pietro Grasso, che riprende Morra: "Stiamo ricordano Paolo, perché non credo proprio che Salvatore Borsellino sia nelle condizione di essere ricordato". Salvatore, infatti, è il fratello. Vivo e vegeto. Grillini, analfabeti parlamentari: "Non capiamo che cosa votiamo" Che autogol in diretta streaming...I senatori a 5 Stelle si coprono di ridicolo nella loro assemblea: "Emendamenti incomprensibili, qualcuno ce li traduca". Però incolpano gli altri partiti, scrive Franco Bechis su “Libero Quotidiano”. Per giorni e giorni fra marzo e aprile avevano tuonato contro la mancata costituzione delle commissioni parlamentari perché così non li facevano lavorare. Ora dopo quattro mesi di lavoro in commissione il Movimento 5 stelle scopre di annegare in quel lavoro che gran parte dei suoi eletti non sanno fare. La gran confusione e l’esteso dilettantismo è emerso durante la riunione (parzialmente trasmessa in streaming) del gruppo parlamentare al Senato giovedì 25 luglio. A sorpresa la conduzione dell’assemblea è stata affidata a Maurizio Buccarella e non al capogruppo pro-tempore Nicola Morra, che pure gli sedeva a fianco silente. A illustrare l’imbuto in cui il movimento si è infilato è stato invece Maurizio Santangelo, il senatore che si è ritagliato un po’ di notorietà a palazzo Madama perché ogni cinque minuti interrompe la seduta per chiedere la votazione elettronica. Santangelo si è lamentato della scarsa incidenza dei parlamentari del movimento, che spesso fanno lunghi interventi «anche di qualità», che però nessuno ascolta. Forse è meglio - ha sostenuto - utilizzare più delle parole gli emendamenti per migliorare i provvedimenti presentati dal governo e della maggioranza. Ed è qui che è nato lo psicodramma interno al gruppo. A prendere la parola è stata infatti la catanese Ornella Bertorotta, membro della commissione bilancio del Senato: «A proposito di emendamenti», ha esordito, «esco un attimo dal tecnicismo per dire che nella commissione bilancio abbiamo molta difficoltà a difendere i nostri emendamenti, perché proprio non li capiamo». Scritti - come quasi tutte le leggi che si vorrebbero cambiare in modo incomprensibile. «Ci vuole tutto uno studio», ha sostenuto la Bertorotta, «per capire il linguaggio giuridico, e con i tempi che abbiamo non ce le facciamo. Forse potremmo approfittare delle nostre segretarie perché prendano appunti da chi conosce le cose e poi redigano una spiegazione in calce ad ogni emendamento». Semplifica Laura Bignami: «Sì, anche io ho questa impressione: che non capiscono i nostri emendamenti e quindi poi non riescono a difenderli». Di fronte allo smarrimento di gran parte dei senatori a Cinque stelle, va diretto un altro membro della commissione Bilancio, Elisa Bulgarelli: «Guardate, gli emendamenti debbono passare tutti in bilancio. Quando arrivano sono veramente molto tecnici, e non solo a livello giuridico. Gli ultimi che venivano dalla commissione Lavoro erano scritti in modo del tutto incomprensibile. Così non siamo riusciti a difenderli: non capendoli non sapevamo che argomenti trovare con gli altri». Qualcuno fa osservare che gli ultimi emendamenti inviati avevano la loro spiegazione allegata, e la Bulgarelli scuote la testa: «Non dovete scriverci spiegazioni che sono identiche al testo incomprensibile perché ovviamente non capiamo nemmeno quelle». Ai Cinque stelle puoi dire di tutto, salvo che lavorano male. Perché sono molto fieri del proprio presunto sapere e pontificano su tutto. Quindi di fronte alle critiche si offendono. E rigirano la frittata. L’ha fatto subito lo stesso Santangelo: «Loro hanno certo ragione. Però questa problematica nasce dal fatto che il governo e questa maggioranza mettono dei decreti omnibus in cui ci sono delle cose complicatissime e c’è sempre poco tempo per capire e trovare soluzioni. Ecco: quando parliamo di ostruzionismo il vero ostruzionismo è quello che si sta facendo nei confronti dell’unica forza politica nuova, che è la nostra: il Movimento 5 stelle. Noi ancora non siamo pratici, abbiamo bisogno di un po’ di tempo...». Ribaltando la frittata, Santangelo sostiene che «ad esempio nel decreto Iva sia Pd che Pdl avevano presentato molti emendamenti di buon senso che avremmo votato. Appena l’hanno capito hanno fatto ostruzionismo contro noi, decidendo di ritirare tutti gli emendamenti». Siamo alla fantasia più sfrenata. Che nasconde una sola verità, poi ammessa nella riunione: «Dobbiamo imparare e farci furbi. Basterebbe essere un po’ più veloci e presentare emendamenti nostri anche all’ultimo, con la firma di otto senatori. Quelli non li possono ritirare…». E il grande complotto alla fine diventò un auto complotto.
ED I LIBERALI? SOLO A PAROLE.
Liberali? Solo a parole, scrive Nicola Porro su “Il Giornale”. C’è chi confonde l’idea liberale con un’ideologia: un set di regole precise e immutabili. Un dogma. Il fascino liberale è che esso, piuttosto, è un metodo. Prendiamo il caso delle sigarette e del maldestro tentativo governativo (poi annacquato) di vietarne l’uso in auto in presenza di minori. È l’apoteosi dello statalismo. Cioè l’esatto contrario del metodo liberale. La religione di Stato (in alcuni paesi basta togliere il predicato) decide cosa sia buono e giusto per il singolo, usurpando il libero arbitrio. La «violenza» dell’imposizione statuale detta un comportamento o uno stile di vita, che, se non rispettato, procura sanzioni. Molti considereranno la questione delle sigarette una bazzecola. Ma dietro questa pensata c’è un’ideologia pericolosa e che pervade le nostre istituzioni. Che banalmente si può riassumere così: c’è un gruppo di persone (politici e burocrati) da noi retribuite che pretendono di sapere cosa sia meglio per noi. Una roba da far accapponare la pelle. La libertà è pericolosa. È pericoloso aprire un’azienda, è pericoloso concepire un figlio, è pericoloso pensare diversamente, è pericoloso mangiare, bere e fumare. Ma è molto più pericoloso che qualcuno decida per noi riguardo questi affari. Un effetto collaterale di questo diffuso cancro ideologico è la deresponsabilizzazione che provoca dell’individuo. Ci conformiamo alla legge non perché ne siamo convinti, ma perché la trasgressione è punita. In un recente libro dell’istituto Bruno Leoni (Breve storia della libertà) si ricorda l’esperimento psicologico di Milgram. La facciamo breve: i cittadini possono diventare carnefici del prossimo, pur non volendolo, solo perché l’Autorità lo richiede e solo grazie alla pulizia della coscienza che ci fornisce un meccanismo di deresponsabilizzazione. In quanti casi un funzionario pubblico può devastare una vita, una storia, un’impresa solo imponendo il rispetto di una norma? Un ultimo suggerimento non richiesto alla componente governativa che si rifà al centrodestra. E che per di più si dice voglia ritornare allo spirito originale di Forza Italia. Libertà civili e libertà economiche sono strettamente connesse, come insegnava Einaudi, e fare i furbetti sulle prime, rende meno credibili le battaglie sulle seconde.
POPULISTA A CHI?!?
Tutti contro il «populismo» Chi ha detto che è un insulto? Da un trentennio è il nuovo "spettro" che ossessiona il mondo. Ma far coincidere questo fenomeno con l'antipolitica è un errore...scrive Stenio Solinas su “Il Giornale”. Se il populismo sia un'ideologia, uno stile politico, una mentalità, o le tre cose insieme, è difficile dire. Negli anni Sessanta, Isahia Berlin parlò in proposito di «complesso di Cenerentola», ovvero la difficoltà/frustrazione degli addetti ai lavori nel non riuscire a trovare nella pratica politica ciò che nella teoria politologica veniva di volta in volta configurato. Certo è che, da un trentennio a questa parte, esso ha preso il posto del comunismo quale «spettro» destinato a ossessionare il mondo. È uno degli effetti, il più vistoso, del disincanto verso le democrazie occidentali, e insieme il più virtuoso. La fine del Novecento ha portato con sé la fine delle passioni ideologiche proprie dei totalitarismi e ogni nostalgia paternalistico-autoritaria, facendo emergere una linea critica interna alla democrazia stessa nella quale è il popolo, appunto, la radice, il soggetto e il fine ultimo del modello democratico, la ragion d'essere che ne legittima la superiorità rispetto agli altri modelli politici. Ce lo siamo forse dimenticati, ma si governa, meglio, si dovrebbe governare, in nome del popolo, per il popolo, da parte del popolo. Al populismo ha ultimamente dedicato un interessante dossier monografico, Cos'è il populismo, la rivista Diorama (n° 313, 3 euro; casella postale 1.292, 50122 Firenze), ed è curioso come un fenomeno di per sé trasversale, presente cioè a destra come a sinistra e ormai oggetto di una robusta produzione scientifica, faccia fatica a imporsi nel dibattito corrente delle idee, se non come insulto banale, metafora di pura e semplice demagogia, ennesima variante di quelle parole-talismano atte a dequalificare l'avversario. È come se, una volta legata strettamente la democrazia ai suoi meccanismi di delega e di rappresentanza, si preferisca vederla strangolata loro tramite, invece di valutare quanto e come le istanze di partecipazione diretta alla gestione del potere potrebbero farla meglio respirare. Alla base di questa contraddizione c'è un combinato disposto che ha a che fare, da un lato, con il discredito della classe politica nella sua totalità, dall'altro con la sua distanza dalla propria fonte legittimante, l'elettorato, ovvero il popolo. È un problema che riguarda tutti gli attori politici presenti, ma che, nel campo delle idee, della formazione del consenso e delle mentalità, incide più profondamente a sinistra di quanto non faccia a destra, e vale la pena approfondire il perché. Abbandonate le speranze messianiche riposte nella classe operaia, i suoi intellettuali e le sue élites politiche si sono convertite all'economia di mercato e alla «marginalità» degli interessi da difendere. I «people» hanno insomma preso il posto del popolo, con tutto il loro corteo di «politicamente corretto», «diritti delle minoranze», «omoparentalità», arte d'avanguardia, «discorso sui generi», fobie corporali, sorveglianza/penalizzazione del comportamento altrui... Stabilito che il popolo «pensava male» lo si è per certi versi ripudiato, infliggendo a chi si sentiva minacciato dalla disoccupazione, l'insicurezza economica e sociale, la perdita di status e di identità, il moralismo proprio di una nuova classe globalizzata che essendo parte integrante del sistema agisce sulla base dei propri privilegi e non dei bisogni altrui. Il corollario finale di questo modo d'essere e di pensare è che, se non ci fosse il popolo, non ci sarebbe il populismo...Il fatto è, come ben spiega il fascicolo di Diorama citando L'eloge du populisme di Vincent Coussédiere, «non vi è politica senza popolo, né popolo senza politica. Lo stare insieme populista è il reagire al posto vuoto della direzione politica. Corrisponde a quel momento della vita delle democrazie in cui il popolo si mette a malincuore a fare politica, perché dispera dell'atteggiamento dei governanti che non ne fanno più». È anche per questo che associare il populismo all'antipolitica è fuorviante. Come nota Marco Tarchi, che di Diorama è il direttore, «per quanto i populisti siano spinti dall'impazienza e dal culto della semplificazione a diffidare della politica e a dipingerla come un luogo dove regnano pigrizia, corruzione e parassitismo, essi non rifuggono dal misurarsi con i concorrenti sul piano della conquista del consenso e delle leve del potere. Ogni volta che si cimenta sul piano della competizione istituzionalizzata con altri soggetti, a partire dalla partecipazione alle elezioni, la loro è un'azione squisitamente politica». Certo, il populismo può anche incarnare una «corruzione ideologica della democrazia» - come nota ancora su Diorama Pierre-André Taguieff - ma «nel contempo esprime un'esigenza di democrazia partecipativa e di cittadinanza attiva che il sistema funzionale ben temperato della democrazia rappresentativa non è capace di soddisfare». Così, il populismo è l'ombra della democrazia, nel senso di proiezione e riaffermazione legittimante della volontà dei cittadini, ma è anche il fantasma che la accompagna e la ossessiona, stimolo e insieme minaccia... È molte cose, dunque, tranne che un insulto o un anatema.
Nonostante che costino tanto alla collettività, per ricevere niente in cambio, ti ritrovi a parlare di queste cose.
TUTTI UGUALI.
Il prefetto La Motta arrestato insieme ad altre 3 persone. L'inchiesta capitolina riguarda la gestione dei Fondi del Viminale: le accuse sono di peculato e falsità ideologica. Un'inchiesta parallela a Napoli lo vede indagato per associazione a delinquere e rivelazione del segreto d'ufficio, scrive Maria Elena Vincenzi su “La Repubblica”. Peculato e falsità ideologica. Con queste accuse sono stati arrestati dai carabinieri del Ros stamattina il prefetto Francesco La Motta e l'ex banchiere Klaus George Beherend. Altre due ordinanze di custodia in carcere sono state notificate ai broker Edoardo Tartaglia e Rocco Zullino, già arrestati dalla procura di Napoli. Ed è proprio dalla Campania che sono arrivati gli atti ai Pm romani: la vicenda dei soldi rubati dalle casse del Viminale attraverso il Fec (fondo per gli edifici di culto attraverso il quale il ministero dell'Interno gestisce un enorme patrimonio artistico) era di competenza della capitale. Il Pm Paolo Ielo e i militari hanno continuato le indagini e accertato che, grazie a La Motta, direttore del Fec dal 2003 al 2006 quando è stato nominato vice direttore di quello che ora è l'Aisi, sarebbero spariti nel nulla circa 10 milioni di euro, transitati su conti svizzeri. La Motta avrebbe affidato l'investimento a Zullino, collaboratore di Tartaglia, a sua volta parente di La Motta. Per quanto riguarda la posizione del banchiere Beherend, secondo i Ros e i carabinieri di Napoli che stanno svolgendo le indagini, è colui che avrebbe redatto i piani di investimento dei Fondi in collegamento con Tartaglia. Stamattina all'alba, gli arresti. Ma La Motta è indagato anche in un'inchiesta parallela condotta dalla Direzione antimafia della Procura di Napoli per associazione per delinquere e rivelazione di segreto di ufficio, sulla base di dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Secondo un pentito, avrebbe offerto coperture a imprenditori e fornito informazioni sulle indagini in corso, nonche' tentato di ostacolare le inchieste ''silurando'' un magistrato della Procura. L'indagine, svolta dal procuratore aggiunto Melillo e dai pm Ardituro e Del Gaudio, riguarda in particolare l'attività di riciclaggio del clan Polverino, una potente organizzazione camorristica attiva nell'hinterland settentrionale di Napoli.
La banda del Viminale è finita agli arresti la mattina del 14 giugno 2013, scrive Massimo Martinelli su “Il Messaggero”, quando le indagini dei carabinieri del Ros di Roma hanno consentito di mettere in fila tutti i tasselli utili a sostenere la responsabilità concreta di Francesco La Motta, prefetto di prima classe del Viminale e già vice capo dei servizi segreti civili, nella presunta sottrazione di dieci milioni di euro dal fondo del ministero dell'Interno alimentato con il patrimonio sterminato dei beni degli enti religiosi disciolti. Con lui è stato condotto in carcere il banchiere svizzero Klaus Georg Beherend, mentre analoghi provvedimenti di custodia cautelare, per gli stessi reati contestati a La Motta, cioè il peculato e il falso, sono stati notificati a due broker già detenuti a Napoli per aver intrattenuto rapporti finanziari e aver riciclato denaro per il clan Polverino. Si tratta di un intermediatore finanziario parente di La Motta, Eduardo Tartaglia; e di Rocco Zullino, cittadino svizzero nato in Francia, al vertice della banca Hottinger et Associés di Lugano, che è quella dove sarebbero transitati i dieci milioni di euro sottratti al Fec, il Fondo per i disciolti Enti di Culto. L'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Massimo Di Lauro, ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero Paolo Ielo, che nelle scorse settimane aveva raccolto importanti riscontri sulle sospette operazioni finanziarie di La Motta e dei suoi sodale e anche sui tentativi di ottenere “coperture” coinvolgendo alti funzionari dello Stato. Quest'ultima circostanza, in particolare, risulta da alcune intercettazioni telefoniche tra La Motta e Zullino. Mentre a inchiodare lo stesso Francesco La Motta alle sue presunte responsabilità c'è anche la testimonianza di Lucia di Maro, attuale Direttore Centrale del Fec, la quale, si legge nell'ordinanza: “interpellata sul punto lo scorso 3 giugno anche in relazione ai contratti di gestione con le altre banche ha testualmente dichiarato: Domanda: Gli investimenti effettuati dal Fec riconoscevano tutti autonomia di gestione, ossia un mandato fiduciario a gestire il portafoglio? Risposta: No, l'unico caso è stato quello a favore della Hottinger, o meglio, a favore dello Zullino, che era legittimato ad operare sul conto aperto presso la Hottinger”. E ancora, nell'ordinanza si racconta come La Motta e Zullino abbiano di fatto creato una banca ad hoc scegliendo un nome che poteva ingenerare confusione, solo per svuotare le casse del Fec: “Ma vi è una coincidenza ancor più inquietante: se è vero che l'Hottinger & Group è un istituto di credito svizzero fondato nel 1786 e presente in 10 paesi, nella relazione della commissione viene evidenziato che la mandataria Hottinger et Associes, si è costituita nel 2004 cioè appena l'anno dopo la decisione del FEC di contattare istituti di credito per investire il proprio patrimonio. Non appare affatto inverosimile che la predetta società, riconducibile a Zullino, soggetto in stabili rapporti con la criminalità organizzata campana,sia stata costituita al precipuo scopo di gestire anche il patrimonio del Fec”. Anche da queste dichiarazioni, il gip Di Lauro deduce che “Gli investimenti sono stati effettuati con un meccanismo assai complesso e poco trasparente che non prevedeva assolutamente il deposito degli utili nel c/ c infruttifero acceso presso la tesoreria centrale. Non è mai stata acquisita periodicamente una precisa rendicontazione. La qualificazione giuridica del fatto come peculato appare corretta”. Anche perchè, prosegue il documento: “Le altre quattro banche che avevano in deposito il patrimonio del Fec hanno investito gran parte di questo in titoli governativi, a differenza della banca svizzera a cui sin dall'instaurazione del rapporto era stato consentito di effettuare investimenti ad alto rischio”.
PARLIAMO DI BUROCRAZIA INOSSIDABILE: CHI DETIENE LE LEVE DEL POTERE?
Burocrazia [bu-ro-cra-zì-a] s.f. (pl. -zìe).
1 Organizzazione statale nella quale lo svolgimento dell'attività, spec. amministrativa, è affidato a enti che agiscono nel rispetto dei regolamenti. L'insieme degli uffici e dei funzionari della pubblica amministrazione: b. statale, regionale; l'organizzazione e le pratiche cui costringe, spesso con valore spreg.: c'è tanta b.
2 spreg. Esagerata e pedantesca osservanza dei regolamenti e delle forme procedurali, spec. nello svolgimento di pratiche amministrative.
3 Complesso dei pubblici impiegati.
Con il termine burocrazia si intende l'organizzazione di persone e risorse destinate alla realizzazione di un fine collettivo secondo criteri di razionalità, imparzialità, impersonalità. Il concetto fu definito in maniera sistematica da M. Weber nella sua opera "Economia e società", il quale considerò la struttura burocratica come espressione ed effetto dei processi di razionalizzazione e specializzazione delle comunità moderne nelle quali si sviluppa una relazione di subordinazione fra i cittadini e i pubblici funzionari, che conquistano la legittimità dell’esercizio del potere per la razionalità tecnica con la quale svolgono il loro operato. L'organizzazione burocratica costituirebbe così un momento fondamentale in questa legittimazione. L'etimologia ibrida del termine, dal francese bureau (ufficio) connesso al greco krátos (potere), ne rivela d’altronde l'origine moderna. Il termine burocrazia si riferisce dunque al "potere degli uffici", ad una forma di esercizio del potere che si struttura intorno a regole impersonali ed astratte, procedimenti, ruoli definiti una volta per tutte e immodificabili dall'individuo che ricopre temporaneamente una funzione. Regole, aspettative e ruoli che sono tutte parti di quell’etica burocratica al quale ogni membro di una burocrazia adegua la sua condotta, spersonalizzando il suo agire e imponendo una regolazione etero-diretta al proprio comportamento. Altri elementi della burocrazia sono: la divisione del lavoro in una sequenza di azioni limitate entro una struttura gerarchica, il principio di responsabilità delle competenze, la remunerazione degli impiegati con uno stipendio e, infine, la distinzione tra ufficio e suo detentore.
Secondo Max Weber, uno dei teorici classici della burocrazia, forma di organizzazione basata sul principio della competenza (divisione del lavoro), della gerarchia degli uffici, della conformità degli atti a criteri prefissati e della qualificazione tecnica quale unico requisito per l'impiego. I primi studi dal punto di vista economico sulla burocrazia risalgono agli anni Settanta quando autori statunitensi, rifiutando radicalmente la concezione di Weber, hanno tentato di spiegare il comportamento delle organizzazioni pubbliche giungendo alla conclusione che il funzionario pubblico tende ad incrementare il budget a propria disposizione. Se, seguendo Niskanen e Downs (i maggiori esponenti della teoria), si suppone che i burocrati non si comportino diversamente da ogni altro individuo, e che quindi cerchino di massimizzare la propria utilità, è ragionevole supporre che essi, più che astratti doveri (quali il perseguimento dell'interesse pubblico, l'efficienza ecc.) cerchino di soddisfare propri interessi (prestigio, potere, autonomia decisionale, numero di sottoposti, quantità di risorse da gestire). Ciò significa che essi tenderanno a massimizzare le dimensioni del bilancio sotto il proprio controllo. Il comportamento individualista dei burocrati genererebbe:
— eccessiva dimensione degli uffici e della produzione;
— inefficienza allocativa.
Ciò è spiegabile attraverso la considerazione che i funzionari pubblici godono di una posizione di monopolio informativo. Essi, infatti, sono i soli a conoscere l'effettivo fabbisogno finanziario e dimensionale degli uffici. Quest'ultimo dipenderebbe, secondo Niskanen, proprio dagli argomenti della funzione di utilità dei burocrati, e cioè da tutti i vantaggi non monetari, i quali aumentano al crescere delle dimensioni dell'ufficio. La burocrazia costituisce, dunque, una delle cause per cui le imprese pubbliche hanno un'efficienza X minore delle imprese private.
Compito dei burocrati sarebbe pure quello di snellire le pratiche, ma, salvo lodevolissime eccezioni, si comportano all’opposto, riescono a complicare anche le cose più semplici. Si provi, per esempio, a chiedere il semplicissimo permesso per tinteggiare la casa, ebbene anche in tal caso, questi riusciranno a mettersi di “traverso”. Trovo difficoltà nel capire il loro maldestro comportamento, c’è chi dice che si tratta della vendetta dei mediocri, sui capaci.
Ma chi sono i burocrati? Di loro si sa poco, si sa solo che molti si sono “imboscati” in una “selva” di sportelli, che il volenteroso, pratica alla mano, dovrà obbligatoriamente rivolgersi per elemosinare gli indispensabili timbri. Siamo nel ridicolo, ci troviamo in piena era della telematica, ma la burocrazia italiana è ancora ferma nel Medioevo. I danni creati dai burocrati all’economia, non sono facilmente quantificabili, se la legislazione italiana considerasse reato il “frenare il progresso”, alcuni di loro potrebbero essere penalmente puniti.
La riforma burocratica è una delle “vere emergenze”, ma considerato che solo i burocrati sono in grado di farla, tale riforma non sarà mai fatta, e conseguentemente non sarà possibile fare le altre.
AFORISMI.
Burocrazia. Un gigantesco meccanismo azionato da pigmei. Honoré de Balzac (Fonte sconosciuta).
Legge di Murphy sulle burocrazie. Se qualcosa può andar male, lo farà in triplice copia. Arthur Bloch, Il terzo libro di Murphy, 1982.
La menzione delle noie burocratiche tra i motivi che giustificano il suicidio, mi sembra la cosa più profonda che Amleto abbia detto. Emil Cioran, Sillogismi dell'amarezza, 1952.
Una delle radici della cattiva amministrazione, della burocratizzazione intesa in senso deteriore, consiste proprio nella pretesa di molti cattivi funzionari di limitarsi ad "applicare" le norme: essi così facendo esercitano la loro discrezionalità in maniera non consapevole e comunque non orientata alla risoluzione dei problemi che sono appunto di competenza dell'amministrazione e sono la ragione stessa della sua esistenza, bensì orientata unicamente all'illusorio e mistificante adempimento delle disposizioni ricevute dall'alto. Massimo Corsale, L'autunno del Leviatano, 1998.
Un'organizzazione burocratica è un'organizzazione che non arriva a correggersi in funzione dei propri errori. Michel Crozier, Il fenomeno burocratico, 1964.
Scopo della burocrazia è di condurre gli affari dello Stato nella peggior possibile maniera e nel più lungo tempo possibile. Carlo Dossi, Note azzurre, 1870/1907 (postumo 1912/64).
Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l'assenza del modulo H. Conclude che passerà il progetto, per un sollecito esame, all'ufficio competente, che sta creando. Ennio Flaiano, Diario notturno, 1956.
Più burocratica è un'organizzazione, più grande è la misura in cui il lavoro inutile tende a rimpiazzare il lavoro utile. Milton e Rose Friedman, Liberi di scegliere, 1980.
I ceppi dell'umanità tormentata sono fatti di carta bollata. Franz Kafka, in Gustav Janouch, Colloqui con Kafka, 1951.
La burocrazia è lo Stato immaginario accanto allo Stato reale, è lo spiritualismo dello Stato. Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, (Postumo, 1932).
L'unica cosa che ci salva dalla burocrazia è l'inefficienza. Una burocrazia efficiente è la più grande minaccia alla libertà. Eugene McCarthy, su Time magazine, 1979.
Ciò che la gente rifiuta non è la burocrazia come tale, quanto piuttosto l'intrusione di essa in tutte le sfere della vita e delle attività umane. Ludwig von Mises, Burocrazia, 1944.
Burocrazia − una difficoltà per ogni soluzione. Herbert Samuel (attribuito - Fonte sconosciuta).
Vi sono in cielo e in terra assai più cose di quante ne sogni la vostra burocrazia. Giovanni Soriano, Finché c'è vita non c'è speranza, 2010.
Burocrazia. L'incapacità addestrata. Thorstein Veblen (Fonte sconosciuta).
La stupidità della burocrazia. Devo confessare che quando si tratta di burocrazia non riesco a liberarmi da un certo astio personale, scrive Giancarlo Livraghi sul suo libro “Il Potere della Stupidità” . Ci sono cose più gravi e più preoccupanti dell’assillante stupidità della burocrazia. Ma poche sono così fastidiose, così balorde, così esasperanti e quotidianamente persecutorie come l’ottusità burocratica. Franz Kafka ne aveva fatto un’efficace, quanto deprimente, descrizione novant’anni fa. Ma da allora le cose non sono migliorate. La cronica e ostinata stupidità della burocrazia non è solo squallidamente “kafkiana”. È una variante particolare della stupidità del potere – con tutte le caratteristiche di cui si è parlato nel capitolo 10, ma con qualche perversità in più. Produce talvolta risultati drammatici o catastrofici. Ma anche quando ha effetti meno disastrosi è una snervante persecuzione che ci costringe spesso a ogni sorta di comportamenti assurdi, incomprensibili e fastidiosamente irritanti. Il problema, alla radice, è che la burocrazia ha una tendenza, difficilmente eliminabile, a soddisfare i propri ottusi meccanismi a scapito della generale utilità. Ed è estremamente conservatrice. Tende a riprodurre continuamente i suoi metodi, anche quando sono inutili o nocivi, come se fossero necessità inderogabili e impenetrabili a ogni considerazione di praticità e di buon senso. Si comporta come quei parassiti stupidi che continuano a seguire le proprie logiche ciecamente ed “egoisticamente” evolutive – e perversamente invasive – anche quando, così facendo, rischiano di distruggere l’ospite e perciò anche se stessi. Il noto apologo dello scorpione e della rana è un’efficace sintesi di uno dei modi in cui funziona la stupidità. Sono online alcune osservazioni su questo argomento. In altre parole – la burocrazia, portata alle sue estreme conseguenze, diventa una malattia terminale di ogni comunità umana. Ma la soluzione, purtroppo, non può essere estirparla radicalmente, perché una chirurgia così drastica metterebbe a rischio molte parti sane della società che dipendono, loro malgrado, dal funzionamento della burocrazia. Come il potere, anche la burocrazia non si può eliminare del tutto. Ci vuole qualcuno che controlli, che verifichi, che tenga nota, con tutta la necessaria pignoleria – e anche con un certo rigore formale. Ma solo una piccola parte delle enormi risorse impegnate in ogni sorta di apparati burocratici svolge efficacemente questo compito. Siamo abituati a pensare che l’Italia abbia una delle peggiori burocrazie del mondo. Purtroppo è vero – anche se, guardandoci un po’ intorno, possiamo constatare che nel resto del mondo i malanni burocratici non mancano. Siamo anche abituati a pensare che il peso della burocrazia si faccia sentire solo negli apparati pubblici, ma non è così: ci sono gravi sindromi burocratiche anche in molte imprese private. Uno dei problemi è che siamo troppo “rassegnati”. Non solo perché ci sottomettiamo troppo facilmente alle prepotenze della burocrazia. Ma anche perché, in una congerie di regole confuse e contrastanti, la trasgressione è considerata normale. Si comincia con l’accettare che sia necessario violare qualche regola assurda, con la speranza di non essere mai colti in fallo – o contando sul fatto che, se saremo scoperti, le conseguenze non saranno molto più pesanti delle mostruose procedure che abbiamo evitato. E così, un po’ per volta, si arriva a credere che si possano trasgredire tutte le regole, comprese quelle della correttezza, dell’onestà e della convivenza civile. C’è, in pratica, una sostanziale e pericolosa alleanza fra un eccesso di burocrazia e una proliferazione di comportamenti che vanno dalla piccola scorrettezza alla grande criminalità. Non tutti i burocrati sono sciocchi, arroganti, ignoranti o stupidi. Ho conosciuto varie persone in tutti i livelli della burocrazia – dall’addetto a uno sportello fino al direttore di un grande apparato – che sono intelligenti, umane, attente, comprensive, perfino simpatiche. Ma le loro descrizioni di come funzionano i sistemi in cui lavorano hanno aumentato le mie preoccupazioni sull’andamento generale della burocrazia. C’è qualcosa di eroico in alcune persone che svolgono bene il loro lavoro nonostante l’ambiente in cui si trovano. Come, per esempio, insegnanti che cercano davvero di insegnare – in un sistema scolastico orientato a tutt’altre priorità. Per quanto strano possa sembrare, la burocrazia può essere usata bene. Un sistema di regole ben concepite, e applicate con buon senso, può servire a fare chiarezza, ad attenuare i contrasti, a trovare un giusto equilibrio fra le libertà personali e il benessere collettivo. Il vero problema non è, in assoluto, l’esistenza della burocrazia, ma il fatto che ce n’è troppa – e che funziona quasi sempre male. Ci vorrebbe una terapia che trasformasse la stupidità della burocrazia in intelligenza. In teoria è facile: basta un’energica somministrazione di buon senso, con un po’ di spirito di servizio e responsabilità civile, continuata con dosi pesanti e ostinata perseveranza fino a completa guarigione. Ma in pratica l’impresa è estremamente difficile. Se qualcuno troverà una cura efficace, e saprà come applicarla, meriterà la gratitudine di tutto il genere umano – o almeno di quelle fortunate parti del mondo in cui la sua terapia avrà avuto effetto.
La burocrazia nella Roma antica.
Dal punto di vista storico, tuttavia, l'introduzione sistematica di un sistema amministrativo suddiviso in numerosi uffici e basato su procedure in qualche modo unificate risale addirittura all'imperatore Claudio nel I secolo d.C. - una sostanziale novità rispetto al tradizionale accentramento del potere politico nelle mani del Senato, conseguenza inevitabile di un progressivo svuotamento dei poteri di quest'ultimo. L'interposizione di un corpus di funzionari, seppure inizialmente legati in modo strettissimo al potere imperiale, come intermediario tra il potere e la società romana rappresentò una vera rivoluzione concettuale. Claudio affidò arbitrariamente i vari uffici ai suoi liberti, i cui nomi (Pallante, Narcisso, Callisto) sono ancor oggi sinonimo di corruttela, arbitrio, intrallazzo, cospirazione, finanche omicidio: ben lontani dunque dall'idealizzazione impersonale di rettitudine elaborata molti secoli più tardi. Questi burocrati ante litteram, designati direttamente dall'Imperatore, secondo Tacito nei suoi Annales: "esercitavano poteri regali con animo di schiavi". L'articolazione e l'importanza della burocrazia continuarono a crescere ed espandersi in epoca imperiale, di pari passo con il potere ed il peso politico dei burocrati: un potere formalmente limitato e subordinato a quello imperiale, ma estremamente frammentato, praticamente vitalizio e continuamente espanso nelle sue prerogative da una ininterrotta proliferazione di leggi e regolamenti (in gran parte confluiti nel Corpus Iuris). Questo modo di procedere divenne un tratto peculiare dell'impero bizantino e del suo complicatissimo cerimoniale: ancora oggi, infatti, il termine bizantinismo come sinonimo di astrusità, cavillosità, pedanteria, tortuosità è utilizzato quasi esclusivamente in riferimento alla burocrazia ed alle sue procedure.
La burocrazia in epoca moderna.
In epoca moderna l'introduzione sistematica di una burocrazia rigidamente organizzata risale all'epoca della costituzione dei primi Stati nazionali, con un ruolo di primo piano ricoperto da Napoleone Bonaparte. Napoleone riuscì a realizzare un apparato burocratico estremamente accentrato, fondato sulla funzione dei prefetti, per nulla pachidermico, anzi snello e ben funzionante; tant'è che dopo la restaurazione alcuni governi tentarono di imitarne il funzionamento, in testa a tutti la Casa Savoia, senza però riuscirvi del tutto.
Burocrazia come apparato dell'amministrazione statale moderna. Il termine fu coniato verso la metà del XVIII secolo, quando ormai era concluso in tutta l'Europa occidentale il processo di costruzione dello stato moderno, segnato dalla formazione di apparati di ufficiali e funzionari. Ma già dalla fine del secolo XVI si era venuta elaborando una teoria dello "stato burocratico" che ebbe in J. Bodin il suo più autorevole rappresentante. Questi evidenziò nei Sei libri della repubblica (1576, ed. it. 1588) la funzione svolta dagli "ufficiali" nella vita dello stato e ne sottolineò la collegialità nel lavoro e la gerarchia delle funzioni. Nel corso del XVIII secolo, con il dispotismo illuminato, lo stato venne visto come un organismo avente per fine il conseguimento del bene pubblico. Alla sua testa si poneva il monarca, primo burocrate a capo di una gerarchia di servitori dello stato. Si trattava di una concezione, fatta propria soprattutto da Giuseppe II d'Asburgo e Federico II di Prussia, venata di tinte etiche e religiose che passò anche nelle "monarchie amministrative" dei primi decenni dell'Ottocento. Nei Lineamenti della filosofia del diritto di Hegel (1821) i funzionari costituivano lo strumento essenziale per la realizzazione dello "stato di diritto". A loro spettava contenere le tendenze corporative presenti nella società e frenare le spinte dell'autorità politica ad assorbire ogni forma di sovranità e di potere. La concezione marxista della burocrazia si orientò a considerarlo un apparato di dominio di uno stato visto come espressione delle classi dominanti. In questo senso Marx criticò la visione hegeliana e non giunse a riconoscere la funzione della burocrazia in società altamente complesse. Con gli studi di M. Weber (specie Economia e società, 1922, ed. it. 1961) si ebbe la prima completa analisi della burocrazia intesa come categoria storico-sociologica indispensabile per la comprensione di tendenze più generali della società moderna e contemporanea. La burocrazia sarebbe, secondo Weber, espressione e risultato dei processi di razionalizzazione e di specializzazione funzionale che si registrano nelle comunità politiche nelle quali si realizza un rapporto di subordinazione fra i cittadini e un ceto di pubblici funzionari che conquista la loro fiducia per la razionalità tecnica che dispiega nel suo operare. Ne scaturirebbero alcuni tratti caratteristici della burocrazia: la sua obbedienza a una serie di ordinamenti; il suo essere definita da relazioni di dipendenza gerarchica che presuppongono una rigida divisione del lavoro e un'organizzazione sulla base della competenza; la remunerazione degli impiegati con uno stipendio e, infine, la distinzione tra ufficio e suo detentore. Il modello weberiano è stato sottoposto a critiche da parte di quanti ritengono che esso non sia in grado di spiegare lo sviluppo di concrete realtà storiche e che nell'azione del funzionario privilegi l'aspetto ritualistico. In tempi recenti vari fattori, tra i quali i profondi cambiamenti dell'assetto geopolitico ed una migliore consapevolezza dei cittadini, nata anche dal confronto generalizzato con altre realtà oltre i confini nazionali, hanno posto al centro dell'attenzione il tema di una nuova sensibilità nei rapporti con la burocrazia, anche in Paesi tradizionalmente deficitari sotto questo aspetto e privi di una normalizzazione dello spoil system. D'altro canto i progressi nella governance razionale, supportata anche dall'applicazione sistematica della Teoria dei giochi ad opera di studiosi come Robert Cooter, Douglas Baird, Robert Gertner e Randal Picker, hanno contribuito in modo fondamentale ad una migliore comprensione delle dinamiche sociali nella classe dirigente ed hanno portato vari Governi a prendere atto che i continui mutamenti dell'ambiente sociale ed economico (sviluppo tecnologico, differenziazione e frammentazione della domanda sociale, dispersione del potere politico su nuovi livelli anche transnazionali) richiedevano adeguate riforme e ridimensionamenti del "potere degli uffici". Al modello burocratico si sono quindi nel tempo apportate modifiche sia nella pratica che nella teoria, sviluppando forme di amministrazione partecipata, flessibile, contrattata, per progetti (cosiddetto modello telocratico).
La concezione di burocrazia.
L'accezione originaria del termine, in epoca moderna e premoderna, indicava un progresso ed una positiva terzietà rispetto alle forme organizzative basate sull'arbitrio e sull'esercizio individuale e dispotico di un potere personale. Rispetto a questi fenomeni, l'ideale burocratico all'epoca degli Stati nazionali poneva il potere in mano alla legge attraverso, ad esempio, la non-proprietà da parte del funzionario dei mezzi di produzione del proprio lavoro; la disciplina garantistica del rapporto di lavoro del funzionario, che non poteva essere licenziato perché sgradito al superiore; la definizione di procedimenti e procedure prestabiliti per tipologie uniformi di atti... L'attuale accezione del termine è principalmente negativa, a causa di quelle che nel corso del Novecento sono state definite da alcuni "conseguenze inattese" del fenomeno burocratico: rigidità, lentezza, incapacità di adattamento, inefficienza, inefficacia, lessico difficile o addirittura incomprensibile (il cosiddetto burocratese), mancanza di stimoli, deresponsabilizzazione, eccessiva pervasività, tendenza a regolamentare ogni minimo aspetto della vita quotidiana. Lord Cyril Northcote Parkinson, autore di un libello ironico in cui definiva tale omonima legge empirica, osservò che, anche nel momento di massimo declino del sistema coloniale britannico, la burocrazia degli uffici coloniali continuava costantemente ad aumentare di numero. Dalle sue rigorose osservazioni si evince che, in una qualsiasi organizzazione burocratica, il tasso di crescita degli impiegati si attesta su un 5-7% annuo, indipendentemente da qualsiasi variazione nel lavoro da svolgere. Tali fenomeni dipendono strettamente da elementi intrinseci al modello burocratico, che tende ad espandersi per perpetuare ed aumentare il proprio potere, diluendo al contempo le responsabilità individuali.
L'etimologia ibrida del termine, dal francese bureau ("ufficio") connesso al greco krátos ("potere") ne rivela l'origine tarda e la derivazione di chiara matrice francofona. Burocrazia Termine entrato in uso nel XVIII secolo per indicare il corpo dei funzionari preposto all'amministrazione pubblica. Nella formazione degli stati moderni la burocrazia svolse una funzione di primaria importanza; la creazione di un ordine di professionisti permise infatti agli stati nazionali di stabilire un controllo diretto sull'amministrazione fiscale e della giustizia, sottraendo all'aristocrazia una parte consistente del suo potere e subordinando al controllo centrale gli affari della periferia. Nell'Ottocento, con lo sviluppo ulteriore delle funzioni dello stato, la burocrazia allargò di molto le sue competenze. Oggi il termine viene spesso usato in senso più lato, per indicare in modo generico l'insieme della struttura amministrativa e del personale di ogni organizzazione complessa, sia pubblica sia privata. Negli ultimi decenni esso ha acquisito anche un'accezione negativa, che si riferisce, spesso qualunquisticamente, alla lentezza, agli sprechi e alla corruzione dell'amministrazione pubblica e che riprende la sfumatura polemica e ironica che il termine aveva all'atto della sua comparsa; infatti fu usato probabilmente per la prima volta dall'economista Vincent de Gournay verso la metà del XVIII secolo per criticare il potere crescente dei funzionari dello stato francese.
L'analisi della burocrazia. Un primo approfondito studio del fenomeno si deve al sociologo tedesco Max Weber. Nella sua analisi la burocrazia si configura come una forma di organizzazione razionale basata sul principio di competenza e diversificazione dei ruoli, che nasce in risposta ai crescenti bisogni delle moderne società industriali ed è destinata a una graduale ma inevitabile espansione nei vari settori dell'amministrazione statale, all'interno dei partiti politici e nelle aziende pubbliche e private (vedi Apparato burocratico). Molti contributi successivi a quello di Weber hanno però denunciato i pericoli legati alla eccessiva burocratizzazione, che può ostacolare il funzionamento democratico della società e dello stato. L'esperienza sovietica permise ad alcuni sociologi di cogliere lo stretto legame tra il totalitarismo e la gestione burocratica del potere, che sottraeva al controllo democratico i processi decisionali degli apparati statali. L'italiano Bruno Rizzi e l'americano James Burnham interpretarono in questo modo il sistema sociale sovietico, rispettivamente in Il collettivismo burocratico (1939) e in La rivoluzione dei tecnici (1940), sostenendo però che la tendenza ad aumentare il potere dello stato e dei suoi apparati burocratici era rintracciabile anche nei paesi occidentali.
Lo sviluppo della tecnoburocrazia. Nel secondo dopoguerra la critica alla funzione antidemocratica della burocrazia ha privilegiato gli aspetti collegati alla gestione diretta del potere e si è quindi trasformata nella polemica contro i 'tecnoburocrati', ovvero contro la fascia dirigenziale delle agenzie pubbliche e private che si serve di saperi e competenze altamente specifici e specializzati per sottrarre il suo operato all'esame non solo dei cittadini, ma anche degli organi parlamentari addetti al controllo. Secondo alcuni filosofi e sociologi, tra cui Ralf Dahrendorf e Herbert Marcuse, la tecnoburocrazia costituisce uno dei pericoli maggiori per le libertà democratiche ed è necessario liberarsene anche a costo di mettere in discussione le stesse conquiste tecnologiche. Altri, come ad esempio il sociologo francese Alain Touraine nel suo La società postindustriale (1969), hanno adottato una visione più pessimista, ritenendo che le modalità di trasmissione e di gestione dei saperi nell'era tardoindustriale siano collegate strutturalmente alla tecnoburocrazia e che i rischi a questa collegati non siano quindi evitabili.
Uno dei motivi, forse il principale, per cui il governo guidato da Mario Monti non è riuscito a tagliare la spesa pubblica è stata la scelta di mantenere al loro posto, quasi senza eccezioni, tutti i grandi burocrati che guidano i ministeri, scrive Francesco Giacovazzi su “Il Corriere della Sera”. Il nuovo governo aveva tempo fino al 31 maggio 2012 per decidere se confermare gli alti dirigenti dei ministeri: capi di gabinetto e degli uffici legislativi, capi dipartimento, direttori generali. Chi non verrà esplicitamente confermato, automaticamente decadrà. Accadde qualcosa di analogo con il primo esecutivo Berlusconi. I nuovi ministri della Lega che scesero a Roma nel 1994 - Giancarlo Pagliarini, Vito Gnutti, Roberto Radice - erano uomini concreti, abituati a gestire imprese, inesperti di burocrazia romana. Al suo primo giorno di lavoro il neoministro del Bilancio, Pagliarini, dopo aver letto un documento della Ragioneria generale dello Stato, a suo avviso incomprensibile, disse: «Bisogna rifare il bilancio dello Stato da zero. Se continuano a scriverlo così, solo la Ragioneria generale lo capisce e solo loro decideranno».
Il monopolio delle informazioni è il vero motivo della potenza della burocrazia. Gestire un ministero è una questione complessa: richiede dimestichezza con il bilancio dello Stato e il diritto amministrativo e soprattutto buoni rapporti con i burocrati che guidano gli altri ministeri e la presidenza del Consiglio. Gli alti dirigenti hanno il monopolio di questa informazione e di questi rapporti, e tutto l'interesse a mantenerlo. Hanno anche l'interesse a rendere il funzionamento dei loro uffici il più opaco e complicato possibile, in modo da essere i soli a poterli far funzionare. E così quando arriva un nuovo ministro, animato dalle migliori intenzioni, a ogni sua proposta la burocrazia oppone ostacoli che appaiono incomprensibili, ma che i dirigenti affermano essere insormontabili. Giancarlo Pagliarini perse la sua battaglia con la Ragioneria e in quel 1994 nulla cambiò.
Mario Canzio, Ragioniere generale dello Stato, entrò in Ragioneria nel 1972, 41 anni fa, come funzionario dell'Ispettorato generale del Bilancio, l'ufficio che ha il controllo della spesa pubblica. Da quel giorno la spesa pubblica al netto degli interessi è cresciuta (ai prezzi di oggi) di circa 200 miliardi, dal 32 al 45 per cento del Pil. Da quando, otto anni fa, fu nominato Ragioniere generale, è cresciuta di oltre 30 miliardi. I sindaci durano in carica cinque anni, con la possibilità se rieletti di un solo secondo mandato, il Governatore della Banca d'Italia sei, il presidente della Bce otto. Il Ragioniere generale a vita. Andrea Monorchio rimase tredici anni, con dieci diversi governi.
Sono tutti ottimi funzionari dello Stato, ma se non sono riusciti ad arginare la spesa pubblica per quarant'anni saranno davvero le persone più adatte per gestire una spending review? Non è venuto il momento di affrontare il ricambio della burocrazia? E di farlo per davvero, ponendo un termine alla perenne rotazione da un ministero all'altro, da un ministero a un'autorità indipendente e da questa ancora a un ministero? Non c'è ricambio se si abbassa l'età media dei ministri mentre la struttura sotto di loro resta immutabile. Cambiare i vecchi burocrati è certamente costoso perché un nuovo dirigente ci metterà un po' a prendere in mano le redini del ministero. Ma è un costo che val la pena pagare. L'alternativa è continuare a non fare nulla.
SEMPLIFICARE?
«Semplificare»: non c'è politico o governante che non abbia pronunciato almeno una volta questa parola, scrive Sergio Rizzo su “Il Corriere della Sera”. L'ex ministro leghista Roberto Calderoli, per rafforzare il concetto, si fece immortalare nel cortile di una caserma dei pompieri mentre dava fuoco con un lanciafiamme a 375 mila leggi inutili. Nemmeno troppo tempo fa: il 24 marzo del 2010. Poi è toccato al governo Mario Monti, per bocca del ministro Corrado Passera, lanciare un «urlo di dolore» per le complicazioni della burocrazia, invocando «semplificazioni» al più presto (8 novembre 2012). E ora è la volta del ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, annunciare che l'esecutivo di Enrico Letta «sta lavorando a un'operazione di semplificazione molto forte che dovrebbe vedere la luce a brevissimo» (4 giugno 2013). Auguri. Perché da quando è cominciata la precedente legislatura, nella primavera del 2008, sono state varate qualcosa come 288 norme fiscali che hanno avuto come conseguenza quella di complicare la vita alle imprese. E' un numero pari al 58,7 per cento di tutte le disposizioni di natura tributaria (491) introdotte attraverso 29 differenti provvedimenti. Oltre quattro volte superiore a quello delle 67 «semplificazioni» fatte nello stesso periodo: ogni norma approvata per snellire la burocrazia ne ha quindi portate con sé 4,3 capaci di riversare altra sabbia negli ingranaggi. E forse non è un caso, sottolinea l'ultimo rapporto della Confartigianato che contiene questo dato scioccante, che «la pressione burocratica abbia lo stesso ritmo di crescita della pressione fiscale». Ha raggiunto il 44,6 per cento, livello mai visto dal 1990, anno d'inizio della serie storica . Con un picco negli ultimi tre mesi 2012, durante i quali per ogni minuto che trascorreva il Fisco incassava un milione 731.416 euro. L'ufficio studi della Confartigianato ricorda che tra il 2005 e il 2013, secondo le stime Ue, le entrate fiscali sono salite del 21,2 per cento, pari a 132,1 miliardi: cifra esattamente corrispondente all'aumento nominale del Pil, diminuito però in termini reali. Per ogni euro di crescita apparente, dunque, l'Erario ha intascato un euro in più: è l'eredità di quello che nel rapporto viene definito «il ventennio perduto», iniziato nel 1993 e proseguito con 12 differenti governi. Senza che nemmeno gli esecutivi tecnici siano riusciti a invertire la rotta. Negli ultimi 600 giorni, 530 dei quali governati da Monti, il numero delle imprese è calato dell'uno per cento, il Pil è diminuito del 3,4 per cento, il credito al sistema produttivo ha subito una flessione di 65 miliardi, il debito pubblico è aumentato di 122 miliardi, la pressione fiscale è cresciuta dell' 1,8 per cento, la disoccupazione giovanile si è ingigantita dell' 8,5 per cento. Il numero delle persone senza lavoro è lievitato di 728 mila unità. La pressione fiscale sulle imprese risulta ben più elevata di quella per le famiglie: è arrivata al 68,3 per cento. Misura che vale il primato europeo e la quindicesima piazza mondiale. In Francia, dove pure non scherzano, il total tax rate sulle imprese è del 65,7 per cento. Ma in Germania scende al 46,8 per cento, per calare ancora in Spagna al 38,7 e planare nel Regno Unito al 35,5 per cento. «In Italia sembra si faccia apposta per penalizzare il patrimonio produttivo. Non possiamo sempre cercare scuse o alibi. Chi governa deve assumersi le proprie responsabilità. Ci vuole meno fisco, meno burocrazia, più credito, servizi pubblici efficienti. Se muoiono le imprese, muore il Paese», dice Giorgio Merletti. Ma se l'Italia, a sentire il presidente della Confartigianato, è un Paese fiscalmente e burocraticamente ostile all'impresa, non lo è certo meno rispetto al lavoro. Lo dicono chiaramente le tasse. Le imposte sul lavoro sono pari mediamente al 42,3 per cento, sono 4,6 punti al di sopra della media dell'Eurozona. Ancora. Il rapporto sottolinea come a una crescita del 4,5 per cento registrata in Italia a partire dal 1995, ha fatto riscontro un calo europeo di un punto. Risultato è un ulteriore ampliamento della forbice per il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, salito qui al 47,6 per cento per un dipendente a medio reddito senza figli, contro il 35,6 per cento della media Ocse. Non bastasse, dobbiamo fare i conti anche con un curioso controsenso: l'aumento inarrestabile delle tariffe dei servizi pubblici locali per famiglie e imprese, cominciato proprio dalla seconda metà degli anni Novanta, in coincidenza con l'avvio delle liberalizzazioni. Fatto sta che dal 1997 al 2012 si è assistito a una crescita del 66,4 per cento, 26,7 punti in più dell'inflazione. La tassa sui rifiuti, per esempio, recentemente inasprita con l'introduzione della Tares alla fine del 2011 con il decreto «salva Italia»: negli ultimi dodici anni le imposte sulla spazzatura hanno mostrato una progressione del 76,3 per cento. Su alcune categorie di imprese, poi, l'impatto della Tares è pesantissimo, con aumenti dell'imposta sui rifiuti che arrivano fino al 301,1 per cento. E di nuovo è avvilente il paragone con la Germania, dove dalla fine del 2007 all'inizio di quest'anno quella tassa è calata mediamente dello 0,2 per cento, mentre in Italia saliva del 22,9 per cento. Ma si capisce il perché confrontando l'andamento della spesa pubblica nei due Paesi. Mentre in Germania, considerando il periodo che va dal 2001 al 2011, diminuiva di 1,7 punti di Prodotto interno lordo, qui al contrario cresceva di 4 punti. Se la spesa pubblica italiana avesse seguito l'andamento tedesco, avremmo potuto risparmiare in un decennio 93,9 miliardi, quasi 9,4 l'anno. Perché non ci siamo riusciti? Si dice che la nostra spesa pubblica sia in larga misura «incomprimibile». Sarà. Resta però «incomprensibile» il fatto che nelle venti Regioni, le cui uscite incidono per oltre un quarto sul totale, ci siano livelli tanto differenti. Ecco allora che allineando semplicemente i livelli di spesa per le retribuzioni dei dipendenti e le forniture a quelli degli enti più virtuosi si potrebbero ottenere risparmi rilevantissimi. L'ufficio studi della Confartigianato li cifra in 20 miliardi 193 milioni. Ovvero, l'intero gettito previsto lo scorso anno per l'Imu dal governo Monti.
COME SI ENTRA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O IN UNA PROFESSIONE ABILITANTE DI PUBBLICO SERVIZIO O DI PUBBLICA NECESSITA’.
ANTONIO GIANGRANDE: VI SPIEGO COME IN ITALIA SI TRUCCANO I CONCORSI PUBBLICI E SI SCHIAVIZZANO I PRATICANTI.
Antonio Giangrande, suo malgrado proprio per questo perseguitato, con i suoi canali divulgativi e con gli strumenti testuali e video, vuole portare avanti e meglio far conoscere questo grave problema e quindi chiede a tutte quelle persone che hanno fatto o che stanno facendo l’esperienza di praticantato o di partecipare ad un concorso pubblico di sostenerlo in questa denuncia, facendo conoscere i suoi video ed i suoi libri, anche da leggere gratuitamente. Inoltre si rivolge a quei Parlamentari che si dichiarano di essere diversi dagli altri e che proclamano di attivarsi in Parlamento per l’interesse comune e non per tornaconto personale o di corporazione. L’invito è rivolto anche a tutte le persone che non hanno mai avuto, per loro fortuna, questa esperienza, ma che vogliono dare un contributo a questa iniziativa, affinchè per i loro figli non sia dedicata questa sorte.
La domanda che tutti dovremmo porci è: cosa succede oggi quando si raggiunge la fatidica laurea con i sacrifici propri e della famiglia? Semplice, si cerca un lavoro, e siccome il lavoro per i comuni mortali ormai è diventato un miraggio se non si hanno santi in paradiso, per non stare con le mani in mano, di solito ti iscrivi a una scuola di specializzazione, il cui risultato finale è uno stage gratuito di 6 mesi senza percepire un soldo, e magari per fare questo stage cambi anche città per cui ti devi pagare l’affitto e il resto. Questa classe di lavoratori sono gli “stagisti” o meglio i “nuovi proletari”, dove la loro unica ricchezza sono mamma e papà che devono continuare a dargli la “paghetta” per andare avanti. Quel che è peggio è che in moltissimi casi lo stage, che dovrebbe rappresentare un momento formativo al lavoro, viene svilito delle capacità professionali di una persona, nel senso: ci sono da fare le fotocopie, le fa lo stagista! Al termine del periodo dello stage, cosa succede? Arrivederci, grazie e avanti un altro. Tanto è gratis. Accanto agli stagisti, ci sono centinaia di migliaia di praticanti (come si fa a non vederli), molti dei quali tenuti a stecchetto per anni da avvocati, notai, commercialisti ed altri liberi professionisti, che hanno avuto la fortuna di superare un concorso di abilitazione truccato: perché pagare chi, per accedere all’Ordine, ha bisogno di svolgere il praticantato? Siamo allo sfruttamento vero e proprio del lavoro. Praticanti e collaboratori anche presso gli stessi parlamentari che legiferano. Di questo mondo di stagisti e praticanti i sindacati e la politica non ne parlano e non ne vogliono parlare. Oggi i praticanti avvocati sono come i “ragazzi-spazzola” dei barbieri di una volta, quelli costretti a sperare nella generosità dei clienti che volevano lasciargli una mancia. Ebbene i giovani aspiranti avvocati, laurea in tasca e dignità sotto i piedi, lavoreranno gratis o quasi come i garzoni di bottega dei tempi andati. Aspiranti avvocato trattati come una schiavi. Questa è la riforma votata nell’ultimo scorcio del governo Monti da destra e da sinistra. Ed i giornalisti che dovrebbero denunciare l’arcano? In base a una norma da poco approvata l’esame gi giornalista lo possono fare tutti i pubblicisti che dimostrano di vivere di questo mestiere (non ci sono più requisiti stringenti di reddito). Oltre, naturalmente, a tutti quelli che hanno lavorato in una redazione: in regola come praticanti, e sono pochissimi (compresi i soliti raccomandati), o in nero. Poi però devi sborsare quasi 500 euro tra tasse e bolli vari, iscriverti obbligatoriamente a un corso preparatorio – quello online, per esempio, costa 200 euro -, andare a Roma due volte per fare scritto e orale nel bunker burocratico dell’hotel Ergife. Siamo sui mille euro come ridere. Ma poi c’è poco da ridere e stare allegri. Che cosa si risolve diventando professionisti? Nelle ultime infornate di esami ci sono già molti trentenni che non lavorano già più o fanno lavoretti giornalistici saltuari per poche centinaia di euro l’anno. Un importante gruppo editoriale ha di recente imposto ai collaboratori condizioni standard per cui i pezzi molti brevi sono pagati… zero euro. Zero. Il lavoro gratuito viola la Costituzione. Anche quello a condizioni non dignitose. Sui problemi delle professioni grava da anni una cappa di silenzio, un muro di gomma. Paradossale, grottesco, kafkiano perché stiamo parlando del mondo dei mass media, della comunicazione. Ma visto che sui giornali non se ne può parlare, perché gli editori non gradiscono indotti dagli Ordini professionali a tacere, dove altro parlarne? Internet per fortuna sta un po’ cambiando le cose e sul web non tutti i giornalisti sono uguali. Qualcuno rompe l’omertà.
Un esempio per tutti di come si legifera in Parlamento, anche se i media lo hanno sottaciuto. La riforma forense, approvata con Legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra gli ultimi interventi legislativi consegnatici frettolosamente dal Parlamento prima di cessare di fare danni. I nonni avvocati in Parlamento (compresi i comunisti) hanno partorito, in previsione di un loro roseo futuro, una contro riforma fatta a posta contro i giovani. Ai fascisti che hanno dato vita al primo Ordinamento forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36) questa contro riforma reazionaria gli fa un baffo. Trattasi di una “riforma”, scritta come al solito negligentemente, che non viene in alcun modo incontro ed anzi penalizza in modo significativo i giovani. Da venti anni inascoltato Antonio Giangrande denuncia il malaffare di avvocati e magistrati ed il loro malsano accesso alla professione. Cosa ha ottenuto a denunciare i trucchi per superare l’esame? Prima di tutto l’ostracismo all’abilitazione. Poi, insabbiamento delle denunce contro i concorsi truccati ed attivazione di processi per diffamazione e calunnia, chiusi, però, con assoluzione piena. Intanto ti intimoriscono. Ed anche la giustizia amministrativa si adegua. A parlar delle loro malefatte i giudici amministrativi te la fanno pagare. Presenta l’oneroso ricorso al Tar di Lecce (ma poteva essere qualsiasi altro Tribunale Amministrativo Regionale) per contestare l’esito negativo dei suoi compiti all’esame di avvocato: COMMISSIONE NAZIONALE D'ESAME PRESIEDUTA DA CHI NON POTEVA RICOPRIRE L'INCARICO, COMMISSARI (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI) DENUNCIATI CHE GIUDICANO IL DENUNCIANTE E TEMI SCRITTI NON CORRETTI, MA DA 15 ANNI SONO DICHIARATI TALI. Ricorso, n. 1240/2011 presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro il voto numerico insufficiente (25,25,25) dato alle prove scritte di oltre 4 pagine cadaune della sessione del 2010 adducente innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda di fissazione dell’udienza di trattazione. Tale ricorso non ha prodotto alcun giudizio nei tempi stabiliti, salvo se non il diniego immediato ad una istanza cautelare di sospensione, tanto da farlo partecipare, nelle more ed in pendenza dell’esito definitivo del ricorso, a ben altre due sessioni successive, i cui risultati sono stati identici ai temi dei 15 anni precedenti (25,25,25): compiti puliti e senza motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più punti. Per l’inerzia del Tar si è stati costretti a presentare istanza di prelievo il 09/07/2012. Inspiegabilmente nei mesi successivi all’udienza fissata e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata alcuna notizia dell’esito dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi presentati un anno dopo hanno avuto celere ed immediato esito positivo di accoglimento. Eccetto qualcuno che non poteva essere accolto, tra i quali i ricorsi dell'avv. Carlo Panzuti e dell'avv. Angelo Vantaggiato in cui si contestava il giudizio negativo reso ad un elaborato striminzito di appena una pagina e mezza. Solo in data 7 febbraio 2013 si depositava sentenza per una decisione presa già in camera di consiglio della stessa udienza del 7 novembre 2012. Una sentenza già scritta, però, ben prima delle date indicate, in quanto in tale camera di consiglio (dopo aver tenuto anche regolare udienza pubblica con decine di istanze) i magistrati avrebbero letto e corretto (a loro dire) i 3 compiti allegati (più di 4 pagine per tema), valutato e studiato le molteplici questioni giuridiche presentate a supporto del ricorso. I magistrati amministrativi potranno dire che a loro insindacabile giudizio il ricorso di Antonio Giangrande va rigettato, ma devono spiegare a chi in loro pone fiducia, perché un ricorso presentato il 25 luglio 2011, deciso il 7 novembre 2012, viene notificato il 7 febbraio 2013? Un'attenzione non indifferente e particolare e con un risultato certo e prevedibile, se si tiene conto che proprio il presidente del Tar era da considerare incompatibile perchè è stato denunciato dal Giangrande e perché le sue azioni erano oggetto di inchiesta video e testuale da parte dello stesso ricorrente? Le gesta del presidente del Tar sono state riportate da Antonio Giangrande, con citazione della fonte, nella pagina d'inchiesta attinente la città di Lecce. Come per dire: chi la fa, l'aspetti?
In Italia tutti sanno che i concorsi pubblici sono truccati e nessuno fa niente, tantomeno i magistrati. Gli effetti sono che non è la meritocrazia a condurre le sorti del sistema Italia, ma l’incompetenza e l’imperizia. Non ci credete o vi pare un’eresia? Basta dire che proprio il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo anni di giudizi amministrativi, è stato costretto ad annullare un concorso già effettuato per l’accesso alla magistratura. Ed i candidati ritenuti idonei? Sono lì a giudicare indefessi ed ad archiviare le denunce contro i concorsi truccati. E badate, tra i beneficiari del sistema, vi sono nomi illustri.
IL VADEMECUM DEL CONCORSO PUBBLICO TRUCCATO.
INDIZIONE DEL CONCORSO: spesso si indice un concorso quando i tempi sono maturi per soddisfare da parte dei prescelti i requisiti stabiliti (acquisizione di anzianità, titoli di studio, ecc.). A volte chi indice il concorso lo fa a sua immagine e somiglianza (perché vi partecipa personalmente come candidato). Spesso si indice il concorso quando non vi sono candidati (per volontà o per induzione), salvo il prescelto. Queste anomalie sono state riscontrate nei concorsi pubblici tenuti presso le Università e gli enti pubblici locali. Spesso, come è successo per la polizia ed i carabinieri, i vincitori rimangono casa.
COMMISSIONE D’ESAME: spesso a presiedere la commissione d’esame sono personalità che hanno una palese incompatibilità. Per esempio nella commissione d’esame centrale presso il Ministero della Giustizia del concorso di avvocato è stato nominato presidente colui il quale non poteva, addirittura, presiedere la commissione locale di Corte d’Appello. Cacciato in virtù della riforma (decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180). Spesso le commissioni d’esame sono mancanti delle componenti necessarie per la valutazione tecnica della materia d’esame. Le Commissioni d’esame hanno sempre e comunque interessi amicali, familistiche e clientelari. Seguendo una crescente letteratura negli ultimi anni abbiamo messo in relazione l’età di iscrizione all’albo degli avvocati con un indice di frequenza del cognome nello stesso albo. In particolare, per ogni avvocato abbiamo calcolato la frequenza del cognome nell’albo, ovvero il rapporto tra quante volte quel cognome vi appare sul totale degli iscritti, in relazione alla frequenza dello stesso cognome nella popolazione. In media, il cognome di un avvocato appare nell’albo 50 volte di più che nella popolazione. Chi ha un cognome sovra-rappresentato nell’albo della sua provincia diventa avvocato prima. Infine vi sono commissioni che, quando il concorso è a numero aperto, hanno tutto l’interesse a limitare il numero di idonei per limitare la concorrenza: a detta dell’economista Tito Boeri: «Nelle commissioni ci sono persone che hanno tutto da perderci dall’entrata di professionisti più bravi e più competenti».
I CONCORSI FARSA: spesso i concorsi vengono indetti per sanare delle mansioni già in essere, come il concorso truffa a 1.940 posti presso l’INPS, bandito per sistemare i lavoratori socialmente utili già operanti presso l’Ente.
LE PROVE D’ESAME: spesso sono conosciute in anticipo. A volte sono pubblicate su internet giorni prima, come è successo per il concorso degli avvocati, dei dirigenti scolastici, o per l’accesso alle Università a numero chiuso (medicina), ovvero, come succede all’esame con più sedi (per esempio all’esame forense o per l’Agenzia delle Entrate, le tracce sono conosciute tramite cellulari o palmari in virtù del tardivo inizio delle prove in una sede rispetto ad altre. Si parla di ore di ritardo tra una sede ed un’altra). A volte le tracce sono già state elaborate in precedenza in appositi corsi, così come è successo all’esame di notaio. A volte le prove sono impossibili, come è successo al concorsone pubblico per insegnanti all’estero: 40 quesiti a risposta multipla dopo averli cercati, uno ad uno, in un volume di oltre 4mila che i partecipanti alla selezione hanno visto per la prima volta, leggere quattro testi in lingua straniera e rispondere alle relative domande. Il tutto nel tempo record di 45 minuti, comprese parti di testo da tradurre. Quasi 1 minuto a quesito.
MATERIALE CONSULTABILE: spesso, come al concorso di magistrato o di avvocato dello Stato ed in tutti gli altri concorsi, ad alcuni è permessa la consultazione di materiale vietato (codici commentati, fogliettini, fin anche compiti elaborati dagli stessi commissari) fino a che non scoppia la bagarre. Spesso, come succede al concorso di avvocato, sono proprio i commissari a dettare il parere da scrivere sull’elaborato, tale da rendere le prove dei candidati uniformi e nonostante ciò discriminati in sede di correzione.
IL MATERIALE CONSEGNATO: il compito dovrebbe essere inserito in una busta da sigillare contenente un’altra busta chiusa con inserito il nome del candidato. Non ci dovrebbero essere segni di riconoscimento. Non è così come insegna il concorso di notaio. Oltre ai segni di riconoscimento posti all’interno (nastri), i commissari firmano in modo diverso i lembi di chiusura della busta grande consegnata.
LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI. Quanto già indicato sono i trucchi che i candidati possono vedere ed eventualmente denunciare. Quanto avviene in sede di correzione è lì la madre di tutte le manomissioni. Proprio perchè nessuno vede. La norma prevede che la commissione d’esame (tutti i componenti) partecipi alle fasi di:
• apertura della busta grande contenente gli elaborati;
• lettura del tema da parte del relatore ed audizione degli altri membri;
• correzione degli errori di ortografia, sintassi e grammatica;
• richiesta di chiarimenti, valutazione dell’elaborato affinchè le prove d’esame del ricorrente evidenzino un contesto caratterizzato dalla correttezza formale della forma espressiva e dalla sicura padronanza del lessico giuridico, anche sotto il profilo più strettamente tecnico-giuridico, e che anche la soluzione delle problematiche giuridiche poste a base delle prove d’esame evidenzino un corretto approccio a problematiche complesse;
• consultazione collettiva, interpello e giudizio dei singoli commissari, giudizio numerico complessivo, motivazione, sottoscrizione;
• apertura della busta piccola contenete il nome del candidato da abbinare agli elaborati corretti;
• redazione del verbale.
Queste sono solo fandonie normative. Di fatto si apre prima la busta piccola, si legge il nome, se è un prescelto si dà agli elaborati un giudizio positivo, senza nemmeno leggerli. Quando i prescelti sono pochi rispetto al numero limite di idonei stabilito illegalmente, nonostante il numero aperto, si aggiungono altri idonei diventati tali “a fortuna”. In effetti, con migliaia di ricorsi al TAR si è dimostrato che i giudizi resi sono inaffidabili. La carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio negativo reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque la infondatezza dei giudizi assunti, tale da suffragare e giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta discrasia tra giudizio e contenuto degli elaborati, specie se la correzione degli elaborati è avvenuta in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio composito. Tempi risibili, tanto da offendere l’umana intelligenza. Dai Verbali si contano 1 o 2 minuti per effettuare tutte le fasi di correzione, quando il Tar di Milano ha dichiarato che ci vogliono almeno 6 minuti solo per leggere l’elaborato. La mancanza di correzione degli elaborati ha reso invalido il concorso in magistratura. Per altri concorsi, anche nella stessa magistratura, il ministero della Giustizia ha fatto lo gnorri e si è sanato tutto, alla faccia degli esclusi. Già nel 2005 candidati notai ammessi agli orali nonostante errori da somari, atti nulli che vengono premiati con buoni voti, mancata verbalizzazione delle domande, elaborati di figli di professionisti ed europarlamentari prima considerati “non idonei” e poi promossi agli orali. Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio. Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati. O ancora l’esame di ammissione all’albo dei giornalisti professionisti del 1991, audizione riscontrabile negli archivi di radio radicale, quando la presenza di un folto gruppo di raccomandati venne scoperta per caso da un computer lasciato acceso nella sala stampa del Senato proprio sul file nel quale il caposervizio di un’agenzia, commissario esaminatore, aveva preso nota delle prime righe dei temi di tutti quelli da promuovere. E ancora lo scandalo denunciato da un’inchiesta del 14 maggio 2009 apparsa su “La Stampa”. A finire sotto la lente d’ingrandimento del quotidiano torinese l’esito del concorso per allievi per il Corpo Forestale. Tra i 500 vincitori figli di comandanti, dirigenti, uomini di vertice. La casualità ha voluto, inoltre, che molti dei vincitori siano stati assegnati nelle stazioni dove comandano i loro genitori. Una singolare coincidenza che diventa ancor più strana nel momento in cui si butta un occhio ad alcuni “promemoria”, sotto forma di pizzini, ritrovati nei corridoi del Corpo forestale e in cui sono annotati nomi, cognomi, date di nascita e discendenze di alcuni candidati. «Per Alfonso, figlio di Rosetta», «Per Emidio, figlio di Cesarina di zio Antonio», «Per Maria, figlia di Raffaele di zia Maria». Piccole annotazioni, certo. Il destino, però, ha voluto che le tutte persone segnalate nei pizzini risultassero vincitrici al concorso.
GLI ESCLUSI, RIAMMESSI. Candidati che sono stati esclusi dalla prova per irregolarità, come è successo al concorso per Dirigenti scolastici, o giudicati non idonei, che poi si presentano regolarmente agli orali. L’incipit della confidenza di Elio Belcastro, parlamentare dell’Mpa di Raffaele Lombardo, pubblicata su “Il Giornale”. Belcastro ci fa subito capire, scandendo bene le parole, che Tonino non era nemmeno riuscito a prenderlo quel voto, minimo. «Tempo fa l’ex procuratore capo di Roma, Felice Filocamo, che di quella commissione d’esami era il segretario, mi ha raccontato che quando Carnevale si accorse che i vari componenti avevano bocciato Di Pietro, lo chiamò e si arrabbiò molto. Filocamo fu costretto a tornare in ufficio, a strappare il compito del futuro paladino di Mani pulite e a far sì che, non saprei dire come, ottenesse il passaggio agli orali, seppur con il minimo dei voti». Bocciato e ripescato? Magistrato per un falso? Possibile? Non è l’unico caso. Era già stato giudicato non idoneo, ma in una seconda fase sarebbero saltati fuori degli strani fogli aggiuntivi che prima non c’erano. Ecco come sarebbe sorto il sospetto che qualcuno li avesse inseriti per “salvare” il candidato già bocciato, in modo da giustificare una valutazione diversa oppure da consentire un successivo ricorso al TAR. I maggiori quotidiani nazionali e molti locali, ed anche tanti periodici, si sono occupati di tale gravissimo fatto, e che è stato individuato con nome e cognome il magistrato (una donna) in servizio a Napoli quale autore del broglio accertato. Per tale episodio il CSM ha deciso di sospendere tale magistrato dalle funzioni e dallo stipendio. In quella sessione a fronte di 350 candidati ammessi alle prove orali pare che oltre 120 siano napoletani, i quali sembrano avere particolari attitudini naturali verso le scienze giuridiche e che sembrano essere particolarmente facilitati nel loro cammino anche dalla numerosa presenza nella commissione di esami di magistrati e professori napoletani.
TUTELA GIUDIZIARIA. Un ricorso al TAR non si nega a nessuno: basta pagare la tangente delle spese di giudizio. Per veder accolto il ricorso basta avere il principe del Foro amministrativo del posto; per gli altri non c’è trippa per gatti. Cavallo di battaglia: mancanza della motivazione ed illogicità dei giudizi. Nel primo caso, dovendo accertare un’ecatombe dei giudizi, la Corte Costituzionale, con sentenza 175 del 2011, ha legittimato l’abuso delle commissioni: “buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni sottese ad un giudizio di non idoneità, sia per i tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia per il numero dei partecipanti alle prove”. Così la Corte Costituzionale ha sancito, il 7 giugno 2011, la legittimità costituzionale del cd. “diritto vivente”, secondo cui sarebbe sufficiente motivare il giudizio negativo, negli esami di abilitazione, con il semplice voto numerico. La Corte Costituzionale per ragion di Stato (tempi ristretti ed elevato numero) afferma piena fiducia nelle commissioni di esame (nonostante la riforma e varie inchieste mediatiche e giudiziarie ne minano la credibilità), stabilendo una sorta d’infallibilità del loro operato e di insindacabilità dei giudizi resi, salvo che il sindacato non promani in sede giurisdizionale. I candidati, quindi, devono sperare nel Foro presso cui vi sia tutela della meritocrazia ed un certo orientamento giurisprudenziale a favore dei diritti inviolabili del candidato, che nella massa è ridimensionato ad un semplice numero, sia di elaborato, sia di giudizio. Giudizi rapidi e sommari, che spesso non valorizzano le capacità tecniche e umane che da un’attenta lettura dell’elaborato possono trasparire. Fatto assodato ed incontestabile il voto numerico, quale giudizio e motivazione sottesa. Esso deve, però, riferire ad elementi di fatto corrispondenti che supportino quel voto. Elementi di fatto che spesso mancano o sono insussistenti. All’improvvida sentenza della Corte Costituzionale viene in soccorso la Corte di Cassazione. Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’elaborato sottoposto a valutazione. In sostanza il TAR può scendere sul terreno delle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici per l’accesso a una professione o in un concorso pubblico, quando il giudizio è viziato da evidente illogicità e da travisamento del fatto. Ad affermare l’importante principio di diritto sono le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 8412, depositata il 28 maggio 2012. Insomma, la Cassazione afferma che le commissioni deviano il senso della norma concorsuale.
Certo che a qualcuno può venire in mente che comunque una certa tutela giuridica esiste. Sì, ma dove? Ma se già il concorso al TAR è truccato. Nel 2008 un consigliere del Tar trombato al concorso per entrare nel Consiglio di Stato, si è preso la briga di controllare gli atti del giorno in cui sono state corrette le sue prove, scoprendo che i cinque commissari avevano analizzato la bellezza di 690 pagine. “Senza considerare la pausa pranzo e quella della toilette, significa che hanno letto in media tre pagine e mezzo in 60 secondi. Un record da guinness, visto che la materia è complessa”, ironizza Alessio Liberati. Che ha impugnato anche i concorsi del 2006 e del 2007: a suo parere i vincitori hanno proposto stranamente soluzioni completamente diverse per la stessa identica sentenza. Il magistrato, inoltre, ha sostenuto che uno dei vincitori, Roberto Giovagnoli, non aveva nemmeno i titoli per partecipare al concorso. Mentre il Governo rifiuta da mesi di rispondere alle varie interrogazioni parlamentari sul concorso delle mogli (il concorso per magistrati Tar vinto da Anna Corrado e Paola Palmarini, mogli di due membri dell’organo di autogoverno che ne nominò la commissione) si è svolto un altro – già discusso – concorso per l’accesso al Tar. Nonostante l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi (Consiglio di Presidenza – Cpga) si sia stretto in un imbarazzante riserbo, che davvero stride con il principio di trasparenza che i magistrati del Tar e del Consiglio di Stato sono preposti ad assicurare controllando l’operato delle altre amministrazioni, tra i magistrati amministrativi si vocifera che gli elaborati scritti del concorso sarebbero stati sequestrati per mesi dalla magistratura penale, dopo aver sorpreso un candidato entrato in aula con i compiti già svolti, il quale avrebbe già patteggiato la pena. Dopo il patteggiamento la commissione di concorso è stata sostituita completamente ed è ricominciata la correzione dei compiti. Si è già scritto della incredibile vicenda processuale del dott. Enrico Mattei, fratello di Fabio Mattei (oggi membro dell’organo di autogoverno), rimesso “in pista” nel precedente concorso c.d. delle mogli grazie ad una sentenza del presidente del Tar Lombardia, assolutamente incompetente per territorio, che, prima di andare in pensione coinvolto dallo scandalo della c.d. cricca, si era autoassegnato il ricorso ed aveva ammesso a partecipare al concorso il Mattei, redigendo addirittura una sentenza breve (utilizzabile solo in caso di manifesta fondatezza), poco dopo stroncata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6190/2008), che ha rilevato perfino l’appiattimento lessicale della motivazione della decisione rispetto alle memorie difensive presentate dal Mattei. Dopo il concorso delle mogli e il caso Mattei, un altro concorso presieduto da Pasquale De Lise è destinato a far parlare di sé. Si sono infatti concluse le prove scritte del concorso per 4 posti a consigliere di Stato, presieduto da una altisonante commissione di concorso: il presidente del Consiglio di Stato (Pasquale De Lise), il presidente aggiunto del Consiglio di Stato (Giancarlo Coraggio), il presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia (Riccardo Virgilio), il preside della facoltà di giurisprudenza (Carlo Angelici) ed un presidente di sezione della Corte di Cassazione (Luigi Antonio Rovelli). Ma anche il concorso al Consiglio di Stato non è immune da irregolarità. Tantissime le violazioni di legge già denunciate all’organo di autogoverno: area toilettes non sigillata e accessibile anche da avvocati e magistrati durante le prove di concorso, ingresso a prove iniziate di pacchi non ispezionati e asseritamente contenenti cibi e bevande, ingresso di estranei nella sala durante le prove di concorso, uscita dei candidati dalla sala prima delle due ore prescritte dalla legge, mancanza di firma estesa dei commissari di concorso sui fogli destinati alle prove, presenza di un solo commissario in aula. Tutti vizi, questi, in grado di mettere a rischio la validità delle prove. Qual è l’organo deputato a giudicare, in caso di ricorso, sulla regolarità del concorso per consigliere di Stato? Il Consiglio di Stato… naturalmente! Ecco perché urge una riforma dei concorsi pubblici. Riforma dove le lobbies e le caste non ci devono mettere naso. E c’è anche il rimedio. Niente esame di abilitazione. Esame di Stato contestuale con la laurea specialistica. Attività professionale libera con giudizio del mercato e assunzione pubblica per nomina del responsabile politico o amministrativo che ne risponde per lui (nomina arbitraria così come di fatto è già oggi). E’ da vent’anni che Antonio Giangrande studia il fenomeno dei concorsi truccati. Anche la fortuna fa parte del trucco, in quanto non è tra i requisiti di idoneità. Qualcuno si scandalizzerà. Purtroppo non sono generalizzazioni, ma un dato di fatto. E da buon giurista, consapevole del fatto che le accuse vanno provate, pur in una imperante omertà e censura, l’ha fatto. In video ed in testo. Se non basta ha scritto un libro, tra i 50, da leggere gratuitamente su www.controtuttelemafie.it o su Google libri o in ebook su Amazon.it o cartaceo su Lulu.com. Invitando ad informarsi tutti coloro che, ignoranti o in mala fede, contestano una verità incontrovertibile, non rimane altro che attendere: prima o poi anche loro si ricrederanno e ringrazieranno iddio che esiste qualcuno con le palle che non ha paura di mettersi contro Magistrati ed avvocati. E sappiate, in tanti modi questi cercano di tacitare Antonio Giangrande, con l’assistenza dei media corrotti dalla politica e dall’economia e genuflessi al potere. Ha perso le speranze. I praticanti professionali sono una categoria incorreggibile: “so tutto mi”, e poi non sanno un cazzo, pensano che essere nel gota, ciò garantisca rispetto e benessere. Che provino a prendere in giro chi non li conosce. La quasi totalità è con le pezze al culo e genuflessi ai Magistrati. Come avvoltoi a buttarsi sulle carogne dei cittadini nei guai e pronti a vendersi al miglior offerente. Non è vero? Beh! Chi esercita veramente sa che nei Tribunali, per esempio, vince chi ha più forza dirompente, non chi è preparato ed ha ragione. Amicizie e corruttele sono la regola. Naturalmente per parlare di ciò, bisogna farlo con chi lavora veramente, non chi attraverso l’abito, cerca di fare il monaco.
LA CASTA CORROTTA E SFRUTTATRICE.
Senatori e deputati a libro paga di multinazionali e lobbisti. È quanto sostiene un assistente parlamentare intervistato dalle Iene. L’intervista è andata in onda su Italia 1 domenica 19 marzo 2013 e riportata da tutta la stampa. Nel servizio delle Iene un assistente parlamentare di Palazzo Madama, che preferisce restare anonimo, denuncia l'esistenza di senatori e onorevoli a libro paga di alcune multinazionali, le cosiddette lobby. L'obiettivo, spiega sempre la fonte anonima, è «far sì che quando ci sono degli emendamenti da votare, i senatori e gli onorevoli li votino a favore della categoria che paga». Inoltre il servizio fa presente l'esistenza di collaboratori di senatori, i cosiddetti «portaborse», che lavorano in nero a 800 euro al mese ma che per entrare a Palazzo Madama dispongono di regolare tesserino: «Il 70% dei miei colleghi si trova nelle mie stesse condizioni ed entriamo con un badge regolare», racconta la fonte anonima spiegando di «lavorare in nero dal 2003» e di essere stato assistente «sia di un senatore di destra che di un senatore di sinistra». «Tutta colpa dell'autodichia», commenta il questore del Senato e esponente grillina Laura Bottici: «All'interno di Palazzo Madama vige la regola che si fanno le leggi ma la legge esterna non può entrare a controllare quello che si fa all'interno del palazzo. È questo il problema grandissimo». «Giorni fa ho evidenziato l'esigenza di una legge che disciplini, in maniera chiara e trasparente, l'attività lobbistica che al momento, seppur sempre presente, si muove in maniera nascosta» ha chiarito il presidente del Senato.
L'anticipazione ha provocato l'immediata reazione del presidente del Senato, Piero Grasso: «Chi sa qualcosa sui parlamentari pagati farebbe bene a denunciare questi comportamenti gravissimi». Ha affermato l'ex procuratore antimafia. «Io - ha aggiunto - mi adopererò per fornire agli inquirenti nel più breve tempo tutte le informazioni che riterranno utili alle indagini. Purtroppo - fa notare la seconda carica dello Stato - la natura di denuncia, anonima nella fonte e nei destinatari, rende difficile procedere all'accertamento della verità. Spero quindi che gli autori del servizio e il cittadino informato di fatti così gravi provvedano senza indugio a fare una regolare denuncia alla Procura, in modo da poter accertare natura e gravità dei fatti contestati». Una risposta immediata potrebbe essere una nuova legge sul tema della corruzione e del voto di scambio: «Per quanto mi riguarda ho dimostrato di considerare la lotta alla corruzione un'assoluta emergenza depositando, il mio primo giorno da senatore, un ddl con Disposizioni in materia di corruzione, voto scambio, falso in bilancio e riciclaggio , che martedì sarà preso in esame dalla Commissione Giustizia del Senato».
Nel servizio in onda domenica sera, l'assistente parlamentare parla di «senatori e onorevoli a libro paga di alcune multinazionali, le cosiddette lobbies». L'uomo ha chiesto di restare anonimo: «Ci sono le multinazionali - ha raccontato - che ogni mese per mezzo di un loro rappresentante fanno il giro dei palazzi, sia al Senato che Camera: incontrano noi assistenti e ci consegnano dei soldi da dare ai rispettivi senatori e onorevoli». L'obiettivo, ha spiegato sempre la fonte anonima, è «far sì che quando ci sono degli emendamenti da votare, i senatori e gli onorevoli li votino a favore della categoria che paga». Operazioni che prevedono una sorta di tariffario: «Per quel che mi riguarda, conosco due multinazionali, una del settore dei tabacchi e un'altra nel settore dei video giochi e delle slot machine ed entrambe elargiscono una 1.000 euro e un'altra 2.000 euro ogni mese». La tariffa «cambia a seconda dell'importanza del senatore e quindi, se è molto influente, sale fino a 5.000 euro». Per quanto riguarda poi, ha detto ancora, «le sale Bingo, si sono formati due gruppi, partecipati sia da uomini del centro sinistra che da uomini del centro destra. I due gruppi fanno capo ad ex ministri del centro sinistra».
Insomma l'assistente del senatore parla velatamente di tangenti. Le lobbies dunque pagherebbero uno stipendio mensile ad alcuni parlamentari per ottenere in cambio dei favori.
Davide Parenti, autore del programma, commenta così l'intervento di Grasso: "Noi abbiamo fatto il nostro mestiere, siamo riusciti a trovare qualcuno che parla. Ma va detto che la questione sollevata dal nostro programma non può essere certo un fatto di cui nessuno è a conoscenza. Ovvero, come ci siamo arrivati noi, immagino, saranno stati informati da tempo quelli che lavorano nel palazzo. Mi risulta difficile immaginare che lì nessuno sapesse".
LA CASTA ASSENTEISTA.
Cero è che è la presunta corruzione è mal riposta. Perché “In Aula non c'è mai nessuno”, spiega Mauro Munafò su “L’Espresso”. E' la denuncia, rilanciata quasi ogni giorno attraverso i social network, degli onorevoli del Movimento 5 Stelle. I question time e le discussioni senza votazione vedrebbero solo la presenza dei grillini tra i banchi. E bastano un paio di foto col cellulare per alimentare la polemica. E' una denuncia quasi giornaliera, tanto da essere diventata ormai un vero e proprio tormentone. Un onorevole, quasi sempre del Movimento 5 Stelle ma a volte anche del Pd, scatta una foto con il cellulare ai banchi del Parlamento e la carica sul proprio profilo Facebook per mostrare ad amici e fan come in quel momento l'aula sia quasi vuota. E bastano pochi secondi perché arrivino decine o centinaia di commenti indignati contro la Casta. Il 'format' di sicuro successo è stato lanciato nelle settimane scorse in occasione delle discussioni e dei question time su terremoto in Emilia e crediti alle PA ed ha acquistato sempre maggiori sostenitori. Il cuore del problema, spiegano i pentastellati, è l'assenteismo dei parlamentari di Pd e Pdl: quando in Aula non ci sono votazioni, e quindi la mancata presenza non viene sanzionata con decurtazioni sulla diaria, pochi tra i parlamentari della maggioranza si fanno vedere. "Oggi question time. Noi cittadini tutti presenti", scrive Gianluca Castaldi, senatore cinque stelle, caricando una di queste foto, "Quando si vota vengono. L'assenza al voto è scalata dalla diaria!!!". Stessi toni, e scatto simile, anche per l'altro senatore grillino Giuseppe Vacciano: "La nostra interrogazione sulla Tav interessa molto ai "colleghi" del Pdl", che poi specifica, "Devo onestamente testimoniare che quelli del Pd sono sempre molto più presenti, seppure non nella totalità la differenza è evidente. Oggi la presenza non è "monetizzata", non essendo prevista votazione. Sarà un motivo in più?". Rincara la dose Giuseppe Brescia, deputato del Movimento. "Buongiorno! Ieri abbiamo finito di lavorare alle 20 30 ed oggi alle 10 eravamo di nuovo a lavorare in aula. Nonostante ciò, come sapete abbiamo ritenuto opportuno anche tagliarci gli stipendi che ci sembravano iniqui se confrontanti con quelli dei normali cittadini [...]. In questa foto potete apprezzare quale sia il contributo in aula di chi non si è tagliato neanche un euro dallo stipendio. Questa è una cosa che non leggerete mai sui giornali...si chiama realtà!", scrive includendo una nuova foto dell'aula. L'uso dei social network come strumento di denuncia anti-casta ha però fatto breccia anche nel Pd, con la senatrice Laura Puppato pronta a immortalare lo scarso interesse dei pidiellini sul tema esodati: "Question time con il ministro Giovannini su esodati e lavoro. Questi i banchi del centrodestra (Pdl e Lega). Vuoti. Deserti. Come quando si parlava dei terremotati dell'Abruzzo e dell'Emilia. Il lupo perde il pelo... ma non il vizio". Come ogni tormentone che si rispetti però, c'è anche qualche utente piuttosto stufo di questa cronaca costante. "Perché mai l'aula dovrebbe riempirsi ai question time?", scrive Paolo, "Basta col postare foto del Parlamento ad ogni respiro per far vedere che siete gli unici presenti: non è così che si fa i legislatori".
31 ore e 5 minuti è quanto sono stati impegnati i Deputati nel primo mese di Legislatura, dal 15 Marzo al 15 Aprile. Si tratta di poco più di 3 giorni lavorativi da 8 ore quando nello stesso periodo l'italiano medio ha lavorato 21 giorni. Ciò è dovuto sopratutto alla mancata istituzione della Commissioni Parlamentari. Infatti nelle 8 sedute d'Aula convocate hanno avuto luogo solo gli adempimenti istituzionali (elezione del Presidente della Camera, elezione dell'ufficio di Presidente, formazione dei gruppi, etc..) e le comunicazioni del Governo.
LA CASTA PERSEGUITATA ED INETTA. SE SUCCEDE A LORO…FIGURIAMOCI AI POVERI CRISTI.
Marina Berlusconi: "Ecco perché l'estremismo giudiziario può uccidere il Paese". In un'intervista esclusiva a Giorgio Mulè su Panorama il presidente di Mondadori e Fininvest ripercorre il calvario giudiziario di suo padre Silvio Berlusconi e definisce il processo Ruby "una farsa".
«E' un attacco concentrico. Un assedio. L’obiettivo è chiaro: colpire una volta di più mio padre, come politico, come imprenditore, ma anche nella sua dignità di uomo. E, una volta di più, per colpire Silvio Berlusconi non si fermano neppure davanti al rischio di fare danni gravi, molto gravi, all’intero Paese».
Marina Berlusconi lascia perdere i preamboli. La presidente di Fininvest e di Mondadori (editore, tra l’altro, di Panorama) va dritta al cuore del suo ragionamento e afferma: «Sbaglia chi pensa che oggi la questione riguardi solo le vicende giudiziarie di mio padre. No, siamo davanti a un’emergenza che riguarda tutti. E in questa situazione non è possibile tacere».
Pensa che le iniziative della magistratura possano far saltare gli accordi di governo?
Mio padre è stato molto chiaro. Non ce la faranno. Non la si darà vinta ai signori della guerra, a un sistema che da vent’anni paralizza l’Italia e su questa paralisi ha costruito le sue carriere e le sue fortune.
Anche perché il Paese ha uno straordinario bisogno di stabilità…
Credo che nessuna persona di buon senso possa tifare per l’instabilità. A maggior ragione chi di mestiere fa l’imprenditore. E, mi lasci aggiungere, se oggi, tra mille difficoltà, la politica tenta di superare le barricate e di garantire governabilità e stabilità, un grandissimo merito va proprio a mio padre. Con un atteggiamento molto responsabile e leale, più di tanti altri si è speso e si sta spendendo.
Beh, al di là delle dichiarazioni di principio, l’esecutivo deve ancora dimostrare quel che sa fare.
Il governo Letta di fatto non ha ancora cominciato a operare, verrà giudicato dai risultati. Quel che è certo è che abbiamo bisogno di scelte, e scelte veloci. Anche se sappiamo bene che non tutto dipende da noi, i vincoli dell’Europa sono pesanti. È in Europa che il governo si giocherà una partita decisiva.
Ma la Germania non sembra disposta a fare sconti.
Che questo rigorismo a senso unico non ci porti da nessuna parte è ormai evidente. Guardiamo a quel che sta succedendo nel resto del mondo. Di ricette alternative ce ne sono. Pensi per esempio agli Stati Uniti, e, su un piano ben più radicale, anche al Giappone. È presto per dare un giudizio, bisognerà vedere come andrà nel medio-lungo termine, ma qualche primo risultato positivo mi pare ci sia. E in ogni caso, anche se di formule magiche non ne esistono, resta il fatto che economie molto importanti hanno rifiutato la linea del rigore a ogni costo.
In Italia, però, ai problemi creati da una crisi economica drammatica, si aggiungono i guasti provocati dalla «guerra dei vent’anni».
È mostruoso il solo pensare che il destino del Paese passi per le mani di un gruppo di magistrati spalleggiati da qualche redazione e qualche arruffapopoli.
Così però si mette in discussione un principio cardine della nostra Costituzione: l’indipendenza della magistratura.
L’indipendenza della magistratura è un principio costituzionale sacrosanto. Il problema è che è stato usato per cancellare altri principi, altrettanto fondamentali. Si è fatto scempio dei più elementari diritti della persona: il diritto al rispetto della propria dignità, a una privacy, a non vedersi linciati sui media prima ancora non dico di una sentenza, ma di un processo… Hanno imposto un meccanismo in cui sono saltati tutti i confini tra personali opinioni di tipo morale, valutazioni di tipo politico, verdetti giudiziari. È un meccanismo diabolico, dove rischi di trovarti in totale balia dei personalismi e dei protagonismi di certe toghe. Che a volte sembrano proprio aver dimenticato quel che dovrebbero essere: servitori della giustizia, e non «giustizieri» in nome di qualche fanatismo ideologico.
Ma molti sostengono che suo padre insista sui problemi della giustizia soprattutto o solo perché lo riguardano da vicino.
So bene che oggi, con la crisi, le preoccupazioni delle famiglie sono altre. Ma dobbiamo tutti renderci conto che l’incertezza del diritto può distruggere un Paese. In una comunità in cui le regole vengono sovvertite, in cui basta anche un solo avviso di garanzia per cambiare il corso della politica o devastare la vita di un’azienda, in una comunità dalla quale le imprese che potrebbero venire a investire e creare benessere si tengono alla larga spaventate da questa giungla, ecco, non credo si possa far finta di niente dicendo: tanto a me non capiterà mai. A parte il fatto che può capitare a tutti – e ogni giorno leggiamo storie di condannati poi assolti, di assolti poi condannati, di innocenti finiti in galera, di criminali in libertà – a parte questo, quello della giustizia malata non è un concetto astratto, è un problema che tocca direttamente la vita quotidiana di ciascuno di noi.
Con queste critiche, ha già messo nel conto che sarà accusata anche lei di delegittimare la magistratura?
Credo che il problema, per la magistratura, non siano le critiche. Intanto, qui nessuno si sogna di criticare la magistratura, qui stiamo parlando di un gruppo non ampio di magistrati, a cominciare da una pattuglia di procure, che sono, quelle sì per davvero, procure ad personam. E poi, è proprio il comportamento di certe toghe a minare la credibilità della magistratura.
Facciamo un esempio concreto?
Gliene faccio uno fra i tanti. Pensi a quel pm che ha costruito la sua carriera politica sulle inchieste, naturalmente a vuoto, contro mio padre, che si è candidato alle elezioni senza nemmeno avvertire il pudore di dimettersi, che adesso, bocciato sonoramente dal voto, contesta la sua nuova sede di lavoro e continua a comportarsi, tra una dichiarazione infuocata e un tweet, come se non fosse a tutti gli effetti un magistrato ma un leader politico. Le pare normale tutto questo? Non meriterebbe un po’ più di attenzione da parte di chi, in Italia ma anche all’estero, è sempre pronto ad alzare il ditino scandalizzato?
Facciamo pure nome e cognome del pm di cui sta parlando: Antonio Ingroia.
Certo, facciamolo. Questo signore si permette di descrivere la Fininvest come una società che ha riciclato capitali mafiosi. E lo fa ignorando, o addirittura manipolando, i risultati dei processi nati dalle sue stesse inchieste, i quali non hanno potuto che dimostrare l'assoluta inconsistenza di ipotesi simili. Firmerò personalmente l'atto di citazione dei suoi confronti che gli avvocati stanno ultimando. Il tentativo di riproporre la storia del nostro gruppo come quella di un gruppo di malfattori è degno dei peggiori regimi sempre rispettato nel modo più totale le regole. Siamo una delle realtà imprenditoriali più significative del Paese. Negli ultimi vent'anni abbiamo pagato più di 9 miliardi di euro di tasse, ne abbiamo investiti 27, diamo lavoro a quasi 20 mila persone. E' troppo chiedere un po' di rispetto, che poi non è altro che il semplice rispetto della verità?
D’accordo, ma resta il fatto che non tutti credono alla tesi della persecuzione giudiziaria.
Quando è entrato in politica mio padre era, da tempo, uno dei più importanti imprenditori italiani. Era arrivato all’età di 58 anni senza ricevere nemmeno un avviso di garanzia. Poi, non si sa perché, anzi, mi correggo, si sa benissimo perché, nel giro di pochi mesi si è scatenato un attacco che dura ininterrotto da vent’anni e che peraltro non ha portato neppure a una condanna definitiva, nonostante 33 procedimenti. Qualcuno in buona fede può ancora mettere in dubbio che si tratti di persecuzione giudiziaria? Tutti dobbiamo essere uguali di fronte alla legge, e ci mancherebbe, ma anche la legge deve essere uguale per tutti.
E infatti per questo si celebrano i processi. Come quello sulla vicenda Ruby, per il quale il pm Ilda Boccassini ha appena chiesto una condanna a 6 anni di reclusione oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il processo Ruby? Quello non è un processo, è una farsa che non doveva neppure cominciare. Le presunte vittime negano, o addirittura accusano l’accusa. I testimoni dei presunti misfatti non ne sanno nulla. Di prove neppure l’ombra. Hanno lavorato per anni, hanno accumulato lo sproposito di 150 mila intercettazioni, hanno raccolto quintali di verbali, hanno vivisezionato in modo morboso e vergognoso la vita di mio padre e tutto per realizzare non un processo, ma una fiction agghiacciante a uso e consumo di media molto compiacenti. Certi interrogatori, nella loro sconcertante insistenza, facevano pensare ben più al voyeurismo che alla ricerca della verità. Finirà tutto in una bolla di sapone, come sempre, ma all’associazione della gogna non importa nulla di come andrà a finire, interessa solo la condanna mediatica. E, quando il teorema dell’accusa crollerà, quale interdizione dovrebbe essere chiesta per coloro che hanno costruito questa montatura infernale?
Intanto ci sono anche le condanne già pronunciate, come quella in primo grado per la vicenda dell’intercettazione su Unipol-Bnl…
Sì, l’uomo più intercettato d’Italia, il presidente del Consiglio che ha visto pubblicati sui giornali migliaia di suoi privati e ininfluenti colloqui, condannato senza la minima prova per una intercettazione di cui neppure conosceva l’esistenza. La prima e unica condanna del genere in Italia.
E' arrivata anche la condanna in appello per la frode fiscale sui diritti Mediaset tra il 2002 e il 2003.
Accusano mio padre per l’evasione di 3 milioni di euro, a fronte dei 567 milioni di imposte che il nostro gruppo ha pagato in quello stesso biennio. E ignorano due sentenze definitive sugli stessi fatti contestati, che lo scagionano completamente, chiarendo che non si occupa più, da tempo, delle aziende. Guardi comunque che all’elenco che lei sta facendo deve aggiungere una voce, pesantissima: gli attacchi al patrimonio. Quell’esproprio da 564 milioni per la vicenda del Lodo Mondadori, ma non solo.
Che altro?
Per chi avesse ancora dei dubbi sull’aria che tira nel palazzo di giustizia di Milano, c’è anche la sentenza sul divorzio di mio padre. La cifra fissata mi pare dimostri come ogni senso della realtà e della misura sia stato ampiamente superato.
Che cosa si attende dai processi in corso e dalle sentenze che arriveranno?
Posso dirle quel che dovrei attendermi. Una cosa soltanto. Giustizia.
Dopo la condanna per i diritti Mediaset, però, anche a sinistra si è sottolineato che non si può essere considerati colpevoli prima del giudizio di Cassazione.
Troppo facile pensare di salvarsi la coscienza recitando l’inciso rituale: «Premesso che nessuno può essere considerato colpevole fino a sentenza definitiva…», e poi però avanti, dagli addosso al Caimano. Di questo garantismo ipocrita non si sa che farsene.
Insomma, a suo giudizio questo Paese resta prigioniero dell’antiberlusconismo, della caccia al nemico che ha sostituito il confronto politico?
Uno dei più gravi errori della sinistra, che mi pare stia pagando a carissimo prezzo, è stato proprio quello di aver rinunciato a fare politica, ad affrontare l’avversario sul terreno della politica. Ha preferito illudersi che altri provvedessero, in altri modi. Si è consegnata così alle procure e a determinati gruppi editoriali, ma ha fatto anche di più: ha perfino inseguito un ex comico che straparla di golpe, sperando che fosse lui a toglierle finalmente le castagne dal fuoco. Sia chiaro, una sinistra così non è un bene per nessuno: prima torna la politica, la buona politica, e meglio è. Almeno questo, per quel che vale, è il mio auspicio.
…lasciando in questo modo ai grillini la bandiera dell’antiberlusconismo?
Facciamo chiarezza: per Grillo e i suoi guardiani della rivoluzione parlerei piuttosto di nullismo, con l’antiberlusconismo e con il loro essere antitutto tentano di mascherare il nulla assoluto di programmi e proposte. La politica avrà mille colpe, ma non può finire nelle mani di un gruppo di dilettanti, o replicanti, allo sbaraglio. Certo, se poi i replicanti dimostrano di avere un’anima e un portafoglio, e se l’antipolitica va subito a impantanarsi nelle questioni più «terrene» della politica, rimborsi spese e diarie, beh, chissà che non ci siano presto sorprese.
Ha appena accusato «determinati gruppi editoriali». Va da sé che in cima alla sua lista c’è L’Espresso-Repubblica. O no?
Va da sé, anche se devo dire che negli ultimi tempi, sul fronte dello sciacallaggio editoriale, la Repubblica ha ceduto abbondanti quote di veleno al Fatto. Ci sono media che sono diventati vere e proprie incubatrici permanenti di faziosità, di menzogne e di odio. E ci sono giornalisti che ormai conoscono solo l’insulto. Ma io mi auguro che chi ha scelto come mestiere quello di spargere odio conservi ancora quel minimo di obiettività per capire che questo gioco perverso rischia di sfuggirgli di mano, di diventare molto pericoloso. In Italia si respira un’aria brutta, un’aria incattivita, non solo nella rete, che è ormai lo sfogatoio della peggiore intolleranza, ma anche nelle piazze, lo abbiamo visto pochi giorni fa a Brescia.
L’Espresso-Repubblica ha un editore, l’ingegner Carlo De Benedetti, che ha appena definito suo padre un impresario, e non un imprenditore.
Certo che vedere De Benedetti dare lezioni di imprenditorialità… Proprio lui, con le macerie industriali che si è lasciato alle spalle… Altro che imprenditore: lui era e resta un inarrivabile prenditore, il numero uno di quel capitalismo cannibale che pensa solo ad arricchirsi senza dare nulla in cambio, anzi, costruisce le sue fortune sulle sfortune altrui. E non mi sorprende che ormai sembri un disco rotto, è innamorato della patrimoniale: la sua unica ricetta per risolvere i guai del Paese è quella di impoverire gli altri.
L’Ingegnere adesso sponsorizza Matteo Renzi alla leadership del Pd…
Sono questioni che non mi riguardano. Anche se, visto com’è andata a finire per tutti quelli che finora hanno ricevuto l’investitura dell’Ingegnere, fossi in Renzi magari qualche scongiuro lo farei.
Fin qui abbiamo parlato molto di antiberlusconismo. Ma mi dia una definizione del berlusconismo.
Posso parlare di quello che conosco, e benissimo: le idee, i valori, i tanti risultati che Silvio Berlusconi ha raggiunto. Ma quello che sento chiamare berlusconismo non so davvero cosa sia, semplicemente perché non esiste. Se l’è inventato l’antiberlusconismo per darsi una identità e legittimare se stesso. È la tattica vecchia come il mondo di creare, quando non hai idee migliori, un nemico che non c’è.
Da tutto quel che ha detto in questa intervista, si potrebbe obiettare che lei parla per amor filiale...
L’amore filiale c’è, chi ha intenzione di negarlo? C’è ed è enorme, perché mio padre se lo merita, per il padre che è sempre stato e per il padre che è. Sono orgogliosa di essere figlia di Silvio Berlusconi, non c’è mai stato nulla che potesse anche lontanamente incrinare questo orgoglio. Ed è un orgoglio che diventa ancora più grande per il coraggio con cui mio padre si difende e si batte per quello in cui crede. A volte mi chiedo come faccia a sopportare tutto quello che gli hanno inflitto e gli stanno infliggendo.
E quale risposta si dà?
È riuscito a rimanere sempre se stesso, a non cambiare mai. Di fronte ai successi ma anche agli attacchi più ignobili. Ha saputo affrontarli senza mai perdere il suo entusiasmo per la vita, il suo ottimismo, e senza mai lasciarsi andare alla rabbia, al rancore, al desiderio di vendetta. Reazioni che, con quel che gli hanno fatto, personalmente ritengo sarebbero state più che legittime.
Che cosa l’ha ferita di più in questi anni?
Tutto quel che mio padre ha dovuto subire e sta subendo mi fa star male. Ma c’è una cosa, una in particolare. Ed è la distanza siderale fra quello che lui è e il modo in cui in tanti cercano di dipingerlo. Sui giornali, in tv, in certe aule di tribunale. Quando vedo personaggi che di Silvio Berlusconi hanno fatto la loro spesso redditizia ossessione descrivere mio padre in un modo che non c’entra nulla, ma proprio nulla con quello che lui è veramente, sento tutto il peso di un’ingiustizia inaccettabile, ma provo anche una gran rabbia, la rabbia dell’impotenza, perché da questa ingiustizia è molto difficile difendersi. Ecco, questa è la cosa più insopportabile.
E questo, mi scusi, non è parlare per amor filiale?
No. Io parlo per amore di verità.
CASTA SENZA VERGOGNA.
Gli onorevoli sprechi di carta e pelle. La confessione di una deputata su “Libero Quotidiano”: in dotazione risme di carta di tutti i formati, dvd, cd. Ma oggi si comunica con sms e email. L’esperienza aiuta. Alla Camera ci vivo da quasi 6 anni, vedo e rifletto. La mia attenzione si concentra su due voci di spesa: carta e pelle. Cominciamo dalla carta. Quando sono arrivata alla Camera, nel 2006, l’azienda mi ha fornito, come se fossi una brava scolaretta, la cancelleria. Mi viene in mente quel meraviglioso primo film di Ermanno Olmi «Il posto». Il protagonista, al suo primo impiego, si siede al posto di lavoro e gli forniscono una matita, una gomma da cancellare e un blocchettino di carta. Sottolineo «una». A me arriva invece la cosiddetta dotazione annuale di cancelleria. Una marea di scatoloni. Ne apro uno: centinaia di buste piccole, da lettera, con l’intestazione Camera dei deputati, che troverò dappertutto. Ne apro un altro: centinaia di buste di media grandezza. Un altro ancora: i bustoni formato A5. Ancora: un altro tipo di busta normale, meno pregiata. Guardo il primo dei due armadi di cui è dotato il mio ufficio. Metà è già pieno. Continuo ad aprire. Una marea di contenitori metallici per l’archiviazione dei documenti. Dieci li metto nel secondo armadio. Gli altri dieci, o forse più, sul tetto della libreria. C’è un pacchetto di cartelline, belle, bianche bordate di verde chiaro: utilissime e purtroppo pochissime. E poi, ecco i fogli di carta: risme formato lettera, formato letterina, cartoncini, carta per fotocopie. L’armadio scoppia. Devo andare al secondo. Continuo ad aprire: penne, pennarelli, evidenziatori, due tipi di cucitrici con decine di scatolette di punti di ricambio, forbici, nastro adesivo, gomme morbide e dure, matite, elastici, colle liquide e cremose, Post-it di vari formati, fapunte per le matite, e poi cd, dvd, strutturine per archiviarli. Un cassetto della scrivania è tutto pieno. Sono alle prime armi, ma mi chiedo: quanto ci metterò a consumare tutta questa roba? Un anno, due anni, tutta la legislatura? Oppure meno? Tranquilla, se finisci tutto in tre mesi, puoi chiedere la dotazione trimestrale. Tutto quanto detto sopra diviso per quattro. Un giorno mi viene a trovare un impiegato della Regione. Vede tutto questo ben di Dio e imbarazzato mi chiede: posso prendere un po’ di matite? Qualche biro? Oh, che belli i Post-it. Ma guarda, i cD. Noi non abbiamo nulla. Se ne va con la borsa piena. In sei anni, credo di aver chiesto due dotazioni annuali. Radiocamera parla di richieste trimestrali continue da parte dei miei colleghi. Tutto legittimo, per carità. Credo si sia formata una cordata di assistenza di cancelleria a tutti quegli uffici pubblici che ne sono sprovvisti: uffici di polizia, carabinieri e vigili, uffici comunali, provinciali e regionali. Escludo l’Agenzia delle entrate ed Equitalia. Quanto può costare una dotazione annuale? Poiché siamo alla Camera in 630, non credo meno di tre milioni di euro anno. Basta ridurre del 50% la dotazione gratuita, e abbiamo risparmiato un milione e mezzo di euro. Ma siamo in piena era internet. Usiamo per comunicare sempre meno carta. E allora potremmo fare grandi risparmi, parecchie decine di milioni di euro, eliminando la versione cartacea della rassegna stampa, che tutti si possono leggere sul sito della Camera. Una sola cosa deve restare: la documentazione dell’aula. Per non parlare dei biglietti augurali, che sono dati gratuitamente ogni Natale ai parlamentari. Non li usa più nessuno, ma sono sempre stampati. Infine, l’altra voce di spesa: la pelle. E per pelle intendo le copertine delle agende. Ogni fine anno ci vengono date gratuitamente una agenda grande con lussuosa copertina nera, in vera pelle made in Italy e due piccole agende tascabili, sempre con copertina in pelle. Tutte e due con inciso sopra il proprio nome. Così è stato quando sono entrata in Parlamento. Nel nuovo anno mi aspettavo di ricevere il ricambio interno. E invece no. Sempre le agende integre. A casa ho una pila di copertine in pelle. Ma è mai possibile? Io mi chiedo se non sia possibile avere solo i ricambi. Scopro che esiste un magazzino sotterraneo dove oltre ai ricambi ci sono tante altre belle cosette, che non cito per carità di patria. Sono in pochi a sapere che esiste. Se penso a tutte quelle copertine in pelle che si buttano via, uno spreco che vale qualche milioncino di euro, mi chiedo se non sia arrivato il momento, in piena campagna demagogica contro la Casta, mettere mano agli sprechi dell’Azienda Camera, tagliando tutte quelle voci di spesa non essenziali. Un taglio netto, drastico, che vada anche a chiudere il ristorante aperto alla sera. Che senso ha il ristorante serale e tenerlo aperto quando a mangiare ci vanno quattro gatti? Lo si tiene aperto solo quando i lavori in aula sono in notturna. Mi fermo qui. Qualcuno dirà: sono briciole di risparmio. Qualche decina di milioni di euro non sono briciole, se si pensa che non riusciamo, uno dei tanti esempi, ad assegnare 20 milioni di euro per il sostegno territoriale ai servizi per i malati affetti da malattie rare. Ci vorrebbe una commissione apposita, fatta di parlamentari, non onerosa, costituita al fine di studiare e concretizzare la razionalizzazione dell’impiego delle risorse «aziendali».
CASTA ANTICASTA.
Per gli amici del M5S: i proclami anticasta che rischiano di diventare un boomerang. "Non è un' autoblù ma una vettura di servizio". È costretto a rifugiarsi in un sofisma degno degli azzeccagarbugli della Prima Repubblica, il vicepresidente dell'Ars Antonio Venturino. Per difendersi da un comportamento di cui non dovrebbe dare alcuna spiegazione: l'utilizzo di una vettura dell'Ars per un incontro istituzionale. Peccato che facciano sorridere le sue parole, e il web rilancia questo sentimento, se accostate a quelle che Venturino pronunciò solennemente in un video confezionato da M5S qualche mese fa: "L'autoblù? Può restare parcheggiata da qualche parte, noi non la utilizzeremo assolutamente". Non era affatto tenuto, il neo-deputato grillino, dice Emanuele Lauria, a fare quell'affermazione, a gettarla in pasto ai tifosi dell'antipolitica, a indicare un modus operandi estremo: niente benefit, in ogni caso. E invece eccolo qui, il seguace di Grillo, prendere carta e penna e scrivere al presidente dell'Ars per chiedere una vettura di servizio ("con autista", specifica) e poi balzare sul sedile di quel simbolo della casta. Eccolo qui respingere con fare scostante i rilievi: "Io non ho l'automobile e mica posso venire qui in bicicletta". Ora, a parte il fatto che Venturino dovrebbe spiegare perché fra gennaio e febbraio ha dichiarato di aver trattenuto 1.100 euro come "rimborso spese benzina", il punto è un altro: lodevole l'intento di eliminare sprechi e privilegi, encomiabile la restituzione di parte dei compensi da parte dei "cittadini a 5 stelle" eletti all'Ars. Ma risibile l'idea che la politica non abbia i suoi costi. Gli stessi grillini attingono alle spese dell'Assemblea (chissà fino a quando, se il decreto Monti sui trasferimenti ai gruppi sarà recepito anche in Sicilia) per pagare 13 collaboratori che contribuiscono a scrivere interrogazioni e disegni di legge. E non si scandalizzano per questo. E allora Venturino e i suoi colleghi dovrebbero riflettere sul fatto che i facili proclami a volte non pagano. Anzi, possono trasformarsi in formidabili boomerang. Specie se utilizzi la Rete che, come ben sanno gli esponenti di M5S, non perdona.
Milena Gabanelli: da candidata per il M5S a Casta. Report e la giornalista contestati per il servizio sulla trasparenza dei finanziamenti del M5S. Molti commentatori la difendono: "E' un simbolo di indipendenza", scrive Alberto Sofia su “Gionalettismo”. Da vincitrice delle “Quirinarie” del MoVimento 5 Stelle, per l’elezione del capo dello Stato, al servizio che incalza Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio sulla trasparenza. Non pochi telespettatori italiani sottolineano come Milena Gabanelli, attraverso le domande di Report al M5S, durante la puntata che mostrava le opacità nel finanziamento dei privati ai partiti, abbia dimostrato di “essere una giornalista indipendente e libera”. Su Twitter si sottolinea come Gabanelli non si sia fatta influenzare dall’essere risultata, poco tempo fa, la candidata più votata dai militanti grillini on line La giornalista, che aveva già rinunciato alla corsa per il Colle per proseguire il suo lavoro, non ha risparmiato nessuno. Ha così cercato di fare luce anche sui fondi del M5S, chiedendo al “Semplice Portavoce” Grillo se i proventi del blog vadano al MoVimento stesso. Oltre a domandarsi a quanto ammonti il guadagno della Casaleggio Associati dalla pubblicità del sito. Non tutti hanno apprezzato, soprattutto dalla base dei 5 stelle: “Qualcuno mi sa dire i motivi di questo attacco?”, si chiedono alcuni militanti. Altri criticano la giornalista e la trasmissione Report: “Avete fatto le pulci al M5S per essersi finanziato con 27.943 donazioni volontarie, a una media di 27 euro a testa. E per aver incassato 774.208, dei quali metà spesi per la campagna elettorale e il resto destinato al comune terremotato di Mirandola. Al contrario dei partiti che prendono milioni di euro pubblici”, attacca un commentatore. C’è chi reputa invece il servizio, realizzato da Sabrina Giannini, “troppo fazioso”. Report aveva spiegato come il blog di Grillo avesse raddoppiato l’audience nel mese delle elezioni: “Il successo del movimento ha dato più visibilità al sito dal quale Grillo lancia i suoi comunicati politici, richiamati dai mass media che così fanno aumentare i visitatori, quindi gli introiti”. Eppure emergeva il problema della trasparenza, dati i silenzi dei 5 stelle: “Difficile fare una stima del ricavo in pubblicità. Attendiamo l’ultimo bilancio della società di Casaleggio sperando che non sia generico come quello del 2011″, si sottolineava. Gianroberto Casaleggio, l’uomo che poteva rispondere ai quesiti di Report, ha preferito non rilasciare l’intervista. Ma la trasmissione della Gabanelli ha puntato la sua attenzione anche sullo staff di Grillo che si occupa della comunicazione. Messora, Martinelli, Biondo e “un’altra ragazza”, sono stati assunti in base a un accordo pre-elettorale stipulato dai candidati con Grillo. E vengono pagate con i fondi parlamentari. Ai militanti a 5 stelle non è piaciuto l’invito finale della Gabanelli: la giornalista ha spiegato come, con 3 milioni di disoccupati, il M5S dovrebbe smettere di parlare dei scontrini. “Il vostro 25% di voti tiri fuori tutte le idee che ha”, incalzava.
Beppe Grillo e la Casta del Movimento 5 stelle. Da Rocco Casalino a Magda Andreola. Lo staff dei comunicatori M5s costano 50 mila euro di soldi pubblici al mese, scrive Giovanni Florio su “Lettera 43”. Ma quanti soldi (pubblici) spende il M5s per il suo staff comunicazione? Visto poi che il movimento di Grillo non comunica coi giornalisti, non partecipa ai talk show, non fa conferenze stampa tanto «è tutto in streaming», non rilascia interviste, insomma non comunica, che ci stanno a fare la dozzina di comunicatori e addetti stampa dei gruppi pagati coi rimborsi al gruppo parlamentare 5 stelle? E poi, selezionati come? Per simpatia di Casaleggio? Per fedeltà a Beppe? Il dubbio sorge, vedendo la composizione del gruppo. Qualche esperto informatico, altri esperti di video, altri cosiddetti giornalisti. Il risultato finora è stato tragico: ai parlamentari M5s hanno hackerato le mail (che ci stanno a fare gli informatici nello staff?), i parlamentari grillini sono stati incastrati da telecamere nascoste e telereporter sgamati (che ci stanno a fare gli esperti di video nello staff?), e hanno collezionato una serie di gaffe e dichiarazioni choc alla stampa (che ci stanno a fare i giornalisti nello staff?). Il tutto per la modica cifra di 4 mila euro mensili ai coordinatori della comunicazione e 2 mila mensili ai 10 addetti. Pochissimi a detta di Rocco Casalino, ex Grande Fratello, uno degli assunti dal gruppo parlamentare (soldi nostri) per curare la comunicazione. «Ho scoperto che Grillo/Casaleggio hanno previsto 4 mila euro lordi per i ragazzi del gruppo comunicazione da fatturare con partita Iva, quindi senza 13esima e dovendo poi pagare tutti i contributi», ha scritto su Facebook. Non in una intervista perché il comunicatore pagato per comunicare non comunica coi giornalisti. «Quindi saranno 2 mila euro netti. Considerate che i ragazzi sono in trasferta lontani da casa». Poverini, 2 mila euro al mese, una miseria. Ma di grazia, Casalino, che concorso avete superato per ottenere quel posto? Un provino, come al Grande Fratello? In totale, per tutto lo staff M5s della comunicazione la spesa si aggira sui 50 mila euro al mese, ma è una stima a spanne, perché il gruppo non ha pubblicato un rendiconto. Un altra assunto è Dario Adamo, responsabile dei social network per i parlamentari del M5s. Dove l’hanno preso? Bè, non troppo lontano, alla Casaleggio e Associati Srl. Poi c’è una 30enne bresciana, Magda Andreola, trombata alle Regionali in Lombardia e riciclata come videomaker del gruppo parlamentare M5s, anche lei a 2 mila euro al mese. Andreola, che cita frasi di J.F. Kennedy pensando siano di Beppe Grillo, si definisce «la pasionaria del M5s di Brescia». E in effetti, da questo video, la passione sembra sconfinare nell’invasamento. Poi, altro assunto coi soldi del gruppo parlamentare, c’è Nick il Nero, camionista bolognese, famoso perché fa le clip mentre guida il Tir. Nick è molto vicino a Casaleggio, scelto perché fautore, insieme con la moglie, della faida che ha portato all’espulsione degli eretici Favia e Salsi dal M5s bolognese. Sul web un suo video che riassume una serie di riflessioni profonde sulla politica italiana («Due coglioni questi Favia e Salsi! Prendo più soldi ora a fare il camionista che a lavorare in Regione, non me ne frega un cazzo!»), è commentato così: «Leccocrazia a 5 stelle: questo è l'esperto di comunicazione di stelle. Lavora per i parlamentari 5 stelle pagato con i soldi nostri. Avevano detto che avrebbero assunto il personale parlamentare in base al curriculum. Questo 'signore' fino a ieri faceva il camionista, è stato assunto solo perché insieme con la moglie (consigliera 5 stella di Bologna) è tra i principali artefici dell'infame complotto per cacciare la Salsi e Favia da 5 stelle. Rendetevi conto, altro che meritocrazia, questa è leccocrazia del Grillo-pensiero». Poi ci sono giornalisti freelance e blogger, come Daniele Martinelli, Matteo Incerti, Nicola Biondo («Scrive per l'Unità, è stato consulente di diverse procure. Ha lavorato nella redazione di Blu notte di Carlo Lucarelli»), Claudio Messora, e appunto Rocco Casalino. E l’autista ufficiale che accompagna Grillo e i capigruppo alle riunioni importanti, anche al Quirinale, cioè quel Walter Vezzoli delle società off shore ai Caraibi (secondo l’inchiesta dell’Espresso). Anche lui pagato coi soldi pubblici del gruppo? Tutti loro, ha detto un parlamentare M5s (ovviamente anonimo, sennò lo cacciano) a Repubblica, farebbero parte del Cerchio magico di Beppe. «Ormai c'è un direttorio, un Cerchio magico che decide come devono andare le cose. Ne fanno parte Roberta Lombardi, Vito Crimi, gli uomini della comunicazione insieme con Roberto Fico, Carla Ruocco, Laura Castelli e Alessandro Di Battista. Sappiamo che si incontrano. Vorremmo sapere di cosa parlano». E anche quanto ci costano, già che ci siamo.
BEPPE GRILLO ANTI CASTA ED ANTI LOBBY? MA MI FACCIA IL PIACERE!!!!
Grillo vuol eliminare gli Ordini Professionali? No! Solo quello dei giornalisti e poi chiede che sia una “non giornalista” che fa la giornalista ad essere il Presidente della Repubblica.
C’E’ CHI FA IL VERO GIORNALISTA, MA NON LO E’, C’E’ INVECE CHI GIORNALISTA LO E’, MA NON LO MERITA.
Le “Quirinarie” sul blog di Beppe Grillo hanno finalmente eletto quello che – salvo rinunce – sarà il candidato presidente della Repubblica per il Movimento 5 Stelle: Milena Gabanelli, giornalista televisiva.
Un po’ il colmo che la persona che i pentastellati andranno a votare faccia parte proprio di quella «casta» che Grillo il 29 marzo 2013 definì «peggiore di quella dei politici». Per la precisione, sul suo blog il comico divise i giornalisti in tre categorie: «gli indipendenti (pochi, eroici e spesso emarginati), gli schiavi (tantissimi, sfruttati e pagati 5/10/20 euro a pezzo) e i Grandi Trombettieri del Sistema, nominati in posizioni di comando dai partiti e dalle lobby (direttori di testata, caporedattori, grandi firme, intellettuali per meriti sul campo)». La Gabanelli inoltre, viene fuori da quella stessa televisione di Stato che Grillo ha sempre definito una struttura «morta da un pezzo» nella quale «gli unici a non saperlo sono quelli che ci vanno».
Curioso che quindi una formazione politica porterà in auge un rappresentante di quello stesso universo tanto criticato. In merito si ricorda Vito Crimi, capogruppo al Senato, che il 21 marzo affermò «i giornalisti e le tv li sto rifiutando tutti perché mi stanno veramente sul cazzo» a degli studenti per Radio 24.
È dunque passata molta acqua sotto ai ponti dallo scorso 22 febbraio, quando Grillo concluse la campagna elettorale a Piazza San Giovanni: allora, i giornalisti furono esclusi dal backstage, ora verranno portati al Colle.
Questa è “Mi-Jena Gabanelli” (secondo Dagospia), la Giovanna D’Arco di Rai3, che i grillini volevano al Quirinale.
Milena Gabanelli intervistata da Gian Antonio Stella per "Sette - Corriere della Sera".
Sei impegnata da anni nella denuncia delle storture degli ordini professionali: cosa pensi dell'idea di Grillo di abolire solo quello dei giornalisti?
«Mi fa un po' sorridere. Credo che impareranno che esistono altri ordini non meno assurdi. Detto questo, fatico a vedere l'utilità dell'Ordine dei giornalisti. Credo sarebbe più utile, come da altre parti, un'associazione seria e rigorosa nella quale si entra per quello che fai e non tanto per aver dato un esame...».
Ti pesa ancora la bocciatura?
«Vedi un po' tu. L'ho fatto assieme ai miei allievi della scuola di giornalismo. Loro sono passati, io no».
Bocciata agli orali per una domanda su Pannunzio.
«Non solo. Avrò risposto a tre domande su dieci. Un disastro. Mi chiesero cos'era il Coreco. Scena muta».
Come certi parlamentari beccati dalle Iene fuori da Montecitorio...
«Le Iene fanno domande più serie. Tipo qual è la capitale della Libia. Il Coreco!».
Essere bocciata come Alberto Moravia dovrebbe consolarti.
«C'era una giovane praticante che faceva lo stage da noi. Le avevo corretto la tesina... Lei passò, io no. Passarono tutti, io no».
Mai più rifatto?
«No. Mi vergognavo. Per fare gli orali dovevi mandare a memoria l'Abruzzo e io lavorando il tempo non l'avevo».
Nel senso del libro di Franco Abruzzo, giusto?
«Non so se c'è ancora quello. So che era un tomo che dovevi mandare a memoria per sapere tutto di cose che quando ti servono le vai a vedere volta per volta. Non ha senso. Ho pensato che si può sopravvivere lo stesso, anche senza essere professionista».
Grillo, l'arcangelo della legalità tra condanne e condoni fiscali, raccontato da Giancarlo Perna su “Il Giornale”. Vive all’opposto di come predica e pensa il contrario di ciò che dice. Da ragazzo voleva giocare nella Sampdoria, incontra Baudo poi la Rai lo caccia. E si ricicla imbonitore politico. Ora che Beppe Grillo è un leader, abbiamo un altro spiantato che ha trovato rifugio nella politica, oltre a Di Pietro e De Magistris. Poiché vive all’opposto di come predica e pensa il contrario di ciò che dice, Grillo è continuamente costretto ad arrampicarsi sugli specchi e a spararle grosse. Poco male se fosse rimasto quel che era: un comico di cabaret. Ma poiché si proclama coscienza critica e arcangelo della legalità, è il caso di esaminare l’uomo quale si è manifestato nelle sue 64 primavere. Giuseppe Piero Grillo è cresciuto nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Il padre, Enrico, aveva un’aziendina di fiamme ossidriche, la «Cannelli Grillo». Ma poiché né il Giuse (suo vero diminutivo, Beppe è un nome d’arte), né il fratello ne seguirono le orme, l’officina fu ceduta ai dipendenti. Giuse, che era ragioniere, piantò economia e commercio dopo due anni e si mise in proprio. Provò a vendere jeans ma restò in braghe di tela e fu a lungo un bighellone. Stazionava al bar e tifava Sampdoria. Da ragazzino voleva diventare calciatore, ma - come raccontò il dirigente di un club - «era una balena e lo chiamavano Porcellino anche se aveva un buon tocco di palla». In squadra - ha scoperto Filippo Facci - giocavano altri due genovesi poi diversamente famosi: Antonio Ricci, l’inventore di Striscia la notizia, e il killer Donato Bilancia (diciassette omicidi, tredici ergastoli). Bilancia pareva così inoffensivo da meritarsi l’appellativo di «belinetta», diminutivo di belin, parola variamente usata a Genova: «Sei un belin!». Giuse intanto suonava la chitarra, aveva la battuta pronta e tirava tardi. Cominciò a fare del cabaret nelle balere con tiepido successo. Nei primi anni Settanta traslocò a Milano in cerca di miglior fortuna. Inalberò l’attuale barbone (pare per risparmiare sulle lamette) e approdò a «La Bullona», night in. Una sera entrò Pippo Baudo con una troupe Rai che cercava talenti da lanciare. Fu la svolta. Grillo piacque, ma altrettanto un suo amico cabarettista. Poiché l’attenzione di Baudo sul rivale si prolungava, Beppe ebbe una crisi di invidia e si dileguò. Più egocentrico della monaca di Monza, Grillo è soggetto a capricci da primadonna. Il regista Dino Risi, che lo diresse in Scemo di guerra (1984), ha raccontato: «Beppe si ingelosì del rapporto speciale che avevo con Michel Coluche. Così, per ripicca, si diede malato. Per due mesi dovemmo sospendere le riprese. Finché gli fu fatta balenare la minaccia di una penale: da buon genovese si ripresentò sul set». Anni dopo, quando già Grillo era come oggi, Risi aggiunse: «La cosa che gli è riuscita meglio è l’antipolitica. Ma è più attore adesso che non al tempo in cui girava il film. Grillo non crede affatto in ciò che scrive quotidianamente nel blog». Sotto l’ala di Baudo, divenne famoso in tv. Poi incappò nell’incidente. Il 15 novembre 1986, mentre presentava Fantastico 7, mise alla berlina Bettino Craxi, allora premier. Bettino era reduce da un mandarinesco viaggio in Cina con la sua corte e vagonate di champagne. Grillo fece lo spiritoso in diretta: «La cena in Cina... i socialisti... mangiavano... A un certo punto Martelli ha chiamato Craxi e ha detto: «Senti un po’, qua ce n’è un miliardo e sono tutti socialisti?». E Craxi ha detto: «Sì, perché?». «Se sono tutti socialisti, a chi rubano?». Così, fu cacciato dalla Rai e nacque l’imbonitore politico che conosciamo. Niente lo autorizzerebbe a impancarsi, poiché le sue notevoli magagne prevalgono sulle sue scarne virtù. È tirchio, avido, bugiardo e pregiudicato, anche se fa continui gargarismi con la parola legalità. Tutti sanno dell’incidente che causò alla vigilia di Natale 1981, correndo con un fuoristrada su una mulattiera ghiacciata delle Marittime. Tre morti: una coppia di amici e il figlioletto di nove anni. Nei tre gradi di giudizio cercò sempre di sminuire le sue responsabilità. Ebbe un anno e 4 mesi per «macroscopica imprudenza». Chiunque sarebbe rimasto annichilito, evitando per l’eternità di fare le bucce agli altri. Grillo invece, come si sveglia, insulta. Ha trattato da «vecchia puttana» Rita Levi Montalcini; ha dato del «coglione» a Maurizio Lupi; ha minacciato di prendere «a calci in culo» Franco Battaglia, nostro illustre collaboratore, reo di essere nuclearista e denunciare gli inganni ecologisti. Già, l’ecologia. Grillo se ne riempie la bocca ed è al centro del suo M5S. Ma gratta gratta, trovi il saccheggiatore. Il comico, che abita una satrapica villa a Sant’Ilario, vista Tigullio, ha sempre detto di usare poca energia e quel po’ solare. Su queste basi, attaccò l’Enel e l’allora presidente, Chicco Testa, un verde convertito al nucleare. Testa reagì in un’intervista: «Grillo non mi piace. Il suo blog è un concentrato di leggende metropolitane e populismo». Alludeva alle bufale ecologiste che Beppe spaccia ogni giorno via internet. Una volta scrisse che le onde di una coppia di cellulari avevano fatto cuocere delle uova. Un’altra, prendendosela con i detersivi, reclamizzò il biowashball, pallina di ceramica in grado di fare il bucato in lavatrice senza detergenti. Giurò che l’aveva sperimentata con successo. Ma era una bubbola dell’accidente. La biopalla, infatti, non è mai esistita perché era l’invenzione di un articolo satirico inglese per ridicolizzare le fisime ambientaliste. Grillo o ha abboccato da pirla o ha ingannato con dolo i seguaci del blog. Aggiungeva Chicco Testa di avere ordinato una verifica dei consumi di Grillo nel villone. «Diceva che a casa sua con il solare - raccontò Testa, citando la relazione tecnica - produceva tanta energia da vendere quella in eccesso. Venne fuori invece che da solo consumava come un paesino». La sua presunta autonomia energetica si riduceva a un paio di pannelli capaci di fornire al massimo due kilowatt, buoni per l’asciugacapelli. Il tenore di Beppe fa a pugni con lo sviluppo sostenibile di cui si proclama seguace. Ha avuto Ferrari, Porsche, Chevrolet, Maserati, yacht. Ha immobili a Genova, in Sardegna, Torino, Valle d’Aosta, una villa da milord in Toscana. È ricorso due volte al condono edilizio (1997 e 2002) e una a quello fiscale (2003). Ma, a ogni varo di condono, ha condannato con indignati proclami una «pratica che premia i disonesti». Col denaro Beppe non scherza. Ne sa qualcosa la seconda moglie, Parvin Tadjk, che dopo la spesa subiva dal marito controlli di tipo doganale sugli scontrini, al limite della perquisizione corporale. Antonio Ricci ha raccontato che dopo un pranzo «io sparecchiavo, e se buttavo delle briciole, Beppe le recuperava dalla spazzatura e ci impanava la milanese». Da quando ha aperto il blog, cuore del M5S, i suoi redditi sono balzati da 2.133.720 a 4.272.591 euro annui. Attira allocchi a migliaia e lucra con gadget, video, opuscoli ideologici sul «Vaffa Day» (pagamento cash e in dollari), in un sapiente intreccio tra ideali e pecunia. Grillo è ragioniere e i conti li sa fare bene.
Ecco alcune domande a cui Grillo non ha risposto e che Travaglio non ha fatto poste da Francesco Maria Del Vigo e Domenico Ferrara su “Il Giornale”. Dopo l'intervista a Grillo, Travaglio bacchetta chi ha osato criticarlo: "Dicono che le domande erano sbagliate, senza però suggerirci quelle giuste". Eccone alcune. In ginocchio o a schiena dritta? Questione di punti di vista. Per alcuni è stata un'intervista "zerbino", per altri un vessillo giornalistico da sfoggiare. Beppe Grillo concede due paginate di colloquio (così lo ha definito il vicedirettore del Fatto) a Marco Travaglio. E più che il contenuto delle affermazioni del leader del Movimento 5 stelle, stupisce la repentina metamorfosi di Travaglio: da fustigatore di ogni tipo di servilismo a interlocutore docile e mansueto. Tutta un'altra cosa rispetto a quello a cui ci ha abituato. Persino ai lettori del Fatto e ai grillini il colloquio non è andato giù. Sarà mica la prova che il giornale di Padellaro ha sposato le tesi del nonpiùcomico? Illazioni. E per assicurarlo è scesa in campo, prima, l'ad del quotidiano Cinzia Monteverdi (che tuttavia ha ammesso che forse avrebbe fatto qualche domanda in più a Grillo) e poi il diretto interessato (non prima di aver rivelato di aver votato due volte il Movimento 5 Stelle). Travaglio nel suo editoriale al vetriolo di ieri (eccolo rivestire finalmente i panni dell'implacabile accusatore) se l'è presa con i "migliori servi di regime" che impartiscono "lezioni di giornalismo" spiegando che le "domande erano sbagliate, senza però suggerirci quelle giuste". Eccole qui, ti aiutiamo noi. Ma non noi del Giornale, ché poi ci dici che siamo i soliti lacché. Basta che ti fai un giro in rete e cerchi "le domande che Travaglio non ha fatto a Grillo". Noi le raccogliamo e le giriamo al leader del M5S. Nella speranza che qualcuno le faccia e magari Grillo le raccolga. Non si sa mai...
1. I sondaggi vi indicano come seconda forza del Paese. Alle elezioni politiche, chi sarà il vostro candidato premier e con quali logiche verrà scelto?
2. Gianroberto Casaleggio, in una lettera al Corriere della Sera, si è definito il cofondatore del Movimento 5 Stelle, di cui ha scritto le regole, e ha ammesso di dare ai candidati consigli sulla comunicazione elettorale. Qual è il suo vero ruolo all'interno del Movimento?
3. E’ vero che Pizzarotti, neosindaco di Parma, ha telefonato a Casaleggio per chiedere il nulla osta sulla nomina di Tavolazzi (epurato da Grillo) a direttore generale?
4. Lei parla di trasparenza, ma poi (come lamentano alcuni militanti) le riunioni per decidere linee e strategie del M5S vengono fatte a porte chiuse e in forma privata. Non è un controsenso?
5. Lei collega internet alla democrazia diretta, ma poi i suoi interventi sul blog sono unidirezionali e sul web non risponde mai a nessuno, se non per emanare quelli che sembrano veri e propri editti (come quello di non andare in tv o come la minaccia di revocare l’utilizzo del simbolo del M5S). Un altro controsenso?
6. Lei parla di demolizione dei partiti e invoca un processo alla Norimberga. Ma perché nel luglio del 2009 ha annunciato la sua candidatura alla primarie del Partito Democratico?
7. Pensa ancora che lo ius soli (il diritto alla cittadinanza dei bambini nati in Italia da genitori stranieri) sia una questione priva di senso?
8. Nel Non Statuto sul tema del lavoro c'è solo il punto che prevede l'abolizione della legge Biagi. Avete altre ricette per contrastare la disoccupazione?
9. Facevi gli spot per le multinazionali e ora le critichi, come mai?
10. Credi ancora che l'Aids sia una bufala?
11. Perché nel 2000 spaccavi pc durante i tuoi spettacoli e ora veneri la tecnologia?
12. Il M5S è contrario alle coppie di fatto?
Sprechi, tagli sui servizi, disservizi e solita partigianeria.
Regione Puglia, Lazio, Sicilia e tutte le altre. Per favore non chiamatele Mafia.
«Un certo tipo di giornalismo, che va per la maggiore, produce un certo tipo di politica imperante. Questi promuovono un certo tipo di antimafia monopolista: di parte e di facciata. - spiega il dr Antonio Giangrande, presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie” www.controtuttelemafie.it , scrittore dissidente che proprio sul tema della mafia e della mala politica e della mala amministrazione ha scritto dei libri, tra i tanti libri scritti dallo stesso autore e pertinenti questioni che nessuno osa affrontare. - I soliti giornalisti promuovono ed i soliti politici finanziano iniziative della solita antimafia monopolista. Iniziative volte a dare un’immagine della mafia come la manovalanza del crimine organizzato. Per loro la mafia deve essere il cafone analfabeta con la lupara in mano che chiede soldi a strozzo o denaro in cambio di sicurezza. Come dire: affidati allo Stato che con i soldi estorti con le tasse esso sì ti presta i soldi e ti assicura benessere, istruzione, cultura, salute, giustizia e sicurezza (sic). Invece per me la mafia siamo tutti noi: omertosi, emulatori, collusi e codardi. Questo tipo di giornalismo e questo tipo di antimafia, che addita gli avversari politici o la manovalanza criminale come mafiosi, è foraggiato da questo tipo di politica, spesso regionale. Ed è foraggiato con i nostri soldi estorti con le tasse. Invece di denunciare lo sperpero di denaro pubblico per amicarsi un certo sistema d’informazione ed un discutibile sistema antimafia, ai consiglieri ed agli assessori regionali si dà la colpa di dilapidare i nostri soldi. Ed i cittadini lì ad imprecare. Però si fa finta di non sapere che quei soldi, di cui a volte facciamo finta di chieder conto, non sono altro che quelli usati (per voto di scambio) per attirare favori e benevolenza da parte di quell’elettorato, che oggi è indignato. Quei soldi servono per comprare il consenso per la rielezione di quei politici che oggi si manda all’inferno. Fa niente se per mantenere lor signori si chiudono ospedali e tribunali. Ma tanto per il sistema tutto ciò non è racket, anche perché è omertosamente taciuto. Sulle emittenti tv vi sono sempre servizi di parte, se non servizi che raccontano altre realtà (su Studio Aperto alle 12.47 circa di tutti i giorni vi è un servizio sulla famiglia reale inglese). Certo che a fare vera informazione si rischia l’oscuramento del portale web o la galera (ma solo per il direttore de “Il Giornale”, Alessandro Sallusti, vi è stato il polverone). Anche di questo una certa politica si deve fare carico. Sul nostro canale Youtube MALAGIUSTIZIA abbiamo dovuto montare e produrre un video sugli scandali alle Regioni. Un video tratto da servizi caricati sul web dal TG3, dal 884c25tv e dal TRnews di Tele Rama. Un video che è bene far vedere a tutti perché si dimostra che tutte le regioni sono uguali. Spezzoni video di tv anche locali. Vi è anche una parte riferita alla Regione Puglia di Nicola Vendola (dispensatore di sogni e di speranze), affinchè ci si renda conto con che tipo di informazione e di antimafia e di politica il cittadino si deve confrontare e che con questo sistema informativo è dura debellare.»
PAGARE LE TASSE: SI’, MA PERCHE’?
Per mantenere uno Stato con una classe dirigente di burocrati con i suoi funzionari inetti, esempio di sprechi e di inefficienza. Classe dirigente che, oltretutto, cura i propri interessi e non tutela i diritti dei cittadini. Un esborso complessivo di 152,2 miliardi. Niente di eclatante, ma per un Paese come l'Italia è un fatto storico. I dipendenti pubblici a fine 2010 erano 3 milioni 458.857. Se si misura il costo degli stipendi pubblici in rapporto ai cittadini, noi italiani spendiamo decisamente più dei tedeschi: 2.849 euro ciascuno, contro 2.830 euro in Germania. Ovvio. Meno ovvio, forse, che la nostra spesa procapite sia superiore anche a quella di Grecia (2.436) e Spagna (2.708). Va detto che ci sono Paesi anche più generosi dell'Italia. Per esempio il Regno Unito (3.118) e l'Olanda (3.557). Per non parlare della Francia (4.001), dove peraltro dovrebbe salire quest'anno ancora di 4 miliardi. Il vero problema non è però il livello della spesa, peraltro perfettamente allineato alla media europea dell'11,1% del Prodotto interno lordo (anche se di ben 3,2 punti superiore alla Germania dove in dieci anni è calato dello 0,3% mentre da noi è salito dello 0,6%).
Piuttosto, la sua efficienza, e qui sta il vero problema della pubblica amministrazione made in Italy. Lo dice senza mezzi termini un rapporto della Corte dei conti: «In un contesto caratterizzato dalla perdita di competitività del sistema Italia preoccupanti segnali riguardano la produttività del settore pubblico». In quella relazione appena sfornata dalla magistratura presieduta da Luigi Giampaolino c'è un grafico che mostra come proprio la produttività, cresciuta nel 2010 di oltre il 2%, sia tornata nel 2011 a zero, ricominciando nel 2012 perfino a scendere «in linea con le stime dell'andamento del Pil». Dunque, il costo del lavoro per unità di prodotto riprende a salire. Di chi la colpa? L'assenza della meritocrazia. Rielaborando i dati della Funzione pubblica, la Corte dei conti giunge a questa conclusione: «la fruizione di aspettative retribuite, permessi, permessi cumulabili e distacchi relativamente al 2010 può essere stimata come l'equivalente all'assenza dal servizio per un intero anno lavorativo di 4.569 unità, pari a un dipendente ogni 550 in servizio». Con un costo «a carico dell'erario» pari a 151 milioni. E «al netto degli oneri riflessi».
L’impero sindacale pagato dallo Stato: 151 milioni di euro all’anno. Relazione sul costo del lavoro pubblico. Maggio 2012. E’ uscito l’ennesimo studio, ma questo è serissimo perché è la Corte dei Conti che mette a nudo – ma non troppo – quel mondo oscuro che si chiama “sindacato” composto in gran parte da personale distaccato del pubblico impiego affinché quella sorta di truppa composita meglio conosciuta sotto la denominazione di “organizzazione dei lavoratori” non abbia oneri a proprio carico. Il folto stuolo di dipendenti sindacali percepiscono lauti stipendi e contributi Inps direttamente dallo Stato ma non lavorano per lui, come Servitori, bensì occupano posti nelle associazioni private, chiamate appunto Sindacati. Beneficiano di leggi proprie come fossero una zona franca, una Repubblica di San Marino. Nessuno può controllare i loro bilanci perché, lor signori, i sindacati, non si sono mai adeguati alla norma costituzionale che li obbliga da oltre sessant’anni alla registrazione. Prima o poi dovrà finire anche questo ultimo baluardo. Per ora si fanno i conti, poi si vedrà. Come la immunità dell’Imu sugli immobili di loro proprietà (sono tanti, interi palazzi e lussuose residenze), al pari del Vaticano. Ma quanto costano all’Italia i sindacalisti che possono agevolmente chiedere di essere distaccati dal proprio posto di lavoro continuando a percepire lo stipendio di pubblico impiegato? La Corte dei Conti ha analizzato a quanto ammontano i costi che lo Stato sopporta per aspettative retribuite, permessi, permessi cumulabili e distacchi. Ecco i numeri da brivido. La fruizione di questi istituti per il 2010 può essere stimata come equivalente all’assenza dal servizio per un intero anno lavorativo di 4.569 unità di personale, pari ad un dipendente ogni 550 in servizio. Applicando a tale dato il costo medio di un dipendente pubblico, il costo a carico dell’erario è stato di 151 milioni di euro al netto degli oneri riflessi. Bazzecole? Forse queste “logiche” che non hanno più senso, visto il ridimensionamento del finanziamento pubblico ai partiti, dovrebbero essere riviste dal governo. Senza contare che l’oligarchia sindacale con i contributi dello Stato – a parte i permessi e i distacchi – ha creato un vero e proprio Impero economico, sociale e politico (leggasi Caf, Patronati, società dentro altre società, scatole cinesi, consorzi, Ati, formazione professionale e chi più ne ha ne metta).
Altro che Quarto Potere.
Una riprova che dell’inutilità e della dannosità di questo sistema la fornisce Maurizio Tortorella su “Panorama”: Quando lo Stato non funziona. L’Italia dei mille commissari straordinari. Altro che pizza, mafia, mandolini. E dimenticatevi anche i santi, i poeti, i navigatori. In realtà siamo un popolo di commissari straordinari.
L’ultimo, fresco di nomina, è Enrico Bondi. Alla tenera età di 78 anni è stato appena assunto dal governo Monti per occuparsi di quei tagli alla spesa pubblica che nessuno, nemmeno il governo dei tecnici, pare in grado di fare. Il compito di Bondi, effettivamente, tutto è tranne che ordinario. Ma forse il grande risanatore della Parmalat non sa che sta per sedersi nel girone più trafficato tra quelli, pure affollati, della pubblica amministrazione. Certo, a volte i commissari straordinari sono chiamati a occuparsi di problemi dannatamente seri, come terremoti e alluvioni: Claudio Burlando, governatore ligure, è commissario ai danni provocati dal maltempo alla fine di ottobre. Poi ci sono i commissari designati a ripulire un ente locale dalle infiltrazioni mafiose: tra i 943 comuni appena andati alle urne quelli commissariati erano 162, uno su sei. E non si tratta solo di mafia: il ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri, prima di salire al governo, per 14 mesi è stata commissario al Comune di Bologna, sciolto per il sexy scandalo che aveva travolto il sindaco Flavio Delbono. Ma ormai non c’è ambito della vita pubblica che non esiga un commissario straordinario. Come se non bastassero assessorati e uffici tecnici di comuni, province e regioni, basta una minima emergenza ambientale, un’esondazione o una franetta, e subito parte una nomina. I radicali hanno calcolato che in questa legislatura, e soltanto dal maggio 2008 all’agosto 2010, in 104 riunioni del Consiglio dei ministri sono stati adottati 154 provvedimenti d’urgenza. Non serve nemmeno un incidente concreto: oggi non c’è regione italiana che non abbia il suo commissario straordinario “delegato all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” (la dizione è barocca, ma sorprendentemente comune). Ed è così anche in altri settori. Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Calabria, per esempio, sono commissariate per i conti in rosso della sanità, e i commissari sono i rispettivi presidenti. Ma basta che i bilanci di un ente pubblico zoppichino, o che i lavori per una strada avanzino troppo lentamente, oppure anche che ci sia da organizzare una manifestazione un po’ complessa, e subito scatta l’emergenza, con il suo commissario. È la dimostrazione che l’amministrazione ordinaria non funziona, per colpa di una burocrazia che l’avvolge come le incrostazioni sulla chiglia del Titanic affondato: così ci si affida al “deus ex machina”, che per legge ha meno vincoli e più capacità decisionale. Ovvio, non è detto che lo strumento sempre funzioni. Passò alla storia l’ex ministro dei Lavori pubblici Paolo Costa (che da sindaco di Venezia sarebbe poi divenuto commissario straordinario al moto ondoso): nel 1997 nominò in un colpo solo 152 commissari per altrettanti cantieri bloccati. Quattro anni più tardi la Corte dei conti censurò il risultato: “Proprio la soluzione del commissariamento, e la retribuzione dei commissari” scrissero i giudici “potrebbero avere favorito il protrarsi di fattispecie sostanzialmente prive di sbocchi”. Tradotto: perché mai i commissari avrebbero dovuto accelerare i cantieri, se avrebbero perso l’indennità? Un po’ cinico, forse, ma realistico. Era stata la legge 400 del 1988 a istituire i commissari: la norma stabiliva che il governo potesse farne uso per fronteggiare “temporanee esigenze” o per “realizzare specifici obiettivi”. Un quarto di secolo dopo la sua logica è stata stravolta e, neanche avessero fatto proprio l’incitamento biblico, i commissari sono andati ovunque e si sono moltiplicati. Quanti sono oggi? Nessuno azzarda un numero, perché le fonti istitutive (regioni e ministeri) sono troppe e le situazioni sono in continua evoluzione. Nemmeno alla Corte dei conti, che pure dei commissari dovrebbe monitorare costi e risultati, sanno rispondere. Nel febbraio 2005 Il Sole 24 Ore riuscì a strappare una cifra alla direzione generale del personale dello Stato: “Secondo le nostre stime” risposero da quell’ufficio “siamo nell’ordine dei 10 mila, al 70 per cento nelle regioni meridionali”.
Troppi? Il numero resterebbe sconvolgente anche dimezzato: di certo, è il simbolo di un paradosso e di una sconfitta. Dice il grande amministrativista Sabino Cassese: “I commissari straordinari sono il sintomo del problema, della malattia. Si ricorre a loro, sempre di più, perché l’amministrazione ordinaria non funziona”. Del resto, perfino la Croce rossa italiana è arrivata al terzo commissariamento (il primo era durato 18 anni, dal 1980 al 1998): dal novembre 2008 è affidata a Francesco Rocca, retribuito con 190-200 mila euro lordi l’anno per sanarne i bilanci. Un compito lungo: in base al decreto dell’ex ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, Rocca doveva stare lì per “un periodo non superiore ai 12 mesi”; invece è stato appena prorogato fino al 30 settembre. Sarà forse che, per convenzione, nessuno può sparargli addosso…Ma non è a Rocca che spetta il record di longevità. La Corte dei conti, alcuni mesi fa, ha censurato la decima proroga del commissaro straordinario al passante di Mestre: Silvano Vernizzi (80 mila euro l’anno) è lì dal marzo 2003 a occuparsi di accelerare espropri, appalti, asfalti. Il passante, costato 986 milioni di euro, è stato inaugurato dopo 12 anni di lavori nel febbraio 2009, ma la carica di Vernizzi scadrà soltanto alla fine di questo maggio. Fino al 31 dicembre insisterà però nel ruolo di commissario straordinario alla pedemontana veneta, che più modestamente copre dal 2009. Ancora più lungo è il curriculum di Carlo Schilardi, 63 anni, consigliere di stato. Dal 7 agosto 1997 è commissario straordinario “per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della legge n° 219/1981″. A Napoli, dietro la misteriosa dizione, Schilardi e una dozzina di addetti prestati dalla Regione Campania e dal ministero del Tesoro affrontano un compito certosino, retribuito con circa 100 mila euro d’indennità aggiuntive: da 15 anni coordinano la difesa legale dell’amministrazione pubblica dall’assalto delle imprese concessionarie che dopo il terremoto del 1980-81 si occuparono della ricostruzione di Napoli e ancora lamentano mancati pagamenti o danni, e si oppongono alle pretese dei 4 mila privati che ancora reclamano risarcimenti per gli espropri subiti. “Quanto durerà ancora? Dipende dai tribunali” risponde Schilardi. Non si sa bene da cosa dipenda, invece, la durata del commissariato al “superamento dell’emergenza socioeconomica del bacino idrografico del fiume Sarno”: l’alluvione che causò 160 morti è del 5 maggio 1998, 14 anni fa. Da commissari a Napoli si sono alternati alti burocrati e perfino generali, come Roberto Jucci. L’attuale è Flavio Cioffi, già commissario dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo. Proprio la Campania, in molti casi, mette in scena un vero teatro dell’assurdo. Prendiamo i rifiuti. Il primo commissario straordinario, nel febbraio 1994, fu Umberto Improta. Dopo di lui, in una catena ininterrotta, vennero Antonio Rastrelli, Andrea Losco, Antonio Bassolino, Corrado Catenacci, Guido Bertolaso, Alessandro Pansa, Umberto Cimmino, Goffredo Sottile e perfino l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Da ultimo, con un decreto del maggio 2008 sfacciatamente intitolato “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nello smaltimento dei rifiuti in Campania”, il bubbone venne rifilato nuovamente a Bertolaso, che lo risolse nel 2009. Ma Napoli continua a rigurgitare di rifiuti. In certi casi servirebbe un commissario ai commissari straordinari. Vista la durata dei problemi “urgenti”, e data la lentezza degli interventi, a volte il commissariato è addirittura ereditario: Giuliano Pisapia, dal maggio 2011 sindaco di Milano, è commissario straordinario all’Expo del 2015 esattamente come lo era stato il suo predecessore, Letizia Moratti. Capita anche che il successore smonti il lavoro compiuto da chi lo ha preceduto. L’ex capo dell’amministrazione penitenziaria, Franco Ionta, nel gennaio 2009 era stato nominato anche commissario straordinario all’edilizia carceraria. Dal dicembre 2011 la carica è passata ad Angelo Sinesio, ex commissario straordinario dal 2006 al 2008 di un comune siciliano sciolto per mafia, Roccamena. Oggi annuncia: “Faremo a meno di 220 milioni rispetto al vecchio piano carceri e costruiremo soltanto nuovi padiglioni. Così avremo 11.573 posti in più”. Decine, se non centinaia, sono le asl, i parchi, i teatri commissariati. Nell’ultimo bimestre è toccato prima al Petruzzelli di Bari: restituito al pubblico nel 2009, 18 anni dopo il rogo che l’aveva distrutto, ha già accumulato un buco di bilancio fra 3 e 5 milioni.
Così il 1° marzo è stato affidato al commissario straordinario Carlo Fuortes, che resterà almeno fino al 31 agosto (24 mila euro per sei mesi). Poi è stata la volta del Parco delle Cinque terre: il 18 aprile Vittorio Alessandro, capitano di vascello, s’è imbarcato come commissario. Resterà fino al 18 agosto (35 mila euro per quattro mesi). Salvo proroghe. Centinaia, se non migliaia, sono gli eventi che inspiegabilmente richiedono un commissario straordinario. Dal 23 aprile 2012 l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Carlo Malinconico, travolto in gennaio dallo scandalo delle vacanze pagate dall’imprenditore della “cricca” Francesco Piscitelli, è stato ripescato alla Fondazione valore Italia con il compito di realizzare un’esposizione del made in Italy all’Eur e con uno stipendio ancora da stabilire. Il 29 maggio Papa Benedetto XVI visiterà Milano, per la Festa delle famiglie, e il prefetto Gian Valerio Lombardi è già stato nominato commissario straordinario. In altri casi la nomina si colora di una pompa inversamente proporzionale all’utilità. Dal 2003 al Viminale esiste un commissario straordinario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione. Ma la polizia che ci sta a fare? E c’è anche un commissario straordinario al fenomeno delle persone scomparse: lo nomina sempre il ministro dell’Interno e l’ultimo si chiama Michele Penta, un prefetto che è lì dal 22 luglio 2009 e ci resterà fino al 2 giugno incassando un’indennità aggiuntiva di 3.700 euro mensili. Lunghissimo è infine l’elenco degli enti pubblici comissariati. Dal marzo 2011 Gian Luigi Rondi, 91 anni, è alla Siae, la società degli autori ed editori. Massimo De Felice dal 12 aprile 2012 è il nuovo commissario dell’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: retribuito con 137 mila euro lordi, dovrebbe diventarne presidente effettivo. Intanto dichiara, bellicoso: “Riteniamo che il ruolo dell’Inail debba essere valorizzato e riattivato con maggiore impulso”. Buon lavoro. Il 24 aprile 2012 il presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, ha dichiarato che per problemi di finanziamento anche il prestigioso istituto di statistica “rischia il commissariamento”. E l’istituto Invalsi, che si occupa della valutazione delle scuole, dal marzo scorso ha un commissario: è Paolo Sestito, dirigente della Banca d’Italia. Perfino l’Aeroclub d’Italia ha il suo commissario: Giuseppe Leoni, senatore leghista, è lì dal 2002. È stato al centro di polemiche, una recente interrogazione parlamentare lo accusava di malversazioni, c’è stato anche un esposto alla Corte dei conti. Inossidabile, Leoni è stato confermato il 16 aprile e continuerà a volare almeno fino a giugno. Disastri reali. Urgenze vere. Impegno concreto. Ma anche intrallazzi, favori, nepotismo. È così che il fenomeno dei commissari straordinari cresce, si gonfia, diventa indigestione. C’è chi azzarda un costo folle: 1 miliardo all’anno. Chissà se ne vale la pena. Per fortuna l’ultimo commissario, Enrico Bondi, ha annunciato che rifiuterà i suoi 150 mila euro. Questo sì, è straordinario.
PARLIAMO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA.
Gli italiani, soliti ignavi, non lo dicono, ma dimostrano il loro odio e disprezzo, o comunque il loro distacco dalla politica contemporanea che viene da lontano con l’astensionismo od altre forme di protesta.
La politica interessa solo a 3 italiani su 10 e magari.
Secondo Renato Mannheimer su “Il Corriere della Sera” la politica interessa solo a 3 italiani su 10 e magari, dico io, proprio perché interessati dai favori richiesti e ricevuti.
I risultati delle ultime amministrative hanno dato una scossa violenta alla vita dei partiti. L'elevato tasso di astensione, il gran numero di schede bianche e nulle (di cui troppo poco si è parlato) e il successo di un movimento antipartitico come la lista 5 stelle hanno mostrato tutta la debolezza delle forze politiche tradizionali nell'opinione pubblica italiana. D'altra parte, questo scarso appeal dei partiti era già stato indicato dalle ricerche che mostravano il decrescere progressivo del grado di fiducia nei loro confronti.
Diversi esponenti politici avevano obiettato che, malgrado il consenso per l'insieme delle forze politiche si fosse costantemente ridotto, il supporto per i singoli partiti - ciascuno si riferiva in particolare al proprio - non aveva probabilmente subito un trend siffatto. I risultati delle elezioni hanno mostrato che le cose non stanno così. Ma lo hanno indicato, prima e dopo le consultazioni, anche le risposte ai sondaggi, che ci offrono una serie di indicazioni ulteriori a quelle emerse dal voto. Essi confermano ad esempio come anche la fiducia espressa per ciascun partito sia molto esigua. La sfiducia verso i partiti si inquadra in un più generale trend di disaffezione da tutte le principali istituzioni politiche, anch'esso accentuatasi negli ultimi anni. L'indice sintetico di fiducia per le istituzioni politiche elaborato da Ispo (che misura, attraverso un algoritmo statistico, il consenso verso diverse istituzioni, dall'Ue al Parlamento, al Governo, fino al presidente della Repubblica) mostra al riguardo un calo drastico al valore del 25,5 di oggi. A questo calo di fiducia complessiva corrisponde una altrettanto drastica diminuzione del livello di interesse verso gli avvenimenti politici. Anche questo è un trend in corso da molto tempo: nell'aprile 2006, il 56% della popolazione dichiarava di essere in qualche misura («molto» o «abbastanza») interessato alla politica. Oggi questa percentuale si è drasticamente contratta, superando di poco il 30%, ciò che significa che il 70% degli elettori - era il 43% nel 2006 - afferma di non occuparsi di vicende politiche. Insomma, la politica è seguita oggi da meno di un italiano su tre. Appare relativamente più interessata la generazione di età centrale (35-55 anni), specie tra coloro che si collocano nel centrosinistra o nella sinistra tout court . L'interesse è poi notevolmente più alto (61%) tra i laureati. D'altra parte, il calo di attenzione per la politica è percepito anche soggettivamente dagli stessi cittadini. Ben il 43% dichiara infatti di avere ridotto il proprio interesse per le tematiche politiche anche (per alcuni, specialmente) a seguito dei numerosi scandali che hanno coinvolto svariati partiti ed esponenti politici. Un fenomeno siffatto si è manifestato con particolare intensità tra i meno giovani, tra le casalinghe e, ovviamente, tra i meno partecipi politicamente. Il quadro complessivo che emerge da questi dati è dunque assai critico. I risultati prima delle politiche e poi delle amministrative non sono che un segnale evidente del clima di opinione del Paese. Alla sfiducia nelle istituzioni - e nei partiti in particolare - corrisponde un senso di impotenza (e talvolta, ma in modo minoritario, di rabbia) tra i cittadini che finisce col tradursi nella scelta di forze politiche che «rappresentino» la protesta o, più spesso, in un disinteresse per quanto accade nel mondo politico che si traduce nell'astensione.
PARLIAMO DI VOTO DI SCAMBIO IN PARLAMENTO: NATURALMENTE IMPUNITO!
Cari Amici, siete curiosi di vedere da vicino cos'è la legge mancia? Franca Rame, la moglie del Nobel Dario Fo, lo spiega sinteticamente: “Si tratta di una risoluzione che indica al Governo una serie di finanziamenti a pioggia. Attenzione però, non si tratta di un provvedimento all'esame dell'aula, ma solo della commissione bilancio di Camera e Senato: ovvero viene decisa "a porte chiuse" o quasi dai membri delle due commissioni.”
E’ stato grazie alla invenzione (come il motore a scoppio) di questa legge: “mancia” appunto, come quella che si da al garzone, da parte del già ministro dell’Economia, Tremonti, nel 2003, che la scuola Bosina di Emanuela Marrone in Bossi ha potuto riscuotere 1 milione e 120mila euro in tre tranche. “Un finanziamento superiore anche a quanto denunciato dalla leghista Rosi Mauro, vicepresidente del Senato”, specifica il Sole 24Ore, “che aveva parlato di almeno 800mila euro arrivati grazie alla 'scorciatoia' di questo strumento che garantisce soldi sicuri per piccole opere 'segnalate' come bisognose di aiuti da deputati e senatori.” E grazie a questa brillante idea elargitoria, in forma di “mancia”, è stato finanziato di tutto per l’ammontare, dal 2005, della bellezza di oltre mezzo miliardo di euro. Abolita dal Governo Prodi, è stata ripresa nel 2008 da Berlusconi per un importo di 265 milioni ripartito per altre necessità, tra il clientelare e l’amichevole, fino all’ultimo stratagemma, in forma di emendamento, del leghista Massimo Garavaglia che ha scovato altri 150 milioni per l'anno 2012 e per il 2013. “La legge mancia è una colossale porcheria. E’ grave che il governo Monti l’abbia mantenuta in vita, nonostante i nostri emendamenti che ne chiedevano la soppressione”, ha dichiarato in una nota Antonio Borghesi, vicepresidente del gruppo IDV alla Camera. “Come abbiamo già fatto in passato destineremo la quota di nostra competenza alla riduzione del debito pubblico”. Anche per questo ci sorge sempre un dubbio: vuoi vedere che i sacrifici imposti attraverso le tasse, compresi i tagli sanguinolenti alla scuola, sono indispensabili per dare mance ai tanti fornitori del palazzo? Broches in cambio di pane?
Hanno legalizzato il voto di scambio: ora si chiama legge Mancia
Gli onorevoli dispongono di 120 milioni di euro che possono dare direttamente a terzi senza passare per alcun controllo. Bossi, ad esempio, ha usato questa legge per "donare" 800.000 euro alla scuola privata di sua moglie.
“Legge mancia”. La legge non prende il nome dal suo ideatore, ma dal fatto intrinseco: centinaia di milioni vengono ogni anno - a partire dal 2004 anno in cui l’allora Governo Berlusconi la rese legittima – suddivisi fra quei circa 120 Parlamentari che ne fanno un pò ciò che vogliono.
Teoricamente, la Legge parla di sviluppo economico, competitività, stabilizzazione della Finanza Pubblica ed anche di perequazione tributaria. Teoricamente, appunto. Perché i tanti milioni stanziati dal 2004 ad oggi, sono serviti solo ai soliti Parlamentari a “farsi belli” con il denaro dei contribuenti. Un finanziamento ad un Ente inutile. Un altro alla parrocchia tal dei tali. Un altro ancora ad un misconosciuto ente privato...Senza alcuna vergogna, in tempi di crisi nera e con finanziarie correttive o meno capaci di affossare anche il più speranzoso cittadino italiano, questo DL, subito convertito in Legge, altro non è se non – appunto – la possibilità di dare a destra e manca qualche mancetta (nemmeno troppo mancetta) in maniera da assicurarsi una buona fetta di elettorato al momento giusto. Ebbene sì: lo stato Italiano, il Governo italiano, distribuiscono denaro pubblico a piene mani al solo scopo di rendere Legge il voto di scambio. Una enorme truffa. Una aberrazione tossica nel nostro sistema giuridico. Si spaccia per Legge buona ed equa, una Legge che determina l’assoluta legalità di un obbrobrio quale da sempre è – appunto – la bagarre del voto di scambio. In Italia da sempre, intere regioni – in special modo al Sud - vengono tenute sotto schiaffo per anni, specialmente per ciò che riguarda il tema del lavoro, per poi profondere favori di ogni tipo al momento giusto. Ed il momento giusto è sempre la nuova tornata elettorale. Che sia addirittura una Legge a stabilirne la legalità, è una delle cose più illegali che si possano leggere. Nel 2012 poi addirittura, dopo esser stati tutti bastonati a sangue dalla manovra “correttiva” in odore di soldi ad ogni costo, ben 120milioni vengono stanziati per la Legge mancia, con la scusa delle migliorie strutturali necessarie agli istituti scolastici. In pratica: la Commissione Bilancio e Cultura della Camera, stanzia i 120 milioni, motivando il finanziamento con l’urgente necessità di ristrutturare i tanti edifici scolastici che crollano solo a guardarli. Nella realtà dei fatti, questo denaro verrà equamente distribuito fra i parlamentari che potranno poi utilizzarli a proprio piacimento e senza dover dare conto sull'utilizzo a nessuno, finanziando parrocchie, enti inutili, enti sconosciuti e pure imprese private. A volte di proprietà di un familiare del parlamentare di turno. Come nel caso degli 800mila euro elargiti alla scuola Bosina s.r.l. di Varese per il triennio 2009/2011 la cui fondatrice si scopre essere - udite udite - la consorte di Umberto Bossi, signora Manuela Marrone, maestra elementare.
PARLIAMO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO.
Il finanziamento pubblico ai partiti è una delle modalità, assieme alle quote d'iscrizione e alla raccolta fondi, attraverso cui i partiti politici reperiscono i fondi necessari a finanziare le proprie attività.
Il finanziamento pubblico ai partiti in Italia
La legge Piccoli
Il finanziamento pubblico ai partiti è introdotto dalla legge Piccoli n. 195 del 2 maggio 1974, che interpreta il sostegno all'iniziativa politica come puro finanziamento alle strutture dei partiti presenti in Parlamento, con l'effetto di penalizzare le nuove formazioni politiche. Il flusso di fondi ha anche l'effetto di rafforzare gli apparati burocratici interni dei partiti e disincentivare la partecipazione interna. Proposta da Flaminio Piccoli (DC), la norma viene approvata in soli 16 giorni con il consenso di tutti i partiti, ad eccezione del PLI. La nuova norma si giustifica in base agli scandali Trabucchi del 1965 e petroli del 1973: il Parlamento intende rassicurare l'opinione pubblica che, attraverso il sostentamento diretto dello Stato, i partiti non avrebbero avuto bisogno di collusione e corruzione da parte dei grandi interessi economici. A bilanciare tale previsione, si introduce un divieto - per i partiti - di percepire finanziamenti da strutture pubbliche ed un obbligo (penalmente sanzionato) di pubblicità e di iscrizione a bilancio dei finanziamenti provenienti da privati, se superiori ad un modico ammontare. Ciò risulta tuttavia smentito dagli scandali affiorati successivamente (tra cui i casi Lockheed e Sindona). Nel settembre 1974 il PLI propone un referendum abrogativo sulla norma, ma non riesce a raccogliere le firme necessarie.
Il fallito referendum abrogativo del 1978
L'11 giugno 1978 si tiene il referendum indetto dai Radicali per l'abrogazione della legge 195/1974. Nonostante l'invito a votare "no" da parte dei partiti che rappresentano il 97% dell'elettorato, il "si" raggiunge il 43,6%, pur senza avere successo. Secondo i promotori del referendum lo Stato deve favorire tutti i cittadini attraverso i servizi, le sedi, le tipografie, la carta a basso costo e quanto necessario per fare politica, non garantire le strutture e gli apparati di partito, che devono essere autofinanziati dagli iscritti e dai simpatizzanti.
Le prime modifiche negli anni '80
Nel 1980 una proposta di legge vorrebbe introdurre il raddoppio del finanziamento pubblico, ma viene messa da parte al momento dell'esplosione dello scandalo Caltagirone, con finanziamenti elargiti dagli imprenditori a partiti e a politici.
La legge n. 659 del 18 novembre 1981 introduce le prime modifiche:
· i finanziamenti pubblici vengono raddoppiati;
· partiti e politici (eletti, candidati o aventi cariche di partito) hanno il divieto di ricevere finanziamenti dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici o a partecipazione pubblica;
· viene introdotta una nuova forma di pubblicità dei bilanci: i partiti devono depositare un rendiconto finanziario annuale su entrate e uscite, per quanto non siano soggetti a controlli effettivi.
I Radicali manifestano in aula parlamentare con tecniche di ostruzionismo per bloccare la proposta di indicizzazione dei finanziamenti e a ottenere maggiore trasparenza dei bilanci dei partiti nonché controlli efficaci.
Il referendum del 1993 e l'abrogazione della norma
Il referendum abrogativo promosso dai Radicali Italiani dell'aprile 1993 vede il 90,3% dei voti espressi a favore dell'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, nel clima di sfiducia che succede allo scandalo di Tangentopoli.
La reintroduzione dei "rimborsi elettorali" nel 1994
Nello stesso dicembre 1993 il Parlamento aggiorna, con la legge n. 515 del 10 dicembre 1993, la già esistente legge sui rimborsi elettorali, definiti “contributo per le spese elettorali”, subito applicata in occasione delle elezioni del 27 marzo 1994. Per l'intera legislatura vengono erogati in unica soluzione 47 milioni di euro. La stessa norma viene applicata in occasione delle successive elezioni politiche del 21 aprile 1996.
Il 4 per mille ai partiti politici (1997)
La legge n. 2 del 2 gennaio 1997, intitolata "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici" reintroduce di fatto il finanziamento pubblico ai partiti. Il provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti, al momento della dichiarazione dei redditi, di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito al finanziamento di partiti e movimenti politici (pur senza poter indicare a quale partito), per un totale massimo di 56.810.000 euro, da erogarsi ai partiti entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il solo anno 1997 viene introdotta una norma transitoria che fissa un fondo di 82.633.000 euro per l'anno in corso. Il Comitato radicale promotore del referendum del 1993 sull’abolizione del finanziamento pubblico tenta il ricorso rispetto al tradimento dell’esito referendario, ma pur essendo stato riconosciuto in precedenza come potere dello Stato, gli viene negata dalla Corte Costituzionale la possibilità di depositare tale ricorso. Sempre la legge 2/1997 introduce l'obbligo per i partiti di redigere un bilancio per competenza, comprendente stato patrimoniale e conto economico, il cui controllo è affidato alla Presidenza della Camera. La Corte dei Conti può controllare solo il rendiconto delle spese elettorali. L’adesione alla contribuzione volontaria per destinare il 4 per mille ai partiti resta minima. La legge n. 157 del 3 giugno 1999, Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, reintroduce un finanziamento pubblico completo per i partiti. Il rimborso elettorale previsto non ha infatti attinenza diretta con le spese effettivamente sostenute per le campagne elettorali. La legge 157 prevede cinque fondi: per elezioni alla Camera, al Senato, al Parlamento Europeo, Regionali, e per i referendum, erogati in rate annuali, per 193.713.000 euro in caso di legislatura politica completa (l'erogazione viene interrotta in caso di fine anticipata della legislatura). La legge entra in vigore con le elezioni politiche italiane del 2001. La normativa viene modificata dalla legge n. 156 del 26 luglio 2002, “Disposizioni in materia di rimborsi elettorali”, che trasforma in annuale il fondo e abbassa dal 4 all'1% il quorum per ottenere il rimborso elettorale. L’ammontare da erogare, per Camera e Senato, nel caso di legislatura completa più che raddoppia, passando da 193.713.000 euro a 468.853.675 euro. Infine, con la legge n. 51 del 23 febbraio 2006: l’erogazione è dovuta per tutti e cinque gli anni di legislatura, indipendentemente dalla sua durata effettiva. Con quest’ultima modifica l’aumento è esponenziale. Con la crisi politica italiana del 2008, i partiti iniziano a percepire il doppio dei fondi, giacché ricevono contemporaneamente le quote annuali relative alla XV Legislatura della Repubblica Italiana e alla XVI Legislatura della Repubblica Italiana.
Ecco chi sono gli imprenditori che danno soldi ai politici e ai partiti. Il più generoso è Berlusconi (con se stesso). Poi Moratti, Bonsignore, Caltagirone e anche il palazzinaro multipartisan che offre denaro e appartamenti a quasi tutti. L'Espresso vi mostra la mappa dei finanziamenti privati dal 2008 a oggi, scrivono Giovanni Tizian e Stefano Vergine il 28 novembre 2017 su "L'Espresso". Una legislatura può costare cara. Specie se ti chiami Silvio Berlusconi e gestisci il partito come un’azienda. Coadiuvato dai suoi figli, negli ultimi dieci anni il Cavaliere è stato il principale finanziatore della politica italiana. Ha sborsato di tasca propria la bellezza di 109 milioni di euro. Come lui nessuno mai. Alle sue spalle, sebbene distanziata, c’è però una lunga fila di imprenditori che ama fare regali alla politica. Industriali, armatori, ras degli appalti pubblici, re delle cliniche private, signori dell’accoglienza migranti, nomi noti dell’alta borghesia e della finanza. C’è persino qualche grande evasore, imprenditori bancarottieri e altri con frequentazioni malavitose. Gente di fede politica dichiarata, ma anche donatori laici che preferiscono fare un regalo a tutti per evitare di puntare sul cavallo perdente. L’Espresso, grazie a documenti ufficiali, ha analizzato le donazioni private arrivate a partiti e politici italiani dal 2008 a oggi. Emerge una radiografia del passato per immaginare il futuro. Perché le prossime elezioni saranno le prime senza il finanziamento pubblico ai partiti. Le prime in cui, per effetto di una legge varata a furor di popolo dal governo Letta, i partiti dovranno affidarsi completamente alle donazioni. Ecco perché è utile sapere chi ha già le spalle coperte.
Ripartiamo da Berlusconi, di gran lunga la testa di serie numero uno tra i finanziatori della politica. Che cosa sarebbe oggi Forza Italia senza i soldi del suo fondatore? Un partito poverissimo. Se infatti consideriamo solo le donazioni private ricevute da FI negli ultimi dieci anni (escludendo i denari giratigli dal Popolo delle Libertà) il totale arriva a 117 milioni. Dei quali 106 sono stati regalati da Silvio e famiglia. Berlusconi è l’unico dei big spender italiani ancora ufficialmente in gioco. Gli altri due uomini piazzati sul podio delle donazioni hanno infatti smesso da qualche anno di finanziare la cosa pubblica. Con motivazioni diverse. Gian Marco Moratti, patron delle raffinerie Saras, nel solo 2011 ha messo sul piatto 12 milioni di euro per la campagna elettorale della moglie Letizia a sindaco di Milano. Investimento andato in fumo, dato che alla fine a spuntarla è stato Giuliano Pisapia. Diverso il profilo dell’altro grande finanziatore. Costruttore, editore e finanziere, Francesco Gaetano Caltagirone ha regalato all’Udc oltre 3 milioni di euro in dieci anni: quasi due terzi di quanto ricevuto in totale dal partito guidato dall’ex genero Pier Ferdinando Casini. Ex, appunto. E infatti, da quando i due non sono più parenti, il finanziamento si è improvvisamente bloccato. Se Berlusconi e Moratti hanno preferito fare donazioni personali, Caltagirone - così come tanti altri - ha spesso usato le sue società per sostenere la politica. Particolare rilevante se si considerano i vantaggi fiscali. La vecchia legge prevedeva una detrazione del 19 per cento limitata ai primi 109 mila euro donati. Regola valida sia per i cittadini che per le aziende. Non a caso i grandi finanziatori hanno spesso scelto la taglia da 100 mila. Da un paio d’anni le cose sono però cambiate. Oltre all’abolizione del finanziamento pubblico e alla possibilità di devolvere ai partiti il 2 per mille, il parlamento ha modificato le regole per chi dona. La detrazione è stata alzata al 26 per cento, ma il limite su cui viene calcolata è sceso a 30mila euro. Traduzione? Oggi il risparmio fiscale non può andare oltre i 7.792 euro, quasi un terzo rispetto al passato. Le soglie restano uguali per cittadini e aziende, ma c’è una novità: sia le persone che le società possono finanziare al massimo 100 mila euro. O meglio, le prime possono superare la fatidica soglia solo donando a più partiti. Insomma, la nuova legge cerca di mettere un freno alle maxi elargizioni, avvantaggiando quelle diffuse e di piccola entità. Ma la sostanza non cambia: le donazioni private diventeranno fondamentali per la politica.
Renzi chi? All’appello c’è tutto il giglio magico. Il grande assente nella lista dei donatori del Pd è lui, Matteo Renzi. Dal 2008 a oggi non c’è traccia di un suo versamento nelle casse del partito né in quelle delle sezioni locali. È vero, l’ex premier non è mai stato parlamentare: non vale dunque per lui la prassi, comune a quasi tutte le forze politiche, di girare parte dell’indennità al partito. Ma che dire allora di Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena, che ha regalato all’organismo nazionale quasi 10 mila euro? Altra scuola. Basta guardare quanto fatto dai membri storici del centro sinistra. Gente come Pier Luigi Bersani, Gianni Cuperlo e Rosy Bindi: dal 2012 a oggi hanno speso più di 280 mila euro per mantenere la “Ditta”. C’è però anche un’altra particolarità che riguarda il Pd: il partito nazionale conta pochissime donazioni private. C’è ad esempio quella di Patrizio Bertelli, proprietario di Prada insieme alla moglie Miuccia, che nel 2013 ha regalato 100 mila euro. E quella del produttore cinematografico, Aurelio De Laurentis, che l’anno scorso, attraverso la Filmauro, ha staccato un assegno da 50 mila euro (50 li aveva versati al Pdl nel 2013). La maggior parte dei benefattori privati del centro sinistra si annida però in provincia. È lì che gli imprenditori preferiscono versare il loro contributo. Così per esempio nella sezione di Cesena troviamo la donazione di una società del gioco legale, la HippoGroup. Senza dimenticare le elargizioni delle cooperative, rosse e bianche, dei consorzi e delle cliniche private. E i regali ricevuti dai singoli parlamentari. Come Pier Paolo Baretta, sottosegretario all’Economia, che attraverso l’associazione AReS ha ricevuto 17 mila euro dalla British American Tobacco e 7 dalla Cisl. Sindacato oggi impegnato a discutere con il governo la riforma delle pensioni.
Chi invece ha dato poco utilizzando canali ufficiali sono i grillini. Grillo Giuseppe, comitato elezioni europee 2014: 54 mila euro. Un po’ pochini. Beppe e i suoi seguaci, si sa, non copiano i partiti tradizionali. Nei documenti pubblici si contano in tutto poche decine di migliaia di euro di donazioni. Ma allora come fanno i 5 Stelle a finanziarsi? E dove finiscono i soldi di deputati e senatori? Innanzitutto, ricordano dal movimento, abbiamo rinunciato a 42 milioni di rimborsi elettorali. E poi ci sono i soldi versati dai parlamentari in due fondi, il più ricco dei quali è quello dedicato al microcredito per le imprese (22,3 milioni di euro). E la propaganda elettorale? Le varie feste organizzate a Rimini, Roma o Palermo? Un parlamentare grillino che preferisce non essere citato racconta che per questi eventi vengono aperti dei conti correnti sui quali tutti, potenzialmente anche degli imprenditori, possono versare soldi. Un sistema difficilmente tracciabile, insomma. Proprio come per le fondazioni politiche, il grande buco nero del finanziamento ai partiti, che continuano a restare opache grazie alla possibilità di non dover dichiarare l’identità dei donatori. È il caso della misteriosa fondazione “1000 nomi”, che ha versato 100 mila euro all’ex ministro Giulio Tremonti. O della Kairos di Vicenza, quasi 50 mila euro a Alessandra Moretti per le regionale del Veneto. Tornando alla lista pubblica dei finanziatori della politica, ci si imbatte in un paio di casi particolari. Partiti praticamente inesistenti, ma con entrate rilevanti. Sono le creature personali di Giampiero Samorì e Corrado Passera. Manager di successo che hanno investito alla grande nei propri partiti personali. Senza però aver ottenuto particolare fortuna. Al suo Mir, acronimo di Moderati in rivoluzione, Samorì ha regalato più di 2 milioni di euro in cinque anni. Parecchio, visto lo 0,24 per cento ottenuto alle ultime elezioni. Ha speso più o meno la stessa cifra Passera, ma anche qui sono stati soldi buttati al vento dato che alla fine l’ex ministro ha scelto di appoggiare Stefano Parisi nella corsa a sindaco di Milano.
I dieci maggiori finanziatori privati. C’è poi chi finanzia tutti, da destra a sinistra passando per il centro. Categoria variegata. C’è Sergio Scarpellini, immobiliarista sotto processo per corruzione (avrebbe pagato tangenti a Raffaele Marra, ex braccio destro di Virginia Raggi), che negli ultimi dieci anni ha sborsato 222 mila euro per finanziare un po’ tutto l’arco parlamentare, da La Destra di Storace al Pd passando per Verdini e Baccelli. Se le donazioni di Scarpellini si traducono spesso in appartamenti offerti gratuitamente al partito di turno, Gianfranco Librandi punta tutto sui bonifici effettuati dalla sua Tci Telecomunicazioni Italia, azienda del varesotto che produce luci a led. Partito da Forza Italia e approdato nel Pd dopo una parentesi da tesoriere con Scelta Civica, Librandi si è dimostrato trasformista anche nei finanziamenti politici. Per dire: negli ultimi due anni è riuscito nell’impresa di sostenere contemporaneamente Fratelli d’Italia, Pd, Mariastella Gelmini e gli ultimi due candidati-sindaco di Milano, Beppe Sala e Stefano Parisi. Trascende la dicotomia destra-sinistra anche il gigante della carne Cremonini, proprietario delle catene di ristoranti Roadhouse Grill e Chef Express. Negli ultimi dieci anni ha donato circa 120 mila euro: soldi andati a Forza Italia e Ncd, ma anche a due volti noti del centro sinistra come gli ex ministri Cécile Kyenge e Paolo De Castro. Stessa strategia per l’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, che attraverso le sue imprese ha finanziato al contempo il senatore del Pd Nicola Latorre, l’Mpa di Raffaele Lombardo e il Grande Sud di Gianfranco Micciché. Profili nazionali, ma espressioni dei territori dove Zamparini ha investito in progetti commerciali.
I re degli appalti. Portatori di interessi economici concreti sono anche i ras degli appalti. Le cui donazioni, ora che i finanziamenti pubblici sono stati aboliti, rischiano di risultare ancor più cruciali per i partiti. Prendiamo Vito Bonsignore. Partito dalla Dc, passato per il Pdl e approdato oggi al Nuovo centro destra di Alfano, il politico siciliano è titolare della società di ingegneria Mec. L’impresa ha finanziato soprattutto lo stesso Bonsignore, regalandogli 4,5 milioni di euro all’epoca in cui sedeva sui banchi del Parlamento europeo in quota Pdl. Ma dalle casse aziendali sono partiti bonifici diretti anche ad altri parlamentari: 20 mila euro a Fabrizio Cicchitto e altri 20 mila al sottosegretario Ncd Giuseppe Castiglione, mentre ad Angelino Alfano è stato offerto lo spostamento aereo durante la campagna elettorale del 2013 al costo di 8.400 euro. Il metodo Bonsignore funziona. Perché prima o poi l’appalto arriva. Come nel 2010, quando il Cipe - governo Berlusconi in carica - concede il via libera alla superstrada Ragusa-Catania: della cordata di aziende che si aggiudica l’appalto fa parte proprio la Mec. Anche il gruppo Gavio, interessato al business di strade e autostrade, contribuisce al finanziamento della politica nazionale. Nel 2008 ha elargito 400 mila euro a Forza Italia. Cinque anni più tardi ha regalato 50 mila euro a Ugo Sposetti, storico tesoriere dei Ds. Ha speso invece un po’ meno il colosso delle costruzioni Astaldi, in lizza per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Nel 2008 l’azienda ha staccato un assegno da 100 mila euro a Forza Italia. Alle elezioni successive ne ha dati altri 10 mila a Linda Lanzillotta, eletta con Scelta Civica e moglie di Franco Bassanini, all’epoca presidente di Cassa Depositi e Prestiti e dunque potenziale finanziatore dell’opera. Un ruolo da donatore (70 mila euro in totale) se lo è ritagliato anche Gemmo, l’azienda vicentina che ha realizzato le parabole del sistema Muos a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Opera contestatissima. Forse per questo il gruppo veneto nel 2008 ha donato 15 mila euro al Movimento per l’Autonomia dell’allora governatore siciliano Raffaele Lombardo, che tre anni dopo firmerà il via ai lavori.
Alfredo Romeo. Nel balletto dei finanziamenti privati non poteva mancare Alfredo Romeo. L’imprenditore campano, finito di recente al centro del caso Consip, gestisce appalti in tutta Italia. Pubblici, molto spesso. Chi ha finanziato? All’amico Italo Bocchino - che dopo la fallimentare avventura in Futuro e Libertà diventerà suo consulente personale - alle ultime politiche Romeo ha donato 25 mila euro, ma è con il centro sinistra che l’imprenditore si è rivelato più generoso: con la sua Isvafim ha distribuito equamente altri 75 mila tra Nicola Latorre, Massimo Paolucci (ora Mdp) e il Centro democratico di Tabacci. Tra le cooperative rosse più attive c’è invece la Cpl Concordia. Nei due anni precedenti allo scandalo in cui è finita per presunti accordi con la camorra (a ottobre i vertici sono stati assolti) ha contribuito alla causa del Pd con 53 mila euro: piccole somme suddivise tra Sposetti, l’ex ministra Kyenge, la lista per Ambrosoli presidente della Regione Lombardia e due sezioni locali del partito.
Do ut des. I signori dell’accoglienza-migranti non sono da meno. Anche loro, come i ras degli appalti, vivono di politica. Perché devono mantenere buoni rapporti con chi gestisce flussi e decide strategie. Bastano pochi spiccioli per farlo. La cooperativa La Cascina, area Comunione e Liberazione, ha interessi nel più grande centro per richiedenti asilo, quello siciliano di Mineo. Una gestione messa sotto la lente d’ingrandimento dalla magistratura. Nell’indagine che ha coinvolto i vertici della coop bianca è rimasto impelagato anche il sottosegretario Giuseppe Castiglione del Nuovo centrodestra, il partito di Alfano e Lupi. E proprio a Lupi nel 2013 arriverà una mancia da 5 mila euro da Salvatore Menolascina, all’epoca amministratore delegato de La Cascina. L’ex ministro ne riceverà altri 5 mila da Camillo Aceto, ras dell’accoglienza con la sua Senis Hospes, ma comunque legato al mondo della coop La Cascina. Senis Hospes ha foraggiato anche il Pdl per un totale di 15 mila euro, mentre la cooperativa vicina a Cl ha distribuito offerte anche a sinistra. Nel 2013 10 mila euro finiranno infatti al “Comitato provvisorio città di Roma” del Pd, che nello stesso periodo registra un’entrata di identico importo dalla cooperativa 29 giugno. Esattamente quella di Salvatore Buzzi, il boss dell’accoglienza condannato nel processo Mafia Capitale.
Cemento, servizi, migranti. E sanità. Tutti settori in cui l’aggancio politico aiuta. Nel caso delle cure private il vero business ruota attorno agli accreditamenti presso le aziende sanitarie locali, garanzia di introiti sicuri. Per questo gli imprenditori della sanità privata dedicano parte del loro budget a sostenere i politici. Tra i più generosi c’è Federfarma, che rappresenta le farmacie private convenzionate con il servizio sanitario. L’Aiop, che raccoglie circa 500 case di cura in tutta Italia. Ma soprattutto Multimedica, colosso lombardo dei poliambulatori privati, che negli ultimi dieci anni ha versato 190 mila euro ai partiti: quasi tutti finiti a Forza Italia, ma anche alla Lega Nord. Proprio i partiti che hanno governato in Lombardia. Ora, con le elezioni regionali in arrivo, l’azienda sanitaria controllata da Daniele Schwarz ha messo una fiche da 15 mila euro su Lombardia Popolare, il nuovo movimento dell’ex ministro Lupi, espressione di Comunione e Liberazione e da sempre sensibile al mondo delle cure private.
Giovanni Arvedi. In classifica non potevano mancare i big dell’industria italiana. Il più generoso è Giovanni Arvedi, fondatore dell’omonimo gruppo siderurgico, che ha concentrato i suoi regali nel 2008, alla vigilia delle elezioni poi vinte da Berlusconi. Attraverso le sue società, l’imprenditore ha donato 300 mila euro a Forza Italia. Scommessa vinta solo a metà. Per diversificare il rischio, infatti, Arvedi ha regalato 200 mila euro anche al Pd Lombardia, dove hanno sede quasi tutti i suoi stabilimenti. Ancor più variegata la lista dei beneficiari del gruppo Maccaferri. La multinazionale bolognese dell’ingegneria meccanica ha usato una tattica particolare: donazioni piccole, suddivise con estrema imparzialità. Il risultato è che i 200 mila euro investiti da Gaetano Maccaferri, membro di Confindustria e del consiglio superiore della Banca d’Italia, sono finiti in mille rivoli: dal Pd a Renato Brunetta, da Scelta Civica agli autonomisti siciliani di Lombardo. Ha scelto invece una strada opposta l’ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Attraverso Mapei, la sua azienda, l’imprenditore emiliano ha puntato tutto su un unico cavallo. Sbagliato. Squinzi ha infatti investito 60mila euro per finanziare la campagna elettorale a sindaco di Milano di Stefano Parisi, infine sconfitto da Sala.
Dalla Turchia a Cuffaro. Che cosa lega la fedelissima di Berlusconi, Licia Ronzulli, a uno degli uomini più ascoltati dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan? Un bonifico da 20 mila euro datato 2014. La donazione in favore dell’allora europarlamentare di Forza Italia, oggi considerata vicinissima al Cavaliere, è firmata Hasan Cuneyd Zapsu. Imprenditore di successo basato a Istanbul, consulente di gruppi globali come Coca Cola e Rosatom, fondatore del partito turco Akp e consigliere speciale di Erdogan, Zapsu ha un solo legame noto con l’Italia: un ruolo da «senior advisor» per il gruppo Ferrero, quello della Nutella, che proprio nel 2014 ha ottenuto dalla Commissione europea l’ok alla contestata fusione con l’azienda turca Oltan, uno dei principali produttori di nocciole al mondo. Perché Zapsu ha regalato 20mila euro alla Ronzulli? Contattato da L’Espresso, il consulente di Erdogan non ha risposto. La Ronzulli ci ha invece spiegato di conoscere l’imprenditore dal 2012. Tra noi c’è «una buona amicizia», per questo gli ho chiesto «un aiuto per la mia campagna elettorale». C’è un legame con la Ferrero? Nessuno, garantisce l’ex parlamentare, che dice di aver appreso da L’Espresso della consulenza di Zapsu. Ha chiarito la sua posizione anche Salvatore Cuffaro, beneficiario di una donazione particolare. Nel 2013 il politico siciliano si trova infatti in carcere a Rebibbia. La condanna per favoreggiamento aggravato dall’aver agevolato Cosa nostra è diventata ormai definitiva. Eppure, proprio quell’anno, secondo i documenti ottenuti da L’Espresso, Cuffaro riceve un versamento di 220 mila euro da Forza Italia. Perché? «È quanto mi dovevano per la campagna elettorale del 2006, quando diventai presidente della Regione», ci ha risposto l’ex governatore siciliano. «L’Udc saldò subito la sua parte. Forza Italia, nel frattempo diventato Pdl, chiuse invece il debito sette anni dopo. Ma io ci tengo a precisare che di quella cifra non ho mai visto un euro, del resto mi trovavo in carcere. I soldi sono serviti a estinguere il debito contratto all’epoca con la banca per la campagna elettorale». Caso risolto, dunque. Ma Cuffaro, che mastica politica da quando è nato e sa che forma assumono i poteri forti, cosa pensa della fine del finanziamento pubblico? «È stata una garanzia di libertà», dice, «ora il rischio è che i partiti finiscano in mano ai privati. Del resto danno un contributo perché hanno delle speranze, mentre il partito che non ha bisogno di denaro non crea alcuna aspettativa nei privati». Seguendo il ragionamento di Cuffaro, viene da pensare che Giovanni Toti di aspettative ne abbia create parecchie. D’altronde la campagna elettorale dell’attuale presidente della Liguria, scelto da Berlusconi per violare la storica roccaforte della sinistra, è stata lunga e dispendiosa. Per fortuna sono arrivati in suo soccorso un po’ di denari privati. Certo, da un pezzo grosso dell’imprenditoria come Aldo Spinelli - ex patron del Genoa e del Livorno - c’era da aspettarsi qualcosa in più dei 15 mila euro donati. Ma tant’è. L’aiuto simbolico è comunque servito: dopo l’elezione di Toti, Spinelli ha acquistato insieme a Msc il Terminal Rinfuse di Genova. La maggior parte delle donazioni per Toti sono però arrivate dalla Fondazione Change: impossibile dunque conoscere l’origine del denaro. Tra i pochi ad aver fatto bonifici diretti c’è l’imprenditore Giovanni Calabrò, sponsorizzato dallo stesso Toti per l’acquisto del Genoa calcio. Non proprio una mossa felice, visto che quest’anno la Cassazione ha condannato Calabrò a sei anni per bancarotta.
Meloni e mattoni. «C’è l’Italia colpevole di Angiola Armellini, che non paga di ereditare un impero senza aver fatto nulla, nasconde due miliardi di euro al fisco». Parola di Giorgia Meloni, che durante la campagna elettorale per diventare sindaco di Roma descriveva così la grande ereditiera da sempre in affari con il Comune capitolino (incassava più di 4 milioni all’anno per l’affitto di suoi appartamenti usati come case popolari). I documenti analizzati da L’Espresso permettono di raccontare un inedito retroscena sul rapporto tra la Meloni e la donna accusata di evasione fiscale. La leader di Fratelli d’Italia ha infatti ricevuto donazioni da quattro società che fanno capo alla Armellini, per un totale di 20 mila euro. Spiccioli- ma sempre ben accetti- per “lady no tax”, che col mattone ha guadagnato miliardi. Ai quali si aggiunge una mancetta dei costruttori romani, i Mezzaroma. Una donazione da 1.500 euro attraverso una società del gruppo. Imprenditori che hanno sempre avuto simpatie per la destra: nel 2010 hanno versato 100 mila euro al partito di Berlusconi, nel quale la Meloni era ministro. Tra i finanziatori della leader di destra alle elezioni comunali - 210 mila euro in totale - c’è anche la società Corallobeach. Il titolare è Claudio Balini, ras dei lidi del litorale e parente di Mauro Balini, a cui la magistratura ha sequestrato beni per 50 milioni di euro. Mauro Balini, per gli investigatori, ha legami con la malavita locale. Insomma, pecunia non olet. Neppure per l’erede di Almirante.
Nessun indizio contro Romeo, ma lo stanno rovinando, scrive Simona Musco il 30 Settembre 2018 su "Il Dubbio". Alfredo Romeo è «il capro espiatorio», per evitare «l’ennesimo flop di certa giustizia italiana e proteggere la Consip e certa politica». Non usano mezzi termini gli avvocati Francesco Carotenuto e Alfredo Sorge, forti della sentenza delle sezioni unite della Cassazione che, giovedì, hanno dato ragione, per la quarta volta in un anno, all’avvocato fondatore del gruppo Romeo, fulcro dell’inchiesta Consip che ha fatto tremare il governo Renzi. Nessun indizio di colpevolezza, confermano i giudici accogliendo il ricorso contro la misura interdittiva cautelare emessa dal gip di Roma a maggio 2017, con la quale veniva impedito alla società di fare affari con la pubblica amministrazione per un anno. Un provvedimento sulla cui base, pochi giorni fa, la società si è vista confermare dal Consiglio di Stato l’esclusione da un maxi- appalto dal valore di oltre un miliardo di euro. E mentre Romeo è a processo a Roma e Napoli, «il rischio vero – raccontano i legali al Dubbio – è che in Consip tutto continui come se niente fosse».
La Cassazione ha smentito l’esistenza di prove a sostegno del cosiddetto ‘ Sistema Romeo’. È un capro espiatorio?
«L’avvocato Romeo è il capro espiatorio – insieme alla sua azienda Romeo Gestioni – di un procedere delle indagini nate senza un reato da perseguire, e delle conseguenze amministrative derivate, che insieme sommano una quantità di anomalie senza precedenti e che non sembrano mai casuali, come cercheremo sempre di dimostrare, e che hanno come unico evidente bersaglio Romeo e la sua azienda, lasciando indietro invece uomini e affari che palesemente – carte alla mano – dovrebbero essere ben diversamente seguiti dalle Procure».
Quella dell’affare Consip non è l’unica indagine a carico dell’avvocato. Ci sarebbe un accanimento? Perché le procure di Napoli e Roma sarebbero interessate a distruggere Romeo?
«L’accanimento contro il nostro assistito c’è da più di dieci anni. Ma ha avuto una recrudescenza a partire dalla assoluzione da dodici capi di imputazione su dodici, “perché il fatto non sussiste”, del 9 luglio 2014, nel processo cosiddetto Global Service. Oggi, di fronte al gigantesco tam tam mediatico sullo “scandalo Consip”, e del nulla giudiziario che sembra corrispondere alle indagini, l’unico modo per evitare l’ennesimo flop di certa giustizia italiana e di proteggere la Consip e certa politica, è portare a casa almeno lo scalpo di Romeo. Non dimentichiamo che è stato fatto un calcolo approssimativo per difetto che questa inchiesta non sia costata meno di cinque milioni di euro fino ad oggi».
Quali sono state le conseguenze sulle aziende di Romeo?
«Devastanti, su un Gruppo – non dimentichiamolo – di 20mila dipendenti. Le aziende dell’avvocato Romeo hanno subìto danni di immagine e di mercato gravissime, a fronte di mesi e mesi di indagini capillari che hanno potuto solo evidenziare, invece, l’integrità amministrativa e operative delle stesse aziende. E tutto questo perché nel processo di Napoli, per esempio, si contesta che una pianta del valore di 80 euro o un voucher- sauna da 37 euro siano stati usati per corrompere pubblici ufficiali. Surreale».
Avete parlato di altri nodi "affaristico- politici" ai quali l’indagine non avrebbe fatto caso. Quali sono questi nodi?
«Da esposti presentati da Romeo Gestioni ad aprile 2016, si sono aperte indagini su cartelli anti- concorrenza messi in piedi da competitor della Romeo Gestioni. Dopo due anni, pur in presenza di dichiarazioni confessorie di aziende e amministratori delle stesse, nessun provvedimento è stato preso, tenendo a bagnomaria anche l’azienda che quei traffici ha denunciato. La Romeo Gestioni, appunto. In più, è nelle carte, che mancano agli atti i sei ( e forse più) mesi di intercettazioni fatte in Consip prima che l’ex Ad Marroni bonificasse gli uffici. Intercettazioni che abbiamo chiesto più volte per la nostra difesa e che non sono state messe “in onda”. Intercettazioni che probabilmente farebbero grande chiarezza sulle deposizioni – come testimone dell’ex Ad di Consip, Marroni – nelle quali si leggono infiniti comportamenti arbitrari e discutibili contro la pubblica amministrazione compiuti dallo stesso ex Ad di Consip proprio con i referenti delle aziende che sono sotto inchiesta all’Antitrust dopo gli esposti di Romeo Gestioni. E che farebbero chiarezza proprio sul ruolo dell’architetto Gasparri. Possibile che nessuno si chieda perché, con tali evidenze anche di conflitti di interesse, l’ex Ad di Consip resti testimone e non sia indagato? A nostro avviso questo non è un giusto processo».
A due anni dai vostri esposti l’Antitrust non è arrivata ad una conclusione, nonstante la ‘ confessione’ delle aziende che voi avete segnalato. Cosa ha comportato questa situazione?
«Sottolineiamo che gli esposti furono inviati anche all’Anac che in proposito non ha mai assunto iniziative di alcun tipo. Tornando all’Antitrust, abbiamo usato la parola “bagnomaria”. Ma la verità è che combattiamo una aspra battaglia contro atti amministrativi fondati sul nulla (come afferma la Cassazione a sezioni unite) e quindi del tutto arbitrari, come l’esclusione dalla gara FM4 ad opera di Marroni, avallata da un Consiglio di Stato che ha giudicato l’atto dell’ex Ad di Consip, senza entrare nel merito della sua condotta anomala, e quindi senza verificare la fondatezza delle presunte “ragioni” di Marroni. Che infatti non c’erano, come affermato dalle sezioni unite. Se si fosse attesa la Cassazione – o correttamente il deposito degli atti dell’indagine della Procura di Roma – crediamo che il Consiglio di Stato avrebbe semplicemente bocciato Marroni e dato ragione a Romeo Gestioni. Detto ciò, il collegio di civilisti sta già studiando ogni forma possibile di iniziativa risarcitoria».
Parliamo del processo a Roma: secondo i pm, Romeo avrebbe pagato 100mila euro in quattro anni a Marco Gasparri in cambio di notizie riservate sulle gare, informazioni che l’ex dirigente ha confermato. Qual è la vostra versione dei fatti?
«L’avvocato Romeo non ha mai versato una lira a Gasparri, il quale nell’incidente probatorio ha escluso di aver dato informazioni riservate al nostro assistito e non ha neppure confermato la cifra dei 100mila euro».
E perché si sarebbe autoaccusato? Quali erano i loro veri rapporti?
«L’architetto Gasparri aveva un ruolo di marketing all’interno di Consip. Parlava con tutte le aziende e tutti gli interlocutori di Consip perché questo era il suo ruolo: promuovere gli appalti della Centrale acquisti dello Stato. Bisognerebbe chiedere a lui perché si sia autoaccusato. Forse, se si mettessero insieme quelle famose intercettazioni che mancano, con le dichiarazioni di Marroni e con gli incontri di quest’ultimo con i concorrenti di Romeo (ai quali il Gasparri partecipava), verrebbero fuori nodi per i quali i 18 mesi patteggiati da Gasparri sono ben poca cosa».
Qual è la situazione in Consip? Cosa manca a questa indagine, cosa ci sarebbe dietro?
«Abbiamo già ampiamente risposto su questo fronte. Ma va detto che il rischio vero è che in Consip – una volta incastrato Romeo – tutto continui come se niente fosse. Infatti ci domandiamo come sia possibile che la gara FM4 non venga annullata, visti soprattutto gli intrecci che si stanno analizzando in Antitrust».
Si parla di traffico di influenze e vicinanza ai Renzi. Quali sono i rapporti di Romeo con la famiglia dell’ex premier?
«L’avvocato Romeo non ha mai incontrato Tiziano Renzi. Ha solo ascoltato le chiacchiere di tal Carlo Russo. La domanda che ci si dovrebbe porre – tutti – a leggere le dichiarazioni del solito Marroni, è invece un’altra: quali sono i rapporti di tutte quelle imprese oggi al vaglio dell’Antitrust con la politica?»
In un’intervista a Repubblica l’avvocato Romeo ha smentito le intercettazioni. Ci sono inesattezze?
«Noi non mettiamo in discussione l’autenticità delle intercettazioni. Mettiamo in discussione la loro validità e la loro utilizzabilità, in quanto disposte ed eseguite senza il rispetto delle regole. E dunque sono nulle».
Sapevate in anticipo dell’inchiesta grazie alla fuga di notizie?
«Il nostro assistito le ha lette sulla Verità e sul Fatto Quotidiano molto prima che arrivassero avvisi di garanzia e quant’altro. E per settimane abbiamo letto che non era nemmeno indagato».
Il trucchetto delle fondazioni per nascondere le mazzette. Da destra a sinistra nessuno si fa mancare una fondazione. Il motivo? Non sono tenuti a dichiarare chi li finanzia, scrive Paolo Bracalini, Mercoledì 01/04/2015, su "Il Giornale". L'ultima stima ne conta più di cento, 105 per la precisione. Per tutti i gusti, da destra a sinistra, da leader a presunti tali, nessuno si fa mancare una fondazione. Se lievitano a vista d'occhio è perché offrono diversi vantaggi, soprattutto in tempi di magra per il finanziamento pubblico ai partiti. Le fondazioni ricevono fondi ministeriali, accedono al 5 per mille, hanno sgravi fiscali, a differenza dei partiti possono ricevere donazioni da aziende pubbliche - munifici colossi come Eni, Finmeccanica, Poste - ma il grosso delle risorse arriva da tasche private, ed è qui il principale vantaggio dei think tank: non sono tenute a dichiarare chi le finanzia, neppure a depositare un bilancio, tutto al riparo da sguardi indiscreti. «Non siamo neppure obbligati a tenere una contabilità ufficiale delle erogazioni che riceviamo» racconta il presidente di un'importante fondazione politica, legata ad un ex ministro. Così negli ultimi anni il flusso di denaro si è spostato dalle segreterie di partito alle segrete stanze delle fondazioni, che puntualmente spuntano in miriadi di inchieste per corruzione, da Mafia capitale con la «Nuova Italia» di Alemanno, fino a quella sulla coop Cpl. Il presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone ha segnalato ancora il problema: «È inutile imporre la trasparenza nei bilanci dei partiti, che ormai sono spompati e nessuno li finanzia più. Oggi il vero potere passa per le fondazioni». In questo campo Massimo D'Alema è un precursore, perché la sua fondazione Italianieuropei, prestigiosa sede in piazza Farnese a Roma, festeggiava già nel 2008 i dieci anni di vita. Il volume celebrativo edito per l'occasione riporta anche un po' di cifre e di nomi. Circa 350mila euro di donazioni, arrivati da big come la Glaxo, multinazionali del tabacco come Philip Morris, aziende di elettrodomestici come Merloni, e poi Pirelli, Ericcson, e una serie di coop: Coop Estense, Legacoop Imola, Lega Nazionale Coop e Mutue, Lega Ligure delle Coop... Chi la finanzi adesso non si sa (anche se basta comprare la rivista bimestrale e vedere chi sono gli inserzionisti di pubblicità, a botte di decine di migliaia di euro, tutte grosse aziende con tanta voglia di buone relazioni con la politica), perché alla richiesta la fondazione dalemiana risponde che i nomi non si fanno, per la privacy («Dai finanziamenti si potrebbe desumere l'orientamento politico di chi ha elargito il contributo» ha spiegato lo stesso D'Alema). Privacy che altrove, come in Germania, dove le fondazioni sono ampiamente finanziate dallo Stato, non esiste, perché si devono seguire precise e severe regole di trasparenza. Anche a Bruxelles è così, e D'Alema lo sa bene, visto che presiede un'altra fondazione, la Foundation for European Progressive Studies (espressione del Partito socialista europeo di cui fa parte il Pd), che nell'ultimo anno si è presa 3 milioni di euro di fondi dalla Ue. Dietro le carriere politiche c'è spesso l'attivismo di una fondazione. Tosi è arrivato alla rottura con la Lega proprio per la sua fondazione «Ricostruiamo il Paese», 57 sedi in tutta Italia, finanziatori ignoti. Enrico Letta, appena diventato premier, ha chiuso la sua VeDrò, appena visitata dalla Guardia di finanza, ma l'associazione politica è servita a preparare la strada di premier di larghe intese (tutti invitati a Vedrò). Quella di Renzi, prima la Big Bang e poi la Fondazione Open, guidate dal braccio destro Carrai, sono stati i motori della repentina ascesa del sindaco di Firenze, concentrando finanziamenti, sponsor, amicizie. Renzi, in piena guerra di primarie Pd (coi bersaniani che lo accusavano di ricevere soldi persino da Usa e Israele...), ha pubblicato una lista di finanziatori. Ma sugli sponsor di Renzi e sui partecipanti alle cene di fund raising resta un'ampia zona di mistero. Come in tutte le altre. Sarà per questo che piacciono tanto?
La galassia delle fondazioni “politiche”. Nessuno spiega da dove arrivano i soldi. Di centrodestra, di centrosinistra e sempre più spesso trasversali: le associazioni culturali fondate dai parlamentari vengono finanziate dai big dell'imprenditoria nazionale e da società di Stato senza nessuna trasparenza. La legge lo permette, scrive Ferruccio Sansa il 27 novembre 2011 su "Il Fatto Quotidiano". Il manifesto è chiaro: “Declinare al futuro i valori dell’unità nazionale”. Tra le parole chiave il “patriottismo consapevole”. Ma a leggere l’elenco dei membri dell’associazione Italiadecide ecco Roberto Calderoli. Un politico che del patriottismo, per di più consapevole, non ha mai fatto una bandiera. Non è la sola sorpresa: accanto a Luciano Violante(presidente), e a tanti esponenti Pd, c’è mezzo governo Berlusconi. Centrosinistra e centrodestra uniti; pare quasi un embrione della strana coalizione che ritroviamo oggi a sostegno del governo Monti. Italiadecide è una delle decine, forse centinaia di fondazioni e associazioni politiche fiorite negli ultimi anni. Una febbre, per essere un politico decente bisogna averne almeno una. Soggetti che promuovono attività culturali, ma che talvolta sembrano il nuovo bancomat della politica. Un fenomeno che dopo le inchieste degli ultimi mesi merita un approfondimento.
Indagati e inchieste. Tommaso Di Lernia dal carcere dice: “Optimatica è una società vicina al ministro Altero Matteoli, credo che eroghi finanziamenti alla fondazione a lui riconducibile”. Di Lernia sostiene che Optimatica finanzierebbe anche l’Officina delle Libertà vicina adAldo Brancher (che inizialmente aveva sede in casa di Silvio Berlusconi). Ma ci sono anche le inchieste su Franco Morichini, in contatto con i vertici Finmeccanica e procacciatore di finanziamenti per Italianieuropei. Per finire con l’indagine sul ‘sistema Sesto’ che tocca anche la fondazione FareMetropoli di Filippo Penati. Finora, va detto, le fondazioni di Brancher, Matteoli e D’Alema non sono state oggetto di addebiti penali. Le polemiche e gli scandali degli ultimi mesi, però, sono legati da un filo invisibile: le fondazioni e le associazioni di esponenti politici. Sulla scena politica degli ultimi anni, con i partiti defilati, sono loro i protagonisti: “Soggetti perfettamente trasversali, che non hanno nemmeno più bisogno di quello sgradevole inciampo che sono gli elettori e gli iscritti”, racconta l’ex dirigente di una fondazione di centrodestra che mantiene l’anonimato. Aggiunge: “I segreti del loro successo, però, sono altri: le fondazioni con le assemblee e i convegni sono un formidabile centro di potere. Lobbies all’amatriciana, tanto diverse da quelle americane”. Ma non somigliano neanche ai think tank del resto del mondo, ai salotti del potere tipo Davos. Qui non sono in gioco gli eventuali gettoni di presenza, ma l’appartenenza, l’influenza, le poltrone. Una merce invisibile e, però, preziosissima. Ma soprattutto, grazie a una disciplina molto benevola, da questi soggetti passano finanziamenti per la politica. Per questo in tanti si sono buttati a pesce nello spiraglio lasciato aperto (apposta?) dalla legge. Niente di illegale, quindi, ma le inchieste rischiano di scoperchiare il pentolone. Matteoli, tanto per ricordare l’ultimo nome assurto all’onore delle cronache, smentisce categoricamente le affermazioni degli indagati dell’inchiesta Finmeccanica. Ma questi organismi geneticamente modificati restano un mondo inesplorato. Un labirinto di nomi che paiono slogan, dove le parole ‘fare’, ‘futuro’, ‘Italia’, ‘libertà’ sono le più gettonate. Ormai tanti esponenti politici o aspiranti tali comunicano attraverso editoriali di fondazioni e associazioni: da Gianfranco Fini (Farefuturo) a Luca Cordero di Montezemolo (Italiafutura), fino a Claudio Scajola rientrato sulla scena dopo lo scandalo della casa comprata “a sua insaputa” contando i deputati fedeli nell’associazione Cristoforo Colombo per le libertà. Un viaggio attraverso le fondazioni e le associazioni politiche apre nuovi mondi, aiuta a disegnare la mappa del potere. Magari partendo proprio dalla prestigiosa Italiadecide (mai toccata da inchieste, né da ombre di alcun genere), perché è l’emblema del trasversalismo: destra e sinistra, politica e affari. “Niente di strano, lo scopo della nostra associazione è proprio unire persone di aree diverse”, racconta il presidente Luciano Violante. Tra i promotori (il grado più alto della gerarchia) compaiono nomi perfettamente bipartisan: si va da Giuliano Amato a Giulio Tremontipassando per Gianni Letta.
Amici di amici. Ma l’elenco dei “semplici” soci riserva altre sorprese. Ecco il dalemiano Antonio Bargone, che dalla politica è passato all’impresa con la passione per le grandi opere. Come l’autostrada Livorno-Civitavecchia della cui società Bargone è diventato presidente (oltre che Commissario Governativo) dopo essere stato sottosegretario alle Infrastrutture con Prodi e D’Alema. Poi, si diceva Roberto Calderoli, quindi Franco Bassanini (Pd), Giovanni Maria Flick (ex ministro del governo Prodi), Altero Matteoli (altro ministro berlusconiano), Vito Riggio (presidente Enac) e Alessandro Profumo (il banchiere che stava preparando il grande salto in politica, corteggiato dal Pd, quando è stato azzoppato da una clamorosa inchiesta giudiziaria). Tra i soci anche l’attivissimo Andrea Peruzy, che oltre a sedere in diversi consigli di amministrazione (Acea, per dire) è anche in Italianieuropei e nell’associazione Romano Viviani (che raccoglie altri dalemiani soprattutto toscani). Non basta, perché, caso più unico che raro, Italiadecide tra i soci accoglie non solo persone fisiche, ma anche giuridiche. Insomma, imprese con il portafogli bello gonfio e gli occhi magari puntati sulle opere pubbliche: Autostrade per l’Italia, Banca Intesa San Paolo (fino a pochi giorni fa guidata dal ministro Corrado Passera), Banca Popolare di Milano, Eni, F 2 i e Unicredit spa. Ma è una specie di catena di sant’Antonio, prendi un nome, uno qualsiasi, e lo ritrovi in tante altre fondazioni e associazioni. Prendete Giuliano Amato e lo ritrovate, per dire, in Italianieuropei di D’Alema. Non è il solo, anche Violante e Bassanini sono in entrambe le associazioni. Tremonti invece siede anche nell’Officina delle Libertà. Matteoli ha la sua Fondazione della Libertà per il bene comune. Nel sito campeggia una bella immagine di un Lego tricolore: come dire costruiamo l’Italia. Le attività, però, non paiono esattamente febbrili visto che ancora ieri veniva reclamizzato un evento del 26 ottobre scorso. Nessuno pare aver aggiornato il sito.
Vetrine “vuote”. Ma stando alle pagine web di associazioni e fondazioni parecchie paiono vetrine tutte addobbate di negozi che nel magazzino non hanno molta merce. L’ultima news di Riformisti Europei (presidente Carlo Vizzini) è del 26 giugno. Il sito di Riformismo e Libertà di Fabrizio Cicchitto è totalmente kaputt. Su quello di Costruiamo il futuro di Maurizio Lupi (nel comitato anche il neo-ministro Lorenzo Ornaghi) sono ancora reclamizzate le cene estive e appuntamenti di mesi fa. Oltre ovviamente alle presentazioni di libri di Lupi. Ma davvero ogni politico ha una fondazione: Renato Brunetta ha la sua Free Foundation, in inglese perché la parola “libera” era già inflazionata. Praticamente è un Brunetta fan club: interventi, dichiarazioni, rassegna stampa, l’ex ministro domina. Poi, tra mille esempi possibili, ecco Magna Carta (senza ‘h’) di Fabrizio Quagliariello e Foedus di Mario Baccini. Spostandosi verso il centro troviamo Liberal che fa capo a Ferdinando Adornato. In zona centrosinistra ecco Nens, Nuova Economia e Nuova Società, fondata da Pier Luigi Bersani e Vincenzo Visco. Un’associazione in passato toccata da qualche polemica: la sede (“in affitto”, precisò Visco) era di proprietà della famiglia di uno dei massimi dirigenti pubblici del Demanio. Niente di illegale, una questione di opportunità. Poi ecco Astrid, di Franco Bassanini, dove ritroviamo, tra gli altri, Amato (siamo a quota tre) e Giulio Napolitano (stimato professore universitario, figlio del Presidente Giorgio, presente anche in Italianieuropei), e Democratica che fa capo a Walter Veltroni. A un primo esame le associazioni di centrosinistra sembrerebbero più attive. Italianieuropei di D’Alema, per esempio, ha una sua sede in piazza Farnese, nel centro di Roma, suoi dipendenti e un’attività consistente: organizza convegni, aggiorna il sito e stampa una rivista. Lo stesso per Democratica di Veltroni che, tra l’altro, organizza corsi di politica. Ma gli organigrammi delle fondazioni vanno letti insieme con quelli dei cda delle società, soprattutto pubbliche. Nel consiglio della Nuova Italia, presieduta da Gianni Alemanno, oltre a sua moglie Isabella Rauti, troviamo, per dire, Franco Panzironi, nominato dal sindaco amministratore delegato dell’Ama (società comunale che si occupa di rifiuti) e Ranieri Mamalchi (già capo segreteria di Alemanno al ministero dell’Agricoltura e oggi dirigente di Acea). Fondazioni e associazioni sono, però, oggetti misteriosi. A parte le dichiarazioni di principio piuttosto vaghe. L’unico modo per saperne qualcosa sono i siti internet dove compare almeno l’elenco dei soci. Come per esempio nel Maestrale di Claudio Burlando (governatore della Liguria), associazione trasversale che ha tra i membri la Genova che conta. Sono esplose polemiche per gli incarichi pubblici ottenuti dai membri, anche perché tra i promotori apparivano una bella fetta della società Italbrokers (da cui Lorenzo Borgogni, pezzo grosso di Finmeccanica, sostiene di aver ricevuto due milioni, ma gli interessati smentiscono e annunciano azioni legali), nonché Franco Pronzato, arrestato per le mazzette Enac. Lo stesso Pronzato che era socio di Interconsult (società in passato legata a Italbrokers), impresa che ha versato 25 mila euro di contributi pubblicitari alla società Solaris che fa capo a Italianieuropei. Dopo le polemiche nessun chiarimento, ma il sito di Maestrale non è più visitabile.
Copertura assoluta. Impossibile, ecco il nodo della questione, per comuni cittadini e cronisti avere notizie sui finanziatori di associazioni e fondazioni. Si era visto all’epoca dell’inchiesta su Franco Morichini, procacciatore di finanziamenti per Italianieuropei: “Rivelare i nomi sarebbe come renderne pubblici gli orientamenti politici”, dissero dalla fondazione dalemiana. Vero, ma i partiti hanno l’obbligo di rendere pubblico chi li finanzia. I nuovi soggetti della politica italiana invece no: basta depositare in prefettura l’atto costitutivo e lo statuto. E nessuno, a parte eventualmente i magistrati, può metterci il naso. Così ecco la domanda: chi paga le fondazioni? Chi è il destinatario finale del denaro? Certo, ci sono casi – più unici che rari – come Magna Carta che rende pubblici i nomi dei finanziatori, come Francesco Bellavista Caltagirone, British American Tobacco, Mediaset, Wind e Finmeccanica. Viene da chiedersi che utilità abbia una società pubblica a sponsorizzare la fondazione di un politico. Per scoprire chi finanzia le fondazioni non resta che prendere scorciatoie. Per esempio andando a vedere l’elenco degli inserzionisti pubblicitari dei loro giornali. Prendiamo Italianieuropei. Nel 2011 troviamo una bella lista di imprese pubbliche: Eni, Fincantieri, Enel, Trenitalia e ancora Finmeccanica. Poi giganti del settore privato: di nuovo British American Tobacco, poi si passa al mattone stavolta di sinistra con Coopsette, quindi al settore ferroviario con Bombardier che sforna centinaia di locomotive per i nostri treni, quindi Lottomatica, Barclays, Conad-Leclerc, Allianz, Sky, la banca ‘rossa’ del Monte Paschi di Siena e Telecom Italia. Infine Sma, società del gruppo Intini, un imprenditore amico di D’Alema che faceva affari con Gianpi Tarantini. Lo stesso Intini che attraverso due società, Sma e Milanopace, contribuisce all’associazione Faremetropoli di Penati. Niente di illegale, comunque, Italianieuropei (come Faremetropoli) ha sempre regolarmente registrato i finanziamenti. Da Il Fatto Quotidiano del 27 novembre 2011
Pd, la mappa del tesoro tra fondazioni e immobili. Il patrimonio del partito, 500 milioni di euro, in una ragnatela di fondazioni e società immobiliari. Amministratori a vita di nomina dalemiana, scrive Antonio Calitri il 17 marzo 2017 su Quotidiano.net. Il Partito dei Democratici di sinistra è stato archiviato, confluito con la Margherita nel Pd. Ma i suoi beni sono ancora in mezzo a noi. Palazzi, case del popolo, capannoni. Tutto finito in mano a decine di fondazioni politiche create con lo stampino da Ugo Sposetti, ex tesoriere dei Ds. Le fondazioni della vecchia Ditta hanno tutte lo stesso statuto, mutuato dalle fondazioni bancarie: non hanno scopo di lucro e sono ufficialmente indipendenti e blindate da qualsiasi aggressione esterna. Hanno come "finalità" lo "studio, la ricerca, la formazione, all’innovazione della politica" e in particolare quello di "intraprendere iniziative" per "promuovere il pensiero, la cultura e l’azione politica della sinistra italiana ed europea". E per fare questo possono "progettare e organizzare attività formative, corsi, convegni e seminari", oltre che "promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali". Alcune sono molto attive in questo senso, come la bolognese Fondazione Duemila presieduta da Mauro Roda, ex dalemian-bersaniano, poi con Vasco Errani e ora indipendente anche da loro visto che è rimasto nel Pd. Di fatto però queste fondazioni, al di là di qualche iniziativa politico-culturale, come primo impegno reale hanno la gestione di quasi 2.400 immobili. Che sulla carta non hanno scopo di lucro, ma che le fondazioni cercano di far fruttare al meglio. E per farlo in tranquillità e senza conflitti con il loro scopo ‘ufficiale’, si sono dotate di società di gestione immobiliare. Società di diritto privato del tutto simili alle altre immobiliari che hanno lo scopo di lucro e possono fare assunzioni e operazioni senza dover rendere conto al livello politico. Al Pd, che ogni tanto tenta di attaccarle, le società immobiliari affittano le sedi dei circoli, con prezzi che dovrebbero essere "calmierati". Il problema però è che molte sezioni piccole o periferiche non riescono a pagare regolarmente gli affitti. Tant’è che accumulano debiti e rischiano lo sfratto. Ma le immobiliari sono società private e – ha spiegato lo stesso Sposetti – non possono fare beneficenza perché devono rispondere al codice civile. Così si è creato un incrocio tra le fondazioni – tenute a rispettare solo il proprio statuto e non obbligate a pubblicare i bilanci (e molte appunto non lo fanno) – e le società immobiliari, non tenute agli alti scopi ideali delle fondazioni, e spesso anche difficili da rintracciare. Così, per esempio, l’immobiliare Porta Castello che fa capo alla Fondazione Duemila di Roda, è una delle più trasparenti: pubblica sul sito non solo lo statuto e l’organigramma ma anche i bilanci. Mentre altre non hanno neppure un sito oppure ce l’hanno completamente vuoto. Per questo, per ricostruire la dinamica della gestione immobiliare del patrimonio, si deve andare a spanne. Tra quelle che si sono dotate di immobiliare c’è la fondazione Ugo Quercioli di Milano che controlla la Risorgimento Srl. O la fondazione Rinascita di Venezia che controlla l’omonima immobiliare (52 immobili). In Friuli Venezia Giulia, la fondazione Isonzo controlla le immobiliari Isontina e Monfalconese. E così via per 2.400 immobili, per i quali ricostruire davvero il business è quasi impossibile. Anche per i creditori e per lo stesso Pd.
Tutte le Fondazioni su cui si litiga nel Partito Democratico. Sono 67 e sono nate nel 2007 dopo lo scioglimento dei Democratici di sinistra per gestire il patrimonio del partito. Ma la loro gestione è spesso opaca, scrive Maurizio Tortorella il 2 marzo 2017 su Panorama. Queste sono le 67 fondazioni create dopo lo scioglimento dei Democratici di sinistra, deciso nell’aprile 2007, con lo scopo principale di gestire e conservare il patrimonio immobiliare del partito. Si tratta di enti che, per legge, non sono tenuti alla pubblicità dei bilanci: la loro gestione è pertanto opaca. Quello che segue è comunque un accurato studio della documentazione patrimoniale pubblicata online dalle 67 fondazioni, là dove ne sono disponibili i dati.
Alessandria – Fondazione Luigi Longo: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Ancona – Fondazione 1° Maggio: costituita nell’aprile 2009. Patrimonio netto dichiarato nel bilancio 2013: 5,7 milioni di euro.
Aosta – Fondazione Giulio Dolchi: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Aquileia (Udine) - Fondazione Valmi Puntin: costituita nel dicembre 2007, nell’atto costitutivo indica un «patrimonio di immobili nel centro di Aquileia», non meglio determinato.
Arezzo - Associazione culturale La Quercia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Asti – Fondazione Bruno Ferraris: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Bari – Fondazione Tommaso Sicolo: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Belluno – Fondazione Società bellunese: costituita nel marzo 2008, ha 3 immobili di proprietà in città, valutati 570 mila euro nel bilancio 2015.
Bergamo - Fondazione Gritti Minetti: costituita nel luglio 2008, possiede 57 immobili tra città e provincia, 28 dei quali affittati al Pd, 4 alla Cgil, 2 a testa a Sel e Pcd’I. Nel bilancio 2015 vengono valutati 4,8 milioni di euro.
Biella – Fondazione Biella domani: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Bologna –Fondazione Duemila: costituita nel 2007, nel bilancio 2015 indica un patrimonio immobiliare di 12,9 milioni di euro, più partecipazioni in società immobiliari per altri 6,7 milioni.
Bolzano – Fondazione Andrea Mascagni: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Cagliari – Fondazione Enrico Berlinguer: costituita nel giugno 2007, possiede direttamente 68 immobili in tutta la regione, più altri 16 attraverso la società Karalis Srl. Nel bilancio 2012 vengono complessivamente valutati 3,5 milioni.
Campobasso – Fondazione Antonio di Maria: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Cesena – Fondazione Le radici della sinistra: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Como – Fondazione Avvenire: costituita nel novembre 2009, ha un sito internet, ma nessun dato disponibile.
Crema - Fondazione Ds: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Cremona – Fondazione Cremona democratica: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Crotone - Fondazione Berlinguer: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Ferrara – Fondazione L'approdo: costituita nel luglio 2007, possiede 29 immobili tra città e provincia, 21 dei quali affittati al Pd e 3 alla Cgil, senza alcuna valorizzazione patrimoniale.
Foggia – Fondazione Vittorio Foa: possiede 6 immobili tra città e provincia. È del 2009 l’ultimo bilancio pubblicato, senza alcuna valorizzazione patrimoniale.
Forlì – Fondazione Ariella Farnetti: costituita nel 2007, ha un sito internet, ma nessun dato disponibile.
Genova - Fondazione Diesse: costituita nell’aprile 2008, nel bilancio 2015 indica un patrimonio immobiliare di 9,2 milioni di euro.
Gorizia – Fondazione Isonzo: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Grosseto – Fondazione Associazione culturale La Quercia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Imola - Fondazione Politica per Imola: costituita nel giugno 2007, nell’atto costitutivo è scritto che le si conferisce il pacchetto azionario di una società immobiliare, allora valutato 950 mila euro.
Imperia - Fondazione Alessandro Natta: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Ivrea – Fondazione Canavese democratico: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
La Spezia - Fondazione Duemilasette: costituita nel 2007, possiede 44 immobili tra città e provincia, 32 dei quali affittati al Pd, 3 all’Arci e uno alla Cgil.
Lecco – Fondazione Ciceri Losi: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Lodi – Fondazione Antonio Taranelli: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Macerata – Fondazione Giuseppe Belli: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Mantova – Fondazione Mantova: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Massa Carrara – Fondazione La rosa apuana: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Mestre (Venezia) – Fondazione Rinascita 2007: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Milano - Fondazione Elio Quercioli: costituita nel novembre 2007, possiede 128 immobili più 19 pertinente, e di questi 72 sono utilizzati dal Pd, 2 da Rifondazione comunista, 3 da Sel, 8 dall'Arci; altri 12 immobili sono utilizzati da circoli o associazioni che svolgono attività culturali, 25 affittati per attività commerciali, 6 sono vuoti. Nel bilancio 2013 questo patrimonio immobiliare è stato valutato 11,5 milioni di euro.
Modena – Fondazione Modena 2007: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Napoli – Fondazione Gerardo Chiaromonte: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Novara - Fondazione novarese democratici di sinistra: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Padova – Fondazione Nuova Società: costituita nel 2007, possiede 31 immobili tra città e provincia, 12 dei quali concessi gratuitamente al Pd. Possiede anche la Left Srl, che organizza campagne pubblicitarie. Nel bilancio 2015 gli immobili vengono valutati 6,2 milioni di euro.
Parma – Fondazione Arta, Ds Parma: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Pavia - Fondazione Pavia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Pesaro Urbino – Fondazione XXV Aprile: costituita nel novembre 2008, possiede 57 immobili tra città e provincia; nel bilancio 2011 vengono valutati 11,5 milioni, cui si aggiunge 1 milione di partecipazioni finanziarie.
Pescara – Fondazione Abruzzo riforme: costituita nel dicembre 2007, possiede 36 immobili, che nel bilancio 2015 vengono stimati 3,3 milioni di euro.
Piacenza – Fondazione Piacenza futura: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Piombino (Livorno) – Fondazione Associazione culturale La Quercia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Pisa – Fondazione La Quercia pisana: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Pistoia - Associazione La Quercia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Potenza - Fondazione Basilicata futuro: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Prato – Fondazione Europa futuro: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Ravenna – Fondazione Bella ciao: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Reggio Emilia – Fondazione Tricolore: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Rimini – Fondazione Rimini democratica per la sinistra: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Rovigo – Fondazione L'arca: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Savona – Fondazione Cento fiori: costituita nel 2007, possiede 21 immobili, 17 dei quali sono sedi del Pd, e un terreno.
Siena – Fondazione Associazione culturale La Quercia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Palermo – Fondazione Rosario di Salvo: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Perugia – Fondazione Pietro Conti: costituita nel settembre 2007, ha un sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Trento - Fondazione Sinistra trentina: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Treviso – Fondazione Treviso 2000: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Trieste - Fondazione per il riformismo nel Friuli-Venezia-Giulia: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Varese - Fondazione Città futura: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Vercelli – Fondazione Rinascita: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Verona – Fondazione Verona: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Viareggio (Lucca) - Fondazione dei democratici di sinistra della Versilia: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Vicenza – Fondazione Mauro Nordera Busetto, Ds vicentini: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Viterbo - Fondazione Gualtiero Sarti: costituita nell’agosto 2007, possiede 27 immobili, 17 dei quali affittati al Pd, 1 alla Cgil e 1 all’Unipol, che nel bilancio 2015 sono valutati 1,6 milioni di euro.
Il capitale non teme scissioni, scrive Maurizio Tortorella il 20 marzo 2017. Con lo scisma del Pd si rieccitano gli appetiti intorno all’eredità del Pci. Indagine su un enorme patrimonio di entità sconosciuta che nessuno può rivendicare. Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola. – Per raccontare del mitico patrimonio del disciolto Partito comunista italiano, poi ribattezzato Partito democratico della sinistra e infine trasformato nei Democratici di sinistra, viene perfetta l’antica filastrocca dell’araba Fenice, sia pure con qualche variazione: che vi sia, ciascun lo dice; dove sia, qualcun lo sa; quanto valga, è il gran mistero. Eppure, non è affatto nascosto quell’immenso patrimonio. Al contrario: è fatto di case, immobili, terreni, negozi. E di capannoni industriali, ristoranti e bar. C’è chi favoleggia ci sia perfino qualche cinematografo. Di sicuro, dalla Valle d’Aosta fino a Trapani, ne fanno parte centinaia di case del popolo, e quasi duemila sezioni, e sedi di partito, e di sindacato. Stime prive di qualsiasi ufficialità, nel corso del tempo, hanno ipotizzato da 3 mila a 5 mila unità immobiliari, per un valore oscillante tra 500 e 1.500 milioni di euro. Ma sedi e milioni potrebbero essere anche il doppio, tanto è il mistero. Insomma, per tornare alla filastrocca: quanto sia, nessun lo sa. L’unica cosa certa è che almeno una buona parte dei beni del Pci-Pds-Ds, a partire dall’estate 2007, quando i Ds si sciolsero per confluire nel Partito democratico, è stata infilata in 67 fondazioni, costituite da fidatissimi compagni, spesso anziani, e tutte amministrate gratuitamente da quegli stessi fidatissimi compagni, spesso nominati a vita. Per la prima volta (vedere la scheda nelle pagine 20 e 21), Tempi rompe il mistero e rivela il nome delle 67 fondazioni, elencate in base alle regioni e alle città in cui operano, e là dov’è possibile ne indica anche il patrimonio immobiliare per com’è stato dichiarato negli atti costitutivi. Le fondazioni sono collegate tra loro e coordinate operativamente dall’Associazione Berlinguer, creata più o meno nel 2010, che può considerarsi una fondazione numero 68.
Nessuna trasparenza. Non aspettatevi alcuna trasparenza, però, perché notoriamente le fondazioni sono il più opaco tra gli strumenti societari previsti dal nostro Codice civile. Tant’è vero che soltanto 12 su 67 hanno pubblicato online uno straccio di documento costitutivo, da cui si desume possiedano oltre 510 immobili, in gran parte sedi e uffici affittati al Pd o ad organizzazioni vicine, ufficialmente valorizzato sui 70 milioni di euro. Ma sono bazzecole. Briciole. Un’irrealistica mezza miseria. Del resto, gli stessi bilanci, là dove esistono, risalgono a volte al 2013 o al 2012. In molte città, poi, stranamente non esistono fondazioni: né a Roma, né a Firenze, per esempio, ma nemmeno a Livorno, dove pure il Pci nacque nel 1917. Mille domande restano tutte senza risposta. L’attenzione al tema, del resto, è poca e labile. Si solleva un poco oggi, che il Partito democratico si rompe. Perché, con la scissione organizzata da compagni antichi come gli ex segretari Massimo D’Alema e Pier Luigi Bersani, il tema del patrimonio dell’ex Pci diventa piatto ricco, in cui viene voglia di ficcarsi. E infatti proprio sulle fondazioni litigano neanche troppo sommessamente, gli ex comunisti: divisi tra quelli che resistono nel Pd in funzione antirenziana e gli scissionisti antirenziani che fondano il Movimento democratico e progressista. Qualche giorno prima del battesimo della nuova formazione, per esempio, D’Alema ha lanciato un avvertimento: «Le fondazioni non sono di nessuno: sono di proprietà di quelle compagne e di quei compagni che hanno costruito case del popolo e sezioni». E ha ragione, il vecchio Max, perché le 67 fondazioni con il Pd non hanno proprio nulla a che fare. Al contrario, furono costituite tra 2007 e 2009 per proteggersi dai creditori, che rivendicavano oltre 150 milioni di euro (poi pagati dallo Stato nel novembre 2015 grazie a una furba legge, opportunamente sponsorizzata nel 1998 proprio dai Ds), ma anche per evitare di mettere in comune i beni del Partito con gli ex democristiani della Margherita. Mai gli eredi del Pci avrebbero conferito in dote al Pd la ricchezza della “Ditta”. In quei mattoni c’era il sangue di generazioni di comunisti e si concretizzava la storia stessa del Pci, che di alcuni di quegli immobili s’era impossessato durante la Resistenza, mentre altri erano stati acquistati grazie ai finanziamenti segreti dall’Unione Sovietica oppure con le “tangenti” incassate su ogni operazione commerciale tra Italia e paesi dell’Est durante la Guerra fredda. Altri erano il frutto di milioni d’ore di lavoro regalate al Partito dagli iscritti, oppure d’infinite collette e sottoscrizioni.
La bandiera di Sposetti. Ad avere l’idea di infilare l’eredità del Gran Partito in queste 67 scatole oscure è stato un signore baffuto e simpatico, che ha appena compiuto 70 anni e somiglia a Peppone: si chiama Ugo Sposetti, negli anni Settanta era segretario della Federazione Pci di Viterbo ed è stato l’ultimo tesoriere dei Ds. Entrato in Parlamento nel 1987, dal 2007 il compagno senatore Sposetti è il grande custode delle fondazioni. Nella sua mente il patrimonio che controllano, in quanto eredità storica del Pci, ha un valore metapartitico e metafisico, di certo superiore alle umane oscillazioni della politica. Gli immobili, insomma, non sono di nessuno e non seguono nessuno: sono lì come un simbolo, una bandiera (rossa) che resiste al vento della Storia. Un po’ come le 410 opere d’arte del Pci, che al contrario dei mattoni sono state censite, e rappresentano una ricchezza che affianca in un’ideale galleria capolavori di Renato Guttuso, Mario Schifano, Giò Pomodoro e mille altri, più l’intero archivio storico da Palmiro Togliatti a Piero Fassino.
Né a Renzi né a D’Alema. Sposetti in cuor suo è convinto che le fondazioni e la loro “roba” non appartengano al Pd, ma nemmeno a D’Alema o a Bersani, neppure se questi cercano di costruire un Partito della sinistra. Già all’inizio del 2014, quando l’ex democristiano Matteo Renzi s’era impossessato della segreteria e nel Pd tiravano i primi venti di rottura contro il Rottamatore, Sposetti aveva ringhiato: «Io non metterò il patrimonio dei Ds a disposizione di una scissione». Lo stesso fa oggi: «Le fondazioni non c’entrano né con il Pd né con gli scissionisti» proclama, tetragono. C’è da credergli. Il problema riguarda semmai la destinazione d’uso degli immobili. Perché almeno 1.800 sedi del Pd oggi sono ospitate nelle ex sezioni del Pci-Pds-Ds. Molte pagano l’affitto alle fondazioni, poche occupano gli spazi in comodato gratuito, alcune sono morose a causa della crisi economica. Da buon custode anche dell’ortodossia immobiliare, Sposetti nel 2016 ha guidato un’offensiva contro gli inquilini inadempienti: «Attenti. Chi non paga sarà sfrattato». Ma il punto, oggi, è un altro: resteranno davvero tutte neutrali, le fondazioni, mentre gli ex comunisti del Pd si dividono? E che cosa accadrà alle sezioni? A Serino, in provincia di Avellino, gli scissionisti di provenienza Ds sono in stragrande maggioranza, così la sede è passata con loro e qualcuno ha già provveduto a staccare l’insegna con la P verde e la D rossa. Quella sezione, forse, non apparteneva a una fondazione. Ma che cosa potrebbe accadere se invece la scissione dovesse avere il sopravvento, mettiamo, in una grossa città dell’Emilia rossa? A Bologna Mauro Roda, classe 1952, un lungo passato nel Pci, dal 2007 guida la Fondazione Duemila, che gestisce almeno 28 case del popolo e chissà quanti altri immobili: «Io mi sono battuto per sommare Ds e Margherita e per far nascere il Pd», dichiara. «La Fondazione, però, è un’altra cosa: noi le sedi le diamo a chi ce le chiede. Abbiamo lo scopo di diffondere la cultura della sinistra. Già ora non ospitiamo soltanto il Pd, ma anche circoli Arci e associazioni culturali».
La sconfitta della magistratura. Chissà come andrà a finire. E chissà se, tra cento anni, sarà possibile avere una mappa più trasparente e realistica del patrimonio dell’ex Pci. Non sarà facile: non c’erano riusciti nemmeno i magistrati ai tempi d’oro di Tangentopoli. Il pm veneziano Carlo Nordio, che è appena andato in pensione, stimò allora che dalle sue parti il patrimonio immobiliare del Pci-Pds, in molti casi fittiziamente intestato a un numero imprecisato di compagni, valesse almeno mille miliardi di lire. Nelle richieste finali della sua indagine sulle tangenti rosse, però, Nordio scrisse di non aver potuto procedere nell’inchiesta sul patrimonio del Partito a causa della scomparsa della documentazione. Era accaduto che il 19 settembre 1993 Tiziana Parenti, la collega di Nordio che da Milano indagava su Marco Fredda, allora responsabile del patrimonio immobiliare del Pds, avesse fatto perquisire i suoi uffici alle Botteghe Oscure. Davanti a tonnellate di carta, e su richiesta dei funzionari di Partito («Se portate via la documentazione, noi non possiamo lavorare»), i carabinieri avevano rinunciato a trasferire quelle migliaia di fascicoli a Milano. Le carte, così, erano rimaste nelle stanze del palazzo, sigillate dai militari. Due giorni dopo Parenti aveva spedito la Guardia di finanza a visionare i documenti, ma i sigilli erano stati violati e la documentazione era sparita. Nordio ricorda, sconsolato: «Gli agenti trovarono l’ufficio assolutamente vuoto». Erano rimaste solo le tracce degli scatoloni, trascinate sui pavimenti. La Fenice era volata via.
Le 67 fondazioni (più una) che custodiscono la leggendaria fortuna dei “compagni”. Queste sono le 67 fondazioni create dopo lo scioglimento dei Democratici di sinistra, deciso nell’aprile 2007, con lo scopo principale di gestire e conservare il patrimonio immobiliare del Partito. Le fondazioni, in base al Codice civile, non sono tenute alla pubblicità dei bilanci: la loro gestione è pertanto opaca. Quello che segue è comunque un accurato studio della documentazione patrimoniale pubblicata online dalle 67 fondazioni, là dove ne sono disponibili i dati.
Emilia Romagna: 11
Bologna – Fondazione Duemila: costituita nel 2007, nel bilancio 2015 indica un patrimonio immobiliare di 12,9 milioni di euro, più partecipazioni in società immobiliari per altri 6,7 milioni.
Cesena – Fondazione Le radici della sinistra: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Ferrara – Fondazione L’approdo: costituita nel luglio 2007, possiede 29 immobili tra città e provincia, 21 dei quali affittati al Pd e 3 alla Cgil, senza alcuna valorizzazione patrimoniale.
Forlì – Fondazione Ariella Farneti: costituita nel 2007, ha un sito internet, ma nessun dato disponibile.
Imola – Fondazione Politica per Imola: costituita nel giugno 2007, nell’atto costitutivo è scritto che le si conferisce il pacchetto azionario di una società immobiliare, allora valutato 950 mila euro.
Modena – Fondazione Modena 2007: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Parma – Fondazione Arta, Ds Parma: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Piacenza – Fondazione Piacenza futura: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Ravenna – Fondazione Bella ciao: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Reggio Emilia – Fondazione Tricolore: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Rimini – Fondazione Rimini democratica per la sinistra: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Lombardia: 10
Bergamo – Fondazione Gritti Minetti: costituita nel luglio 2008, possiede 57 immobili tra città e provincia, 28 dei quali affittati al Pd, 4 alla Cgil, 2 a testa a Sel e Pcd’I. Nel bilancio 2015 vengono valutati 4,8 milioni di euro.
Como – Fondazione Avvenire: costituita nel novembre 2009, ha un sito internet, ma nessun dato disponibile.
Crema – Fondazione Ds: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Cremona – Fondazione Cremona democratica: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Lecco – Fondazione Ciceri Losi: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Lodi – Fondazione Antonio Taranelli: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Mantova – Fondazione Mantova: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Milano – Fondazione Elio Quercioli: costituita nel novembre 2007, possiede 128 immobili più 19 pertinenze, e di questi 72 sono utilizzati dal Pd, 2 da Rifondazione comunista, 3 da Sel, 8 dall’Arci; altri 12 immobili sono utilizzati da circoli o associazioni che svolgono attività culturali, 25 affittati per attività commerciali, 6 sono vuoti. Nel bilancio 2013 questo patrimonio immobiliare è stato valutato 11,5 milioni di euro.
Pavia – Fondazione Pavia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Varese – Fondazione Città futura: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Toscana: 9
Arezzo – Associazione culturale La Quercia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Grosseto – Fondazione Associazione culturale La Quercia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Massa Carrara – Fondazione La rosa apuana: sito inattivo, nessun dato disponibile.
Piombino (Livorno) – Fondazione Associazione culturale La Quercia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Pisa – Fondazione La Quercia pisana: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Pistoia – Associazione La Quercia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Prato – Fondazione Prato Europa futuro: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Siena – Fondazione Associazione culturale La Quercia: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Viareggio (Lucca) – Fondazione dei democratici di sinistra della Versilia: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Veneto: 7
Belluno – Fondazione Società bellunese: costituita nel marzo 2008, ha 3 immobili di proprietà in città, valutati 570 mila euro nel bilancio 2015.
Mestre (Venezia) – Fondazione Rinascita 2007: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Padova – Fondazione Nuova Società: costituita nel 2007, possiede 31 immobili tra città e provincia, 12 dei quali concessi gratuitamente al Pd. Possiede anche la Left Srl, che organizza campagne pubblicitarie. Nel bilancio 2015 gli immobili vengono valutati 6,2 milioni di euro.
Rovigo – Fondazione L’arca: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Treviso – Fondazione Treviso 2000: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Verona – Fondazione Verona: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Vicenza – Fondazione Mauro Nordera Busetto, Ds vicentini: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Piemonte: 6
Alessandria – Fondazione Luigi Longo: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Asti – Fondazione Bruno Ferraris: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Biella – Fondazione Biella domani: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Ivrea – Fondazione Canavese democratico: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Novara – Fondazione novarese democratici di sinistra: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Vercelli – Fondazione Rinascita: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Friuli-Venezia Giulia: 3
Aquileia (Udine) – Fondazione Valmi Puntin: costituita nel dicembre 2007, nell’atto costitutivo indica un «patrimonio di immobili nel centro di Aquileia», non meglio determinato.
Gorizia – Fondazione Isonzo: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Trieste – Fondazione per il riformismo nel Friuli-Venezia-Giulia: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Liguria: 4
Genova – Fondazione Diesse: costituita nell’aprile 2008, nel bilancio 2015 indica un patrimonio immobiliare di 9,2 milioni di euro.
Imperia – Fondazione Alessandro Natta: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
La Spezia – Fondazione Duemilasette: costituita nel 2007, possiede 44 immobili tra città e provincia, 32 dei quali affittati al Pd, 3 all’Arci e uno alla Cgil.
Savona – Fondazione Cento fiori: costituita nel 2007, possiede 21 immobili, 17 dei quali sono sedi del Pd, e un terreno.
Marche: 3
Ancona – Fondazione 1° Maggio: costituita nell’aprile 2009. Patrimonio netto dichiarato nel bilancio 2013: 5,7 milioni di euro.
Macerata – Fondazione Giuseppe Belli: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Pesaro Urbino – Fondazione XXV Aprile: costituita nel novembre 2008, possiede 57 immobili tra città e provincia; nel bilancio 2011 vengono valutati 11,5 milioni, cui si aggiunge 1 milione di partecipazioni finanziarie.
Trentino-Alto Adige: 2
Bolzano – Fondazione Andrea Mascagni: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Trento – Fondazione Sinistra trentina: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Puglia: 2
Bari – Fondazione Tommaso Sicolo: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Foggia – Fondazione Vittorio Foa: possiede 6 immobili tra città e provincia. È del 2009 l’ultimo bilancio pubblicato, senza alcuna valorizzazione patrimoniale.
Valle d’Aosta: 1
Aosta – Fondazione Giulio Dolchi: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Umbria: 1
Perugia – Fondazione Pietro Conti: costituita nel settembre 2007, ha un sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Lazio: 1
Viterbo – Fondazione Gualtiero Sarti: costituita nell’agosto 2007, possiede 27 immobili, 17 dei quali affittati al Pd, 1 alla Cgil e 1 all’Unipol, che nel bilancio 2015 sono valutati 1,6 milioni di euro.
Abruzzo: 1
Pescara – Fondazione Abruzzo riforme: costituita nel dicembre 2007, possiede 36 immobili, che nel bilancio 2015 vengono stimati 3,3 milioni di euro.
Molise: 1
Campobasso – Fondazione Antonio di Maria: nessun sito, nessun dato disponibile.
Campania: 1
Napoli – Fondazione Gerardo Chiaromonte: sito internet inattivo, nessun dato disponibile.
Basilicata: 1
Potenza – Fondazione Basilicata futuro: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Calabria: 1
Crotone – Fondazione Berlinguer: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Sicilia: 1
Palermo – Fondazione Rosario di Salvo: nessun sito internet, nessun dato disponibile.
Sardegna: 1
Cagliari – Fondazione Enrico Berlinguer: costituita nel giugno 2007, possiede direttamente 68 immobili in tutta la regione, più altri 16 attraverso la società Karalis Srl. Nel bilancio 2012 vengono complessivamente valutati 3,5 milioni.
Esiste poi una sessantottesima fondazione, l’Associazione Berlinguer, che ha una funzione di coordinamento e apparentemente non possiede immobili.
Giuseppe Alberto Falci per il Corriere della Sera 19 giugno 2018. C' è un velo di mistero dietro al finanziamento dell'imprenditore romano Luca Parnasi alla fondazione Eyu (Europa, Youdem, Unità), legata al Partito Democratico. Tutto ruota attorno al finanziamento di 123 mila euro che Parnasi ha stanziato nel bel mezzo della campagna elettorale delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo per uno studio sul rapporto tra gli italiani e la proprietà immobiliare. Il presidente della fondazione, il renziano Francesco Bonifazi, resta in silenzio. Anche Domenico Petrolo, responsabile relazioni esterne e fundraising di Eyu, che avrebbe seguito passo passo l'iter dell'erogazione del finanziamento, preferisce tenere la bocca cucita: «Sono in silenzio stampa, non dico nulla». Lo studio esiste, almeno secondo la versione che è stata fornita al Corriere della Sera dal segretario generale Mattia Peradotti, ed è stato redatto da ricercatori di livello di alcune prestigiose università. C' è anche un titolo: «Il rapporto degli italiani con il progetto di casa». Oltre però non si può andare. Non è dato sapere chi saranno mai stati gli autorevoli ricercatori. Né tantomeno è possibile visionare il paper perché, spiegano dalla fondazione Eyu, «in questo caso la proprietà intellettuale appartiene a Parnasi e noi». Dall' altra parte è impossibile contattare il gruppo Parnasi. Perché Giulio Mangosi, il responsabile comunicazione e relazioni istituzionali di Eurnova, colui che da sempre tiene i rapporti con la stampa per il gruppo Parnasi, è finito agli arresti. Eppure c' è un giallo nel giallo. Digitando su Google «casa proprietà italiani fondazione Eyu», il motore di ricerca rimanda a un link di Eyu del tipo: «Casa, ma solo di proprietà?». Cliccando però non si legge nulla, lo studio non sarebbe più presente all' interno del sito della fondazione. Il motivo? Peradotti la mette così: «In questi giorni il sito è in revisione, quindi abbiamo alcuni problemi». Tuttavia il Corriere è riuscito a consultarlo. Il progetto di ricerca, come si legge dall' incipit, «si pone l'obiettivo di studiare il rapporto degli italiani con il concetto di proprietà di casa». E ancora: «Tenendo conto delle caratteristiche demografiche, lavorative e della ricchezza finanziaria famigliare, verrà analizzata la probabilità di essere proprietario di casa, rispettivamente, all' età di 30, 40, 50 anni, e verrà illustrato come tale probabilità sia differente per diverse categorie di soggetti». Di fatto, il titolo e il contenuto ricordano lo studio richiesto da Parnasi. Ci sono anche i nomi dei due ricercatori che hanno contribuito ad avvalorare la ricerca. Si tratta di Renata Bottazzi e Serena Trucchi, entrambe dell'università di Bologna. Bottazzi precisa via mail: «Ho condotto insieme a Serena Trucchi un progetto commissionato dalla Fondazione Eyu dal titolo "Casa, ma solo di proprietà?" riguardo il rapporto degli italiani con il concetto di proprietà della casa. []. Tale attività è stata svolta tra l'ottobre e il dicembre 2015, e si è conclusa con la consegna, da parte nostra, di un rapporto inviato il 10 dicembre 2015. Il compenso omnicomprensivo per tale attività consiste nel totale di 3.500 euro lorde per ciascuna delle due ricercatrici, senza ulteriori indennità o rimborsi spese». E dal giallo si passa direttamente al mistero.
Leopolda, boom di incassi per la fondazione Open di Renzi. Mentre il Pd perde donatori. Da quando l'ex sindaco di Firenze è diventato segretario, le elargizioni private ricevute dal partito sono calate di un terzo. Ma sono cresciute quelle al giglio magico. E tra i finanziatori persino fiduciarie dal nome misterioso, scrivono Giovanni Tizian e Stefano Vergine il 24 novembre 2017 su "L'Espresso". Matteo Renzi alla Leopolda del 2016C'è una strana tendenza iniziata in concomitanza alla sua ascesa ai vertici del Pd. Da quando Matteo Renzi è diventato segretario, le donazioni private ricevute dal partito sono calate di un terzo. Contemporaneamente sono quasi triplicate quelle incassate dalla sua fondazione. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni. Dal 2013 al 2016 le contribuzioni liberali ricevute dalla fondazione Open sono passate da 672 mila a 1,9 milioni di euro, mentre quelle incassate dal Pd sono calate dagli 11,6 milioni del 2013 agli 8,1 milioni dell’anno scorso. L'inchiesta dell'Espresso in edicola con Repubblica da domenica 26 novembre traccia il profilo dei grandi finanziatori della politica, analizzando i dati delle donazioni private di cui hanno beneficiato i partiti negli ultimi dieci anni. Una radiografia del passato per comprendere il futuro. Perché le prossime elezioni saranno le prime senza finanziamento pubblico. Con i capitali privati destinati a pesare più che mai sulla campagna elettorale. Quello della fondazione renziana Open, organizzatrice in questi giorni della Leopolda, è solo uno dei tanti casi analizzati dal settimanale. Un caso sintomatico della strada intrapresa da diversi leader politici. Gli imprenditori hanno infatti preferito sostenere la creatura del giglio magico, piuttosto che il partito di cui l'ex sindaco di Firenze è segretario. Chi paga e chi manipola: sono le due vere domande che ci accompagneranno in vista delle elezioni del 2018. Nel nuovo numero dell'Espresso mostriamo chi sono dal 2008 a oggi i grandi finanziatori privati della politica, sempre più importanti con la fine del finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali, e chi invece cerca di manipolare, qui e all'estero, l'agenda politica. La tendenza potrebbe aver colpito anche altre forze politiche, ma è difficile verificarlo dato che la fondazione Open è una delle poche a pubblicare bilanci e liste dei donatori. O almeno di quelli che non si sono opposti a questa operazione di trasparenza. Spulciando i resoconti della fondazione che sostiene Renzi si legge che finora ha ricevuto donazioni pari a 5,5 milioni di euro. Tesoretto a cui hanno contribuito oltre un centinaio di imprese. In cima alla classifica dei donatori di Matteo c'è il finanziere Davide Serra, 225 mila euro finora versati. Subito dietro – 200 mila euro - si piazza Vincenzo Onorato, armatore napoletano proprietario della compagnia di traghetti Moby, che da un paio d'anni ha acquisito anche il controllo dell'ex azienda pubblica Tirrenia. Operazione tuttora sotto i riflettori dell'Antitrust. Al fianco dei grandi finanziatori convivono donatori poco noti. Tra i più recenti c'è per esempio la Assisi Project, tra i cui azionisti troviamo Giacomo Straffi, collega e socio, in un'altra impresa, del senatore Nicola Di Girolamo, condannato per la vicenda Fastweb-Telecom Sparkle. C'è l'ex numero due del ministero dell'Economia, Lorenzo Codogno, che ha donato 30 mila euro attraverso una società inglese, la Mci Research and Management, il cui socio di maggioranza è il finanziere Claudio Zampa, italiano con base in Svizzera. E c'è pure una misteriosa fiduciaria: la S. Andrea Mf 1117, di cui non è possibile conoscere i soci, ma che di certo ha molti interessi in Italia essendo azionista di ben 51 aziende.
Ecco chi finanzia Matteo Renzi. Nomi e cifre, scrive Venerdì 4 settembre 2015 Affari italiani. L‘Espresso dedica un articolo alla fondazione del premier Matteo Renzi “Open”. In un recente report, Openpolis in Italia ha contato 65 “pensatoi”, quasi tutti nati negli ultimi quindici anni (…)” e ancora “Il punto è il bilancio 2014 della Fondazione Open gestita dal cerchio magico del premier, Maria Elena Boschi, Luca Lotti, Marco Carrai, tutti con incarichi sociali a titolo gratuito. La data è quella del 20 giugno 2015. Il dato interessante è l’ottimo risultato in fatto di raccolta fondi, con donazioni pari a un milione e 184mila euro. Sono 300mila euro in più rispetto all’anno precedente, quando però il bilancio registrava anche 100mila euro raccolti durante le manifestazioni: era però l’anno della campagna elettorale, delle molte cene e iniziative (…)”. Ma chi sono i finanziatori di Renzi? Sul sito della Fondazione Open ci sono parlamentari, varie case di cura e ospedali privati, fondi di capitali (come l’argentino Corporación América che, con 25mila euro di donazione, vanta interessi anche nel settore aeroportuale) e società. Alcune di queste, come la Bassilichi s.p.a. – che ha donato 20mila euro – lavorano per la pubblica amministrazione in Toscana, ma non solo. Molte, comunque, operano nel campo dell’aeronautica e della gestione di aeroporti e non stupisce, essendo Marco Carrai presidente della quotata Aeroporto di Firenze. Il finanziamento più grande, sempre stando a quanto scritto sul sito della Fondazione Open, arriva però dalla British American Tobacco: 100mila euro è il contributo lasciato dalla seconda più grande società produttrice di sigarette al mondo che, essendosi aggiudicata la privatizzazioni dell’Ente Tabacchi Italiani nel 2004, vanta marchi nazionali come Ms oltre ai planetari Lucky Strike e Pall Mall. 50mila euro è invece il contributo di Davide Serra, che si aggiungono ai 175mila versati precedentemente insieme alla moglie Anna.
Contributi dei privati, ecco tutti i finanziatori del centrosinistra. Non solo 98mila euro dati dal gruppo Riva a Pier Luigi Bersani. A Enrico Letta 15mila euro dal re delle slot machines Antonio Porsia; A Nichi Vendola, 40mila dal truffatore dei tributi Giuseppe Saggese. Matteo Renzi non deve rendere conto dei suoi sponsor passati perché non è mai stato candidato al Parlamento, ma continua a non pubblicare l’elenco integrale dei sostenitori della Fondazione Big Bang che lo appoggia, scrive "Il Fatto Quotidiano" l'1 dicembre 2012. Non ci sono solo i 98mila euro donati dalla famiglia Riva a Pier Luigi Bersani. A sfogliare i libroni dei contributi registrati alla Camera dei deputati, si scopre che la sinistra italiana negli ultimi dieci anni spesso non ha guardato troppo per il sottile di fronte a un generoso imprenditore. Per restare in tema di acciaierie, Enrico Letta ha incassato 40mila euro nel 2008, proprio come Bersani, dall’associazione padronale di categoria, quella Federacciai che vanta come vicepresidente Nicola Riva, ora indagato a Taranto per inquinamento. Letta è uno dei politici di sinistra più graditi agli imprenditori: ha ricevuto 15mila euro nel 2004 da uno dei signori del gioco: Antonio Porsia, già collaboratore di Tiziano Treu nella Margherita e ora titolare della Hbg, una delle dieci concessionarie delle slot machine. Quell’anno Letta ha incassato 9.800 euro anche dalla società del finanziere svizzero Henry Shoet, oltre ai 25mila euro del pastificio Rana e ai 13 mila euro della Federfarma. Matteo Renzi a differenza di Bersani non deve rendere conto sui suoi finanziatori del passato perché non è mai stato candidato al Parlamento. Quanto al presente la sua pagella resta senza voto solo perché Renzi continua a non pubblicare l’elenco integrale dei finanziatori della Fondazione Big Bang che lo sostiene. Diversa è la situazione dell’altro candidato delle primarie. Nichi Vendola non ha accettato come Bersani i soldi dei padroni dell’acciaio ma, a leggere le sue dichiarazioni del passato al Parlamento, con il senno di poi anche lui poteva dire almeno un no. Il leader di Sel ha accettato nel 2004 un contributo di 40mila euro dalla San Giorgio Spa, di Giuseppe Saggese, il concessionario dei tributi arrestato a ottobre 2012 perché faceva la cresta sulle tasse altrui. Altri 115mila euro arrivano a Vendola nel 2005 dalla Fimco, della famiglia Fusillo, già presente nella società editrice della Gazzetta del Mezzogiorno, impegnata nel settore delle grandi opere in Puglia. Tra i finanziatori del 2005 di Vendola troviamo anche un non meglio specificato “Degennaro” che dona 10mila euro. Chissà se si tratta di Gerardo, arrestato a marzo 2012 per corruzione. La Puglia è una terra difficile per chi voglia accettare serenamente un finanziamento lecito. Massimo D’Alema ha accettato nel 2008 il contributo di 12.500 euro della Uniland di Angelo Intini, del gruppo omonimo di NociinprovinciadiBari, diretto da Enrico Intini poi indagato nel 2009 per turbativa d’asta insieme a Gianpaolo Tarantini. Altri 50mila euro nell’ultima campagna elettorale sono arrivati a D’Alema da una società emiliana che organizza eventi, la Goodlink, mentre la Lo deserto Impianti di Taranto, una ditta di impiantistica che ha lavorato anche all’Ilva di Taranto, ha donato una piccola somma: 2.500 euro. L’ex ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni ha incassato per la campagna elettorale del 2008 un contributo di 10mila euro dalla I Borghi Srl nella quale c’erano un ex compagno della Margherita, come Francesco Carducci, ma anche il rivale Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc. Nicola Latorre invece ha avuto 100mila euro dalle Masserie Salentine del gruppo Zamparini, che poi nel 2010 si è lanciato nel settore dell’energia e solare e della distribuzione commerciale in Puglia. Sempre nella campagna del 2008, Latorre ha ricevuto altri50mila dalla società Cesd, la holding del gruppo Cepu. Poi c’è il capitolo del mattone rosso. Se si prende per esempio l’elenco dei contributi versati nel 2005 alla Federazione dei Ds di Roma si scopre la passione dei palazzinari per la sinistra. Nel 2005 arrivano ai Ds di Roma 30mila euro dalla Romeo Gestioni, di Alfredo Romeo, che gestiva ai tempi di Rutelli il patrimonio immobiliare del Comune e che nel 2010 sarà arrestato dai magistrati napoletani e poi condannato a due anni per corruzione nell’inchiesta Global service. Quello stesso anno arrivano 15mila euro anche dalla SAC di Claudio Cerasi, che poi sarà indagato nell’inchiesta sulla cosiddetta “cricca dei grandi eventi” nel 2010. Altri 10mila euro sono offerti ai Ds romani nel 2005 dall’impresa di Domenico Bonifaci, già noto per l’arresto e il patteggiamento a Perugia per la mazzetta Enimont. In quel magico 2005 le società di un altro costruttore che era uscito indenne dalla stessa inchiesta di Perugia, Pietro Mezzaroma, donano 38 mila euro ai Ds di Roma. Sempre nel 2005 i Ds di Roma incassano 10mila euro e l’anno prima ne avevano incassati altri 9mila dalla Cler Coop, società che è citata negli atti dell’inchiesta romana del 2010 su Vincenzo Morichini, l’imprenditore amico di Massimo D’Alema che ha patteggiato la pena di 18 mesi per corruzione. Dalle informative del 2011 della Guardia di Finanza si scopre che la Cler Coop, mai indagata, ha ottenuto appalti per milioni di euro dalla Provincia di Roma a guida Pd. Altri 30 mila euro nel 2005 arrivano ai Ds dalla Italiana costruzioni della famiglia Navarra, altro grande nome delle opere pubbliche a Roma. Sempre nel 2005 si fa vivo anche Sergio Scarpellini, l’immobiliarista famoso per avere affittato a partire alla Camera dei deputati per 25 milioni di euro all’anno i suoi palazzi nel centro di Roma e per essere il proprietario della sede attuale del Pd, in via Sant’Andrea delle Fratte, subaffittata al Pd dalla Margherita nell’epoca Lusi. Scarpellini e le sue società donano 20 milioni di vecchie lire a D’Alema nel 1997, altri 50 milioni ai Ds della Calabria nel 2000, nel 2003 arrivano 68mila euro ai Ds di Roma e 13mila euro nel 2005 quando altri 20mila euro vanno al senatore romano Michele Meta. Nel 2007 Scarpellini dona 100mila euro ai Ds di Roma e altri 100mila euro nel 2008 al Pd, senza dimenticare l’Udc del Lazio al quale vanno 100mila euro e il Pdl che si accontenta di 50mila euro. Impressionante anche l’elenco delle donazioni dei manager del Monte dei Paschi ai Ds di Siena. Ci sono molti nomi del presente e del passato del gruppo bancario nell’elenco degli ultimi dieci anni di contributi ai Ds locali: da Marco Spinelli a Moreno Periccioli dal compianto Stefano Bellaveglia ad Antonio Sclavi. In testa ai manager-finanziatori ovviamente c’è l’ex presidente Giuseppe Mussari. L’attuale presidente dell’Abi ha donato negli ultimi dieci anni 673mila euro ai Ds senesi. Dei quali 100mila nel 2010 e 99mila euro nel 2011. Mentre il vicepresidente della banca, Ernesto Rabizzi ha donato 125mila euro nell’ultimo biennio. Nonostante i conti disastrosi della banca abbiano imposto al governo Monti di iniettare 4 miliardi di euro pubblici nell’istituto, i due manager e il loro partito non ne hanno risentito. Mussari è tuttora presidente dell’Abi e nel 2011 ha guadagnato ben 712mila euro mentre Rabizzi si è accontentato di 412mila euro. Di Marco Lillo e Valeria Pacelli da Il Fatto Quotidiano dell’1 dicembre 2012.
Da dove prende i soldi per fare politica il M5S. Formalmente il Movimento 5 Stelle rinuncia ai contributi di Stato, come nel caso dei 42 milioni dei rimborsi pubblici. Ma ha creato un sistema di introiti pulviscolari pieni di anonimi, sigle, voci opache e fittizie spesso difficili da ricostruire, scrive Susanna Turco il 27 novembre 2017 su "L'Espresso". L’altra volta, aprile 2013, Beppe Grillo se la cavò con un post: abbiamo raccolto 774 mila euro, ne abbiamo spesi 348 mila, il restante andrà ai terremotati dell’Emilia, saluti e ringraziamenti. A occhio, nella prossima campagna elettorale, sventolare il vessillo della casa di vetro non sarà altrettanto semplice. Troppe cose sono cambiate: l’M5S non è più un movimento di sconosciuti, ciascun ex pulcino vorrà coltivare il proprio orto per essere rieletto. Serviranno più soldi, ci saranno più rivoli, e il meccanismo di auto-finanziamento che nel frattempo è stato costruito si rivelerà per quel che è: un impasto colloso. Trasparente nei dettagli, opaco nel suo complesso. Tutto sommato e per paradosso, M5S è all’avanguardia su questo: gestione dei soldi e manipolazione del consenso sui social. Due fronti che i Cinque stelle sono arrivati a maneggiare prima e meglio di altri, dando ad entrambi lo stesso indecifrabile marchio di vischiosa sineddoche: te ne mostro una parte, e la spaccio per il tutto. Onestà! Per quel che riguarda il denaro, in effetti, i Cinque stelle hanno anticipato i tempi, rinunciando al finanziamento pubblico prima che venisse abolito, cioè a “42 milioni di euro” come amano ripetere ovunque. Non accedono al meccanismo che l’ha sostituito, il due per mille. Ufficialmente, tutt’oggi dicono di non volere soldi pubblici. Eppure ormai non è più così. Rinunciare a quegli introiti ha portato ad attivare altri meccanismi. Non è politica a costo zero. I soldi servono, anche al M5S. Ma da dove vengono, dove vanno, come sono conteggiati? Si può rispondere solo a una parte di queste domande. Le entrate sono svariate, a partire dalle sottoscrizioni per singoli eventi, ma per grandi linee: ci sono quelli raccolti dall’Associazione Rousseau; i contributi ai gruppi di Camera e Senato; gli stipendi dei parlamentari; le sottoscrizioni per singoli eventi, come la kermesse annuale; e quelli - ma quest’ultimo è più un postulato che un numero - che provengono dall’intreccio blog-rete-Casaleggio Associati, e che danno luogo a una domanda tanto frequente quanto inevasa: gli introiti per la pubblicità per i link che rimandano al sito beppegrillo.it che fine fanno? Lo chiese pure l’amata Milena Gabanelli, nel lontano 2013, ottenendo come risposta un laconico e offeso “non vanno a finanziare M5S”. Nel complesso, chi se ne intende per aver frequentato a lungo il Movimento, parla di “polverizzazione” delle entrate. Come a dire che i soldi sono diventati una polvere di stelle, frazionata, inintercettabile. Un esempio, locale ma emblematico. Per la corsa al Campidoglio, Virginia Raggi nel 2016 ha raccolto circa 225 mila euro. Ma ne ha dichiarato la provenienza solo per un terzo, 70 mila euro, trincerandosi per il resto dietro la privacy che copre i contributi di privati sotto i 5 mila euro. Cioè non si potrà mai dire chi l’ha finanziata. La tendenza Raggi fa scuola. L’Associazione Rousseau, il sistema di interfaccia tra eletti e militanti di cui Davide Casaleggio è presidente e amministratore unico dichiara circa 485 mila euro di fund raising, e pubblica anche la lista dei circa 16 mila donatori. Ma sono anonimi: a sfogliarla, ci si trova davanti a ben 373 surreali pagine di iniziali. Si parte da “A. A.” e si arriva a “Z.W.”. Non propriamente un inno alla trasparenza. Dal rendiconto 2016 sempre Rousseau (+ 76 mila euro) vien fuori che 30 mila euro provengono da “soggetti esteri”: 8.500 li ha messi Filippo Pittarello, responsabile comunicazione M5S al Parlamento europeo ed ex dipendente della Casaleggio Associati; gli altri 22 mila risultano come “contributi ricevuti dall’estero da altre persone fisiche”, senza ulteriori precisazioni. Si obietterà che sono 22 mila euro, mica miliardi: ecco, proprio in casi come questi, che sono svariati, sta la “polverizzazione” opaca. Anche nella campagna 2013, del resto, Grillo finì per dichiarare soltanto alcune spese, e per di più in modo generico (esempio: 140 mila euro per consulenze legale/tributaria, senza chiarire a chi erano andati i soldi). Fornì, soprattutto, un rendiconto parziale che, come ha sottolineato all’epoca l’associazione Casa della Legalità di Genova, non tenendo conto di entrate e uscite al livello locale per sostenere le 87 tappe dello Tsunami Tour: l’affitto e il montaggio dei palchi, l’elettricità, la Siae eccetera. Il tutto moltiplicato per quasi cento incontri. Non pochi soldi. Nel resoconto sul blog, fu specificato solo il costo del palco montato a Piazza San Giovanni a Roma: 50 mila euro. Per il resto, Grillo ringraziò chi aveva fornito gratis l’attrezzatura: ma non sempre era stata gratis. E anzi più di un neo-eletto rimase sbigottito nello scoprire - solo allora - che non avrebbe riavuto indietro i soldi prestati per mettere in piedi questa o quella serata. Del resto, neanche le attrezzature acquistate per gli streaming sono entrate poi a disposizione degli eletti per svolgere la comunicazione a Palazzo. Agli atti rimase invece quella cifra, 348 mila euro dei quali anche Gianroberto Casaleggio poté vantarsi nel suo intervento a Cernobbio nel 2013. Quando portò M5S ad esempio dimostrando che nel rapporto tra soldi raccolti e voti presi era stato virtuosissimo: “4 centesimi a voto” contro i “4,87 euro” di un partito tradizionale. Per concludere: «I partiti hanno ricevuto più di 100 volte la spesa sostenuta dal M5S Stelle per partecipare alle elezioni». La cifra di riferimento era però quella dimagrita, non quella totale. La versione ufficiale non arrivava a misurare la realtà che ne è rimasta fuori. Nello stesso modo, sul sito tirendiconto.it campeggia il counter con i versamenti fatti dai 123 parlamentari M5S in favore dei fondi per il microcredito: «Ad oggi abbiamo restituito 24.014.613,22 euro». Quel che non c’è scritto è però che vengono ormai disattese almeno due regole volute da Grillo e Casaleggio: il tetto di tremila euro che ciascun parlamentare poteva tenere per sé; il divieto a finanziare attività politica nei territori. Di fatto, spendendo gli 8-10 mila euro di rimborsi cui ogni parlamentare ha diritto, c’è chi paga i propri collaboratori come Roberta Lombardi, e chi «eventi legati al territorio come Luigi Di Maio. Anzi, il candidato premier del M5S in tre anni ha totalizzato 108 mila euro di spese “territoriali”, per poi specificare trattarsi di “una dicitura fittizia”. Ed ecco il sistema colloso. Non è difficile ipotizzare che a breve tutte queste “diciture fittizie” potrebbero sostenere la campagna elettorale. Si pensa male? Il fatto è che la consuetudine col Palazzo ha portato ad aggirare i proclami sulla politica a zero euro. Caso lampante: si è rinunciato a 42 milioni di euro, ma via gruppi parlamentari in una legislatura i Cinque stelle ne hanno incassati comunque 31 (3,8 alla Camera, 2,5 al Senato, media annua). Al gruppo M5S di Montecitorio si è registrata nel 2016 una impennata di spese per la comunicazione: + 375 per cento, per un totale di 522 mila euro (più della campagna elettorale 2013). È invece diminuita la quota dedicata alle consulenze per l’ufficio legislativo. Meno leggi, più video. Sempre a Montecitorio, vi sono fatture mensili dal totale fisso di quasi 15 mila euro, indirizzate alla comunicazione/web, ma senza che vi sia modo di sapere a chi sono destinate (per legge si può omettere). E, dei 3,8 milioni di trasferimenti del 2016, ben 354 mila sono andati a finanziare la causa del no al referendum costituzionale, mentre 35 mila circa sono finiti come contributo alla festa annuale del Movimento. D’altronde, da dove dovrebbe prendere i soldi il Movimento? Anche la Casaleggio Associati ha problemi economici. Il che rende ancor più fitto il mistero. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la società fondata dal guru ha chiuso i conti in rosso (-48 mila), con un bilancio che nemmeno questa volta chiarisce snodi essenziali: quanto rendano gli intrecci politico-finanziari con il partito, se tra i ricavi ci sia anche la pubblicità, e se il Movimento paghi per il supporto che riceve. Buio fitto. Come del resto nel complesso sistema di siti, banner e scatole cinesi che fa del sistema M5S-Casaleggio una cyber costellazione dagli intrecci davvero sfuggenti. Ma questa è un’altra storia.
Esclusivo: i nomi segreti dei finanziatori di Giovanni Toti. La fondazione del governatore ha ricevuto quasi un milione in due anni. Chi sono i donatori. E quali i loro affari in Liguria, scrivono Giovanni Tizian e Stefano Vergine il 2 ottobre 2018 su "L'Espresso". Il vento è cambiato», recita lo slogan coniato da Giovanni Toti per il comitato Change, nato due anni fa da un’idea del governatore ligure poco dopo le elezioni regionali che hanno portato il centrodestra al governo della roccaforte rossa. Change, una fondazione con «finalità divulgative», ente no profit dedicato a «cultura, ambiente, politiche sociali, salute e sicurezza». Questo si legge sul suo sito internet. Alcuni documenti finanziari inediti permettono di capire meglio le funzioni dell’entità creata dal berlusconiano più vicino a Matteo Salvini. Change si occupa soprattutto di incassare donazioni da privati: 792 mila euro in due anni. Finanziamenti rimasti top secret, che ora L’Espresso è in grado di rivelare nome per nome. Si scoprono così signori dell’industria e ras delle concessioni portuali, costruttori e petrolieri. Quasi tutti legati da un unico denominatore: interessi a sei zeri su Genova e la Liguria. Conflitti d’interessi? Macché. La legge italiana consente di creare fondazioni, comitati o associazioni del genere per finanziare segretamente la politica. Tutto regolare, anche se per nulla trasparente. I documenti inediti mostrano anche come sono state usate le donazioni. Una parte è servita per foraggiare altri esponenti politici: sindaci liguri come quello di Genova, Marco Bucci, ma anche primi cittadini di sponda leghista, a testimoniare il ruolo di cerniera del centrodestra ricoperto da Toti. Gli altri denari sono stati spesi personalmente dal governatore. Che non ha fatto certo il “genovese”.
Il costruttore e l’ospedale. Il primo bonifico è del 17 marzo 2016: 10 mila euro versati dalla Pessina costruzioni Spa, storica azienda sostenitrice della politica, dal centrodestra al centrosinistra, ultima azionista di maggioranza dell’Unità prima della chiusura definitiva dello storico giornale fondato da Antonio Gramsci. Pessina in Liguria ha in ballo la realizzazione del nuovo ospedale di La Spezia, appalto aggiudicato nel 2015 con la precedente giunta guidata dal Pd. All’epoca il centrodestra sollevò un vespaio di polemiche e i giornali berlusconiani si occuparono della vicenda lanciando il sospetto che Pessina avesse ottenuto la gara milionaria grazie all’amicizia con Matteo Renzi, con l’ex governatore Claudio Burlando e l’allora assessore Raffaella Paita. La posa della prima pietra avverrà la prima settimana di ottobre 2016 con Toti già a capo della Regione, l’ente cioè che aveva appaltato il lavoro. Nel frattempo i nemici di Renzi cambiano registro. Il nuovo governatore presente alla cerimonia di apertura del cantiere mostra una certa soddisfazione: «Oggi è una giornata di svolta. Questo grande investimento sulla sanità deve essere valorizzato al massimo per aumentare quantità dei pazienti, che oggi fuggono, e la qualità che il pubblico deve sapere offrire». Pace fatta, quindi, con i costruttori amici dei nemici. Che - si scopre adesso - solo pochi mesi prima avevano fatto un regalino alla fondazione di Toti: 10 mila euro, appunto. L’Ospedale? Il cantiere va a rilento, procede a singhiozzo. La società l’anno scorso ha presentato una variante al progetto originario, una modifica che potrebbe far aumentare i costi. E il cui futuro dipende anche dalla stazione appaltante della Regione.
I re delle concessioni portuali. Quattro giorni più tardi il versamento di Pessina, sul conto del comitato Change vengono accreditati altri 10 mila euro. Portano la firma della Gip Spa, il Gruppo investimento portuali. La proprietà al 95 per cento è di due fondi di investimento stranieri (Infravia e Infracapital) e per il 5 per cento di Giulio Schenone, esponente della storica famiglia di imprenditori marittimi della Lanterna. Da anni la Gip gestisce il terminal Sech, nel porto di Genova. I 10 mila euro a Toti sono stati versati due anni fa, quando il governatore era da poco stato eletto e il suo fedelissimo Paolo Emilio Signorini da lì a qualche mese sarebbe diventato capo dell’autorità portuale, la struttura che rilascia il rinnovo delle concessioni. Concessione che arriva proprio con Signorini in carica, e nonostante i revisori dell’Autorità avessero sollevato perplessità sulla mancata messa a bando della gara: una pratica non in regola con le prescrizioni dell’Unione europea e del codice degli appalti. Un anno dopo è il gruppo della famiglia Schenone a far gioire Toti: viene ufficializzata la firma tra Gip e Mcs per la realizzazione del terminal di calata Bettolo, un investimento da 150 milioni per una durata della concessione di 30 anni, attrezzato per l’attracco di enormi porta container. «È una giornata storica», ha esultato Giovanni Toti, presente il giorno della firma al fianco di Signorini, Aponte (patron di Msc) e Schenone. Nella lista dei finanziatori di Change c’è anche la famiglia Gavio, protagonista del ricco settore di concessioni autostradali e portuali, che evidentemente ha preferito tenere riservata la sua donazione a Toti. Il 28 ottobre 2016 sul conto a disposizione del governatore sono piovuti 15 mila euro firmati Terminal San Giorgio Srl, braccio operativo dei Gavio nell’hub genovese. Coincidenza: lo stesso giorno della donazione i giornali pubblicano la notizia della nomina di Signorini a capo dell’autorità portuale. Quasi un anno dopo il contributo, la società San Giorgio è tra le fortunate a ottenere il rinnovo della concessione, sempre senza gara pubblica, fino al 2030. Il mese successivo, giugno 2017, un’altra società del gruppo Gavio (Autoservice 24) dispone un bonifico di 20 mila euro. Se si guardano gli affari andati a buon fine, però, il più fortunato è sicuramente Aldo Spinelli. Presidente del Genoa calcio e poi del Livorno, l’imprenditore genovese ha costruito la sua fortuna nello scalo cittadino. Amico del centrosinistra, certo. Legato all’ex governatore Claudio Burlando, vero. Ma anche sostenitore di Toti, almeno da quando l’ex giornalista si è preso la scena in regione. Tra il 2017 e il 2018 la Spinelli Srl ha foraggiato il comitato Change con 25 mila euro, che diventano 40 mila se si aggiungono i bonifici del 2015 al Comitato Giovanni Toti Liguria, creato durante la campagna elettorale per le Regionali. Il primo dei bonifici a Change viene accreditato sul conto corrente una settimana prima dell’ufficialità dei rinnovi delle concessioni per l’uso delle banchine. Il secondo, datato febbraio 2018, arriva due mesi dopo aver ottenuto una nuova vittoria: l’ok dell’autorità portuale guidata da Signorini a utilizzare 14 mila metri quadri di banchina presso il “ponte ex idroscalo”. Un bel colpo per l’industriale marittimo appassionato di calcio.
Donatore e bancarottiere. Difficile invece capire quali siano gli interessi economici in Liguria di Giovanni Calabrò, donatore assai generoso ma impossibile da inquadrare in una semplice categoria. Nato in Calabria ma residente nel Principato di Monaco, interessi d’affari in Lussemburgo e Panama, una condanna a sei anni in via definitiva per bancarotta in Italia, l’eclettico imprenditore ha regalato al governatore di Forza Italia quasi 50 mila euro in due tranche. La prima, da 27 mila euro, è stata bonificata nel 2015, durante la campagna elettorale per le regionali: una donazione regolarmente dichiarata al Parlamento. Due anni dopo il businessman con residenza a Montecarlo sceglie una strada più riservata. Trasferisce 19 mila euro sul conto di Change. Perché nascondersi dietro alla fondazione? Di certo nel frattempo l’immagine pubblica dell’imprenditore calabrese è cambiata. Il suo nome è finito sulle pagine della cronaca giudiziaria per sospetta bancarotta, quella che sette mesi dopo il bonifico verrà confermata dalla Cassazione. Ma a imbarazzare Toti ci potrebbe essere altro: le amicizie del suo finanziatore con personaggi contigui alla ’ndrangheta. La notizia emerge dagli atti dell’indagine Breakfast, condotta dalla procura antimafia di Reggio Calabria. Intercettando la commercialista di fiducia di Amedeo Matacena, l’ex parlamentare di Forza Italia finito sotto inchiesta insieme all’ex ministro Claudio Scajola, gli investigatori arrivano a un facoltoso imprenditore reggino. Si chiama Bruno Minghetti, è un mago delle operazioni immobiliari. Minghetti ha goduto di «rapporti privilegiati con i fratelli Lampada», potente clan della ’ndrangheta a Milano. È stato socio di uno degli indagati nell’operazione che ha svelato il radicamento della cosca all’ombra della Madonnina. E, sottolineano gli investigatori, è intimo di Calabrò. Amici di infanzia, ma anche partner d’affari da adulti. Connessioni che non hanno trovato sbocchi processuali, tant’è che Calabrò per vicende di mafia non è mai stato indagato e Toti ha deciso di accettare i suoi regali, seppur in parte segretamente.
Aiuti agli amici e spese di lusso. A questo punto vale la pena di capire che fine hanno fatto tutti questi soldi finiti sul conto di Change. Anche perché la lista dei riceventi rivela qualche sorpresa. La lista della spesa non comprende infatti solo spese politiche del governatore. A beneficiare delle donazioni riservate sono stati diversi altri politici, tra cui anche leghisti come Giacomo Chiappori, storico esponente del Carroccio in Liguria, prima bossiano e oggi salviniano di ferro, sindaco di Diano Marina uscito indenne dall’indagine prefettizia sulle infiltrazioni della ’ndrangheta nel suo Comune. Il 24 maggio 2016, a dieci giorni dalla tornata elettorale che lo ha riconfermato a capo della giunta cittadina, Chiappori ha ricevuto mille euro dal comitato di Toti. Contributo minimo, ma sufficiente a provare il legame anche finanziario tra la Lega e il consigliere di Berlusconi. Non è il solo amministratore pubblico ad aver incassato da Change. Nell’elenco c’è anche la ex fotomodella, scrittrice e oggi sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio (5 mila euro a ridosso delle Comunali), ma soprattutto Pierluigi Peracchini e Marco Bucci. Entrambi eletti primi cittadini il 26 giugno 2017, il primo a La Spezia e il secondo a Genova. Peracchini ha ricevuto dalla fondazione di Toti 67.500 euro, Bucci ha incassato 102 mila euro. Ed è proprio nel capoluogo ligure amministrato da Bucci che ci riporta una delle donazioni più generose ricevute da Change: quella della Europam. Azienda di petrolieri, marchio storico della famiglia Costantino, ha regalato 80 mila euro al comitato elettorale di Toti quando Bucci era già candidato sindaco. I primi 50 mila vengono accreditati un mese prima delle elezioni, gli altri 30 mila due giorni dopo la vittoria. Risultato? Sarà merito o no di questi regali, ma una delle ultime commesse pubbliche aggiudicate dall’Europam è arrivata proprio con Bucci primo cittadino. L’Amt, la società del Comune e della città metropolitana che gestisce il trasporto pubblico, l’ha infatti preferita a Eni, Q8 e Erg affidandole per sei mesi una fornitura di gasolio da autotrazione. Valore dell’affare: 8 milioni e 355 mila euro. Nulla di illecito, sia chiaro. L’azienda fa il suo mestiere di lobbying, e sicuramente l’offerta di Europam era più vantaggiosa per il Comune rispetto a quelle avanzate dalle imprese concorrenti. Starebbe però al politico di turno evitare di ricevere donazioni da imprenditori che poi concorrono per gare pubbliche. Discorso che vale per moltissimi altri sostenitori della fondazione Change, diventato il crocevia del flusso di denaro che dal potere economico locale e nazionale scorre verso le casse di chi governa la Regione e i suoi comuni più importanti. Le dichiarate “finalità divulgative” della fondazione? Stando ai resoconti finanziari interni, sembrano essere rimaste sulla carta: più che finanziare attività culturali, i soldi ricevuti dai benefattori sono serviti per pagare le spese personali del governatore. Almeno 173 mila euro incassati da Change sono infatti approdati sui conti correnti personali di Toti. Anche in questo caso non c’è alcun rilievo penale. Si tratta di finanziamenti privati che giungono a un comitato fatto da privati, i quali possono dunque usare le risorse a proprio piacimento. Certo colpisce notare come il governatore non abbia badato a spese, per di più con le risorse di una fondazione che in teoria dovrebbe usarli per fare attività culturale. Nei documenti letti da L’Espresso ci sono poco meno di 30 mila euro usati in un anno e due mesi per dormire nel lussuoso hotel Valadier, un quattro stelle nel centro di Roma. E poi ristoranti tra Forte dei Marmi e Saint Tropez, ancora alberghi, spese da Prada, l’affitto di una casa a Genova, la rata del mutuo. “Il vento è cambiato”, insomma. I conti di Change dimostrano che ai politici non conviene più farsi donare denaro in modo trasparente. Molto meglio usare una fondazione come quella di Toti, dove tutto resta sempre riservato, segreto. Quasi sempre.
Esclusivo: ecco chi ha finanziato Giorgia Meloni. Tra le donazioni più generose ricevute dalla leader di Fratelli d'Italia c'è quella di Ylenia Lucaselli. Che così è stata accolta a braccia aperte nel partito. E ora è neoparlamentare con un ruolo in una multinazionale americana, scrivono Giovanni Tizian e Stefano Vergine il 4 ottobre 2018 su "L'Espresso". Fratelli d’Italia, ma anche degli Stati Uniti. Non solo perché Giorgia Meloni ha abbracciato con entusiasmo il movimento lanciato dall’americano Steve Bannon, quello che mira a creare la rete internazionale dei populisti-sovranisti contro l’Europa dei “poteri forti, delle multinazionali e dei burocrati”. Fratelli d’Italia strizza l’occhio all’America trumpiana anche perché il contributo di gran lunga più generoso al partito è arrivato da nomi che riconducono a una multinazionale made in Usa: messi insieme Ylenjia Lucaselli, Daniel Hager e la Hc Consulting Srl hanno infatti regalato al piccolo partito nazionalista 200 mila euro. Hager e Lucaselli sono marito e moglie. La famiglia di Hager è azionista della Southern Glazer’s Wine and Spirits, la più grande azienda statunitense della distribuzione di vini e alcolici (secondo stime di Forbes nel 2016 ha fatturato 16,5 miliardi di dollari e distribuito 60 milioni di bottiglie di vino italiane negli States). Una multinazionale americana che finanzia un partito sovranista italiano? Succede anche questo nel tortuoso mondo del neonazionalismo. E non è l’unica contraddizione, perché la Southern Glazer’s è da poco entrata anche nel business della cannabis legale in Canada, settore che in teoria Meloni e i suoi vedono come fumo negli occhi. Ma d’altra parte come dire di no a 200 mila euro. La stessa Lucaselli lavora per il gruppo americano: avvocato, appassionata di vino biologico e made in Italy, lo scorso 4 marzo è stata eletta alla Camera proprio con Fratelli d’Italia. Una new entry la cui unica esperienza in politica risale alle Regionali di Puglia nel 2010: candidata con il Pd a sostegno della sinistra con Nichi Vendola. All’epoca l’avvocato non ebbe grande successo. Oggi invece siede in Parlamento con i sovranisti che guardano ai dazi di Trump con ammirazione. Certo, c’è da dire che Lucaselli ha avuto il notevole vantaggio di correre da numero uno nei listini proporzionali in Emilia Romagna. Del resto è stata molto generosa con i suoi nuovi compagni di avventura politica: a suo nome ha versato 90 mila prima delle elezioni. Una cifra che fa impallidire un pezzo da novanta del partito qual è Ignazio La Russa, che ne ha versati molti meno nello stesso periodo. Ai denari firmati Lucaselli vanno poi aggiunti i restanti 110 mila euro: 95 mila euro donati a nome del marito e 15 mila arrivati dalla loro società italiana di logistica, la H.c. Consulting di Livorno. L’intento politico di Lucaselli e del suo partito è di difendere i prodotti dell’agroindustria nostrana. C’è però da capire, vista la sua vicinanza alla multinazionale, nell’interesse di chi lo faccia. Dei produttori di vino italiani o della società statunitense che li distribuisce oltreoceano? Un mix di interessi che, comunque la si guardi, resterebbero delusi dall’eventuale imposizione di dazi sulle importazioni minacciato dall’amato Trump. Scorrendo l’elenco dei finanziatori ufficiali di Meloni troviamo poi un’altra sorpresa, questa più coerente con gli ideali del suo partito. Fratelli d’Italia ha infatti ricevuto un bonifico da 20 mila euro, poco prima delle elezioni del 4 marzo, da Vincenzo Onorato. È l’armatore napoletano che controlla le compagnie Moby, Tirrenia e Toremar, punite dall’Antitrust con una multa da 29 milioni per abuso di posizione dominante sulle rotte verso la Sardegna. Due settimane dopo il voto, sul profilo Facebook di Meloni è apparso un post a proposito dell’armatore: non per ringraziare della donazione, ma per schierare il partito a favore della controversa pubblicità delle compagnie di Onorato. Quella che invitava i passeggeri a scegliere solo le società che impiegano personale italiano.
Giorgia Meloni fa la sovranista in Belgio: una nuova associazione per ricevere fondi Ue. La leader di Fratelli d’Italia, da sempre in prima linea contro la burocrazia europea, ha fondato vicino a Bruxelles un movimento politico che potrà essere finanziato dall'Unione. Allo stesso indirizzo è stata registrata anche una fondazione amministrata da estremisti di destra indagati per spionaggio a favore della Russia, scrivono Vittorio Malagutti ed Andrea Palladino l'1 ottobre 2018 su "L'Espresso". La piccola Rue des Allies, a Charleroi, in Belgio, dista poche decine di chilometri dal cuore dell’Unione europea. Le casette primi ’900, coi mattoncini rossi, ricordano la storia industriale di questa cittadina della Vallonia, una storia di lotte operaie. Da qualche tempo però il civico 15 di Rue des Allies si è trasformato in una enclave nera. Anzi, nerissima. Con fili che portano a Mosca e a politici accusati di spionaggio a favore della Russia di Putin. Dallo scorso aprile Luca Romagnoli ha trasferito a questo indirizzo di Charleroi la sede della sua creatura politica. Romagnoli, ex Fiamma tricolore, poi Destra sociale, oggi è vicino a Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. La fondazione di cui è presidente si chiama Identités & Traditions Européennes, in sigla Ite, ed è amministrata da un board di cui fa parte anche Bela Kovacs, eurodeputato ungherese meglio conosciuto in patria come KGBela. Per i magistrati di Budapest, infatti, Kovacs è un agente sotto copertura del Gru, il servizio segreto militare di Putin. Nella Ite di Romagnoli militava, fino al suo arresto, anche il polacco Matheusz Piskorski, finito in carcere con l’accusa di essere una spia, pure lui, al servizio dell’intelligence russa. A ben guardare, comunque, Romagnoli non è l’unico italiano con un domicilio politico a Charleroi. Allo stesso indirizzo troviamo anche il partito politico europeo - con annessa fondazione - appena creato da Fratelli d’Italia. L’Alliance pour l’Europe des Nations (Aen) presieduta da Giorgia Meloni, così come la collegata Fondation pour l’Europe des Nations, sono state iscritte alla camera di commercio belga a fine agosto, pochi giorni prima dell’arrivo di Steve Bannon ad Atreju, alla festa di Fratelli d’Italia. Nella casa di Rue des Allies 15 sono registrate in tutto 12 società. Niente altro, però, che possa in qualche modo ricondurre al mondo della politica. C’è l’ufficio di un contabile, Patrick Gorloo, una ditta di commercio al dettaglio, una piccola agenzia di comunicazione, un elettrotecnico e una profumeria. La fondazione presieduta da Romagnoli è a sua volta l’emanazione dell’Alleanza europea dei movimenti nazionalisti, Aemn, fondata nel 2009 a Budapest da partiti di estrema destra ungheresi, belgi, italiani e svedesi. Un gruppo eterogeneo, in cui Bela Kovacs è senza dubbio la figura di maggior peso politico. Esperto di relazioni internazionali, poliglotta, fino all’avvio delle indagini era un esponente di spicco dello Jobbik, partito magiaro forte di un 20 per cento alle ultime elezioni, che fa opposizione, da destra, a Viktor Orbán. Per due volte il Parlamento europeo ha votato - nel 2015 e nel 2017 - la decadenza dell’immunità parlamentare per Kovacs. Un anno fa a Bruxelles è arrivato un dossier che lo vede accusato di frode in bilancio e utilizzo di documenti contraffatti. Ma la prima inchiesta, avviata subito dopo le elezioni del 2014, parla di «spionaggio ai danni delle istituzioni dell’Unione europea». Secondo quanto ricostruito dalla stampa ungherese, Kovacs avrebbe agito per conto dei servizi militari russi, il Gru, con «l’obiettivo finale di creare un fronte anti Ue nel Parlamento europeo», riporta il sito di news Magyar Idok. Questo sarebbe stato il vero obiettivo politico della sua frenetica attività a Bruxelles, secondo l’accusa, tra le sedute del Parlamento e l’attività dell’Aemn e della fondazione di Rue des Allies. KGBela non è l’unico del gruppo di Charleroi sospettato di legami con Putin. Il polacco Matheusz Piskorski, noto in patria per le sue posizioni di estrema destra, risulta tra i membri dell’associazione Identités & Traditions Européennes di Romagnoli almeno fino al 2014. Due anni dopo, le autorità di Varsavia hanno arrestato Piskorski con l’accusa di spionaggio a favore della Russia. Quando lo ammanettano i suoi colleghi di partito gridano al complotto, lanciando appelli di solidarietà. Appelli raccolti non solo dall’estrema destra: oltre ad Antonio Razzi, anche l’europarlamentare di Forza Italia Alberto Cirio si è attivato inviando lettere alle autorità polacche, parlando di arresto politico. Al pari di Cirio ci sono altri berlusconiani in qualche modo legati al crocevia nero di Charleroi. Dai documenti depositati a Bruxelles si scopre infatti che nel novembre 2017 Francesco Graglia, consigliere regionale forzista in Piemonte si è registrato come membro sostenitore dell’Aen di Giorgia Meloni. Tra gli amministratori della collegata Fondation pour l’Europe des Nations, troviamo invece, insieme a due esponenti di Fratelli d’Italia - Marco Scurria e il senatore Stefano Bertacco, veronese - anche il forzista torinese Fabrizio Bertot, deputato a Bruxelles fino al 2014. «Movimenti interessanti quelli che qui da Roma e da Atreju possono prendere corpo verso l’Europa delle Nazioni e delle Identità!», ha commentato entusiasta Bertot su Facebook dopo il discorso di Bannon alla festa di Fratelli d’Italia. Lo stesso Bertot che nel recente passato si era più volte pubblicamente schierato contro le sanzioni a Mosca.
L’universo delle fondazioni politiche. Ecco le 20 dell’area di centrodestra, scrive Flaminia Camilletti il 14 Ottobre 2016 su Nazione Futura. Il panorama politico italiano sta vivendo un forte cambiamento, i soggetti stanno cambiando insieme al modo di fare politica. I partiti così come erano stati concepiti non funzionano più e stanno mano mano diventando delle vetrine dietro le quali operano i veri centri di potere politico: le fondazioni. Da interessanti pensatoi, le fondazioni rischiano di diventare le casseforti segrete dei partiti, questo perché le prime non sono soggette agli stessi stretti controlli cui sono soggetti i partiti. Secondo i dati di Openpolis le fondazioni oggi attive in Italia sono 65 di cui il 30,77% è riconducibile al centro sinistra, un 10% alla sinistra, mentre il 24,62% appartiene al centro destra e un 6% alla destra. Interessante il fatto che il 27% (sommato tra centro e bipartisan con un 13% ciascuno) di essi sia difficilmente collocabile politicamente. La maggior parte di queste fondazioni sono nate dopo il 2000 il che combacia con l’aumento della crisi dei partiti post millennio.
Le fondazioni legate alla destra e al centro destra. Un tempo si chiamavano correnti, oggi le fondazioni riconducibili al centro destra e alla destra insieme formano il circa 30% del panorama politico italiano, in seconda posizione dopo il centro sinistra e seguite subito dal gruppo centro-bipartisan che insieme tocca il 28%. Bisogna considerare che molti di questi attori politici si collocano idealmente a destra pur avendo appoggiato in grande parte governi di centro sinistra e centro, da Monti a Renzi. Dalla ricerca di Openpolis risulta che di queste fondazioni 5 siano riconducibili a NCD, 2 ex Futuro e Libertà, 1 ex Lega, 1 ex Scelta Civica, 1 ex FDI e infine 6 a FORZA ITALIA e 4 di ex PDL. In questa prima parte dell’inchiesta ci occuperemo delle 5 fondazioni legate a NCD, delle due legate all’ex Futuro e Libertà, 1 ex Lega, 1 ex Fratelli d’Italia e 1 ex scelta civica. Le cinque fondazioni legate a NCD sono legate ai nomi di punta dello stesso partito: Gli obiettivi di Costruiamo il futuro, di Maurizio Lupi sono “lo studio e lo sviluppo di una cultura politica che si fondi sul principio di sussidiarietà”, si occupa inoltre di cultura e ricerca. Non esiste né un bilancio consultabile, né un elenco dei sostenitori, tuttavia nell’ultima di copertina del magazine legato alla fondazione sono stampati i loghi dei sostenitori fra cui Bcc, Enel, Lottomatica, Credito Valtellinese e una società di costruzioni edili. Magna carta, è stata fondata il 28 gennaio 2004 dal suo presidente, Gaetano Quagliariello, insieme ad un politico Giuseppe Calderisi e ad un banchiere di Arezzo, Giuseppe Morbidelli, divenuto nel frattempo numero uno della Cassa di risparmio di Firenze. Tra gli altri il gruppo di assicurazioni Sai-Fondiaria, Erg Petroli e Nuova Editoriale. A differenza della Fondazione di Lupi, Magna Carta pubblica i bilanci, ma non i sostenitori. La Fondazione De Gasperi, di Angelino Alfano viene creata nel 1982. In principio l’intero capitale fu versato dal partito da cui era appoggiato, la DC. La cifra ammontava a circa 400 milioni di lire dell’epoca. Ad oggi questa rappresenta l’unica informazione che si ha sulle entrate di questa fondazione. Nel direttivo, fra gli altri, Fouad Makhzoumi, presidente del colosso del gas Future Pipes Industries. Su Europa e Civiltà di Roberto Formigoni si riescono ad ottenere poche informazioni, complice un sito internet poco funzionante e soprattutto il fatto di dichiararsi attiva solo sul suolo lombardo e quindi per lungo tempo vigilata dallo stesso Formigoni. Stesso discorso vale per Riformismo e libertà, di Fabrizio Cicchitto che non ha neanche un sito web, ma solo una pagina facebook nella quale non esistono informazioni sui componenti o sui bilanci della fondazione. Fare Futuro di Adolfo Urso è riconducibile a Futuro e Libertà e quindi a Gianfranco Fini, ha un’attività praticamente nulla negli ultimi tre anni il che combacia con la morte politica di Fini stesso. Costituita nel 2007 con l’obiettivo di sviluppare una destra laica, liberale, aperta sul versante dei diritti civili e di quelli di nuova cittadinanza, dal 2013 il nome di Fini scompare dall’organigramma della fondazione. Anche qui non si hanno informazioni sui bilanci e i sostenitori. Economia Reale è un centro studi indipendente fondato nel 2005 da Mario Baldassarri ex parlamentare di Futuro e Libertà. Il Centro realizza ricerche e pubblica rapporti, con l’obiettivo di valutare gli interventi concreti di politica economica. Anche qui non si hanno informazioni sul bilancio e i donatori. Ricostruiamo il Paese, è la fondazione di Flavio Tosi governatore del Veneto ed ex LEGA, costituita il 18 febbraio 2014 su iniziativa del suo unico Fondatore, con lo scopo di elaborare una nuova cultura politica. I finanziatori sono top secret. Si parla di imprenditori, artigiani, singoli cittadini: «Non ho contato quanti sono i soci», ammette Venturi, vicepresidente della Provincia di Verona «per riservatezza non possiamo dire chi sono». La tessera per iscriversi costa 10 euro, e finora Ricostruiamo il Paese ha raccolto 70-80 mila euro: la donazione più alta è stata di 10 mila euro, sborsata da un imprenditore, la più bassa di 5 euro. Report si è occupato della Fondazione il cui obiettivo sembra essere portare Tosi a vincere le primarie del centrodestra. La Fondazione Nuova Italia, di Gianni Alemanno leader di Azione Nazionale, ex sindaco di Roma, è stata sciolta il 23 novembre 2015, risultando inattiva per un anno. La fondazione si è trovata al centro delle indagini di Mafia Capitale, per la quale oggi la Procura di Roma ha chiesto il proscioglimento di 116 indagati. Libertiamo, di Benedetto Della Vedova risulta nell’elenco delle fondazioni di centro destra in quanto ex Scelta Civica. In verità Della Vedova è principalmente un ex radicale il cui obiettivo principale è quello di far legalizzare la cannabis in Italia.
LA CASTA DEI TESORIERI DI PARTITO
Dalla Dc alla Lega Nord, passando per Pci, Psi e tanti altri: tutti gli affari grossi, e spesso sporchi, dei segretari amministrativi. Con Citaristi, Lusi e la new entry Belsito secondo Donato De Sena. Visto dal lato dei guai giudiziari, ai quali si espone il mestiere del tesoriere di partito, non dev’essere affatto semplice. C’è infatti un filo sottile fatto di scandali, inchieste e condanne che unisce l’amaro destino dei segretari amministrativi della Prima Repubblica alle vicende dei cassieri degli ultimi tempi della Seconda Repubblica. Oggi come ai tempi del pentapartito e di Tangentopoli quegli uomini spesso oscuri, ma preziosissimi, che custodiscono le chiavi delle casseforti delle principali forze politiche, finiscono nella bufera per la gestione di fondi milionari piovuti da casse pubbliche o private.
SEVERINO CITARISTI, DC – Severino Citaristi, deputato e tesoriere della Democrazia Cristiana ai tempi di De Mita, destinatario e gran manovratore dei quattrini sporchi e puliti nella disponibilità dello scudocrociato, riuscì a collezionare ben 74 avvisi di garanzia. Le principali accuse a suo carico erano la violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, la concussione, il finanziamento illecito. Citaristi finì sotto inchiesta per decine di mazzette versate dagli imprenditori in cambio di favori e appalti, come le gare per la costruzione della terza corsia della Serenissima, per l’ampliamento dello scalo di Malpensa, per i lavori dell’Anas, così come per la costruzione dell’ospedale di Asti. Gli furono inflitte condanne, in parte definitive, per oltre 30 anni. Ma subì un solo arresto, ai domiciliari, e non andò mai in carcere per le sue precarie condizioni di salute. Secondo un calcolo di Milano Finanza realizzato nel 1993, il tesoriere della ultima Dc incassò, nei sette anni in cui fu sottosegretario amministrativo della ‘balena bianca’, più di 128 miliardi di lire in tangenti, 35 dall’operazione Enimont, altri 93 dalle accuse contenute nelle 29 richieste di autorizzazione a procedere nei suoi confronti fino al settembre ’93 giunte in Parlamento. Negli anni delle inchieste e dei processi, Citaristi sottolineò di non aver mai preso per sè una sola lira. E spiegava come delle operazioni sospette fossero a conoscenza anche i vertici: “I segretari politici del mio partito sapevano, alla fine dell’anno li informavo sempre delle entrate regolari. E di quelle irregolari. Loro ne prendevano atto”. “Il costo di un partito – raccontò poi Citaristi ad Enzo Biagi in un’intervista ricordando la sua esperienza da tesoriere – in anni regolari era di 60/70 miliardi. Un 23/24 miliardi provenivano dal contributo dello Stato, poi c’era il tesseramento che dava 13/14 miliardi; c’erano contributi regolari e poi c’erano dai 18 ai 20 miliardi all’anno non regolarmente denunciati”.
VINCENZO BALZAMO, PSI – Visse un’esperienza simile anche Vincenzo Balzamo, tesoriere del Partito Socialista di Bettino Craxi. Fu il cassiere che gestì un fiume di denaro dalle grandi imprese finito nelle tasche del Garofano, e successivamente nel mirino del pool di Mani Pulite. Finì sotto inchiesta, ad esempio, per le tangenti incassate dall’impresa di costruzioni Lodigiani impegnata nella costruzione della metropolitana milanese, un miliardo di lire l’anno, dal 1985 in poi. Il 14 ottobre del ’92 ricevette un avviso di garanzia in cui i magistrati ipotizzavano i reati di corruzione e violazione della legge sul finanziamento dei partiti. “Sofferenza e angoscia sono state fatali”, affermò Craxi commentando la morte per infarto di Balzamo, avvenuta pochi giorni dopo l’iscrizione nel registro degli indagati.
MARCELLO STEFANINI, PCI – Inchieste e avvisi di garanzia raggiunsero anche Marcello Stefanini, tesoriere del Pci-Pds. Fu coinvolto su più fronti giudiziari: il famigerato conto ‘Gabbietta’ del ‘compagno G’ Primo Greganti, le tangenti alla Sea, presunti finanziamenti ricevuti dalla società torinese Eumit, la compravendita di un immobile del partito a Roma, il denaro dal Pcus al Pci Pds e il versamento di 370 milioni alla Quercia dalla cooperativa Unieco, le tangenti per i lavori di Malpensa 2000. Il suo nome apparì per la prima volta a Tangentopoli nel settembre ’93. Anche lui fu accusato di finanziamento illecito e violazione della legge sul finanziamento dei partiti. Nel corso delle sue testimonianze ammise forme di contributi dalle cooperative. Ad anni dalla sua morte, avvenuta nel ’94, Massimo D’Alema parlò dell’esperienza giudiziaria di Stefanini, vissuta “con angoscia personale e con indignazione per l’ingiustizia subita”, ma anche affrontata “con lealtà verso le istituzioni”.
FRANCESCO PONTONE, AN – Poi arrivò la Seconda Repubblica, nuovi uomini e nuovi simboli, nuovi metodi e nuove idee. Ma i denari continuarono a far gola a politici e agli apparati delle forze politiche. Con un piccolo particolare: se prima i quattrini venivano dirottati dall’esterno alle casse dei partiti, ora dalle casse dei partiti vengono dirottate nelle tasche private. Ce ne siamo accorti negli ultimi anni, soprattutto. Nel 2010, ad esempio, il senatore, ed ex tesoriere di An, Francesco Pontone, finì nel registro degli indagati della Procura di Roma con l’accusa di truffa aggravata. Nel mirino dei magistrati romani era finita la compravendita di un’immobile di An, la nota casa di Montecarlo. L’appartamento di boulevard Pricnesse Charlotte 14, nel ’99 lasciato in eredità ad An dalla Contessa Colleoni, nel 2008 fu ceduto, ad un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, ad una società con sede nei Caraibi, Santa Lucia, per poi passare ad un’altra società, con sede in un altro paradiso fiscale (Santa Lucia) e finire nella disponibilità dei Giancarlo Tulliani, cognato del leader del partito Gianfranco Fini. Pontone aveva concluso l’atto di compravendita davanti al notaio grazie ad una delega ‘a disporre dei beni sociali’ conferitagli da Fini nel dicembre 2004. A conclusione delle indagini il gip dispose l’archiviazione sia per Pontone che per Fini. “Come ha fatto Tulliani a diventare inquilino proprio di quella casa donata ad An? Devo ammettere che questa singolare coincidenza resta al momento del tutto inspiegabile anche per me”, ripeteva il tesoriere, poi dimessosi dall’incarico. Nel febbraio 2011 Pontone, 85 anni, avvocato napoletano, ha abbandonato il gruppo parlamentare di Futuro e Libertà.
GIUSEPPE NARO, UDC – Nel novembre 2011 il tesoriere e deputato dell’Udc Giuseppe Naro è finito sotto inchiesta per le tangenti a partiti e politici dell’Enav. L’onorevole è accusato di finanziamento illecito ai partiti per aver intascato 200mila euro dall’imprenditore Tommaso Di Lernia, legale rappresentante della Print System, che sarebbe stato incaricato dell’operazione dall’amministratore delegato Enav Guido Pugliesi. Le carte dell’inchiesta parlano di un “sistema di illegalità” che forniva posti di lavoro e consulenze per i figli e i familiari dei politici e intestava quote di società private a parlamentare oppure a loro parenti. L’agenda elettronica di Pugliesi ha svelato 12 incontri tenuti con Naro, a dimostrazione del legame tra aziende pubbliche e partiti.
LUIGI LUSI, MARGHERITA – Il senatore Luigi Lusi, eletto tra le fila del Pd, è accusato alla procura di Roma di appropriazione indebita per aver sottratto, nella veste di tesoriere della Margherita, circa 20 milioni di euro di rimborsi elettorali dalle casse del partiti di Rutelli. Lusi avrebbe creato una sorta di contabilità parallela sfuggita ai controllori del partito e avrebbe investito il denaro in immobili, in Italia e all’estero. Ha ricoperto l’incarico di tesoriere dal 2002.
FRANCESCO BELSITO, LEGA NORD – Anche Francesco Belsito, tesoriere dimissionario della Lega Nord, è stato raggiunto dalle stesse accuse. E’ indagato per appropriazione indebita e truffa aggravata ai danno dello Stato per aver sottratto al partito i finanziamenti pubblici derivanti dai rimborsi elettorali. Un’inchiesta congiunta delle procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria ha condotto ad un blitz nella sede nazionale del partito del Carroccio.
Da quanto emerge finora, i fondi sarebbero stati sottratti e destinati alla famiglia del leader Umberto Bossi. Automobili, denaro in contanti, richieste continue. Dagli atti del Noe dei Carabinieri, che “L’Espresso”pubblica in esclusiva, i movimenti di fondi per moglie e figli del leader e per Rosi Mauro. Oltre ai conti all'estero e al riciclaggio. La segretaria intercettata: "Se esce fuori qualcosa della famiglia, il Senatùr è rovinato'. Alla fine le rivelazioni sono state più forte del carisma del padre padrone: alle 16,44 del 5 aprile 2012 Umberto Bossi ha gettato la spugna lasciando la guida della Lega a un triumvirato composto da Roberto Maroni, Renzo Calderoli e Manuela Dal Lago, e cioè il grande oppositore interno, l'uomo di fiducia della famiglia Bossi sotto schiaffo e del cerchio magico in crisi e la rappresentante dell'ala veneta del movimento. Il Senatur resterà presidente, ma la sua stella è tramontata per sempre. Con lui scompare la Lega così come l'abbiamo conosciuta e si chiude perfino la Seconda Repubblica nata vent'anni fa grazie all'alleanza di ferro con Silvio Berlusconi. Le evidenze, gli intrecci con imprese e faccendieri e soprattutto le intercettazioni, in particolare le conversazioni tra il tesoriere (dimessosi) Francesco Belsito e la segretaria Nadia Degrada, sommergono Bossi & C. sotto una valanga di fango disegnando una rete di falsi contabili, di favori personali, di piccoli e grandi imbrogli nei quali spiccano i figli di Bossi, la fedele Rosi Mauro e il suo sindacato padano, lo stesso Calderoli: lauree e diplomi falsi e dunque a pagamento; spese senza giustificativi per centinaia di migliaia di euro; Porsche affittate o acquistate da uno dei figli di Bossi, Riccardo, e non pagate...
Sempre, dice Belsito al telefono con Degrada, con l'imprimatur del Capo. Su “L’Espresso” le dichiarazioni a verbale di Nadia Dagrada e Daniela Cantamessa, segretaria particolare del leader del Carroccio dal 2005, sui soldi spesi per i titoli di studio. La laurea di Renzo Bossi presso un'università privata di Londra, gli studi di Rosy Mauro e del suo amante: tutto a carico della Lega. Queste le dichiarazioni di Nadia Dagrada: "Anche Renzo Bossi dal 2010 sta 'prendendo' una laurea ad un'università privata di Londra e so che ogni tanto ci va a frequentare e le spese sono tutte a carico della Lega, ed anche qui credo che il costo sia sui 130.000". E ancora: "Il diploma di laurea (forse in corso) di Moscagiuro Pier, compagno e segretario particolare della Rosy Mauro. Il diploma e la laurea per la Rosy Mauro per complessivi 130.000 euro". Però, anziché arrossire di vergogna e tacere i leghisti con la bella faccia tosta da “Polentoni” (po’ lentoni, ossia un po’ lenti di comprendonio) che si ritrovano hanno reagito a loro modo: per loro i ladri sono sempre gli altri. 'Il vero scandalo? I soldi ai terroni'. Dall’inchiesta di Daniele Sensi su “L’Espresso”. Gli interventi dei deputati leghisti su Radio Padania adottano la linea del complotto. 'Belsito è una trappola dei servizi segreti, una polpetta avvelenata per Bossi'. E Borghezio abbandona la via della non-violenza: 'Stiano attenti a non tirare troppo la corda, la colpa di noi patrioti padani è di essere troppo pacifici'. Belsito una trappola dei servizi segreti e della magistratura, messo lì per far fuori il Carroccio. Lo sostiene il deputato leghista Alberto Torazzi, intervenuto, nella tarda serata di giovedì 5 aprile 2012, su Radio Padania: «Se Belsito è arrivato lì con quel fardello e con quei contatti preoccupanti è chiaro che il potere romano lo sapesse e che i servizi segreti e la magistratura hanno preparato questa polpetta avvelenata e l'hanno cucinata per bene per poi far fuori Umberto Bossi». «E' stato sollevato un polverone per niente», ha inoltre aggiunto l'onorevole, «perché Bossi, che per dieci anni ha vissuto in un monolocale spendendo per il movimento tutti i soldi che incassava, è un uomo che dopo il malore del 2004 aveva una famiglia da mantenere e se il Consiglio federale avesse stabilito un fondo di 50, 100 mila euro a sua disposizione nessuno avrebbe avuto niente da ridire, poiché 50, 100 mila euro l'anno, dal 2004 al 2012, fanno 800 mila euro, quindi il doppio della cifra ora contestata». «Il vero scandalo sono i 400 miliardi di euro che pur stando in Padania vengono gestiti da leggi stabilite dai nostri cuginetti terroni», ha infine concluso Alberto Torazzi, prima di prendersela con i tre parlamentari della Lega che già un anno fa avrebbero presentato un esposto in Procura sul conto del tesoriere Belsito: «Spero che questa notizia sia falsa, perché ricorrere alla magistratura italiana, invece che risolvere internamente il problema, sarebbe la cosa che mi rattristerebbe di più, poiché vorrebbe dire che noi abbiamo ancora in giro personaggi che credono di poter avere giustizia e legalità passando dagli apparati dello Stato italiano, mentre dovremmo avere invece il coraggio degli irlandesi e dei baschi». Un riferimento al «coraggio» degli irlandesi e dei baschi, ovvero all'abbandono della via non-violenta fino ad oggi tenuta dal Carroccio, anche nelle parole dell'eurodeputato Mario Borghezio, pure lui intervenuto su Radio Padania:«Sarebbe stato da pazzi pensare che l'unico movimento che si oppone al governo della Trilaterale e del Club Bilderberg non si dovesse aspettare una qualche grande puttanata, ma stiano ben attenti a non tirare troppo la corda questi signori che vomitano contro Bossi e contro la Lega, perché forse la colpa di noi patrioti padani è di essere troppo pacifici, ma molti di noi la pensano esattamente come i baschi, e io sono uno di quelli». Contrario alla via gandhiana anche Giuliano Citterio, speaker dell'emittente: «E' l'inizio della nuova dittatura romana contro il popolo padano: spero che contro i feroci colonizzatori di oggi si metta in cantina Gandhi». E su Radio Padania si è fatto sentire lo stesso Umberto Bossi, il quale, dopo aver ribadito la tesi del complotto («Questo è il Sistema che si difende, perché com'è possibile che noi abbiamo un amministratore collegato a famiglie dell'ndrangheta e nessuno lo abbia fermato prima, avvisandoci?»), ha meglio spiegato le ragioni delle proprie dimissioni: «L'ho fatto per il movimento, che così può meglio liberarsi delle beghe; ma anche per me, perché fossi rimasto lì avrei dovuto procedere a eventuali interventi sui figli». Insomma ragioni di convenienza personale, non solo l'immagine agiografica del leader che, tra le lacrime dei militanti, si immola per la Causa («l'unico segretario che, appena lambito dal sospetto, abbia avuto il coraggio di dimettersi»). L'impressione, per la verità, è che davvero Bossi, più che un passo indietro, abbia voluto fare un passo di fianco, per lasciare agli altri il lavoro 'sporco' e tornare in pista a 'pulizie' ultimate: «Nessuno all'interno della Lega può farmi le scarpe: tra pochi mesi c'è il Congresso, e saranno il Congresso e la militanza a riprendere in mano le regole», ha rassicurato Bossi a conclusione del suo intervento. Non sarebbe quindi un caso se qualcuno nel Consiglio federale mal vedesse le dimissioni del segretario, il quale, rimanendo in carica fino al Congresso del autunno, sarebbe stato trascinato a fondo assieme al "cerchio magico". Con le sue dimissioni, la base si è invece ricompattata attorno a quello che Roberto Ortelli, conduttore di Radio Padania Libera, in questa settimana di Pasqua oramai definisce, in termini escatologici, un «Dio»: «Il Venerdì santo ci insegna che dal dolore più grande, dalla crocifissione e dal deicidio, nasce la gioia più grande, la certezza della Salvezza, la resurrezione del Dio vero, del Re dei Re, e del suo trionfo sul Male». Nell'attesa della Redenzione, sulle pagine Facebook di area leghista si susseguono gli appelli a mettere da parte le divisioni tra "maroniani" e "cerchisti", mentre si moltiplicano gli strali contro le origini meridionali di Belsito («terrone sei e terrone resterai», «mai fidas dì terù!», «prima o poi il terrone ti incula»), Rosy Mauro («sangue non mente», «questa è la prova provata che i terrun son terrun senza eccezioni», «mi sono sempre chiesta cosa ci facesse questa faccia da terrona sul palco della Lega») e Manuela Marrone, moglie del Senatur: «Sarà un caso, ma dall'interno ci hanno rovinato i meridionali». E se qualcuno annota, sarcastico, che «non si dice terrone, altrimenti ci criticano», altri, come la sezione Lega Nord di Cairate, rilanciano: «Vero, non si dice terrone: si dice terronazzo!». Il peggiore, un militante dei giovani padani di Torino: «Purtroppo ho il cognome terrone per un mio lontano parente, ma per fortuna io sono nato in Padania e la maggior parte dei terroni mi fanno schifo, non hanno voglia di fare un cazzo e puzzano che sembra che non si lavano da 100 anni». Bene. Qualcuno di loro, però, mi deve spiegare la propria genealogia e l’origine del proprio cognome: giusto per capire quanto puro sia il loro sangue celtico e quanto invece sia discendete da meridionali rinnegati, che dal Sud sono stati costretti ad espatriare.
E su Di Pietro e il finanziamento o rimborso spese all’Italia Dei Valori? Stare dalla parte dei magistrati paga? Filippo Facci su “Libero Quotidiano”: «Di Pietro spudorato, faccia di tolla sui soldi a IdvTonino, altra sparata: se la prende con la legge sui rimborsi elettorali. Proprio lui che l'ha sfruttata in ogni modo.» Sul serio, che dobbiamo fare con Di Pietro? Dobbiamo continuare a censire giornalmente tutte le cazzate che spara? Ditecelo, perché dobbiamo prendere una decisione. Aveva detto che Monti ha i suicidi sulla coscienza: proprio lui. Poi ha detto che «la legge sui rimborsi elettorali permette ai politici di fare quello che vogliono»: proprio lui. Lui che ha affiancato l'Italia Dei Valori con un'associazione costituita da Di Pietro (Presidente) e da Silvana Mura (tesoriera), nel cui consiglio si può entrare solo con il consenso del Presidente (Di Pietro), al quale vanno tutti i soldi del finanziamento pubblico, mentre il Partito e le singole campagne elettorali sono finanziati coi soldi degli iscritti; il presidente del partito inoltre corrisponde al presidente a vita dell'associazione (cioè a Di Pietro) e la Tesoreria del partito appartiene alla tesoriera a vita dell'associazione (cioè a Silvana Mura) e insomma: saluti dalla Corea del Nord. Parliamo dell'uomo che ha acquistato appartamenti che affittava al Partito (cioè a se stesso) per cifre mensili che andavano a coprire e superare le singole rate del mutuo che frattanto aveva acceso: in pratica, col denaro pubblico gestito dal partito, cioè gestito da lui, si comprava case. E allora che facciamo, continuiamo? Vale la pena?
'E' successo a mia insaputa': il resoconto di Riccardo Pennisi su “L’Espresso”. Sembra essere diventato il nuovo tormentone, l'alibi perfetto per ogni situazione incresciosa. Da Scajola a Rutelli, da Diliberto alla casa risistemata di Bossi, un imbarazzante catalogo di autodifese. Negli ultimi tempi, sulla scia della celebre autodifesa di Claudio Scajola, sono sempre di più gli uomini politici pronti a giurare che gli affari che li riguardano accadono a loro insaputa. Gli esempi sono tanti: da chi si stupisce per il malaffare che lo circonda, a chi giura vendetta contro chi gli paga una casa o una vacanza, fino a chi non riesce proprio a credere di non essere un latin lover.
"Denuncerò chi ha utilizzato i soldi della Lega per sistemare casa mia. Io non so nulla di queste cose. Avendo pochi soldi non ho ancora finito di pagare le ristrutturazioni della mia casa".Umberto Bossi, 3 aprile 2012. Il segretario della Lega reagisce così all'inchiesta sull'uso dei fondi del partito, che vede coinvolto il tesoriere Francesco Belsito.
"Ridicolo e provocatorio. Le attività di Luigi Lusi sono state condotte solo per il suo tornaconto personale, al di fuori di ogni mandato, e a totale insaputa mia e del gruppo dirigente della Margherita". Francesco Rutelli, 2 aprile 2012. Il presidente dell'Api parla alla Procura di Roma, che indaga sull'appropriazione di 18-20 milioni da parte dell'ex tesoriere della Margherita Lusi.
"Non avevo minimamente notato lo slogan sulla maglietta". Oliviero Diliberto, 20 marzo 2012. Il segretario del Pdci si era appena fatto fotografare accanto a una manifestante che indossa una maglietta con la scritta "Fornero al cimitero". Un video dimostra che Diliberto e la donna chiacchierano a lungo prima di farsi la foto insieme.
"Sono stato un
fesso ad accettare quelle quattro spigole e le 50 cozze pelose. Le ho dovute
mettere nella vasca da bagno. Non sapevo che i Degennaro (autori del regalo ndr)
fossero corrotti". Michele Emiliano, sindaco di Bari, giustifica così i
suoi rapporti con Gerardo e Daniele Degennaro, imprenditori, uno consigliere
regionale del Pd, l'altro presidente regionale di Federalberghi, arrestati per
corruzione, frode e numerosissimi falsi. 18 marzo 2012.![]()
"Io non mi sono accorto di niente". Vittorio Sgarbi, sindaco di Salemi, provincia di Trapani. 6 febbraio 2012. Il suo comune è stato da poco sciolto per infiltrazione mafiosa. Nel 2011, l'ex deputato Dc Giuseppe Giammarinaro subisce il sequestro di 35 milioni in un'operazione dell'antimafia di Palermo sul condizionamento delle amministrazioni locali. Due mesi fa, Sgarbi ha nominato Giammarinaro vicesindaco.
"Chiesi con insistenza all'albergo chi avesse pagato il mio conto. Mi fu risposto che non era possibile dirlo per ragioni di privacy. Quindi ignoro chi sia stato e perchè". Carlo Malinconico, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, 3 gennaio 2012. Le vacanze di Malinconico sono state pagate dall'imprenditore Francesco De Vito Piscicelli, coinvolto nell'inchiesta sulla "cricca" che indaga su appalti e vantaggi ricevuti da alcuni dirigenti pubblici in cambio di favori e regali.
"Ho detto quella frase a mia insaputa. Ma non è un mio pensiero.
Fini non è un maiale. Forse ho detto meno male". Francesco Storace, 14 novembre 2011. Al congresso de La Destra, Storace chiede le dimissioni di Fini dalla presidenza della Camera gridando "maiale, maiale traditore!".
"Gli investimenti in Tanzania? Io non ne sapevo niente". Roberto Maroni, 12 gennaio 2011. L'ex ministro dell'Interno si indigna quando scopre che il tesoriere della Lega Belsito (oggi in arresto) utilizzava i rimborsi elettorali per operazioni finanziarie in Tanzania.
"Non sapevo che la casa di Montecarlo fosse stata ristrutturata e affittata a mio cognato". Gianfranco Fini, 8 agosto 2010. Il presidente della Camera si dichiara stupito di apprendere che una parte del patrimonio immobiliare della vecchia AN sia passato nelle disponibilità di Giancarlo Tulliani, fratello minore della sua compagna Elisabetta.
"Forse mi hanno fatto un regalo a mia insaputa. Se trovo chi è stato...". Il 4 maggio 2010 Claudio Scajola, in una conferenza stampa, commenta così il dono ricevuto da Diego Anemone. Il faccendiere accusato di aver ricevuto appalti dalla Protezione Civile grazie alla corruzione, ha contribuito con 900.000 euro all'acquisto dell'appartamento di 180 mq con vista sul Colosseo in cui vive l'ex ministro dello Sviluppo economico. I due saranno processati dalla procura di Roma.
"A me piace la conquista, altrimenti non c'è gusto. Se nelle mie residenze c'erano delle prostitute, vuol dire che qualcuno le ha intrufolate a mia insaputa"."Non ho mai invitato consapevolmente a casa mia persone poco serie". Silvio Berlusconi difende il proprio onore, maggio-agosto 2009.
DALLA PARTE DEI CITTADINI ??
"Questo è un Paese che fa quattro chilometri di Gazzetta Ufficiale l'anno, un chilometro quadrato di regole all'anno". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, a Levico Terme, il 13 giugno 2010, ospite della Festa nazionale della Cisl. "Abbiamo una quantità impressionante e crescente di regole, che hanno l'effetto di un blocco oltre il bisogno, di una ragnatela, che fa anche paura", ha aggiunto il ministro, sottolineando la presenza di un "labirinto di leggi".
Le leggi in Italia non si sa con certezza quante siano. Si parla di diverse decine di migliaia e c'è chi azzarda che siano più di centomila. Poco meno di 100mila sono le leggi in Italia secondo una ricerca condotta dal servizio studi della Camera tra le quali 18mila di carattere regionale e 10mila comunitarie. Il massimo esperto di diritto amministrativo Sabino Cassese, pare che sia riuscito ad inventariarle, dice che sono oltre 160.000 le normative primarie, per non parlare delle regionali e comunitarie. Il professor Sabino Cassese, uno dei responsabili della commissione per la delegificazione istituita presso la Presidenza del Consiglio. Secondo uno studio fatto all' Università di Genova, siamo a quota 200 mila. E' facile dunque intuire quanto sia complicato, anche per gli "addetti ai lavori", orientarsi fra le migliaia di testi che aumentano di giorno in giorno. Le difficoltà aumentano quando si passa alla consultazione perché quando meno te lo aspetti comincia l'avventura dei "rinvii" ad altre leggi . Non credo vi sia al mondo nessuna burocrazia, così oppressa. Sfido qualsiasi burocrazia ad applicare e a far rendere efficiente un sistema così.
Da anni il dr. Antonio Giangrande, presidente dell'Associazione Contro Tutte le Mafie e di Tele Web Italia ed autore del libro "L'Italia del trucco, l'Italia che siamo" propone ai Parlamentari eletti di votare una legge, in cui si preveda l'obbligatorietà del Difensore Civico amministrativo presso gli enti pubblici, per la tutela della comunità contro gli sprechi ed i disservizi della Pubblica Amministrazione, e, più importante, si preveda la figura del Difensore Civico giudiziario presso ogni Corte d'Appello, per la tutela del cittadino contro abusi ed omissioni degli operatori della Giustizia e della Sicurezza. Risultato: lettera morta.
L'Italia ha ricevuto circa 90 raccomandazioni per la violazione dei diritti degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Il Gruppo di lavoro della Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha criticato il nostro Paese per i centri di identificazione ed espulsioni. Lo ricorda Amnesty International, che ha presentato il rapporto sulla «Situazione dei diritti umani nel mondo», dal quale «viene fuori che l’Italia è un Paese pieno di lacune».
L'introduzione del reato di immigrazione clandestina, si legge nel rapporto, «potrebbe dissuadere gli immigrati irregolari dal denunciare i reati subiti e ostacolare il loro accesso a istruzione, cure mediche e altri servizi pubblici per il timore di denunce». Inoltre «gli sforzi da parte delle autorità per controllare l'immigrazione hanno messo a repentaglio i diritti di migranti e richiedenti asilo». «A noi - nota la responsabile dello studio per la parte italiana, Giusy D'Alonzo - non sembra che l'insicurezza nella vita degli immigrati abbia portato maggiore sicurezza per gli italiani», mentre il risultato più evidente è che i richiedenti asilo sono calati in un anno dai 31 mila ai 17 mila. Ma la violazione dei diritti degli stranieri non è limitata all'Italia, Amnesty parla di «esplosione di xenofobia e razzismo» in tutta Europa. Il nostro Paese, però, stando al rapporto, «ha continuato ad espellere persone verso luoghi in cui erano a rischio di violazioni di diritti umani» - ovvero la Libia - «senza valutare le loro necessità di asilo e protezione internazionale. I governi italiano e maltese in disaccordo sui rispettivi obblighi di condurre operazioni di salvataggio in mare, hanno lasciato i migranti per giorni senza acqua e cibo, ponendo a grave rischio le loro vite».
L'associazione per i diritti umani punta il dito anche sulla mancanza di norme specifiche contro il reato di tortura, senza il quale sono potenzialmente sempre presenti i rischi di casi come quello del giovane Cucchi. «Sono pervenute frequenti denunce di tortura e altri maltrattamenti commessi da agenti delle forze di polizia, nonchè segnalazioni di decessi avvenuti in carcere in circostanze controverse», dice Amnesty. L'Italia, infatti, ricorda l'ong, «a distanza di decenni non ha ratificato la Convenzione Onu contro la tortura», di conseguenza i maltrattamenti commessi da pubblici ufficiali in servizio vengono perseguiti come reati minori. Tra i casi citati, tra gli altri, anche quello di Emmanuel Bonsu, il ragazzo di origine ghanese, pestato e insultato a Parma e i maltrattamenti inflitti nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001. Amnesty chiede per questo «l'adozione di meccanismi di prevenzione della tortura e dei maltrattamenti», come previsto dal Protocollo della Convenzione, «un'istituzione indipendente di monitoraggio sui luoghi di detenzione» e «un organismo di denuncia degli abusi della polizia».
Lo Stato italiano deve risarcire le vittime di violenza sessuale (e di altri reati contro la persona) se il colpevole, per varie ragioni, non lo fa. È questo il senso di una sentenza con cui il tribunale civile di Torino ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri a versare 90 mila euro a una giovanissima studentessa piemontese che nel 2005 venne aggredita da due stranieri. Il giudice, Roberta Dotta, ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati dello studio legale, i quali non hanno fatto altro che ricordare come lo Stato italiano, unico caso in Europa insieme alla Grecia, non si sia ancora allineato a una direttiva comunitaria del 2004 (Il cittadino europeo che subisca un reato intenzionale violento in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente, potrà presentare la domanda di risarcimento presso un'autorità o qualsiasi altro organismo dello stato in cui risiede.
E' quanto prevede la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004, il cui obiettivo è quello di garantire ad ogni cittadino europeo il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso).
Bisogna prevedere un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio da persone di qualsiasi nazionalità. L'Italia è inadempiente da molti anni. Grazie a questa sentenza, che giunge al termine di una causa pilota, adesso dovrà provvedere. I due imputati della violenza, entrambi stranieri, erano stati condannati in via definitiva, al termine del processo penale, a dieci anni e quattro mesi di reclusione, ma non avevano indennizzato la parte civile: non solo non avevano le risorse economiche, ma durante il giudizio di primo grado si erano resi latitanti (rintracciati all'estero, sono stati arrestati).
La Presidenza del Consiglio, tramite l'Avvocatura dello Stato, nel corso della causa si era difesa affermando che in Italia esistono già dei casi in cui è previsto l'indennizzo delle vittime (si tratta, per esempio, dei reati di mafia, usura, terrorismo ed estorsione), e aveva rivendicato una sorta di discrezionalità nella scelta dei delitti da includere nell'elenco. Il giudice, però, ha fatto notare che la direttiva del 2004 impone agli Stati «di prevedere un meccanismo indennitario per tutti i reati intenzionali violenti e dunque anche per i reati di violenza sessuale, reati contro la persona di evidente natura violenta e intenzionale».
La sentenza colma finalmente una grave lacuna che ci distingueva, in negativo, dagli Stati europei.
Ma c'è ancora una differenza: oggi le vittime colpite da questi reati in territorio italiano non hanno un fondo cui rivolgersi e si trovano costrette a ricorrere ai tribunali affrontando, come nel nostro caso, un vero e proprio processo.
C'è il rischio di un elevatissimo numero di cause civili contro la Presidenza del Consiglio, con costi per lo Stato e aggravi ulteriori per le vittime. L'auspicio, dunque, è di una legge che dia concreta attuazione alla direttiva, evitando alla magistratura di dover sopperire alle carenze del Governo e del Parlamento.
Il gratuito patrocinio dovrebbe essere la tutela per il diritto di difesa dei più poveri e per questo motivo la parte politica di riferimento, secondo le loro enunciazioni, dovrebbe essere la “sinistra”. Guarda caso, però, fu proprio il Governo “D’Alema” con la legge 134 del 2001 a prevedere l’obbligatorietà della scelta del difensore iscritto nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine. In questo modo il povero non può più scegliersi l’avvocato di fiducia pagato dallo Stato, quant’anche non sia iscritto nell’elenco, com’era prima, ma gli viene imposto un avvocato che a tutti gli effetti è un avvocato di ufficio.
Il Governo “Prodi” vara un disegno di legge sull’editoria. Nel silenzio generale, esso è approvato formalmente dal Consiglio dei Ministri n. 69 del 12 ottobre 2007. La norma prevede l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione a tutti coloro che operano nel campo dell’informazione, sia editoriale e non, sia profit e non, sia professionale e non. E' un attacco agli internauti, alla libera informazione mediatica ed ai blog.
Il Governo “Berlusconi” vara il decreto legge n. 200, approvato il 22 dicembre 2008 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), che elimina il decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944: una norma che tutela chi reagisce ai soprusi dei pubblici ufficiali. Il D.L. ha tagliato 29mila leggi che vanno dal 1861 al 1947, tra cui anche il testo del 1944 senza accorgersi che così ha privato il cittadino di una garanzia dell'ordinamento democratico contro gli eccessi arbitrari dei funzionari pubblici: e cioè la norma che esime il cittadino dalle ricadute penali di talune sue reazioni ad atti arbitrari o illegali dell'Autorità pubblica. Insomma all'uso scorretto del potere discrezionale dei rappresentanti lo Stato. Quello che subisca un fermo per motivi infondati, quello che allo stadio si ritrovi vittima di azioni immotivate delle forze dell'ordine, quello che in piazza veda equivocato il proprio ruolo nel parapiglia di una manifestazione politica, quello che in udienza abbia un acceso confronto con un giudice prepotente, si ritrova più indifeso rispetto a potenziali soprusi di Stato.
Oggi in un regime apparentemente liberticida e garantista, ci ritroviamo a dover rimpiangere leggi promulgate in tempi di guerra.
Questo è il paradosso italiano: nulla è vero di tutto quello che appare.
Il Ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli (Lega Nord) il 24 marzo 2010 ha dato fuoco a 375.000 leggi inutili o dannose. Il gesto simbolico per far arrivare ai cittadini l'immagine di un lavoro di oltre un anno e mezzo. Un muro di scatoloni lungo 16 metri, da abbattere a picconate e poi da bruciare. Il tutto fatto da un Ministro ed in presenza di Pubblici Ufficiali.
Peccato che tra quelle bruciate non ci fosse il Decreto legislativo 152/2006, riguardo lo smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti, che prevede notevoli pene pecuniarie e risvolti di carattere penale se lo smaltimento avviene in modo illecito.
In questo caso la violazione di legge a lui non è stata applicata.
Però, a tal proposito, gli agricoltori sono oggetto di controlli presso i loro fondi agricoli sui quali si procede, così come accade da secoli, alla bruciatura dei residui di potatura. I controlli si concludono con l’apertura di procedimenti penali a carico dei contadini per la violazione delle norme sui rifiuti. Agli agricoltori viene contestata, appunto, la violazione del Decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico di norme in materia ambientale), riguardo lo smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti, che prevede notevoli pene pecuniarie e risvolti di carattere penale.
In data 2-3-4 marzo
2010, il servizio di Stefania Petix, inviata di Striscia La Notizia, per la
prima volta in Italia ha sollevato il problema della destinazione clientelare
dei beni confiscati alla mafia.
In quel caso si evidenziava che a Palermo la destinazione a fini sociali dei
beni confiscati era stata effettuata a favore di associazioni inesistenti o a
fini di lucro.
A Manduria (TA), in data 3 marzo 2010, anche grazie ad una legge regionale, denominata appunto “Libera il bene”, attraverso la quale la Regione Puglia si assume il 90% dell’onere economico delle spese per la ristrutturazione degli immobili, il commissario straordinario prefettizio di Manduria ha promosso ed ottenuto, con la firma del protocollo di intesa, la collaborazione della stessa associazione Libera e della Prefettura di Taranto, finalizzata all’analisi dei beni confiscati agli esponenti mafiosi di Manduria, al monitoraggio delle loro condizioni strutturali, alla verifica del possibile riutilizzo e alla progettazione per la trasformazione in centri di aggregazione o per altro uso (da stabilirsi). L’Ente pubblico in questo caso si assume l’onere del restante 10%.
Si riscontra che l’associazione “Libera” ha un rapporto privilegiato con le strutture Prefettizie a scapito delle tantissime associazioni indipendenti che non fanno capo a quel coordinamento.
Al sodalizio nazionale denominato “Associazione Contro Tutte le Mafie”, iscritta presso la Prefettura di Taranto al n. 3/2006, è impedita l’iscrizione presso altre prefetture pur operando nel loro territorio, in virtù del Decreto del Ministero dell’Interno n. 220 del 24/10/2007, che prevede l’iscrizione delle associazioni antiracket solo ed esclusivamente presso le prefetture competenti sulla sede legale.
Si denuncia che “Libera” è un coordinamento, non
un’associazione, e come tale, in virtù del Decreto citato, non può essere
iscritta presso la Prefettura di Taranto o di altre città, in quanto il
coordinamento non ha la sede legale in quella città, ma in via IV Novembre, 98,
Roma, per cui i protocolli d’intesa con Prefetture ed Enti Locali per
l’affidamento dei beni sono nulli Se passa il principio che chiunque spenda il
nome “Libera” possa essere iscritto e privilegiato dagli enti Prefettizi, è
normale che in Italia si formi un monopolio illegale delle assegnazioni dei
beni, specie se poi questa attività è sostenuta dai finanziamenti pubblici. E’
ancor più grave se poi i coordinamenti hanno sede presso la CGIL. In questo caso
parrebbe un’espropriazione proletaria.
Poi non si capisce come mai la Regione Puglia possa riconoscere finanziamenti
solo a “Libera”, escludendo le altre associazioni indipendenti, specie se dopo
tanta enfasi, dopo anni non è ancora stato istituito l’albo regionale delle
associazioni antiracket, che dovrebbe legittimare gli stessi finanziamenti.
PARLIAMO DI FONDI COMUNITARI
Le regioni del Sud hanno posto in essere "uno scandaloso percorso" nella gestione dei fondi comunitari. E' quanto ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, il 2 luglio 2010 nel corso dell'assemblea di Coldiretti. "C’è stato uno stanziamento di fondi comunitari sul programma 2007-2013 pari a 44 miliardi di euro. Questi signori ne hanno spesi solo 3,6 miliardi, mentre cresceva la protesta contro i tagli subiti, aumentavano i capitali non usati - ha evidenziato il ministro -. Più il Sud declinava, più i fondi salivano. Questa cosa è di una gravità inaccettabile". Secondo il ministro "la colpa non è dell'Ue né dei governi nazionali di destra o sinistra. La colpa è della cialtroneria di chi prende i soldi e non li usa".
PARLIAMO DI MORALITA’.
Generalmente si dice che i partiti rubano soldi ai cittadini con il finanziamento pubblico mascherato da rimborso elettorale. Mai si era sentito che i partiti fossero derubati essi stessi dai loro componenti. Bene. E’ successo anche questo.
Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita indagato per appropriazione indebita per aver preso dalle casse del partito 13 milioni di euro, prova a difendersi. Dice: "avevo bisogno di quei soldi e li ho presi. Ho lavorato dieci anni come amministratore...". Il senatore Pd si dice pronto a patteggiare la condanna. Ai magistrati si è detto pronto a restituire il maltolto. Ma la proposta di fidjussione che è già stata depositata - secondo quanto scrive il Corriere - copre 5 milioni di euro. Una cifra di gran lunga inferiore rispetto a quello che sarebbe l'importo del maltolto. Lusi ha spiegato che il resto dei soldi è servito a pagare le tasse, ma non è apparso convincente e bisognerà effettuare nuove verifiche. Il partito accetterà l'offerta di Lusi per la restituzione di soli 5 milioni. Nell'attesa i magistrati stanno valutando l'eventualità di disporre il sequestro cautelativo dei beni immobili ma anche di convocare quei dirigenti di Democrazia e Libertà che sostengono di aver chiesto una verifica dei bilanci già nei mesi scorsi, ma di non aver ottenuto nessuna risposta.
Da “Panorama” si apprende che la Margherita era stata già sciolta ma i soldi fluivano ancora dalle casse del partito che non era più, dissolto petalo dopo petalo e innestato nella Quercia, a quelle del suo tesoriere vivo, vegeto e sempre più florido. Dal conto corrente del (fu) partito di Rutelli e Parisi a quelli personalmente collegati all’ex capo dei Boy Scout e senatore del PD alla seconda legislatura, Luigi Lusi. Certo, la prima legge che ha infranto Lusi è proprio quella dei benemeriti Scout. Con l’aggravante grottesca di succhiare linfa a un ramo morto, un partito zomby che aveva perso la sua funzione politica ma continuava a svolgere una funzione reale di drenaggio fondi (pubblici) e relativa redistribuzione (privata). All’insaputa anche di chi di quel conto era cointestatario, cioè l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli.
Regola numero 8: “Lo Scout sorride e fischietta in tutte le difficoltà”.
Regola numero 9: “Lo Scout è economo”. Non sappiamo se Lusi, accusato di aver dirottato su società e conti propri o della famiglia quasi 13 milioni di euro di finanziamento pubblico a Democrazia e Libertà, abbia l’animo di fischiettare, come non fosse stato colto con le dita nella marmellata. Certo, “un economo” lo era. Probabile che sia rimasto ligio anche ad altre regole: essere cortese, amico degli animali, ubbidiente verso i genitori e il Capo Pattuglia, amico di tutti e fratello di ogni altro Scout. Ma ha inciampato, magari sorridendo, sulla regola numero 1 della Legge dello Scout (“L’onore di uno Scout è di esser creduto”), la 2, sulla fedeltà alla Patria e ai datori di lavoro, e la 10: “Lo Scout è pulito nel pensiero, nella parola e nell’azione”.
Rutelli oggi è parte lesa, degli intrallazzi del suo tesoriere non sapeva né aveva sospettato nulla. Chi, invece, aveva subodorato la truffa e protestato e chiesto lumi nelle riunioni da zombi della Buonanima Margherita è il professor Arturo Parisi. Una voce di bilancio fantasma di 4 milioni di euro, per esempio, Lusi l’avrebbe giustificata come obolo per Dario Franceschini nelle primarie contro Bersani. Ma Franceschini nega. Gli altri, da Gentiloni a Fioroni, da Bianco a Santagata, per arrivare ai confluenti della Quercia con in testa lo stesso Bersani, dicono che nulla sapevano e nulla si immaginavano. Il bilancio era stato pubblicato sull’organo della Margherita, Europa. Per quel che vale. Ma la cosa più incredibile è che i soldi erano veri, e infatti si sono trasformati al tocco della bacchetta magica di Lusi in una villa a Genzano e un appartamento milionario in una delle più eleganti vie del centro di Roma, dietro Campo de’ Fiori, e in flussi milionari in più tranche (per non dare nell’occhio) verso una società collegata a Lusi in cambio di consulenze di facciata.
Vizi privati e pubbliche virtù: quando il Tribunale di Milano decise di non ammettere il patteggiamento per gli imputati nel fallimento Parmalat, Lusi, che oggi sembra voglia chiedere il patteggiamento, esultò perché erano state “riconosciute le ragioni di decine di migliaia di italiani che hanno visto azzerati i loro risparmi in uno degli scandali finanziari più catastrofici della storia d’Italia. Una decisione che conforta chi crede che nel nostro Paese le leggi ci siano e vadano rispettate”. Inquieta pensare che uno come lui abbia ricoperto nella sua carriera incarichi da consigliere giuridico del Comune di Roma per le politiche della casa e della sicurezza, delegato del sindaco, poi nelle municipalizzate Metroferro e Trambus, tesoriere nella campagna elettorale del 2001 di Rutelli per Palazzo Chigi, infine “cassiere” della Margherita. Che già era un fossile della politica. Ma un fossile d’oro.
Luigi Lusi ha ammesso di aver sottratto 13 milioni di euro dai bilanci della Margherita. Come hanno reagito alla vicenda gli ex dirigenti di quel partito? E che cos'hanno detto al “L’Espresso” i colleghi di Lusi di oggi, cioè i vertici di del Pd? Ecco qua:
«Lusi? Affari suoi. Io non commento la storia di uno che ha già ammesso di essersi preso i soldi per farsi la casetta piccolina in Canadà.» (Rosy Bindi).
«Mi sembra che si stia parlando di una persona diversa da quella che conosco.» (Roberto Giachetti).
«Io non do mai giudizi prima di aver letto le carte ma di certo Lusi riscuoteva la fiducia di tutti, erano riconosciute le sue capacità di tesoriere.» (Giuseppe Fioroni).
«Siamo incazzati e addolorati. La Margherita intende recuperare tutto il maltolto.» (Francesco Rutelli, ex leader Margherita).
«C'erano alcune voci opache. Somme consistenti in uscita che non convincevano. Per questo chiesi di sospendere l'assemblea per avere tempo di leggere meglio il bilancio. Ma eravamo in scadenza dei termini per l'approvazione del bilancio e quindi si andò avanti. Ma ottenni che si istituisse un organismo di verifica. Però questa commissione non veniva mai convocata. Alla fine si decise una data. Era novembre. Io tornai da un viaggio in Cina per partecipare. Ma la riunione andò deserta. Non venne nessuno». (Arturo Parisi).
«Noi non ne sapevamo niente». (Pierluigi Bersani).
«Le voci del bilancio erano troppo riassuntive e chiesi chiarimenti. Infatti l'assemblea di fine giugno andò per le lunghe e alla fine il bilancio preventivo 2011 non fu votato e il chiarimento rinviato a un organismo ad hoc. Sono molto turbato, è un'accusa che addolora.» (Pier Luigi Castagnetti).
«Questa storia meno si commenta e meglio è»; «In passato ho contestato in più di un'occasione l'integrità dei processi di rendicontazione e la trasparenza dei bilanci»; «E' da tre anni che non ci è consentito di vedere i bilanci e, conseguentemente, di approvarli»; «E' una storia strana. Va bè che Lusi gestiva con abbondante autonomia i bilanci, ma c'è un revisore dei conti. Un comitato di tesoreria politico, composto da tante persone, mica da uno solo. Sono troppi soldi, la cosa non si spiega...»; «Mi sembra sia riuscito a bypassare troppi controlli.» (Renzo Lusetti).
«Ho chiesto più volte le carte e non me le hanno date. Le cose che so le dirò ai giudici, se mi chiameranno.» (Giulio Santagata. In seguito ha precisato: «Era solo una conversazione scherzosa»).
«Il potere amministrativo, in base allo Statuto, era interamente nelle mani del senatore Luigi Lusi: persona da tutti stimata.» (dalla nota diffusa dalla Margherita dopo lo scoppio dello scandalo).
Sono 84 i rappresentanti del popolo che hanno questioni aperte con la giustizia. Tra i reati ci sono quelli tipici della politica (corruzione, concussione ecc.), ma crescono quelli da legami con organizzazioni mafiose. Alcuni, invece, si portano dietro condanne legate agli anni di piombo.
L'ELENCO pubblicato da “La Repubblica”.
Gli 84 sotto accusa. Un database dettagliato con tutti i nomi dei parlamentari nei 'guai' con la giustizia. Tra Montecitorio e Palazzo Madama siedono deputati e senatori con sentenze di condanna sulle spalle, in attesa di processo oppure rinviati a giudizio. E tra questi, ben 34 risultano condannati per reati che vanno dalla diffamazione fino all'associazione mafiosa o per una cattiva gestione di fondi pubblici di cui ora devono rispondere di tasca propria. Altri nove legislatori sono stati beneficiati dalla prescrizione dei reati.
|
Nome |
Partito |
In Parlamento |
Procedimento giudiziario |
|
Abrignani Ignazio |
PDL |
CAMERA |
Indagato per dissipazione post-fallimentare |
|
Angelucci Antonio |
PDL |
CAMERA |
Indagato per associazione a delinquere, truffa e falso |
|
Aracu Sabatino |
PDL |
CAMERA |
Rinviato a giudizio nella sanitopoli abruzzese |
|
Barani Lucio |
PDL |
CAMERA |
Richiesta di rinvio a giudizio per abuso d’ufficio |
|
Barbareschi Luca |
GRUPPO MISTO EX PDL - FLI |
CAMERA |
Indagato per abusivismo |
|
Berlusconi Silvio |
PDL |
CAMERA |
Sotto processo per frode fiscale (Mediaset), corruzione in atti giudiziari (Mills), frode fiscale e appropriazione indebita (Mediatrade), prostituzione minorile e concussione aggravata (Ruby), diffamazione aggravata dall’uso del mezzo televisivo, abuso d’ufficio (Trani). Altri reati prescritti o estinti per amnistia |
|
Bernardini Rita |
PD |
CAMERA |
Condannata nel 2008 a quattro mesi per cessione gratuita di marijuana, pena estinta per indulto |
|
Berruti Massimo Maria |
PDL |
CAMERA |
Condannato in appello a due anni e dieci mesi per riciclaggio |
|
Bosi Francesco |
UDC |
CAMERA |
Indagato per abuso d'ufficio |
|
Bossi Umberto |
LEGA NORD |
CAMERA |
Condannato per finanziamento illecito |
|
Bragantini Matteo |
LEGA NORD |
CAMERA |
Condannato in appello per propaganda di idee razziste |
|
Brancher Aldo |
PDL |
CAMERA |
Condannato in appello a due anni per appropriazione indebita e ricettazione |
|
Calderoli Roberto |
LEGA NORD |
SENATO |
Prescrizione per tafferugli |
|
Caliendo Giacomo |
PDL |
SENATO |
Indagato per violazione della legge Anselmi sulle società segrete (inchiesta nuova P2) |
|
Camber Giulio |
PDL |
SENATO |
Condannato im via definitiva a 8 mesi per millantato credito |
|
Cantoni Gianpiero Carlo |
PDL |
SENATO |
Ha patteggiato una pena di 2 annui per concorso in corruzione e bancarotta fraudolenta |
|
Caparini Davide |
LEGA NORD |
CAMERA |
A processo per resistenza a pubblico ufficiale (reato prescritto) |
|
Carra Enzo |
UDC |
CAMERA |
Condannato per false dichiarazioni al pm |
|
Castagnetti Pierluigi |
PD |
CAMERA |
Rinviato a giudizio e poi prescritto per le presunte tangenti nel ‘91-‘92 sulle concessione dell’Istituto vendite giudiziarie di Ancona |
|
Castelli Roberto |
LEGA NORD |
SENATO |
Condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti |
|
Cesaro Luigi |
PDL |
CAMERA |
Indagato per associazione camorristica |
|
Ciarrapico Giuseppe |
PDL |
SENATO |
Quattro condanne in via definitiva: violazione della legge che tutela il lavoro minorile, ricettazione fallimentare, finanziamento illecito ai partiti, bancarotta fraudolenta |
|
Cosentino Nicola |
PDL |
CAMERA |
Rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione camorristica |
|
Crisafulli Vladimiro |
PD |
SENATO |
Condannato a cinque mesi, pena sospesa, per l’occupazione di un’autostrada per protestare per la mancata apertura dell’Università di Enna. Rinviato a giudizio per concorso in abuso d’ufficio per la pavimentazione fatta con fondi pubblici di una strada che porta alla sua villa |
|
Cursi Cesare |
PDL |
SENATO |
Indagato per corruzione |
|
De Angelis Marcello |
PDL |
CAMERA |
Condannato a 2 anni e mezzo per banda armata |
|
Del Pennino Antonio |
GRUPPO MISTO EX PRI |
SENATO |
Condannato per finanziamento illecito |
|
Di Stefano Fabrizio |
PDL |
SENATO |
Richiesta di rinvio a giudizio per corruzione |
|
D’Alì Antonio |
PDL |
SENATO |
Indagato per concorso esterno in associazione mafiosa |
|
Enzo Galioto |
UDC |
SENATO |
Condannato in primo grado per falso in bilancio |
|
Esposito Stefano |
PD |
CAMERA |
Indagato, ha versato un'oblazione di duemila euro per evitare l’accusa di aver violato la legge elettorale |
|
Farina Renato |
PDL |
CAMERA |
Condannato a sei mesi per favoreggiamento, condannato per diffamazione |
|
Fazzone Claudio |
PDL |
SENATO |
Rinviato a giudizio per abuso d’ufficio |
|
Firrarello Giuseppe |
PDL |
SENATO |
Condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi per turbativa d’asta |
|
Fitto Raffaele |
PDL |
CAMERA |
Rinviato a giudizio per corruzione, abuso d’ufficio, peculato, finanziamento illecito ai partiti |
|
Galati Giuseppe |
PDL |
CAMERA |
Rinviato a giudizio per associazione a delinquere e truffa |
|
Genovese Francantonio |
PD |
CAMERA |
Indagato per abuso d’ufficio per affidamenti fatti durante la sua sindacatura a Messina a un’azienda di servizi |
|
Grassano Maurizio |
I RESPONSABILI EX LEGA NORD |
CAMERA |
Sotto processo per truffa |
|
Grillo Luigi |
PDL |
SENATO |
Condannato in primo grado a un anno e otto mesi per reati bancari nel processo sulla scalata Bpi/antonveneta. Indagato per truffa sulla Tav Milano-Genova: prescritto |
|
Iapicca Maurizio |
PDL |
CAMERA |
Rinviato a giudizio per false fatture, falso in bilancio e abuso d’ufficio: prescritto |
|
La Malfa Giorgio |
GRUPPO MISTO PRI |
CAMERA |
Condannato per finanziamento illecito |
|
Laganà Maria Grazia |
PD |
CAMERA |
Rinviata nel 2010 a giudizio per falso e abuso d’ufficio ai danni dell’Azienda sanitaria di Locri |
|
Landolfi Mario |
PDL |
CAMERA |
Indagato per concorso in corruzione |
|
Lehner Giancarlo |
I RESPONSABILI EX PDL |
CAMERA |
Condannato per diffamazione |
|
Lolli Giovanni |
PD |
CAMERA |
Prescritto per il reato di favoreggiamento nell’inchiesta sulla missione Arcobaleno |
|
Lombardo Angelo |
GRUPPO MISTO MPA |
CAMERA |
Indagato per concorso esterno in associazione mafiosa |
|
Lumia Giuseppe |
PD |
SENATO |
Indagato per diffamazione. È stato querelato dal suo ex addetto stampa |
|
Lunardi Pietro |
PDL |
CAMERA |
Indagato per corruzione |
|
Luongo Antonio |
PD |
CAMERA |
Rinviato nel 2009 a giudizio per corruzione nell’inchiesta su affari e politica a Potenza |
|
Malgieri Gennaro |
PDL |
CAMERA |
Condannato dalla Corte dei Conti a risarcire - con altri 5 - 11 milioni per la nomina di Alfredo Meocci a dg della Rai |
|
Marcello Dell'Utri |
PDL |
SENATO |
Condannato in appello per concorso esterno in associazione mafiosa |
|
Maroni Roberto |
LEGA NORD |
CAMERA |
Condannato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (pena commutata in multa) |
|
Matteoli Altero |
PDL |
SENATO |
Indagato per favoreggiamento |
|
Messina Alfredo |
PDL |
SENATO |
Richiesta di condanna a un anno per favoreggiamento alla bancarotta |
|
Milanese Marco |
PDL |
CAMERA |
Indagato per corruzione, rivelazione segreta e associazione a delinquere |
|
Nania Domenico |
PDL |
SENATO |
Condannato per banda armata. Condannato in primo grado per abusivismo edilizio: prescritto |
|
Naro Giuseppe |
UDC |
CAMERA |
Condannato a 6 mesi per abuso d'ufficio |
|
Nespoli Vincenzo |
PDL |
SENATO |
Indagato per bancarotta fraudolenta e riciclaggio |
|
Nessa Pasquale |
PDL |
SENATO |
Rinviato a giudizio per concussione |
|
Orlando Leoluca |
ITALIA DEI VALORI |
CAMERA |
Condannato per diffamazione |
|
Papa Alfonso |
PDL |
CAMERA |
Indagato a Napoli per corruzione |
|
Papania Nino |
PD |
SENATO |
Ha patteggiato una condanna a 2 mesi per aver scambiato regali e assunzioni quando era assessore regionale al Lavoro |
|
Paravia Antonio |
PDL |
SENATO |
Condannato in primo grado per corruzione: prescritto |
|
Piso Vincenzo |
PDL |
CAMERA |
Condannato in primo grado a 8 mesi per favoreggiamento |
|
Pistorio Giovanni |
GRUPPO MISTO MPA |
SENATO |
Condannato dalla Corte dei conti per danno erariale |
|
Pittelli Giancarlo |
PDL |
CAMERA |
Rinviato a giudizio per associazione a delinquere e truffa. Rinviato a giudizio per lesioni e minacce |
|
Porfidia Americo |
I RESPONSABILI EX IDV |
CAMERA |
Richiesta di rinvio a giudizio per tentata estorsione e favoreggiamento alla Camera |
|
Rizzoli De Nichilo Melania |
PDL |
CAMERA |
Indagata per concorso in falso |
|
Romano Saverio |
I RESPONSABILI EX UDC |
CAMERA |
Richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa |
|
Rutelli Francesco |
ALLEANZA PER L'ITALIA |
SENATO |
Condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti |
|
Savino Elvira |
PDL |
CAMERA |
Indagata per concorso in riciclaggio |
|
Scapagnini Umberto |
PDL |
CAMERA |
Condannato in primo grado a 4 mesi per abuso d’ufficio (nomina di un consulente) condannato in primo grado a 2 anni per abuso d’ufficio continuato e aggravato. |
|
Scelli Maurizio |
PDL |
CAMERA |
Condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 900.000 euro per irregolare acquisizione di servizi informatici ai tempi in cui era presidente della Croce Rossa |
|
Sciascia Salvatore |
PDL |
SENATO |
Condannato in via definitiva 2 anni e 6 mesi per corruzione |
|
Serafini Giancarlo |
PDL |
SENATO |
Ha patteggiato una condanna per corruzione |
|
Simeoni Giorgio |
PDL |
CAMERA |
Rinviato a giudizio per truffa |
|
Speciale Roberto |
PDL |
CAMERA |
Condannato a 18 mesi per peculato in appello |
|
Tedesco Alberto |
GRUPPO MISTO EX PD |
SENATO |
Agli arresti domiciliari, indagato per turbativa d'asta e corruzione |
|
Tortoli Roberto |
PDL |
CAMERA |
Condannato a 3 anni e 4 mesi per estorsione |
|
Verdini Denis |
PDL |
CAMERA |
Indagato per emissione fatture false e mendacio bancaria |
|
Vizzini Carlo |
PDL |
SENATO |
Indagato per corruzione aggravata dall’aver favorito la mafia. Condannato in primo grado per corruzione: prescritto |
|
Zinzi Domenico |
UDC |
CAMERA |
Condannato in primo grado per omicidio colposo |
Parlamento italiano: pomeriggio del 20 luglio 2011. Già è mortificante il fatto che in quei luoghi non si votino le leggi, ma le autorizzazioni alla custodia cautelare in carcere per alcuni dei suoi membri. Ma già li è chiaro: in Italia la legge, come l’etica e la morale, non è uguale per tutti. Se sei del centrodestra sono tutti d'accordo a sbatterti in galera, se sei del centrosinistra invece ti graziano. E' questa la triste verità che emerge dai voti che hanno spalancato le porte del carcere di Poggioreale per il deputato Pdl Alfonso Papa e hanno salvato il senatore Pd Alberto tedesco. Ed è la stessa triste verità che ispira il diverso trattamento concesso a Piergianni Prosperini, l'ex assessore lumbard finito ai domiciliari perché accusato di aver ricevuto delle tangenti per favorire un imprenditore in una gara d’appalto per la promozione di eventi in Valtellina, e Filippo Penati del Pd, capo della segreteria politica di Bersani e consigliere regionale lombardo, ex sindaco di Sesto San Giovanni e Presidente della provincia di Milano, indagato perché avrebbe preso mazzette fino a 4 miliardi di lire. Questa è la giustizia all'italiana.
"Ho dimostrato a tutti di essere un uomo, chiedendo di votare per il mio arresto. Ma ora ho il dovere di restare al mio posto, in Senato". A Tedesco non lo sfiora nemmeno l'idea di lasciare la poltrona a Palazzo Madama. Assicura che andrà avanti, puntualizza che aspetterà che la magistratura faccia il suo lavoro e fa sapere che in futuro si batterà per l'abolizione della custodia cautelare. E, mentre il senatore piddì resta in parlamento, Papa ha già passato una notte in carcere. Eppure, come spiega il vicepresidente della Camera Antonio Leone, "a carico di Tedesco sussiste un impianto accusatorio ben più pesante di quello messo insieme per Papa dai pm napoletani". Finito nell'inchiesta che ha sconvolto la sanità in Puglia, l'ex assessore di Vendola è accusato di corruzione, concussione, turbativa d’asta, abuso d’ufficio e falso. Nel mirino dei pm di Bari ci sono i presunti appalti truccati e le nomine dei vertici dell'Asl: dal 2005 al 2009 la sinistra pugliese avrebbe, infatti, imposto i primari e gli imprenditori che avrebbero poi dovuto vincere le gare d’appalto. "La prassi politica dello spoil system - si legge nell'ordinanza del gip Giuseppe de Benedictis - era talmente imperante nella sanità regionale da indurre Vendola, pur di sostenere alla nomina a direttore generale di un suo protetto, addirittura a pretendere il cambiamento della legge per superare, con una nuova legge a usum delphini, gli ostacoli che la norma frapponeva alla nomina della persona da lui fortemente voluta".
Di tutt'altro spessore le accuse rivolte a Papa, finito nell'inchiesta P4 portata avanti dai pm Henry Woodcock e Francesco Curcio della procura partenopea. I reati contestati sono: corruzione, concussione, estorsione e favoreggiamento personale. Secondo il gip di Napoli, Papa, Luigi Bisignani, Enrico La Monica e Giuseppe Nuzzo "promuovevano, costituivano e prendevano parte a una associazione per delinquere, organizzata e mantenuta in vita allo scopo di commettere un numero indeterminato di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia". Insomma, per la procura di Napoli Papa avrebbe fatto parte di "un sistema informativo parallelo" al fine di acquisire informazioni sulle indagini e usarle per avanzare "indebite pretese e indebite richieste" sugli indagati.
Per i due politici indagati sono state usate due pesi e due misure diverse. Mentre il Pdl si è dimostrato garantista con entrambi i parlamentari, a Palazzo Madama i numeri ci dicono che tutti i 34 suffragi necessari a negare i domiciliari provengono dalle fila della sinistra....
Insomma, l'opposizione ha usato, come al solito, due pesi e due misure. Proprio come viene fatto dalla magistratura. Risulta infatti emblematico le indagini che, in questi giorni, hanno investito la Lombardia. Filippo Penati ieri, Piergianni Prosperini oggi. Il capo della segreteria politica di Bersani ed ex presidente della Provincia di Milano è indagato per corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti. L'accusa è di aver preso tangenti per circa 4 miliardi di lire tra il 2001 e il 2002 per la riqualificazione di due ex aree industriali e per i servizi di trasporto dei comuni dell'Alto milanese. Un illecito che Penati avrebbe proseguito fino a dicembre dell'anno scorso. Il decreto di perquisizione firmato dai pm di Monza Walter Mapelli e Franca Macchia parla di "gravi indizi di colpevolezza", eppure su Penati non grava alcuna misura di custodia cautelare. Gli arresti domiciliari, invece, sono stati dati per la seconda volta all'ex assessore lombardo Prosperini, accusato di corruzione e false fatturazioni in relazione alle tangenti "incassate" per favorire un imprenditore in una gara d’appalto per la promozione di eventi in Valtellina.
"Il voto di ieri ha dato la conferma della doppia morale della sinistra che vota contro gli avversari politici e salva i suoi sodali". Con queste parole il viceministro Roberto Castelli ha sintetizzato il film andato in scena ieri in parlamento. "Ora si capisce perché i capigruppo Pd si sono lamentati del voto segreto: temevano giustamente che in tanti disobbedissero agli ordini - fa eco il Pdl Lucio Malan - sempre che non fosse tutta una sceneggiata finalizzata a salvare l’ex assessore alla Sanità". D'altra parte, a questo punto, è solo il leader Idv Antonio Di Pietro a chiedere a Tedesco di dimostrare un po' di coerenza e dimettersi. Il Pd tace.
Non parliamo di questione morale, per carità. Quelli lì - quelli del Pd - mica ne vogliono sentire parlare. A partire dal leader Pier Luigi Bersani che si appiglia alle querele per far passare i giornalisti come una macchina del fango messa in moto per minare la superiorità dei democratici. Perché, dal sistema di tangenti che avrebbe orchestrato Filippo Penati, dall'amministrazione della sanità pugliese targata Alberto Tedesco e dall'affaire Enac che ha fatto scattare le manette per l'ex consigliere al ministero dei Trasporti di Bersani, Franco Pronzato (tanto per fare qualche esempio, solo gli ultimi in ordine cronologico), non si evince mica che in via del Nazareno qualche problema con la giustizia esiste. Macchè! Quelli lì - quelli del Pd - sono diversi, sempre e comunque. Diversamente ladri, magari, ma diversi, dice il Giornale.
Guai a parlare di questione morale, guai a dare il nome giusto alle cose: la parola "mazzetta" è off limit. Eppure, secondo una inchiesta di Panorama, dal Piemonte alla Sicilia sono oltre cento i membri del Partito democratico finiti nelle maglie della giustizia per i reati più diversi. "Una contabilità devastante - si legge - per il partito che ha sempre affermato la propria diversità e cha fatto della questione morale il proprio cavallo di battaglia".
Vallo a spiegare al Partito democratico che i reati non sono mai diversi a seconda di chi sia a infrangere la legge, che aver votato a favore della carcerazione del pdl Alfonso Papa e contro quella di Tedesco, che a negare sempre e comunque l'esistenza di una questione morale non giova affatto al dibattito.
«Il Partito Democratico? Premetto che ormai è una vicenda estranea ai miei interessi politici perchè ho ormai preso le distanze dopo alcune reazioni assolutamente smodate». Lo dice il senatore Alberto Tedesco in un'intervista a Radio Ies in cui spara a zero su Rosy Bindi.
«La Bindi parla di carcere da sette mesi, ma la stagione del '92 che l'ha resa protagonista non tornerà più. Rosy Bindi ricevette, come reso noto in un libro di Pomicino mai smentito, un finanziamento di 50 milioni dalla corrente andreottiana, nonchè dell'appoggio di Andreotti che la fecero salire al Parlamento europeo. Era il 1989. Prima era una sconosciuta. Nonostante ciò non si fece nessuno scrupolo nel condannare Andreotti, anche prima della conclusione del procedimento».
La lettura di Panorama dell’estate 2011 sotto l’ombrellone per i vertici del Partito democratico rischia di diventare il codice etico approvato nel 2008 e in particolare l’articolo 5, quello sulle «condizioni ostative alla candidatura e obbligo di dimissioni». Infatti l’elenco di uomini del Pd coinvolti in inchieste della magistratura sembra un bollettino di guerra da aggiornare giorno per giorno.
I dirigenti di via Nazionale hanno tirato un sospiro di sollievo quando, martedì 26 luglio 2011, è arrivata l’ultima infornata di arresti in provincia di Pescara: tra i fermati anche l’ex presidente del consiglio regionale Mario Roselli e il sindaco di Spoltore, Franco Ranghelli, entrambi recentemente fuoriusciti dal Pd (Ranghelli è stato espulso). In ogni caso c’è poco da stare allegri: il 21 luglio 2011 sono stati perquisiti uffici e abitazione del vicepresidente del consiglio regionale lombardo ed ex capo della segreteria politica di Pier Luigi Bersani, Filippo Penati, nell’ambito di un’inchiesta su presunte tangenti milionarie, mentre il 28 giugno sono scattate le manette per Franco Pronzato, ex consigliere al ministero dei Trasporti di Bersani e di Claudio Burlando. In questa inchiesta i pm romani contestano le presunte mazzette pagate dagli imprenditori Viscardo e Riccardo Paganelli per agevolare il proprio lavoro in diverse regioni «rosse», dalla Toscana all’Umbria fino alle Marche. Una giaculatoria di nomi che turba i piani alti del Pd. L’ordine di scuderia è quello di dimettersi una volta colti con le mani nel sacco. Ma qualcuno resiste. O, se si dimette, viene richiamato all’ovile. Come è successo a Michele Mazzarano, ex dirigente del Pd pugliese, candidato alle elezioni comunali nella sua Massafra (Taranto), a cui il segretario regionale Sergio Blasi ha chiesto di riprendere il proprio posto. Il senatore Alberto Tedesco, invece, si è dimesso, dopo che i compagni di partito lo avevano salvato a Palazzo Madama dalla richiesta di arresto.
Esattamente 30 anni fa, il 28 luglio 1981, uno dei padri nobili del partito, Enrico Berlinguer, lanciava un anatema che oggi suona beffardo, quasi una profezia al contrario: «La questione morale, nell’Italia d’oggi, fa tutt’uno con l’occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti» disse in una celebre intervista a Repubblica, «fa tutt’uno con la guerra per bande, fa tutt’uno con la concezione politica e con i metodi di governo di costoro, che vanno semplicemente abbandonati e superati». Per l’allora segretario del Pci «ladri, corrotti, concussori delle alte sfere della politica e dell’amministrazione» andavano «scovati», «denunciati», «messi in galera».
All’epoca Massimo D’Alema era segretario pugliese dei comunisti e la sua affettuosa biografia su Wikipedia ci informa che dopo l’intervista di Berlinguer «si attestò sulla stessa posizione e cominciò una dura battaglia per impedire al Psi di fare della Puglia una solida base politica e di potere». Oggi, però, sono le marachelle dei suoi amici e sostenitori a creare il maggiore imbarazzo al Pd. Soprattutto in Puglia, dove, per esempio, è stato recentemente condannato e rinviato a giudizio l’ex sindaco di Gallipoli, quel Flavio Fasano di cui D’Alema è stato pure «compare» di nozze.
In verità le vicissitudini giudiziarie del Pd attraversano tutte le correnti e quasi tutte le regioni. Sono ormai decine, se non centinaia, i casi di malaffare o furberia di cui sono protagonisti personaggi e amministratori del partitone della sinistra. Panorama ha fatto un piccolo censimento e ha contato oltre cento casi di uomini (molti) e donne (poche) che avrebbero violato la legge e tradito gli elettori. I reati più contestati sono corruzione, abuso d’ufficio e turbativa d’asta. Non abbiamo inserito nell’elenco il presidente di circolo stupratore seriale o il killer di camorra (tra l’altro assassino e vittima erano entrambi iscritti al Pd), così come l’assessore spacciatore. Non sono stati conteggiati gli indagati per calunnia o diffamazione.
Ci siamo concentrati su corrotti e concussori (presunti o già condannati), quelli che Berlinguer voleva mandare in galera: allignano nei circoli del Pd quanto o più che in altri partiti. Un fenomeno che, come dimostra l’inchiesta di Panorama, è particolarmente allarmante al Sud, dalla Campania alla Puglia, passando per Calabria e Sicilia, tutte regioni dove il Pd governa o ha governato. Qui hanno problemi con la giustizia molti big del Pd dall’ex governatore calabrese Agazio Loiero, agli ex sindaci di Napoli Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino, alla sbarra per la cattiva gestione dell’emergenza rifiuti.
Iniziano a preoccupare anche le regioni del cosiddetto «buongoverno», dalla Toscana all’Emilia-Romagna, all’Umbria. Qui la politica sembra diventata un ufficio di collocamento, come dimostra l’indagine condotta a Perugia dal pm Sergio Sottani, che da mesi scava sul voto di scambio e su gare d’appalto. In questo fascicolo è stata iscritta sul registro degli indagati l’ex presidente della regione Maria Rita Lorenzetti, attuale presidente di una partecipata delle Ferrovie dello Stato, accusata di abuso d’ufficio. Per la procura avrebbe tenuto in caldo un posto da quadro di settimo livello in una asl perugina per la sua ex capogabinetto. Che in un’intercettazione si lamentava del possibile ritorno al vecchio posto di lavoro: «Con 1.500 euro al mese poi non so cosa mangiare». Più o meno lo stipendio di una buona fetta degli elettori del Pd.
Il virus della corruzione sembrerebbe meno diffuso al Nord, però qui il Pd è spesso all’opposizione, mentre dove amministra, per esempio in Liguria, i problemi non mancano. Ora l’inchiesta della procura di Monza su Penati sembra aprire una pericolosa voragine. E comunque i rapporti tra politica e affari sono sempre più evidenti. Una stagione inaugurata da D’Alema premier con quella che l’economista Guido Rossi battezzò la «merchant bank» di Palazzo Chigi. L’ex premier sostenne la scalata alla Telecom di Roberto Colaninno e prese una sbandata per la razza padana di Emilio Gnutti, poi condannato per insider trading.
Anche Gianpiero Fiorani e Stefano Ricucci, prima dei guai giudiziari, ebbero rapporti e interessi convergenti con gli allora Ds. Nel 2007 i giornali pubblicarono le telefonate trionfanti registrate dai finanzieri due anni prima di Piero Fassino e D’Alema con Giovanni Consorte, ex presidente Unipol impegnato nella conquista della Bnl. «Abbiamo una banca!», «Facci sognare!» esultavano i due politici al telefono. Il gip milanese Clementina Forleo, che voleva approfondire quei rapporti e utilizzare le intercettazioni, venne costretta a fare i bagagli e a trasferirsi in un altro tribunale. Ma questo non è bastato a evitare problemi a molti finanzieri rossi, compagni di cene e di barca di svariati politici del Pd: sono finiti nei guai lo stesso Consorte, condannato a 3 anni per aggiotaggio, e Vittorio Casale, immobiliarista arrestato a giugno per bancarotta fraudolenta, Piero Collina, potente presidente del Consorzio cooperative costruttori indagato per corruzione a Bologna, come Vincenzo Morichini, intermediario di affari, procacciatore di finanziamenti per la fondazione Italianieuropei di D’Alema; Giovanni Errani, fratello del presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco, è finito invece sotto inchiesta per finanziamento illecito ai partiti con la sua cooperativa.
Con questi esempi non deve essere facile per quadri e amministratori del partito stare a guardare senza approfittare. Come dimostra la nostra inchiesta. E chissà se oggi Berlinguer si iscriverebbe al Pd.
L’elenco pubblicato da Panorama è aggiornato al 2011.
Legenda:
P patteggiamento o condannato
A arrestato
I indagato
R rinviato a giudizio o imputato
Piemonte 8
A P Bartolomeo Valentino ex assessore di Collegno (Torino): 2 anni per concussione.
P Antonio Tenace assessore della Provincia di Novara: 2 mesi e 20 giorni per violazione del segreto d’ufficio.
R Michele Cressano consigliere comunale a Vercelli: falso ideologico e abuso d’ufficio.
P Giusi La Ganga candidato alle ultime elezioni comunali del Pd: 20 mesi di reclusione e multa di 500 milioni di lire per finanziamento illecito ai partiti.
I Giuseppe Catizone sindaco di Nichelino: abuso edilizio.
R Andrea Oddone sindaco di Ovada: omicidio colposo.
I Franco De Amicis ex segretario Pd Basso Canavese: bancarotta fraudolenta.
Liguria 8
A Franco Pronzato ex consigliere di Claudio Burlando e Bersani: corruzione.
A Franco Bonanini presidente del Parco delle Cinque Terre e parlamentare europeo: truffa e associazione a delinquere.
A Roberto Drocchi funzionario, ex candidato di Savona: truffa continuata e falso in atti pubblici.
I Vito Vattuone consigliere regionale: associazione per delinquere, corruzione e altri reati.
I Giancarlo Cassini assessore regionale all’Agricoltura: associazione a delinquere, corruzione e altri reati.
P Massimo Casagrande ex consigliere comunale di Genova: 1 anno e 6 mesi per corruzione.
P Claudio Fedrazzoni ex consigliere comunale di Genova: 1 anno e 6 mesi per turbativa d’asta.
P Stefano Francesca ex portavoce del sindaco di Genova: 1 anno e 4 mesi per corruzione.
Lombardia 2
I Filippo Penati ex presidente della Provincia di Milano: corruzione, concussione e finanziamento illecito.
A Tiziano Butturini ex sindaco di Trezzano sul Naviglio: 2 anni e 5 mesi per corruzione.
Emilia-Romagna 9
I Luigi Ralenti sindaco di Serramazzoni (Modena): corruzione e turbativa d’asta.
I Alberto Caldana ex assessore della Provincia di Modena: peculato.
P I Flavio Delbono ex sindaco di Bologna: 1 anno e 7 mesi per truffa aggravata, peculato, intralcio alla giustizia.
I Alberto Ravaioli sindaco di Rimini: abuso d’ufficio.
I Aldo Preda, ex senatore, Cinzia Ghirardelli, membro coordinamento provinciale, Cesare Marucci, ex consigliere comunale di Ravenna, Gianluca Dradi ex assessore di Ravenna: tutti per falso in bilancio.
I Nerio Marchesini attivista: trasferimento fraudolento di valori di una ‘ndrina calabrese.
Toscana 15
R Alberto Formigli ex capogruppo in comune a Firenze: associazione per delinquere, corruzione e altri reati.
R Salvatore Scino vicepresidente del consiglio comunale: falso ideologico.
I Andrea Vignini sindaco di Cortona (Arezzo): abuso d’ufficio.
I Graziano Cioni ex assessore di Firenze: corruzione e violenza privata.
I Gianni Biagi ex assessore all’Urbanistica di Firenze: corruzione.
I Gianluca Parrini consigliere regionale: abuso d’ufficio.
I Gian Piero Luchi ex sindaco di Barberino del Mugello: abuso d’ufficio.
I Alberto Lotti ex vicesindaco di Barberino del Mugello: corruzione e abuso d’ufficio.
I Paolo Cocchi ex assessore regionale: abuso d’ufficio.
I Daniele Giovannini ex assessore comunale di Barberino del Mugello: abuso d’ufficio.
I Giovanni Guerrisi consigliere comunale di Barberino del Mugello: falso ideologico.
I Marzio Flavio Morini sindaco di Scansano (Grosseto): corruzione.
I Fabrizio Agnorelli sindaco di Piancastagnaio (Siena): truffa aggravata e falso.
R Fabrizio Neri ex sindaco di Massa-Carrara: abuso d’ufficio.
I Antonella Chiavacci ex sindaco di Montespertoli: omissione di controllo.
Umbria 7
I Eros Brega presidente del consiglio regionale: peculato e concussione.
I Maria Rita Lorenzetti ex presidente della regione: abuso d’ufficio.
I Maurizio Rosi ex assessore regionale alla Sanità: abuso d’ufficio.
I Luca Barberini consigliere regionale: peculato.
I Nando Misnetti sindaco di Foligno: peculato.
I Sandra Santoni ex capo di gabinetto di Lorenzetti: peculato.
R Giacomo Porrazzini ex sindaco di Terni ed ex deputato europeo: disastro ambientale e truffa.
Marche 1
P Fabio Sturani ex sindaco di Ancona: 1 anno e 9 mesi e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per concussione.
Puglia 7
P Domenico Gatti sindaco di Modugno (Bari): falso ideologico.
I Alberto Tedesco senatore: associazione per delinquere, corruzione, concussione, turbativa d’asta, abuso d’ufficio e falso.
I Michele Mazzarano ex segretario organizzativo del partito: finanziamento illecito ai partiti.
R P Flavio Fasano ex sindaco di Gallipoli (Lecce) ed ex assessore provinciale ai Lavori pubblici: 2 anni per falso e rinviato a giudizio per turbativa d’asta.
A I Sandro Frisullo ex vicepresidente della regione: associazione a delinquere e turbativa d’asta.
I Antonio De Caro capogruppo al consiglio regionale ed ex assessore di Bari alla Mobilità e al traffico: tentativo d’abuso d’ufficio.
I Adolfo Schiraldi ex presidente consiglio comunale di Triggiano (Bari): concussione.
Calabria 4
R I Agazio Loiero ex governatore regionale: associazione per delinquere, falso e abuso d’ufficio e imputato per abuso d’ufficio.
R Nicola Adamo ex vicepresidente della giunta regionale: associazione per delinquere, falso e abuso d’ufficio e imputato per associazione per delinquere, concussione, abuso d’ufficio.
A I Pietro Ruffolo assessore comunale di Cosenza: associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio, e arrestato per detenzione abusiva d’armi.
Veneto 2
P Statis Tsuroplis imprenditore iscritto al partito ed ex consigliere del sindaco di Venezia: 1 anno e 9 mesi per corruzione.
P Tullio Cambruzzi, tesserato pd e manager pubblico: corruzione, ha patteggiato 2 anni.
Lazio 5
Piero Marrazzo ex presidente della regione dimessosi dopo una vicenda di cocaina e trans.
R Francesco Paolo Posa ex sindaco di Frascati e consigliere provinciale: truffa, falso e indebita percezione di erogazioni pubbliche.
I Guido Milana eurodeputato ed ex presidente del consiglio regionale: truffa, falso e indebita percezione di erogazioni pubbliche.
I Ruggero Ruggeri consigliere provinciale: truffa, falso e indebita percezione di erogazioni pubbliche.
R Valdo Napoli ex assessore all’Ambiente di Montefiascone: corruzione.
Campania 13
R I Antonio Bassolino ex presidente della regione: epidemia colposa e omissione d’atti d’ufficio, sotto processo per truffa aggravata ai danni dello Stato e frodi in pubbliche forniture e per peculato.
I Rosa Russo Iervolino ex sindaco di Napoli: epidemia colposa e omissione in atti d’ufficio.
I Andrea Lettieri ex sindaco di Gricignano d’Aversa (Caserta): concorso esterno in associazione mafiosa.
I R Vincenzo De Luca ex senatore e sindaco di Salerno: abuso d’ufficio, concussione, associazione per delinquere finalizzata a truffa e falso.
P Corrado Gabriele consigliere regionale ed ex assessore regionale: 4 anni e 3 mesi per pedofilia.
A R Aniello Cimitile presidente della Provincia di Benevento: falso.
I Enrico Fabozzi sindaco Villa Literno: concorso esterno in associazione mafiosa.
A I Fabio Solano componente direttivo cittadino pd di Benevento: truffa.
I Giuseppe Russo cons. regionale: truffa. Carlo Nastelli ex consigliere comunale di Castellammare: tentata estorsione.
R Carlo Nastelli, Nino Longobardi, Antonio Cinque ex consiglieri comunali di Castellammare di Stabia: truffa ai danni dello Stato e concorso in falso.
Sardegna 3
I Renato Soru, ex presidente regione, consigliere regionale e membro della segreteria nazionale: aggiotaggio, assolto in primo grado per abuso d’ufficio e turbativa d’asta.
P Graziano Milia presidente Provincia di Cagliari: 1 anno e 4 mesi per abuso d’ufficio.
I Roberto Deriu, presidente Provincia di Nuoro: abuso d’ufficio.
Abruzzo 7
R Ottaviano Del Turco ex presidente della regione: associazione per delinquere, concussione, corruzione e altri reati.
R Antonio Boschetti ex assessore regionale alle Attività produttive: associazione per delinquere, concussione e altri reati.
R Bernardo Mazzocca ex assessore regionale alla Sanità. associazione per delinquere, concussione e abuso d’ufficio.
R Camillo Cesarone ex capogruppo alla regione: associazione per delinquere, concussione e corruzione.
P Luciano D’Alfonso ex sindaco di Pescara: 4 mesi per abuso d’ufficio.
I Massimo Cialente sindaco dell’Aquila: rifiuto in atti d’ufficio.
I Fabio Ranieri consigliere comunale dell’Aquila: truffa.
Basilicata 4
I Franco Stella presidente Provincia Matera: indagato per abuso d’ufficio.
R Prospero De Franchi ex presidente del consiglio regionale: rinviato a giudizio per falso e truffa.
R Pasquale Robortella consigliere regionale e sindaco di San Martino d’Agri: rinviato a giudizio per truffa ai danni dell’Ue.
I Nicola Montesano consigliere comunale di Policoro (Matera): indagato per falso e turbativa d’asta.
Sicilia 7
A Gaspare Vitrano deputato regionale: concussione.
I Elio Galvagno consigliere regionale: falso in bilancio.
I Salvatore Termine consigliere regionale: falso in bilancio.
I Vladimiro Crisafulli senatore: falso in bilancio, rinviato a giudizio per abuso d’ufficio.
I Giuseppe Picciolo deputato regionale: calunnia.
P Vittorio Gambino funzionario: falso in atto pubblico.
P Giuseppe Palermo funzionario: falso in atto pubblico.
Furti ovunque. Anche in Parlamento che, da quanto si è saputo, non è affatto un luogo sicuro. Anzi! L'ultimo furto ha dell'incredibile. E' l'ex deputata Elisa Pozza Tasca a denunciare la scomparsa della sua pelliccia di visone da seimila euro. Lo scrive il quotidiano La Stampa del 13 dicembre 2008.
Già nel 2003 Pierferdinando Casini decise di fare incatenare gli oltre duemila computer per evitare sparizioni. Nel 2008 sono 26 i furti denunciati avvenuti all'interno del Palazzo. Un giornalista ricorda che gli è bastato dimenticare il telefonino in bagno per 5 minuti e questo aveva già preso il volo. Andò a denunciare il furto alla polizia interna e la risposta dell'agente fu: "Dottò, neanche quando stavo alla narcotici ho visto le cose che vedo qua".
Vittime dei topi del Palazzo furono anche Paolo Buonaiuti e gli uffici dell'Udc. Quanto alle telecamere nel Palazzo questa possibilità è sempre stata respinta dagli onorevoli per motivi di privacy. Incredibile ma vero, il risarcimento per loro esiste sempre. Sono 600 euro che vengono corrisposti sulla parola. E così le denunce sono sempre di più.
A questo punto mi pare che il titolo di “LIBERO” sia già abbastanza chiaro: Onorevoli ladri e drogati. L’editoriale di Vittorio Feltri del 14 dicembre 2008 è una sciabolata al sistema. “Poi ci aspettiamo una sana amministrazione. Bella pretesa. – dice Feltri - In un Parlamento in cui si annidano tossicodipendenti e furfanti di mano lesta è del tutto normale non succeda niente di buono. Come è normale che nel Paese, di conseguenza, si coltivino la diffidenza nei confronti del Palazzo e addirittura l’antipolitica. Circa un anno fa i reporter delle Iene, programma televisivo berlusconiano e di successo, ricorrendo a mezzucci e sotterfugi riuscirono a dimostrare (inequivocabilmente) la tendenza dei deputati a usare ed abusare di sostanze stupefacenti. Stupefacenti almeno quanto le reazioni dei medesimi deputati i quali la misero giù tanto dura (sollevando polemiche sul fatto di essere stati “spiati” e colti col naso nella polverina) da costringere l’emittente a non mandare in onda il servizio galeotto in cui, tra l’altro, si dimostrava - attraverso le risposte (...) (...) a onorevoli quiz - l’ignoranza abissale dei cosiddetti rappresentanti del popolo. L’ex presidente Casini fu l’unico leader eccentrico rispetto alla bolgia conformistica: organizzò, per chi avesse voluto sottoporvisi, un esame anticoca a Montecitorio. Risultato, la maggioranza qualificata dell’assemblea (oltre il 75 per cento) ignorò la provocazione evitando con cura di farsi analizzare.”
"La compravendita di parlamentari non è solo uno scandalo, ma si può pensare anche ad un reato di corruzione". Il segretario del Pd Pier Luigi Bersani lancia l'allarme sulle "grandi manovre" in vista del voto di fiducia del 14 dicembre 2010, ma ha la memoria corta. Innanzitutto, perché il trasformismo e il cambio di casacca sono pratiche vecchie quanto la politica. Secondo, perché negli ultimi 15 anni i governi del centrosinistra sono sempre stati appesi, nel bene e nel male, alla transumanza di un pugno di onorevoli.
Nell'inverno 2007, con il secondo governo Prodi alla canna del gas, la maggioranza accoglie a braccia aperte il prezzemolino Clemente Mastella, buono per tutte le stagioni (e i colori). Come ammise il portavoce dell'allora premier, Silvio Sircana, il lider maximo di Ceppaloni prometteva ogni giorno l'arrivo di altri rinforzi dal centrodestra. Alla fine, però, andò male all'Ulivo: nel 2008, al momento della fiducia, Mastella tornò a destra. L'unico dell'Udeur a rimanere fedele all'ex avversario Prodi fu Cusumano, insultato da molti colleghi. Il pendolino per eccellenza però fu Sergio De Gregorio, passato da Berlusconi a Di Pietro e di nuovo a Berlusconi. Più "idealista" il passaggio dall'Udc alla maggioranza di Marco Follini, che in realtà non spostò gli equilibri e ricevette ben poco in cambio.
Il "meglio", però, si registrò nel 2006, nelle settimane di fuoco in cui il nascente governo Prodi, cercava il sì del Parlamento nonostante numeri risicatissimi. I bocconi più ambiti erano i senatori eletti all'estero. L'"argentino" Luigi Pallaro era corteggiato sia dal Professore sia dal Cavaliere. Entrambi, in caso di sostegno, gli avevano promesso un Dicastero. Il buon Pallaro finì per fare il... battitore libero. Né con la destra, né con la sinistra, molto spesso malato in infermeria se non addirittura in Sudamerica, come il giorno della fiducia.
La sinistra, però, non può dimenticare quello che accadde nel 1999. Il primo governo Prodi era appena caduto e Massimo D'Alema stava lavorando per sedere a Palazzo Chigi. Una mano gliela diede, ancora una volta, il... clemente Mastella: in accordo con Cossiga, formò l'Udr e si spostò a sinistra. Dalla Casa delle Libertà via agli insulti: da "truffatori" al celebre "puttani" rifilato da Gianfranco Fini ai centristi. Qualcuno, poi, tradì il Baffo ex Pci e lui se la prese. "E' proprio grazie al trasformismo se sei diventato premier", lo rimbrottò il picconatore Cossiga. A quell'episodio si riferisce Fabrizio Cicchitto, presidente dei deputati Pdl, criticando l'uscita di Bersani: "Repubblica e il Pd dimenticano che il più grande spostamento di parlamentari è avvenuto quando, per dar vita al governo D'Alema circa 30 parlamentari si spostarono dal centro destra al centro sinistra. Allora nessuno parlò di compravendita. Il centro sinistra non è abilitato a dare lezioni di alcun tipo".
Intanto Antonio Di Pietro ha annunciato di aver "messo alcuni elementi a disposizione della magistratura" circa il cambio di partito di alcuni deputati in vista del 14. Secondo il leader dell'Italia dei Valori, gli elementi riguardano "trasversalmente diverse situazioni". Il fondatore dell'Idv ha affermato che "quando c'è un atto corruttivo i soggetti sono due, chi prende e chi dà, invogliando e imponendo, facendo capire all’altro: 'ho qualcosa su di te'". Di Pietro commenta anche il passaggio di Razzi a Noi Sud: "Spero che l'abbia fatto per una soddisfazione personale e non per un ricatto subìto..Dio abbia pietà di lui". Lo stesso vale per Domenico Scilipoti (IDV), Massimo Calearo e Bruno Cesario (PD), e chissà quanti altri ancora.
“Il giornale” del 25 giugno 2009 riporta una notizia. C’è un’inchiesta, a Bari, che anziché restare riservata finisce sui giornali perché riguarda indirettamente un premier e/o persone a lui vicine presumibilmente in contatto con alcune prostitute. E c’è un’altra inchiesta, a Roma, che invece resta «sconosciuta» per quasi dieci anni e che riguarda l’entourage di un altro premier in contatto sicuramente con una scuderia di prostitute d’alto bordo. Il doppiopesismo mediatico-giudiziario cui si fa riferimento concerne un’inchiesta avviata nel 1999 dal pm capitolino Felicetta Marinelli e conclusasi il 4 ottobre 2000 con il patteggiamento a un anno della maîtresse R.F. che secondo l’accusa inviava sue «squillo» ai fedelissimi dell’allora presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, per ottenere ritorni economici di vario genere.
A giocar troppo col fuoco si rischia di rimaner bruciati: quelli che a sinistra puntavano il dito contro Silvio Berlusconi storcendo il naso per la “politica priva di morale” del Cavaliere, avrebbero dovuto ricordarlo questo proverbio della saggezza popolare. Perché il ritornello si è ritorto contro.
L’inchiesta pugliese alla base della “scossa di Bari” si è, infatti, allargata con nuove “ragazze” pronte a testimoniare e nuovi festini: incredibilmente non più solo a Palazzo Grazioli, come preferirebbero quelli del partito del dito puntato, ma anche a Cortina, Milano e nella stessa Bari. Festini che coinvolgerebbero numerosi altri nomi noti fra imprenditori, professionisti e politici, fra cui - appunto - alcuni esponenti baresi del PD.
Articolo che parla di prostitute d’alto bordo coinvolte con uomini importanti e di ingressi “confidenziali” alla Camera dei Deputati, che non ha reso per nulla contento l’ex Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, che ha dato mandato ai suoi legali di querelare il quotidiano. In quell’articolo viene tirato in ballo anche l’on. Cesa dell’UDC.
In relazione alla querela annunciata dall’On. Massimo D’Alema e dall’onorevole Lorenzo Cesa, Il Giornale ribadisce che la notizia pubblicata si fonda su un dato di fatto incontrovertibile: Cesa era socio, nella Global Media Srl, di R.F., la maitresse che aveva organizzato un giro di squillo per ottenere favori da un gran numero di politici, tra i quali alcuni stretti collaboratori di Massimo D’Alema. In quella società Cesa era intestatario di quote per 11 milioni, R.F per otto.
Inutile dirlo: la Rete ha buona memoria.
Correva l’anno 1994. Il pubblico ministero pugliese, Alberto Maritati, stava indagando su un finanziamento illecito erogato - tramite assegno - dal patron delle Cliniche Riunite di Bari a Massimo D'alema.
Nel giugno del 1995, quel processo fu archiviato per decorrenza dei termini di prescrizione, su richiesta dello stesso pm Maritati. Il gip Concetta Russi, con queste parole dispose l’archiviazione: “Uno degli episodi di illecito finanziamento riferiti, e cioè la corresponsione di un contributo di 20 milioni in favore del Pci, ha trovato sostanziale conferma, pur nella diversità di alcuni elementi marginali, nella leale dichiarazione dell’onorevole D’Alema, all’epoca dei fatti segretario regionale del Pci. Con riferimento all’episodio riguardante l’illecito finanziamento al Pci, l’onorevole D’Alema non ha escluso che la somma versata dal Cavallari fosse stata proprio dell’importo da quest’ultimo indicato”.
D’Alema, dunque, confessò di aver percepito un finanziamento illecito per il Partito comunista. E tuttavia, non venne condannato e non finì in gattabuia grazie alla prescrizione del reato da lui compiuto. Destino diverso toccò agli indagati di Di Pietro.
Va aggiunto, inoltre, che il pubblico ministero di questo processo, Alberto Maritati, fu candidato - per volontà di D’Alema - alle elezioni suppletive del giugno 1999 (si era liberato un seggio senatoriale, dopo la morte di Antonio Lisi). E divenne sottosegretario all’Interno del governo presieduto dallo stesso D’Alema. Ancora oggi, Maritati, siede al Senato nelle fila del Partito democratico. Dalle mie parti si dice: una parola è poca, e due sono troppe.
Sulla moralità e l’onestà dei candidati al Parlamento dell’elezione 13 aprile 2008, con prefazione “condannati, prescritti, indagati, imputati e rinviati a giudizio”, si è scritto un libro.
Esso è intitolato “Se li conosci li eviti” di Marco Travaglio e Peter Gomez.
Da quelle pagine, con attenta analisi si è fatto un elenco di “Impresentabili”, così come li ha definiti un’inchiesta dell’Espresso: Popolo delle Libertà (56); Partito democratico (18); Lega Nord (8); Udc-Rosa Bianca (9); Partito Socialista (3); Sinistra Arcobaleno (3); La Destra (2).
Da qui sarebbe dovuto nascere lo scandalo contro una politica a conduzione aziendale e contro candidature di gente che rappresenta solo il dominus.
Invece, era palese l’intento giustizialista del partito dei giudici, che con utopia crede nella “giustizia giusta” in una Italia dove tutto è truccato.
La finalità è il creare una democrazia con l’adozione della mannaia delle sentenze politicizzate, usate contro gli avversari politici e risaltate da una informazione foraggiata dalla politica e dalla finanza.
Peccato che l’inchiesta di Travaglio abbia volutamente omesso i riferimenti all’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro e alcuni dei suoi fedelissimi, sia in ambito di inchieste, sia in ambito di conflitto di interessi. Non solo. Dalle cronache dei giornali, secondo i canoni rappresentati dal libro di Travaglio e Gomez, risultano impresentabili al Parlamento lo stesso Travaglio, Grillo e Santoro (tutti condannati) e lo stesso Antonio Di Pietro, di cui Travaglio, ricorda "i 54 procedimenti a carico”, escluso l’ultimo di Roma attinente l’amministrazione del partito. Procedimenti i cui giudici erano suoi ex colleghi.
Già dal gennaio 2003 il Presidente dell'Associazione Contro Tutte le Mafie, dr Antonio Giangrande, in una semideserta ed indifferente assemblea dell'IDV a Bari, in presenza di Antonio Di Pietro e di Carlo Madaro (il giudice del caso Di Bella) criticò il modo di fare nell'IDV. L'allora vice presidente provinciale di Taranto contestò alcuni punti, che furono causa del suo abbandono: Diritto di parola in pubblico e strategie politiche esclusiva di Di Pietro; dirigenti "Yes-man" scelti dal padre-padrone senza cultura politica, o transfughi da altri partiti, o addirittura con troppa scaltrezza politica, spesso allocati in territori non di competenza (in Puglia nominato commissario il lucano Felice Bellisario); IDV presentato come partito della legalità-moralità in realtà era ed è il partito dei magistrati, anche di quelli che delinquono impunemente; finanziamenti pubblici mai arrivati alla base.
2015. I portaborse: "Siamo sfruttati e umiliati". Intanto l’onorevole fa la cresta sul rimborso. Collaboratori costretti a pagare le bollette. Altri inquadrati come colf per pagare meno contributi. Malgrado i parlamentari ricevano oltre 3500 euro al mese per regolarizzarli. E adesso gli assistenti chiedono di modificare la normativa. Per una maggiore trasparenza nell’uso dei soldi pubblici, scrive Paolo Fantauzzi su “L’Espresso”. Marta tutte le mattine varca l’ingresso della Camera dei deputati. Consegna la sua carta d’identità e riceve il badge di “ospite”. In realtà sarebbe una collaboratrice parlamentare a tutti gli effetti. Una portaborse, insomma. Per l’onorevole con cui lavora scrive discorsi, comunicati e prepara le interrogazioni. Ma lui non ne ha voluto sapere: troppi contributi da pagare. E così Marta si è dovuta piegare e ha firmato un contratto da colf, che prevede invece oneri fiscali e previdenziali bassissimi. Collaboratrice sì, ma familiare. E per andare al lavoro, nel tempio della democrazia, deve sottoporsi quotidianamente all’umiliazione della finta visitatrice accreditata come ospite. Nel luogo in cui si fanno le leggi Marta (il nome è di fantasia) è in buona compagnia: sia alla Camera che al Senato sono diverse le ragazze, tutte laureate come lei, formalmente assunte con un contratto da donna delle pulizie. Eppure i loro datori di lavoro ricevono in busta paga un apposito “rimborso delle spese per l’esercizio del mandato parlamentare” (quindi esentasse) con cui pagare i collaboratori, oltre che gestire l’ufficio e affidare consulenze e ricerche. Non si tratta di spiccioli: 3.690 euro al mese per i deputati e addirittura 4.190 per un senatore. Moltiplicando per il totale degli eletti, fanno 44 milioni l’anno. E il bello è che per avere diritto a queste somme basta rendicontare metà delle spese, il resto viene erogato forfettariamente. Insomma, come nel caso del finanziamento pubblico ai partiti formalmente abolito ma di fatto reintrodotto con un altro nome - si tratta di rimborsi di nome ma non di fatto. Ma proprio per questo l’onorevole con cui lavora Marta si comporta così: perché tutto quello che risparmia, se lo può mettere in tasca. Ed è grazie a questo perverso meccanismo che, nel tempio dove si fanno le leggi, ancora accade che i portaborse siano lavoratori in nero, inquadrati con finti contratti a progetto o pagati con stipendi da fame. Nel 2012 un’inchiesta dell’Espresso fece luce sul modo in cui venivano spesi questi soldi extra e scoprì tanti “furbetti” che facevano la cresta su questi fondi. Oggi non molto sembra essere cambiato, come racconta Andrea (nome di fantasia), che alla soglia dei 40 anni lavora per un parlamentare dell’opposizione a 600 euro al mese: «Pago regolarmente le sue bollette ma mi è anche capitato di andare a ritirare pacchi natalizi che gli avevano spedito. E non è nemmeno il peggio che possa capitare. Un collega è costretto a fare la spesa per la deputata che lo ha assunto e un altro ha perfino presentato delle pratiche di invalidità, come se fosse un’agenzia di servizi». Adesso qualcosa forse si muove. Stanchi di questa situazione, i collaboratori parlamentari si sono riuniti in associazione (Aicp, un’ottantina gli aderenti) e hanno deciso di uscire allo scoperto, chiedendo espressamente una modifica della normativa. Così da tutelare il loro lavoro, spesso indispensabile all’attività legislativa degli onorevoli, e far gestire in maniera trasparente i soldi pubblici. «Non abbiamo modo neppure di sapere quanti siamo esattamente» spiega Francesca Petrini, portavoce dell’Aicp al Senato: «Per far rilasciare ai loro assistenti il badge per l’accesso a Montecitorio o Palazzo Madama, i parlamentari devono depositare i contratti. Ma gli uffici di Questura, formalmente per motivi di privacy, non ci hanno mai voluto dare il numero preciso». Il modello vagheggiato è quello del Parlamento europeo: un contratto con maternità, ferie, contributi previdenziali pagati e livelli retributivi rispettosi delle mansioni svolte. Senza più dover dipendere dalla magnanimità del politico di turno né doversi ridurre a fare i collaboratori familiari, più che parlamentari. La soluzione sarebbe semplice: l’onorevole indica il collaboratore da contrattualizzare ma a pagare sono direttamente Camera e Senato. Risultato: niente più cresta né abusi. Soprattutto, senza spendere un euro in più di quanto avviene nella giungla attuale perché basterebbe prevedere come soglia massima lorda quella già attualmente erogata sotto forma di rimborso. Ci vorrebbe anche poco, fra l’altro, in virtù dell’autonomia che i due rami del Parlamento rivendicano ogni vota che si tratta di toccare qualche privilegio: una delibera degli Uffici di presidenza, come accaduto con la revoca dei vitalizi ai condannati . Del resto l’Italia, al contrario di Francia e Regno Unito, è l’unico Paese dove vige ancora il far west: per gli assistenti non è previsto alcun nessun riconoscimento giuridico, nessuna voce di spesa specifica o vincolata, controlli solo formali e in particolar modo zero trasparenza. Facile immaginare, però, che le resistenze sono fortissime, perché quei soldi extra fanno comodo a tutti: a chi se li mette in tasca così come a chi li versa ai partiti di appartenenza, a corto di risorse col taglio dei contributi pubblici (che finiranno definitivamente nel 2017). Non a caso il Parlamento sta facendo di tutto per non muovere un dito. Nel 2012 a Montecitorio fu approvata una proposta di legge che cercava di mettere ordine, ma a causa delle elezioni anticipate il provvedimento non è stato ratificato dal Senato. Nel 2013, con la nuova legislatura, si è deciso di seguire la strada degli ordini del giorno in occasione dell’approvazione dei bilanci. Ne sono stati approvati addirittura 4 per “disciplinare tempestivamente” la materia ma sono rimasti tutti lettera morta. Stessa scena l’estate scorsa al Senato, dove è stato approvato un generico odg della maggioranza per “valutare ulteriori misure idonee a disciplinare in modo trasparente il rapporto coi collaboratori”. Ma la valutazione evidentemente è ancora in corso…
Da “L’Espresso” viene un colpo al moralizzatore per antonomasia e per il suo partito di riferimento. Noi sfruttati di Montecitorio. Portaborse vessati: ecco i casi di chi ha deciso di ribellarsi ai politici. Superlavoro, orari impossibili, vessazioni, pagamenti in nero. A volte il difficile rapporto tra parlamentari e portaborse finisce in liti fragorose sbarcando anche in tribunale. E' il caso di Liliana, addetta stampa di Francesco Barbato, il deputato-anticasta dell'Idv, famoso per avere registrato in aula le confessioni del collega Antonio Razzi. Liliana, licenziata l'estate 2011 per "carenza di attività politica", è riuscita alla fine a chiudere la questione con una transazione privata prima che l'intera faccenda finisse davanti al giudice del lavoro. Anche Vincenzo Pirillo, collaboratore di Domenico Scilipoti (ex Idv, ora nei Responsabili), "stufo di essere sfruttato", ha minacciato di recente di trascinare il suo parlamentare in tribunale. "Per un anno ho lavorato dalle nove del mattino alle undici di sera, sabato compreso", ha raccontato. "E la domenica c'erano i convegni e i comizi in Sicilia, senza pernottamento né rimborso spese. Prendevo 600 euro al mese, versati quasi sempre con assegno bancario firmato dal deputato e motivati come pagamento di contratti a progetto". Altro parlamentare balzato agli onori della cronaca, Antonio Razzi: anche lui ex Idv, anche lui come il suo amico Scilipoti pesantemente accusato dal proprio ex assistente. Massimo Pillera, ora giornalista a Trani, ha infatti chiesto al suo ex assistito Razzi (che respinge gli addebiti) la bella somma di centomila euro. A motivare la richiesta di rimborso e indennizzo, Pillera ha portato oltre 2 anni di lavoro in nero (dal 2006 al 2008), pagato in contanti sotto forma di rimborsi spese forfettari bimestrali: "Ho girato in lungo e in largo con Razzi", rivela, "ho lavorato sette giorni su sette, sempre con la promessa che nel 2008, dopo la sua rielezione nel partito di Di Pietro, sarebbe arrivato anche il contratto regolare". Invece, niente. A trionfare in tribunale è stata invece l'ex assistente di Gabriella Carlucci, deputata del Pdl da poco transitata nell'Udc, che dalla parlamentare ha ottenuto circa 10 mila euro a titolo di indennizzo. Lezione servita: la Carlucci ha adesso alle sue dipendenze due collaboratori in piena regola, con contratto a orario e paga concordati. Ancora peggio potrebbe andare a Giuseppe Lumia, senatore del partito democratico, che si è visto citato da un suo ex collaboratore, Davide Romano, al tribunale del lavoro di Palermo. Astronomica la richiesta di indennizzo chiesta all'ex presidente della commissione antimafia: 368 mila euro per 8 anni di mancate retribuzioni, per i danni morali e materiali e per i contributi non versati.
Ma non è nulla rispetto al filmato de “Le Iene” trasmesso il 9 febbraio 2012 nei confronti di Barbato. L’Onorevole Francesco Barbato dell’Italia dei Valori è diventato un moralizzatore della Casta con la sua microcamera all’interno del Parlamento, anche lui però ha la sua carcassa nell’armadio. Una affare risalente al 2009 in cui la sua collaboratrice ha denunciato di essere stata pagata in nero. Barbato ha certo un atteggiamento difforme nei confronti di Liliana. C’è stata un tira e molla finito con un accordo tra le parti in cui Barbato ha pagato diverse migliaia di Euro all’assistente Liliana con obbligo di discrezione e riservatezza tra le parti. Barbato cambia discorso all'insistenza incalzante di Filippo Roma.
Di Barbato si occupò la denuncia su “Il Giornale”: "Io, pagata in nero dai dipietristi". La denuncia di Liliana, collaboratrice del deputato Barbato: "Promise un contratto dopo un periodo di prova. Invece mi ha lasciata a casa. Metteva i soldi in una busta della Camera, senza buoni pasto né assicurazione". La replica: "Era un test andato male".
«Eeeh, mo’ non mi servi, non tengo molto da fare, è estate...». Clic. Fine della chiamata. Fine di un rapporto professionale, seppure coi contorni in chiaroscuro del lavoro nero. Il «principale» in questione, che scarica così il suo dipendente, è il deputato dell’Italia dei Valori Francesco Barbato, un tempo tra i più vicini ad Antonio Di Pietro, sempre tra i più attivi nel condannare la Casta e nel «rappresentare veramente le esigenze dei cittadini», come rivendica spesso in Aula; la «defenestrata», invece, è la sua collaboratrice Liliana. Che dopo quattro mesi da «fantasma» ha ricevuto il benservito. Alla faccia dei Valori e delle esigenze dei cittadini.
Liliana, anche i dipietristi hanno il pessimo vizio di sfruttare i collaboratori?
«Io posso parlare di uno solo, Barbato. E lui questo vizio ce l’ha. Eppure io non sono nata nella bambagia. Ho lavorato tre anni all'ufficio stampa dei Radicali, so cosa vuol dire farmi un mazzo così. Ma almeno avevo un contratto regolare».
Però ha dovuto cambiare...
«Purtroppo sì. Un altro suo collaboratore esterno mi ha detto che l’onorevole Barbato cercava una persona, quindi ci hanno presentati. Un colloquio senza nemmeno parlare di lavoro e un “cominci mercoledì”. Così a febbraio è iniziato il bailamme».
Qualche promessa?
«Semplicemente un contratto dopo un periodo di prova. Ma alla Camera non ci sono regole e quelle che valgono per tutti i lavoratori italiani lì sono ignorate perché con l’autodichiarazione c’è sempre la scusa per mettere all’angolo i principi costituzionali. Quindi passavano i mesi e il contratto non si vedeva. Come del resto Barbato».
Desaparecido?
«In aula c’era, ma è sempre molto difficile parlare. Quando lo vedevo e gli chiedevo notizie sul contratto mi diceva: “Vabbé, mo’ vediamo”».
Intanto lei lavorava...
«Dalle 9.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì. Toh, a volte arrivavo alle 10, ché non abito vicino a Montecitorio, io... Solitamente l’attività di un’assistente è strettamente legata a quella del parlamentare in questione: interrogazioni, appuntamenti, proposte di legge, rassegne stampa. E devo riconoscere che il lavoro svolto per Barbato non era esattamente frenetico».
Nella
classifica di produttività dei deputati di Open Polis è 207° su 630. Comunque,
dice il saggio: lavoro è se principale paga. Sennò è volontariato. Lei almeno
era pagata?
«Puntualmente. Ma rigorosamente in nero. Andava a prelevare i contanti e li
metteva in una bella busta con la scritta “Camera dei Deputati”. Io trattenevo
la mia parte e poi lasciavo il resto dei soldi al mio collega».
Prassi comune tra i politici...
«Zero assicurazione, zero buoni pasto. Ho speso un capitale in panini nei bar, dato che io non pranzavo alla buvette con 4 euro come i parlamentari».
Epperò questo incanto si è spezzato...
«E in modo davvero antipatico. Alla vigilia della settimana bianca della Camera, giorni in cui è sospesa l’attività parlamentare, mi ha telefonato il mio collega dicendo di aver “intuito” che non sarei stata confermata. Ho chiamato Barbato che ha fatto il pilatesco: “Devi parlarne con lui, è stato lui che inizialmente ti ha contattata... in estate, sai, non servono persone...”. Eppure il “capo” era lui, era lui che mi pagava, però a decidere era il collega. Mah...».
E tanti saluti.
«Esatto. Mai più sentito. Il 6 giugno mi ha fatto chiamare dal suo collaboratore dicendo che mi lasciava a casa perché non ero all’altezza del compito. Ah, giusto perché d’estate non serviva una figura come la mia, so che il mio posto è già stato assegnato a un’altra. Magari senza contratto. Ma tanto la giustificazione è la stessa: il periodo di prova...».
Cosa chiederebbe a Di Pietro?
«In quest’esperienza gli unici “valori” che ho incontrato sono stati quelli in nero e in busta chiusa. L’Idv parla di ripristino della legalità, trasparenza, aiuto alle fasce deboli e alternativa di diritto: ecco però in concreto come sono stata tutelata. Di Pietro non può tenere sotto controllo tutti i parlamentari, ma deve sapere che ci sono cellule cancerogene nel suo partito».
La stessa
cosa che gli rimproverava Barbato a proposito dei membri campani di Idv...
«Appunto. Tralascio commenti».
Francesco Comellini, presidente dell’associazione collaboratori parlamentari, si augura che tutti seguano il suo esempio. Ma lei non teme di non lavorare più al Parlamento?
«Non guardo al rischio ma al coraggio di denunciare ciò che non va. Se uno sta zitto, come spesso i miei colleghi, subisce. Io nei Radicali ho imparato ad agire piuttosto di lamentarmi».
In seguito alla questione morale nell'IDV sollevata dal Luigi De Magistris su “Libero-News” del 28/12/2010 è uscito un interessante articolo: La questione morale nell'IDV. Antonio di Pietro come Craxi, bersaglio delle monetine del pubblico inferocito. Cambia l'anno, non siamo nel 1993, e la location: il Tonino-bersaglio stava a Matera, e non all'hotel Raphael di Roma. Già, una questione morale nell'Italia dei Valori esiste. Eccome. Per ultimo, a ricordarlo al leader del movimento, è stato Antonio Razzi, il deputato che alla vigilia del voto di fiducia del 14 dicembre 2010 ha abbandonato l'Idv. Meta, la maggioranza di Silvio Berlusconi.
I RAPPORTI CON DE MAGISTRIS - La critica di Razzi coinvolge i rapporti tra Di Pietro e lo stesso De Magistris, "rinviato a giudizio per omissione di atti di ufficio perché non avrebbe indagato, nonostante l'ordine del Gip, su un caso di collusione tra magistrati di Lecce e magistrati di Potenza con ipotesi di reato gravissime", aggiunge Razzi, "che vanno dall'associazione per delinquere all'estorsione". (Probabilmente è l'insabbiamento, oggetto delle denunce del dr Antonio Giangrande, in cui si parlava di una sorta di consorteria mirata all'impunità tra i magistrati di Potenza per i reati commessi da quelli di Lecce). Insomma, si ribadisce che la questione morale c'è, eccome, e riguarda Di Pietro e gli stessi uomini che lui ha scelto e difeso. "De Magistris", conclude Razzi, "doveva autosospendersi dalla carica, volente o nolente, in quanto il codice etico del partito lo impone. Antonio Di Pietro lo ha difeso a spada tratta invece ponendo una deroga a quanto egli stesso prescrisse".
SUPER SCILIPOTI - Insieme a Razzi, a voltare le spalle a Tonino, è stato l'ormai celeberrimo Domenico Scilipoti. Anche in questo caso la "svolta" è arrivata poco prima che la Camera votasse la sfiducia bramata da Gianfranco Fini (sfiducia al Cavaliere che, puntualmente, non si è concretizzata). Scilipoti ha cercato di spiegare che la sua era stata una scelta "di responsabilità politica". Niente da fare, però. Prima ci si sono messi i suoi stessi compagni di partito - Scilipoti ha parlato di vere e proprie minacce ricevute dai vertici della "nomenklatura" -, poi è stato il turno dei media e dei parlamentari di opposizione ("venduto", "corrotto", "voltagabbana", "mezz'uomo" e via dicendo"). Infine non poteva mancare Santoro, che ha spedito la sua troupe a Barcellona Pozzo di Gotto per intervistare la madre - novantenne - del deputato. Il gesto ha scatenato la divertente (e divertita) ira di Scilipoti, che ha trovato massimo sfogo nell'indimenticabile show trasmesso dall'etere di Radio 1.
FLORES D'ARCAIS: "SONDAGGI TRUCCATI" - Facile puntare il dito, parlare di compravendita di parlamentari e mercato delle vacche. Ma guardiamo in casa Idv. Se non bastasse l'accusa lanciata in queste vacanze natalizie dall'intellettuale Paolo Flores D'Arcais (alfiere del partito, che però ha messo sotto accusa Tonino Di Pietro, tacciato di truccare un sondaggio sulla trasparenza nel suo partito), possiamo fare un tuffo nel passato per ricordare tutte le incongruenze che hanno animato il partito della legalità. Il cartello elettorale del padre-padrone che, però, viene abbandonato.
"INDEGNITA' MORALE" - Partiamo dal 2005, quando Beniamino Donnici si permise di dire che l'Idv avrebbe dovuto aderire subito al progetto riformista di Romano Prodi, prima tappa verso la nascita del Partito Democratico. Donnici contestò la decisione di Di Pietro di candidarsi alla primarie dell'Unione, e affermò di voler sostenere Prodi. Il democratico risultato fu l'espulsione - senza appello - di Donnici dall'Italia dei valori. Il motivo? "Indegnità morale".
INDULTO E DE GREGORIO - Torniamo poi al 2006, quando con il sostegno del centrodestra, al posto della rifondarola Lidia Menapace, fu eletto presidente della Commissione difesa Sergio De Gregorio. Il deputato accettò l'incarico, anche se l'Idv, in un vortice di controsensi, gli chiedeva di declinare l'offerta. Si trattava proprio di quel Sergio De Gregorio finito nell'inchiesta Telecom Sparkle. Certo, vero, l'Idv quando sono sbucati i fondi neri, De Gregorio lo aveva già abbandonato. Lo aveva fatto proprio nel 2006, pochi giorni dopo lo scontro sulla Commissione e pochi giorni dopo le plateali manifestazioni di Tonino sotto Palazzo Madama. Di Pietro cercava di boicottare l'indulto promosso dalla sua stessa coalizione, che all'epoca governava. Ma a favore di quell'indulto votò una deputata dell'Idv. E' Federica Rossi Gasparrini, e contro di lei si concentrò il fuoco incrociato dei pasdaran dipietristi. Morale, lei fa "ciao ciao" con la manina e va con Mastella. Per inciso, anche De Gregorio, sull'indulto, preferì astenersi. Come a dire, "noi nel partito del tiranno Di Pietro non ci vogliamo rimanere". Esattamente quello che pensano Razzi - in maniera - e l'ex fido alleato De Magistris - in modo meno esplicito.
FRANCA RAME - Andiamo avanti di un anno, siamo nel 2007. La defezione è di quelle pesanti. Si tratta di Franca Rame, la moglie di Dario Fò, portata in pompa magna dall'Idv in Senato. Franca non condivide alcune scelte del gruppo, in particolare quella di non votare a favore dello scioglimento della società per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Insomma: Di Pietro ordina, il partito obbedisce. Ma il dissenso cresce, e le persone l'Idv possono anche abbandonarlo. Così fa la Rame, come un mese prima aveva abbandonato Salvatore Raiti. Meglio il Partito Democratico. Meglio evitare le bizze di Tonino.
Ancora nel 2007, il movimento Repubblicani Democratici guidato da Giuseppe Ossorio preferì rescindere l'accordo con l'Idv. Non per fare salti (politicamente) pindarici, ma per stringere un'alleanza con i nascenti Democratici. Esattamente come il deputato Salvatore Raiti, che lasciò La Rete per aderire al Pd. Sarà proprio vero che quelli di Scilipoti, Razzi e De Magistris (perchè no...) siano solo capricci, fregnacce e tradimenti?
Qui si soprassiede alle critiche e alle denunce che vari colleghi di partito hanno presentato, volta per volta, contro il loro leader, in relazione all’amministrazione dei fondi e dei sovvenzionamenti del partito. Ma si prende in esame anche un altro aspetto: l’antipolitica d’affari.
Quello della “Casaleggio associati” è un business a 360 gradi. E gli affari vanno sempre meglio. L’anno scorso il fatturato dell’azienda si è assestato oltre il milione di euro. Fra le varie attività dell’azienda risulta anche la vendita e la distribuzione on line dei dvd degli spettacoli e dei libri di Beppe Grillo. Rimane un dubbio. Ma perché una società, leader di settore, che “ha la missione di sviluppare consulenza strategica di Rete per le aziende e di realizzare Rapporti sull’economia digitale” ha deciso di investire buona parte delle sue energie su Grillo e Di Pietro?
E meno male che siamo di fronte a coloro i quali si definiscono la parte politica più onesta !!
Esce in edicola un libro che promette di svelare tutti i segreti di Antonio Di Pietro e dell’Idv. Ne parla Libero. Un libro bomba scritto da Mario Dì Domenico, ex amico di Di Pietro e cofondatore dell’Idv. Si chiama “Il "Colpo" allo Stato, la legge è uguale per tutti... salvo alcuni” e promette di esporre al pubblico ludibrio tutti i scheletri nell’armadio dell’Idv e del suo presidente. Dalla raccolta di firme false, agli avvistamenti ad Hong Kong dell’ex pm di Mani pulite in una banca con una pesante valigia, fino alle stravaganti operazioni immobiliari e a strani movimenti circa i rimborsi elettorali. Di Pietro prepara querele, e ha diffidato la pubblicazione del libro. Ma l’editore è andato avanti lo stesso.
Ne parla Gianluigi Nuzzi dalle pagine di Libero in un articolo intitolato: “Di Pietro, un libro svela i suoi segreti”. «Già un anno fa – spiega Nuzzi - uscì una prima esplosiva anticipazione del volume. Il «Corriere della Sera» pubblicò in prima pagina la storia di una cena del 15 dicembre del 1992 con commensali d’eccezione. Tra i quali l’allora pubblico ministero, il Tonino nazionale, e l’ex numero tre dei servizi segreti Bruno Contrada, che sarà arrestato poco dopo». Una data non casuale: «quel 15 dicembre, a metà giornata, l’Ansa ha ufficializzato con un dispaccio l’avviso di garanzia contro Bettino Craxi per concorso in corruzione, ricettazione e violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti». Il provvedimento era firmato «con Saverio Borrelli e gli altri colleghi del pool di Milano proprio da Tonino Di Pietro la sera precedente, il 14. E, ventiquattro ore dopo, il giudice per il quale mezza Italia ormai tifa, sta lì a tavola, Contrada seduto accanto a lui, l’agente americano pronto con la targa premio». Superati gli ostacoli legali che ne hanno impedito per mesi l’uscita, finalmente vede la luce l’autobiografia non autorizzata del leader dell’IdV Antonio Di Pietro (Colpo allo Stato. La legge è uguale per tutti…salvo alcuni, Edizioni Sì) scritta dall’avvocato Mario Di Domenico, tra i fondatori dell’IdV.
Pubblicazione rilanciata in prima pagina in un articolo del quotidiano Libero di Gianluigi Nuzzi che ne anticipa i contenuti. Il libro, infatti, accusa Di Pietro di aver compiuto una nutrita serie di irregolarità, scorrettezze e persino reati. Tonino, manco a dirlo, non ci sta. E annuncia non una, ma 50 querele contro il suo ex collaboratore e amico. Panorama.it ha intervistato Di Domenico, che si toglie qualche sassolino dalla scarpa.
Avvocato, finalmente è riuscito a pubblicarlo…
Oltre alle difficoltà che esistono in ogni lavoro di ricerca nel reperire i documenti che non erano in mio possesso, per portare avanti un discorso di verità, bisogna aggiungere le forti pressioni esercitate almeno da un anno dall’onorevole Di Pietro ai miei editori (Di Domenico è stato costretto a cambiare casa editrice, ndr) per bloccarne l’uscita: montagne di atti spediti per spiegare che lui è il San Giorgio della liberazione e per diffidarne la pubblicazione (Di Pietro di diffide ne ha inviate ben sei, ndr).
Ma è in edicola. Di Pietro, tuttavia, dice che lei nel suo libro racconta balle. E annuncia una montagna di querele.
Ho letto stamane che sarebbero 50. Ma io gli rispondo: caro Di Pietro, ne basta una sola. Venga piuttosto in tribunale a rispondere delle pressioni che ha esercitato in questi mesi sulle case editrici che avevano in mano il mio manoscritto: sporgerò querela per violenza privata, intimidazione e diffamazione. Di Pietro parla di una sentenza in cui sarei definito “grafomane di professione”, ma dice il falso. La verità è che sono un ricercatore accreditato al Cnr e, per mestiere, scrivo anche libri.
Di Pietro dice che lei non ha pagato le spese processuali e che la sua casa sarebbe finita all’asta.
I debiti li ho pagati: 20.000 euro di tasca mia, come tutti i cittadini onesti, e non con i soldi degli inquisiti…
Lei non è il solo ex collaboratore ad attaccare il leader dell’IdV. Com’è che Di Pietro in tutti questi anni si è creato così tanti nemici proprio tra i suoi ex amici?
Perché lui vuole essere il Re Sole, il padrone assoluto del partito. Si finge comunista, ma non lo è e non lo è mai stato. E ora si sta mangiando il Pd. Questo è l’uomo Di Pietro e nel mio libro ho fatto luce su questo aspetto, scrivendo cose che poi già tutti sanno. Volevo affrontare la questione morale di cui parlò Berlinguer e che non può essere trascurata oggi. La verità non deve far paura.
Ed ora che farà?
Sto scrivendo un altro libro di più ampio respiro sulle ombre nella Seconda Repubblica. Si chiamerà Archivio di Stato. E parlerà, ovviamente, anche di Antonio Di Pietro e dei danni che ha recato alla magistratura stessa. Ma non solo: metterò in rilievo altre contraddizioni. Per esempio, pur avendo buoni rapporti con il Carroccio, di cui stimo la maggior parte dei suoi esponenti e che anzi devo ringraziare per avermi aiutato nelle mie ricerche, vorrei far notare che nell’articolo 1 dello Statuto della Lega si parla tranquillamente di secessione. Lo scrissero anche gli indipendentisti siciliani nel 1947 e finirono in galera. No, la legge non è uguale per tutti.
Di Pietro da parte sua risponde alle accuse del libro, rilanciate da Libero, direttamente dal suo blog, pubblicando una corposa documentazione “relativa alle accuse diffamanti e denigratorie del signor Di Domenico”.
Quanto segue è il sunto coordinato di tutto quanto pubblicato sui giornali. Articoli di stampa di pubblico dominio e di pubblico interesse.
A fare la radiografia dell'attuale gruppo di comando di Idv con il metodo Di Pietro i risultati sono impietosi. Fedina penale immacolata, d'accordo. Fedina politica, molto meno.
Nei gruppi parlamentari di Idv trasformisti, riciclati e capibastone sono ben rappresentati.
Il senatore Aniello Di Nardo, per esempio, ha cominciato a fare politica a Castellammare di Stabia, nella Dc di Antonio Gava. Eletto deputato nel Ccd di Casini, ha traslocato nell'Udeur di Mastella, ottenendo in cambio la poltrona di sottosegretario all'Interno e la protezione civile in Campania con Antonio Bassolino. Stesso percorso del suo collega a palazzo Madama Giacinto Russo: assessore mastelliano all'Industria, lascia l'Udeur e passa con Di Pietro l'8 febbraio 2008, quando alle elezioni mancano poche settimane, ricompensato con un seggio al Senato. A personaggi così Di Pietro chiede di lasciare le giunte in Campania: gli affetti più cari.
Casi isolati? Macché. Alla Camera c'è Antonio Borghesi, l'uomo della commissione Bilancio, il Tremonti di Di Pietro, che da presidente della Provincia di Verona con la Lega si professava secessionista. Oppure l'eterno Aurelio Misiti, che per due anni mantenne il doppio incarico di assessore ai Lavori pubblici in Calabria nella giunta di destra di Chiaravallotti e di presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici nominato da Pietro Lunardi, alla faccia delle incompatibilità e dei conflitti di interesse. E poi David Favia, deputato marchigiano. Un forzista della prima ora, un pasdaran berlusconiano. Al punto che nel 2000 nei suoi volantini chiede agli elettori: "Volete l'Italia di Berlusconi o quella di D'Alema e di Di Pietro?". Lui non ha dubbi, sta con il Cavaliere e viene eletto consigliere regionale. Fino al 2004, quando passa ai mastelliani. Il 27 febbraio di quest'anno, a poche ore dalla chiusura delle liste, altra conversione: Clemente addio, "Idv è il partito più vicino al mio modo di intendere i valori". E questa sì che è un'abiura, altro che Galileo.
"Non ci servono gli estremisti, dobbiamo rappresentare quei moderati che hanno a cuore la legalità. Un elettorato perbenista", teorizza il deputato barese Pino Pisicchio, uno che alla Camera per la prima volta è stato eletto più di vent'anni fa, nella Dc e che ha appena pubblicato un libro sull'Idv. Sarà. Ma non è esattamente il tipo di personale politico che gli elettori si aspettano di trovare.
"Siamo un partito che non è ideologicamente ingabbiato, ma programmaticamente evoluto", si difende Tonino. Traduzione: prendere voti a tutto campo. Strapparli alla Lega al Nord, alle liste civiche, all'elettorato legalitario di An e soprattutto al Pd. Con qualche new entry mirata come lo storico Nicola Tranfaglia, nell'ultima legislatura deputato Pdci. E i nuovi dipartimenti affidati a figure di prestigio, tutte legate al Pd: l'ex senatore dell'Ulivo Paolo Brutti parlerà di infrastrutture, al sociologo Pino Arlacchi, esperto dell'Onu sulla droga, sarà affidato il dipartimento internazionale. E di riforma delle istituzioni si occuperà il giurista Stefano Passigli, ex repubblicano, ex senatore ulivista, tra i fondatori del Pd, deluso del partito veltroniano. Altri sono in arrivo.
Nomi che nei piani di Di Pietro dovrebbero consentire di fare il famoso salto, almeno di qualità. Per la quantità bisogna lavorare sulle fasce di elettorato più attratte dal verbo dell'ex pm: i ragazzi tra i 18 e i 34 anni sono al primo posto tra gli elettori potenziali, seguono le donne. I giovani si organizzano via Facebook, fanno i banchetti per raccogliere le firme contro il lodo Alfano davanti alle discoteche. Il coordinatore Massimo Romano è il prototipo del nuovo dipietrista: uomo di legge (studia da avvocato), ambizioso (sogna di fare il sindaco di Campobasso) e molisano come il leader. A reclutare le donne ci pensa la senatrice Patrizia Bugnano, rappresentante della sparuta quota rosa di Idv (due deputate su 28, due senatrici su 14). Con una modalità originale: dalle colonne di 'Gioia' Di Pietro ha chiesto di spedire un curriculum, l'idea è piaciuta, sono in corso i colloqui. Obiettivo: conquistare l'Italia della protesta. Il monopolio dell'opposizione. E non solo sulla giustizia: la questione morale e il referendum sul lodo Alfano restano i cavalli di battaglia, ma serve anche rafforzare il messaggio sulle questioni economiche e sociali che sono al primo posto delle preoccupazioni degli elettori. Di Pietro studia: tabelle, grafici, carte, emendamenti. Passa da una trasmissione all'altra, infreddolito, febbricitante, combattivo. Con un sogno non confessato: il10 per cento alle elezioni europee. Per raggiungerlo è disposto anche al supremo sacrificio: cancellare il suo nome dal simbolo elettorale di Idv, per dare vita a "una grande lista civica nazionale".
La leadership val bene un po' di umiltà. Anche per un uomo della Provvidenza come Antonio Di Pietro.
Tutti gli intrallazzi del clan Di Pietro. Giudicate voi.
1) Il 23 settembre 2008 il senatore Sergio De Gregorio dice al Velino che Cristiano Di Pietro, consigliere provinciale a Campobasso, risulta intercettato e coinvolto in un’inchiesta non ben definita.
2) Il 10 ottobre 2008 il settimanale La voce della Campania circostanzia le accuse: la magistratura sarebbe in possesso di intercettazioni dove Cristiano chiederebbe l’assunzione di amici suoi a Mario Mautone, ai tempi provveditore alle opere pubbliche di Molise e Campania.
3) Il 21 ottobre2008 è invece il Giornale, in prima pagina, a riprendere la stessa notizia spiegando che fu Antonio Di Pietro, da ministro delle Infrastrutture, a nominare Mauro Mautone Direttore centrale del settore edilizia e poi presidente di una commissione tecnica sugli appalti autostradali; Di Pietro, genericamente, annuncia querele.
4) Il 3 dicembre 2008 il Giornale e il Mattino rivelano che il citato Mautone figura nell’informativa giudiziaria che darà il via alla Tangentopoli partenopea; Di Pietro allora dirama un comunicato dove spiega che in realtà, a metà del 2007, trasferì appositamente il provveditore Mautone «nel momento in cui ho appreso le prime avvisaglie di indagini». Nota: non è chiaro, rileva solo il Giornale, come Di Pietro già a metà del 2007 potesse essere a conoscenza di «indagini» ovviamente coperte da segreto istruttorio.
5) Il 4 dicembre 2008 comincia il soccorso di Repubblica: il vicedirettore Giuseppe D'Avanzo scrive che il Giornale ha dato «una notizia farlocca» e parla di un «venticello calunnioso» che si insinua su Di Pietro, persona che sue fonti anonime definiscono «di esemplare correttezza»; Repubblica definisce «sventurato» Cristiano Di Pietro, vittima solo di qualche incauto colloquio telefonico. Nota: la notizia, come visto, non è farlocca per niente; nota 2: Di Pietro, a quel punto, si difende dalle accuse del Giornale spiegando che «come qualsiasi cittadino» aveva saputo «dell’esistenza delle indagini dalle agenzie di stampa». Circostanza, questa, che risulta falsa: nessuna agenzia ne ha mai parlato.
6) Nega e rinnega, si giunge a ieri: alcuni quotidiani pubblicano un’informativa della Dia che sbugiarda tutte le uscite precedenti di Di Pietro. Tutta roba che avrete già letto. È la Dia a scrivere di «fuga di notizie» (altro che agenzie) e di un Di Pietro che di colpo, il 29 luglio 2007, mangia la foglia e smette o quasi di parlare al telefono; è Cristiano Di Pietro, spiega la Dia, a chiedere assunzioni e favori a Mario Mautone salvo smettere improvvisamente, dalla stessa data, di chiamarlo o rispondergli al telefono; e Di Pietro, durante una riunione politica coi suoi, a giudicare d’un tratto «troppo esposto» suo figlio. L’informativa e le intercettazioni di Cristiano Di Pietro fanno capolino sulle prime pagine di molti giornali: sono notizie. Tra le tante telefonate ce n’è poi una, pubblicata anche dal Giornale, dove la moglie di Mario Mautone, alla notizia che verrà trasferito, cerca un po’ pateticamente di spronare il marito: «Buttala sul ricatto al figlio, ricattalo sul fatto che lui ha bisogno di te su tante cose». Una frase come un’altra, buttata lì da un’attrice senza parte: tanto che il marito neppure commenta. La Dia, in ogni caso, precisa che il ricatto neppure tentato è comunque «non riuscito».
7) Ed eccoci. Di Pietro dirama un comunicato titolato «Magistrati avanti tutta» che ha dell'incredibile. In precedenza aveva detto di sapere dell'indagine sin dal 2007, grazie a fantomatiche agenzie di stampa: «Non so nulla di più di quello che ho letto sui giornali circa le accuse che vengono mosse a questo dirigente ministeriale», dice ora. Poi: «Quando arrivai al ministero presi una decisione che ora, a ragion veduta, si è dimostrata davvero azzeccata: ho trasferito Mautone ad altro incarico e l’ho spostato di sede, togliendogli quindi ogni possibilità di fare danni».
Cioè: il trasferimento che portò Mautone alla direzione del settore edilizia pubblica e interventi speciali del ministero delle Infrastrutture, guidato da Di Pietro, sarebbe un luogo di espiazione dove non si possono far danni. Né favori. Ma sempre ieri, soprattutto, eccoti il capolavoro di Repubblica. Il soccorso finale. Le intercettazioni, quelle di Cristiano Di Pietro con Mautone, non compaiono. Mentre il rapporto della Dia, quello che evidenzia le contraddizioni e le bugie di Di Pietro, è affogato nel piombo di in un articolo che parla d'altro: la marginalissima telefonata della povera moglie di Mautone («Buttala sul ricatto») diventa il provvidenziale titolo a tutta pagina: «Dobbiamo ricattare il figlio di Di Pietro. Così volevano tenere sotto il ministro». «Così» come? Non lo spiegano. Nel richiamo di prima pagina diventa addirittura così: «Napoli, nelle carte spunta ricatto al figlio di Di Pietro». Nell’articolo, del ricatto, non c’è traccia. E non è tanto una forzatura, non è tanto una faziosità: è una barzelletta. La cui morale, terminato di ridere, è che Antonio Di Pietro resta l’uomo più protetto d'Italia.
Travaglio ricorda con ardore "i 54 procedimenti contro Antonio Di Pietro”, facendolo passare per vittima di calunnie.
La prima grana giudiziaria è del 7 aprile 1995: a Brescia, Di Pietro, è iscritto nel registro degli indagati per le dichiarazioni del generale Cerciello, che racconta di avere appreso di pressioni esercitate su altri imputati, affinché lo coinvolgessero nelle indagini assieme a Silvio Berlusconi. L’inchiesta, condotta del PM Fabio Salamone, si conclude poco dopo con la richiesta di archiviazione, fatta dallo stesso magistrato che, nel frattempo, però, aveva indagato Di Pietro per varie altre vicende.
Il secondo e terzo proscioglimento arrivano tra il febbraio e il marzo 1996 per le accuse di concussione e abuso d’ufficio per l’informatizzazione degli uffici giudiziari.
Una quarta archiviazione per alcuni esposti di Sergio Cusani.
Il quinto proscioglimento per un’accusa di concussione ai danni dell’ex presidente della Maa assicurazioni Giancarlo Gorrini (prestito di 100 milioni, compravendita Mercedes) e per il reato di abuso d’ufficio per avere favorito l’amico Eleuterio Rea nella nomina a comandante dei vigili urbani di Milano.
Il 15 ottobre 1997 Di Pietro è prosciolto dall’accusa di falso ideologico in relazione alla firma dei verbali di alcuni interrogatori delegati ad ufficiali di polizia giudiziaria.
Il 10 dicembre 1998 è archiviata l’accusa di avere ottenuto l’uso di un appartamento in centro e per aver favorito il socialista Sergio Radaelli nell’inchiesta sulle tangenti Atm.
Il 18 febbraio 1999 Antonio Di Pietro è di nuovo prosciolto dall’accusa di corruzione per aver favorito, nelle sue inchieste, Pierfrancesco Pacini Battaglia.
“Altro che apparentamento nel segno della legalità. Io credo che se Veltroni ha imbarcato Di Pietro lo ha fatto per annettersi tutte le clientele dell’Udc in Calabria e in altre regioni del Sud, visto che queste clientele stanno adesso tutte confluendo nell’Italia dei Valori”. Le parole e il concetto sono espressi dall’avvocato Franco Romano, che dell’Italia dei Valori è stato responsabile proprio nella regione Calabria, e a raccoglierle solo qualche giorno fa è stato il corrispondente dal Senato di Radioradicale, Alessio Falconio.
Che in una serie di interviste radiofoniche, con la giornalista di “Panorama” Laura Maragnani, con l’ex amico di Di Pietro Elio Veltri e con l’ex socio di partito Achille Occhetto ha sviscerato nell’indifferenza generale dei grandi media il caso Di Pietro. In tutto questo, il prossimo 27 febbraio Antonio Di Pietro dovrà anche comparire in udienza camerale davanti al gip di Roma in veste di indagato per falso e truffa aggravata in relazione all’utilizzo dei soldi pubblici incamerati dall’Idv e dall’ex organo di partito. Insomma Veltroni ancora non lo sa ma la questione morale nel Pd fra poco potrebbe avere il volto, anzi il lato B, di Di Pietro.
Ma nel senso esattamente opposto a quello che crederebbero tutti i suoi ammiratori.
La giornalista Maragnani parla di un “metodo di Pietro” che ben poco sarebbe cambiato dall’epoca delle inchieste subite a Brescia e finite tutte con assoluzioni. La definizione più bonaria che viene data all’unisono da tutti i testimoni sentiti è quella di un padre padrone che gestisce un patrimonio di ormai 22 milioni di euro. Nelle interviste si parla di una società, la Antocri (Anna, Totò e Cristiano sono i nomi dei tre figli di Di Pietro) che possiede case a Roma, Milano, Bruxelles, Montenero di Bisacce e persino in Bulgaria e che quelle stesse case le dà poi in locazione al partito, alla sede del giornale, agli uffici.
Sia come sia, l’Italia dei valori è stata segnalata al Consiglio d’Europa perché ad approvarne i bilanci è di fatto un’unica persona, cioè Di Pietro stesso. Che nelle società si avvale anche della ex moglie Susanna Mazzoleni e di un’amica di Brescia, Silvana Mura. L’atto di nascita del sistema di Pietro e del suo partito personale ha anche una data, il 26 settembre 2000. E un luogo: via delle Province 37, Roma. E’ lì che prende forma la “Libera associazione Italia dei valori-Lista Di Pietro, in breve Idv”. L’oggetto sociale? “La valorizzazione, la diffusione e la piena affermazione della cultura della legalità, la difesa dello stato di diritto, la realizzazione di una prassi di trasparenza politica e amministrativa”. Però adesso uno dei soci fondatori di allora, l’avvocato abruzzese Mario di Domenico, anche lui sentito da Radio radicale, ha fatto un esposto in cui Di Pietro viene accusato proprio di quelle cose che lui per anni ha rovesciato addosso ai politici per dimostrare che sono gli affaristi della politica.
Di Domenico ha raccontato come dal 5 novembre 2003 l’associazione partito sia diventata una cosa privata di Di Pietro. Anche dal lato politico il metodo Di Pietro non ha nulla da invidiare a quello Mastella: prima si diceva delle clientele calabresi passate in blocco dall’Udeur all’Idv, ebbene non è da dimenticare che tra questi uomini ce ne sono alcuni che il Di Pietro non farebbe passare sotto silenzio qualora si trattasse di gente presente in altri partiti. Però per se stesso fa una eccezione. Come nel caso dell’avvocato Armando Veneto, ex Udeur ora maggiorente Idv in Calabria, che nel 1979 aveva tenuto l’orazione funebre del boss Girolamo Piromalli, detto Momo. Di questo fatto ormai si parla persino nei libri di storia, come quello del professor Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti della ‘ndrangheta esistenti in Italia e consulente della stessa commissione parlamentare antimafia. La notizia dei giorni scorsi era che Di Pietro aveva declinato l’invito del direttore di “Panorama”, Maurizio Belpietro, a presenziare a una puntata televisiva di “Panorama del giorno” su Canale 5. Magari l’italiano medio crederà che “il gran rifiuto” sia legato al fatto che Di Pietro non vuole andare nelle stesse tv che dichiara di volere chiudere. Qualcuno più smaliziato potrebbe ritenere che l’ex pm di “Mani pulite” avrà ritenuto di evitare qualche domanda scomoda su vicende personali.
«Al giorno d’oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente». Che c’azzecca una delle più celebri citazioni di Oscar Wilde con quello che leggerete fra qualche riga? C’azzecca, fidatevi. Pensate che, prima o poi, sarà costretto anche lo stesso Antonio Di Pietro, vessillifero dei Valori d’Italia o dell’Italia dei Valori a riconoscere che quella massima c’azzecca. Perché quei suoi Valori conclamati e sbandierati, giorno dopo giorno stanno diventando sempre più Disvalori. Colpa di scivoloni, scandali e incidenti di percorso che hanno coinvolto soldati e militanti di quello che, così annunciò Di Pietro a suo tempo, sarebbe stato il partito più pulito del Paese. Peccato che nel partito della trasparenza il primo a incespicare più volte sia stato proprio il leader maximo. Così come dicono gli eurodeputati Achille Occhetto, Giulietto Chiesa e Elio Veltri (ex amici che ora ne dicono peste e corna ai microfoni di Radio radicale) i quali lo accusano di essersi intascato i cinque milioni di rimborso elettorale per le europee lasciando a secco il famoso “cantiere”
Era il febbraio del 2008 quando Di Pietro attirò l’attenzione della magistratura di Roma per appropriazione indebita, falso in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato finalizzata al conseguimento dell'erogazione di fondi pubblici. Storie di presunte irregolarità commesse dall’ex pm nella gestione delle finanze nell'Italia dei Valori riguardo alle spese elettorali, alle movimentazioni dei conti del suo partito: in tutto, oltre 20 milioni di euro. Più l'antipatica questione di un assegno «non trasferibile» da 50mila euro destinato al partito ma ugualmente incassato da Di Pietro. Fatto sta che la Procura decise di rinviare a giudizio anche la deputata-tesoriera dell’Idv, Silvana Mura. Una bolla di sapone, qualcuno obietterà. Dissoltasi nell’aria all’arrivo dei prima caldi primaverili. Eppure Di Pietro ci rimane male quando qualcuno, metti il Giornale, mette in piazza alcune sue debolezze. Per esempio il vizietto di giocare a Monopoli comprando case con soldi che non si capisce da quale parte e come arrivino. Tra il 2002 e il 2008 ha speso quattro milioni di euro per collezionare, assieme alla moglie Susanna Mazzoleni, immobili un po’ ovunque da Montenero, a Bergamo, a Milano, da Roma a Bruxelles. Lui non appare mai, fa tutto l’amministratore della sua società immobiliare An.to.cri (acronimo di Anna, Toto, Cristiano, i figli di Di Pietro) compagno di Silvana Mura. Siamo alle solite. Confusione di ruoli e ambiguità fra movimento e associazione con locazioni degli immobili di proprietà di Di Pietro al partito del medesimo. «Da noi c’è posto solo per candidati che oltre al certificato elettorale portano con sé anche il certificato penale», amava ripetere. Evidentemente si deve essere distratto in più d’una occasione se è vero come è vero che Paride Martella, ex presidente della Provincia di Latina, esponente Idv è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta su appalti truccati della Acqua latina, un giro da 15 milioni di euro. In Liguria due suoi consiglieri su tre hanno avuto problemi giudiziari. Gustavo Garifo, capogruppo provinciale dell’Idv di Genova, è stato ammanettato in ottobre per aver lucrato sugli incassi delle multe. Andrea Proto, consigliere comunale, reo confesso, ha incassato una condanna a un anno e nove mesi per aver raccolto la firma di un morto. Giuliana Carlino, consigliere comunale Idv, indagata per aver falsificato migliaia di firme.
Per corruzione è finito in cella il segretario Idv di Santa Maria Capua Vetere, Gaetano Vatiero. Mentre Mario Buscaino, già sindaco di Trapani, nel Luglio del 1998 è stato accusato di concorso in associazione mafiosa per voto di scambio. Maurizio Feraudo, consigliere regionale calabrese, indagato per concussione (per anni avrebbe preteso un tot sullo stipendio da un suo autista) e truffa. A Foggia l’ex assessore ai Lavori pubblici e coordinatore provinciale del partito, Orazio Schiavone, è stato condannato a un mese e dieci giorni per esercizio abusivo della professione. Rudy D’Amico, un altro ex assessore dell’Idv, questa volta a Pescara, e rimasto coinvolto nell’inchiesta «Green Connection» sulla gestione del verde pubblico. E ancora per Aldo Michele Radice, portavoce Idv in Basilicata, consigliere del ministro Di Pietro il Pm ha chiesto 9 mesi per la raccomandazione di un manager sanitario.
Sorridete: perché c’è anche chi l’auto blu, pur non avendola assegnata, se la compra e utilizza lampeggiante e paletta in dotazione al Consiglio regionale. È Ciro Campana, fermato nei giorni scorsi a Napoli dai carabinieri. Campana non è un consigliere, ma un collaboratore esterno del capogruppo Idv, Cosimo Silvestro. Che abbia ancora una volta ragione Di Pietro? «Quando crescono le responsabilità, e la classe dirigente la devi trovare sul territorio - si difende - lo sa anche Gesù Cristo che ogni dodici c’è un Giuda».
E allora, viene da chiedersi, che cos'è un conflitto d'interessi per Antonio Di Pietro allorché vi sia un rapporto di parentela, piuttosto che di amicizia o di legame professionale? Forse che il rapporto di parentela, al quale Antonio Di Pietro fa riferimento nel lanciare la sua solita populistica accusa nel suo ultimo post, non sia lo stesso che lo riguarda rispetto al di lui figlio Cristiano per l'appunto, per non parlare del rapporto di amicizia e/o professionale con riferimento al di lui avvocato, Scicchitano, membro del consiglio di amministrazione dell'Anas nominato, il 20 luglio 2006, dallo stesso ministro, Presidente Lazio Service S.p.a., Liquidatore Federconsorzi nonché eletto IDV nel Lazio come appariva sino a mesi fa sul sito dell'IDV? Le ovvie risposte che si possono dare strappano un amaro sorriso, siamo alla farsa!!
Scicchitano nell’ottobre 2003 è stato nominato dal Tribunale Civile di Roma Liquidatore Giudiziale della Federazione dei Consorzi Agrari Federconsorzi in Concordato Preventivo.
Esemplare è il fallimento della Federconsorzi. Caposaldo dello scandalo, la liquidazione di un ente che possedeva beni immobili e mobili valutabili oltre quattordicimila miliardi di lire per ripagare debiti di duemila miliardi. L’enormità della differenza avrebbe costituito la ragione di due processi, uno aperto a Perugia uno a Roma. La singolarità dello scandalo è costituita dall’assoluto silenzio della grande stampa, che ha ignorato entrambi i processi, favorendo, palesemente, chi ne disponeva l’insabbiamento.
Paolo Madron: È vero
che molti avvocati di parte civile erano aderenti all'Italia dei valori?
Pellegrino Capalbo: Sì, c'era anche Antonio Di Pietro che però a un certo punto
si defilò.
Bel sistema all'italiana, quello escogitato dal ministro Antonio Di Pietro per sveltire i lavori delle autostrade: istituire commissioni speciali nominate da lui medesimo in persona. Peccato che finora questi nuovi organismi abbiano prodotto soltanto ritardi e aumenti di costi. Tempi allungati, perché il titolare delle Infrastrutture non è tempestivo nelle nomine. E maggiori spese, perché i commissari insediati sono autorizzati a chiedere parcelle astronomiche: anche il 2 per cento a testa dell'importo complessivo dei lavori. La denuncia parte dal Friuli Venezia Giulia, dove l'urgenza di accelerare i lavori per alleggerire il sempre più inadeguato sistema autostradale è particolarmente sentita; ma potrebbe riguardare anche altre opere. È tutto scritto in un'interrogazione presentata in consiglio regionale dai capigruppo di Forza Italia, Isidoro Gottardo, e Alleanza nazionale, Luca Ciriani. Succede questo, per esempio: i tre commissari incaricati di valutare l'assegnazione del progetto esecutivo della terza corsia dell'autostrada A4 nella quindicina di chilometri fra Quarto d'Altino e San Donà di Piave hanno mandato un conto complessivo di circa 130mila euro.
La composizione di queste commissioni, infatti, tocca non genericamente al ministero «ma specificamente al gabinetto del ministro Di Pietro». Con il risultato, osservano ancora, di rendere «evidente il grave livello di interferenza politica nella composizione delle commissioni giudicatrici». «Dei tre commissari per il progetto della Quarto d'Altino-San Donà - dice Gottardo - uno era un ingegnere dello Iacp di Gorizia in pensione candidatosi per l'Italia dei Valori, e il secondo un dirigente delle opere pubbliche del Lazio nato a Montenero di Bisaccia. Il terzo è il direttore del dipartimento Anas. Due nomi su tre sono legati personalmente a Di Pietro».
Ma per Di Pietro la famiglia è sacra. «Io sono sempre stato a difesa della legalità». Antonio Di Pietro ieri aveva un comizio a Perugia e in campagna elettorale si possono dire anche cose che rischiano di essere smentite dai fatti, in particolare da quella che Achille Occhetto ha di recente definito «la gestione padronale e autoritaria del suo partito». Se poi ci sono di mezzo i figli...
Anna Di Pietro è brillante, di bella presenza, studentessa all'università Bocconi e parla con quell'accento milanese che non ha mai intaccato la cadenza molisana del papà. Nel marzo 2006 viene assunta dalla Editrice Mediterranea, la società che pubblicava il giornale dell'Italia dei valori: nella redazione romana di via della Vite, una splendida traversa di via del Corso, raccontano però di non averla mai vista, nemmeno per ritirare le buste paga. Insomma, sulla carta è assunta a tutti gli effetti per svolgere il praticantato, che dà diritto a sostenere l'esame da professionista. Solo che non ha mai lavorato. Al giornale, nel frattempo, avevano pensato che avesse cambiato idea, che di fare la cronista non avesse più alcuna intenzione. E però in mancanza di comunicazioni diverse continuano a darle lo stipendio, che non ha mai ritirato. Non è l'unica figlia eccellente affidata alle cure della direttrice Delia Cipullo. Tra i praticanti figura anche Antonio Formisano, figlio di Nello, capogruppo al Senato dell'Idv. Lui però lavora davvero, tant'è che nella lista dei praticanti ammessi a sostenere il prossimo esame figura iscritto al numero 83. Di Anna Di Pietro, invece, al giornale del partito avevano perso le tracce. Anche perché nel frattempo, esattamente a luglio 2007, suo padre intima alla Editrice Mediterranea la dismissione della testata Italia dei valori e pone fine al rapporto che faceva del giornale l'organo del suo partito, con i relativi fondi per l'editoria. L'editore dà seguito alle richieste dell'ex magistrato, restituendogli la titolarità della testata. Da allora di Di Pietro non hanno più notizie dirette. Incoraggiato dalla combattiva Cipullo, l'editore cerca però di andare avanti con il suo giornale che esce fino allo scorso 4 agosto sotto la testata Idea democratica. Ma il disconoscimento dell'Idv porta alla chiusura di «una redazione vera, di persone vere che facevano un giornale vero» spiega Delia Cipullo, «con più di dieci giornalisti». Insomma, ci tiene a precisare orgogliosa, «non uno di quei giornali finti che servono solo ad avere i soldi dell'editoria di partito». A gennaio la sorpresa, Antonio Di Pietro si ricorda del suo ex giornale, e così nella redazione ormai in via di dismissione, cominciano ad arrivare dal suo staff una serie di telefonate. Alla direttrice viene chiesto di certificare l'avvenuto praticantato di Anna Di Pietro. A fronte di una situazione contributiva regolare, ci tiene a specificare la direzione del giornale, per far sì che la figlia del ministro possa sostenere l'esame da giornalista nella prima sessione utile occorre che Delia Cipullo certifichi ufficialmente l'apporto dato dalla ragazza alla redazione. La direttrice però da questo orecchio non ci sente e risponde alle insistenti richieste con un netto no: «Non firmo la certificazione perché non sussistono gli estremi per farlo. Il praticante deve stare in redazione e io Anna Di Pietro non l'ho mai vista nemmeno una volta. Non ha mai ritirato le buste paga. A tutt'oggi è ancora una dipendente della Editrice Mediterranea, malgrado tutto non l'abbiamo licenziata. Però fino ad ora non ha mai lavorato e quindi non posso firmare alcunché».
L'ultima telefonata è di giovedì 13 febbraio 2008. Ma la Cipullo continua a non cedere. Per la figlia del ministro Di Pietro niente esame da giornalista. Una questione di rispetto della legge, in teoria lui dovrebbe capirlo. I figli so' piezz 'e core, si sa, ma un uomo che fonda le sue fortune politiche sulla fama di rigoroso cultore delle regole non può farsi beccare in un plateale fallo di nepotismo: va a finire che in privato sembra adottare esattamente quei metodi «mastelliani» che ama criticare in pubblico.
Comunque al peggio non c'è fine. L'Ordine degli avvocati sospende Di Pietro. Tre mesi di sospensione per l’avvocato Antonio Di Pietro. L’ex pm di Mani Pulite si è visto confermare dal Consiglio nazionale forense la «sanzione» del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergamo che aveva già stigmatizzato il «doppio ruolo» ricoperto nei confronti di un amico di Montenero coinvolto in un omicidio: prima il neo avvocato ne prese le difese, poi passò tra le parti civili che sostenevano la tesi dell’accusa. Una cosa che non si fa: «La condotta del professionista - si legge nelle motivazioni della decisione - integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e di fedeltà (articolo 5, 6, 7 del codice deontologico forense) nei confronti della parte assistita e integra altresì l’illecito deontologico». A seguito degli accertamenti svolti, e della sussistenza degli illeciti contestati, «non può che conseguire la sanzione disciplinare». Calcolata in tre mesi di sospensione dell’esercizio della funzione di avvocato in quanto «adeguata alla gravità dell’illecito compiuto».
Ufficialmente indagato dalla Procura di Roma per concorso in abuso d’ufficio e interruzione di pubblico servizio. Ma anche ufficialmente candidato alle elezioni europee di giugno 2009 per l’Italia dei Valori.
È la posizione di Luigi De Magistris, l’ex pm di Catanzaro che martedì 17 marzo 2009 ha annunciato il suo ingresso in politica nel partito di Antonio Di Pietro. Partito che segue – o dovrebbe seguire – un codice etico interno: divieto di candidatura per chi è indagato e divieto di assumere o mantenere incarichi di governo per chi è rinviato a giudizio. «Noi ci siamo dati questo codice perché la questione morale riguarda chi è presente nelle istituzioni e approfitta di questo ruolo», ribadiva Di Pietro il 28 dicembre 2008 al termine degli incontri del suo partito in Sardegna.
Ora è De Magistris ad essere indagato, insieme ad altri sette pm di Salerno, nel filone dell’inchiesta Why Not. Il magistrato dovrà rispondere delle deposizioni rese alla procura di Salerno nel dicembre 2008: denunciava di essere stato vittima di una manovra dei colleghi di Catanzaro per delegittimare le sue indagini.
Ora che è indagato, però, dovrebbe andare ad allungare la lista degli “impresentabili” di Di Pietro. Che tace. Parla, invece, De Magistris, ospite trasmissione “Omnibus” su “La 7” del 19 marzo 2009: «L’ipotesi di reato è del tutto infondata. È ridicola e grottesca». Non pare intenzionato a farsi da parte. Anzi. «Sarò indagato per i prossimi 30 anni. Su di me sono stati aperti più di 100 procedimenti, un numero superiore a quello che riguardò i pm di Mani Puliti», è la previsione tra il serio e il sarcastico dell’ex magistrato.
La notizia di una sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma, insieme ad altri sette pm di Salerno, è arrivata poche ore dopo la conferenza stampa, in cui l'ex magistrato era stato presentato da Antonio Di Pietro come candidato indipendente con l'Idv. Il fascicolo nei suoi confronti era stato però aperto già a febbraio e riguarda la «guerra» tra le due Procure di Salerno e Catanzaro relativa all'inchiesta «Why not» — che provocò l'intervento addirittura di Giorgio Napolitano e quello del Csm — e nella quale si sono trovati invischiati e poi scagionati Romano Prodi e Clemente Mastella.
I reati ipotizzati sarebbero quelli di abuso d'ufficio — per aver eseguito una perquisizione che sarebbe andata oltre le necessità investigative e sarebbe stata realizzata in modi «anomali» — e interruzione di pubblico servizio, perché avendo realizzato una perquisizione abusando del proprio ufficio, in questo modo avrebbe anche interrotto l'attività della magistratura in modo non giustificato. Secondo le accuse ora al vaglio della procura capitolina, il sequestro del fascicolo dell'inchiesta Why Not eseguito dalla procura di di Salerno - e ispirato da De Magistris - alla procura generale di Catanzaro costituì — parole dell'ex pg Enzo Jannelli, indagato a Salerno — «un danno devastante per l'intera Magistratura italiana e disdoro anche per quella, pur complessivamente sana, magistratura inquirente salernitana».
Nonostante ciò, Luigi De Magistris è stato in Puglia due giorni per la campagna elettorale dell’Idv per le europee 2009 e non si è lasciata sfuggire l’occasione di attaccare il Pd per la scelta di alcuni candidati alle europee, a partire da Paolo De Castro quale capolista per il Sud, che «a quanto ho capito serve solo a dare la possibilità di mandare in parlamento Alberto Tedesco» (indagato) e, «al di là della vicenda giudiziaria, mi sembra il sintomo di un grave inquinamento della classe politica meridionale».
Quando si dice: il bue chiama cornuto l’asino! Ma non basta.
Che c’azzecca Antonio Di Pietro con l’omicidio del giornalista Beppe Alfano assassinato da Cosa nostra nel 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto? Ovviamente, nulla. Eppure c’è da chiedersi perché, in una memoria di 75 pagine presentata il 2 aprile 2004 alla Dda di Messina dalla figlia del collaboratore del quotidiano La Sicilia, Sonia Alfano - candidata di punta in tutte e cinque le circoscrizioni nel partito di Tonino - si tiri in ballo proprio l’attuale leader dell’Italia dei valori. E lo si fa accostando il nome dell’ex magistrato molisano a un giro di presunte coperture istituzionali e giudiziarie di cui avrebbero goduto personaggi mafiosi e paramafiosi, come Rosario Cattafi, il cui nome venne alla ribalta con la nota inchiesta sull’Autoparco di Milano, poi con una doppia storia di traffico d’armi, e infine con la divulgazione del cosiddetto «memoriale Cerciello» redatto dal generale della Guardia di finanza, grande accusatore dell’ex pm ai tempi di Mani pulite.
I riferimenti a Cattafi crearono qualche grattacapo a Tonino nel giugno del ’95 quando si sparse la notizia (poi risultata infondata) di una sua iscrizione sul registro degli indagati della procura di Reggio Calabria per aver rallentato, insieme al magistrato Giorgianni, alcune indagini su un traffico d’armi che riguardavano proprio questo Cattafi. Veleni, anonimi e corvi fecero da sfondo alle denunce dell’avvocato Carlo Taormina, difensore del generale Cerciello, che chiese alla procura di Brescia di ascoltare Di Pietro in merito ai suoi rapporti con Cattafi. Non se ne fece nulla. Di Pietro annunciò, e inoltrò, querele. La cosa morì lì. Adesso dai cassetti esce questa memoria nella quale l’attuale candidata dell’Idv, nel 2004, chiese alla procura di Messina di fare luce su una serie di indiscrezioni stampa che parlavano di Cattafi e anche di Tonino.
Ma andiamo per gradi. L’8 gennaio del ’93 Beppe Alfano viene ucciso nella sua auto da sicari di Cosa nostra. Per l’omicidio finiscono condannati, quale mandante, il capomafia di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Gullotti, e come killer, Antonino Merlino. Le indagini sono affidate al pm Olindo Canali, magistrato per bene trapiantato in Sicilia dalla Brianza, una toga considerata molto vicina al giornalista ammazzato al punto da essere considerato suo confidente, e soprattutto suo amico. La famiglia Alfano continua a intrattenere buonissimi rapporti col pm almeno fino all’anno 2001, quando Sonia Alfano non decide di cambiare strategia e di affidarsi al battagliero avvocato Fabio Repici. Da quel momento, nonostante le condanne incassate al processo per la morte del papà, la giovane Alfano comincia a sostenere che l’inchiesta presenta evidenti lacune, che non si è toccato il terzo livello, che vi sarebbero stati depistaggi istituzionali. Da parte dei carabinieri, che avrebbero chiuso un occhio sulla presenza in zona del latitante capomafia catanese Benedetto “Nitto” Santapaola. Da parte, soprattutto, del pm non più amico di famiglia, Olindo Canali, “eterodiretto” dal defunto magistrato Francesco Di Maggio, un tempo magistrato inquirente a Milano, per anni trapiantato proprio a Barcellona Pozzo di Gotto.
Secondo le ricostruzioni giornalistiche (e difensive) riprese e rilanciate nel 2004 da Sonia Alfano, il giudice Di Maggio avrebbe intrecciato rapporti proprio con il noto Rosario Cattafi. Nell’ambito del procedimento poi avviato presso la Dda di Messina (numero 2886/02) utilizzando, e facendo proprie, con forma retorica, le considerazioni espresse il 2 marzo 1998 dal settimanale locale Centonove, Sonia Alfano richiamava l’attenzione della procura di Messina sui rapporti tra il mafioso Cattafi e Antonio Di Pietro, e tra quest’ultimo e tale Francesco Molino, altro mafioso barcellonese.
L’intreccio fra toghe (Canali, Di Maggio, Di Pietro), boss mafiosi (Santapaola e Gullotti) e frequentatori di ambienti e personaggi criminali (Cattafi su tutti) porta la Alfano ad affrontare il caso Di Pietro a partire da pagina 54 della memoria stilata dall’avvocato Repici. Letterale: «È da notare un’altra curiosa coincidenza: a metà degli anni ’80 mentre il dottor Di Maggio era titolare di alcune indagini su Cattafi e raccoglieva dichiarazioni di accusa contro quest’ultimo da Epaminonda, suo uditore giudiziario fu il dottor Olindo Canali». E di seguito. «Di questo curioso intreccio di inchieste, inquirenti e inquisiti, si sono ripetutamente occupati gli organi di informazione. Il settimanale Centonove - si legge nella memoria - in un articolo dal titolo "Un dossier porta ad Hammamet" e avente a oggetto un memoriale prodotto dal difensore del generale Cerciello all’autorità giudiziaria di Brescia contro Di Pietro, scrisse… » e giù varie considerazioni. Tra le quali, questa: «Cattafi a Milano, dove aveva iniziato un’attività nel campo dei farmaceutici e sanitari, rivede e frequenta il giudice Francesco Di Maggio, che ha passato la sua giovinezza fra Milazzo e Barcellona, dove ha frequentato le scuole, compreso il liceo (il padre era appuntato dei carabinieri) e dove ha conosciuto Cattafi di cui è coetaneo. Di Maggio introduce Cattafi nell’ambiente dei magistrati (il 3 aprile ’96 Cattafi ottenne in affitto a Taormina un’abitazione del magistrato in servizio alla procura generale di Milano, Luigi Martino), dove pare Cattafi abbia conosciuto Di Pietro (allora sconosciuto) e la sua donna, poi divenuta sua moglie. Cattafi ha necessità di coperture della magistratura. Conosce - continua la memoria-esposto - anche tale Molino, che è di origine siciliana, che poi diventerà anche amico di Di Pietro. Cattafi viene arrestato su ordine dei magistrati di Firenze per la questione dell’autoparco milanese. I giudici di Firenze intuiscono o vengono a sapere qualcosa sui legami passati fra i due magistrati e Cattafi e cercano di indagare. Scoppia la guerra fra le due procure - prosegue la memoria - e le indagini si interrompono.
Di Pietro vola a Messina, dove incontra il pool Mani pulite, in testa il giudice Giorgianni, che più tardi si recherà ripetutamente a Milano da Di Pietro». Nella memoria si fa poi presente che il settimanale Centonove, il 28 febbraio ’98, intervista proprio Cattafi. Il quale conferma d’aver incontrato un paio di volte Di Maggio, mai Di Pietro («l’ho visto un paio di volte in un locale pubblico») e Giorgianni in occasione di un’inchiesta su un traffico d’armi. I riferimenti a Di Maggio sono importanti - prosegue la memoria - per capire la natura dei rapporti col pm Olindo Canali «di cui era certamente a conoscenza Beppe Alfano». E proprio per andare a fondo alla faccenda nella quale è citato Di Pietro, la Alfano chiede alla Dda di Messina di svolgere una lunga serie di atti istruttori, tra i quali «l’assunzione a sommarie informazioni del dottor Olindo Canali» (che verrà ascoltato come persona informata sui fatti) e del giornalista autore dell’articolo su Di Maggio e Di Pietro «per sapere quali siano state le sue fonti di prova e comunque, se prima della redazione di quell’articolo, egli avesse avuto contatti con Canali».
Questo scriveva la Alfano nel 2004. Della tesi Cattafi-Di Maggio-Di Pietro la ragazza continuava a parlare fino al 2006-2007. Da allora, però, Sonia Alfano non segue più quella pista concentrando l’attenzione - quale causale alla base dell’omicidio del padre - sulla latitanza del boss Nitto Santapaola nel barcellonese. La scoperta di Alfano padre del luogo ove a fine del 1992 era tenuto il boss, secondo la figlia, ne determinò l’eliminazione. Pressoché contemporaneamente all’abbandono della pista Cattafi-toghe lombarde iniziano i contatti con il politico di Montenero di Bisaccia che condurranno alla candidatura di Sonia Alfano alle Europee nella lista Italia dei valori. Nessuno, ovviamente, arriva a sospettare una ricompensa elettorale di Tonino all’abbandono della pista “milanese” da parte della Alfano. Ci mancherebbe. Fa riflettere, piuttosto, la decisione della Alfano di rispolverare, nel 2004, fatti vecchi e sepolti.
Antonio Di Pietro è sempre più organico alla casta che dice di combattere: dopo aver candidato l’inquisito De Magistris, dopo non aver eccepito a che il suo figlio mantenesse lo stipendio di consigliere provinciale benché inquisito, dopo aver cooptato mezza famiglia in politica, dopo essersi intestato la ricezione di tutto il finanziamento pubblico del partito, dopo tutto questo, ecco la nemesi definitiva a 17 anni da Mani pulite: l’ex pm si trincera dietro l’immunità parlamentare per non essere condannato in una causa per diffamazione che l’avrebbe sicuramente visto perdente. Il Parlamento europeo, con 654 sì e 11 no e 13 astenuti, ha deciso di non revocare l’immunità, che Di Pietro stesso aveva chiesto dopo averlo pubblicamente negato. E non si tratta neppure di un procedimento penale, ma di una causa civile: significa che Di Pietro l’ha fatto solo per non perdere soldi, proprio come i mostri della casta.
Di questo passo somiglierà sempre più all’imitazione che ne fa Neri Marcorè: dice una cosa, fa il suo contrario. Di Pietro si è fatto proteggere dall’immunità di eurodeputato per una causa civile di diffamazione, dopo aver pubblicamente detto che avrebbe rinunciato alle garanzie da eurodeputato (Ansa, 11 febbraio 2009), dopo aver detto che l’articolo 68 della Costituzione, per l’appunto l’immunità, va cancellato perché «aveva senso quando fu scritto, dopo la fine del fascismo. Ho sempre detto che l’articolo 68 andrebbe abrogato» (Ansa, 23 luglio 2007). Si protegge con l’immunità, ancora, dopo aver fatto sfoggio di eticità sulla pelle del senatore Luigi Grillo, Pdl, raggiunto da rinvio a giudizio nel maggio 2008: «Ora chiederà di non avvalersi dell’immunità parlamentare per farsi giudicare, come responsabilità istituzionale vorrebbe?», disse Di Pietro.
Chiede e ottiene la tutela parlamentare, dopo aver sfidato pubblicamente Silvio Berlusconi sul medesimo punto: «Se vuole querelarmi rinunci all’impunità» (Ansa, 12 aprile 2008); dopo aver tuonato pubblicamente, lo stesso giorno della sua immunità, contro quella del premier, che sarebbe invece segno di «paraculaggine». Qualcosa non torna. Se ne sono accorti pure i suoi elettori, che non nascondono un forte imbarazzo, sfociato persino sul blog del loro leader.
Prima di entrare in politica, Antonio Di Pietro, ex magistrato, ex poliziotto, ex tecnico della Difesa ed ex trattorista, possedeva una villetta con giardino a Curno, nella bergamasca, che ampliava comprando un'altra villa adiacente di 8 locali.
Una volta entrato in politica fa il salto di qualità.
Nel 1995 comprava un'abitazione da 300 mq a Busto Arsizio che girava al suo partito dopo aver acceso un mutuo per l'80% del valore.
Quando viene eletto al parlamento europeo compra un bilocale di 80 mq a Bruxelles (cifra ignota) mentre, nel 2002, quando è ministro delle Infrastrutture, si accasa a Roma in via Merulana, acquistando una casa di 180 mq e 8 locali per 650.000 euro (mutuo Bnl di 400.000 euro).
Nel 2003 a Montenero di Bisaccia Antonio Di Pietro cede al figlio Cristiano un attico da 173 mq per valore di 300.000 euro in tutto sei vani e mezzo poi ampliati a otto e a 186 metri quadrati (più 16 di garage) il tutto grazie al condono del 2003. Nello stesso anno l'ex-pm compra un appartamento di 190 mq nel centro di Bergamo, mentre la moglie ne compra uno adiacente da 48 mq (valore 800.000 euro).
Nel 2004 se ne aggiunge uno in via Casati a Milano di 190 mq (620.000 euro) e uno di 190 mq a Roma (via Principe Eugenio, un milione e 50.000 euro) ambedue intestati alla An.to.cri, cioè la società da lui stesso creata con un capitale sociale iniziale di soli 50.000 euro. I due mutui contratti ammontano complessivamente a 660.000 euro circa, e in quest'ultima si trasferisce la sede dell'Italia dei Valori che versa l'affitto proprio alla An.to.cri. Non passano due mesi e alla fine di marzo, l'ex pm compra a Bergamo un bel quarto piano, per i figli Anna e Toto: 190 metri quadri in un signorile palazzetto liberty in via dei Partigiani. Lo stesso giorno, con lo stesso notaio, la moglie del segretario politico dell'Italia dei valori fa suo un appartamento di 48 metri quadrati, sempre al quarto piano, oltre a due cantine e a un garage: si parla di una cifra oscillante intorno agli 800mila euro, ma non c'è conferma nemmeno su chi abbia provveduto all'esborso e in quale misura.
Il 2005 è alle porte, e il nuovo appartamento di 190 metri quadri acquistato per 620mila euro in via Felice Casati a Milano - come da rogito stipulato in aprile - Di Pietro lo intesta alla Srl An.to.cri. Poi per un milione e 50mila euro la medesima società immobiliare fa suoi dieci vani (190 metri quadri) in via Principe Eugenio a Roma, dove - stando al bilancio 2005 dell'Idv - trasloca la sede nazionale di rappresentanza politica del partito, fino al giorno prima ubicata in via dei Prefetti 17». Per i due locali Tonino si rivolge alla Bnl e si carica due mutui sulle spalle: 276mila euro da saldare entro il 2015 per la casa milanese, 385mila per quella romana (scadenza 2019). Le pesanti rate Di Pietro inizialmente le ricaverà (salvo poi ripensarci quando scoppia lo scandalo) dal pagamento dei canoni d'affitto versati all'Antocri da un inquilino eccellente: la sua Italia dei Valori. Non è finita. Alla vigilia di Natale del 2005, Susanna Mazzoleni, moglie di Di Pietro e madre dei tre figli, compra un piccolo appartamento in via del Pradello a Bergamo. Poche ore dopo acquista anche un ufficio di quattro vani nella stessa palazzina. Spesa approssimativa? Tra i 400 e 500mila euro.
L'anno successivo, come detto, Tonino compra all'asta con offerte segrete la casa di via Locatelli 29, sempre nella città orobica: 178 mq di superficie catastale, 9 vani, il tutto per una cifra molto bassa: 261.661.000 euro. Qualche mese prima si poteva acquistare solo a non meno di 500 mila euro. Mentre l'anno dopo ancora, per una spesa-lavori consistente (decine, se non centinaia, di migliaia di euro) inizia a ristrutturare la masseria di famiglia in quella Montenero di Bisaccia dove l'ex ministro delle Infrastrutture, a dar retta al «catasto dei terreni» possiede 33 «frazionamenti» pari a 16 ettari di proprietà, in parte ereditati, in altra parte acquistati da parenti e familiari. Secondo la Voce (ma ancora non c'è traccia nelle visure camerali) Di Pietro avrebbe acquistato anche un altro appartamento per la figlia, 60 metri in piazza Dergano a Milano. Di Pietro in aula ha spiegato d'essersi dato al mattone dopo aver venduto l'ufficio politico di Busto Arsizio (a 400mila euro, 100mila li ha dovuti restituire alla banca per il mutuo) e con il ricavato ha acquistato gli appartamenti affittati all'IdV: quello di via Felice Casati a Milano - acquistato dalla Iniziative Immobiliari di Gavirano, Gruppo Pirelli Re - e l'altro, in via Principe Eugenio a Roma (alienato nel 2007). Ha detto che se tornasse indietro non rifarebbe quello che ha fatto, anche se la sua passione per gli affari immobiliari ha travalicato i confini nazionali: Tonino possiede infatti il 50% della Suko, una srl bulgara con sede a Varna.
A fronte di quattro milioni di euro spesi per comperare immobili fra il 2002 e il 2008, l'ex pm ha incassato dalle vendite all'incirca un milione di euro, scremati dalle rimanenze calcolate per i mutui. Niente di penalmente rilevante, come dicono gli ex colleghi di Tonino, ma il conflitto d'interessi torna ora d'attualità per gli approfondimenti operati dal mensile «la Voce delle voci» in contemporanea al reportage del Giornale. Si scopre così che il 16 marzo 2006, in quel di Bergamo, il padre-padrone dell'Idv si aggiudica alle buste, in condizioni burrascose e rocambolesche, un signor appartamento a un prezzo scontatissimo dovuto alle cartolarizzazioni del patrimonio immobiliare dell'Inail. Roba da Svendopoli per vip. Lui non appare mai, fa tutto l'amministratore della sua società immobiliare An.to.cri (che però non agisce in questa veste), nonché compagno di Silvana Mura, deputata Idv, tesoriera del partito e socia dell'Associazione IdV. Visti i precedenti, le confusioni di ruoli, le ambiguità fra «movimento» e «associazione», le locazioni degli immobili di proprietà di Di Pietro al partito dello stesso Di Pietro (gli appartamenti di cui parleremo dopo in via Casati a Milano e in via Principe Eugenio a Roma) non è stata una sorpresa scoprire che anche su quest'ultimo immobile qualcosa non quadra: l'ha comprato Di Pietro, attraverso il convivente della Mura, la quale ha intestate le utenze di casa che corrispondono perfettamente a quelle un tempo in uso all'ex sede della tesoreria nazionale di via Taramelli 28.
Ma i conti non tornano lo stesso. «Anziché minacciare a destra e a manca, - dice Capezzone del PDL - Di Pietro dia un po' di spiegazioni, prima di tutto spiegazioni politiche. È vero o falso che esiste una società An.to.cri che gestisce gli immobili citati dal Giornale? È vero o falso che esiste una associazione formata da tre persone, ovvero lui stesso, la tesoriera del partito Silvana Mura e la moglie che di fatto è un'associazione di controllo rispetto al partito?». «Il problema è che Di Pietro - prosegue Capezzone - deve rendersi conto che se chiede il centoeuno di trasparenza agli altri dovrà garantire almeno il 15-20% di trasparenza su se stesso, sennò è tutta roba da ridere. Come mai tutti quelli che hanno fatto intese politiche con Di Pietro se ne sono andati o hanno fatto causa? Magari avranno torto, ma sarebbe interessante capire perché. Oppure sono tutti berlusconiani? Achille Occhetto, Elio Veltri... Insomma, faccia una bella piazza Navona». « Di Pietro vada a piazza Navona e renda note tutte queste risposte al suo pubblico. Vorrei che i moralisti che fanno le prediche facessero un po' di pulizia nel loro pulpito. Il suo amico Marco Travaglio, per esempio: che sta facendo? Si fosse trattato di un esponente del Pdl avrebbe già fatto 4 articoli sull'Unità più 2 videomessaggi. In quale piscina sta a mollo per non accorgersi di queste cose?».
Anche il Corriere della Sera scrive sugli investimenti dell' ex pm, «i conti non tornano». Un milione di entrate e quattro milioni di euro spesi dal 2002 al 2008. Una girandola di appartamenti e immobili tra Milano, Roma, Bergamo, Busto Arsizio, Curno, Montenero e Bruxelles riconducibili a Di Pietro, la famiglia e la società «An.to.cri.», acronimo Anna, Toto e Cristiano, i tre figli. E curiosità varie, tipo gli investimenti attraverso la Suko, una srl bulgara con sede a Varna che Tonino possiede al 50 per cento. O un appartamento di 178 metri quadri acquistato a Bergamo per 261 mila euro grazie alle cartolarizzazioni Inail e non direttamente, ma tramite il compagno della tesoriera dell' Idv Silvana Mura.
«Una campagna di veleni» del «giornale di famiglia» (Berlusconi) che «inventa un'inesistente connessione tra l' Idv e le mie proprietà», replica dal suo blog Di Pietro. «Gli immobili sono stati acquistati, oltre che con i soldi miei, di mia moglie o con i mutui, anche con soldi che Il Giornale ha già dovuto sborsare negli anni per le innumerevoli diffamazioni perpetrate ai miei danni». Così l' ex pm assicura che metterà «in rete copia degli assegni che mi hanno versato». Precisa: «Non prendo soldi dalle casse dell'Idv». E annuncia che «anche il prossimo appartamento lo comprerò col denaro che dovranno pagare per l' ennesima diffamazione».
C' è chi gli dà ragione, «mi sembra una delle tante porcate a suo danno», considera il giornalista Marco Travaglio: «Non mi pare d'aver letto nulla di nuovo, del resto da quindici anni è l' uomo più diffamato d' Europa, con le decine di cause che ha vinto non mi stupisco dei proventi. Che poi l' accusa arrivi dal quotidiano di proprietà di un immobiliarista che con le case ne ha combinate di tutti i colori, mi pare singolare».
C'è chi si morde la lingua, come Achille Occhetto: «Non parlo di Di Pietro. Noi del "Cantiere" abbiamo già querelato il suo partito che ha preso i soldi nostri in campagna elettorale». L' uomo della Bolognina sbotta contro i mass media: «Avete mandato a casa la gente migliore, e questo è il ceto politico che c'è ora in Italia. Tenetevelo».
E poi c' è Elio Veltri, anche lui del Cantiere, un fiume in piena. «Che ha detto Di Pietro?» Nel blog ha scritto... «Nel blog? Ma stiamo scherzando? Perché una società bulgara? Perché una casa comprata da un prestanome che gliela vende in segreto? In qualsiasi Paese europeo un politico che facesse come lui andrebbe a casa domani. Convochi una conferenza stampa, si sottoponga alle domande dei giornalisti. Ci andrò anch'io». A domandare cosa? «Nel '98 fondammo l'Idv. E due anni più tardi Di Pietro creò clandestinamente, all'insaputa del partito - io, vicepresidente, lo ignoravo - un' associazione con lo stesso nome composta da lui, dalla moglie e da Silvana Mura. Ed è l' associazione "Italia dei valori" a incassare il finanziamento pubblico, non il partito dichiarato "contumace" al processo di Roma». La causa sui finanziamenti contesi è ancora in corso a Milano. «Io ne uscii, ma nel Psi di Craxi c'erano più garanzie, i probiviri! Perché ha fatto quell'associazione? Come può prendere soldi pubblici? Perché in Parlamento nessuno dice niente? E poi dicono che Di Pietro attacca la Casta. Un cacchio. La Casta sta zitta. Perché?».
Ma quante case ha l'onorevole Di Pietro? E con quali soldi le ha acquistate? E' vero che il gip di Roma ha messo nero su bianco che Tonino non ha usato un euro del partito, ma rimane il fatto che sono tante case e tanti soldi. Lui dice che le ha acquistate con le querele ai giornalisti, ma noi restiamo trasecolati da tutto questo giro di denaro e di case intestate a moglie, e a figli e a se stesso. L'imponibile di Di Pietro del 2008? Euro 218 mila, poi c'è la casa dei genitori a Montenero di Bisaccia, dove Di Pietro ha anche una casa colonica e un'azienda agricola. Il leader Idv è poi proprietario del 100% della An.To.Cri. spa, proprietaria di un altro appartamento a Milano. C'è poi un pacchetto azionario Enel da 17.500 azioni. La macchina è una Hyunday Santafè.
L'imponibile di Di Pietro nel 2002 era di 463 milioni di lire, nel 2005 era solo di 175 mila euro, nel 2006 di 189 mila euro e nel 2007 di 218 mila euro. Non abbiamo parole. Siamo basiti. Siamo esterefatti. Ha ragione Capezzone (PDL) il signor Di Pietro prima di fare il grande moralizzatore deve agli italiani una risposta esauriente ed esaustiva su case di proprietà e denaro contante per acquistare, visto che il suo imponibile oscilla da anni intorno ai 200 mila euro soldi con cui a Milano compri solo un bilocale più servizi in zona semicentrale.
Anche a proposito del richiamo ai risarcimenti per diffamazione a mezzo stampa c’è qualcosa che non quadra. Come ha salmodiato Marco Travaglio ad Annozero, «negli Usa un giornalista deve controllare una cosa sola, che la notizia sia vera. In Italia ci sono denunce civili e penali ed esposti all’Ordine...».
È il caso di Antonio Di Pietro, uno dei primi ad appoggiare la manifestazione di Roma del 3 ottobre 2009 sulla libertà di stampa. Un vero recordman della querela con oltre 300 cause (357 secondo Repubblica) contro la stampa e ben 700mila euro incassati. Con buona pace del diritto di critica.
"Di Pietro - La storia vera" di Filippo Facci (Mondadori): Tutto quello che pensate su Di Pietro è vero. Purtroppo. E lì lo si documenta.
Su “Panorama” del 30 marzo 2010 esce un’inchiesta sconvolgente sulle frequentazioni di Di Pietro.
In Bulgaria le chiamano Zlatni Piasazi, Sabbie d’oro: chilometri di spiagge larghe e affollate, nella località balneare più chic del Mar Nero. Ogni estate, negli eleganti alberghi della riviera si ritrovano i più facoltosi uomini d’affari del paese. È la sera del 19 agosto 2002: sono passate da poco le 10 di sera. La leggera brezza marina non smorza l’afa: il termometro segna più di 30 gradi. Al primo piano del Grand hotel International, un grattacielo di vetro alto 40 piani, i bocchettoni dell’aria condizionata sparano aria gelida. Ma nel resort a cinque stelle il clima si sta comunque surriscaldando: su una passerella sfilano aspiranti miss, piuttosto discinte. A osservarle dall’alto, nella sala riservata ai vip, c’è Antonio Di Pietro, leader dell’Italia dei valori, a quei tempi europarlamentare. Viene sorpreso da un paparazzo bulgaro: indossa camicia bianca a maniche corte e pantaloni color kaki.
Il fotografo coglie il suo sguardo sorpreso. Sembra preoccupato, Tonino. La sua espressione è probabilmente legata alla «qualità» dei commensali. Davanti a lui, in giacca mattone e maglietta bianca, siede Ilia Pavlov, 42 anni: un multimilionario che sette mesi dopo, il 7 marzo 2003, viene assassinato a Sofia. Un cecchino, nascosto fra i cespugli, lo centra da 70 metri: un solo colpo, dritto al cuore. Ucciso come un boss. Trud, il primo quotidiano bulgaro, annota: «L’omicidio è dovuto a interessi inconciliabili tra gruppi mafiosi». Mai condannato in patria, Pavlov viene considerato un tipo poco raccomandabile dalle polizie di mezzo mondo. Comprese l’Fbi e la Cia.
I sospetti trovano conferma in un dossier del 1998: l’ambasciata americana a Sofia lo invia in via riservata all’Uscis, l’ufficio immigrazione degli Stati Uniti. E si parla di Pavlov in questi termini: «Le società dell’imprenditore sono sospettate di riciclaggio, furti e omicidi».
Anche gli altri convitati hanno un passato oscuro. A capotavola, in camicia a quadretti e giacca color tortora, c’è Ahmed Dogan: 48 anni, leader del Movimento per i diritti e le libertà (Dps), il partito che rappresenta i turchi in Bulgaria. È un personaggio molto discusso. Nel 1986 viene arrestato per attività terroristiche. A quell’epoca è a capo di un gruppo estremista, considerato responsabile di diversi attentati. Il più grave è quello del 9 marzo del 1985 alla stazione di Bunovo, minuscolo paesino a est di Sofia: muoiono sette persone, tra cui due bambini.
Dogan resta in carcere sei mesi e 15 giorni. Viene condannato a 10 anni. Ma nel 1989, dopo la caduta del comunismo in Bulgaria, gli concedono l’amnistia. E Dogan comincia la sua ascesa. Fonda il Dps, che diventa l’ago della bilancia nella politica bulgara. Spesso in totale spregio delle regole elettorali. Nel 2007 Dogan dichiara candidamente: «Comprare voti è una pratica europea, diffusa dalla Seconda guerra mondiale». Tanta disinvoltura costringe la Corte costituzionale bulgara a intervenire. Le elezioni parlamentari del giugno 2009 sono falsate: i giudici annullano migliaia di voti nelle sezioni all’estero. I brogli si concentrano nelle roccheforti del partito di Dogan. I 23 seggi incriminati sono tutti in Turchia e qui il Dps ha ottenuto un plebiscito: 18.140 preferenze su 18.358.
Dogan era fraterno amico di Pavlov. Giornali e politici sottolineano spesso il sodalizio. Lo spiega a Panorama l’europarlamentare bulgaro Dimitar Stojanov: «Il partito di Dogan è il volto politico della nostra mafia. E Pavlov è sempre stato sospettato di essere il braccio economico della criminalità organizzata».
Certamente il leader del partito turco non ha mai avuto problemi di finanziamento. Nel giugno del 2005 dichiara in tv: «Il mio partito è circondato da una serie di imprese. Loro ci danno soldi e noi le aiutiamo». Dove finiscano i fondi resta un mistero. Di certo, e alla luce del sole, Dogan sguazza nel lusso più sfrenato: in Bulgaria vive in residenze da favola. Per i giornali di Sofia, una sarebbe intestata a due prestanome: un ex manovale e un’ex parrucchiera. Ma sono almeno cinque le ville e gli alberghi riconducibili a lui, scrive la stampa.
La sera del 19 agosto 2002, in quella sala esclusiva del Grand hotel International, seduto a fianco di Di Pietro c’è un altro uomo: ha la camicia bianca e i pantaloni blu. Viene immortalato di spalle, ma un’altra foto scattata durante la serata non lascia dubbi. Il signore si chiama Ivan Slavkov: è un assistente di Dogan, poi diventerà assessore del Dps a Varna, a pochi chilometri dalle Sabbie d’oro.
Il 17 ottobre 2008 viene arrestato: «Sfruttamento della prostituzione, riciclaggio e traffico di droga». Per i magistrati è il capo di un’organizzazione criminale di 80 persone. Le sue prime prodezze risalgono al 1996: sei anni prima dell’incontro con Di Pietro. Slavkov è tuttora in carcere.
Il quinto commensale è una distinta donna di mezza età: Tania Tzvetanova Zhelyazkova. Vive tra Sofia e Vigevano, dove ha sposato un italiano. La signora compare anche in altre immagini con il fondatore dell’Italia dei valori: incontri che, a Sofia, Tonino ha con diversi politici e uomini d’affari bulgari. Viaggi istituzionali, perlopiù: dal 2001 al 2006 l’ex pm di Mani pulite è europarlamentare.
Va in missione nel paese balcanico almeno tre volte solo nel 2002: tra aprile e novembre. Mentre in agosto, quando viene sorpreso al concorso di bellezza, Di Pietro è in vacanza. Lo rivela a Panorama la stessa Zhelyazkova. È lei a far conoscere Pavlov al leader dell’Italia dei valori. E perché? «Erano entrambi miei amici» spiega al telefono da Sofia, dove è proprietaria di due aziende. «Conosco Di Pietro da tanti anni: me lo ha presentato il mio dentista, Carmelo Tindiglia».
Il medico è consigliere comunale dell’Idv a Vigevano. E Tania Zhelyazkova è la persona che assiste Di Pietro nelle sue trasferte in Bulgaria. Interpellata sulle frequentazioni sospette dell’ex magistrato, la donna prima chiede a Panorama di inviarle le domande per email: «Risponderò entro mezzogiorno di domani» promette. Salvo poi fare marcia indietro, appena letti i quesiti. Nelle telefonate precedenti con Panorama, Zhelyazkova accenna però anche a un incontro fra Pavlov e Di Pietro: «Si sono visti all’hotel Excelsior di via Veneto» ricorda. «Una cena di lavoro: c’erano anche 30 imprenditori italiani interessati a investire in Bulgaria». E c’era anche Sergio De Gregorio, fondatore dell’Associazione italiani nel mondo. La sua presenza viene confermata dalla stessa Zhelyazkova.
Oggi De Gregorio è senatore del Popolo della libertà. Quell’incontro a Roma lo ha raccontato il 5 febbraio scorso al quotidiano di Sofia 24 Chasa: «Pavlov mi disse di essere l’incarnazione del potere politico ed economico della Bulgaria. Si vantava: “Nel mio paese comandano persone come me”» ha ricordato De Gregorio nell’intervista. «Spiegai a Di Pietro che Pavlov non mi piaceva: parlava e si comportava come un mafioso. Mi rispose che era un grande imprenditore».
Il senatore non lesina dettagli: «Di Pietro aveva intenzione di portare in Bulgaria alcuni imprenditori italiani. Proprio attraverso Pavlov e la sua Multigroup».
La società era la holding del finanziere: la più grande della Bulgaria. All’apice della sua espansione, controlla 120 imprese. Sono attive in tutti i settori, dal turismo all’estrazione mineraria. Un impero costruito dal nulla. Pavlov in gioventù è un campione di lotta: come gran parte dei criminali che spadroneggiano nel paese dopo la fine del comunismo. Ex pugili, pesisti e combattenti ribattezzati dalla stampa bulgara «mutri»: brutti musi. La scalata inizia prima della caduta del regime. È ancora uno studente universitario quando sposa Antoaneta, figlia di Peter Cherghilanov, dal 1973 al 1988 capo dei servizi segreti militari bulgari. È il 1981. Il matrimonio dura solo due anni. Però il legame del rampante finanziere con gli 007 dura tutta la vita. Tanto che affida alcuni posti chiave delle sue aziende a ex agenti.
Un commensale scomodo, per Di Pietro. Che conferma la sua tendenza a intrattenere rapporti conviviali con uomini legati ai servizi segreti. Meno di due mesi fa il Corriere della sera pubblica una foto del 15 dicembre 1992: una cena con carabinieri e uomini dei serviz. L’ex magistrato è accanto a Bruno Contrada, numero tre del Sisde, arrestato nove giorni dopo e poi condannato a 10 anni per «concorso esterno in associazione mafiosa». Di Pietro si è giustificato: «Per me era un funzionario dello Stato, nemmeno lo conoscevo». Ma nel dicembre 1992 la notizia dell’arresto di Contrada circolava da settimane negli ambienti investigativi.
Dieci anni più tardi, in uno sfarzoso hotel di Zlatni Piasazi, l’altra istantanea. Di Pietro siede davanti a Pavlov: un imprenditore in odore di mafia che ha costruito la sua fortuna anche grazie ai legami con gli 007 del regime comunista. Informazioni, stavolta, di pubblico dominio. Contattato più volte da Panorama, Di Pietro non ha voluto commentare le sue frequentazioni bulgare. La mattina di martedì 23 marzo il suo ufficio stampa ha solo fatto sapere che il leader dell’Idv «probabilmente ricorrerà alle vie legali». Senza entrare nel merito dei suoi incontri con Pavlov, né su ogni altro aspetto dell’inchiesta di Panorama.
Dopo il matrimonio con la figlia di Cherghilanov, nel 1988 il magnate conosce l’attrice Darina Gheorghieva, 25 anni. Per le cronache rosa è la «ragazza più bella di Sofia». Sono gli anni in cui Pavlov diventa l’uomo più ricco e potente della Bulgaria: alla sua morte ha un patrimonio di 1,5 miliardi di dollari. La presunta illiceità dei suoi affari è sulla bocca di tutti. L’unico inconveniente giudiziario gli capita nel 1998: il premier Ivan Kostov tenta di incastrarlo per contrabbando. Una delle sue società, la Barteks Trading, è sospettata di avere importato illegalmente 305.914 tonnellate di zucchero. L’azienda paga una multa esorbitante. Ma il finanziere evita il processo per un motivo che sa di beffa. L’inchiesta è archiviata: nessun danno per la concorrenza. Buona parte dello zucchero si sarebbe sciolta con le piogge.
La fama di Pavlov travalica i confini nazionali. Gli Stati Uniti gli negano la cittadinanza per due volte di seguito. Il rapporto dell’ambasciata americana a Sofia parla di riciclaggio, furti e omicidi. È il 1998. Un anno dopo anche la moglie Darina incappa in un incidente diplomatico. Il 22 ottobre 1999 Hillary Clinton, in corsa per diventare senatrice del Congresso, organizza una festa per raccogliere fondi. Alla serata partecipa pure Pavlova, da poco cittadina americana. La donna stacca un assegno di 1.000 dollari per la first lady. Ma il 31 ottobre la donazione viene rispedita al mittente. «Ci sono forti sospetti sulla provenienza dei fondi» dichiara Howard Wolfson, portavoce di Clinton. La notizia fa scalpore: viene ripresa da molti quotidiani e agenzie americane. La signora sconta la poco lusinghiera fama del marito.
L’incontenibile ascesa di Ilia Pavlov termina però il 7 marzo 2003. Sono le 19.50 di un venerdì sera: il finanziere esce dal suo ufficio, nel centro di Sofia. La macchina lo aspetta fuori. L’autista ha già avviato il motore. Pavlov viene trafitto da una pallottola al cuore: muore 20 minuti dopo. Il giorno prima aveva testimoniato al processo per l’assassinio di Andrej Lukanov, l’ex premier bulgaro ucciso nel 1996. Anche lui freddato da un cecchino: un colpo alla testa e uno al petto. Un omicidio per cui viene sospettata la mafia russa. Lukanov era considerato l’artefice della fortuna di Pavlov. Poco prima della morte del primo ministro i rapporti però si erano incrinati. I quotidiani riferiscono di un burrascoso incontro fra i due, avvenuto a Mosca il 30 settembre 1996, due giorni prima dell’uccisione di Lukanov. Il politico sbotta: «Ti ho creato e posso distruggerti». Pavlov risponde a tono: «Non dimenticarti che sono io ora a guidare il treno».
I rapporti tra il finanziere assassinato e Di Pietro vengono confermati a Panorama dall’ex braccio destro di Pavlov, Stojan Denchev, vicepresidente della Multigroup fino a gennaio 2002: «So che si conoscevano. Anzi, erano amici» assicura. Il manager non aggiunge dettagli. Ma le agenzie di stampa bulgare testimoniano che fu proprio Denchev a invitare Di Pietro a Sofia nel novembre del 2002.
È un periodo in cui l’ex magistrato bazzica la Bulgaria non solo in veste istituzionale, ma anche per interessi personali. Il 28 dicembre 2002 a Varna, a pochi chilometri dalle Sabbie d’oro, viene iscritta nel registro bulgaro delle imprese la Suko: una società immobiliare di cui Tonino ha metà delle quote. Un affaire raccontato da Panorama nel novembre del 2007. L’altro 50 per cento è dell’imprenditore Tristano Testa. Di lui si sa poco o nulla. Tranne una sospetta coincidenza: il 26 marzo 2007 diventa consigliere d’amministrazione della Brebemi, l’autostrada Brescia-Bergamo-Milano.
Nello stesso periodo Di Pietro è ministro delle Infrastrutture nel governo guidato da Romano Prodi. Panorama ha cercato di contattare Testa tramite la Brebemi, una società pubblica. Ricevendo però sempre cortesi dinieghi.
Le attività immobiliari di Di Pietro lasciano sorpreso Nicolaj Kamov, un ex parlamentare bulgaro. Uno di quelli che rimase affascinato dalla fama d’integrità dell’ex pm di Mani pulite. Tanto da invitarlo a Sofia nel giugno 2002. «Non sapevo che avesse interessi economici nel nostro paese» dice Kamov a Panorama. «E nemmeno che frequentasse gente come Pavlov. Non sono un magistrato, però la mia opinione su di lui è chiara: era parte della criminalità organizzata. E la sua Multigroup era uno stato nello stato». Anche su Dogan, l’altro commensale di Tonino, il giudizio di Kamov è categorico: «Da vent’anni il suo partito fa brogli elettorali» accusa. «I turchi che non votano per lui sono minacciati. L’ho visto con i miei occhi. L’ho denunciato in parlamento. Ma non è servito a niente».
Le frequentazioni pericolose di Tonino non si limitano però a quelle immortalate la sera dell’elezione di Miss Grand hotel International. A Sofia, Di Pietro incontra anche il deputato Alexander Tomov. L’occasione è una tavola rotonda sulla giustizia. E sei anni dopo, nel 2008, anche Tomov finisce nei guai. In luglio viene indagato come presidente della squadra di calcio del Cska Sofia: avrebbe distratto fondi per 3,5 milioni di euro. La stessa accusa che gli contestano quattro mesi dopo: 15 milioni sottratti dalle casse della Kremikovtzi, la più grande industria metallurgica del paese di cui Tomov era manager. Ora rischia 15 anni di carcere. «Sono una vittima della piovra politica che stritola la Bulgaria» si difende Tomov. E racconta a Panorama dei suoi rendez-vous con Di Pietro: «L’ho visto molte volte, anche all’estero. Sono un suo grande ammiratore e condivido le sue battaglie».
Giudizi lusinghieri. Condivisi anche da Anton Stankov, ex ministro della Giustizia: «Per noi era il simbolo della battaglia contro la criminalità» ricorda. «Tanto che gli ho chiesto consigli per il nostro nuovo codice penale». Tra la primavera e l’estate del 2002, anche Stankov vede Di Pietro un paio di volte. Il 3 giugno 2002 l’ex magistrato è addirittura l’ospite d’onore di un convegno sulla «lotta alla corruzione»: il suo pane quotidiano. Passano due mesi: l’uomo simbolo di Mani pulite si trova a banchettare amabilmente con Pavlov e compagni. Tra i ficus di un lussuoso resort affacciato sul Mar Nero.
Il 25 settembre del 2010 Gianfranco Fini ha fatto questa promessa a tutti gli italiani: "Se dovesse emergere che l'appartamento di Montecarlo appartiene a Tulliani lascerò la presidenza". E’ stato dimostrato che la casa ex AN è stata venduta a prezzi non di mercato al cognato, ma la promessa del Presidente della Camera e di Futuro e Libertà per l’Italia non è stata mantenuta: per la serie, quando la parola data è un impegno d’onore…..
Affari di famiglie secondo Maurizio Caverzan su il Giornale.it. Anzi, di famiglie allargate: mogli, cognati, figli, amici e parenti vari. I tre moschettieri Italo Bocchino, Carmelo Briguglio e Fabio Granata, fedelissimi del presidente della Camera Gianfranco Fini, il D’Artagnan della situazione, grandi moralizzatori della vita politica che hanno combattuto la crociata separatista del Fli «non sembrano immuni dal morbo familistico». Come scrive Panorama nel numero in edicola il 28 gennaio 2011, «negli ultimi anni milioni di euro pubblici sono andati a società amministrate o partecipate da parenti dei tre finiani». In Sicilia ci sono le società che fanno capo alla famiglia Granata e quelle del clan Briguglio. A Napoli invece c’è la ragnatela di Bocchino e consorte.
Ricerca e innovazione, corsi di formazione, sport e eventi sono i campi di azione della galassia di Granata. Dal 2001 al 2006 lui è assessore regionale ai Beni culturali e poi al Turismo. Così, tra il 2005 e il 2006, la Lucas Engine di cui è amministratore Luigi Martines, sposato con Sabrina Cortese, sorella di Paola, moglie di Granata, percepisce la bellezza di 423.450 euro per attività di «promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l’innovazione». Interpellato da Panorama Granata dichiara di non aver «mai dato direttamente contributi a mio cognato, al limite lo hanno fatto altri assessorati». Ma la Lucas Engine che privilegia il settore energetico, ottiene casualmente denaro pubblico (24mila euro) anche per un progetto di studio su bizantini, normanni e svevi in Sicilia proprio durante il suo mandato. Quando Granata torna a Siracusa come vicesindaco, il palazzo a cinque piani che ospita la ragioneria comunale acquistato dalla solita Lucas Engine viene affittato allo stesso comune con contratti prima di sei poi di 10 anni, con una procedura che «ricorda alla lontana quella del cognato per eccellenza: Giancarlo Tulliani». Si resta sempre a Siracusa ma si cambia campo d’intervento con i 351mila euro assegnati in dieci anni da Regione, Provincia e Comune al club sportivo Match Ball (nove campi da tennis e due piscine), a cento metri dal Teatro Greco di Siracusa, di proprietà della moglie di Granata. Con la Cuiform i fondi (non ancora definiti) arrivano invece per un progetto sulla formazione.
Ma la formazione è il terreno d’azione privilegiato dell’altro campione del futurismo, Carmelo Briguglio, messinese che, insieme a Granata, vara il Cufti (Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale), ente pubblico con le quote distribuite a metà tra l’Azienda del turismo di Taormina (area Briguglio) e quella di Siracusa (Granata). Ma anche qui c’è di mezzo una donna. È Crocifissa Maltese, detta Fina, che ha sposato Briguglio in seconde nozze. È lei il dominus del Consorzio, nel quale, distribuiti nei vari organismi, si trovano amici d’infanzia e cognati vari fino a un totale di cinque parenti dell’inflessibile onorevole. Morale, scrive Panorama «dal 2002 a oggi il Cufti, o l’“Ente Briguglio” come l’hanno malevolmente ribattezzato nel Messinese, ha ricevuto dalla regione quasi 16,6 milioni di euro».
Per scavare nell’«impero di carta di Bocchino», invece bisogna spostarsi a Napoli, dove il braccio destro di Fini sfoga la sua «passionaccia per l’editoria». E dove si pubblica il Roma, quotidiano da 4.500 copie che percepisce, attraverso la società di cui è azionista di maggioranza Gabriella Buontempo, mogli di Bocchino, la cifra spropositata di quasi 2,5 milioni di euro l’anno di fondi pubblici. Poi ci sono i finanziamenti ottenuti da L’Indipendente fino a prima della cessione della testata...
Che dire del PD. I “comunisti” con i loro alleati ex avversari: i democristiani. Si considerano da sempre i migliori dal punto di vista intellettuale: o sei con loro o sei nulla. Invece sono ignoranti perché si nutrono solo con cultura sinistroide. Efficienti dal punto di vista amministrativo per favorire al meglio i loro amici a scapito degli altri, creando consenso. Gli avversari non li combattono, li distruggono con la violenza, spesso giudiziaria. Inquadrati ed omologati ad un “Kapo” e alla sua idea conforme e retrograda, che non si discute, ma si impone agli altri. Con le primarie, spesso, l’ala più oltranzista, fondamentalista ed organizzata si impone con il solo 10% di tutto l’elettorato di sinistra.
La nascita del Partito Democratico ha creato le condizioni per una svolta, non soltanto politica, ma anche culturale e morale, nella vicenda italiana. [..] Si è creato così un vuoto politico molto pericoloso, che ha dato spazio alla demagogia populistica, all’arroganza di ristrette oligarchie e anche a poteri opachi che tendono a sottrarsi al controllo della legge e delle istituzioni democratiche. […] Il Partito Democratico sa bene che anche la conquista di nuovi diritti può rivelarsi effimera, se non si afferma un’etica pubblica condivisa, che consenta agli italiani di nutrire un senso più alto dei loro doveri.
Questo è quello che potete leggere sfogliando le 11 pagine del Manifesto dei valori del Partito Democratico, mentre di tutt’altro tenore sono le notizie che arrivano da tutta la Penisola. A Firenze, Napoli, Roma, Genova e Perugia, in Abruzzo, Campania, Toscana e Calabria, nelle carte dell’inchiesta Why Not di Luigi De Magistris, emergono fatti e misfatti molto imbarazzanti per un partito che vorrebbe rilanciare l’etica della politica.
Caso Marrazzo, Del Turco. Inchieste. Arresti. Appalti. Finto tesseramento. Scandali, corruzioni,persino delitti (a Castellammare di Stabia, omicidio di Gino Tommasino, consigliere Pd ucciso da un camorrista iscritto al partito).
Cose dell'altro mondo?
In merito all’arresto di Luigi Bianchini, già coordinatore di un circolo del Pd di Roma e accusato di essere l'autore di diversi stupri nella capitale, "E' incredibile - osserva Marino - che un criminale già coinvolto in odiosi reati possa essere arrivato a coordinare un circolo del Pd". Questo proverebbe "che nel Pd abbiamo una questione morale grande come una montagna, che non può essere ignorata". Il senatore si interroga sui criteri con cui vengono individuati i coordinatori dei circoli. "E' chiaro che non sono scelti liberamente ma imposti - dice - per rispondere agli equilibri delle correnti e senza nemmeno sapere chi siano, che cosa hanno fatto nella vita, se davvero in grado di guidare un circolo, anche dal punto di vista morale".
Le primarie del Pd sono un esaltante esercizio di democrazia partecipata o un'operazione manipolata della volontà dei capibastone? Ognuno può pensarla come meglio crede ed è lecito essere certi che i grandi numeri sbandierati dai responsabili del partito sull'affluenza alle primarie (3 milioni di elettori hanno votato su internet o presso i gazebo autotassandosi con 2 euro) siano realistici, anche perché probabilmente è vero. Bersani, che pur essendo una pedina di D'Alema ha lasciato un ottimo ricordo da Ministro dello Sviluppo Economico, ha vinto abbastanza nettamente ma siamo sicuri che sia andato tutto liscio?
Già in fase precongressuale sono stati sferrati duri attacchi, soprattutto da parte dei sostenitori della mozione Marino, alle procedure di tesseramento e voto nei circoli, in particolare della Campania e della Calabria, ma i tanti casi sono arrivate molte testimonianze di brogli.
A Omnibus (il talk show politico della mattina su La7) è stato dimostrato come una giornalista a Castellammare di Stabia abbia votato addirittura 4 volte nell'arco della stessa giornata.
Alcune perplessità poi ci sono state segnalate anche per la velocità di comunicazione dei dati ufficiali. In un paese in cui i risultati elettorali giungono solitamente con molte ore di ritardo rispetto alla chiusura dei seggi, in questo caso i risultati ufficiosi (frutto di exit poll? Mistero a riguardo) sono giunti pochi minuti dopo la chiusura dei seggi e, incredibilmente, rispecchiano perfettamente lo scrutinio ancora in corso. Incredibile in un paese in cui i sondaggisti fanno solitamente sondaggi avventati e imprecisi.
«La verità è che il pesce puzza dalla testa», sparava a zero in un’intervista Achille Occhetto su Pd e dintorni. Titillato sulla questione morale, l’ex capo della Quercia ammetteva che l’olezzo che emana il suo vecchio partito è forte e proviene da capo, corpo e coda. Prima ancora che il Pd andasse definitivamente in trance col caso Marrazzo, da mesi ombre ben più cupe si allungano sul Partito democratico. Inchieste giudiziarie, sospetti, mala politica e scandali stanno travolgendo gli eredi di Berlinguer dalla Calabria alla Puglia, dalla Basilicata alla Campania, passando per il Lazio. La supposta superiorità morale della sinistra s’è così sciolta come neve al sole in moltissime regioni da loro amministrate.
In Campania il Pd è praticamente finito in una discarica. Qui il governatore Antonio Bassolino è stato rinviato a giudizio su richiesta della Procura di Napoli con ipotesi di reato che vanno dalla frode in pubbliche forniture, alla truffa ai danni dello Stato, abuso d’ufficio, falso e reati ambientali, nel periodo in cui era commissario straordinario per l’emergenza rifiuti. Immondizia che ha infestato la regione per mesi, fino all’intervento col pugno di ferro del governo Berlusconi. Pressato dai suoi affinché lasciasse, Bassolino è rimasto però incollato alla poltrona ripetendo a macchinetta di «avere le mani pulite».
Situazione imbarazzante pure a Napoli dove la giunta guidata da Rossa Russo Iervolino è stata decapitata dall’inchiesta sulla delibera della Global Service, società in gara per aggiudicarsi un mega appalto per una serie consistente di lavori pubblici e manutenzioni di competenza del Comune. Qui in manette sono finiti due assessori e due ex componenti della squadra del sindaco. La quale, di fronte alle accuse e alle relative richieste di farsi da parte, ha avuto lo stesso atteggiamento del suo collega di partito: «Sono una persona per bene, non me ne vado». Grumi di collusione con la camorra a Castellammare di Stabia dove un consigliere comunale del Pd è stato addirittura ucciso da un compagno di partito che frequentava lo stesso circolo.
Più a sud stessa musica. Il governatore della Calabria Agazio Loiero è finito nella celebre maxi inchiesta «Why Not?» e anche per lui è arrivato un avviso di garanzia con accuse pesanti: corruzione semplice e corruzione elettorale. Imbarazzo nel partito e reazione piccata dell’indagato: «Dimostrerò di essere estraneo ai fatti». Chiacchieratissimo pure l’ex vicepresidente della giunta Loiero, attuale capogruppo regionale del Pd e coordinatore del partito, Nicola Adamo. Anche per lui una richiesta di rinvio a giudizio nella medesima inchiesta, dopo aver avuto guai giudiziari per ipotetici finanziamenti «pilotati» che hanno interessato aziende amministrate dalla moglie.
Una vera e propria bufera giudiziaria s’è invece abbattuta sull’ex assessore alla Salute della Regione Puglia e poi senatore piddino, Alberto Tedesco. L’uomo di Vendola, indagato con una quindicina di persone per presunti abusi relativi alla fornitura di servizi da parte di società private ad alcune Asl della regione, si difende: «Le accuse su di me? Falsità». Di fatto, tutti gli atti della giunta Vendola sono finiti nel mirino dei pm della Procura di Bari. Scandalo sanità e scandalo escort ha provocato l'azzeramento della giunta.
Guai giudiziari anche per il Pd in Basilicata dove, nell’indagine che ha portato all’arresto per tangenti dell’amministratore delegato di Total Italia, Lionel Levha, c’è finito pure il deputato Salvatore Margiotta. Richiesta di arresti domiciliari negata da Montecitorio e Tribunale del riesame che ha recentemente annullato il provvedimento. Beghe giudiziarie anche per il presidente della Regione Vito De Filippo, accusato di favoreggiamento e rivelazione di segreto d’ufficio. E beghe politiche: la sua giunta s’era dimessa in blocco a fine 2008.
Insomma, grane su grane, che hanno coinvolto sia i vertici che la base del partito. A Roma, per esempio, è finito in manette un presunto stupratore seriale che poi si è scoperto essere coordinatore di un circolo piddino dell’Eur. «C’è una questione morale grande come una montagna», aveva commentato in quell’occasione il candidato alla guida del partito Ignazio Marino. Concetto opposto a quello espresso dal dalemiano Nicola Latorre: «Nel Pd non esiste una questione morale». Il pesce non sembra aver voglia di decapitarsi.
PARLIAMO DELLA LEGA NORD PADANIA: RAZZISTA? LADRONA? TRAFFICONA? MAFIOSA?
Se è pur vero che politicamente non rappresenta tutti i cittadini del nord Italia, è indiscutibile il fatto che essa incarna il modo di essere e di pensare della quasi totalità di essi: saccenza ed ignoranza; arroganza e presunzione.
La mia ricerca e la mia didattica, non per giudicare, ma per conoscere. Partiamo da quanto scritto da Alberto Custodero su “La Repubblica”.
La Lega secessionista
Dopo gli scandali che l'hanno colpita la Lega Nord torna a parlare di secessione, di Parlamento Padano, di esercito e di moneta da battere. Sembra un ritorno agli anni '90, quando Bossi e i suoi furono vicini al tentativo separatista e, per questo, finirono anche sotto inchiesta. Una legge ad hoc, li salvò. Ma le carte dell'inchiesta dimostrano che facevano piuttosto sul serio.
"All'armi siam leghisti". Così la Lega minacciava lo Stato.
Nel passato della Lega 'di lotta' ci sono episodi che coinvolgono molti degli attuali vertici del partito. In una conversazione telefonica Umberto Bossi si sfoga con l'allora segretario regionale del Veneto del Carroccio Alberto Mazzonetto: "Dobbiamo contestare Scalfaro, non mandate i bambini quando viene in visita". Ecco le intercettazioni, i verbali di interrogatori e persino rapporti del ministero degli Interni che monitorava la mosse secessioniste del movimento. E le carte delle indagini in cui la procura di Verona chiese il rinvio a giudizio per lo stato maggiore della Lega, contestando il reato di cui all'articolo 241 del Codice Penale per aver tentato di "disciogliere l'unità dello Stato italiano mediante disgregazione del suo territorio per creare una nuova entità statuale chiamata Padania". Il reato però è stato depenalizzato dal Parlamento da una legge "ad legam".
Le intercettazioni. Bossi (30 settembre 97) è intercettato al telefono mentre parla con l'allora segretario veneto della Lega, Alberto Mazzonetto. Al quale dice: "Gavremo (Avremo) tutti con il mitragliatore in mano. Sarà una soddisfazione enorme portarmi all'altro mondo il più possibile di questa merda vivente". Bossi incita il segretario veneto ad andare in piazza "a menare la mano", gli dà istruzioni affinchè la visita di Scalfaro sia disertata dai veneti e dai ragazzi delle scuole. "Tutte le volte che viene Scalfaro va contestato". dice il Senatur. E poi gli dice che i bambini devono sventolare la bandiera della Padania, "come ai tempi di Mussolini".
E i discorsi: Maroni arringa la folla padana. (14 settembre 97): Maroni (presidente del Consiglio del governo padano, con interim Poste e telecomunicazioni, e Intelligence) ex ministro dell'Interno. Dice che il governo padano ha in corso una trattativa con lo Stato italiano per ottenere la secessione. Ma la trattativa non ha sortito effetti. Spiega che analoghi episodi di autodeterminazione dei popoli si verificano dal Quebec alla Catalogna, dalla Fiandre alla Scozia al Galles. Maroni annuncia le elezioni politiche della Padania per l'elezione del Parlamento. Annuncia che la Padania avrà due imposte, una diretta sui redditi e una indiretta sui consumi per un prelievo massimo del 25 per cento. Quindi propone di tassare alcune attività illecite, come "la prostituzione, attività commerciale". Prevede che il sistema pensionistico padano sarà contributivo a capitalizzazione. E svela che la sicurezza sarà affidata "alla guardia nazionale padana", mentre i magistrati, eletti dal popolo, dovranno rispondere dei loro errori.
La legge 'ad Legam' che salva il Carroccio. Il testo della legge 24 febbraio 2006, n 85, approvato in scadenza di legislatura dall'allora maggioranza di governo (Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega e Udc), che ha modificato gli articoli del codice penale che si riferiscono all'attentato contro l'integrità, la Costituzione e i simboli dello Stato. Nella "normativa precedente" compare (art. 241 del codice penale) ancora la dicitura originale "è punito con la morte", in realtà, ovviamente, la pena era stata già da tempo sostituita con l'ergastolo. Questi reati sono quelli per cui sono stati imputati a Verona Bossi, Maroni, Calderoli, Borghezio e altri dirigenti del partito. Il processo è ancora in corso ma loro, ormai, ne sono usciti.
Parlamento, esercito e moneta. Torna il progetto separatista della Lega. Bossi ne ha riparlato recentemente a Mantova. Con toni forse più soft. Ma i temi sono gli stessi del tentativo che mandò sotto inchiesta (con reati, allora, da ergastolo) 41 dirigenti del Carroccio. Poi, con un colpo di mano, il codice è stato cambiato e il Senatùr e gli altri leader sono usciti dal processo. Ma Borghezio ricorda che si faceva sul serio e parla di "un tintinnio di sciabole".
Allarme siam leghisti. E secessionisti. Fallita la secessione dei "fucili" degli anni Novanta ("... che gavremo tutti il mitragliatore in mano..." disse Bossi ad Alberto Mazzonetto, segretario della Lega veneta, in una famosa telefonata intercettata dalla Digos). Abortita quella "istituzionale" del federalismo durante il decennio di governo col Pdl, ora Bossi ci prova ancora. E per rilanciare l'attuale stagione di moti separatisti padani, utilizza una nuova formula di secessione. Questa volta la chiama "consensuale". Oppure "morbida", sul modello Cecoslovacchia . "Abbiamo Veneto e Piemonte - dice - parleremo con Formigoni per capire se ci sta. Poi tocca a Trentino Friuli Valle d'Aosta e Liguria per formare la Padania, una macroregione che incorpora Svizzera, lander tedeschi e porzioni dell'Austria". Questo è il suo slogan politico per lo scampolo di legislatura che restava fino al 2013. Ma l'inno alla Padania che s'è levato a metà dicembre 2011 a Vicenza (sede del parlamento del Nord presieduto dall'ex ministro Roberto Calderoli) da uno stato maggiore leghista schiacciato a Roma in una rumorosa opposizione, si riallaccia ideologicamente e politicamente, senza soluzione di continuità, a quello di 15 anni prima. Quando la Lega, mutuando il linguaggio resistenziale, fondò (sulla falsa riga del Cln che s'oppose a nazisti e fascisti), il Clp, il Comitato di Liberazione padano (liberazione da Roma ladrona, mutatis mutandis). Costituì quindi "una complessa e articolata struttura militare", le "camicie verdi" o "guardia nazionale padana" alle dipendenze di Roberto Maroni. Tentò anche "di ottenere il riconoscimento da parte della comunità internazionale" destando l'interesse (lo ha rivelato a Repubblica l'europarlamentare leghista Mario Borghezio), "di alcune cancellerie europee. E perfino della Cina". Convocò infine "apposite elezioni padane per eleggere i rappresentanti del governo e del parlamento della Padania". Con tanto di ministri e ministeri: Maroni presidente del consiglio con l'interim di poste e intelligence, vicepresidente Gnutti, Economia Pagliarini, Interno Borghezio, Difesa Bampo, Immigrazione Ramadam. E così via. Allora il moto secessionista di Bossi suscitò la reazione della magistratura: il procuratore di Verona, Guido Papalia, mise sotto accusa quarantuno esponenti leghisti e fra questi tutti i parlamentari (da Bossi a Gnutti a Maroni, da Speroni a Borghezio, referente, quest'ultimo dell'associazione dei giovani leghisti Sole delle Alpi). Il procuratore veronese incaricò le Digos (allora coordinate dal direttore dell'Ucigos, prefetto Carlo De Stefano) di svolgere indagini, pedinamenti e intercettazioni telefoniche. Era proprio De Stefano che, per conto del capo della Polizia, teneva aggiornato l'allora preoccupatissimo titolare dell'Interno Giorgio Napolitano di ogni mossa dei secessionisti del Carroccio. "La Lega - scriveva, ad esempio, De Stefano in un appunto riservatissimo a Napolitano - avrebbe istituito un nucleo scorte di 15 persone autorizzate a reagire contro chiunque ostacolasse il loro servizio". Ma il reato da ergastolo che Papalia contestò agli esponenti leghisti "secessionisti", il 241 del codice penale ("per aver commesso atti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano mediante disgregazione del suo territorio e la costituzione della Padania"), è stato depenalizzato nel 2006. A proporre quella legge salva-processo fu l'onorevole Carolina Lussana (deputata leghista lombarda che ha dato l'esame da avvocato a Napoli), la votarono Fi, Lega, Udc, si astennero i Verdi, contrari Margherita e Ds con la motivazione che non si trattava di un provvedimento "a favore della libertà d'opinione", così com'era stato spacciato. Ma di una vera e propria norma "ad legam". Dopo 15 anni scanditi da conflitti di attribuzione costituzionali, ricorsi e controricorsi, il processo, incredibilmente, è ancora in corso. Tutti gli onorevoli, però, si sono salvati grazie alla legge che si sono votati e beneficiando altresì della tutela (anche in questo caso autovotata) dell'insindacabilità parlamentare. Alle udienze dibattimentali ancora in corso compaiono alla sbarra "solo" una cinquantina di militanti, figure minori della stagione secessionista degli anni Novanta. E oggi che torna d'attualità la secessione leghista, sulla scena politica spunta, forse non a caso, l'ex capo dell'Ucigos, De Stefano, nominato sottosegretario al ministero dell'Interno, mentre è ancora Napolitano - ieri dal Viminale, poi dal Quirinale - a vigilare politicamente contro il separatismo di Bossi e "compagni" appellandosi, con autorevoli moniti, all'unità d'Italia. Sono cambiate molte cose in questi ultimi 15 anni. Il contesto politico del 2012, rispetto al '97, è radicalmente cambiato. Allora la stagione berlusconiana era agli albori. Ora è al tramonto. Allora s'era appena passati dalla prima alla seconda Repubblica, ora Napolitano sta traghettando il Paese verso la Terza. Allora l'economia italiana si stava riprendendo dai contraccolpi di Tangentopoli e del crollo del Caf, oggi il Paese, indebolito dal terzo debito pubblico del mondo e dall'incipit di una recessione, è investito in pieno da una crisi internazionale. Allora c'era la lira e le frontiere erano protette dalle barriere doganali, oggi siamo nell'eurozone con la moneta unica e il trattato di Schengen. Allora il Carroccio aveva coniato monete e banconote, scudi e leghe padane, allarmando - come testimoniato da Borghezio - le più alte cariche dello Stato. E financo la Banca d'Italia. Oggi Bossi torna a parlare di un nuovo conio padano: "Avremo la nostra valuta - annuncia dal parlamento di Mantova - una volta finito l'euro, la Padania non tornerà alla lira, ma si farà una sua moneta". Allora il Carroccio aveva addirittura organizzato una propria "polizia", le camicie verdi maroniane appunto, destinate a costituire le forze armate padane. "Nel momento in cui il vento secessionista soffiò con forza - ricorda Borghezio - s'avvertì un tintinnar di sciabole. E fra le gerarchie militari ci fu chi guardò con interesse alla Padania". Fu in quel periodo che - come ha rivelato l'ex presidente leghista della Camera, Irene Pivetti, al pm Papalia - Maroni, in qualità di "responsabile dell'ufficio esteri della segreteria politica di via Bellerio, teneva rapporti con i movimenti indipendentisti, secessionisti e autonomisti operanti all'estero come baschi, catalani e scozzesi per costituire l'Internazionale indipendentista". Fu in quel retroscena che s'inquadrò la visita di Vladimir Zhirinovskij, il capo del partito ultranazionalista russo ed ex ufficiale dell'Armata Rossa, al quartier generale della Lega di Milano. Nel 2012 il Senatur torna a parlare di struttura militare: "Avremo il nostro esercito", avverte minaccioso da Vicenza. Nonostante tutti questi cambiamenti, Bossi vede oggi nel combinato disposto della crisi economica e di quella della politica la congiuntura ideale per tirare fuori dal cassetto il vecchio progetto separatista, un po' impolverato, ma, come confermato dall'europarlamentare torinese, mai abbandonato. Questo progetto del Senatur, va ricordato, mira a spezzare il circolo - per lui - vizioso di un Nord che riceve solo una parte delle tasse che invia a Roma, mentre l'altra serve a "Roma ladrona" per comprare con le clientele voti al Sud e riottenere, all'infinito, la riconferma del potere romano. Non caso Maroni nel '97 aveva "annunciato" il sistema fiscale padano fondato su due imposte, una diretta sui redditi e l'altra indiretta sui consumi con un tetto impositivo non superiore al 25 per cento". E sull'imposizione fiscale di "attività illecite commerciali, come la prostituzione". Il leader del Carroccio, mentre è in corso all'interno della Lega una resa dei conti tra i bossiani del "cerchio magico" e i maroniani, ha dato il via segretamente alla fase 2 del suo progetto secessionista, ovvero la fondazione della Lega in Sicilia per poter schiacciare Roma nella morsa di una doppia forza separatista: una dal Settentrione, e una dal Meridione. Per favorire il distacco Nord-Sud, il leader leghista questa volta approfitta dello stato di sofferenza che attraversa il Paese, evocando uno scenario post bellico e facendo leva sullo stato di emergenza che ha portato a Palazzo Chigi un governo di tecnici. "L'Italia ha perso nella guerra economica", spiega Bossi dal parlamento di Mantova. "E noi della Padania - aggiunge - da popolo vincitore dobbiamo essere pronti a scrivere i trattati per l'Europa dei popoli". Slogan come "l'Italia ha perso, la Padania vincerà", "Libertà, Roma ladrona", "L'Italia va giù e la Padania va su" sono diventati il mantra ideologico di un Carroccio che dopo la stagione dell'asse di ferro con Berlusconi, ha scelto di isolarsi politicamente all'opposizione. Toccherà a Roberto Maroni, ex presidente del Consiglio della Repubblica padana, ed ex ministro dell'Interno di quella italiana, fare - per usare le parole di Calderoli, "l'ambasciatore a Roma" delle istanze padane. E "fare il culo a Monti in Parlamento".
"Il Banco di Napoli? Troppo sudista. Anzi no, adesso è venuto al Nord". Dalle carte del processo di Verona emerge una vicenda sconcertante. L'istituto partenopeo era concessionario (dal 1871) degli sportelli interni al Parlamento. Con la Pivetti presidente a Montecitorio, i leghisti volevano cacciarlo. Ma invertirono rapidamente rotta quando si seppe che la Bipop stava per acquistarlo. E anche oggi... Una banca “meridionale” (il Banco di Napoli), all’interno del Parlamento non piaceva ai leghisti che volevano cacciarla. Ma gli uomini del Carroccio cambiarono idea quando quegli sportelli bancari “meridionali” per deputati furono acquistati da un istituto bancario settentrionale, il Banco Popolare di Brescia, nel 2007 entrato nel gruppo Ubi. A rivelare questo giallo sulla mancata “espulsione” da Montecitorio del Banco di Napoli è stata l’ex presidente leghista della Camera, Irene Pivetti, in un interrogatorio reso al procuratore di Verona Guido Papalia e al sostituto Antonino Condorelli. “Durante il mio periodo di presidenza – racconta ai pm la Pivetti - si è verificata una vicenda abbastanza sconcertante riguardante il Banco di Napoli”. “Ricordo – aggiunge - che io avevo intenzione di ridiscutere la questione relativa alla concessione ad un istituto di credito dell’agenzia bancaria all’interno della Camera dei deputati, concessione che dal 1871 è stata da sempre riconosciuta al Banco di Napoli”. “Per questo motivo – dice ancora l’ex presidente della Camera – ho predisposto una gara di appalto e ricordo che dopo l’apertura delle buste il Banco di Napoli è risultato tra gli ultimi istituti partecipanti. Nonostante ciò l’istituto partenopeo ha fatto pressione su tutti i componenti l’ufficio di presidenza per ottenere la riammissione nella rosa ristretta dei primi aventi diritto a partecipare alla gara definitiva”. “Ricordo – spiega la Pivetti – che protestai duramente per questa procedura esternando le mie proteste a tutti i componenti della presidenza e primi fra tutti Balocchi”. Maurizio Balocchi era il segretario amministrativo della Lega, nonché questore della Camera. “Notai allora con mia grande sorpresa – continua l’interrogatorio – che Balocchi, che in un primo tempo s’era dimostrato particolarmente ostile al Banco di Napoli, aveva cambiato opinione mostrando di voler accogliere le richieste di quella banca. Quel suo cambiamento fu decisivo per l’ammissione in gara della concessione al Banco di Napoli in quanto i voti leghisti allora erano determinanti”. Ma cos’era successo in quel periodo alla Camera? Perché il voltafaccia dei Lumbard che prima volevano far fuori dalla Camera il Banco di Napoli, e poi addirittura votarono per riammetterlo quando non aveva più i titoli per partecipare al bando?. Il finire degli anni Novanta fu un periodo di grande confusione del mondo bancario tra acquisizioni, fusioni, incorporamenti e cessione di sportelli tra un gruppo finanziario e l'altro per aggirare trust e per consolidare i mercati. Operazioni in qualche caso finite in clamorosi crac. Bipop dopo svariate traversie alla fine del Duemila sarebbe poi confluita in Unicredit, mentre il Banco di Napoli (compresa il tanto "discusso" sportello della Camera), in Intesa San Paolo. Il retroscena di questa strana manovra politico-finanziaria tutta in casa Carroccio è svelato dalle carte giudiziarie del processo di Verona. Il motivo del cambio di rotta leghista sta con ogni probabilità nell’acquisizione dell’istituto napoletano da parte di un istituto settentrionale, per questo più gradito agli uomini di Bossi. Il procuratore di Verona su quella operazione avviò un’indagine giudiziaria, incaricando il professor Franco Della Sega e il dottor Maurizio Grassano di “accertare il prezzo, le modalità dell’acquisizione e del pagamento". E stando alla perizia contabile disposta dalla procura, la Banca Popolare di Brescia acquistò tra il ’96 e il ’97 – e dunque proprio nel periodo delle manovre leghista antipartenopee a Montecitorio - le 50 filiali del Banco di Napoli. I ct accertarono che il prezzo di acquisto fu di duecentonovanta miliardi di vecchie lire pagati dalla Bipop in due tranche, una di 247 il 28 ottobre ’96, l’altra di 42 il 20 marzo ’97. Alla fine della complessa operazione, l’istituto creditizio bresciano accumulò una situazione debitoria complessiva di circa mille miliardi, procurandosi le risorse necessarie all’acquisto sia tramite il ricorso al mercato interbancario, sia (per ovviare a un conseguente deficit patrimoniale), tramite l’emissione di un prestito obbligazionario Bipop per circa 250 miliardi quotato prima alla Borsa Valori lussemburghese. E solo in un secondo tempo in quella italiana. Il procuratore veronese a tal riguardo aveva chiesto ai suoi consulenti anche di trovare “i sottoscrittori di quelle obbligazioni”, individuati in “banche d’affari, istituti di credito e fondi comuni di investimento”. Il passaggio di proprietà da Napoli alla più padana Brescia, ecco spiegato il voltafaccia della Lega alla Camera. Ma c’è di più. Il maresciallo Carlo Alesci della polizia giudiziaria veronese accertò nel ’98 che, una volta passato nelle mani dei banchieri settentrionali, “il Banco di Napoli aveva svolto articolate trattative con la Lega per concederle un mutuo necessario all’acquisto della sede del Carroccio a Milano in via Bellerio”. Trattative che, però, osserva il maresciallo, non andarono a buon fine. Il Banco di Napoli “bresciano” torna, anche se marginalmente, nelle “relazioni” della polizia giudiziaria relative alle indagini sull’acquisto da parte della Lega dei gazebo usati per il referendum secessionista del 1997. Ebbene, tutti quei gazebo furono pagati per circa 750 milioni di vecchie lire con assegni firmati da Balocchi ed “emessi dall’agenzia numero uno del Banco di Napoli, sportello interno a Montecitorio, dal conto corrente intestato alla Lega Nord, Italia Federale”. Il Banco di Napoli della Camera pare non avere pace. Dopo la Pivetti negli anni Novanta, ad occuparsene, nel Duemila, è il deputato radicale Rita Bernardini che da anni ha messo sotto la lente d’ingrandimento i conti della Camera. Il 29 settembre del 2009 ci fu una delibera dei Questori di Montecitorio con la quale s’è disposta la proroga della convenzione col Banco di Napoli fino al 31 dicembre 2010. Contestualmente s’è deliberato l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della nuova convenzione. Anche nel 2012i, però, pare che ci sia un giallo. Lo conferma la stessa Bernardini: “Nonostante le mie richieste di informazioni – dichiara la deputata radicale – dell’attuazione della delibera dei Questori di un anno fa non ho saputo più nulla. Né si trova nulla, sotto la voce gare pubblicche, sul sito www.camera.it”. Che siano intervenuti anche questa volta misteriosi protettori del “lombardo” Banco di Napoli?
Quelle "camicie verdi" armate che dovevano proteggere il Senatùr.
Documenti e testimonianze raccontano di una vera e propria struttura clandestina incaricata di salvaguardare l'incolumità del "capo". Avevano pistole regolarmente denunciate o con matricole abrase. Qualche volta vennero "beccati" da uomini della Digos e denunciati per porto d'armi abusivo. Una struttura clandestina di "camicie "verdi", uomini armati pronti a tutto, proteggeva Bossi ai tempi della secessione degli anni Novanta. Il particolare è stato svelato dalle carte del processo di Verona del procuratore Papalia. Tutto ha avuto inizio il 14 settembre del 1996 durante il rituale padano dell'attraversamento del Po di Umberto Bossi a Boretto di Reggio Emilia. In quel frangente, si legge in una relazione della Digos di Verona, "a uno degli uomini della sicurezza personale del parlamentare cadeva un'arma". Il particolare, ovviamente, non sfuggì ai poliziotti che seguivano passo passo, per conto della magistratura, gli sviluppi politici della "secessione" leghista. "L'uomo - si legge nell'appunto riservato della polizia - veniva identificato per Ferrari Fabio, figlio di Genesio, segretario provinciale della Lega di Reggio Emilia. L'arma del Ferrari, regolarmente denunciata, aveva la canna priva del previsto numero di matricola". La Digos a quel punto perquisì la casa del bodyguard in camicia verde denunciandolo dopo aver "rinvenuto e sequestrato una ulteriore arma", questa volta "priva del numero di matricola perché abraso". Poco più di un mese dopo, sempre la questura di Verona scoprì che in un comizio svoltosi a Rovigo, un agente della Digos di scorta a Bossi "fu minacciato da parte di uno della security personale" del leader leghista. L'uomo, Locatelli Aurelio, armato di pistola, "pur essendo dotato di licenza di porto d'armi", fu comunque denunciato "per aver portato l'arma nel corso di una pubblica manifestazione". Le indagini sulle camicie verdi e sulla guardia nazionale padana proseguirono fino a quando, nel settembre '97, ci fu una svolta. Carlo De Stefano, il capo dell'Ucigos, l'antiterrorismo dal quale dipendono tutte le Digos, firmò - utilizzando la formula "per il capo della Polizia" - un rapporto riservatissimo sulla scorta personale di Bossi composta da uomini armati indirizzata all'allora ministro dell'Interno, Giorgio Napolitano. "Il 3 agosto '97 - scriveva il capo dell'Ucigos - in Rovato, provincia di Brescia, s'è svolta la terza festa della Lega Franciacorta alla quale parteciparono, tra gli altri, gli onorevoli Pagliarini, Molgora e Tirelli". "All'interno della vettura sulla quale viaggiava Pagliarini, intestata a Davoli Matteo, operaio, c'era un lampeggiante del tipo in uso alle Forze di Polizia, nonché una paletta del 118". Le indagini, riferisce De Stefano, accertarono che "la Lega avrebbe istituito un "nucleo scorte" composto da una quindicina di persone provenienti da diverse località della Regione, e coordinate da un responsabile di Milano presso la sede di via Bellerio". "Le persone preposte alla scorta - concludeva con preoccupazione la nota riservata del prefetto De Stefano - sarebbero autorizzate a reagire contro chiunque ostacolasse il loro servizio".
La Lega trafficona
Questa è la definizione che dà “La Repubblica” alla sua inchiesta. Così la definisce: C'era una volta "Roma ladrona". Adesso al centro dell'attenzione della nuova Tangentopoli c'è il Carroccio. Dall'inchiesta sul tesoriere Belsito, che ha portato alle dimissioni di Bossi, alle vecchie e delicate vicende bancarie, fino alle mazzette all'amico Brancher e a una cinquantina di casi "minori" che vanno dalla corruzione alla "parentopoli" in salsa da Giussano.
Escort, mazzette ed evasioni. La carica dei 'mariuoli' padani.
· LOMBARDIA Dario Ghezzi – Ex capo della segreteria di Boni. Accusato di corruzione nella stessa inchiesta. Si è dimesso il 13 marzo 2012;
· LOMBARDIA Marco Paoletti – Consigliere regionale leghista, accusato di corruzione nell'inchiesta che coinvolge anche Boni e Ghezzi. E' stato espulso dal partito;
· LOMBARDIA Monica Rizzi –Ex assessore allo Sport della Regione Lombardia, indagata dalla procura di Milano per abuso di titolo (dichiarava una laurea mai ottenuta) e dalla procura di Brescia per trattamento illecito di dati personali (è accusata di aver realizzato falsi dossier contro altri esponenti leghisti per favorire l'ascesa al Pirellone di Renzo Bossi). Si è dimessa dall'incarico il 16 aprile 20121;
· LOMBARDIA Francesco Belsito – Ex tesoriere del Carroccio, indagato per frode e finanziamento illecito di partiti. Si è dimesso in seguito alla maxi inchiesta della procura di Milano;
· LOMBARDIA Angelo Ciocca – Consigliere regionale della Lombardia, è stato il più votato tra gli esponenti del Carroccio ad essere eletto. E' stato coinvolto, senza essere indagato, nell'inchiesta della Dda di Pavia sulle infiltrazioni 'ndrangheta al nord per i suoi presunti rapporti con l'avvocato Pino Neri, considerato uno dei capi dell'organizzazione criminale al nord;
· LOMBARDIA Roberto Castelli – Indagato per abuso d'ufficio per il suo piano di edilizia carceraria, da ministro della Giustizia, affidato all'amico Giuseppe Magni. E' stato condannato della Corte dei Conti a rimborsare 33 mila euro perché la consulenza era "irrazionale e illegittima";
· LOMBARDIA Luca Talice – Ex assessore alla sicurezza della Provincia di Monza, è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale nei confronti di due militanti del Carroccio;
· LOMBARDIA Fabio Rolfi – Ex vicesindaco di Brescia, indagato nel 2010 per peculato. Avrebbe messo in conto al comune circa 2000 euro di spese per cene svolte in giorni festivi;
· LOMBARDIA Roberto Manenti – Ex sindaco di Rovato, in provincia di Brescia, condannato per stupro nel 2009. Sarebbe stato responsabile di alcuni episodi di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza romena. Manenti si è ripresentato come candidato sindaco della Lega Lombardo Veneta alle elezioni amministrative che si terranno a Rovato nel 2012;
· LOMBARDIA Aldo Fumagalli – Ex sindaco di Varese, è sotto processo per peculato e concussione. Tra i fatti contestati, anche la presunta pressione su alcune cooperative in affari con il Comune per l'assunzione di alcune amiche. E' uscito dalla Lega nord e ha aderito alla Democrazione Cristiana;
· LOMBARDIA Alessandro Patelli – Il "pirla", come fu definito da Umberto Bossi. Ex tesoriere della Lega, ammise nel 1993 di aver incassato 200 milioni di lire dal gruppo Ferruzzi, azionista di maggioranza della Montedison, causando a Umberto Bossi una condanna per finanziamento illecito nell'ambito del processo Enimont;
· LOMBARDIA Mauro Galeazzi – Ex assessore ai lavori pubblici di Castel Mella, in provincia di Brescia, arrestato nel 2011 con l'accusa di peculato e corruzione è stato poi prosciolto per il primo reato;
· LOMBARDIA Marco Rigosa – Capo ufficio tecnico e assessore di Rodenigo Saiano, nel bresciano, ancora indagato nella inchiesta che coinvolge Galeazzi per il presunto reato di corruzione;
· LOMBARDIA Giampaolo Maloberti – Ex consigliere provinciale a Piacenza, condannato per truffa i danni dello Stato dal Tribunale di Milano per non aver pagato le multe dovute allo sforamento delle quote latte;
· LOMBARDIA Davide Allegri – Assessore all' Urbanistica del comune di Cortemaggiore, nel piacentino, indagato per concussione e abuso di ufficio. Si è dimesso dall'Amministrazione;
· VENETO Marino Finozzi – Assessore regionale al turismo in Veneto, indagato per truffa a danno di un creditore nel 2010. Il suo nome, secondo quanto riferisce l'Espresso, comparirebbe anche nel filone reggino dell'inchiesta che vede coinvolto Belsito per truffa ai danni dello Stato;
· VENETO Cesare Biasin – Ex sindaco di Silea, in provincia di Treviso, ora consigliere comunale. Imputato per sfruttamento della prostituzione, il processo è in corso. E stato espulso dal partito nel 2010;
· VENETO Luigino Vascon – Assessore all'agricoltura della Provincia di Vicenza, è stato indagato per furto d'acqua, ma il reato è andato prescritto;
· VENETO Gianfranco Vivian – Esponente vicentino del Carroccio vicino alla parlamentare Manuela del Lago ha patteggiato una condanna per appropriazione indebita;
· VENETO Alessia Segantini – Sindaco di Zimella in provincia di Verona, indagata per concorso nel reato di riciclaggio dalla procura scaligera. A dicembre 2011 i pm ne hanno chiesto il rinvio a giudizio;
· VENETO Alberto Filippi – Senatore di Vicenza, è sotto inchiesta per evasione fiscale e false fatturazioni, è stato espulso dal partito;
· VENETO David Codognotto – Ex assessore a San Michele al Tagliaemento, nel vicentino. Colto in flagranza di reato ad aver intascato una tangente da 15mila euro, è accusato di concussione. E' stato espulso dal partito;
· VENETO Alessandro Costa – Ex vigile urbano e assessore alla sicurezza nel Comune di Barbarano Vicentino. E' indagato per sfruttamento della prostituzione: gestiva siti di annunci a luci rosse. Si è dimesso dall'incarico ed è stato sospeso dal partito;
· VENETO Massimo Signorin – Vicesindaco di Arzignano, in provincia di Vicenza, espulso dalla Lega, indagato per evasione fiscale totale e distruzione di documenti contabili. Avrebbe evaso 500mila euro al fisco 2.
· VENETO Tiberio Businaro – Sindaco di Carceri, in provincia di Padova. Sotto inchiesta per bancarotta e falso ideologico, è stato sospeso dal partito. Sarebbe, secondo gli investigatori, coinvolto in affari con una holding campana vicina alla camorra;
· VENETO Camillo Gambin – Storico esponente del Carroccio ad Albaredo d'Adige (Verona), arrestato nel 2010 per falsi permessi di soggiorno rilasciati in cambio di denaro;
· VENETO Gianluigi Soardi – Sindaco leghista di Sommacampagna, in provincia di Verona, ed ex presidente dell'azienda del trasporto pubblico cittadino Atv. Incarico che ha lasciato in seguito alle indagini della procura di Verona su presunte spese gonfiate e ingiustificate. E' stato condannato a tre anni e due mesi per peculato;
· EMILIA ROMAGNA Gianluca Pini – Segretario della Lega Nord in Romagna, indagato dalla procura di Forlì per millantato credito. Avrebbe ricevuto 15mila euro da un avvocato per favorire l'esito positivo del suo esame al concorso per notai;
· EMILIA ROMAGNA Angelo Alessandri – Esponente di spicco della Lega in Emilia Romagna, ha collezionato 70 multe per eccesso di velocità tra il 2008 e il 2009. Ne ha impugnate 58, chiamando in causa la norma che autorizza le auto blu con scorta a superare i limiti di velocità in caso di provate esigenze istituzionali. Le altre dodici sono state invece messe in conto al partito perché, secondo Alessandri, si trattava di eventi legati alla propria attività politica. Un conto, questo, da circa tremila euro;
· EMILIA ROMAGNA Marco Lusetti – Vicesindaco di Guastalla (Reggio Emilia), nel 2010 è stato accusato di irregolarità nella gestione dell'Enci (Ente nazionale per la cinofilia) di cui era commissario ad acta: avrebbe ordinato a se stesso bonifici per 187 mila euro, senza incassarli, con soldi dell'ente;
· EMILIA ROMAGNA Fabio Rainieri – Deputato della Lega, a processo per dichiarazione fraudolenta tramite false fatture. Sul procedimento interverrà la prescrizione;
· PIEMONTE Matteo Brigandì – Ex assessore al Bilancio della Regione Piemonte, è stato processato per truffa, a causa di falsi rimborsi nelle zone alluvionate. Condannato in primo grado, assolto in appello. Ex membro del Csm, venne allontanato con l'accusa di aver fornito a "Il Giornale" i documenti che riguardavano un vecchio provvedimento disciplinare nei confronti di Ilda Boccassini;
· FRIULI VENEZIA GIULIA Edouard Ballaman – Ex presidente del consiglio regionale friulano, si è dimesso dopo essere finito nel mirino della Corte dei conti per una settantina di viaggi non giustificati fatti in auto blu. E' sotto processo per peculato, oggi siede in Parlamento;
· FRIULI VENEZIA GIULIA Enrico Cavaliere –Ex presidente del consiglio regionale del Veneto, imputato insieme a Stefani nello stesso processo, assolto nel dicembre 2011;
· FRIULI VENEZIA GIULIA Stefano Stefani – Senatore della Lega Nord, processato per bancarotta a Udine per il crack della società Euroservice, in seguito a una complessa operazione immobiliare ideata, secondo l'accusa, per finanziare il Carroccio. E' stato assolto in primo grado. In passato è stato anche componente del Cda di Credieuronord la banca voluta dalla Lega e naufragata nei debiti;
· FRIULI VENEZIA GIULIA Maurizio Balocchi – Ex tesoriere della lega ed ex sottosegretario all'Interno. Protagonista di uno scambio di favori incrociati con Ballaman. Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', avrebbero assunto uno la compagna dell'altro, per aggirare la legge che vieta di assumere parenti nel medesimo ufficio. E' morto nel 2010.
Dal Piemonte al Veneto, gli affari di famiglia.
· PIRELLONE Cavalli d'oro – Nel 2008 la moglie di Giancarlo Giorgetti, deputato ed esponente di spicco del Carroccio, ha patteggiato una condanna a due mesi e dieci giorni per truffa a enti pubblici. La moglie del politico leghista, titolare di corsi di equitazione in una onlus, aveva "gonfiato" il numero degli allievi dei corsi di formazione per ottenere 400mila euro di finanziamento dal Pirellone;
· IL FRATELLO Franco Bossi in Europa – Ha studiato fino alla terza media, ma è riuscito a diventare assistente parlamentare di Matteo Salvini dal 2004 al 2009 al Parlamento Europeo con uno stipendio lordo di 12.750 euro al mese;
· LA MOGLIE Manuela Marrone e la scuola Padana – Maestra elementare, 57 anni, è sposata con il Senatùr dal 1984. Con lui ha fondato la Lega Nord. Nel 1998 ha costituito a Varese la “Libera Scuola dei Popoli Padani” detta “Bosina” (dalla materna al liceo linguistico, tutte paritarie) retta da una cooperativa. Una scuola nata “in contrapposizione alla riforma che prevede fino a sette insegnanti diversi invece della maestra unica”. Tra il 2008 e il 2009, la “Bosina” ha ricevuto dallo Stato prima 300 e poi 500 mila euro per “ampliamento e ristrutturazione” dell’edificio in cui ha sede. I soldi sono arrivati dal “Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio” detto più prosaicamente “legge mancia”;
· PIEMONTE La figlia del capogruppo – Michela Carossa, figlia del capogruppo della Lega Nord alla regione Piemonte, è responsabile del gruppo politico femminile leghista di Torino. Adesso lavora alla segreteria del presidente della Regione, Roberto Cota. Nel 2008 si batteva in piazza per l’obbligo delle impronte digitali per i cittadini extracomunitari;
· PIEMONTE Capo di qui, capogruppo di là – Isabella Arnoldi (moglie del capo di gabinetto di Cota, Giuseppe Cortese). Capogruppo leghista al consiglio comunale di Novara, Isabella Arnoldi è anche capo dello staff dell’Assessore allo Sviluppo Economico del Piemonte, Massimo Giordano;
· BRESCIA Concorso per signore – Sara Grumi, figlia dell’assessore leghista di Gavardo (Lago di Garda), Guido Grumi. Katia Peli, nipote dell’assessore provinciale all’Istruzione Aristide Peli di Brescia. Silvia Raineri, moglie del vicesindaco leghista di Brescia, Fabio Rolfi. Cristina Vitali e Anna Ponzoni, collaboratrici del leghista Giorgio Bontempi, assessore alle Attività produttive della Provincia di Brescia. Margherita Febbrai, collaboratrice della Padania. Queste sei signore, tutte con forti legami politici nel mondo leghista bresciano, partecipano al concorso per otto posti di “Istruttore amministrativo” della provincia di Brescia indetto nel 2008. Un concorso a cui s’iscrivono oltre settecento persone. Poco più di un terzo (circa 240) si presentano alla prova scritta. E’ una prova “a crocette” che tutti descrivono come molto difficile, con risposte trabocchetto. In 38 la superano e si presentano all’orale. Le nostre signore prendono voti altissimi: dal 30 (unico della Raineri) al 27 di Peli e Ponzoni. Una sesta del gruppo, Margherita Febbrai (collaboratrice della Padania) prende 28. Gli altri candidati sono tutti o quasi staccatissimi con voti dal 23 al 21. La cosa suscita qualche sospetto e qualche protesta. Risultato: la prova orale si svolge in pubblico. Le cinque signore vanno molto meno bene (tra il 25 del duo Pontoni-Vitali al 21 della Raineri). Ma, grazie all’exploit dello scritto le cinque signore passano (siamo a febbraio 2010) ed avranno un posto sicuro. Solo la Febbrai (con 21) si classifica al decimo posto e resta fuori;
· VERONA La moglie del sindaco – Recentemente, la signora Stefania Villanova in Tosi ha fatto sapere che non voterà per il marito che si ricandida alla poltrona di primo cittadino. Gli preferirà il candidato Pdl. Eppure dovrebbe essere grata al marito grande seguace di Bobo Maroni, famoso per le posizioni piuttosto autonome e critiche all'interno del centrodestra. I due si sono conosciuti quando Tosi era assessore regionale alla Sanità e lei impiegata in Regione a 25 euro l'anno. Quando lui è stato eletto sindaco, al suo posto è arrivata un'altra leghista, Francesca Martini e la moglie di Tosi è stata promossa a capo della segreteria (stipendio da 70 mila euro), posto che ha conservato col nuovo assessore Luca Coletto. Dicono che sia brava e determinata e che, anche se non ha grandi studi (non è laureata), il vero assessore alla sanità è lei;
· LO SCAMBIO DELLE SIGNORE Io assumo la tua, tu assumi la mia – Maurizio Balocchi (chiavarese, tesoriere della Lega prima di Belsito) è morto nel 2010. Quando era sottosegretario agli Interni (2005-2006), Balocchi assunse la allora fidanzata di Edouard Ballaman (allora deputato leghista, poi presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia), Tiziana Vivian, e lui ricambiò assumendo la moglie di Balocchi, Laura Pace. In questo modo, entrambi riuscirono ad aggirare la normativa che impedisce l'assunzione di parenti negli uffici pubblici di cui una persona è responsabile. Ballaman è stato accusato di un uso disinvolto dell'auto blu che aveva a disposizione quando era presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per un danno erariale superiore ai 22 mila euro. Tra le altre cose, quando si sposò (non con la Vivian) pare abbia usato la macchina di servizio per andare in viaggio di nozze;
· TOMBOLO (PADOVA) L'incarico al fratello dell'assessore – Nel 2006, la Regione Veneta finanzia la costruzione del nuovo polo scolastico di Tombolo (Padova) per una cifra vicina ai 900 mila euro. Maurizio Conte, consigliere regionale leghista e segretario della Lega di Padova, è fra i più attivi nel promuovere il finanziamento. Poco tempo dopo, il comune di Tombolo affida progettazione e direzione dei lavori all'architetto Tiziano Conte, fratello di Maurizio per una parcella da 260 mila euro. La cosa viene sollevata dal Pd. Maurizio Conte si difende affermando che il fratello ha vinto un regolare concorso secondo l'ex deputato Pd, Piero Ruzzante, che ha sollevato il caso, non ci sarebbe stato nessun concorso;
· VENETO Le designazioni in agricoltura e zootecnia – Carte alla mano, il democratico veneto Piero Ruzzante denuncia una serie di designazioni di esponenti leghisti ai vertici di tre enti regionali. Corrado Callegari, impiegato di banca mestrino, segretario della Lega Nord, viene nominato amministratore unico di Veneto Agricoltura: una carica da 15 mila euro lordi al mese. Callegari diventerà poi anche deputato e, per un po' cumulerà cariche e stipendi. Antonello Contiero, ex autista di autobus a Rovigo, diventa amministratore unico di Intermizoo, l'azienda zootecnica regionale. Stipendio da 5mila euro mensili;
· BERGAMO Il doppio incarico dell'assessore – Nel 2009, l'architetto Silvia Lanzani riceve l'incarico per la progettazione preliminare di un impianto di sterilizzazione dell'ospedale di Treviglio. Un incarico da 13.754 euro. Il presidente dell'ospedale è il leghista Cesare Ercole. La Lanzani, oltre a svolgere attività professionale, è anche assessore alle Infrastrutture della Provincia di Bergamo;
· LA FAMIGLIA DEL SINDACO Verona, la politica degli affetti – Un dossier presentato dal segretario provinciale del Sel di Verona, Giorgio Gabanizza, denuncia una serie di clientele a favore di esponenti leghisti della zona: “La sorella del sindaco di Sona e assessore provinciale Gualtiero Mazzi, ha trovato lavoro in una controllata di Amia, la Serit, mentre la moglie è in Amia; in Amt la sorella dell'assessore regionale Luca Coletto; la figlia del segretario organizzativo della Lega nord, Giannino Castagna, si è sistemata in Amia; il fratello del vicesindaco di San Giovanni Lupatoto e consigliere provinciale, Giuseppe Stoppato, è in una controllata di Amia, la Transeco; il compagno del già sottosegretario Francesca Martini in Acque Veronesi; il nipote di Giampaolo Sardos Albertini, esponente della Lista Tosi, assunto in Amia e infine la moglie di Flavio Tosi promossa da impiegata a dirigente in Regione». Bertucco sottolinea: "È la politica degli affetti. In alcuni casi non si tratta di reati ma di mancanza di decenza morale".
Deputati e senatori, consiglieri comunali, provinciali e sindaci di piccole città. Nelle carte delle procure del Nord, e non solo, sono finiti molti esponenti leghisti per corruzione o reati legati alla pubblica amministrazione. Ripudiati dal partito, molti hanno abbandonato l'attività politica. Ma c'è anche chi, con una condanna per stupro alle spalle, è pronto a ripresentarsi alle prossime elezioni amministrative. Dalla banca padana alle truffe sul latte. Quanti pasticci in casa del Carroccio secondo Walter Galbiati. Oltre all'inchiesta che sta facendo tremare i vertici del movimento, la Lega paga ancora i conti della sua sfortunata avventura bancaria alla fine degli anni '90. Sponsorizzata dall'allora capo di Bankitalia Antonio Fazio, alla ricerca di una sponda in Parlamento, e salvata dal 'furbetto del quartierino' Gianpiero Fiorani, Credieuronord, l'istituto di credito sognato dal Senatur, è naufragato poi tra i debiti. Colpa, anche, delle operazioni spericolate per nascondere il maxi raggiro da 100 milioni di euro da parte di allevatori vicini al partito. Prima di mettere gli occhi sul complicato mondo delle Fondazioni bancarie, i leghisti hanno cercato di farsi la banca in casa. Si chiamava Credieuronord ed è risultata poco più che una meteora nel firmamento degli istituti di credito. Nata nel 1998, finanziata da piccoli risparmiatori padani, l'istituto è andato pochi anni dopo in liquidazione. Da lì sono passate alcune torbide storie della finanza del Nord. Un tentativo di salvataggio dell'istituto era arrivato da Gianpiero Fiorani con la sua Popolare di Lodi, un gesto interpretato dalla procura di Milano, che indagava sulla scalata di Fiorani alla Banca Antonveneta, come "un favore" alla Lega per mitigare la posizione del partito contraria al mantenimento della carica di governatore della Banca d'Italia a vita, allora in discussione in Parlamento e ricoperta da Antonio Fazio, alleato di Fiorani. E' lo stesso banchiere lodigiano, nell'interrogatorio del 5 gennaio 2006 di fronte ai pm milanesi Greco, Perrotti e Fusco a spiegare cos'era per lui Credieuronord: "A Fazio serviva l'appoggio della Lega in Parlamento. Giorgetti si era impegnato a sostenere il governatore in cambio del salvataggio della banca". Ai leghisti, invece, come Giancarlo Giorgetti sarebbe servito salvare Credieuronord dal fallimento per coprire le operazioni spericolate dei vertici del movimento e le intermediazioni fittizie con le cooperative di allevatori create per nascondere la truffa delle quote latte non pagate. Qui nella banca padana vi erano i conti dei produttori del latte, vicini alla Lega, finiti al centro di più inchieste per una truffa da 100 milioni di euro attuata aggirando le normative europee, somme che dovevano essere versate all'erario, ma di cui si sarebbero appropriati gli stessi allevatori. Nel filone dell'inchiesta milanese, in primo grado è stato condannato a 5 anni e mezzo di reclusione Alessio Crippa, rappresentante di una cooperativa del latte e definito il 'Robin Hood'dei produttori. Con lui altri 15 allevatori e produttori a pene comprese tra uno e due anni e sei mesi. Il giudice ha imposto un risarcimento all'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per 300 milioni di euro e ha confiscato beni per 18 milioni. La ricostruzione della vicenda, invece, si ritrova nelle motivazioni con cui il tribunale di Saluzzo ha condannato per truffa una sessantina di allevatori cuneesi, tutti soci delle cooperative Savoia fondate da Giovanni Robusti, leader dei Cobas del latte piemontesi e successivamente europarlamentare del Carroccio. I giudici Fabrizio Pasi, Fabio Cavallo e Fabio Franconiero raccontano così il raggiro: "Dal momento in cui gli allevatori fatturavano il latte che eccedeva le quote loro assegnate, venivano effettuate (dalla cooperativa) tre registrazioni. La prima estingueva il debito nei confronti del fornitore del latte facendo sorgere contemporaneamente un debito nei confronti degli organi competenti per il superprelievo (la multa n. d. r.). La seconda registrazione registrava lo spostamento del denaro dal conto della banca utilizzata dalle cooperative per incassi e pagamenti a un conto acceso presso la banca Credieuronord. La terza registrazione, che seguiva di pochi giorni le altre due, veniva effettuata in corrispondenza dell'uscita del denaro dal conto della banca Credieuronord". Il denaro tornava così agli allevatori che non pagavano la multa. Oltre ai soldi delle quote latte, da Credieuronord erano passati anche quelli dello "scandalo dei fallimenti" che hanno invischiato la commercialista Carmen Gocini e i fratelli Borra. Dalla banca sarebbero stati prelevati contanti la cui destinazione non è mai stata chiarita.L'architetto, gli imprenditori, il politico. Mazzette a Boni per sbloccare le pratiche, così come l’ha raccontata Emilio Randacio. Tutto comincia dalle rivelazioni di Michele Ugliola, ultimo pentito dell'inchiesta che ha toccato i vertici istituzionali del Consiglio Regionale della Lombardia. Agli inquirenti ha svelato il sistema-Pirellone: l'architetto faceva da mediatore con gli imprenditori, accordandosi con loro sulle cifre necessarie per velocizzare la autorizzazioni sulla riconversione delle grandi aree industriali. Il destinatario: l'esponente leghista, allora assessore all'Edilizia e al Territorio. "Sei o sette mazzette". Portate in una busta, all'undicesimo piano del Pirellone, direttamente negli uffici della segreteria dell'ex assessore regionale all'Edilizia e al Territorio, il leghista Davide Boni. Michele Ugliola, il pentito dell'ultima inchiesta che scuote la giunta del governatore lombardo, Roberto Formigoni, nemmeno se le ricorda più esattamente quelle mattina, quando metteva banconote di grosso taglio in una busta e bussava alla porta del capo segreteria del politico lumbard. Ricorda, però con precisione, come arrivavano quei soldi ("circa 300 mila euro in tutto incassati, oltre un milione e sei quelli promessi"). Era il passepartout necessario a sbloccare pratiche edilizie. Sesto San Giovanni, Santa Giulia, Lonate Pozzolo, fascicoli per convertire ex aree industriali che sarebbero ammuffite senza un occhio di riguardo. Almeno su sei pratiche, Ugliola incontrava gli imprenditori, li ascoltava e poi suggeriva la soluzione: ci vediamo con lo staff di Boni. Nel suo ufficio l'incontro, poi, tutti a tavola nel ristorante milanese specializzato in pesce, Riccione, dove Boni, secondo le parole di Ugliola, dettava le condizioni. La tariffa media erano 800 mila euro a pratica. L'architetto tuttofare, fatturava operazioni inesistenti dopate e una volta incassate ne retrocedeva in contanti in una busta, all'ufficio del leghista. "Ci trovavamo con il suo segretario alla mattina presto", ha svelato. Questo lo scenario che Ugliola, un passato da tangentista di provincia nel '96 a Bresso, nel milanese, (quella volta ha patteggiato meno di due anni). Verbali, almeno sei, riempiti davanti ai pm Alfredo Robledo e Paolo Filippini, per ricordare responsabilità, cifre, accordi sottobanco. E che sono costati un'indagine per corruzione per Boni, per il suo ex capo della segreteria, Dario Ghezzi (l'unico che si è dimesso), e una sua consulente. Accuse riscontrate già da una serie di fatture false acquisite agli atti, ma anche da altre confessioni. Come quella di un compagno di partito di Boni, il consigliere regionale Marco Paoletti. Un passato da assessore allo sport a Cassano D'Adda, al confine con Bergamo, e il vizio di spartirsi tangenti insieme alla sua giunta, in cambio di varianti ai piani regolatori.
La Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, meglio nota come Lega Nord o più semplicemente Lega, è un partito politico nato come federazione di vari movimenti autonomisti regionali, tra i quali, in particolare, la Lega Lombarda e la Liga Veneta. I bersagli dei loro strali sono gli extracomunitari e i meridionali. Le accuse contro questi sono fondate su assiomi che delineano una mancanza di cultura o che sono frutto di una cultura distorta. Gente che si sente dura e pura e autoctona, ma, spesso, nelle sue fila vi è gente proprio di origine meridionale ed extracomunitaria. I loro territori non hanno radici storiche e culturali degne di nota, per cui l’odio verso gli altri è la loro linfa vitale e il programma politico si tramuta in calunnie e diffamazioni. Originariamente sostenitrice del federalismo, dal 1996 la Lega Nord ha proposto la secessione delle regioni settentrionali, indicate collettivamente come Padania. Successivamente ha riproposta il progetto di uno Stato federale, da realizzarsi attraverso il Federalismo fiscale e la devoluzione alle regioni di alcune funzioni esercitate dallo Stato. Propone altresì di aumentare il peso politico delle regioni del Nord Italia, ritenuto non adeguato al peso demografico ed economico delle stesse, nonché di promuovere e valorizzare le culture e le lingue regionali, per fare dell’Italia una “Babele”. La Lega è formata da più Leghe: ognuno con i propri campanili e le loro differenze, che alla minima occasione si fanno notare e che sono foriere di odio interno. A riguardo un articolo di Carlo Puca su “Panorama” del 18 gennaio 2011 rende bene l’idea. “Roberto Calderoli, dentista, già ministro per la Semplificazione e leader dei cosiddetti «bergamaschi» (che poi tutti bergamaschi non sono: per esempio Gianna Gancia, la sua compagna, è presidente della Provincia di Asti). È normale, dunque, che in una Lega divisa in correnti più di quanto si racconti i «varesotti» siano in stato d’allerta. Il loro leader è il già ministro dell’Interno Roberto Maroni. Quando Bossi abbandonerà la vita politica, il Carroccio avrà un problema enorme: trovare il nuovo leader. Tenere assieme i bergamaschi con i varesotti, i piemontesi con i veneti, i lombardi con gli emiliani sarà assai complicato. E non soltanto per le diversità su base territoriale: i nordisti sono divisi tra loro pure all’interno delle singole zone d’influenza. In Emilia-Romagna, dove il partito è in forte crescita, una riunione di partito è addirittura finita in rissa. Erano in discussione le candidature al consiglio comunale. Figurarsi cosa mai accadrà nel prossimo giro per il Parlamento…Date le premesse, per sedare gli animi certo non basterà Renzo «Trota» Bossi, il figlio che il Senatùr vorrebbe (addirittura!) ministro. Men che mai basterà l’altro figlio di Bossi, Eridano Sirio Bossi. Insomma: non basterà il feticcio di un cognome, seppur pesante, a salvare la Lega da una prevedibile diaspora.”
CHI DI SPADA FERISCE, DI SPADA PERISCE
I Media: Lega Nord Padania Ladrona. Giornali e tv ne parlano: Non solo Roma ladrona, ma anche Padania ladrona.
IL CASO. Bufera sulla
Lega, il tesoriere va via. "Denaro pubblico alla famiglia Bossi". Le accuse dei
magistrati: truffa ai danni dello Stato e finanziamento illecito ai partiti.
"Elementi
di opacità nella tesoreria del Carroccio fin dal 2004". Al lavoro le Procure di
Milano, Napoli e Reggio Calabria. Contatti con la 'ndrangheta. Maroni: "Adesso
facciamo pulizia nel partito" di Emilio Randacio su “La Repubblica”.
Soldi pubblici gestiti "nella più completa opacità" da almeno otto anni, tanto
da far sorgere il sospetto che siano andati a coprire le spese personali, cene,
alberghi e viaggi dei figli di Umberto Bossi - tra cui Renzo, 'il Trota',
sovvenzionato anche per la campagna elettorale - e della senatrice Rosy Mauro,
ma anche la ristrutturazione della villa di Gemonio del leader del Carroccio.
Fondi che sarebbero stati "sottratti" alla casse della Lega pure per prendere il
volo verso la Tanzania e Cipro con investimenti su cui ora la
magistratura vuole vederci chiaro. Così come vuole analizzare a fondo quei
rendiconti elettorali, pare truccati, che hanno tratto in inganno i presidenti
di Camera e Senato, cioè coloro che li hanno certificati dando il via libera a
finanziamenti, come l'ultimo da circa "18 milioni di euro", irregolari. Dopo le
presunte tangenti del caso Boni (Davide, il presidente leghista del consiglio
regionale lombardo), arriva un'altra batosta che colpisce al cuore il Carroccio.
Questa volta a finire nelle maglie della giustizia è Francesco Belsito,
diventato non solo sottosegretario nell'ultimo governo di Silvio Berlusconi, ma
tesoriere della Lega. Belsito si è visto piombare negli uffici milanesi di via
Bellerio - crocevia di tre inchieste: una di Milano, una di Napoli e una di
Reggio Calabria - la guardia di finanza e i carabinieri del Noe. Nell'indagine
coordinata dal procuratore aggiunto Alfredo Robledo e dai pm Roberto Pellicano e
Paolo Filippini, è accusato, assieme agli imprenditori Stefano Bonet (già in
affari con l'ex ministro Aldo Brancher) e Paolo Scala, di appropriazione
indebita e truffa ai danni dello Stato. Belsito è arrivato in serata nella sede
della Lega in via Bellerio a Milano e ha presentato le dimissioni. Il passo
indietro era stato auspicato da diversi esponenti del partito, dopo le
perquisizioni e la notizia delle indagini, a cominciare dall'ex ministro Roberto
Maroni. Che commenta: "E' una buona notizia, adesso bisogna andare fino in fondo
e fare pulizia dentro il partito, cominciando dalla nomina di un nuovo
amministratore capace di aprire tutti i cassetti". Dopo le dimissioni non sono
state avanzate, per ora, ipotesi riguardo a una sostituzione o alla nomina di un
commissario: sarà il consiglio federale a deliberare sulla questione. "Visto che
è stato tirato in ballo il nome di Umberto Bossi mi sento di escludere in
maniera assoluta ogni suo coinvolgimento", è stato invece il commento del
governatore lombardo Roberto Formigoni. Sulla stessa lunghezza d'onda l'ex
premier Silvio Berlusconi: "Chiunque conosca Umberto Bossi e la sua vita
personale e politica, non può essere neanche lontanamente sfiorato dal sospetto
che abbia commesso alcunchè di illecito. E in particolare per quanto riguarda il
denaro della Lega, del movimento al quale ha dato tutto se stesso. Perciò
esprimo a Umberto Bossi la mia più affettuosa vicinanza". "Altro che Roma
ladrona. Alla fine i nodi vengono sempre al pettine - ha invece commentato
Felice Belisario, presidente dei Senatori dell'Italia dei valori - La Lega, che
si è sempre messa sul piedistallo dell'integrità morale, adesso si ritrova nei
guai fino al collo". Due i filoni su cui i pm del capoluogo lombardo da tempo,
anche in seguito alla denuncia di un militante della base leghista, hanno acceso
i riflettori: il primo riguarda i fiumi di denaro finiti nelle casse del partito
fondato da Bossi presentando rendiconti, questa l'ipotesi, "irregolari"; il
secondo la "distrazione" di parte di quei fondi, alla fine dello scorso
dicembre, da parte del tesoriere, non si sa in base a quali poteri statutari,
per acquisire tramite la Banca Aletti (dove la Lega ha un conto corrente) quote
in un fondo Krispa a Cipro e quote in un fondo in Tanzania per circa "6
milioni". Operazioni, queste, avvenute per gli inquirenti con la complicità dei
due imprenditori. E proprio uno dei due imprenditori è anche complice di Belsito
nella vicenda, autonoma rispetto a quella sull'andirivieni dei finanziamenti
pubblici alla Lega, che riguarda la Siram, multinazionale che si occupa di
energie rinnovabili e servizi ambientali, anch'essa perquisita dalla guardia di
finanza. Dai primi accertamenti, fra il 2010 e l'anno scorso, i due avrebbero
architettato una maxi truffa che, grazie a un giro di fatture false, avrebbe
consentito al colosso di usufruire in modo indebito di un credito di imposta
pari al 40 per cento dei costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo. E
Belsito in questo caso si sarebbe speso come "procacciatore d'affari" in virtù
delle sue relazioni politiche, perché anche sottosegretario. Ma il capitolo che
ha provocato un terremoto in via Bellerio, dove i militari hanno sequestrato
carte e pc in vari uffici - compresi quelli di Daniela Cantamessa, una delle
segretarie di Umberto Bossi, e di Nadia Dagrada, dirigente amministrativo e
responsabile del settore gadget, acquisendo anche documentazione sul Sindacato
padano, fondato da Rosy Mauro - è quello, come si legge nel decreto di
perquisizione, che riguarda la gestione della tesoreria del partito "avvenuta
nella più completa opacità fin dal 2004". Una "gestione in nero (sia in entrata
sia in uscita) di parte delle risorse affluite alla cassa del partito", soldi
pubblici provenienti dal 4 per mille dell'Irpef o sotto forma di rimborsi
elettorali, che, come emerge da una serie di intercettazioni riportate in
un'informativa del Noe (a coordinare le indagini è il 'capitano Ultimo', lo
stesso che catturò Totò Riina), Belsito avrebbe anche usato per contribuire alle
spese per gli svaghi dei figli del Senatur, ma anche in parte per la moglie di
Bossi e per Rosy Mauro (non sono indagati): cene, alberghi e viaggi. E la
ristrutturazione della villa di famiglia a Gemonio: in un'intercettazione si
sente dire che quelle spese vanno a finanziare "i costi della famiglia". In
sostanza ci sarebbe stata una sorta di viavai di denaro e il tesoriere, che è
stato anche nel consiglio di amministrazione di Fincantieri, avrebbe a volte
anche versato sui conti della Lega soldi "in misura superiore ai redditi da lui
percepiti" - altro punto di indagine su possibili fondi neri - o prelevato in
banca somme in contanti, come i 95mila euro del dicembre 2010 con
giustificazione "alimentare la cassa del partito". E poi ancora quei 6 milioni
sottratti per essere dirottati negli investimenti in Tanzania e a Cipro e che
Belsito dice di aver restituito alla Lega ma su cui gli inquirenti, che hanno
sentito numerosi testimoni, tra cui pare anche la stessa segretaria di Bossi,
vogliono far luce. Così come vogliono fare chiarezza sui rendiconti per le spese
elettorali finiti alla presidenza di Camera e Senato per il via libera ai
rimborsi. Sull'ultimo, quello alla base dei 18 milioni erogati ad agosto, ci
sono seri dubbi: si riferisce al 2010 e - scrivono i pm negli atti - "vi è la
prova della falsità".
L'INCHIESTA. Triangolazioni sospette per milioni. E con Belsito spunta la 'ndrangheta. E' a Reggio Calabria uno dei tre filoni dell'inchiesta sul tesoriere leghista. Giri di fatture e compravendite sospette con società in tutta Italia e un faccendiere in rapporti con il potente caln dei De Stefano di GIUSEPPE BALDESSARRO su “La Repubblica”. Il terremoto giudiziario nella Lega arrivato con l'avviso al tesoriere Belsito e il blitz nella storica sede milanese di via Bellerio, è partito seguendo un sospetto personaggio calabrese. Su Belsito sono ben tre le inchieste aperte: Milano, Napoli, Reggio Calabria. A lui la Dda di Reggio è arrivata seguendo gli affari di Romolo Girardelli, un procacciatore di business in odore di 'ndrangheta. Girardelli, o meglio "l'ammiraglio", come lo chiamavano nell'ambiente, nel 2002 era stato indagato per associazione di stampo mafioso. Gli investigatori lo ritengono vicino ai vertici del clan "De Stefano", famiglia potentissima della città dello Stretto con interessi in Liguria e Francia. Il faccendiere fin dal 2002 è legato a Paolo Martino e Antonio Vittorio Canale, braccia economiche della cosca. Il Pm reggino Giuseppe Lombardo e gli specialisti della Dia gli stavano dietro da tempo, nella speranza di mettere le mani sul tesoro della "famiglia". Una pista buona, che ha poi partato a scoprire anche i rapporti tra la presunta testa economica dei De Stefano e il tesoriere della Lega. Girardelli, secondo l'inchiesta, di affari ne aveva procacciati anche a Belsito, all'imprenditore Stefano Bonet e all'avvocato Bruno Mafrici. "L'ammiraglio", oltre che broker era socio di fatto di Belsito in una immobiliare con sede a Genova. Ma non è tutto, perché gli inquirenti hanno ricostruito una serie di passaggi milionari tra grandi società che si occupavano di consulenza e ricerca. Affari per diversi milioni di euro che consentivano utili sotto forma di crediti d'imposta. Giri di soldi e di "regali" che coinvolgono direttamente il tesoriere della Lega e alcuni altri manager di grandi aziende. C'è ad esempio il caso della Siram che "acquista" servizi per circa 8 milioni dalla Polare del gruppo Bonet (di cui Giradelli è responsabile della sede genovese). La Polare poi è in affari con la Marco Polo da cui compra consulenze per 7 milioni. Ed è attraverso quest'ultima che la stessa cifra torna nuovamente a Siram. Un triangolo strano per i magistrati reggini, che ritengono che nei diversi passaggi alcune centinaia di migliaia di euro restino impigliate in diverse mani. Tra queste quelle di Belsito. L'inchiesta accerta che gli vengono liquidate circa 250 mila euro in due trance. Un caso analogo è quello che coinvolge Siran, Polare e Fin.tecno. Sono 8 gli indagati dell'inchiesta che si muove su tre diversi filoni. Quello reggino che riguarda gli interessi della 'ndrangheta, quello milanese legato a Belsito al riciclaggio e all'appropriazione indebita e quello napoletano dove ha sede una delle società coinvolte nel giro. Le ipotesi di reato sarebbe la truffa allo Stato per i falsi crediti d'imposta e il finanziamento illecito dei partiti oltre che riciclaggio di denaro su conti esteri.
Tre procure contro Belsito: "Soldi pubblici ai Bossi". I pm di Milano, Napoli e Reggio Calabria accusano il tesoriere Belsito di aver truccato i bilanci. Viaggi per i figli e Rosi Mauro, fondi per il Trota e per la casa di Gemonio. Di Luca Fazzo ed Enrico Lagattola su “Il Giornale”. Spericolati investimenti, false fatturazioni, denaro che viaggia estero su estero, bilanci truccati, fondi neri destinati al vertice del partito, pericolosi (e per nulla padani) legami con la ’ndrangheta. È un uragano giudiziario quello che ieri si abbatte sulla Lega Nord. Il Carroccio finisce nel fuoco incrociato di tre Procure: Milano, Napoli e Reggio Calabria. La sede del partito, in via Bellerio, viene perquisita dalla Guardia di finanza (che porta via documenti del Sinpa, il sindacato di cui è segretaria Rosi Mauro), così pure la segretaria personale di Umberto Bossi, Daniela Cantamessa. Undici gli indagati, dalla Lombardia alla Campania, dal Veneto alla Calabria. E su tutti spicca il nome di Francesco Belsito, il tesoriere del partito, che si è dimesso ieri sera. Il cassiere del Carroccio è sotto inchiesta per appropriazione indebita, truffa, riciclaggio e finanziamento illecito. È lui, secondo i magistrati, ad aver «gestito nella più completa opacità la tesoreria della Lega fin dal 2004». È ancora lui, spiegano i pm, ad alterare la contabilità del partito. Ed è sempre Belsito a impiegare i soldi pubblici sfilati alle casse del Carroccio «per le esigenze personali dei familiari del leader della Lega Nord». Umberto Bossi non è indagato. Ma l’ultimo siluro è per il Senatùr. L’inchiesta della Procura di Milano - coordinata dai pm Alfredo Robledo, Paolo Filippini e Roberto Pellicano e condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria- parte da alcune operazioni sospette che riguardano gli investimenti di Belsito, denunciate da un militante leghista il 23 gennaio scorso, e prende di mira proprio gli investimenti del Carroccio in Tanzania e a Cipro. Denaro che, secondo gli inquirenti, non si sarebbe in realtà fermato nel continente africano né nell’isola del Mediterraneo, ma avrebbe preso la strada di ritorno per tornare nella disponibilità del tesoriere. L’indagine milanese si incrocia con quelle dei carabinieri del Noe, coordinata dalla Procura di Napoli, e della Dia di Reggio Calabria. Dal Noe negli uffici milanesi arriva un documento che «fornisce elementi inequivocabili sul fatto che la gestione della tesoreria della Lega Nord è avvenuto nella più completa opacità fin dal 2004 e comunque, per ciò che riguarda Belsito, fin da questi ha cominciato a ricoprire l’incarico di tesoriere». «Egli - si legge negli atti - ha alimentato la cassa con denaro non contabilizzato e ha effettuato pagamenti e impieghi anch’essi non contabilizzati o contabilizzati in modo inveritiero». Quali? Nelle intercettazioni telefoniche, viene fatto riferimento ai «costi della famiglia». La famiglia di Umberto Bossi. «Tali esborsi- insistono i pm- vengono effettuati per esigenze familiari del leader della Lega Nord», in «contanti o assegni o contratti simulati». Cene, alberghi, viaggi per la moglie e i figli del Senatùr, per Rosi Mauro, e per la campagna elettorale di Renzo Bossi (consigliere regionale in Lombardia dal 2010), per ristrutturare la villa di Gemonio. La truffa allo Stato viene contestata perché «il rendiconto della Lega è inveritiero, non dà conto della reale natura delle uscite, né della gestione in nero (sia in entrata sia in uscita) di parte delle risorse affluite alla cassa del partito». E non è un dettaglio da poco. Perché i rimborsi elettorali vengono calcolati in base alla validazione del rendiconto da parte degli organi di revisione del Parlamento. E per il bilancio 2010 (ritenuto truccato dai pm) lo scorso anno al Carroccio sono stati riconosciuti rimborsi per 18 milioni di euro. Da Pontida a Dodoma (capitale della Tanzania), esisterebbe un link. Ed è qui che entra in scena un secondo indagato: Stefano Bonet. Di chi si tratta? Bonet è un commercialista tuttofare, sotto inchiesta oltre che a Milano anche a Napoli ( pm John Woodcock e Vincenzo Piscitelli) e Reggio Calabria (pm Giuseppe Lombardo). È Bonet a intrattenere i rapporti con la Siram spa, colosso dei servizi energetici con sede nel capoluogo lombardo, controllata dai francesi di Veolia e Edf, che nell’inchiesta svolge un ruolo chiave. Dai fondi neri creati da Siram attraverso Bonet, e in parte ceduti allo stesso Bonet, provengono probabilmente i fondi occulti della Lega. Nell’inchiesta la Siram viene definita «la lobby di Giovanni Pontrelli»,il suo direttore generale, che avrebbe versato a Belsito 250mila euro. Tra gennaio e febbraio 2010, le società Polare e Marco Polo Tecnhology- di cui Bonet era amministratore - realizzano «movimenti circolari di denaro fittiziamente giustificati con fatture relative a costi per investimenti in ricerca e sviluppo ». Più precisamente, «la Siram aveva versato alla Polare una somma di 5 milioni di euro dei quali era rientrata in possesso attraverso pagamenti effettuati ad altre società, tutte legate al “gruppo Bonet”». Quei soldi, per il commercialista, sarebbero arrivati grazie al «patrocinio politico» di Belsito, sponsor di un fantomatico «progetto Sirio ». In cambio il tesoriere della Lega ottiene che l’investimento a Cipro venga effettuato tramite Bonet su un conto gestito da Paolo Scala (indagato), che a Larnaka fonda la Krispa Enterprises. Tra il 27 e il 28 dicembre 2011, da uno studio milanese, Belsito fa partire i soldi destinazione Cipro: ma invece del milione e duecentomila euro concordati ne spedisce il quadruplo, quattro milioni e otto. «Devono essere semplicemente parcheggiati, poi andranno dove devono andare », si legge in una intercettazione. Scala e Bonet ne parlano allarmati qualche giorno dopo. E Bonet rivela che i soldi sono del «gruppo», cioè della Lega. Scala: «Non so cosa sia, lui (Belsito, ndr ) mi ha detto che escono da lui». Bonet: «Devono essere del gruppo quelli».«Dobbiamo andare a fare un po’ di giri per andare a creare quelle strutture necessarie per andare a segregare questi importi e per pilotare gli investimenti. Non è che domattina viene fuoriuna fogna e andiamo a finire tutti... ». Infatti.
Secondo di Matteo Pandini su “Libero Quotidiano” qualcuno dice che la Lega è cambiata nel 2000, quando decise di riappacificarsi col Cavaliere. Di sicuro è mutata dall’11 marzo 2004 in poi, quando Umberto Bossi rischiò di morire. È da quella mattina che sulla scena piomba la famiglia del Senatur. Gli inquirenti che ieri hanno perquisito la sede di via Bellerio parlano di «gestione opaca» proprio a partire da lì. Dal 2004 è salita sul ponte di comando Manuela Marrone. È la maestra di origini siciliane che ha sposato il capo lumbard il 12 gennaio 1995 a Palazzo Marino, con la benedizione di un commosso Marco Formentini. Con l’ex ministro in ospedale, parecchi scommettevano sullo sgretolamento del movimento. È andata diversamente. Il fortino di via Bellerio ha retto perché il potere non è scivolato lontano da Gemonio. “La Manuela” ha tutelato il marito tagliando i contatti col mondo, a eccezione di pochi privilegiati. È in quelle fasi drammatiche che nasce il cosiddetto cerchio magico, ovvero il gruppo di fedelissimi in stretto contatto con il leader e i suoi familiari. All’inizio ne fa parte pure Giancarlo Giorgetti, il segretario della Lega Lombarda con cui i rapporti si sono poi raffreddati. Stesso discorso per Roberto Cota. Marco Reguzzoni, allora presidente della Provincia di Varese, era uno dei pupilli della signora Bossi e lo è tuttora. Rosi Mauro, l’anima del sindacato padano (Sinpa), è nelle grazie di Manuela e scala in un amen le gerarchie del partito, fino a quando – con Umberto che torna sulla scena – gli s’appiccica nelle uscite pubbliche. Nel 2007 acquista casa davanti alla villa del Senatur a Gemonio. Bossi sta male a marzo, dicevamo. A novembre dello stesso anno il Parlamento europeo assume come assistenti di Francesco Enrico Speroni e Matteo Salvini il fratello del capo padano, Franco, e il figlio primogenito di Bossi, Riccardo (il pilota di rally avuto con Gigliola Guidali). Nella Lega spunta per la prima volta un’accusa sanguinosa e collegata al suo capo: nepotismo. Nulla, in confronto ai veleni delle ultime ore. Nell’informativa del Noe si parla di denaro che sarebbe stato utilizzato dai familiari del leader e dai suoi strettissimi collaboratori (tra cui la Mauro) per alberghi, cene, viaggi. C’è la ristrutturazione della villa di Gemonio e la campagna elettorale del Trota. Una storiaccia. E che - se confermata - sarebbe ben più grave dell’affaire Montecarlo che investì Gianfranco Fini. Pochi anni fa erano state le disavventure scolastiche di Renzo a riempire i giornali. Prima viene bocciato a 15 anni. Poi rifà due volte la maturità. Nell’ultimo caso decide di presentare ricorso. È il leader ad annunciare in un comizio: «Renzo ce l’ha fatta». Non si sa dove. In Italia o all’estero? «Quando stava male mio padre, avevo i giornalisti che mi aspettavano fuori da scuola. Da lì decisi di non dare più certe informazioni» spiegò il Trota a Libero nell’ottobre 2010. Il mistero rimane, anche perché il diploma non s’è mai visto. Nel 2005, ancora ragazzino, aveva fatto la prima apparizione pubblica con papà. Si affacciò dalla casa di Carlo Cattaneo, in Svizzera, per urlare alla piazza: «Padania libera!». Da lì iniziò a essere sempre più presente. Non solo nei comizi. Pure a Roma.
Nei vertici di governo. A casa Berlusconi. Quando il Corriere gli dedica una paginata, la madre s’inalbera perché non lo vuole così esposto. Bossi smorza: «Lui mio delfino? Al massimo è una trota». Nasce il nomignolo. Nel 2010, però, Renzo finisce al Pirellone incassando quasi 13mila preferenze. Nel frattempo il cerchio magico cambia ma prospera. Vi fanno parte anche il capogruppo a Palazzo Madama Federico Bricolo e, naturalmente, il tesoriere Francesco Belsito. I rapporti nel movimento si fanno sempre più tesi. È gelo soprattutto con Roberto Maroni. La famiglia lo accusa di volersi prendere la Lega sfilandola a Umberto. Renzo nega l’esistenza del cerchio: «Qualche giornalista ha la sindrome Tolkien» dice a fine 2010. Nel novembre 2011 cambia idea: «Non esistono più né cerchisti né maroniani, è tutto a posto». Nel frattempo, alcuni vecchi amici di Umberto faticano addirittura a parlargli, tanto è impenetrabile il cordone di sicurezza che lo circonda. Per esempio, si raffreddano i rapporti con Bruno Caparini, il padre del deputato Davide e che ospita il segretario a Ponte di Legno. Il Trota, approdato al Pirellone, è sempre più al centro della scena. I militanti s’arrovellano: era giusto candidarlo? Di sicuro sono fioccati veleni, con l’assessore lombardo Monica Rizzi accusata di aver fatto confezionare dossier per attaccare altri padani e favorire l’ascesa del rampollo. Il Trota gira con un suv Bmw (intestato a lui) e su un’Audi A5 che risulta di una concessionaria comasca. Vive tra Gemonio e Milano. Spesso si fa vedere a Brescia e sul lago di Garda. Ha frequentato anche alcune vippine da tv. È amicone di Valerio Merola. All’ultimo congresso di Varese l’hanno fatto risultare militante anche se non lo era. Condizione che ne avrebbe dovuto impedire la candidatura alle regionali. Il fratello Roberto Libertà, studente d’Agraria, vive a Gemonio e spesso bazzica una cascina ristrutturata a Brenta, Varese. Eridano Sirio, il più piccolo, è ancora lontano dai riflettori. C’è curiosità per i legami tra Belsito, il tesoriere che ha lasciato l’incarico ieri sera, e la famiglia. Gli inquirenti hanno dato un occhio pure alla Pontida Fin, cioè lo scrigno della Lega. Contiene gli immobili del partito. Tempo fa, all’amministratore unico Ugo Zanello arrivò la richiesta di trasferire le proprietà a una fondazione. Nel luglio 2010, con la Lega al governo, spuntano 800mila euro di finanziamento per la scuola Bosina di Varese, quella della signora Marrone. È lei che, col passare del tempo, è sempre più indigesta alla base. Soprattutto, non la sopportano i militanti che guardano a Maroni. Però, quando a settembre il berlusconiano Panorama spara un articolo che descrive i malumori nei confronti della signora (definita «terrona», mentre la Mauro è «la badante»), tutta la Lega s’inalbera. Ieri sono stati perquisiti anche gli uffici del sindacato padano, che in serata ha parlato di «fraintendimento». Si fa un gran chiacchierare di una sede in Sardegna: sarà vero? Dal canto suo, la Marrone incassa ma resta nell’ombra. In pubblico non parla mai. Neanche con i media di partito. Quelli che, nel febbraio 2011, erano stati affidati alla supervisione di Renzo Bossi. Papà ne fu felice. I professionisti che ci lavorano e i militanti, un filo meno.
CARROCIOPOLI: Bossi, un mare di bugie.
La presentazione e le recensioni di "Il libro che la Lega Nord non ti farebbe mai leggere", saggio di Eleonora Bianchini edito da Newton Compton. Un'inchiesta appassionata che ridisegna il ventennio leghista dagli anni del "celodurismo" all'ossessione del federalismo fiscale. I lati oscuri di un partito pieno di contraddizioni: minacce di secessione che si alternano ad abili mosse politiche per acquisire un peso sempre maggiore nel governo del nostro Paese; vilipendi alla bandiera, diti medi alzati e pernacchie in TV che fanno da contrappunto a raffinate strategie orchestrate nei palazzi e nelle ville del potere. Ma come ha fatto questo movimento, da sempre spina nel fianco della democrazia italiana, a ottenere un simile consenso? Eleonora Bianchini, con una prosa secca e incisiva, mette al muro il partito del Carroccio, svelando i falsi moralismi di chi grida contro "Roma ladrona", ma chiude un occhio sugli scandali finanziari della "Padania ladrona". «Il nostro popolo», affermava Bossi, «è pronto ad attaccare. Si dice che il Paese stia andando a fondo, ma io conosco un solo Paese, che è la Padania. Dell'Italia non me ne frega niente». Ma una volta scoperti i verdi scheletri nell'armadio anche il leghista duro e puro potrebbe vacillare. Una giornalista ricostruisce la storia e le dinamiche del consenso del Carroccio. Rivelando come il partito di Bossi abbia due volti. Uno al nord, dove continua a far sognare un federalismo che non farà mai. E uno a Roma, dove pensa solo a divorare posti di potere. L'ultima, in ordine di tempo, è la proposta di un consigliere comunale di Padova di non finanziare la locale maratona perché "vincono sempre neri in mutande". Ma alle dichiarazioni shock, partite da esponenti di ben altro rilievo, la Lega Nord ha ormai abituato gli elettori: forse persino assuefatti, visto che se ne sentono quasi tutti i giorni.
Dagli anni delle minacce di secessione, della caccia ai terroni e dei riti celtici si è passati al federalismo fiscale e alla lotta all'islam e all'immigrazione (clandestina e non solo). E in un paese che non ha memoria e che dimentica troppo in fretta, il lavoro di Eleonora Bianchini ("Il libro che la Lega Nord non ti farebbe mai leggere" - Newton Compton) prova a mettere in ordine gli eventi. Quasi un manuale per leggere la Lega Nord attraverso tutta la sua storia. "L'espresso" ha parlato con l'autrice, giornalista e blogger che lavora tra l'altro per il network Blogosfere.
Perché la Lega non dovrebbe far leggere il tuo libro, come recita il titolo?
"Il mio lavoro ricostruisce la storia del partito in questi anni: le origini, le parole d'ordine, gli slogan, le dichiarazioni, le promesse. Un elenco di fatti, niente invettive preconcette. E questo li ha fatti innervosire: il loro quotidiano, "la Padania", lo ha subito definito "un libro che esercita mistificazioni politiche", ma senza entrare mai nel merito dei fatti concreti che sono stati raccolti".
Iniziamo da Alberto Da Giussano e la Padania...
"Pochi ricordano che Alberto da Giussano è stato copiato dalla biciclette Legnano, perché a Bossi piaceva il logo. Quanto alla Padania, i suoi confini sono stati scelti a tavolino e nella storia della Lega sono anche risultati piuttosto "elastici" per non lasciare fuori nessun potenziale elettore. Adesso però la Padania esiste davvero nella mente dei sostenitori e, nei primi anni del movimento, queste immagini hanno aggregato molto i leghisti e contribuito a costruire un'aura intorno alla dirigenza".
Dal partito di lotta al governo. Come è cambiata la Lega Nord?
"Il cambiamento è stato enorme, da quando è iniziata la corsa al potere e alle poltrone: lo scandalo di Credieuronord, la conquista delle regioni per avere le banche, la parentopoli interna. L'approccio al potere è simile a quello di tutti gli altri partiti che la Lega critica e di cui ha invece preso i peggiori difetti. Anche in tv, c'è stata la lottizzazione della Rai in pieno stile Prima repubblica. Intanto sono cambiati anche i nemici: dalla guerra ai "terroni" si è passata a quella agli islamici".
Terroni, islamici, immigrati, rom. Le dichiarazioni shock e i suggerimenti a bruciare, impallinare o altro in questi anni non sono mancate. Qualcuno le definisce folklore.
"La Lega ci ha assuefatto. Ormai ci siamo abituati a fare spallucce su affermazioni aberranti, quando in altri paesi non avverrebbe lo stesso: alla Lega invece viene perdonato tutto. Sono le famose "sparate" che servono per coltivare il consenso "di pancia" al Nord mentre a Roma si pensa solo a lottizzare e a conquistare fette sempre maggiori di potere".
Passiamo dalla parole ai fatti. Come governa la Lega?
"A livello locale si devono riconoscere degli esempi dignitosi. A livello nazionale invece si usa lo specchietto per le allodole del federalismo per occupare posti di potere a Roma e nelle istituzioni centrali. Nessun leghista ha mai risposto, concretamente, ad alcune domande semplicissime su questo ipotetico federalismo: quanto costerebbe? Quali direttive avrebbe? Chi lo paga? Se fosse davvero il provvedimento che dice la Lega, in cui tutti guadagnano e nessuno paga, sarebbe un sogno. Invece serve solo a mantenere in vita un sogno in periferia per occupare poltrone al centro".
La Lega sembra essere il fenomeno editoriale di questo Natale. Tanti libri ne parlano e sono tutti testi molto critici.
"Il partito di lotta che diventa partito di governo fa emergere tutte le sue contraddizioni e con queste arriva il disincanto nei confronti del movimento. Ormai le due facce della Lega non si possono più coniugare tra loro: il partito non è né duro e puro né un alieno della politica i Palazzo, tutt'altro".
Però i consensi almeno fino a oggi, sembrano in crescita.
"Il mito del federalismo fiscale attrae voti perché promette di abbassare le tasse al nord. Finché il federalismo non viene attuato, resta un immaginario Sacro Graal di benessere. Infatti viene sempre rimandato".
Aveva negato di essere stato iscritto al Pci. Aveva escluso che il figlio prendesse soldi dalle Coop padane. Aveva smentito gli affari poco limpidi del partito. Un libro-inchiesta rivela: era tutto vero.
Si intitola "Umberto Magno, l'imperatore della Padania" la biografia non autorizzata del leader della Lega Nord che è uscito in libreria il 2 dicembre 2010 per Aliberti (480 pagine). E' un'accurata inchiesta di Leonardo Facco, giornalista che ha conosciuto la Lega (e Bossi) da molto vicino, avendo tra l'altro lavorato per quattro anni al quotidiano "la Padania". L'autore parte dagli "albori della Lega", quando un giovanotto della provincia di Varese senza un lavoro riesce a coagulare attorno all'idea autonomista – non senza screzi e fatti poco chiari – prima alcune decine di amici, poi centinaia e infine migliaia di persone pronte a dare il loro consenso a un progetto politico sempre in bilico tra il federalismo e la secessione. Bossi è la Lega e la Lega è Bossi, secondo Facco, nonostante la malattia abbia ridotto il senatùr all'ombra di quel personaggio movimentista del passato recente. Per dimostrarlo, l'autore racconta fatti, episodi, ricordi personali, con tanto di documentazione (sono quasi 400 le note bibliografiche). «Bossi», sostiene l'autore, «è il responsabile principale della trasformazione della Lega in un soggetto politico partitocratico, dove agli scandali si uniscono le truffe perpetrate ai danni, in primis, dei militanti e simpatizzanti. I crac delle Cooperative Padane, del Villaggio in Croazia e della banca padana rappresentano l'epitome del modo di fare politica del "lumbard", circondato da sempre di yes-men (and women) in carriera». Nel libro ci sono diversi fatti inediti, mai conosciuti e-o raccontati: dalla strana busta paga del figlio primogenito a spese dei militanti ignari, fino alla famosa questione della militanza comunista del giovane Umberto: da lui sempre negata, ma ora provata da un documento scoperto in una vecchia sezione del Pci. E poi si va dai tempi in cui elogiava "Mani pulite" alla sequela di condanne penali incassate dai leghisti odierni. Un capitolo, infine, è dedicato alla vita privata di Bossi che «ama la famiglia tradizionale» ma, secondo l'inchiesta di Facco, non sembra negarsi svaghi al di fuori di essa. «E' un'inchiesta che dovevo a me stesso perché ho un passato da leghista, ho creduto in questo movimento e sono stato anche sul Po, alla metà degli anni '90», dice l'autore. «Era giusto scrivere questo libro adesso, in cui la Lega si sente particolarmente forte e pensa di fare il pieno di voti. Bisogna che tutti gli elettori sappiano chi è il padrone del partito che pensano di votare: un cialtrone, né più né meno».
Ma non è tutto. Due pentiti scrivono la storia di Carrocciopoli, così come ripreso da Alessandro Da Rod sul Riformista.
Due libri coinvolgono i due alti esponenti del partito. Il già titolare della Semplificazione è accusato di furto ai danni della Lega emiliana nel periodo caldo delle cooperative padane. Il già Ministro della Giustizia e viceministro delle Infrastrutture invece sarebbe il candidato “Gamma” favorito dalla malavita calabrese.
Due pentiti. Due libri. Un camion di letame sulla Lega Nord di Umberto Bossi. Non c’è dubbio che giovedì 2 dicembre del 2010 non passerà alla storia del Carroccio come una giornata qualunque. Perché presentare nello stesso giorno due libri come Umberto Magno, l’imperatore della Padania di Leonardo Facco e Metastasi di Gianluigi Nuzzi e Claudio Antonelli, significa scoperchiare l’intero vaso di Pandora di via Bellerio, svelando ciò che il Carroccio ha sempre cercato di nascondere: problemi interni, finanziamenti ai figli di Umberto Bossi, intercettazioni scomode e quant’altro. Il primo è il più pesante. Facco, leghista della prima ora, ex giornalista della Padania, ha riportato in 480 pagine tutta la vita del Senatùr, raccontandone misfatti, debolezze sessuali e di potere. Nel secondo i due cronisti di Libero, non hanno incentrato il loro libro sui rapporti tra la ’ndrangheta e la Lega Nord, ma hanno comunque inserito in un capitolo una storia scomoda per i leghisti. Quella di “Gamma”, leghista di Lecco che ha iniziato a fare carriera nel suo feudo grazie anche all’aiuto dei voti della malavita organizzata. Ex ministro della Giustizia, dirigente di una certa importanza, nessuno ha osato dire il suo nome, ma l’unico che ha alzato la voce per replicare alle illazioni è stato Roberto Castelli, viceministro alle Infrastrutture. Negli ambienti del Carroccio, si vocifera che ci sia una cosa che accomuna i due libri in uscita in questi giorni nelle librerie. Entrambi, in un modo o nell’altro, vanno a colpire, oltre al Senatùr, i due esponenti che in questi mesi hanno perso più posizioni di potere all’interno del partito. Da un lato Castelli, dall’altra Roberto Calderoli, ministro per la Semplificazione. È utile ricordare che il leghista lecchese fu l’unico questa estate a rilasciare un’intervista al Giornale in cui raccontava pubblicamente dei problemi interni al partito. Come allo stesso tempo accadde a Calderoli, finito sulla graticola per l’affare Brancher, il ministro breve del Federalismo, anche lui comparso su svariati quotidiani per difendersi dalle bordate che gli arrivavano dagli uffici di via Bellerio. Sarà un caso, ma in mesi così difficili per la Lega Nord, tra cerchi magici, colonnelli, varesini e veneti, nel libro di Facco ci si sarebbe potuto aspettare qualcosa di più sul potente ministro dell’Interno Roberto Maroni. In realtà c’è ben poco, se non un richiamo al caso Antonveneta, passando per spedizione in Serbia e la storia dei finanziamenti alla sua portavoce Isabella Votino. Quisquilie se messe in relazione ai file alla Wikileaks che riguardano Castelli e Calderoli. Perché se il primo viene di fatto associato alla malavita organizzata dal pentito Giuseppe Di Bella, sul secondo vengono persino pubblicati i documenti che testimonierebbero un presunto furto ai danni della Lega emiliana nel periodo caldo delle cooperative padane. Partiamo dal ministro per la Semplificazione. A pagina 311 di Umberto Magno, Sacco racconta la storia delle “Coop made in Padania Scrl” creatura bossiana organizzata per finanziare il partito, finita in disgrazia quasi come Credieuronord. Presidente delle Coop in un primo momento era proprio Calderoli. E attraverso le parole di Mario Morelli, ex consigliere di amministrazione della catena di supermercati, Facco ripercorre tutti i disastri dei calderoliani, tra dentifrici in esubero, immobili pagati uno sproposito, flop economici e conti lasciati in sospeso. «Bossi, Calderoli e altri padani - si legge nel libro - pensavano che un pizzico di coraggio, un tantino d’inventiva, un po’ di voglia di fare mischiata all’improvvisazione fossero elementi sufficienti per il successo». In realtà la vicenda, oltre ad avere tratti grotteschi, tra cui quello di 24 milioni di buste di deodorante con il sole della alpi rimaste invendute, finì molto male. Morelli, infatti, a cui fu data la presidenza dopo l’addio di Calderoli nel 1999, si ritrovò di fronte in poco tempo un debito di circa un miliardo di lire e un’azienda sull’orlo del fallimento. «Una mattina - racconta Morelli - Calderoli mi convocò nel suo ufficio chiedendomi di sostituirlo in quell’incarico. Motivò la sua richiesta col fatto che questo incarico incideva negativamente sul rapporto politico che aveva con Bossi». Del resto, quando Morelli parlò della situazione al Senatùr, Bossi non la prese affatto bene. «Mi rispose con parole di fuoco - ricorda Morelli - indirizzate contro il mio predecessore Calderoli: tuoni, fulmini e saette». Non solo. Il caso scottante è che al fallimento delle Coop è conseguita la protesta di chi quei soldi li aveva versati nelle tasche di Calderoli. Emblematica la lettera di Genesio Ferrari, ex segretario della Lega emiliana che chiede indietro i dieci milioni di lire versati anche grazie all’aiuto dei militanti: «Il tutto si è risolto in una bolla di sapone». Quanto a Castelli, si è già scritto molto. Ma il dato è comunque pesante, perché nel ’90 ci fu il boom di voti per i leghisti. Il pentito Di Bella, vicino al boss della 'ndrangheta, Coco Trovato, racconta a Nuzzi e Antonelli che la parola d’ordine tra le ’ndrine di Lecco era votare “Lega”: Gamma era il loro uomo di riferimento.
PARLIAMO DI PROBITA’ E CORRETTEZZA.
Non solo dubbia onestà verificabile accedendo al capitolo del partito d'interesse nel libro di Travaglio “Se li conosci li eviti”. Ma anche mancanza di probità e correttezza.
Risse parlamentari: “Cesso corroso” l’epiteto più creativo. I banali “carogna” e “porco”, ma non solo. Un libro racconta la politica attraverso gli scontri tra i banchi.
È il 24 gennaio 2008: durante il voto di fiducia che sancisce la caduta del governo di Romano Prodi, il senatore di An Nino Strano, fra i banchi di Palazzo Madama, dopo aver sventolato un paio di fette di mortadella se le infila in bocca per celebrare la caduta dell’esecutivo di centrosinistra. È solo una della lunghissima serie di scene che hanno costellato la storia parlamentare nel corso dei sessant’anni di repubblica e che, talvolta, hanno trasformato la politica in un’arena nella quale gli onorevoli hanno dato il peggio di sé come protagonisti di risse senza esclusione di colpi.
Dall’Assemblea costituente a oggi nel Parlamento italiano le seconde linee dei partiti, quelli che non decidono le sorti del Paese ma che sono nei banchi di Camera e Senato a cercare il loro momento di notorietà, si sono resi protagonisti di esibizioni degne dei migliori attori di B movie: battute, lanci di oggetti, riprese di boxe, salti fra i banchi. Tutto per scagliarsi lancia in resta contro l’avversario di turno, magari farsi giustizia per un’offesa ricevuta.
Tumulti in aula. Il presidente sospende la seduta (editore Aliberti) è un libro che ripercorre, attraverso i resoconti stenografici, i momenti salienti di quei dibattiti parlamentari sfociati in risse da stadio, con aneddoti e curiosità che aiutano a capire anche i periodi difficili della storia repubblicana. Sceneggiate come quella che ha avuto come protagonista Nino Strano (che prima di assaporare in diretta televisiva la mortadella si era rivolto al collega dell’Udc Nuccio Cusumano, apostrofandolo con un “Sei un cesso corroso”) non erano rare, sebbene con un lessico differente, agli albori del Parlamento repubblicano. In aula si fronteggiavano uomini che, in gran parte, avevano combattuto la Seconda guerra mondiale, che avevano imbracciato un fucile (qualcuno lo conservava ancora sotto il letto) e quindi non si facevano scrupoli ad affrontare un avversario politico con le parole o con le mani.
Per esempio, durante il dibattito per l’adesione dell’Italia al Patto atlantico, nel marzo 1949, durato 52 ore vivacizzate da un’interminabile sequela di insulti e aggressioni. Oppure in occasione dell’approvazione al Senato della cosiddetta legge truffa nel marzo del 1953: dopo 70 ore di seduta ci fu una rissa di 40 minuti che vide Sandro Pertini rivolgersi al presidente Meuccio Ruini con un “Lei non è un presidente, è una carogna! Un porco!”. O ancora, sempre nella stessa seduta, il senatore Elio Spano (Pci) affrontò a muso duro il giovane sottosegretario Giulio Andreotti, che in quel momento aveva in testa il cestino della carta per proteggersi dagli oggetti che piovevano dai banchi della sinistra, urlandogli: “Dopo il voto avrete un nuovo piazzale Loreto!”.
Una volta si è sfiorato anche uno scontro fra titani, era il 14 febbraio 1950 e Palmiro Togliatti decise di affrontare a muso duro Alcide De Gasperi per una frase infelice pronunciata nel corso del suo intervento. Parlando dei funerali di sei operai uccisi dalla polizia nel corso degli scontri a Modena (ai quali aveva partecipato tutto lo stato maggiore del Pci), l’allora presidente del Consiglio li aveva definiti una “parata”. Togliatti si alzò urlando “Vergogna!” e scese minaccioso le scale dell’emiciclo fermandosi a pochi centimetri da De Gasperi. Allora il buon senso ebbe la meglio e “il Migliore” se ne andò. D’altronde i leader non si abbassano a tanto: le risse sono roba da peones.
L'aggressione del senatore Tommaso Barbato al collega Nuccio Cusumano é soltanto l'ultima aggressione avvenuta nelle aule del Parlamento. Una lunga serie di episodi delle stesso genere ha costellato i 60 anni di storia della Repubblica. Dal 1949 al 2008 le aule parlamentari si sono più volte trasformate in un ring, dagli occhiali rotti di Sgarbi alla sospensione per dieci sedute di 14 deputati della Lega.
18 marzo 1949 - Alla Camera si vota l'adesione dell'Italia alla Nato. Quando il presidente dell'assemblea Giovanni Gronchi proclama l'esito del voto, il deputato del Pci Giuliano Pajetta (fratello del più noto Giancarlo) si lancia "a catapulta" (come si legge nel resoconto parlamentare) contro un collega, dando inizio a una rissa che vede anche un cassetto volare nell'emiciclo.
1 aprile 1952 - Il deputato Dc Albino Stella, coltivatore diretto, si getta contro il monarchico popolare Ettore Viola, agricoltore, colpendolo con un pugno.
29 marzo 1953 - La "legge truffa" viene approvata dal Senato ma in aula succede di tutto. In una rissa senza precedenti volano cassetti e banchi, il ministro Randolfo Pacciardi rimane ferito e l'opposizione abbandona compatta l'aula.
4 dicembre 1981 - Durante la discussione sullo scioglimento delle associazioni segrete (P2) il radicale Tessari attacca un questore del Pci e scoppia una rissa tra parlamentari dei due gruppi. Vola qualche calcio e i commessi intervengono per separare i contendenti. Il radicale Cicciomessere spicca un salto sul banco del governo ma cade a terra e i commessi riescono a respingere alcuni deputati del Pci, che volevano aggredirlo.
20 novembre 1991 - Mentre la Camera discute i provvedimenti di attuazione del pacchetto per l' Alto Adige, il missino Giuseppe Tatarella si alza e si avvicina all'esponente della Svp Johann Benedikter, che sta parlando, strappandogli di mano i fogli del suo intervento e gettandoli in aria.
16 marzo 1993 - Durante il dibattito sulla questione morale, il leghista Luca Leoni Orsenigo espone in aula un cappio da forca, agitandolo verso i banchi del governo. Alcuni deputati cercano di raggiungere i banchi della Lega Nord e solo un fitto cordone di commessi impedisce il contatto fisico.
19 maggio 1993 - Durante la discussione della riforma Rai, il deputato missino Teodoro Buontempo cerca di parlare in aula con un megafono e, all'ordine di consegnarlo, scappa per le scale dell'emiciclo rincorso dai commessi. Il vicepresidente lo richiama e poi lo espelle insieme al collega di partito Marenco che ha urlato "ladri-ladri" e altro.
21 settembre 1994 - Il progressista Mauro Paissan, relatore del decreto "salva-Rai", è interrotto da un boato di proteste provenienti soprattutto dai banchi di Alleanza Nazionale. Un gruppo di deputati di An travolge il muro di commessi piazzati nell'emiciclo e ad avere la peggio è Francesco Voccoli, Prc, messo ko da un pugno mentre faceva scudo a Paissan. Anche un commesso deve ricorrere alle cure dell'infermeria.
2 agosto 1996 - Scambi di insulti e strattoni tra deputati di Polo e Lega nella discussione sul finanziamento dei partiti. Il leghista Cavaliere salta un banco e cerca di raggiungere il deputato Giovine e altri esponenti di Forza Italia. Rotti gli occhiali a Vittorio Sgarbi.
17 novembre 1997 - Rissa alla Camera con fascicoli bruciati, portaceneri rotti, insulti, urla e scontro fisico evitato per pochissimo. Gli incidenti avvengono in Transatlantico tra Enrico Cavaliere, Mario Borghezio e Luciano Dussin della Lega da un lato e Famiano Crucianelli (Comunisti Unitari), Ugo Boghetta e Ramon Mantovani di Prc dall'altro.
29 aprile 1998 - Uno scontro verbale su Juventus-Inter tra il deputato di An Gramazio e l'ex calciatore e deputato Ds Massimo Mauro si trasforma in scontro fisico. Gramazio scatta verso i banchi della maggioranza, Mauro cerca di allontanare con un calcio l'avversario, che intanto lo strattona e cerca di colpirlo. Gran lavoro dei commessi per sedare la rissa.
9 luglio 2003 - Durante la seduta della Camera, alcuni leghisti mostrano t-shirt con la scritta "io non sto con Abele" e "Caino sconti la pena". Il presidente Casini richiama due volte il capogruppo Alessandro Cè, Dario Galli, Luciano Dussin, Andrea Gibelli, Sergio Rossi e Luciano Polledri e poi li espelle. Un esponente del Carroccio si strattona da solo fingendo una sorta di colluttazione con uno dei commessi: "Sì, sto facendo anch'io resistenza. Da qui non mi sposto...".
31 luglio 2004 - Dopo un alterco per alcune battute su Tangentopoli e "nani e ballerine" con alcuni socialisti dei due schieramenti, Davide Caparini (Lega) tenta di sfondare il cordone dei commessi e di avvicinarsi a Roberto Giachetti (Margherita). Per Caparini scatta l'espulsione. Renzo Lusetti (Margherita) finisce in infermeria.
14 giugno 2007 - I deputati leghisti si siedono nei banchi del governo sventolando il titolo della Padania: "Governo fuori dalle balle". Seduta sospesa, poi l'occupazione, per circa un'ora, con i leghisti che urlano slogan e insulti alla maggioranza e quindi la rissa con i deputati del centrosinistra. L'ufficio di presidenza sospende 14 deputati della Lega per dieci sedute. Un record per Montecitorio.
15 novembre 2007 - Un senatore di Forza Italia cerca di prendere a testate un parlamentare del centrosinistra che viene circondato dai colleghi e portato in salvo fuori dall'emiciclo dal presidente della commissione Giustizia Cesare Salvi. Dai banchi di Forza Italia parte anche un sonoro "vaffanculo".
24 gennaio 2008 - "Scelgo per il paese, scelgo per la fiducia a Romano Prodi" ha detto Nuccio Cusumano chiudendo il suo intervento al Senato: Il clamore suscitato in Aula ha costretto Marini a sospendere la seduta. Al grido di "pezzo di merda" il senatore Tommaso Barbato, capogruppo dell'Udeur a palazzo Madama, è corso in aula mentre dal video fuori dall'aula stava ascoltando la dichiarazione di voto di Nuccio Cusumano. Al termine del suo discorso nell'aula del Senato il senatore dell'Udeur Nuccio Cusumano si è sentito male. Il malore è arrivato dopo che il capogruppo del Campanile Barbato è entrato in Aula e andandogli incontro gli ha urlato in faccia "Pagliaccio, venduto". I commessi sono intervenuti per allontanare Barbato dall'Aula. In aula intanto era scoppiato l'inferno con insulti - "cesso", "troia" e "frocio" - indirizzati a Cusumano. Il senatore è stato soccorso da colleghi e commessi, mentre il presidente Marini ha sospeso la seduta per cinque minuti. Cusumano, dopo essersi messo a piangere, si è sdraiato tra i banchi circondato dai colleghi, in attesa dell'arrivo del medico. Non si è limitato all'improperio in Transatlantico, ma una volta entrato in aula Tommaso Barbato si è diretto verso il banco del collega di partito dell'Udeur, Nuccio Cusumano, e gli ha "sputato in faccia, cercando anche di colpirlo", facendogli con le mani il segno della pistola. Cusumano, sentitosi aggredito, "è svenuto" e quindi il presidente Marini ha sospeso la seduta dell'aula per alcuni minuti. A riferire ai giornalisti quanto accaduto nell'emiciclo è il senatore Sergio De Gregorio, leader del Movimento degli italiani all'estero.
24 settembre 2009 - Il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, durante l'incontro con i lavoratori dell'azienda Spx di Sala Baganza, realtà industriale a rischio chiusura, si scaglia così contro lo scudo fiscale definendolo un provvedimento "criminale" di un Parlamento "mafioso". Secondo l'ex pm: "Lo scudo garantisce a un gruppo di criminali, falsificatori di bilanci ed evasori fiscali, di farla franca. Ancora una volta il nostro Paese è in mano a un gruppo di persone massone, piduiste, criminali e mafiose che fanno gli interessi propri ai danni del paese".
PARLIAMO DI FALSITA’ DELLE FIRME DELLE LISTE.
Ogni anno le cronache ci parlano di firme false apposte alle liste dei candidati alle elezioni politiche od amministrative. Firme di ignari cittadini o addirittura di cittadini deceduti. La falsità colpisce anche il fenomeno del cambiamento all’ultimo minuto del sostegno ai candidati sindaco o presidente, mancando di fatto il tempo per la raccolta delle firme. In questo caso si usano le firme raccolte per il sostegno di uno schieramento, mentre poi vengono usate per il sostegno dello schieramento opposto. I controlli come le sanzioni sono diseguali. Comunque le conseguenze contro una illegalità diffusa, che colpisce l’Italia da nord a sud, sono nulle. I partiti sono tutti uguali in questo malcostume, compresi quelli che si ergono a paladini della legalità (vedi elezioni regionali 2005 in Campania). I magistrati spesso giudicano in modo difforme le cause di esclusione delle liste, come spesso sono archiviati gli esposti presso le procure.
PARLIAMO DEI VOTI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.
"E' una legge che va immediatamente cambiata, perché il voto per corrispondenza è uno scandalo". A sostenerlo è il presidente del Senato, Renato Schifani, secondo il quale la legge sul voto degli italiani all'estero "consente tipologie di attività illecite come l'acquisizione del voto addirittura pagandolo: dobbiamo immediatamente procedere a una rivisitazione".
Il prezzo del voto, quello che per la Costituzione dovrebbe essere «personale, uguale, libero e segreto», è una vacanza in Italia. Così pare, stando a una denuncia che arriva dall’Australia e, dopo il caso Di Girolamo del Pdl accusato di aver preso i voti della ‘’ndrangheta, getta nuove ombre sul sistema elettorale che consente dal 2006 agli italiani residenti all’estero di votare per la Camera e il Senato. In un video visto da Avvenire, una parte del quale è apparsa anche su You Tube, i responsabili di alcune associazioni che riuniscono i laziali residenti nello stato di Victoria rivelano di aver partecipato a brogli estesi e ripetuti nel tempo. Affermano di aver raccolto, sia nel 2006 sia nel 2008, pacchi di schede elettorali e di averle consegnate ad emissari di due candidati del Pd nella circoscrizione Africa-Asia-Oceania-Antartide, Marco Fedi, eletto alla Camera, e Nino Randazzo, eletto al Senato. Gli accusati smentiscono, si dichiarano estranei alla vicenda e denunciano per diffamazione gli accusatori. Un processo si aprirà a breve a Roma.
Nel video, i testimoni raccontano, dunque, di voti ceduti in cambio di viaggi in Italia, finanziati dalla Regione Lazio, e di non meglio precisati "favori" ai club che hanno raccolto le schede elettorali; spiegano come abbiano convinto i loro connazionali a consegnare le schede che ciascun elettore iscritto al registro degli italiani residenti all’estero avrebbe dovuto compilare «personalmente e segretamente», prima di rispedirle in busta chiusa; citano luoghi e momenti in cui sarebbe avvenuta la consegna; descrivono dove e come la «catena di montaggio» le avrebbe compilate... Il sistema descritto è esteso quanto il bush australiano e l’impressione che si ricava è che ad alimentarlo c’è uno strano mix: la nostalgia per la madrepatria e la superficialità con cui viene gestito il voto dei nostri emigranti. «Mi dicevano – ricorda Salvatore Marrocco, consigliere dell’associazione Laziali nel Mondo –: raccogli tra amici e compari le buste del Consolato, loro non sanno quello che fanno...».
Un altro consigliere, Paolo Sepe, racconta di aver recuperato tra i connazionali una trentina di buste con le schede e di averle consegnate, «chiuse come le aveva inviate il Consolato».
In un’altra occasione, aggiunge, «siamo stati convocati in una sala di Brunswick», dove si si consegnavano le buste e si veniva registrati ma, spiega, «nessuno di noi ha votato. Votavano quelli che stavano seduti al tavolo». Insomma, seggi clandestini nel cuore di associazioni legate a Consolati e a governo australiano: «Noi siamo andati a votare al Coasit di Melbourne, in Faraday Street – dice Paolo Grosso, stessa associazione –. Ho presentato il passaporto e uno mi ha detto metti una firma qua, su un registro, e poi mi ha detto che potevo andarmene. La scheda elettorale non l’ho vista proprio. Al Coasit c’era una fila... uno dietro l’altro, passavano, firmavano, andavano via». Anche Salvatore Marrocco è stato lì: «E non riuscivamo a parcheggiare, perché c’era troppa gente».
La raccolta delle schede, secondo questi testimoni, avveniva alla luce del sole: «Al ristorante La Porchetta di Carlton, quando ci hanno chiesto le buste, c’era il comitato intero dell’associazione, se ne è parlato davanti a tutti quanti, c’erano Vince Pitoggi, Sal Marrocco, Paolo Sepe...», ricorda Attilio Riccardi, presidente dell’Associazione Laziali nel Mondo del Victoria, che parla di «mille voti mandati a Sydney in aereo».
Uno dei "premi" per chi collaborava, sempre secondo queste accuse, sarebbe stata la partecipazione ai viaggi organizzati per i nostri emigranti dalla Regione Lazio. Per questo, il bersaglio delle accuse, oltre a Fedi e Randazzo, è Antonio Bentincontri, il consultore che gestisce i rapporti tra la Regione e le associazioni australiane da 18 anni. Bisogna dire che contro di loro, per il momento, ci sono solo queste testimonianze e l’avvocato Gian Michele Gentile di Roma, legale di Fedi e Randazzo, ricorda che la Procura di Roma ha già chiesto un rinvio a giudizio per diffamazione. Tuttavia, gli accusatori, guidati da Maurizio Maietti, un ex poliziotto dello Stato di Victoria, non demordono: minacciano di produrre «centinaia» di testimonianze oculari, invocano perizie calligrafiche, divulgano su Internet verbali al vetriolo, accusano lo Stato di foraggiare associazioni inesistenti...
Nel kangoroo-gate, se confermato, non finirebbe insomma solo il sistema di voto degli italiani all’estero ma anche la gestione dei fondi pubblici che alimentano le associazioni degli emigranti: oltre ai finanziamenti della Regione Lazio, ci sono i fondi del governo australiano che transitano attraverso il Coasit e le attività commerciali che ruotano intorno al sentimento nazionale. Un piatto ricco, che fa gola. La polizia dello Stato di Victoria starebbe già indagando. «I brogli non sono una novità nella nostra circoscrizione», dice Teresa Restifa, candidata dal Pdl, sconfitta per duemila voti. Due anni fa aveva chiesto di riesaminare lo scrutinio della circoscrizione: «Abbiamo verificato – ci dice – che 2.000 schede erano partite da Sydney ed erano arrivate a Roma, ma non erano state scrutinate. Parallelamente, ne sono sparite 1.500 partite dal Sudafrica». Il riconteggio, a quanto risulta, non è mai avvenuto.
Mariza Bafile, origini aquilane, ma nata a Caracas, nel 2006 è stata eletta nella Circoscrizione America Meridionale per l’Ulivo. Nel 2008 non ce l’ha fatta, ma quando è tornata in Italia ha denunciato anomalie sul voto degli italiani all’estero.
Ma lei ha denunciato irregolarità. Ce ne vuole parlare?
«Nella mia circoscrizione ci sono Paesi dove il servizio postale non funziona affatto. A volte capita che i plichi elettorali non vengono consegnati e altre volte capita quello che è successo a due miei elettori in Cile : non avevano ricevuto le loro buste per il voto e quando sono andati in consolato gli hanno detto che risultavano tra coloro che avevano votato».
Ma lei ha denunciato le irregolarità?
«L’ho fatto in ogni sede, ai consolati interessati, in Cile, in Venezuela e in Italia. Tra l’altro spesso i consolati affidano a ditte private i plichi elettorali e in un caso ho scoperto che una di queste li tratteneva per oltre 24 ore. Il mio sospetto è che i voti siano andati in una direzione anziché in un’altra all’insaputa degli elettori».
PARLIAMO DI PARLAMENTARI NOMINATI.
Nominare gli eletti. Il disegno è chiaro. “Il "Porcellum", la legge elettorale che cancellò il maggioritario, ha già trasformato la elezione del Parlamento in una "nomina". Il cittadino non potrà scegliere il "suo" parlamentare, ma sarà costretto a votare per una lista preconfezionata dall'alto. Saranno quindi i capi partito, e non gli elettori, a decidere chi viene eletto.
Perché la classe politica persegua questo disegno è chiaro. E' un disegno scellerato ma risponde perfettamente ai suoi interessi. Il capo partito trasforma i suoi parlamentari da deputati eletti dai cittadini, e quindi da loro dipendenti, in burocrati nominati, fedeli e obbedienti.
Meno chiaro è perché i cittadini sopportino questa autentica truffa. In altri tempi, e forse in altri paesi, la reazione di base sarebbe stata furibonda. Da noi ci sono stati poco più che mormorii.
Il meccanismo della scelta dall'alto piace a molti leaders della sinistra. Il primo caso di lista bloccata è nato nella regione rossa, la Toscana.
PARLIAMO DEL DISINTERESSE E DEL MENEFREGHISMO.
Il parlamentare nominato non risponde alle e-mail e alle sollecitazioni.
In Italia, ormai da dieci anni, sulla homepage del sito di Camera e Senato, è possibile trovare l’indirizzo e-mail dei nostri parlamentari. Un mezzo, nelle intenzioni, per accorciare le distanze tra il politico e il suo elettore.
Si possono proporre o chiedere soluzioni legislative, denunciare o sollecitare ispezioni o inchieste ministeriali per abusi od omissioni a danno del cittadino. E proprio per verificare la disponibilità dei 994 intestatari, il periodico “Panorama” ha inviato, contemporaneamente, altrettante e-mail da dieci caselle di posta elettronica differenti appositamente create e intestate ad una virtuale e fantomatica signora Anna.
La sua situazione è disperata. Ha bisogno di un aiuto, un consiglio per affrontare una situazione sempre più difficile. Aspetta con ansia una risposta da coloro che la rappresentano in Parlamento.
Dal giorno dell’invio a quello della lettura delle risposte, sono passate due settimane. In un lasso di tempo di 15 giorni effettivi ha risposto soltanto il 2,7 per cento dei parlamentari. 26 e-mail in tutto su 9.940. Davvero pochine. Viene da chiedersi: vero è che non c’è vincolo di mandato, ma rispondere ai cittadini per un politico, è un dovere o solo un obbligo morale del singolo? E comunque, ridotta i minimi termini, non dovrebbe essere una semplice questione di buona educazione?
Invece ci troviamo di fronte ad un paradosso. Il brindisino Luigi Vitali, ospite di una televisione tarantina condotta da Carlo Vulpio, giornalista ed autore di “Roba Nostra”, ad una domanda del presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, in ordine ai problemi della giustizia e della lotta alla mafia, da sottosegretario alla Giustizia in carica ebbe a rispondere: “Lei non mi deve più alluvionare con le sue segnalazioni….”
Secondo l’ex Presidente della Camera Fausto Bertinotti non si può parlare di obbligo morale “per un politico, rispondere alle e-mail, così come più in generale ad ogni altra forma di corrispondenza, ma rappresenta un dovere deontologico. Ad ogni domanda che gli viene dai cittadini e che gli è indirizzata, ha il dovere di rispondere. La politica, la buona politica, è fondata sul consenso, e il dialogo rappresenta uno dei cardini del consenso” afferma. Ma lui e i suoi compagni quante volte hanno risposto??
Il test ha rivelato che il 42,1 per cento dei senatori aveva la casella di posta piena, impossibilitata dunque alla ricezione di nuovi messaggi. Molti di loro e, cosa più grave i loro staff, trascurano di svuotarla o comunque di monitorarla. Le loro e-mail dunque non vengono lette abitualmente, o addirittura, non vengono proprio prese in considerazione.
PARLIAMO DELL’ASSENTEISMO E DEI “PIANISTI”.
La possibilità di mantenere un'attività lavorativa al di fuori del Parlamento ha due conseguenze. Da un lato, facilita l'ingresso alla Camera o al Senato di cittadini particolarmente affermati nel mercato privato, che altrimenti non avrebbero potuto sostenere la candidatura. Un fatto auspicabile laddove la capacità dimostrata sul mercato sia in qualche maniera correlata con la capacità di risolvere i problemi del paese. Dall'altro, riduce il loro impegno nell'attività parlamentare, almeno in quella più strettamente legislativa.
Troppi assenti, ancora una volta, scranni vuoti nell'emiciclo del Pdl e mani che prodigiosamente si allungano per trasformare le assenze dei colleghi in presenze. Pianisti all'opera, come sempre. Ma dai banchi dell'Italia dei valori protestano, il leghista Matteo Bragandì, già avvocato di Bossi, prova a giustificare la prassi: "Non accettiamo lezioni. Se i deputati della maggioranza votano per due possono farlo per ragioni politiche, quelli dell'opposizione lo fanno solo per intascare la diaria. E questo si chiama truffa".
Perché a scorrere i tabulati delle presenze alla Camera relativi alle 103 votazioni, si scopre che a Montecitorio mancano sempre all'appello delle votazioni (solo in quell'occasione si possono rilevare le assenze) dai 120 ai 350 deputati.
In effetti, anche la classifica nominale dei più assenti alle 523 votazioni tenute dall'insediamento, assegna il primato a un paio di casacche Pdl. Ad ogni modo, in testa c'è l'imprenditore Antonio Angelucci, Pdl anche lui, presente solo a 58 delle 523 votazioni, con una percentuale di assenze dell'88,9. Fa poco testo anche Piero Fassino, che segue con l'88,3, ma per "adempiere al suo ruolo di inviato Ue in Birmania e di ministro ombra Pd degli Esteri", fa notare il suo staff. Segue invece Mario Baccini ex Udc, assente nell'81% dei casi, e la Pdl Maria Grazia Siliquini (78%). Veltroni è risultato assente nel 72% delle occasioni e Di Pietro nell'82. Ma come per Casini (29,4% di assenze), gli impegni di partito in tutti questi casi hanno avuto la meglio su quelli d'aula.
Le dita picchiettano, le mani si spostano, le spalle avanzano, arretrano, e poi ancora i polpastrelli si alzano, si abbassano, in una sinfonia di movimenti che solo lo scatto attento di un obbiettivo a ripetizione può fermare. E inchiodare. Ecco i pianisti della Camera. I deputati che votano per sé e per gli assenti, uomini e donne insospettabili, maestri e allievi di segrete lezioni di piano che quasi ogni giorno si praticano tra gli scranni di Montecitorio.
Pianismo, un mestiere vecchio quasi quanto quello della politica e che non ha barriere di parte: si pratica a destra come a sinistra, il voto conto terzi, ma c'è un fatto, una novità di questi giorni. L'aula si è riempita di requisitorie. Improvvisamente, soprattutto dalle fila dell'Italia dei Valori, si è levata la voce del rigore, l'appello contro la doppiezza, l'imbroglio, perché barare «in quest'aula» significa anche raggirare «nella vita giornaliera», perché, diceva l'altro ieri nel suo intervento il dipietrista Domenico Scilipoti, votare per due «è un problema di mentalità e di comportamento che ognuno ha dentro la propria testa, nel proprio cuore e nella propria anima» (stenografico della seduta dell'1 ottobre). «Ho letto con interesse i post del blog del Secolo XIX che riporta quanto accaduto in aula e sono rimasto colpito da alcuni messaggi che equiparano i pianisti di Montecitorio agli impiegati che timbrano per i loro colleghi assenti. I messaggi sul sito del quotidiano ligure invocano il Ministro Brunetta a fare il suo dovere: licenziare i fannulloni anche deputati!». «Recentemente - prosegue Scilipoti - diverse amministrazioni pubbliche hanno licenziato impiegati infedeli che si facevano timbrare dai colleghi e hanno fatto benissimo a licenziare anche coloro che hanno timbrato per i colleghi assenti perché partecipi alla truffa ai danni dell'amministrazione. Ritengo che abbiano ragione i cittadini che oggi equiparano quegli impiegati scorretti ai parlamentari assenteisti e ai loro complici pianisti. Quindi - conclude Scilipoti - ponendo su uno stesso piano impiegati e deputati assenteisti, che si fanno timbrare il cartellino dai colleghi, il Ministro Brunetta dovrebbe costringere il Presidente della Camera, responsabile anche del suo bilancio pagato dai cittadini, a licenziare questi deputati infedeli che truffano l'amministrazione con la complicità di colleghi pianisti che non esisto a definire disonesti, politicamente, moralmente e intellettualmente».
Ma la cosa triste è che proprio in quel lato dell'emiciclo, tra i difensori del voto pulito e a mano sola, succede di tutto: suonata con piano verticale (deputato che vota al suo scranno e a quello dietro con una torsione parziale del busto); allegro con brio (deputato che vota a due mani ridendo a crepapelle); andante con moto (deputato che vota per due, in piedi, come se stesse andando via). E via di questo passo, con un solfeggio che si disperde alle spalle dei leader dei partiti interessati senza che nessuno, all'apparenza, abbia niente di che scandalizzarsi.
La cosa ancora più triste, tra l'altro, è che in una delle foto il deputato che allunga entrambe le mani, nell'intento apparente di votare per due, è nientemeno che....Domenico Scilipoti!
C'è un’immagine bellissima di quest'orchestra di musicanti silenziosi del voto doppio: Massimo D'Alema pensoso che adempie il suo dovere di deputato accanto a Marianna Madia, in piedi. Dietro di lui un concerto di pianisti all'opera: Elisabetta Rampi, Vinicio Peluffo, Ronaldo Nannicini. Mani veloci, voto per due, e nessuno che ha visto niente.
Tornando a Scilipoti, va detto che in aula mercoledì anche Roberto Giachetti del Pd era intervenuto per accusare la maggioranza di pianismo: «Allora, possiamo anche continuare a far finta di non vedere...», aveva insinuato allusivo. Ma l'onorevole di Di Pietro invece spiegava più dispiaciuto, più appassionato: «Io sono nuovo di questo parlamento, e avevo l'idea che i parlamentari dovevano essere punti di riferimento per la cittadinanza. In altre parole, un atteggiamento di imbroglio non è corretto: «Non si può barare né si può imbrogliare!». Poi è scoppiata una piccola rissa tra un deputato della Lega e uno dell’Idv che ha richiesto l'intervento dei commessi.
Ma perché Scilipoti, in una immagine di voto, ha allungato due braccia anziché una al momento di schiacciare il pulsante? Non era al suo posto, perché nei due scranni dove si è sgranchito gli avambracci sarebbero seduti i colleghi Barbato e Porfidia. Quel pianista sospetto è Scilipoti o è un deputato che assomiglia a Scilipoti come una goccia d'acqua? Sarà lui a svelare il mistero.
Comunque quello è il settore dell’Italia dei Valori, e questo è indubbio. Lì sono seduti il capogruppo Donadi, il leader Di Pietro. Vicini di banco ma senza occhi del responsabile organizzazione del Pd Andrea Orlando, pizzicato a braccia allargate in inequivocabile atteggiamento da suonata, del responsabile esteri del Pd Lapo Pistelli, anche lui in posizione sospettissima.
E poi ci sono le donne: hanno mani lunghe Olga D'Antona, Anna Rossomando, Maria Rosa Calipari. I mali del pianismo non hanno colore, ma si capisce perché quando il capogruppo della Lega Roberto Cota mercoledì ha detto in aula che ci sono politici «specializzati nel fare la morale agli altri, ma nel non accettare di applicare la stessa morale a se stessi», l'applauso è stato forte, come un'Eroica.
Il quotidiano “Il Giornale” diretto da Mario Giordano non è nuovo a questi scoop. Già in prima pagina era stata pubblicata la foto dell'ex ministro Livia Turco intenta a votare per i vicini di scranno assenti. Stavolta i pianisti si sono moltiplicati. A quello che è un vero e proprio concerto hanno preso parte numerosi esponenti del Partito democratico e di Italia dei Valori: da Lapo Pistelli a Salvatore Margiotta, da Vinicio Peluffo a Elisabetta Rampi, da Pierluigi Mantini a Lanfranco Tenaglia, da Andrea Orlando a Rolando Nannicini, da Anna Rossomando a Luciana Pedoto, da Andrea Sarubbi ad Alessandro Maran, per concludere con le vedove D'Antona e Calipari, oltre al "predica bene e razzola male" Domenico Scilipoti, siciliano eletto nel partito di Antonio Di Pietro.
PARLIAMO DI "CASA NOSTRA".
Ministri, presidenti delle Camere, sindacalisti, politici. Attuali ed ex. Hanno acquistato attici e appartamenti da enti pubblici o da privati a prezzi di favore. Rendendo doppio il privilegio che spesso già avevano come inquilini. Ci sono ministri e leader di partito, ex presidenti del Parlamento e della Repubblica, magistrati e giornalisti. La nazionale dell'acquisto immobiliare scontato è talmente vasta e assortita che ci si potrebbe fare un ottimo governo di coalizione.
PARLIAMO DI TROMBATI E RIMBORSATI.
Ad ogni fine mandato, non rinnovato, ai nostri parlamentari si dà una buonuscita. Si chiamano “assegni di solidarietà”: una sorta di TFR pari all’80 per cento dell’indennità, moltiplicato per gli anni effettivi di mandato.
PARLIAMO DI PRIVILEGI.
Parlamentari, in apparenza eletti dal popolo, ma di fatto nominati da un sistema politico nazionale gerarchizzato a conduzione aziendale, con alla base una politica locale a conduzione familiare, chiusa ed autoreferenziale. Non era mai successo che un politico, un deputato, raccontasse la verità sugli scandalosi privilegi riservati ai mille inquilini del Palazzo. Sarà stato il pudore, sarà stato il desiderio di non dare pubblicità al trattamento di cui godono e di cui vogliono continuare a beneficiare, gli onorevoli se n'erano sempre guardati dal rivelare ciò che effettivamente sono: prìncipi con poca nobiltà e tanti quattrini in tasca. Quattrini non meritati dato il nulla prodotto dai legislatori e dato il loro disinteresse per qualsiasi problema dei cittadini.
Willer Bordon, nel presentare il suo libro “ Perché sono uscito dalla Casta”, così esternava: “Il 16 gennaio 2008, giorno del mio compleanno, dissi di essermi “fatto un regalo”: come avevo annunciato da un paio di mesi, mi sono dimesso dal Senato in un inedito atto di protesta contro il declino e la corruzione della nostra classe dirigente, incapace di farsi portatrice delle reali esigenze dei cittadini, e contro la grave degenerazione della funzione legislativa del Parlamento. I privilegi economici di cui godono i parlamentari – e sui quali getto in questo libro, con dovizia di cifre, esempi e aneddoti da insider, una luce ancora più inquietante della Casta di Rizzo e Stella – sono tuttavia la punta dell’iceberg, sotto la quale la crisi della politica ha assunto proporzioni disastrose. Di fatto, il Parlamento assomiglia sempre più allo sterile megafono del governo di turno, e i partiti sono macchine mangiasoldi governate da ristrettissime oligarchie: non solo per la disgraziata legge elettorale, che lascia a pochi uomini la potestà di decidere chi siederà nelle Aule, ma per una complessa storia più che ventennale.”
Carlo Monai dopo sette tentativi andati a vuoto, ha accettato di raccontare a "L'Espresso" com'è cambiata la sua vita da quando è entrato nella casta. E' un avvocato di Cividale del Friuli, ex consigliere regionale e oggi deputato dell'Idv al primo mandato parlamentare. Uno dei peones, a tutti gli effetti. Uno coraggioso, direbbe qualcuno, visto che ha deciso di metterci la faccia e guidarci come novello Virgilio nella bolgia di indennità, vitalizi, doppi incarichi, regali, sconti e privilegi, in cui sguazzano politici di ogni risma. Un paradiso per pochi, un inferno per le tasche dei contribuenti italiani, stressati da quattro anni di crisi economica e da una Finanziaria lacrime e sangue che chiederà ulteriori sacrifici. «Per tutti, ma non per noi», chiarisce Monai. «I costi della politica sono stati ridotti di pochissimo, e alcuni sprechi sono immorali. Non possiamo chiedere rinunce agli elettori se per primi non tagliamo franchigie e sperperi».
L'incontro è al bar La Caffettiera, martedì mattina, davanti a Montecitorio. Difficile ottenere un appuntamento di lunedì. «Noi siamo a Roma da martedì al giovedì sera», spiega. «Ma in questa legislatura pare che stiamo facendo peggio che mai: spesso lavoriamo due giorni a settimana, e il mercoledì già torniamo a casa. Nel 2010 e nel 2011 l'aula non è mai stata convocata di venerdì. Le sembra possibile?».
Anche in commissione l'assenteismo è da record. «Su una quarantina di membri, se ce ne sono una decina presenti è grasso che cola. Io credo che lo stipendio che prendiamo sia giusto, ma a condizione che l'impegno sia reale. Se il mio studio fosse aperto quanto la Camera, avrei davvero pochi clienti».
La busta paga di Monai è identica a quella dei suoi colleghi: l'indennità netta è di 5.486,58 euro, a cui bisogna aggiungere una diaria di 3.503,11 euro. Per ogni giorno di assenza la voce viene decurtata di 206 euro, ma solo per le sedute in cui si svolgono le votazioni. E se quel giorno hai proprio altro da fare, poco male: basta essere presenti anche a una votazione su tre, e il gettone di presenza è assicurato ugualmente. Lo stipendio è arricchito con il rimborso spese forfettario per garantire il rapporto tra l'eletto e il suo collegio (3.690 euro al mese), e gli emolumenti che coprono le uscite per trasporti, spese di viaggio e telefoni (altri 1.500 all'incirca). In tutto, oltre 14 mila euro al mese netti. Ai quali molti suoi colleghi con galloni possono aggiungere altre indennità di carica.
Monai inizia il suo viaggio. «Non bisogna essere demagogici. Parliamo solo di fatti. Partiamo dagli assistenti parlamentari: molti non li hanno. Visto che le spese non vanno documentate, preferiscono intascarsi altri 3.690 euro destinati ai portaborse e fare tutto da soli. Altri colleghi per risparmiare si mettono insieme e ne pagano uno che fa il triplo lavoro».
Ecco così svelata la sproporzione tra il numero dei deputati (630) e i contratti in corso per i segretari (230). «Non c'è più tanto nero come qualche anno fa. Anche un altro mito va sfatato: la Camera non ci regala cellulari, come molti credono, ma ogni deputato può avere altri 3.098 euro l'anno per pagare le telefonate. La Telecom ci offre poi dei contratti, chiamati "Tim Top Business Class", destinati a deputati e senatori. Per i computer? Abbiamo un plafond di altri 1.500 euro». Anche quand'era in consiglio regionale del Friuli le telefonate non erano un problema: «La Regione copriva tutto. Se non ti fai scrupoli puoi spendere quanto vuoi. Lo sa che lì c'è pure un indennizzo forfettario per l'utilizzo della propria macchina? Per chi vive fuori Trieste, 1.800 euro in più al mese. Tutti prendevano il treno regionale, e si intascavano la differenza». Portandosi a casa solo grazie a questa voce lo stipendio di un operaio specializzato.
Già. I trasporti gratis sono un must dei politici. Monai elenca i vantaggi di cui può usufruire. «Il precario che su Internet ha svelato gli sconti che ci fa la Peugeot s'è dimenticato che anche altre case offrono benefit simili: ho ricevuto offerte dalla Fiat, dalla Mercedes, dalla Renault. Dal 10 al 25 per cento in meno. Credo che lo facciano per una questione di marketing».
Ogni parlamentare ha una tessera che gli consente di non pagare l'autostrada, i treni e gli aerei (sempre prima classe) e le navi, in modo da potersi spostare liberamente sul territorio nazionale.«Tutto gratis, anche se devo andare al compleanno della nonna», chiosa l'onorevole. «Dovrebbero essere pagati solo i viaggi legati al nostro incarico pubblico».
Oltre a questi soldi è previsto un ulteriore rimborso mensile per taxi e varie che va, a secondo della distanza tra l'abitazione e l'aeroporto, da 1.007 a 1.331 euro al mese. Questa è una cosa nota. Pochi sanno però che quasi tutti i deputati, per comprare i biglietti aerei, fanno riferimento esclusivamente all'agenzia americana (con sede in Minnesota) Carlson Wagonlit. «A loro noi chiediamo sempre di volare con Alitalia, che è la più cara di tutte. Nessuno ci vieterebbe, però, di scegliere compagnie low cost».
I politici se ne guardano bene: da un lato il prezzo di un biglietto low cost lo devi anticipare tu (mentre con Alitalia anticipa il Parlamento), dall'altro perderesti i punti per la carta fedeltà "Millemiglia". «I punti li giriamo a mogli e figli, ma in genere i deputati li usano per andare gratis all'estero: perché tranne qualche missione coordinata con il presidente della commissione», ragiona Monai, «i viaggi all'estero dobbiamo pagarceli di tasca nostra».
Carlo Monai è il nostro Virgilio, che ha accettato di guidare “L’Espresso" nella selva di privilegi e benefit di cui gode la Casta.
Il suo viaggio riparte dai vantaggi economici per gestione dell'auto privata del deputato. «Abbiamo un pass per andare ovunque, e se prendiamo una multa per divieto di sosta o eccesso di velocità c'è l'ufficio "Centro servizi" dove possiamo chiedere agli addetti di fare ricorso al prefetto: se ci sono 'giustificate esigenze di servizio', la multa va a farsi benedire».
A Fiumicino un mese al parking silos "E" costa agli italiani 293 euro, ai parlamentari 50. «Anche in Friuli pagavo, grazie al tesserino da consigliere, poco più di 40 euro: se hai la tessera "Fly Very Good" la vita è davvero più facile», aggiunge ironico l'avvocato.
Un privilegio, quello del parcheggio gratis o quasi, che riguarda quasi tutti i consiglieri comunali d'Italia: a Milano, per esempio, i neoeletti beneficiano di alcuni posti gratuiti nel parcheggio di Linate, senza dimenticare la convenzione con il posteggio di piazza Meda, dietro Palazzo Marino. Inoltre, come ha ricordato Franco Vanni su "Repubblica Milano", l'Atm ai consiglieri fa uno sconto del 50 per cento sui mezzi pubblici, e dà un pass per mettersi gratis sulle strisce, blu o gialle che siano.
Se i parking a sbafo fanno aggrottare la fronte, è il capitolo "auto blu" quello che fa scandalizzare le masse. In Italia se ne contano 86 mila, secondo i dati del ministro Renato Brunetta, per un costo (tra autisti e parco macchine) superiore ai 3 miliardi di euro l'anno. Assessori, consiglieri, ministri, sottosegretari, funzionari di ogni livello sono i beneficiari principali. In Parlamento sarebbero appannaggio esclusivo dei presidenti dei gruppi, in tutto una ventina. Ma a queste vetture vanno aggiunte quelle dei servizi di scorta: in tutto sono 90, tra parlamentari e uomini di governo, più 21 tra sindaci e governatori regionali.
«Alcuni colleghi» racconta Monai «finiscono per avere l'auto blu dopo alcune minacce o presunte tali, arrivate in seguito a decisioni politiche discutibili: penso a Domenico Scilipoti e Antonio Razzi, ex dell'Idv che sono passati con la maggioranza».
La casta non può fare a meno nemmeno dei voli blu, quelli effettuati con aerei di Stato: nell'ultima legislatura, rispetto a quella del governo Prodi, le ore di volo di ministri e sottosegretari sono cresciute del 154 per cento. «Mi hanno raccontato pure che i deputati chiedono un passaggio a qualche imprenditore che possiede un aereo privato», dice il deputato:«Questa è una delle cose più deprecabili, perché non bisogna mai essere ricattabili».
Ma tant'è, la vita della casta è una vita a scrocco. Ci si fa l'abitudine. Il nostro Virgilio ci mostra la tessera del Coni, che dà accesso a quasi tutte le manifestazioni sportive. «Quando ero consigliere in Friuli, se volevi assistere ai match dell'Udinese o della Triestina bastava segnalare i desiderata alla società, che hanno interesse a mantenere buoni i rapporti con la politica. Il posto è assicurato». In tribuna vip, naturalmente.
I parlamentari possono usufruire anche di uno sconto per il Teatro dell'Opera di Roma e in alcuni musei, mentre a Trieste il nostro peone aveva sempre a disposizione un palchetto al Teatro Verdi.
I vantaggi non sono un'esclusiva romana. A Milano i consiglieri comunali possono chiedere il rimborso di pranzi di lavoro (e se mangiano in Consiglio, una cena gli costa 1,81 euro), hanno diritto a biglietti gratis per San Siro (partite o concerti), e due palchi riservati alla Scala per gli appassionati di lirica. Mentre i consiglieri regionali del Piemonte godono ancora dell'autocertificazione per fantomatici impegni durante sabati, domeniche e festivi: si può intascare il gettone di presenza (122,5 euro) anche in quei giorni di riposo, a patto che dicano (senza pezze d'appoggio) di aver partecipato a convegni ed eventi. In Sicilia e Campania la lista dei privilegi comprende di tutto. All'Ars dell'isola le missioni all'estero sono la norma, non l'eccezione (un deputato regionale, Giuseppe Gennuso, nel 2009 ha trascorso quasi tre giorni su quattro fuori dell'Assemblea), mentre fino a pochi mesi fa anche coloro che avevano finito il mandato continuavano a prendere un "aggiornamento professionale" di 6.400 euro annui. E se un deputato regionale morisse avrebbe diritto a un sussidio di 5 mila euro per le esequie.
Anche nella indebitatissima Campania s'è sfiorato il ridicolo. Lo scorso novembre una delibera è stata revocata prima che creasse una rivolta popolare: prevedeva che ogni consigliere potesse avere in ufficio televisione, tre poltrone in pelle, telepass e a scelta un computer fisso, un portatile o l'iPad. Il frigobar era invece appannaggio solo di presidenti, vice e capogruppo.
Carlo Monai, il deputato dell'Idv che ha deciso di raccontare tutti i privilegi della Casta, continua a stupirci su “L’Espresso”.
Racconta che a Montecitorio e Palazzo Madama arrivano ogni giorno inviti per mostre, happening vari, sfilate di moda. Il cibo si paga? «Dipende. Il bar della bouvette è in linea con i prezzi di mercato. Il ristorante, invece, no. Ci costa in media 15 euro, ma la tavola è apparecchiata come un tre stelle Michelin, i camerieri sono in livrea, lo chef è bravo e prepara piatti di grande qualità. Io cerco di non appesantirmi, e ci vado raramente. L'unico appunto», chiosa sorridendo, «riguarda la cantina: ci sono ottimi vini, ma nessuna bottiglia friulana».
Al Senato si può mangiare uno spaghetto alle alici a 1,60 euro, un carpaccio di filetto a 2,76 euro, un pescespada alla griglia a 3,55 euro. Prezzi ridicoli. «Anche in consiglio regionale c'era un buon self service. Primo, secondo, caffè e frutta a 10 euro».Pure uno shampoo costa poco: la nostra guida è un frequentatore della mitica barberia della Camera, dove un taglio costa 18 euro (al Senato, invece, è gratis). «In questo caso, credo che sia un servizio da conservare: consente al parlamentare di avere sempre un aspetto dignitoso, anche quando arriva il martedì con i capelli spettinati».
Ma i servizi dedicati ai politici non finiscono qui. Dentro Montecitorio c'è uno sportello del Banco di Napoli, diventato famoso perché il consigliere Marco Milanese ha movimentato, su un conto dell'agenzia Montecitorio, qualcosa come 1,8 milioni di euro in pochi anni. Non è il solo ad aver aperto un conto lì, visto che gli onorevoli possono approfittare di tassi agevolati per mutui e prestiti.
Precisa Monai:
«Molti usano la diaria non per affittare la casa a Roma, ma per comprarla.
L'importante è essere rieletti. Per un mutuo di 150 mila euro a cinque anni il
tasso fisso è appena del 2,99 per cento, uno o due punti sotto quello di
mercato. Idem per un prestito: possiamo avere un tasso agevolato al 2-3 per
cento».![]()
Anche le prestazioni sanitarie sono rimborsate: Monai dopo un incidente in cui ha distrutto una Mercedes ha ottenuto il rimborso di 580 euro di massaggi, e ammette che il Parlamento gli paga cinque giorni di cure termali l'anno.
I radicali hanno scoperto altri benefit: occhiali gratis, psicoterapia pagata, massaggi shiatsu, balneoterapia. Tutti servizi destinati a oltre 5.500 persone, tra deputati e familiari. Alla Camera, poi, non si chiama mai il 118: ci sono anche alcuni infermieri nascosti tra gli scranni dell'Aula adibiti a "rianimare" il deputato nel caso si sentisse male. Costano al contribuente 650 mila euro l'anno.
Dopo una vita da nababbo, l'ex parlamentare o il consigliere non viene abbandonato dalla casta. L'assegno di fine mandato non si nega a nessuno, e il vitalizio scatta per tutti. Per prendere una pensione bastano cinque anni di mandato alla Camera o al Senato, (in media 6 mila euro a testa al mese), per una spesa che nel 2013 toccherà i 143,2 milioni di euro l'anno. Tra le Regioni solo l'Emilia-Romagna ha abolito il vitalizio, tutte le altre non ci pensano nemmeno: così nel Lazio può accadere che gli ex e i trombati si prendano 4 mila euro al mese ad appena 55 anni.
Non male, in tempo di crisi.
Roberto Poletti, giornalista e conduttore televisivo di successo, eletto deputato nelle liste dei Verdi di Pecoraro Scanio nel 2006, dopo un biennio da peone durante il quale ha vissuto la noia delle aule e ha costatato l'inutilità del proprio ruolo, ha deciso di raccontare tutto al Quotidiano “Libero” in questa inchiesta senza precedenti.
“Sono Roberto Poletti, parlamentare pentito, ricordo il periodo in cui riflettevo sulla mia possibile discesa in campo. Era l’inizio del 2006: la legislatura del Cavaliere alla fine, l’ascesa di Prodi sembrava inarrestabile. C’era feeling e stima con i Verdi, Pecoraro Scanio un amico, facendo due conti, quello dei Verdi era il partito che più degli altri mi dava la possibilità di essere eletto. Sapevo che uno dei candidati in Lombardia avrebbe rinunciato allo scranno romano per rimanere alla Regione, tale Monguzzi e la legge elettorale mi avrebbe permesso di subentrare. I colloqui con i vertici del partito scivolavano via senza problemi, sul mio disinteresse per l’ambientalismo militante, nessun problema: quando puoi garantire qualche crocetta in più sulle schede elettorali, un accordo si trova. L’incontro decisivo con Pecoraro Scanio avvenne a Milano nel gennaio 2006: “Visto che sei giornalista ti potresti occupare dell’informazione e poi ti piazziamo in una commissione parlamentare di quelle giuste” dice il segretario nazionale. Inizia il periodo “faticoso” della campagna elettorale. Imposto la campagna sulla difesa degli anziani e sulla moralizzazione della vita pubblica, i temi che avevano fatto la mia fortuna in televisione. Mi faccio tutti i mercati rionali, il pubblico mi riconosce e si divide, è l’unico momento in cui ti sembra di avere un contatto reale con gli elettori, li incontri, ci parli. Ti illudi di aver fatto la scelta giusta, immagini di arringare l’aula gremita, sogni un futuro da Martin Luther King. Ma la realtà è molto più prosaica, i primi schiaffoni arrivano da quelli che dovrebbero essere dalla tua parte: i compagni di partito, nel mio caso, tal Fiorello Cortiana. I vertici dei verdi avevano deciso di sacrificare la sua candidatura per offrirla a me. Sul suo blog iniziano a uscire commenti non proprio gentili nei miei confronti, si ironizza e si fa del sarcasmo sul Corriere della Sera.
Il 6 giugno 2006 il mio esordio in Parlamento, entro in quello che mi sembra un altro mondo. I grandi corridoi, i soffitti a volta, i tappeti, lo sfarzo. Vado subito nell’enorme salone Transatlantico, quello famoso, dove tutti si incontrano nelle pause delle sedute: i commessi, gli impiegati, i parlamentari. Ecco Bertinotti, D’Alema. Entro in aula, cerco il mio posto, mi siedo, sono commosso. C’è il Presidente della Camera Bertinotti, che informa il governo sul grave attentato subito da una pattuglia del contingente italiano a Nassiriya. Il Vicepresidente Leoni invece passa alla proclamazione dei deputati subentranti, e proclama deputato, vista la rinunzia di Carlo Monguzzi, Roberto Poletti. Sono ufficialmente un onorevole. Guardo e riguardo il tesserino, la medaglietta d’oro da deputato, e mi sento un re. Passeggio per il transatlantico e noto tre colleghi che sembrano stiano giocando a figurine, mi avvicino.
“Questa c’è l’hai?”
“Si, certo.”
“E quest’altra?”.
“Ma no, non vale più, l’hanno abolita”.
“Ehm, ma io la uso ancora…”.
Non sono figurine, ma tessere, tesserine tipo le carte di credito, necessarie per godere di questo beneficio o di quell’esenzione.
Prima tessera da ritirare, è quella con cui si vota in aula, serve anche per mangiare e bere al ristorante di Montecitorio, al self-service, oppure alla “bouvette”, il mitico bistrot extra lusso dai prezzi di una trattoria di ultima classe. Il conto te lo scalano dallo stipendio, il trattamento riservato ai deputati è di dieci euro, ma il conto per le casse statali è di circa 90 euro a pranzo. La tesserina in questione serve anche per l’aereo gratis, basta esibirla in qualunque biglietteria per fissare il volo senza sborsare un centesimo, altrimenti c’è l’agenzia di viaggi interna al Parlamento, che è anche più comoda. A proposito di aeroporti, anche il parcheggio auto, in appositi spazi riservati, è gratuito. Naturalmente anche il treno è gratis. E l’autostrada? Serve il tesserino Aiscat, e la barra si alza senza pagare, volendo si può richiedere pure il telepass, cosi da oltrepassare le barriere senza fermarsi, e lo puoi installare su qualsiasi automobile, anche quella della nonna.
AUTO BLU E PARTITE GRATIS. A Roma e a Milano possiamo usufruire delle corsie preferenziali, e nella Capitale abbiamo anche il permesso per entrare in centro nelle zone a traffico limitato (ZTL). In passato ciascun deputato/senatore poteva estendere il permesso ad altre due vetture, cosa adesso non più possibile. La tessera CONI invece serve per andare gratis allo stadio. San Montecitorio pensa anche alla dichiarazione dei redditi con un servizio gratuito di assistenza e consulenza fiscale. In caso di problemi di salute, invece, c’è la Card Medital che garantisce un servizio medico d’urgenza 24 ore al giorno 365 giorni all’anno, basta chiamare il numero verde 800652585, struttura privata pagata dallo stato, cioè i cittadini. Ma un parlamentare moderno dove va se non è capace di usare il pc? Ecco il corso di informatica gratuito. E le lingue? Per quelle ci sono le lezioni private e individuali, con insegnante madrelingua, a qualunque orario e in qualunque luogo, anche a casa. Si può scegliere l’inglese, il francese, il tedesco il russo e il giapponese!! Tutto alla modica cifra di otto euro all’ora quando costano a noi comuni mortali circa il quadruplo. Peccato che sino ad un anno fa le lezioni erano completamente gratuite!!
IL DEPUTATO PAGA MENO. C’è la sartoria che si offre di confezionarti l’abito su misura con lo sconto del 40%, l’ottico invece ha pensato ad una riduzione del 30%, l’associazione parlamentare amici delle nuove tecnologie garantisce uno sconto del 10% su cellulari e palmari, condizioni agevolate di pagamento arrivano anche da case automobilistiche per l’acquisto di auto nuove presso la rete dei concessionari. Per i libri 20% in meno, che arrivano al 30% per i testi universitari, per i figli dei deputati/senatori. E poi ci sono le mille attività organizzate dal Circolo Montecitorio, quello di via Campi Sportivi, un club elegante, di lusso. Campi di calcetto, golf, palestra, piscina, basket, tennis. Ristorante e club-house. L’iscrizione è gratuita, invece gli ex deputati pagano la modica cifra di 24 euro al mese, non mancano i festini con una di quelle ballerine di lap-dance, che si esibiscono dimenandosi intorno al palo. Dulcis in fundo il corso di Pilates, un sistema di allenamento che migliora la fluidità di movimenti e il coordinamento fisico e mentale, che quando c’è da votare altroché se è importante!!.
GLI UFFICI DI MONTECITORIO. Questa storia degli uffici dei deputati è davvero curiosa. Si trovano a Palazzo Marini, tre minuti a piedi da Montecitorio. Per mantenerli, lo Stato paga circa 30 milioni di euro all’anno soltanto di affitto. Una decina di anni fa, il già grande complesso è stato addirittura ampliato, adesso è arrivato a 60mila metri quadrati. E ci credo: il fatto è che i Parlamentari non confermati non ne vogliono sapere di mollare le stanze, dunque passano mesi prima che i nuovi eletti possano avere a disposizione lo spazio. Così succede anche a me, Poletti Roberto, onorevole di fresca nomina: «E il mio ufficio?» chiedo. «Un po’ di pazienza, adesso salta fuori». Poi scopro che l’ex titolare deve ancora liberarlo, e nessuno si può permettere di impacchettargli le scartoffie: lo farà lui, quando avrà voglia e tempo.
Gli uffici sono assegnati dai gruppi parlamentari. Ed è un litigio continuo: riunioni su riunioni, trattative estenuanti che sembra la Finanziaria, «a me ne serve uno un po’ più grande», «non datemi quello vicino ai bagni, per favore» e via dicendo. Problemi e lamentele finiscono tutte sul groppone di Giampiero Spagnoli, funzionario storico del gruppo dei Verdi e anche di quello misto, bresciano cui Roma non ha rubato l’accento né la voglia di lavorare: è lui che tranquillizza, media, propone, risolve che neanche Gianni Letta. In ogni caso, l’ufficio assegnato me lo liberano dopo l’estate, a tre mesi dall’elezione. All’inizio, mio vicino di stanza è Massimo Fundarò, ma capisco che la situazione è ancora in evoluzione. L’onorevole Arnold Cassola, infatti, non la manda giù: dice che il suo, di ufficio, proprio non va bene, pare sia troppo rumoroso, soprattutto a causa di una caldaia sistemata nei paraggi.
E insomma, Cassola si mette a far la posta agli altri, controlla le frequenze, cronometra i tempi, conclude che Fundarò il suo lo usa poco e invece per lui sarebbe perfetto. Tra l’altro Cassola è stato eletto in una circoscrizione estera, e questi hanno un po’ la fissa di essere discriminati dai deputati “indigeni”, «ma almeno a noi le preferenze ce le hanno date votando il nostro nome, mica come voi». Alla fine, più che altro per sfinimento generale, la spunta. E trasloca nell’ufficio accanto al mio.
E allora, parliamo del mio nuovo stanzone da deputato: non è niente male. E’ al terzo piano, stanza numero 321. Due scrivanie, due computer, fax e telefono e stampante, una televisione, un frigorifero. E poi tre armadioni, due sedie-poltroncine di quelle comode, una finestra che dà sul cortile interno. Di cancelleria ce n’è a strafottere: penne, matite, colle stick, forbici, fermagli e graffette e graffettine da graffettare il mondo, sbianchettatori, evidenziatori, persino le gomme blu, quelle per cancellare la penna (e mi chiedo: ma chi è che oggi cancella le cose scritte a penna con la gomma blu, che se non stai attento ti buca anche il foglio? Non lo fanno più nemmeno alle elementari). E poi carta, un mare di carta, fogli, buste grandi medie e piccole, bloc notes, cartelline: d’istinto, mi vengono in mente le proteste della Polizia, che più volte si è lamentata perché non ne hanno nemmeno per fotocopiare i verbali, o le mamme costrette a portare le risme di carta alla scuola del figlio. Qui, invece, siamo sommersi, alla faccia dei boschi rasi al suolo, e meno male che siamo i Verdi. Peraltro, scoprirò poi che la fornitura di cancelleria viene rinnovata ogni tre mesi: ti arrivano gli scatoloni pieni di questa roba e non sai dove metterla, perché del resto ne hai usato un decimo se va bene. E gli scatoloni con i ricambi te li spediscono a qualunque indirizzo, anche a casa. Oppure, se hai un’urgenza, vai direttamente al magazzino, nei sotterranei di Montecitorio. E fai scorta.
DEPUTATI LATITANTI. Il punto è che questi uffici non li usa nessuno. O si è in Aula, oppure in Commissione, magari in trasferta di lavoro, altre volte semplicemente a casa. Senza contare che c’è l’ufficio del gruppo parlamentare, che sbriga pratiche a richiesta. Oppure quello del partito nazionale, che volendo svolge le stesse mansioni. O l’altro del partito regionale, infine il partito cittadino. E così, la politica italiana è tutta un doppione del doppione del doppione. Risultato: ti aggiri per gli eleganti piani di Palazzo Marini, percorri i corridoi arredati con tappeti e quadri e piante, e subito sei immerso nel paradosso di un dedalo di uffici senza alcuna traccia di lavoratori. Di deputati ne vedi uno ogni tanto, e in genere perché lì ha dato appuntamento all’insegnante di lingua, o deve ritirare qualche fax, o magari schiacciare un pisolino. I commessi fanno capannello attorno alle scrivanie, scattano in piedi e si danno un contegno quando passa qualcuno, il più delle volte sono costretti a ripiegare sul sudoku. E non si dica che sono io, scansafatiche, a essere allergico alla onorevole scrivania gentilmente messa a disposizione dallo Stato: in questo senso, basta citare tra gli altri un ordine del giorno presentato dalla Rosa nel Pugno, che sottolinea come “ogni deputato dispone di un ufficio ubicato a Palazzo Marini, ma è praticamente impossibile il suo utilizzo durante le giornate di lavoro parlamentare, e per tali uffici, di norma scarsamente utilizzati, la Camera sostiene un costo esorbitante”. Appunto, è quello che dico anch’io. Per di più, una gentile circolare interna ha il piacere di informarmi che, “per consentirti di svolgere con il supporto di adeguati strumenti tecnologici il mandato elettivo”, lo Stato è pronto a coprire una spesa “per l’acquisto di strumentazioni e materiali informatici inerenti la dotazione di una postazione di lavoro” di 3.000 euro. In sostanza, ci regalano il computer portatile più costoso che ci sia. Poi si sussurra che qualcuno, in quella cifra, riesca a farci stare anche il lettore Dvd o la lavatrice, magari strizzando l’occhio al negoziante mentre compila la ricevuta. Ma questa è certamente un’ignobile insinuazione.
EVVIVA I PORTABORSE. Tra le “dotazioni da ufficio” a disposizione dei deputati c’è poi il collaboratore personale, meglio noto come “portaborse”, termine che non mi piace perché offensivo nei confronti di persone spesso sfruttate, pagate in nero, e magari poi sono loro che redigono i comunicati “contro il precariato”, poi diffusi da coloro che si presentano come paladini dei lavoratori senza contratto. Non che io voglia fare il moralista: infatti ne assoldo uno (assumo, in questo caso, è una parola grossa), bravissimo, uno dei tanti studenti che si propongono per arrotondare. Ma mi accorgo che davvero posso farne a meno, e dopo cinque mesi interrompo il rapporto. Interrogativo: faccio bene perché smetto di uniformarmi a una prassi vergognosa, o sono uno stronzo perché lascio a casa lo studente? Non sono riuscito a rispondermi. Tra l’altro, dopo che la trasmissione “Le Iene” fa esplodere lo scandalo e tutti fanno gli gnorri, «chi, io? chi, lui?», e Bertinotti tuona, «questi vanno messi in regola!».
Ecco che subito arriva la segnalazioncina, con il solerte onorevole Evangelisti, dell’Italia dei Valori, che gira a tutti i deputati e senatori “la comunicazione indirizzatami dallo Studio Interlandi, che considero in grado di proporre una consulenza professionale adeguata ad affrontare le problematiche inerenti la regolarizzazione del rapporto di lavoro tra i parlamentari ed i propri collaboratori”. Un bel grazie a Evangelisti dai parlamentari e dallo Studio Interlandi.
Dimenticavo: un altro gadget essenziale per il duro lavoro d’ufficio dell’onorevole è il timbro autoinchiostrante. Io non lo sapevo, poi un giorno vedo due deputati che scherzano, lasciano il marchio dappertutto, «guarda il mio», «ma va, io ci no messo pure capogruppo», sembrano ragazzini. Incuriosito, m’informo. Mi viene spiegato che va richiesto «giù al magazzino» e te lo fanno avere. Ora, non è che la spesa per i timbri dei deputati sia determinante per incrinare ulteriormente il malmesso bilancio statale, ma a che cosa serve? Forse per evitarci anche la fatica di firmare? Dice: ma allora tu ci hai rinunciato. Io? E perché? Chi sono, il più sfigato? E allora, vai col timbro: “On. Roberto Poletti “. E lo piazzo lì, sulla scrivania. L’avrò usato due volte.
A proposito di timbri, alla Camera c’è anche un ufficio postale, si trova vicino all’Aula. E come funzionano bene le Poste, per noi parlamentari: impiegati gentilissimi, quel cartello con scritto “gli onorevoli deputati hanno la priorità”, chissà mai che qualche dipendente si metta in testa di farci fare un minuto di fila. Ogni deputato ha la sua casella, ti mandano un avviso, “c’è posta per lei “, tu vai e ritiri. Se devi inviare a te stesso lettere o plichi o raccomandate fuori sede, francobolli e tasse varie non si pagano. E a Natale, sono gratis anche i biglietti d’auguri, con il simbolo della Camera dei deputati e un’illustrazione d’epoca: “Caro collega, abbiamo il piacere di comunicarti che per le prossime festività natalizie potrai, come di consueto, richiedere la dotazione annuale a te spettante di n. 100 biglietti medioevalis a colori e n. 100 biglietti medioevalis color seppia”. Scopro poi che nel caso non mi piacessero, ho a disposizione 800 euro da spendere entro l’anno per farmi stampare dalla tipografia interna qualunque cosa voglio.
SERVIZIO AGENDA. Mica finisce qui: per Palazzo Marini, quello dove si trovano gli uffici, c’è un servizio postale specifico. Nel senso che se per esempio devi ritirare le fondamentali “agende della Camera dei deputati” e ti tocca andare fino a Palazzo Valdina, che si trova a una distanza di metri seicento circa, basta segnalare il problema, e l’agenda la va a prendere e te la porta l’incaricato della società privata che gestisce il servizio. «Ma dai, per un’agenda?». Eh no, perché - come ci comunica la consueta circolare - “la dotazione (ma quante dotazioni abbiamo?) consiste in un’agenda da tavolo personalizzata, un’agendina semestrale in pelle personalizzata e due agendine in pelle”. Cioè, di agende ce ne danno quattro. Quattro a testa, che per 630 deputati fanno 2.520 agende. Poi uno dice che i politici hanno perso il contatto con la realtà: è che noi, con i problemi che fanno imbestialire i normali cittadini, non ci scontreremo mai più. La realtà ce la siamo dimenticata.
SEDUTE DI COMMISSIONE. La sala di Commissione è ai piani alti, per raggiungerla devi salire una scalinata monumentale. Per farla semplice, le commissioni parlamentari sono delle specie di mini parlamentini, dunque composte da rappresentanti di tutti i partiti proporzionalmente alla loro presenza in Parlamento. Le cosiddette “Permanenti”, 14 in tutto, sono incaricate di discutere di un determinato argomento o esaminare i progetti di legge, per metterli a punto e poi eventualmente sottoporli al voto dell’Aula. Poi ci sono le “Bicamerali”, che raggruppano esponenti di Camera e Senato, e le Commissioni d’inchiesta, che approfondiscono vicende “di pubblico interesse” e sono investite anche di poteri giudiziari, in genere invocate una volta ogni due giorni da una parte politica per dare addosso all’altra. Fine della lezioncina. Inciso: uno può anche essere membro di più Commissioni, e neanche tanto raramente succede che si riuniscano contemporaneamente, così che da qualche parte è per forza assente. Secondo e ultimo inciso: ogni Presidente di Commissione ha a disposizione un altro ufficio e relativo staff, oltre a quello cui ha diritto in qualità di deputato, e il suo stipendio è maggiorato. Misteri dell’organizzazione parlamentare.
«DIAMOCI DEL LEI». Una cosa strana delle Commissioni è che tu arrivi nella sala e chiacchieri normalmente con gli altri componenti, così, parli del più e del meno, poi a un certo punto comincia la riunione e di colpo cambia tutto, «adesso la parola al Presidente Folena», e lui «grazie, caro vicesegretario», e comincia a parlare, e tutti si danno del lei. E quando siamo seduti intorno al tavolone e hai bisogno di passare un foglio a un altro deputato, non è che ti sporgi o ti alzi e glielo dai: no, chiami il commesso, lui arriva, gli consegni il documento, quello fa tre metri e lo porta all’altro. Ora, magari adesso la sto mettendo giù un po’ caricaturale, ma in effetti è davvero così: nei lavori parlamentari, la formalità burocratica viene spesso esibita nei momenti più inutili, e dimenticata quando invece potrebbe aver senso. C’è da dire che tutto questo cerimoniale nasce anche dall’esigenza di verbalizzare le riunioni, pensa che casino per il trascrittore se tutti si parlassero uno sopra l’altro. Resta il fatto che avrà anche un senso, ma la prima volta fa uno strano effetto, quasi teatrale. Pare una commedia.
«… e adesso la parola al capogruppo dei Verdi Poletti…».
E infatti scopro che sono capogruppo, pensa te. Non lo sapevo, giuro. Quasi mi sembra d’esser stato promosso, «evvài, che sono già capo».
Il fatto è che, come ho già detto, le commissioni sono parlamentini, e io sono l’unico rappresentante dei Verdi, e quindi in quanto tale sono capogruppo. “Capogruppo dei Verdi in Commissione cultura, istruzione e ricerca”: mi sono firmato così, quando ho inviato la lettera che mi ha pubblicato il Corriere, proprio vicino alla rubrica di Sergio Romano. E se fossimo stati due, i Verdi in Commissione, l’altro sarebbe stato vicecapogruppo (oppure capo lui e vicecapo io, a seconda). Perché in Parlamento ognuno è capo o vicecapo o presidente o vicepresidente di qualcosa: una commissione, un gruppo parlamentare, un’associazione. Tutti. In realtà, non conti nulla, ma questo sul biglietto da visita non si scrive.
E comunque, ripeto, io sono in “Commissione cultura, scienza e istruzione”.
Cultura. Scienza. E istruzione.
Argomento più importante e sentito delle mie prime riunioni: Calciopoli.
Cioè, va bene tutto, ma che cosa c’entrano la scuola e la cultura e la scienza con Calciopoli? E sono sempre piene, queste riunioni, durano ore. D’altronde, la vicenda è sulle prime pagine di tutti i giornali, c’è modo di essere citati in qualche articolo. Il nostro gruppo d’ascolto viene pomposamente chiamato “Indagine conoscitiva sulle recenti vicende relative al calcio professionistico con particolare riferimento al sistema delle regole e dei controlli”. Le audizioni si susseguono: il presidente del Coni, il rappresentante della Consob, nientepopodimeno che Francesco Saverio Borrelli, il presidente di Mediaset Confalonieri, i rappresentanti dei consumatori e quelli delle tv locali, l’onorevole Josè Luis Arnaut “in qualità di esperto del settore del calcio e dello sport in generale” (?). Ognuno chiede di sentire questo e quello, il Ministro dello Sport Melandri viene a riferire. Ma davvero c’è chi pensa che le riunioni in Commissione cultura possano servire alla già strampalata inchiesta su Calciopoli? Ma poi perché discutiamo a Montecitorio di Calciopoli? Per quale motivo? E in realtà, ne parlo così solo perché a me non interessa il calcio, nel senso che chissà quante volte ho invece partecipato con più entusiasmo ad altre discussioni su argomenti che magari m’interessavano, ma ben sapendo che non avrebbero portato a nulla di concreto.
CULTURA E CALCIOPOLI. Non che le riunioni di Commissione siano sempre così. Quando i progetti di legge toccano veri interessi o questioni tecniche, allora si fanno i conti e si programma e ci si scontra su cose serie, insomma. Ma ho come l’impressione che troppe volte i nostri siano invece pseudo-approfondimenti del tutto inutili, nel senso che sono ininfluenti, e in fondo lo sappiamo anche noi, che sono ininfluenti. In questi casi, mi vien da dire che noi, per lavoro… chiacchieriamo. Nel senso che ci troviamo, parliamo e magari litighiamo su argomenti che più o meno c’interessano, e alla fine resta nulla. E non vorrei sembrare troppo sarcastico, perché si tratta anche di discussioni serie, documentate, interessanti davvero. Ci sono deputati che ci credono sinceramente, spaccano il capello in venti, presentano dossier alti così. Ma comunque, sappiamo che non avranno alcun riflesso o quasi. Come dire: sono delle gran pippe.
Compito fondamentale dei componenti di Commissione resta comunque di fornire pareri sui vari progetti di legge. Prima considerazione: a noi peones, come dobbiamo votare sulle questioni un minimo significative ce lo dice il partito, il Segretario, che della cosa ha già discusso in altra sede, con gli altri pezzi grossi. Ma il nostro “parere” - favorevole o contrario - lo dobbiamo comunque motivare, e per iscritto. Lo schema è più o meno sempre lo stesso: di tuo, ci metti la frase di circostanza, “dichiaro voto favorevole” se sei nel centrosinistra, oppure ‘dichiaro voto contrario”se sei nel centrodestra. Poi c’è da corredare il tutto con riferimenti normativi e rimandi a leggi e regolamenti. E allora cosa fai? Siccome sai che il tal giorno si voterà sulla tal proposta, tu vai all’ufficio della Commissione stessa, o a quello del gruppo parlamentare, spieghi la questione e fai fare tutto a loro, che poi ti riconsegnano il plico. A quel punto, non ti resta che cambiare una virgola di qui, inserire un inciso di là, e al momento della chiamata consegni. Un po’ come i vecchi compiti in classe, con la differenza che qui è consigliabile copiare.
Riassumendo: come votare lo decide il partito, il resto se lo vedono gli uffici. A te non resta che alzare la mano e passare le carte. Datemi pure del disfattista, ma dopo un po’ non ci sono più andato.
Perché è proprio la consapevolezza della tua completa inutilità, che ti distrugge. Hai la sensazione di non poter fare nulla o quasi, sei un dito che all’occorrenza deve premere il bottone prestabilito, e se non ci sei fa lo stesso, tanto il bottone per te lo schiaccia qualcun altro. E non è che m’invento, prendete lo stimatissimo e sempre impeccabile Antonio Polito, che adesso ha mollato la poltrona in Senato ed è tornato a fare il giornalista, anche lui dice che «o sei un soldatino o passi per traditore, solo il governo fa le leggi, i parlamentari devono obbedire senza discutere».
SUL DIVANETTO CON ROMANO. Una frustrazione che aumenta col passare del tempo, e aldilà delle convinzioni politiche, comprendi le persone come Turigliatto e affini, che a un certo punto mandano al diavolo le “logiche di coalizione” e votano secondo coscienza, e succeda quello che deve succedere. Ricordo il mio primo incontro con Prodi: io fresco di elezione, lo fermo in corridoio, «Presidente, posso rubarle un minuto?».
Lui guarda l’orologio: «Va bene». «Ci mettiamo lì?». «Perfetto».
E ci appartiamo su un divanetto di Montecitorio.
Gli parlo del problema del cumulo dei redditi tra moglie e marito ai fini della pensione, una delle tante ingiustizie italiane, in campagna elettorale ci avevo puntato parecchio. Portavo con me una lettera di una coppia milanese che aveva deciso di separarsi, ma solo sulla carta, per riuscire a ottenere una pensione dignitosa per tutti e due. La tiro fuori e gliela leggo. Lui mi ascolta e sfodera l’espressione che l’ha reso famoso, gli occhi chiusi, le mani giunte, in realtà mi sorge il dubbio che stia per prendere sonno. Alla fine della mia appassionata esposizione, lui annuisce, e non so se avete presente la sensazione, anzi la certezza, quando sai di aver di fronte uno che non ha ascoltato una sola parola di quello che hai detto. Mi alzo, lo ringrazio e me ne vado imbarazzato, accorgendomi che nel frattempo un’altra decina di questuanti si è lì radunata ad aspettare il proprio turno. Per addormentarlo definitivamente.
LA PUNTUALITA’. La sveglia mi urla nell’orecchio. È martedì, primo giorno della settimana lavorativa di noi parlamentari. Il lunedì? Ma no, il lunedì non esiste. I non romani più coscienziosi lo usano per arrivare in città, ma la maggior parte dei deputati forestieri arriva il martedì mattina, con tanti saluti alle prime riunioni, «che cosa vuoi che sia un’assenza, mica siamo a scuola, e poi se non si va in Commissione non c’è conseguenza sullo stipendio».
Certo che Roma sa essere bellissima. I primi tempi, il tragitto dalla casa che ho preso in affitto in piazza Navona fino a Montecitorio lo faccio in scooter, tanto c’è il parcheggio della Camera vigilato 24 ore su 24 dai Carabinieri. Poi prendo le misure, e decido che a piedi è anche meglio, ci vogliono dieci minuti a dir tanto. Quando mi alzo presto, cammino fino al bar di fianco alla chiesa di San Luigi dei Francesi, in genere incontrando l’auto blu che porta Andreotti in Senato. Lui è sempre il primo ad arrivare. Poi bevo il caffè e mi avvio verso piazza del Parlamento. C’è caso di incontrare il leghista Cota che fa jogging nei pressi del Pantheon, magari accompagnato dal compagno di partito Capanni, alzano la mano e mi salutano trafelati. Va là che Roma ladrona quasi quasi piace anche a loro, alla fine si sono ambientati più che bene. Il traffico insopportabile della Capitale comincia a rumoreggiare, e Montecitorio entra nella giornata lentamente, i deputati arrivano in ordine sparso con l’inseparabile borsa di pelle, vero status symbol. Un salto alla buvette, altro caffè e via, si comincia.
Come detto, il martedì mattina c’è la riunione di Commissione. Il primo voto in Aula è previsto per il pomeriggio, e non è raro che si tenga quando la Commissione è ancora in corso. Ma l’Aula risulta sempre quantomeno mezza piena, d’altronde in questo caso c’è la detrazione di 206 euro se non raggiungi almeno il 30 per cento delle votazioni utili. Saltare la seduta sarebbe un delitto, anche se in casi estremi puoi portare la giustificazione, e vai a controllare se è vera. Entrano allora in scena i famosi “pianisti”, quelli che votano anche per gli assenti. Non mi dilungo su una questione su cui si è scritto e filmato e sputtanato più volte. All’inizio te la meni un po’, ma quando capisci che il costume è generale - a destra, a sinistra, al centro - ti adegui. Io qualche volta mi sono messo d’accordo con una collega: se non sono presente ci pensa lei, e viceversa. Una volta ho votato io per tutti quelli del mio gruppo. Ci sono anche i “votatori ufficiali” dei deputati più importanti, che non è raro siano in altre faccende affaccendati, d’altronde loro mica possono perdere tempo in Parlamento: al momento opportuno, tirano fuori le due schede e svolgono diligentemente il compito. Il numero legale, e dunque il controllo dei votanti, viene richiesto solo per le questioni particolarmente delicate, in ogni caso non così frequentemente. Oppure, quando l’Aula appare squallidamente vuota, si procede con il voto per alzata di mano, che per molti è così romantico, «ma sì, fa tanto antica Roma…». In realtà, non essendo registrato con il procedimento elettronico, è del tutto valido ma non conta ai fini della trattenuta. Cioè, se ci sei bene, se non ci sei bene lo stesso: la busta paga non ne soffre.
L’IMMAGINE PRIMA DI TUTTO. Ed è proprio quando la stampa comincia a denunciare il malcostume dei pianisti, che vengono a galla le tante assenze dei deputati. In questo senso, noi Verdi ci siamo rivelati imbattibili. E allora, ecco puntuale la circolare: “Care e cari - ci scrive Angelo Bonelli, presidente del gruppo parlamentare - come avrete avuto modo di leggere dai più importanti quotidiani nazionali, il gruppo politico dei Verdi viene posto come il meno presente alle votazioni in Aula. Questi articoli certamente non aiutano a costruire una buona immagine del ns. gruppo (eh già, quel che importa è “l’immagine”). È evidente che ognuno di noi sa quanto partecipa alle votazioni, pertanto sono qui a richiamare con forza una maggiore presenza alle votazioni. Certo di un Vs. cortese riscontro, invio cari saluti”. Gentilmente ricambio.
Il mercoledì è di certo la giornata clou. In mattinata, si comincia ancora con la riunione di Commissione, parole parole e ancora parole. I giocatori giramondo della Nazionale parlamentari, che si allenano il martedì sera sul campo militare della Cecchignola - c’è il capitano Manlio Contento di An, il portierone rifondarolo Augusto Rocchi, l’ex pulcino del Catania Salvatore Buglio della Rosa nel Pugno (che però non è stato ricandidato, dunque c’è da rinforzare la fascia), il centrista Peretti detto Beckenbauer, il terzino sciupafemmine Simone Baldelli di Forza Italia - discutono di dribbling e schemi di gioco. E se c’è qualcuno acciaccato, si trascina zoppicando fino alle attrezzate salette dei fisioterapisti, un bel massaggio e via, come nuovo, e sono così bravi, i massaggiatori, che devi prenotarti, e mica solo al mercoledì. Ma verso l’una c’è il voto in Aula. Ora di pranzo, dunque: noi deputati abbiamo una gran fame, è umano, no? Quindi, dopo aver schiacciato il feral bottone, tutti a mangiare. E dì corsa, che poi non si trova posto. La scena ricorda un po’ l’intervallo della scuola: una marea umana che si precipita verso uno dei ristoranti - c’è quello self-service, veloce e informale, e l’altro più tradizionale, con i camerieri in livrea, infine il bistrot della buvette. Gli onorevoli si affrettano, corrono, sgomitano, scorciatoiano per garantirsi il tavolo. E insomma, è la pausa pranzo, mica sarà un privilegio, questo.
MIRACOLI DEL CALCIO. Dopo aver mangiato e digerito, in genere verso le tre del pomeriggio, va in scena quel reality show che è il “question-time”, in pratica un confronto diretto fra Governo e parlamentari. Approfondiremo più avanti. Prosegue più o meno fino alle quattro e mezza. E comunque non c’è voto, ragion per cui l’Aula è quasi sempre semi vuota, e in quell’ora e mezza si possono sbrigare altre faccende, sempre politiche e parlamentari, per carità. Tanto l’adunata generale - con voto incorporato, questa volta - è per le cinque circa, e prosegue fino alle otto di sera. Sempre che non ci sia qualche partita di calcio: in quel caso, come per magia, alle sei e mezza anche le questioni più complicate si dipanano. Più Totti per tutti.
IN CODA AL GUARDAROBA. E si arriva al giovedì. Fin dalla mattina, si respira l’aria del fine settimana, i deputati che non sono di Roma e dintorni fanno mente locale e si mettono al telefono per prenotare il volo. Si vota dalle undici del mattino in poi, mal che vada c’è un’altra seduta dopo pranzo, verso le tre. Poi comincia il fuggi-fuggi. Vai in guardaroba - lo trovi poco prima del ristorante - ed è pieno di borse, valigie, trolley, pacchi e quant’altro. Dal primo pomeriggio si forma una fila anche di un quarto d’ora. I taxi scaldano i motori, gli onorevoli che hanno prenotato lo stesso volo si raggruppano, «parti adesso anche tu? Allora mi unisco, così spendiamo meno». E poi dicono che non tagliamo le spese.
In realtà, qualcuno rimane anche il venerdì. Ma, in tutta onestà, è davvero raro. Sono pochi, in un anno, i venerdì in cui è espressamente richiesta la presenza, chessò, durante la Finanziaria (ne parleremo) o magari per un voto importante in Commissione. Ma, ripeto, sono casi eccezionali, e quando si verificano si limitano alla mattinata. D’altronde, non è che possiamo contarla tanto su: nei primi cento giorni di questa mia prima legislatura, la Camera ha tenuto 36 sedute, equivalenti secondo i calcoli dei giornali a poco più di due ore al giorno di lavoro. E considerando vacanze e feste comandate e ponti e week-end, su un intero anno di attività - dunque da aprile ad aprile - a Montecitorio si è lavorato 160 giorni. Vale a dire nemmeno 5 mesi. Quattro mesi e venti giorni in un anno. Poi dice che la gente s’incazza.
Ma c’è da precisare una cosa: non è che sempre e comunque il deputato non presente in Aula o in Commissione è a grattarsi la pancia sulla spiaggia di un’isola caraibica. No, il più delle volte sta facendo attività politica, ma per il partito. Che cosa c’entra l’attività di partito con il mandato ricevuto dagli elettori? Nulla o quasi, ma tant’è. E comunque, gira per convegni e dibattiti, partecipa a riunioni organizzative. Oppure, c’è caso che si metta cercar tessere.
Succede per esempio questo: c’è il congresso dei Verdi e Pecoraro Scanio punta naturalmente alla rielezione a segretario nazionale, nonostante qualcuno storca la bocca per questo fatto, perché lui è anche parlamentare e ministro contemporaneamente. E insomma capisco l’antifona, qui c’è da tirar su delle tessere, far iscrivere al partito gente che stia dalla sua parte. E io, che fino a qualche mese prima m’immaginavo battagliare alla Camera per risolvere problemi epocali e passare alla storia d’Italia, da fare mi do. Telefono a destra e a manca, chiamo la parente, l’amico, chiedo al vicino di casa, «ma io non ne so niente, di ambientalismo», «e chissenefrega, basta che fai la tessera e voti per i delegati giusti, e come dici? Che non sai chi sono i delegati? Ma te lo dico io, ecco qui…». Alla fine di tessere ne tiro su parecchie, missione compiuta. È vero, non è che sia il massimo. Ma per rimanere nel gruppo si è costretti a fare anche così.
«CI TROVIAMO ALLA CAMERA». Tornando alla Camera, è aperta anche al sabato. Ma questo, ancor più degli altri, è il giorno degli ex. Gli ex deputati, quelli che tornano a respirare l’aria, magari sono anziani, non hanno più tanto da fare, e poi il richiamo del Palazzo è irresistibile. E allora vedi che li portano in macchina davanti all’entrata, poi qualche badante li scarica e li torna a prendere la sera. È così: ci sono pensionati che si ritrovano alla bocciofila, altri in Parlamento. Loro entrano, si aggirano per i saloni, vanno dal barbiere, ricordano i bei tempi andati, hanno ancora una tesserina speciale per mangiare alla buvette. Discutono animatamente, a volte scoppiano dei litigi che finiscono a maleparole. Qualcuno ogni tanto si addormenta su un divanetto o nella sala lettura, i commessi li lasciano riposare, poi magari li svegliano con delicatezza, «Onorevole…». E c’è anche quello che non riesce a trattenere i suoi problemi d’incontinenza, e i commessi ancora lì, ad assisterlo con pazienza. Sia detto con tutto il rispetto, ma sembra una casa di riposo. E non datemi dell’insensibile, non è che sia un problema dar ospitalità a persone che qui hanno lavorato, e certo molto più di quanto faccia io. Ma anche questo strano “sabato degli ex” un po’ contribuisce all’inquietante atmosfera da “basso impero”, che avvolge quello che dovrebbe essere il cuore e il cervello del Paese. E che inesorabilmente sta risucchiando anche me.
Immaginate un grande, enorme, gigantesco ufficio statale. Ma anche no, anche semplicemente un enorme ufficio, di quelli che tanti italiani vivono quotidianamente. Con tutte le dinamiche che ne conseguono: lavoro chi più chi meno, ma anche amicizie, antipatie, tresche più o meno note, litigi col superiore, ripicche. E poi pettegolezzi, pettegolezzi e ancora pettegolezzi. Le malelingue, a Montecitorio, sono in servizio permanente effettivo. Com’è ovvio, de visu è tutto un sorriso e gran pacche sulle spalle. Ma dietro… Gli uomini, se giovani e appena appena intraprendenti, sono raccomandati e naturalmente omosessuali - «Poletti? Bè, certo, se la fa con Pecoraio Scanio…» - oppure inguaribili puttanieri - « Poletti con Pecoraro? Ma no, sei indietro, quello va a donnine una sera sì e l’altra pure…».
CATTIVERIE ALLE SPALLE. E le donne? Quelle più carine di Forza Italia sono prima o poi tutte indistintamente indicate come amanti di Berlusconi, e succede il contrario di ciò che si pensa, cioè che debbano lavorare il doppio delle altre per dimostrare che valgono. In questo senso chiedere informazioni alla povera Carfagna, che ancora non è riuscita a farsi perdonare cotanta avvenenza. Ma questa caccia quotidiana alla preda dell’insaziabile Silvio ha anche un aspetto paradossale, perché la signora o signorina momentaneamente indicata come accompagnatrice clandestina del Cavaliere viene improvvisamente coperta d’ogni tipo d’attenzione e galanteria dai deputati di centrodestra e non solo - «ma come stai», «e come sei bella», «posso fare qualcosa per te» -, chissà mai che non possa metterli in buona luce con il leader che tutto può.
Figuratevi poi che chiacchiericcio si porta dietro un personaggio come Wladimir Luxuria, il deputato transgender, che poi significa “non chiaramente identificabile come uomo o donna”. In ogni caso, per semplificare, ne parlerò al femminile. Luxuria fa parte con me della Commissione Cultura, è una delle più presenti e acute: studia, passa le notti ad approfondire e, forse per far vedere che non è lì solo in quanto “personaggio scomodo”, interviene sempre e comunque, anche troppo. Gli uomini la studiano incuriositi, le donne la odiano e la criticano per principio, soprattutto quando si tratta di vestiti, «ma come si veste quella lì? Ma secondo te gioca a rugby?». E poi è molto abile con i giornalisti, sa come “usarli” e per questo è spesso sui giornali, cosa che aumenta l’antipatia nei suoi confronti. Un giorno prendo un caffè con lei, tutti ci vedono ridere e scherzare, poi vado in Aula. Arriva un commesso con una busta: me la manda un sempre severissimo esponente dell’Udc, uno che in ogni occasione si atteggia a baciapile bigottone. Leggo il biglietto: “Ma Luxuria ce l’ha ancora o se l’è tagliato?”. Alzo lo sguardo, lo rivolgo verso di lui. E vedo che se la ride, facendo gesti come adire “tu lo sai, vero?”. Neanche alle elementari.
LA LOBBY DELLA NUTELLA. Ma passiamo a un altro “passatempo istituzionale”, che molto impegna e diverte gli onorevoli: sono i “gruppi di pressione”, le “lobby”, per dirla all’americana. Trattasi di drappelli di deputati uniti da un comune interesse, che, raggruppandosi anche al di là degli steccati di schieramento, intendono far fronte comune ed eventualmente incidere su decisioni legislative che riguardano l’argomento in questione. Intendiamoci, spesso si occupano di situazioni davvero importanti, non so, l’amicizia per Israele, oppure i diritti dei bambini, o ancora quelli degli animali. E ho scelto a caso. Ma non può non strappare un sorriso leggere che l’onorevole leghista Grimoldi, per rispondere a uno dei tanti aumenti fiscali paventati dal governo Prodi, in questo caso l’innalzamento dell’Iva sulla cioccolata, si sta sbattendo non poco per “costituire l’Intergruppo per la difesa della Nutella”, sottolineando che “la Nutella è simbolo di intere generazioni. Chi non è cresciuto “a pane e Nutella?”. E Grimoldi invita a considerare il fatto che “la nostra amata crema di nocciole ha una capacità di penetrazione nelle famiglie italiane pari al 100%, mentre altri generi spalmabili soltanto del 50%”. Se da una parte la Ferrero ringrazia, dall’altra si aspetta la replica del formaggino Mio.
VIVA LE BOCCE. E dunque, vai col gruppo: la mastelliana Sandra Cioffi auspica la costituzione dell’intergruppo “Amiche e amici del mare”? Le risponde Maria Ida Germontani, di An, con l’intergruppo “Amiche e amici dei laghi e dei fiumi”. L’ulivista ora Partito Democratico Massimo Vannucci segnala che già una cinquantina di onorevoli, che coprono tutto l’arco parlamentare, aderiscono al gruppo “Amici del termalismo”. E non state ad ascoltare chi insinua che la ragione sociale sia anche di ottenere qualche sconto per ritemprarsi a forza di fanghi. Naturalmente si sprecano gli onorevoli club calcistici sul genere “Viva la Juve e l’Inter e il Milan e la Roma e anche il Napoli”. Non mi dilungo perché di calcio non m’intendo. E poi gli intellettualissimi “Amici dei veicoli di interessi storico”, vale a dire le auto d’epoca, capitanati dal senatore Filippo Berselli (e infatti vuole essere un “intergruppo parlamentare”) e i mai fuori moda “Amici della filatelia”, organizzatore Carlo Giovanardi. Per restare su un livello alto c’è l’onorevole Pedrini, che vuole “incentivare il turismo e la crescita economica tramite lo sviluppo del gioco del golf”, controbilanciato dai più tradizionali “Amici della bicicletta”, di cui m’informa l’ulivista emiliana Carmen Motta. Chiudo il discorso con una nota d’altri tempi, quasi romantica, segnalando l’iniziativa dell’azzurro Paolo Russo, che con passione rilancia il gruppo parlamentare “Amici delle bocce”. Nel senso dello sport, naturalmente.
DEGUSTAZIONI? SÌ, GRAZIE. Appuntamenti molto apprezzati da noi deputati sono poi le degustazioni di prodotti tipici: arrivano i rappresentanti di questa o quella regione, invitati dagli onorevoli e servono - in genere al ristorante di Montecitorio – i piatti e i vini della zona. Sono sempre affollate, le degustazioni, e la scena si ripete pressoché uguale: ci sono queste persone, spesso si tratta di gente di paese che del Parlamento ha coltivato un’immagine quasi mitica. E si trovano lì, spaesati, ad osservare un’orda di affamati che si getta a peso morto su salame o tortellini o Franciacorta, e poi magari c’è qualcuno che si avvicina al bancone, «che delizia questo vino, ma non ne ho avuto nemmeno una bottiglia». E loro con espressione paziente ad allungargli - anzi, ad allungarci - la bottiglia. Scene mica tanto diverse da quelle che vedevo durante le mie trasmissioni, quando invitavo il pubblico ad assaggiare le ricette offerte dal paesino di turno. Ma sì dai, che gli italiani sono così, quando si mangia va sempre bene, e non si vede perché noi deputati dovremmo essere l’eccezione. D’altronde che cosa vi aspettate, che tutti si corra per esempio alla “Prima manifestazione d’indipendenza dalla lingua inglese”, organizzata dall’associazione “Esperanto”, cui è stata concessa per l’occasione la sala stampa della Camera, “intervengono tra gli altri il deputato europeo Alfredo Antoniozzi e l’onorevole Bruno Mellano”. No, meglio la bresaola.
MA QUALI NOTTI ROMANE. E poi ci sono le notti, le “notti romane”, con le terrazze e i salotti e le foto su Dagospia, il famoso sito internet di gossip. Ora, non vorrei sbriciolare un mito, ma le “notti romane” sono una gran noia. Certo che le feste ci sono, per noi Verdi il punto di riferimento è l’avvocato Paola Balducci. Lei è una bella signora molto gentile e ospitale, ha una splendida casa in zona Botteghe Oscure, la sua terrazza è leggendaria. Mi viene in mente uno di questi ritrovi. L’allenatore personale della Balducci le aveva suggerito di puntare sulla carne anche per questioni di dieta e allora era tutta una griglia e bistecche grandi così, all’americana. Infatti, se non ricordo male, c’erano piatti guarniti con bandierina a stelle e strisce, ma lì non e’era da protestare contro nessuna base militare yankee, né i vegetariani avrebbero avuto da dire. In genere, però, i party più chic sono riservati ai pezzi grossi della politica, della finanza, dello spettacolo. Gli onorevoli di bassa lega se riescono s’intrufolano, poi si mettono nell’angolo e allargano le narici per annusare il profumo del potere.
Il più delle volte, invece, noi peones ci si organizza per passare serate al limite della tristezza. I Verdi escono coi Verdi, magari andiamo alla Locanda del Pellegrino, e poi leghisti con leghisti, quelli di An con altri di An. O anche i gruppi territoriali, lombardi con lombardi, napoletani con napoletani e così via.
LATIN LOVER A PAGAMENTO. Si va nel solito ristorante dove ti trattano coi guanti - «buonasera Onorevole, cosa le porto Onorevole». E si cerca di coinvolgere un ministro o al limite un sottosegretario, tanto nel governo Prodi sono cento e più, qualcuno si trova, perché arrivare al locale con l’auto blu fa tutta un’altra scena, senza contare che si risparmiano i soldi del taxi. Si finisce quasi sempre a spettegolare su tizio e caio, col risultato che il giorno dopo, saputo che quello che fa l’amico in realtà sparla di te a più non posso, cerchi di ostacolarlo in ogni sua iniziativa politica, così, per antipatia personale. Ed è vero, a fine serata c’è anche chi si rifugia dall’amante più o meno giovane, o raccatta un po’ d’amore a pagamento. Al limite si svena e investe su una bellissima “escort” contattata via Internet, salvo poi sbandierare conquiste e performance improbabili manco fosse Mastroianni. Ma le orge in stile rockstar o i festini con le più disinibite vallette del momento, bè, scusate la delusione, ma per quel che mi riguarda sono più che altro letteratura d’accatto.
In pornostar e dintorni, in effetti, una volta mi sono imbattuto. Mi telefona il capo ufficio stampa del partito, Giovanni Nani, e si lamenta, «Poletti, basta con questi scherzi». Io casco dalle nuvole, «ma quali scherzi?». E lui seccato mi dice che insomma, c’è il manager di questa pornostar, Federica Zarri nota anche come Diana Buson, che lo perseguita perché lei dice di voler entrare nei Verdi, e siccome è lombarda credeva c’entrassi io. Si apre così un gioioso dibattito, pornostar sì pornostar no, con il nostro Camillo Piazza, appassionato di balli sudamericani e che già aveva organizzato una manifestazione con diverse attrici hard per salvare il Ticino dall’inquinamento, a sostenere l’ingresso di Federica nel partito. «Perché, che male ci sarebbe?». Ma la discussione s’interrompe bruscamente: veniamo infatti a sapere dai giornali che la Zarri ha cambiato idea, intende aprire un Circolo della libertà. La volgar battuta nasce spontanea: cazzi loro. E giù risatacce.
LE RIUNIONI. Ma adesso, per favore, adesso non si dica che a Montecitorio non lavoriamo mai. Non è così. Prendiamo la Finanziaria, la legge di bilancio, quella in base alla quale il governo decide come e dove spendere i soldi. Quello sì che è un periodo caldo, anche se arriva prima di Natale. Lo si comincia a capire dagli sms: già durante l’anno ne arrivano parecchi al giorno, “presenziare alla tal riunione”, “voto in Aula sulla tal questione”, ma quando c’è di mezzo la Finanziaria è un continuo, il cellulare manda trillini d’avviso ogni tre minuti. E poi fax ed e-mail di convocazione, decine e decine e decine, carta e carta e ancora carta, un settimanale ha calcolato che, soltanto per le convocazioni via fax degli organi della Camera, vengono spesi 200mila euro ogni anno. E insomma, sulla Finanziaria tutti i deputati sono chiamati a raccolta, prima in Commissione per mettere a punto i capitoli di spesa, poi in emiciclo, quando c’è da votare. In realtà, c’è da dire che si tratta dell’ennesima occasione in cui ti rendi conto che, su 630 onorevoli, quelli che effettivamente hanno voce in capitolo sono sì e no un decimo, ed è un calcolo per eccesso. A decidere è il segretario di partito, che nel mio caso è anche ministro, insieme con gli altri esponenti di governo. Al limite, ne può parlare con il capogruppo e qualche altro fedelissimo. A tutti gli altri non resta che schiacciare il bottone a comando. Salvo prima sorbirsi le relazioni introduttive dei vari sottosegretari, spesso sconosciuti agli stessi deputati, che vengono a spiegare la rava e la fava, e tu fai finta d’ascoltare, già sapendo che la “disciplina di coalizione” t’impedirà di ragionare con la tua di testa.
L’INCONTRO CON PADOA-SCHIOPPA. In questo senso, mi viene in mente il mio primo incontro con Padoa-Schioppa, l’algido e sempre elegante Ministro dell’Economia. Lo vedo in un piccolo supermercato vicino alla mia casa romana, mattino presto, anche lui a fare la spesa. Un saluto timido e in me si rafforza la convinzione: uno che si aggira per gli scaffali vive la realtà di tutti i giorni, vedrai che è l’uomo giusto. E invece, ma questa è un’opinione del tutto personale, con l’andar del tempo mi ricredo: le sue Finanziarie partono in un modo e finiscono in un altro, stritolate da mediazioni e pressioni di partitini e partitoni di governo, ciò che rimane è una gran saccagnata fiscale e via andare. Uno dei miei chiodi fissi è sempre stato quello di esentare dal pagamento del canone Rai gli anziani indigenti sopra i 75 anni, provvedimento magari non epocale, ma secondo me simbolico. E comunque gli telefono per perorare la causa. Mi risponde una segretaria, «vuole parlare col Ministro? Può prima dire a me?», e io le espongo la questione, alla fine chiedendo un appuntamento. Niente da fare, la segretaria risponde che no, l’agenda del Ministro è piena, non ha tempo. Mi rivolgo allora al mio capogruppo Bonelli, ma anche lì nisba, è tutto preso a organizzare non so quale spedizione per salvare non so quale foresta, mi sembra quella amazzonica. Risultato: il canone Rai è addirittura aumentato, la foresta amazzonica va scomparendo.
PASSATEMPI TRA UN VOTO E L’ALTRO. La Finanziaria, dicevo. È un caos totale. Il Palazzo impazzisce. I tempi sono contingentati, le sedute si prolungano fino a notte fonda, c’è chi si addormenta in Aula e sui divanetti, si organizzano i turni per andare a mangiare, tanto il ristorante è sempre aperto, «voti tu per me? Poi ti copro io». Gli avvocati si portano le pratiche più urgenti, già che ci sono gli danno un’occhiata, d’altronde a Montecitorio i doppiolavoristi non hanno bisogno di nascondersi. Altri giochicchiano con il telefonino, c’è addirittura chi si diverte con queste chat erotiche, poi se le guardano a vicenda e sghignazzano. Uno spettacolo deprimente, questa è la verità, e lo dico senza il minimo snobismo, io ci sono in mezzo, sono uno dei commedianti, e pagato per questo, per giunta. I gruppi parlamentari si riuniscono continuamente, ma sono pantomime, alla fine delle quali il segretario o il capogruppo ti dice come votare, peraltro in questa legislatura è il Senato a essere in bilico, alla Camera non puoi nemmeno pensare a un “dispetto”, nel senso che non avrebbe alcuna incidenza. Nei corridoi incontri i ministri che corrono da una parte all’altra, a notte fonda qualcuno ha sbagliato a votare oppure il tal gruppetto ha voluto mandare un avvertimento al governo, dal boato si capisce che è passato un emendamento dell’opposizione, ma l’argomento è secondario, cambia nulla. Poi c’è la Galleria dei Presidenti, in cui i deputati possono ricevere le visite, e lì incontri i rappresentanti delle varie lobby, quelli interessati a che passi questo o quel provvedimento, e cercano di convincerti. Anzi, l’emendamento te lo portano direttamente loro, già bell’e scritto. «Allora, cosa dici lo presenti tu?». Magari trovi la questione effettivamente interessante, ma fai loro presente che comunque saresti l’unico a sostenerlo, e loro non fanno una piega: «tu presentalo, che noi siamo già in contatto con altri onorevoli…» . E c’è caso che nemmeno tanto velatamente ti propongano una contropartita in denaro. Cioè, per dirla chiara, se presenti il loro emendamento ti danno dei soldi. A me è successo. Ho rifiutato.
E nel mezzo di questo gran mercato delle vacche non è raro assistere a dei gran litigi. Ne ricordo uno alla buvette tra il nostro capogruppo Bonelli e il Ministro Bersani finito a grida e minacce, «io questo non te lo voto!!», ma poi in genere rientra tutto. Magari, se sei fortunato, riesci a strappare al Governo una “raccomandazione” su un determinato problema, che non vuol dire nulla, ma puoi in seguito esibirla nel tuo collegio e spacciarla per un grande successo, «visto che sto lavorando per voi?». Che tristezza.
ANDATA E RITORNO. Il meccanismo della Finanziaria è astruso. C’è la prima lettura, dove vengono presentati i provvedimenti e discussi gli emendamenti, si vota e si va. Ma poi il falcone passa all’altro organo parlamentare per la seconda lettura, che è quella più importante, perché si inseriscono le eventuali variazioni e si rivota. Qui ci sarebbe da aprire un altro discorso, quello della sovrapposizione di competenze fra Camera e Senato, l’annoso dibattito sull’inutilità del nostro cosiddetto “bicameralismo perfetto” : non sarebbe più logico e funzionale discuterla una volta sola, ’sta benedetta Finanziaria? Ma rischiamo d’infilarci in un ginepraio, nemmeno ne abbiamo la competenza. In ogni caso, ne consegue che il passaggio fondamentale è la seconda lettura. Nel mio caso, ho vissuto entrambi i brividi. Perché nel mio primo anno da deputato, alla Camera la legge di Bilancio arriva in prima lettura. Nel secondo anno, invece, a Montecitorio ci tocca la seconda e più importante. Tra l’altro, se da principio faccio parte del gruppo parlamentare dei Verdi, poi passo a quello di Sinistra Democratica. E qui vale la pena di raccontare la trasmigrazione.
IO VADO CON MUSSI. Un giorno mi chiama Pecoraro Scanio e mi convoca d’urgenza, «ci vediamo a casa mia? Devo parlarti di una cosa importante». Subito penso: ecco, arriva il cazziatone. In effetti, c’erano state quelle trasmissioni in cui svelavo qualche onorevole trucchetto, e poi le assemblee in Piemonte dove avevo raccontato dei nostri stipendi altissimi, e i collaboratori di un deputato Verde gli avevano chiesto l’aumento, e insomma questo se l’era presa. Arrivo da Pecoraro: lui abita in un bell’appartamento all’ultimo piano di un palazzo nel centro di Roma, poco lontano dalla stazione Termini, nella zona delle ambasciate e dei consolati. Dalla sua terrazza si gode un panorama magnifico. Ci ha anche piazzato una vasca in stile Jacuzzi, così puoi farti l’idromassaggio e cose del genere guardando le stelle. Comunque uno spettacolo, e a quel paese le raccomandazioni sui risparmi. Arrivo e dopo i saluti di rito mi spiega: ci sarebbe da aderire a un altro gruppo parlamentare, quello di Sinistra Democratica. Io? «Sì, tu». Il discorso è semplice: il Ministro Fabio Mussi e i suoi, in rotta con i Ds, soprattutto per via del costituendo Partito Democratico, hanno costituito alla Camera un gruppo parlamentare per conto proprio, chiamato Sinistra Democratica. Solo che adesso dal nuovo gruppo se ne sono andati Grillini e altri due onorevoli e ci vogliono almeno venti deputati per tenerlo in piedi e avere a disposizione gli uffici e incassare i contributi. Insomma mi par di capire che loro stanno per scendere a diciannove, hanno bisogno di un altro. «Tu fai così, mi dice in sostanza Pecoraro, aderisci a Sinistra Democratica, il nostro capogruppo ti scrive una bella lettera in cui ti ringrazia per l’adesione tecnica e il gioco è fatto». Spiego che io con Mussi non c’ho mai nemmeno parlato. Questo loro capogruppo l’avrò incrociato due volte a dir tanto, e poi non so nemmeno che politica intendano fare, questi. Pecoraro mi tranquillizza, «è solo un’adesione tecnica», e mi aspetta la possibilità di essere candidato alle elezioni europee, potrei diventare subito commissario dei Verdi a Sondrio, che Fi ai Verdi se possono gli sparano. Comunque sono offerte che non m’interessano. E allora, volendo, posso cambiare Commissione, ce n’è una che gradisco più della Cultura? Ci penso e decido che va bene, iscrivetemi pure a Sinistra Democratica, per quanto mi riguarda mi piacerebbe la Commissione Affari Esteri, lì ci sono i big. E così succede: io, anticomunista da sempre, mi intruppo con i fuoriusciti dei Ds. Questi neanche mi parlano, ma mi inviano delle e-mail, che cominciano con “Caro compagno” e la mia “adesione tecnica” mi frutta un posto in Commissione Esteri. Mi arriva la letterina preannunciata: «Caro Roberto, desidero ringraziarti a nome del gruppo parlamentare dei Verdi per la preziosa disponibilità che hai dato nell’iscriverti “tecnicamente” (nella lettera è così, tra virgolette) al gruppo Sinistra Democratica Socialismo Europeo. È stato un atto di importante sensibilità politica che consente al suddetto gruppo di sopravvivere ed evitare lo scioglimento, rafforzando al contempo i rapporti tra noi e il gruppo di Sinistra Democratica. Grazie e un abbraccio». Il trionfo delle idee.
LA LEGGE-MANCIA. E comunque, per concludere sulla Finanziaria, vista dai Verdi o da Sinistra Democratica, non c’è differenza. I meccanismi sono gli stessi. E allora vien quasi da rivalutare la tanto bistrattata “legge mancia”, quella a volte giustamente sbeffeggiata dai giornali perché distribuisce piccoli finanziamenti a pioggia sul territorio. Ed è vero, le modalità sono un po’ losche, non deve nemmeno passare dall’Aula, se la vedono quattro big di destra e sinistra in Commissione. “Una fetta a te, l’altra a me, poi ognuno suddivida come crede”, e così ci trovi le centinaia di migliaia di euro regalate all’ente inutile amico dell’amico. Ma anche l’aiuto essenziale all’associazione meritoria, o il contributo per risistemare il campanile o la piazza del paese. Cose concrete, insomma, se poi qualcuno ci fa la cresta è tutt’altro discorso. Dal canto mio, riesco a far passare una sovvenzione alla ONLUS “La Prateria” di Paderno Dugnano, 70mila euro a un’organizzazione specialità nell’ippoterapia con i disabili, serviranno anche per la nuova sede. Uno degli atti da deputato di cui vado più fiero.
IL RAPPORTO CON I GIORNALISTI. E poi c’è questo strano rapporto coi giornalisti, anzi i cronisti parlamentari, che vivo in maniera ambivalente essendo anch’io giornalista, sia pur disprezzato da quelli “seri”, perché faccio la tivù nazional-popolare, sono quello della “scura Maria”, ricordate? E comunque, il giornalista della grande testata lo riconosci subito, arrivi in Transatlantico e lo vedi pienissimo di seissimo, che passeggia a braccetto con il Segretario di partito, anzi ormai sembra anche lui un segretario di partito, tutto impettito nel suo vestito elegante. In realtà, l’impressione è che qui a Montecitorio ci venga anche per fare passerella, tanto lui lavora più che altro al telefono, nella sua agenda tiene tutti i numeri che più riservati non si può, di certo ha più confidenza lui con i politici d’alto rango che il 90 per cento dei parlamentari. E infatti molto spesso noi soldati semplici dell’Aula lo veniamo a sapere dai giornali, che il partito intende presentare questo o quel progetto di legge, e soltanto in seguito il Ministro viene in Commissione a spiegarcelo. Con noi ad annuire come somarelli.
Certo, come direbbe lo psichiatra, quello tra politica e stampa è un rapporto border-line. Noi deputati di seconda fila spacciamo le informazioni di cui siamo a conoscenza, soprattutto i ricercatissimi retroscena, che quasi sempre sono pettegolezzi di quarta mano, e spesso si riducono a impressioni su ciò che sta per accadere, e a volte ce le inventiamo di sana pianta, magari per mettere in difficoltà il rivale politico che nemmeno tanto raramente è dello stesso partito. In cambio, chiediamo un po’ di spazio sul giornale per le nostre iniziative, o le proposte che sappiamo non avranno mai seguito, o la dichiarazione che serve per far vedere al “mondo esterno” che esistiamo.
INTERROGAZIONI A COMANDO. Ecco, è questo: dichiaro, dunque esisto. Questa è una regola fondamentale. Far circolare sulle agenzie di stampa il nostro pensiero su qualunque argomento, anche quello più lontano dalle nostre effettive competenze, serve a qualcuno per nutrire la propria vanità, ad altri per mettersi in evidenza agli occhi del capo, presente o futuro, e agli stessi capi per dimostrare il loro quotidiano impegno al servizio del Paese. In questo senso, Pecoraro Scanio è ormai leggendario: ricordo un articolo in cui si calcolava che in un solo mese era riuscito a far comparire il suo nome in 133 titoli dell’agenzia Ansa. Un record. Ma non si dica che è l’unico: tutti, compreso me, parlano di tutto e anche del suo contrario. E pure ci parliamo addosso: un deputato rilascia una dichiarazione alle agenzie? Subito si aggiunge quella dell’altro onorevole, poi del capogruppo, quindi esterna il Sottosegretario, infine il Ministro. Cinque voci sullo stesso argomento per un solo partito, qualcosa passerà.
Il gioco di sponda prevede poi le cosiddette “interrogazioni a comando”. C’è il giornale che fa l’inchiesta, l’articolista ti chiama, «perché non sollevi il caso?». Tu prepari l’interrogazione e la presenti. La risposta del governo arriva dopo mesi (se arriva). Ma il giornale può esultare: “Il caso X arriva in Parlamento”. E anche i tuoi elettori sono contenti. Ultimamente poi, con tutti questi delitti di cui il pubblico è ghiotto, i giornalisti ti chiamano e chiedono notizie sull’assassino in questione, visto che i parlamentari possono entrare in carcere con la scusa di “controllare come viene trattato il detenuto”. E in realtà, una volta usciti, passano al cronista di riferimento le informazioni necessarie all’articolo: “l’omicida pare sereno oppure è turbato, legge romanzi piuttosto che vede i film gialli, in cella fa ginnastica e via dicendo”.
OCCHIO ALLE INTERCETTAZIONI. In effetti, con questa storia delle inchieste giornalistiche sugli sprechi di Palazzo e anche la continua pubblicazione di intercettazioni telefoniche più o meno sputtananti, la questione è diventata delicata. In questo senso, ero e resto convinto che sia compito della stampa tenere sotto controllo vita e comportamenti di chi ricopre un incarico pubblico. Per questo, eletto da neanche quindici giorni, promuovo la nascita di un “Comitato per la libera pubblicazione delle intercettazioni telefoniche delle inchieste che riguardano il bene pubblico”. Dopo qualche giorno, mi arrendo all’evidenza: messe in fila, le adesioni occupano meno spazio del titolo dell’iniziativa. Tra l’altro, al momento del voto in Aula sul decreto che ne limita la pubblicazione sui giornali, ci saremmo astenuti soltanto in sette, con gli altri onorevoli a fischiarci e a dircene di tutti i colori.
E sempre a proposito di intercettazioni, è davvero comico come hanno cambiato le abitudini telefoniche degli onorevoli, anche quando nulla hanno da nascondere. Ormai si parla solo per metafore, col risultato che le conversazioni durano il doppio.
«Ciao Polettì, senti, hai poi parlato con quello per quell’altra cosa là?».
«Eh? Chi? Quale cosa?».
«Ma sì dai, la questione quella lì… Hai capito?».
«No, guarda…».
«La cena, la cena con coso…».
«Ma quale cena? E con chi?».
«Ma tu non sei Poletti?».
«Sì, certo che sono io».
«Ma che telefono è questo?».
«Ma è il mio, mi hai chiamato tu!».
«Ah già. E non dobbiamo andare a cena?».
«Sì, mercoledì sera, non ti preoccupare che me lo ricordo».
«E non viene anche quello di quell’altro partito?».
«Sìì, viene anche lui, e allora?».
«Bé, sai, al telefono…».
«Ma che problema c’è?».
«No, niente, ma di questi tempi è meglio stare coperti, no?».
PANTOMIMA CONTRO I PRIVILEGI. Ma le denunce su Casta e dintorni provocano altri effetti paradossali. Innanzitutto, dopo ogni privilegio svelato, si susseguono le proposte di legge per eliminarlo, ma costruite in modo da non poter essere tecnicamente accolte, così da ottenere due effetti: per prima cosa sei ripreso dai giornali, per una volta in senso positivo, e poi ti risparmi le occhiatacce di chi di quei privilegi gode. Ma la cosa più divertente, o disarmante, è un’altra. Perché succede, e io ne sono stato testimone diretto, che l’articolo di denuncia su una delle tante assurde franchigie riservate ai deputati sveli a noi stessi onorevoli un vantaggio, di cui non sapevamo l’esistenza. E allora ci si informa: «ma è vero che abbiamo diritto anche a questo?». Per poi usufruirne. Almeno fino a quando il beneficio in questione non sarà travolto dal montante disgusto generale.
È un mondo del tutto autoreferenziale, dai politici stessi che si fanno intervistare per denunciare la “politica politicante”, a quelli che si autovotano nel sondaggio lanciato da Italia Oggi sui “cento parlamentari da salvare”, e vedi i deputati che compilano la scheda del giornale segnalando il proprio nome, e quando si accorgono che li hai visti sorridono imbarazzati, «ma sì, dai, è uno scherzo».
Il problema semmai nasce quando proprio i giornali ti pizzicano sul fatto, magari ritirando fuori vecchie dichiarazioni, che contraddicono l’immagine che adesso vuoi dare. Io poi, col mio passato in Padania quando la Lega era dura e pura e Bossi chiamava il Nord alla secessione, sono bersaglio facile. Eletto con i Verdi, dunque politicamente alleato con l’estrema sinistra pur non essendo in quasi niente d’accordo con lei, provoco infatti un mezzo coccolone ai miei compagni di schieramento e anche, a dir la verità, delle occhiate di scherno ai danni del mio gruppo parlamentare (sul genere “visto chi vi siete portati in casa?”) quando proprio Libero ripubblica un articolo da me firmato anni prima, dove, parlando di clandestini, provocatoriamente mi definivo “razzista” e chiedevo senza giri di parole di “sbattere fuori questi maledetti”. Provate a pensare alla faccia, chessò, dei Comunisti Italiani… Non per discolparmi, e infatti non lo faccio, anzi ci ho parecchio riso su, ma sono figuracce in cui, nel Paese dei ribaltoni e ribaltini, la maggior parte dei Parlamentari è incappata almeno una volta. Tanto, la tattica di reazione, a destra e a sinistra, è sempre la stessa: se il giornale è politicamente avverso, meglio controbattere poco o niente, «tanto i nostri non lo leggono». Oppure gridare alla ” strumentalizzazione di parte”.
TUTTI IN POSA, C’È LA TIVÙ. E passiamo alla tivù. Ah, quanto ci piace a noi parlamentari la tivù. A parte quei pazzi delle “Iene”, che organizzano agguati davanti al Parlamento per farti fare delle gran figuracce, e quando si sparge la voce che sono nei paraggi c’è chi cerca in ogni modo di mimetizzarsi per evitarli. Per il resto, ho spiegato che il mezzo lo conosco, dunque i meccanismi già li avevo compresi. Ma osservati dall’interno, bè, sembra un film comico. E non mi riferisco necessariamente ai pezzi grossi, quelli che vengono invitati a “Porta a Porta”, che loro in effetti qualcosa hanno da dire, comunicare, spiegare, litigare. Parlo ancora una volta di noi peones. Che, tanto per fare un esempio, facciamo a gara per comparire di fianco al Segretario durante un’intervista al tg, così ci vedono e facciamo la figura di quelli che contano qualcosa. Un po’ come il famoso disturbatore Paolini. Solo che a noi non ci cacciano.
Un altro show va in onda durante il cosiddetto “question time”. In teoria, è un confronto durante il quale i rappresentanti del governo, ministri o quant’altro, rispondono in Aula alle domande poste dai deputati. In pratica, si trasforma in una vetrina a uso e consumo della televisione, visto che viene trasmesso in diretta dalla Rai. In genere, si tiene il mercoledì. Gli interventi vanno però consegnati entro lunedì a mezzogiorno, dunque le risposte sono preconfezionate. Quasi sempre, l’Aula è semivuota, poiché in quella ora e mezza non si vota, quindi liberi tutti: si riempie soltanto quando vengono affrontati temi particolarmente importanti, e allora tutti presenti, chissà che i giornali non ne parlino.
In ogni caso, tra i deputati ci sono gli aficionados del “question time”, ormai espertissimi di regia e inquadrature. Il mio vicino di ufficio Arnold Cassola, per esempio, è bravissimo: lui è stato eletto in una circoscrizione estera, e dunque quelli che l’hanno votato vedono in video quanto si dà da fare, e questa volta non lo dico in senso ironico, si dà da fare davvero. Certo, sugli effetti concreti dei suoi appassionati interventi qualche perplessità rimane. Ma tant’è: l’importante è parlare, qualche traccia resterà. Anche se a volte sarebbe meglio di no.”
Tempi duri per Carlo Monai, il deputato dell'Idv che ha raccontato all'Espresso gli infiniti privilegi di cui possono godere consiglieri regionali e deputati. Durante un dibattito in Aula, come racconta ancora “L’Espresso”, è stato infatti contestato e insultato da mezzo emiciclo, da maggioranza (Pdl e Lega Nord) ed opposizione, Pd in testa. Insomma, è scattata la caccia al traditore. Nessuno gli ha contestato l'intervista nel merito (i lavori parlamentari che chiudono il giovedì, le indennità di ogni tipo, gli sconti possibili su auto, mutui, ingressi a teatri, il posto fisso allo stadio, i benefit di ogni tipo e forma, il ristorante dove la bistecca di manzo costa poco più di due euro), ma tutti hanno difeso il lavoro che si fa a Montecitorio. E anche quello che si fa nei week-end fuori dall'Aula: «Noi cerchiamo di capire» ha detto Donata Lenzi del Pd citando, forse involontariamente, una nota sequenza di Ecce Bombo di Moretti «ci prepariamo, incontriamo gente, studiamo...».
La Lenzi è quella che l'ha attaccato per primo. Rivolgendosi ai colleghi, s'è detta colpita da «ciò che sta uscendo sui giornali, le riviste, i siti, e-mail» sul tema della Casta. «Alla campagna già in corso si è aggiunta in questi ultimi due giorni la testimonianza di un nullafacente (allusione a Monai) purtroppo autodenunciatosi nostro collega, il quale però ha ritenuto opportuno allargare questa sua autodefinizione a tutti i 630 componenti di quest'Aula. Non entro nel merito circa l'opportunità, che mi vede assolutamente convinta, di partecipare anche noi, attraverso la riduzione delle nostre indennità, all'attuale situazione di difficoltà... Non entro nel merito dell'elenco delle varie opportunità, molte a me assolutamente sconosciute su acquisto di automobili, entrate gratis in teatro, altri vantaggi del genere di cui la gran parte di noi non solo non sa nulla ma si è ben guardata di andare anche ad informarsi. Chi è in un partito strutturato, vero, radicato sul territorio, il sabato e la domenica è alle iniziative pubbliche, a riunioni di partito, a fare volantinaggio oppure studia, si prepara, cerca di capire, si organizza, incontra gente, incontra rappresentanti della società civile, degli interessi...».
Dopo l'intervento della Lenzi, prende la parola Giuliano Cazzola, del Pdl, che protesta perché su Mediaset una trasmissione seguiva con una telecamera nascosta i parlamentari. «Non si può fare informazione in questo modo, siamo persone che lavorano tutto sommato tutto il giorno, e che magari saltano anche il pranzo. Non possiamo essere presentati come sanguisughe se alla cera ceniamo.
Poi è la volta di Monai, che difende la sua posizione di testimone. «C'è uno scarto tra quello che è il nostro impegno e quello che guadagniamo». Fischi, buu della platea.
Interviene subito dopo Luca Rodolfo Paolini della Lega Nord, che chiede al presidente della Camera di far tutelare meglio l'onore dei deputati. «Anche a costo di spendere qualche cosa, in modo da informare correttamente i cittadini». In altre parole, Paolini propone che il palazzo spenda dei soldi (pubblici) per difendere le spese del Palazzo.
Subito dopo Giovanni Bachelet del Pd se la prende con le statistiche Openpolis («non è un buon indicatore dell'attività parlamentare, non considera l'attività delle Commissioni»), mentre Fabio Garagnani del Pdl attacca Fini, che secondo lui dovrebbe avere «molto più coraggio nel difendere le prerogative dei parlamentari, di chi lavora, del loro operato».
Certo è che per vagliare l’utilità dei nostri parlamentari basterebbe verificare quanta attenzione mostrano alle segnalazioni che arrivano dai cittadini, se non addirittura dai loro elettori: zero!!
Non solo non risolvono il problema, specie se ad esserne causa è lo spauracchio della Casta dei Magistrati (chi li tocca muore, alla faccia della mafiosità), ma addirittura i Parlamentari e/o i loro portaborse non si degnano di riscontro, né di risposta.
Sulla Casta delle Regioni è ancora “L’Espresso” a fare le pulci. Una vale le altre. Si parla della Lombardia, ma è come se si parlasse delle altre 20, comprese le province di Trento e Bolzano. Stipendio che sfiora i 10 mila euro al mese, e senza neppure la scomodità di doversi pagare un albergo a Roma come i Parlamentari. Calcolo delle presenze "elastico", parcheggi e biglietti gratis, iPad omaggio e persino un palco riservato a teatro. E' la vita dei consiglieri regionali, non molto diversa da quella dei deputati e dei senatori. Certo, in busta paga ci sono un paio di migliaia di euro in meno, ma con il fatto che si risparmia i pernottamenti nella capitale, il netto finisce per essere simile. A condurre L'Espresso tra i privilegi della "castina" delle Regioni è Gabriele Sola, consigliere della Lombardia per l'Italia dei Valori, da sempre impegnato sul fronte della riduzione dei costi della politica. E la Lombardia non è certo il consiglio più spendaccione (anzi, in rapporto agli abitanti è tra i più sobri), specie a confronto con casi disperati come la Sicilia.
Proprio su proposta di Sola e del consigliere Cavalli (ex Idv, ora Sel) è stata di recente approvata una mozione per la riduzione dei privilegi dei politici del Pirellone. «Adesso c'è stato un leggero taglio a stipendi e benefit, ma comunque la retribuzione rimane su livelli importanti, tra gli 8.500 e i 9.500 euro al mese», spiega Sola mostrando la sua ultima busta paga. «Abbiamo inoltre tutta una serie di privilegi per il nostro ruolo».
Partiamo quindi dallo stipendio, calcolato attraverso una serie di parametri non proprio intuitivi. I consiglieri hanno diritto a un'indennità e a una diaria collegata al numero di presenze in assemblea e in commissione: per ogni assenza, viene scalato un gettone di circa 140 euro. Ma è proprio sul calcolo di queste presenze che si generano le prime storture. «C'è un registro delle presenze compilato dai commessi, e il consigliere deve firmarlo presentandosi in aula entro 15 minuti dall'inizio della seduta», spiega Sola. «Il problema è che, una volta firmato, volendo si può anche lasciare l'aula».
Lo stesso presidente Formigoni risulta uno dei beneficiari di questo sistema. «Quest'anno, essendo i 150 anni dell'Unità d'Italia, all'inizio delle sedute suona l'inno nazionale», dice Sola «E Formigoni lo vediamo quasi solo in questi minuti iniziali». Insomma, prende i soldi e scappa.
Va però segnalato che in Lombardia, a differenza di altri casi, la partecipazione a un convegno non può essere avanzata come giustificazione per l'assenza in aula. «Non ci sono assenze giustificate, per malattia o per altro», dice Sola. «Solo le missioni istituzionali possono valere in questo senso, ma è difficile che un consigliere possa accedervi». Un'eccezione la fanno quelle che Sola chiama le "gite di gruppo", ovvero missioni istituzionali a cui sono invitati tutti i consiglieri e che si rivelano un'enorme spesa per il bilancio pubblico. Di recente la Regione Lombardia ha invitato assessori e consiglieri all'inaugurazione degli uffici a Bruxelles: una due giorni di viaggio che «di certo non era low cost», spiega Sola. Le proteste dei partiti di opposizione ha poi ridimensionato la "gita di classe", a cui hanno partecipato solo alcuni rappresentanti e non l'intero consiglio.
Oltre all'indennità calcolata sulle presenze effettive, lo stipendio dei consiglieri prevede anche un rimborso variabile in base alla distanza degli uffici dalla propria residenza: in questo modo un consigliere di Sondrio riceve un compenso superiore a uno di Milano. L'importo di questo rimborso può arrivare fino a un massimo di circa 1.900 euro al mese. Su tutto il fronte trasporti comunque i consiglieri lombardi non possono lamentarsi. Innanzitutto hanno diritto a una tessera per l'auto che permette di accedere a tre privilegi non da poco nella città della Madunina: possibilità di parcheggiare in tutta Milano, diritto ad utilizzare le corsie riservate a taxi e autobus e accesso illimitato alla Ztl. Per chi alle ruote preferisce i binari, c'è invece la tessera de Le Nord, il servizio ferroviario locale compartecipato dalla Regione, che permette di andare su tutti i treni della società. Ma il capitolo viaggi si arricchisce anche della possibilità di volare gratis, con un tetto massimo di 11 voli l'anno calcolati sulla tratta Roma-Milano e «da giustificare per esigenze di servizio». Se si è invece alla ricerca delle famigerate auto blu, bisogna salire di un livello e andare all'Ufficio di Presidenza, i cui componenti percepiscono una cifra intorno ai 30 mila euro l'anno se rinunciano a questi veicoli.
«In pratica a fine mandato», chiosa Sola «con tutti i soldi messi da parte possono aprirla loro una concessionaria di auto blu».
I benefit si estendono anche ai gadget tecnologici. Appena entrati in carica ai consiglieri viene infatti chiesto se preferiscono un computer fisso in ufficio o uno portatile per svolgere il proprio lavoro, ed è inoltre possibile richiedere un cellulare regionale (pare vada molto di moda il BlackBerry), con delle tariffe agevolate fornite grazie a delle convenzioni stipulate con gli operatori. Con l'arrivo dei tablet è poi scattata la possibilità di ottenere gratuitamente un iPad. Tra le altre voci dei privilegi vale la pena segnalare la possibilità di accedere al teatro La Scala, visto che due palchi sono riservati proprio alla Regione e ai suoi rappresentanti: una domanda al capogruppo e la segreteria fornisce i biglietti, anche per un accompagnatore.
Il paradosso viene da quanto denuncia “Libero-news” sui benefits della regione Sicilia. La Regione che più di tutte rappresenta “il papponismo”.
Metti che il cittadino finalmente si ribelli e decida di aspettarli fuori dal parlamento per lanciare monetine. Metti che la folla esasperata si munisca di torce e forconi e tenti di scannarli come capretti sulla pubblica piazza. I signori onorevoli saranno anche pronti ad affrontare le offese verbali, ma nella prospettiva di un rischio fisico bisogna pur tutelarsi. E infatti si sono fatti l’assicurazione sul linciaggio.
Dal 13 luglio 2011 - giorno dell’approvazione da parte del Consiglio di presidenza - i componenti dell’Assemblea regionale siciliana (Ars), cioè il parlamento isolano guidato da Raffaele Lombardo, beneficiano di una convenzione stipulata dal Fondo assistenza e solidarietà regionale con la Cassa di assistenza sociale e sanitaria Caspie. Come spiegava ieri su Italia Oggi Antonio Calitri, alla modica cifra di 1.485 euro i parlamentari potranno contrarre una polizza di assistenza sanitaria integrativa, che nemmeno si pagheranno per intero: metà sarà a carico loro, metà la finanzieranno gentilmente le tasche della Regione.
Fin qui sembrerebbe il
solito benefit da nababbi tipico degli onorevoli siculi. E in effetti le
facilitazioni sono cospicue: rimborsi fino a 250mila euro per le prestazioni
sanitarie o addirittura 500mila euro in caso di interventi particolari. Roba che
un fesso qualsiasi come il sottoscritto se la sogna. C’è perfino la possibilità
di estendere la polizza ai familiari al costo di 1.190 euro cadauno (o 850 se
sono più di tre). Ma l’idea veramente geniale è quella di includere alla voce
«casi particolari di infortunio» anche l’ipotesi di assalto da parte degli
elettori imbestialiti. Facciamo un esempio. L’onorevole viene bersagliato da una
pioggia di euro tipo Hotel Raphael? Niente paura, è assicurato contro «tumulti,
atti violenti e aggressioni». Sappia dunque Antonio Di Pietro - il quale poco
tempo fa ha dichiarato che presto gli italiani esasperati torneranno a lanciare
monete - che così facendo si rischia di arricchire la casta. I componenti
dell’Ars non hanno tutti i torti. Con l’astio popolare che sta montando contro i
politici, bisogna pararsi le chiappe. E stare pronti alla pugna. Anche perché
l’assicurazione regionale copre pure le «lesioni sofferte per legittima difesa,
stato di necessità o dovere di solidarietà umana». Se un commando di lettori del
Fatto ti aggredisce fuori dal parlamento, tu li prendi a sberle e mentre meni ti
lesioni una mano, la Regione te la ripaga nuova, così sei pronto a pigiare di
nuovo il bottoncino della votazione in aula. Ma prendiamo che i lettori del
Fatto stiano bastonando un tuo onorevole collega, tu che fai? Fossi matto,
risponde il siculo scaltro, me la do a gambe. Invece no: puoi tranquillamente
giungere in suo soccorso munito di bastone, poiché senza ombra di dubbio sarebbe
un caso di «solidarietà umana».
Oddio, e se il deputato Turi si mangia un chilo e mezzo d’impepata di cozze e
poi si sente male, che devo fare? Le mangio anche io e a quelli della lavanda
gastrica dico che mi sono ingozzato per solidarietà umana? Beh, in effetti il
cavillo regge...
La copertura
assicurativa per gli «infortuni che si verifichino nell’esercizio delle funzioni
istituzionali», tuttavia, è ancora più estesa. I politici non sono al sicuro
solo dagli attacchi di sparuti facinorosi, ma pure dai tumulti di ampie
dimensioni. La polizza paga anche in caso di «rischio insurrezione». Casomai ai
siciliani vessati dalle inefficienze della loro amministrazione venga in mente
di organizzare nuovi Vespri o di armarsi per far piazza pulita dei governanti,
questi ultimi saranno ripagati del danno. Attenzione però, perché il cittadino è
subdolo. Egli, spinto dall’ira funesta contro il politicante sprecone, potrebbe
anche decidere di avvelenarlo mentre si reca al bar a sorbire il cappuccino.
Infatti l’atroce «avvelenamento» è coperto dall’assicurazione.
Immaginiamo che siano terribilmente crudeli questi siciliani, poiché anche
«asfissia e soffocamento» sono ripagati. Sai, in caso l’indignato di turno
assalga il deputato e tenti di strangolarlo. C’è pure un rimborso per le
«infezioni conseguenti da morsi»: nelle notti di pleniluio i siculi mannari in
piena crisi d’antipolitica s’aggirano per le strade in cerca di Lombardo, per
affondargli i denti nei garretti.
Ah, è previsto anche un rimborso in caso di «annegamento». Infatti il pericolo di affogare nel ridicolo è ai massimi livelli.
Francesco Cascio, infatti, il Presidente dell’assemblea, sta cercando, almeno a parole, di mettere un freno ai costi e nel suo discorso di insediamento ha sottolineato come ‘i giovani ci stanno a guardare, rammentiamocelo‘. Purtroppo, però, quest’opera di moralizzazione, almeno per ora, non si è concretizzata nei fatti.
Un esempio su tutti: Cascio ha provveduto all’eliminazione dei 6.400 euro che spettavano agli ex deputati per ‘l’aggiornamento politico e culturale‘. Ma, appunto, solo per gli ex deputati. Chi non è ancora andato in pensione e ha ‘assoluta necessità’ dell’imperdibile aggiornamento, potrà ancora contare su questo sostanzioso sussidio. Sussidio che va ad aggiungersi ai 18.000 euro netti di stipendio al mese e alle indennità che fioriscono per incarichi di presidenti, vicepresidenti, questori, segretari, e chi più ne ha più ne metta.
Se a questo si aggiunge che il lavoro di tutti questi deputati e incaricati non è certo massacrante, la beffa è servita. Nel 2010, infatti, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato solo 23 leggi. Nel 2009, addirittura, erano state soltanto 12. Tanti deputati per nulla. Basti pensare ad un ultimo dato. La Lombardia, che ha il doppio di abitanti della Sicilia, vanta 112 dirigenti. La Sicilia 3000. Insomma, l’opera di moralizzazione sarà molto dura.
PARLIAMO DI RIMBORSI ELETTORALI E DI STIPENDI DEI PARLAMENTARI.
Spendere un euro e incassarne quattro. Il tutto con un rischio finanziario pressochè nullo. Il sogno di ogni investitore, insomma. Per realizzarlo, però, non serve lanciarsi in spericolate operazioni finanziarie, basta fondare un partito politico e prendere almeno l’uno per cento ad una qualsiasi tornata elettorale.
Lo dimostra, in modo inequivocabile, un dettagliato referto pubblicato dalla Corte dei Conti che riassume la differenza tra le spese sostenute in campagna elettorale e i rimborsi intascati secondo quanto previsto dalla legge vigente. Qualche cifra per comprendere la portata dell’”investimento”: alle politiche 2008 il partito che ha speso di più è il Pdl che tra manifesti, volantini e spot ha sborsato oltre 68 milioni di euro. Una cifra tale da mettere in ginocchio tante aziende. Rischio, però, che la politica non corre perchè il Popolo della Libertà ha diritto a un rimborso di 206 milioni di euro.
Cifre simili anche per altre forze politiche: al Pd spettano 180 milioni di rimborso a fronte di una spesa inferiore ai 19 milioni. Meglio ancora è andata alla Lega che incassa 41 milioni dopo averne spesi 4 e all’Italia Dei Valori che chiude con un bilancio in attivo di 17 milioni.
Tutto questo in barba ad un referendum che, nel 1993 con un risultato schiacciante (85% dei favorevoli) aveva stabilito la fine del finanziamento pubblico ai partiti. Fine, però, solo formale. Le forze politiche, infatti, preso atto della volontà popolare, hanno stabilito la sostituzione del finanziamento con un “rimborso” proporzionale ai voti ottenuti. Rimborso spese, caso assolutamente unico, che prescinde dalle spese ma è un forfait stabilito a priori. Morale della favola, indipendentemente dagli esborsi, le forze politiche ogni anno si dividono circa 200 milioni, quattro euro ad elettore.
E per cadere sempre in piedi, la legge stabilisce che i rimborsi proseguono inesorabili anche in caso di conclusione anticipata della legislatura. Così l’Italia si guadagna il primato europeo di paese con i costi più alti della politica: 295 milioni l’anno contro i circa 130 della Germania, gli 80 della Spagna, i 75 della Francia e gli appena 4 della Gran Bretagna dove il finanziamento pubblico foraggia solo chi è all’opposizione.
C’è dell’altro: il “rimborso” si calcola non sui votanti ma sugli aventi diritto e la soglia di sbarramento per averne diritto non è il 4% che vale per l’ingresso al parlamento ma un misero 1%.
Grazie alla pioggia di soldi – la Corte dei Conti, tra le altre cose, definisce improprio il termine “rimborsi” - le spese dei partiti in campagna elettorale si sono gonfiate a dismisura: nel 1996 le spese complessive di campagna elettorale non raggiungevano i 20 milioni, nel 2008 hanno sfondato il tetto dei 136. Tanti? Un’inezia rispetto ai 503 milioni intascati dai partiti sotto forma di rimborsi.
Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto della Corte dei Conti sul voto dell’anno precedente, pubblicato sul proprio sito internet. I dati parlano di un guadagno pari a circa il 270% in un quinquennio. Molto interessante è il dato che riguarda l’aumento esponenziale delle spese e dei “rimborsi elettorali” degli ultimi 15 anni. I partiti nella tornata elettorale del 27-28 marzo 1994 hanno speso 36 milioni contro i 110 milioni delle politiche del 2008. Mentre per quanto riguarda i rimborsi elettorali si è assistito ad una decuplicazione passando dai 47 milioni versati ai partiti nel 1994 ai 503 milioni del 2008.
Questo è stato reso possibile dalle normative emanate dopo la schiacciante vittoria del “sì” al referendum popolare contro il finanziamento pubblico ai partiti del 1993, che vanno in “leggera” controtendenza con quanto espresso dal voto popolare. La corte ha dichiarato che “due sono state le normative che hanno fatto gonfiare il forziere statale in favore delle formazioni politiche: la legge del 2002 che ha elevato da 4 mila lire a 5 euro il contributo calcolato per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni della Camera. A questo regalo si aggiunge quello della leggina che riconosce il versamento del rimborso anche quando la legislatura si interrompe in anticipo”.
La classe politica ha, in pratica, fatto rientrare dalla finestra, ciò che i cittadini hanno fatto uscire con forza dalla porta. Infatti ha adottato la pratica dei lauti rimborsi elettorali per compensare la mancanza dei finanziamenti. Gli stessi magistrati contabili hanno dichiarato: “quello che viene normativamente definito contributo per le spese elettorali è, in realtà, un vero e proprio finanziamento”.
Dubbi sono sorti anche sulla destinazione finale dei rimborsi elettorali.
I magistrati contabili della procura generale della Corte dei Conti hanno aperto un’indagine sul «tesoro» dell’Idv e su quale soggetto abbia effettivamente richiesto e percepito i fondi elettorali destinati al partito di Antonio Di Pietro: la notizia viene confermata dalla Corte dei conti: «L’istruttoria - spiega un alto magistrato - concerne varie questioni, ma non posso dire di più». Il filone è quello aperto inizialmente dalla denuncia dei legali di Veltri e Occhetto, e seguita in prima istanza da un pool di finanzieri, che ha provveduto all’acquisizione di numerosi atti. La vicenda è nota ai lettori del Giornale, che per primo ha evidenziato le stranezze nella contabilità dell’Idv. Se venisse confermato che un’associazione di tre soli soci, Di Pietro, un familiare e un fiduciario, che si chiama «Italia dei Valori» come il partito, si è sostituito ad esso sfruttando i controlli solo formali della Camera, richiedendo e percependo in sua vece questi fondi pubblici, sarebbe un fatto senza precedenti. È la famosa (ma mai veramente chiarita) questione dell’ambiguità tra partito Italia dei Valori (quello che elegge i parlamentari) e associazione Italia dei Valori (il soggetto giuridico che incassa i soldi). Distinzione già riconosciuta dal Tribunale di Roma, che si è pronunciato in proposito nel 2008, nel quadro della causa civile che vedeva opposti l’Idv e il Cantiere, la formazione politica di Veltri, Occhetto e Chiesa, che si era presentata alle Europee 2004 in «ticket» con l’Idv. Una distinzione talmente palese, secondo il Tribunale, che «il partito Idv» venne dichiarato «contumace» al processo, essendosi presentato in sua sostituzione (come se fosse il partito) solo l’«associazione Idv», di cui Antonio Di Pietro, la moglie Susanna Mazzoleni e la fidata tesoriera Silvana Mura, costituiscono la «totalità dei soci», come si legge nella «delibera di associazione» approvata un giorno prima di incassare i rimborsi per le europee. I legali di Veltri & Co. avevano evidenziato, in quella nota, come «nella più totale assenza di qualsiasi controllo da parte dell’Ente pagatore (Montecitorio) sulle condizioni minime di legittimazione a ricevere i pagamenti dei rimborsi elettorali, essi vengono conseguiti da parte di una associazione formata da sole tre persone, che consegue tali ingenti fondi nella inesistenza per giunta di qualsiasi rendiconto».
A questo salasso bisogna aggiungere le competenze dei singoli Parlamentari. Con oltre 5 mila euro di stipendio mensile, sommati agli 8 mila euro tra spese di rappresentanza e diaria, i parlamentari che popolano le aule di Camera e Senato possono maturare retribuzioni superiori ai 20 mila euro in un solo mese, senza considerare il fitto sottobosco di benefit e agevolazioni integrative.
ENNESIMO RICORSO AL GOVERNO, INVIATO PER CONOSCENZA AI 630 DEPUTATI, AI 320 SENATORI, AI 72 PARLAMENTARI EUROPEI
RISULTATO: LETTERA MORTA
-----------
SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SIG. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DELL'INTERNO, DELLA FUNZIONE PUBBLICA, DEL LAVORO, DEI GIOVANI, DEI RAPPORTI CON LE REGIONI
E’ VERGOGNOSO, NON OTTENERE GIUSTIZIA
Giangrande Antonio, nato ad Avetrana (TA) il 02/06/1963 ed ivi residente alla via Manzoni 51.
Tel. 0999708396. Cell. 328.9163996
Presidente dell’Associazione Contro Tutte Le Mafie;
autore del libro “L’Italia del trucco, l’Italia che siamo” ;
ha svolto l’attività forense per ben 6 anni;
da 11 anni vittima di bocciature ritorsive al concorso forense, nonché perseguito per aver dato notorietà alle interrogazioni parlamentari riguardanti gli insabbiamenti delle denunce presentate nel distretto della Corte d’Appello di Lecce.
PREMESSO CHE
il 16, 17, 18 dicembre 2008 ha partecipato alla prova scritta del concorso forense presso la Corte di Appello di Lecce;
il 26 marzo 2009 la commissione presso la Corte di Appello di Reggio Calabria si è riunita per la correzione dei 3 elaborati: IN FORMA ILLEGITTIMA;
il 24 giugno 2009 (dopo 3 mesi) si sono pubblicati i risultati: giudizio identico negativo, 25, 25, 24;
il 3 luglio 2009 si visionano i compiti, i verbali e i criteri di correzione: SI OTTIENE PROVA CHE I COMPITI NON SONO STATI LETTI E CORRETTI E IL GIUDIZIO RESO E’ FALSO;
l’8 luglio 2009 si presenta istanza di ammissione al gratuito patrocinio con gli allegati probatori presso la Commissione del Tar di Lecce per poter presentare ricorso al TAR per manifesta irregolarità dei giudizi, su contestazioni accolte da ampia giurisprudenza amministrativa;
il 7 agosto (dopo un mese e a pochi giorni dalla decadenza del ricorso) si riceve diniego dalla Commissione: MANCA IL FUMUS;
il 12 agosto 2009 si presenta esposto penale ed amministrativo per fax e posta elettronica con gli allegati probatori ai vari uffici competenti di:
Presidenza della Repubblica, quale capo del CSM;
Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari uffici fax 0667793289, 0667793578, 0667795441, 0667793543, 0667796571, 0658492087, 063236210, 0647887878, 0668997064, 066795807, 066797428, 066791131, 0667795049, 066794569, 066798648, 0667796569);
Ministero della Giustizia (vari uffici fax 0668852864, 0668897418, 0668897768, 0668897394, 0668897523, 0668892770, 0668897350, 0668892671, 0666165680, 0666162817, 0668897951, 0666598265, 0668897519, 0668897538, 0668891493);
Ministero degli Interni e sottosegretario Alfredo Mantovano (vari uffici fax 0646549832, 064741717, 0646549599, 0646549815, 064814661, 0646549725, 0646549415);
Ministero della Funzione Pubblica (vari uffici fax 0668997188, 0658324118, 0668997428, 0668997060, 0668997320);
Ministero del lavoro ( vari uffici fax 064821207, 0648161441, 0659945301, 0648161558);
Ministero dei giovani (vari uffici fax 0667796679, 0667795715, 0667792516, 0667792039, 0667792041, 0667792376);
Ministero Pari opportunità fax 06 67792471;
Ministro Raffaele Fitto per i rapporti con le regioni (vari uffici fax 0667794447, 066795500, 0667794078);
Presidenti di Camera e Senato; Commissioni Giustizia di Camera e Senato; Direzione Nazionale Antimafia; Antitrust; Consiglio Superiore della Magistratura; Consiglio Nazionale Forense; Consiglio di Stato; Avvocatura dello Stato; Corte dei Conti; Procura Generale ed ordinaria di Lecce, Taranto, Bari, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria; Prefettura di Lecce e Taranto; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e Taranto.
RISULTATO: TUTTO LETTERA MORTA.
DOMANDA: E’ PIU’ SCANDALOSO L’ABUSO O L’OMISSIONE ?!?!
Tanto premesso si chiede alla S.V. di intervenire in questa vicenda, per mezzo di una interrogazione agli uffici interessati.
Le competenze amministrative ed istituzionali sono varie: impedimento alla difesa; impedimento al lavoro, specie giovanile; impedimento alla libera concorrenza ed al libero accesso professionale; impedimento alla pari opportunità; commissione di reati in procedimenti concorsuali ministeriali; impedimento all’attività di un sodalizio riconosciuto dal Ministero dell’Interno; abusi ed omissioni; ecc.
Giusto per sapere se merito giustizia e per non vergognarmi di essere italiano.
Mi dispiace che in Italia il problema non abbia l’attenzione che merita, solo perché ritengo non dignitoso adottare forme estreme di protesta. O forse perché sono sottovalutate le mie segnalazioni. Si pensi, per esempio, che per quello forense, in Italia, presso tutte le sedi di Corte di Appello, ci sono circa 40.000 candidati all’anno e solo il 30 % di loro ottiene l’abilitazione, oltretutto senza merito.
Il concorso notarile o giudiziario non è diverso.
Il far passare il sottoscritto per mitomane o pazzo, condannandolo all’indigenza, non disobbliga l’autorità adita ad un doveroso riscontro. Sempre che si sia in un paese civile e giuridicamente avanzato.
Dr Antonio Giangrande
RICORSO ALLE ISTITUZIONI CONTRO GLI INSABBIAMENTI
Egregio sig. Presidente della Repubblica,
egregi sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro della Giustizia,
a Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti Umani ha aperto un procedimento, n. 11850/07, GIANGRANDE contro ITALIA, per l’insabbiamento di 15.520 (quindicimilacinquecentoventi) denunce penali e ricorsi amministrativi.
La maggior parte di questi insabbiamenti è avvenuta presso le Procure della Repubblica di tutta Italia.
L’istante, sottoscritto dr Antonio Giangrande, è presidente della "Associazione contro tutte le Mafie", ONLUS, iscritta presso la Prefettura di Taranto nell’elenco delle associazioni antiracket ed antiusura, inserita nel Comitato Provinciale di Solidarietà per le vittime dell’usura e del racket, partecipante al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tenuta in debita considerazione dalle più alte Istituzioni nazionali ed europee, così come da centinaia di cittadini italiani, che ad essa si rivolgono.
Si rileva, non solo l’immenso numero di procedimenti fondati e provati, a cui nulla è conseguito, pur con obbligo di legge, ma, addirittura, spesso e volentieri, colui il quale si era investito della competenza a decidere sulla denuncia penale, era lo stesso soggetto ivi denunciato o esposto. Da qui scaturiva naturale richiesta di archiviazione, prontamente accolta, ancorché non comunicata per impedirne l’opposizione.
Ogni tentativo di coinvolgere le istituzioni italiane preposte ha conseguito ulteriore insabbiamento.
L’ufficio per gli affari giuridici della Presidenza della Repubblica, 197/06, il 28/06/2006, pur essendo il Presidente della Repubblica anche presidente del CSM, comunica che ha richiesto notizie al CSM. Da allora tutto lettera morta.
Il CSM, organo di controllo dei Magistrati, più volte interpellato, comunica che non può censurare i comportamenti dei magistrati, lasciando questi, di fatto, liberi di adottare i comportamenti ritenuti, dai loro interessi, più opportuni, senza timore di istanze di censure o di atti impugnativi, il cui esito si palesa scontato.
Il Gabinetto del Ministero della Giustizia, 201/4244, il 25/01/2006, riferisce che è ancora in corso l’ordinaria istruttoria per gli esposti precedenti. Da allora sembra che, da anni, l’istruttoria sia ancora aperta, senza soluzione di continuità.
Tutti i Parlamentari, interpellati, hanno pensato bene di dare nessun riscontro, meritando la nomea di essere lontani dagli interessi e dalle aspettative del cittadino.
Tutto ciò è allucinante se si rapporta il numero degli insabbiamenti su indicato a quello dei professionisti esercenti, delegati dai cittadini alla tutela dei diritti, ed alla consistenza delle innumerevoli problematiche sociali, che pur sottaciute ed impunite, sono ben esistenti.
In conclusione chiedo a voi:
cosa c’è di onorevole per le Istituzioni Italiane nell’insabbiare ogni tentativo di tutela dei diritti del cittadino, sol perché lede gli interessi dei poteri forti ?!
cosa c’è di lodevole per le Istituzioni Italiane nell’impedire in tutti i modi al sottoscritto di continuare nella sua opera in difesa degli indifesi, nello screditarlo nella sua reputazione e nel condannarlo alla disoccupazione e all’indigenza con tutta la sua famiglia, fino ad impedirgli da 9 anni l’esercizio della professione forense, ed ogni altra occupazione, e la fruizione associativa ONLUS del 5 x 1000, pur avendone tutti i requisiti. La regolare istanza di iscrizione all’elenco dei fruitori ONLUS è avvenuta con prot. 07032440283602153.
Con ossequi
Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”
RICORSO MINISTERIALE CONTRO GLI INSABBIAMENTI
Illustre Presidente del Consiglio dei Ministri,
Illustre Ministro della Giustizia,
tenga conto che
il Dott. Antonio Giangrande, da Presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte Le Mafie, iscritta presso la Prefettura di Taranto, con sede in Avetrana (TA), alla via Piave, 127, e da Presidente di Taranto dell’Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati, dal 10 aprile 2001 ad oggi, ha interpellato il Ministero della Giustizia per ben 29 volte, chiedendo la verifica dell’operato degli Uffici Giudiziari di Taranto, Potenza e Bari circa gli insabbiamenti delle denunce presentate.
Per posta: il 10/04/2001, il 23/04/2002, il 27/05/2002, il 26/09/2003, il 22/04/2004.
Per fax: il 26/09/2002, il 23/10/2002, il 09/02/2003, il 28/07/2003, il 06/11/2003, il 22/01/2004, il 05/04/2004, il 04/06/2004, il 31/07/2004, il 02/08/2004, il 15/01/2005, il 4-8/02/2005, il 11/02/2005, il 16/05/2005, il 09/01/2006, il 01/02/2006, il 18/05/2006, il 15/06/2006, il 22/06/2006, il 10/08/2006; il 07/09/2006.
Per E-mail il 23/10/2002, il 31/01/2005, il 23/08/2005, il 18/05/2006.
Altresì, tenga conto che
il Dott. Antonio Giangrande, Presidente Nazionale dell’Associazione Contro Tutte Le Mafie, iscritta presso la Prefettura di Taranto, con sede in Avetrana (TA), alla via Piave, 127, dal 2 agosto 2004 ad oggi, ha interpellato il Ministero della Funzione Pubblica per ben 8 volte, chiedendo la verifica dell’operato degli Uffici Ministeriali interpellati circa gli insabbiamenti dei ricorsi presentati.
Per posta: il 24/02/2005.
Per fax: il 02/08/2004, il 24/02/2005, il 16/05/2005.
Per E-mail il 09/08/2004, il 24/02/2005, il 23/08/2005, il 18/05/2006.
Consideri che
il Presidente della Repubblica, U.G. 551/2003 prot. SGPR 25/02/2003 0022081 P, UAG 197/2006 prot. SGPR 28/06/2006 0075602 P, più volte ha investito del problema il Consiglio Superiore della Magistratura, a cui è conseguito un naturale insabbiamento.
Altresì consideri che
in risposta alla interrogazione parlamentare presentata al suddetto Dicastero dal Senatore Eupreprio Curto di Alleanza Nazionale, membro della Commissione Antimafia e Giustizia, si accusavano infondate le lamentele del Dr. Antonio Giangrande circa gli insabbiamenti attuati dalle Procure dei Distretti di Corte d’Appello di Bari, Lecce e Potenza, per una sola archiviazione pretestuosa adottata dai magistrati di Potenza nei confronti dei loro colleghi Tarantini, senza aver tenuto conto dei tanti procedimenti penali a carico delle suddette Procure, debitamente provati, i quali non sono stati, ancora, archiviati.
Pensi che
il precedente Sottosegretario alla Giustizia On. Luigi Vitali, anziché rispondere al Dr. Antonio Giangrande come la legge gli impone, ha diffidato pubblicamente il medesimo di continuare ad alluvionare il suddetto parlamentare con le segnalazioni di malagiustizia.
Contempli che
ben oltre 15.000 esposti penali sono stati insabbiati dalle preposte autorità italiane, senza che sia conseguita l’obbligatoria azione penale, o l’obbligato perseguimento per calunnia, ovvero l’accusa di mitomania, nei confronti del Dr. Antonio Giangrande ed altri denuncianti, nonostante che alcuni esposti contenessero l’accusa di associazione mafiosa per avvocati e magistrati.
Accerti che
nel combattere le omissioni e gli abusi a favore di chi all’Associazione si rivolge, il Dr Antonio Giangrande ha ricevuto come unico risultato ritorsivo mafioso la condanna all’indigenza, per impedimento all’accesso alla professione forense, essendo stato bocciato per 9 volte all’esame truccato svolto a Lecce, e la persecuzione per reati inesistenti. A questo si aggiunge la risposta del suo capo di gabinetto che, in data 25/01/2006, prot. 201/4244 (G), gli dice di attendere l’esito istruttorio dei procedimenti ministeriali attivati molti anni prima, tenuto conto dei tempi biblici burocratici attuati da chi è comodo con il suo stipendio, al contrario di chi è disgustato da questo sistema e che è stufo di questa vita.
Premesso ciò le chiedo di notiziarmi su che fine hanno fatto gli esposti presentati dal Dr. Antonio Giangrande, considerato che per l’istruttoria attivata da tempi lontani non si è ancora addivenuti ad assumere gli importanti e fondamentali atti probatori. Tenga conto che il Dr. Antonio Giangrande ormai ha 44 anni, è indigente e combatte da 10 anni da solo una battaglia di giustizia, provata e circostanziata, a riprova che non è tanto incapace a ricoprire il ruolo di avvocato che gli spetta, ma al contrario è scomodo per giudici ed avvocati per la tutela dei diritti dei più deboli.
La saluto con rispetto.
Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”
DENUNCIA PENALE AL CSM CONTRO GLI INSABBIAMENTI
AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
QUALE COMPONENTE IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
QUALE PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM
( L. 24 marzo 1958 n. 195 )
--------
ESPOSTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
INFORMATIVA DI REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO
DENUNCIA PENALE
( L. 241/90; art.20, DPR 3/57; art.330, 331, 333 c.p.p. )
PRESENTATO DA
GIANGRANDE ANTONIO, DENUNCIANTE,
nato ad Avetrana (TA) il 02/06/63 ed ivi residente alla via Manzoni, 51, tel.0999708396, cell. 3289163996, Presidente della “Associazione contro tutte le Mafie”, con sede in Avetrana (TA), via Piave, 127,
CONTRO
IL COMITATO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,
che ha ricevuto ed insabbiato gli esposti dettagliatamente indicati in elenco allegato.
CONSTATATO CHE
il denunciante ha presentato regolari denuncie e querele penali, aventi valore di informative di reato perseguibili d’ufficio, quando erano mancanti delle formalità richieste. Atti presentati a mano, per fax e per e-mail, presso le competenti autorità giudiziarie, le quali le hanno acquisite ai sensi degli artt. 330, 331, 333, 336, c.p.p., senza che sia conseguita azione penale, ex art. 50 c.p.p., ovvero senza che sia stata comunicata, così come richiesto, la proroga delle indagini, ex art. 406 c.p.p., o la richiesta di archiviazione, ex art. 408 c.p.p., per poter presentare opposizione, ovvero, quando c’è stata richiesta di archiviazione, essa è stata presentata al G.U.P. senza aver svolto le doverose indagini, nonostante le voluminose prove e i denunciati erano palesemente indicati, o facilmente identificabili.
ACCERTATO CHE
il denunciante ha presentato regolari ricorsi amministrativi con informativa di reato alle autorità amministrative competenti, le quali le hanno acquisite ai sensi della L.241/90, senza che sia conseguita, in virtù della stessa legge, alcuna comunicazione sull’iter, sul suo responsabile e sull’esito motivato del procedimento, ovvero non è stata presentata da questi l’obbligata denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p..
APPURATO CHE
il denunciante non è stato mai chiamato a rendere testimonianza o a rendere documentazione, ovvero non è stato mai accusato di mitomania, pazzia o calunnia, ovvero gli è stata inibita l’opposizione alla richiesta di archiviazione, ex art. 410 c.p.p., per mancanza di oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, bastando e avanzando già quelli prodotti.
ASSODATO CHE
è pretestuoso chiedere conto delle denuncie presentate.
Le indagini da svolgere sono semplici perché le accuse sono chiare.
Basterebbe verificare sui terminali di accesso al registro generale delle notizie di reato dell’autorità giudiziaria adita, ovvero presso gli uffici protocollo dell’autorità amministrativa adita, se le denuncie e i ricorsi presentati sono stati iscritti e quale è stato l’esito degli stessi, e, se ci fosse stata richiesta di archiviazione o proroga delle indagini, basterebbe verificare se vi sia stata l’obbligata comunicazione richiesta.
Se, a seguito delle presentazione, l’iscrizione del ricorso amministrativo o della notizia di reato non vi è stata, o non vi è stata azione penale, o vi è stato impedimento all’opposizione avversa alla richiesta di archiviazione, si palesano gravi reati, basta avere la volontà di perseguirli, senza scrupoli corporativi. Invece, se le denuncie non sono state mai presentate, vi è il reato di calunnia da me commesso, con l’obbligo di essere perseguito.
STABILITO CHE
Con la presente non si chiede l’approfondimento dell’oggetto delle denuncie, anche se doveroso, ma, semplicemente, si chiede: queste che fine hanno fatto e perché non si è proceduto ?
Il vagliare le denuncie presentate come generiche, o infondate per mancanza di prove, o perché trattasi di reato impossibile, o non procedibili per autore ignoto, è offensivo, specie se si è ritenuto opportuno non approfondire i fatti segnalati, sentendo il denunciate, ed è oltraggioso alla dignità di quei numerosi Magistrati, che per i medesimi fatti hanno ritenuto fondate e provate le identiche denuncie presentate dal denunciante nel loro territorio e hanno ritenuto noti i responsabili di quei reati, che altrimenti resterebbero impuniti per la qualità dei loro autori.
Lo stimare le denuncie presentate come nulle per mancanza di formalità, è uno schiaffo all’ordinamento giuridico italiano, che ritiene le denuncie informali come una informativa di reato perseguibile d’ufficio, ex art. 330, 331, c.p.p..
Il ritenere le denuncie presentate come irricevibili per incompetenza territoriale è irriguardoso nei confronti di altri distretti di Corte d’Appello, come se certi reati non si potessero commettere nel territorio dell’autorità adita, pur avendo carattere nazionale i fatti segnalati nelle denuncie. Inoltre, in questo modo, si omette di procedere, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., nei confronti di Magistrati operanti del distretto della Corte d’Appello limitrofa.
Il ritenere i ricorsi amministrativi con informativa di reato come irricevibili per incompetenza funzionale è irrispettoso delle norme, come se, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e art.20, DPR 3/57, il pubblico ufficiale e l’esercente un pubblico servizio non avessero l’obbligo di denuncia.
Oltremodo, il considerare le denuncie presentate come strumentali, atte a giustificare l’incapacità del denunciante a passare l’esame di avvocato, che, secondo qualche magistrato, si sentirebbe vittima di fantomatici “complotti nazionali”, è oltraggioso nei confronti dell’ 80 % circa dei candidati italiani, ritenuti ingiustamente “non idonei” al concorso forense, ritenuto da tutti truccato e impunito, fin anche dalle Istituzioni. Certamente, quel magistrato, in mala fede, non prenderà mai in considerazione l’esistenza di ritorsioni dei poteri forti contro colui il quale combatte da solo e con coraggio gli abusi e le omissioni commessi dalle medesime lobby.
Inoltre, il valutare le denuncie presentate come univoche, è vergognoso, se si pensa che ogni denuncia ha un fatto penalmente rilevante diverso uno dall’altro, trattandosi di reati attinenti non solo i concorsi truccati, ma, anche, evasione fiscale e contributiva, ovvero abusi ed omissioni nell’esercizio del loro dovere di alcuni Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Medici, Dirigenti amministrativi, Imprenditori. Così come risulta dalla relazione esplicativa, qui acclusa.
Infine, è legittimo pretendere sapere che fine fanno le denuncie che si presentano.
SI E’ PRESO ATTO CHE
IL COMITATO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, PIU’ VOLTE INFORMATO DELLA SISTEMATICA OPERA DI INSABBIAMENTO ATTUATO DA ALCUNI MAGISTRATI, E IN PARTICOLARE DA QUELLI DI TARANTO, POTENZA E BARI, HA PENSATO BENE DI CONTINUARE SU QUESTA STRADA: ARCHIVIANDO PRETESTUOSAMENTE SENZA INDAGINI, O TACENDO SUGLI ESPOSTI PRESENTATI, QUI IN ELENCO ALLEGATO.
TANTO PREMESSO IL DENUNCIANTE CHIEDE ALLA S.V.
la unanime e certa condanna dei responsabili indicati, per violazione degli artt.414, 415, 416, 416 bis, 378, 323, 328, 476, 479, 61 n.2 e 9, 81, c.p. o di altre norme penali, e attivazione d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme amministrative, in quanto i denunciati hanno dolosamente insabbiato le denuncie riguardanti reati commessi da Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Dirigenti amministrativi, Medici, Imprenditori.
----------
Il denunciante con tale atto presenta denuncia penale contro i soggetti identificati e identificabili, da soli, o in correità con persone non conosciute, per gli atti e i fatti indicati e per i reati applicabili, con istanza di punizione, con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale. Inoltre si chiede, come persona offesa dal reato, che gli venga comunicato ogni atto di cui ha diritto di essere avvisato e in particolare modo quanto previsto dagli artt. 406 comma 3 c.p.p. (proroga del termine delle indagini preliminari) e 408 comma 2 c.p.p. (richiesta di archiviazione). Si oppone formale opposizione, ex art.459 c.p.p., alla richiesta dell’emissione del decreto penale di condanna.
Allegati: 1 pagina di elenco di esposti insabbiati;
1 riscontro C.S.M..
AI FINI PROBATORI, DATA LA GRAVITA’ DELLE ACCUSE, SI E’ DISPONIBILI A CONSEGNARE ALLE AUTORITA’ DELEGATE OGNI DOCUMENTO UTILE ALLE INDAGINI.
Con ossequi
Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”
ESPOSTO ALLE ISTITUZIONI CONTRO GLI INSABBIAMENTI
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL PRESIDENTE E ALLE SEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
AL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
AI PRESIDENTI DI OGNI CORTE D'APPELLO D'ITALIA
AI PROCURATORI GENERALI PRESSO OGNI CORTE D’APPELLO D'ITALIA
AL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA
AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D’ASSISE DI OGNI DISTRETTO ITALIANO
AI PROCURATORI CAPO PRESSO I TRIBUNALI DI OGNI DISTRETTO ITALIANO
AI PRESIDENTI E AI PROCURATORI DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO E DELLE SEZIONI REGIONALI
AI PREFETTI DI OGNI PROVINCIA D'ITALIA
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI OGNI CONSIGLIO PROVINCIALE D'ITALIA
AI DIFENSORI CIVICI REGIONALI E PROVINCIALI D'ITALIA
----------
RICHIESTA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI
( art. 412 c.p.p. )
DENUNCIA PENALE - INFORMATIVA DI REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO
( art. 330, 331, 333 c.p.p. )
ESPOSTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE - INFORMATIVA DI REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO
( art.20, DPR 3/57; art.330, 331 c.p.p. )
PRESENTATA DA
GIANGRANDE ANTONIO, DENUNCIANTE,
nato ad Avetrana (TA) il 02/06/63 ed ivi residente alla via Manzoni, 51, tel.0999708396, cell. 3289163996, Presidente della “Associazione contro tutte le Mafie”, con sede in Avetrana (TA), via Piave, 127,
CONTRO
LE AUTORITA’ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE ADITE CONOSCIBILI,
indicate nell’elenco delle denuncie e dei ricorsi insabbiati. Autorità facilmente identificabili, dato il loro grado di notorietà e di qualità pubblica rivestita.
Dettagliato elenco, qui accluso, rendicontato delle denuncie e dei ricorsi, rimasti lettera morta.
CONSTATATO CHE
il denunciante ha presentato regolari denuncie e querele penali, aventi valore di informative di reato perseguibili d’ufficio, quando erano mancanti delle formalità richieste. Atti presentati a mano, per fax e per e-mail, presso le competenti autorità giudiziarie, le quali le hanno acquisite ai sensi degli artt. 330, 331, 333, 336, c.p.p., senza che sia conseguita azione penale, ex art. 50 c.p.p., ovvero senza che sia stata comunicata, così come richiesto, la proroga delle indagini, ex art. 406 c.p.p., o la richiesta di archiviazione, ex art. 408 c.p.p., per poter presentare opposizione, ovvero, quando c’è stata richiesta di archiviazione, essa è stata presentata al G.U.P. senza aver svolto le doverose indagini, nonostante le voluminose prove e i denunciati erano palesemente indicati, o facilmente identificabili.
ACCERTATO CHE
il denunciante ha presentato regolari ricorsi amministrativi con informativa di reato alle autorità amministrative competenti, le quali le hanno acquisite ai sensi della L.241/90, senza che sia conseguita, in virtù della stessa legge, alcuna comunicazione sull’iter, sul suo responsabile e sull’esito motivato del procedimento, ovvero non è stata presentata da questi l’obbligata denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p..
APPURATO CHE
il denunciante non è stato mai chiamato a rendere testimonianza o a rendere documentazione, ovvero non è stato mai accusato di mitomania, pazzia o calunnia, ovvero gli è stata inibita l’opposizione alla richiesta di archiviazione, ex art. 410 c.p.p., per mancanza di oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, bastando e avanzando già quelli prodotti.
ASSODATO CHE
è pretestuoso chiedere conto delle denuncie presentate.
Le indagini da svolgere sono semplici perché le accuse sono chiare.
Basterebbe verificare sui terminali di accesso al registro generale delle notizie di reato dell’autorità giudiziaria adita, ovvero presso gli uffici protocollo dell’autorità amministrativa adita, se le denuncie e i ricorsi presentati sono stati iscritti e quale è stato l’esito degli stessi, e, se ci fosse stata richiesta di archiviazione o proroga delle indagini, basterebbe verificare se vi sia stata l’obbligata comunicazione richiesta.
Se, a seguito della presentazione, l’iscrizione del ricorso amministrativo o della notizia di reato non vi è stata, o non vi è stata azione penale, o vi è stato impedimento all’opposizione avversa alla richiesta di archiviazione, si palesano gravi reati, basta avere la volontà di perseguirli, senza scrupoli corporativi. Invece, se le denuncie non sono state mai presentate, vi è il reato di calunnia da me commesso, con l’obbligo di essere perseguito.
STABILITO CHE
Con la presente non si chiede l’approfondimento dell’oggetto delle denuncie, anche se doveroso, ma, semplicemente, si chiede: queste che fine hanno fatto e perché non si è proceduto ?
Il vagliare le denuncie presentate come generiche, o infondate per mancanza di prove, o perché trattasi di reato impossibile, o non procedibili per autore ignoto, è offensivo, specie se si è ritenuto opportuno non approfondire i fatti segnalati, sentendo il denunciate, ed è oltraggioso alla dignità di quei numerosi Magistrati, che per i medesimi fatti hanno ritenuto fondate e provate le identiche denuncie presentate dal denunciante nel loro territorio e hanno ritenuto noti i responsabili di quei reati, che altrimenti resterebbero impuniti per la qualità dei loro autori.
Lo stimare le denuncie presentate come nulle per mancanza di formalità, è uno schiaffo all’ordinamento giuridico italiano, che ritiene le denuncie informali come una informativa di reato perseguibile d’ufficio, ex art. 330, 331, c.p.p..
Il ritenere le denuncie presentate come irricevibili per incompetenza territoriale è irriguardoso nei confronti di altri distretti di Corte d’Appello, come se certi reati non si potessero commettere nel territorio dell’autorità adita, pur avendo carattere nazionale i fatti segnalati nelle denuncie. Inoltre, in questo modo, si omette di procedere, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., nei confronti di Magistrati operanti del distretto della Corte d’Appello limitrofa.
Il ritenere i ricorsi amministrativi con informativa di reato come irricevibili per incompetenza funzionale è irrispettoso delle norme, come se, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e art.20, DPR 3/57, il pubblico ufficiale e l’esercente un pubblico servizio non avessero l’obbligo di denuncia.
Oltremodo, il considerare le denuncie presentate come strumentali, atte a giustificare l’incapacità del denunciante a passare l’esame di avvocato, che, secondo qualche magistrato, si sentirebbe vittima di fantomatici “complotti nazionali”, è oltraggioso nei confronti dell’ 80 % circa dei candidati italiani, ritenuti ingiustamente “non idonei” al concorso forense, ritenuto da tutti truccato e impunito, fin anche dalle Istituzioni. Certamente, quel magistrato, in mala fede, non prenderà mai in considerazione l’esistenza di ritorsioni dei poteri forti contro colui il quale combatte da solo e con coraggio gli abusi e le omissioni commessi dalle medesime lobby.
Inoltre, il valutare le denuncie presentate come univoche, è vergognoso, se si pensa che ogni denuncia ha un fatto penalmente rilevante diverso uno dall’altro, trattandosi di reati attinenti non solo i concorsi truccati, ma, anche, evasione fiscale e contributiva, ovvero abusi ed omissioni nell’esercizio del loro dovere di alcuni Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Medici, Dirigenti amministrativi, Imprenditori. Così come risulta dalla relazione esplicativa, qui acclusa.
Infine, è legittimo pretendere sapere che fine fanno le denuncie che si presentano.
TANTO PREMESSO IL DENUNCIANTE CHIEDE ALLA S.V.
la unanime e certa condanna dei responsabili indicati, per violazione degli artt.414, 415, 416, 416 bis, 378, 323, 328, 476, 479, 61 n.2 e 9, 81, c.p. o di altre norme penali, e attivazione d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme amministrative, in quanto i denunciati hanno dolosamente insabbiato le denuncie riguardanti reati commessi da Magistrati, Avvocati, Professori universitari, Dirigenti amministrativi, Medici, Imprenditori.
----------
Il denunciante con tale atto presenta denuncia penale contro i soggetti identificati e identificabili, da soli, o in correità con persone non conosciute, per gli atti e i fatti indicati e per i reati applicabili, con istanza di punizione, con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale. Inoltre si chiede, come persona offesa dal reato, che gli venga comunicato ogni atto di cui ha diritto di essere avvisato e in particolare modo quanto previsto dagli artt. 406 comma 3 c.p.p. (proroga del termine delle indagini preliminari) e 408 comma 2 c.p.p. (richiesta di archiviazione). Si oppone formale opposizione, ex art.459 c.p.p., alla richiesta dell’emissione del decreto penale di condanna.
Allegati: 10 pagine di elenco dettagliato delle denuncie presentate;
4 pagine di relazione esplicativa.
Con ossequi
Dr Antonio Giangrande Presidente “Associazione contro tutte le Mafie”