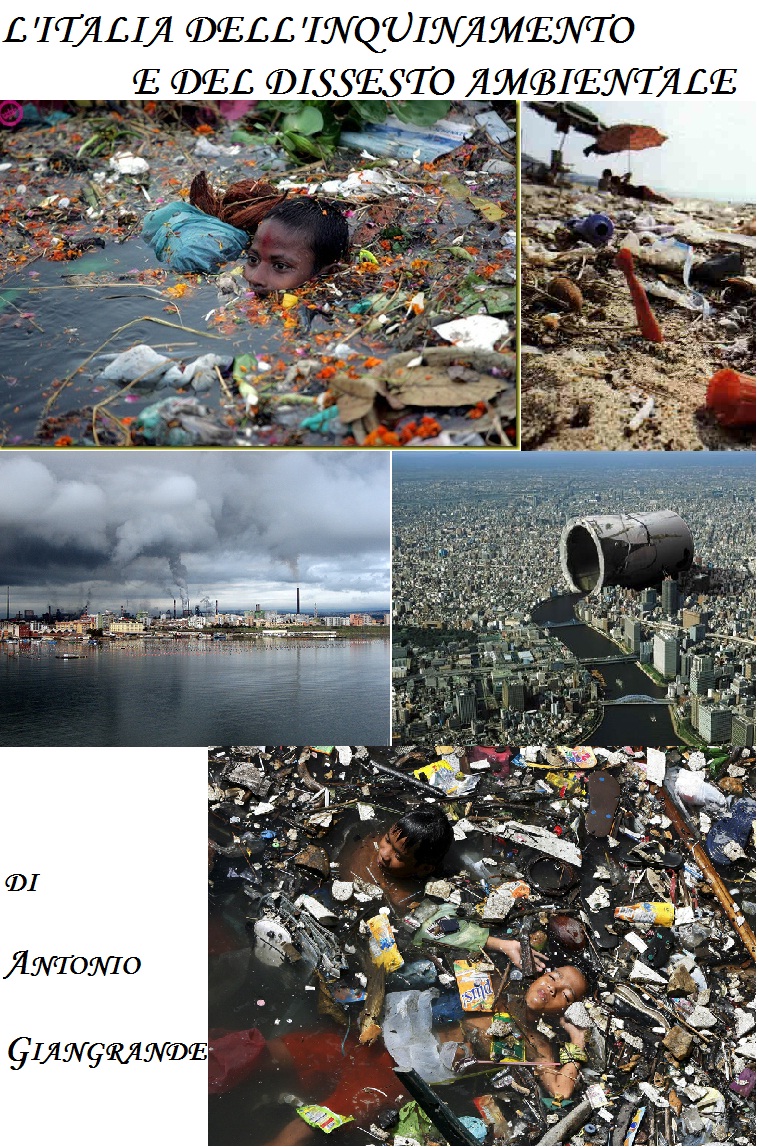Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
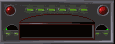
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
AMBIENTOPOLI
DI ANTONIO GIANGRANDE
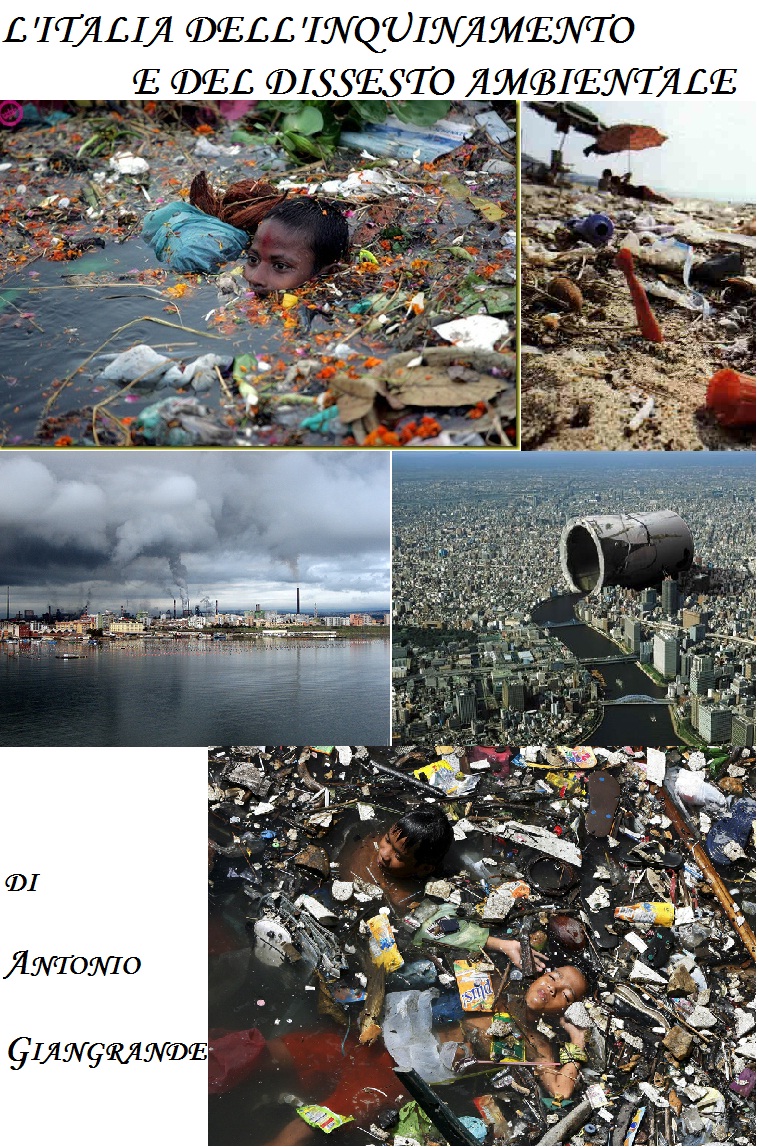
L’ITALIA DELL’INQUINAMENTO
E DEL DISSESTO
OSSIA, SOPRAVVIVERE
“Ognuno pensa che le
disgrazie colpiscano solo gli altri, senza tener conto che gli altri siamo anche
noi. Solo allora ci accorgiamo quanto il sistema non funzioni. Ma le istituzioni
colluse, i media omertosi e i cittadini codardi fanno sì che nulla cambi. Chi
inquina paghi, anche per il patema d'animo".
Di Antonio Giangrande
AMBIENTOPOLI
Ambiente ed ambientalismo ed ecologismo.
Distinzione sui termini dietro cui si nascondono ideologie e fondamentalismi,
bugie ed odio contro l'uomo.
SOMMARIO
INTRODUZIONE.
TASSA AMBIENTALISTA. COME PRENDERLA
NEL…SACCHETTO.
"PADRI DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA
NOSTRA ROVINA.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
PARLIAMO DI TERREMOTI.
PARLIAMO DI RIFIUTI.
GIORNALISMO A LIBRO PAGA DEGLI INQUINATORI.
FOTOVOLTAICO VS FOSSILE: QUALE ENERGIA PER IL
FUTURO?
LA BUFALA DELL’INQUINAMENTO.
RISCALDAMENTO GLOBALE PER MANO DELL’UOMO? LA
PIU’ GRANDE MENZOGNA.
LE PALE EOLICHE. IL
PROGRESSO IDEOLOGICO E LA DISTRUZIONE DI UNA CIVILTA’. L’ISIS COME LA SINISTRA.
E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.
L’ITALIA, IL PAESE DEI NO. LA SINDROME DI NIMBY.
IL SUD TARTASSATO.
ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO
PARLARE CLAUDIO BISIO.
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO UCCIDE, MA SI MUORE
ANCHE DI RUMORE…
CHI INQUINA, NON PAGA.
LA NATURA NON E' AMBIENTALISTA.
LA BEFFA DEI SOLDI NON SPESI PER I DEPURATORI.
AREA MARINA PROTETTA. A MANDURIA QUALCOSA NON
VA……
DEPURATORI. COME CI PRENDONO PER IL CULO.
DEPURATORI DELLE ACQUE E POLEMICHE STRUMENTALI.
UN PROBLEMA NAZIONALE, NON LOCALE.
CONTRO IL DEPURATORE CONSORTILE SAVA-MANDURIA
AD AVETRANA E SCARICO A MARE. LOTTA UNITARIA O FUMO NEGLI OCCHI?
AMIANTO. IL KILLER CONOSCIUTO.
LADROCINIO AL MINISTERO DELL’AMBIENTE?
LA GRANDE BUFALA: LA GREEN ECONOMY.
CHI HA PAURA DELLE
NUOVE TECNOLOGIE: HYST ED OGM?
ILARIA ALPI,
NATALE DE GRAZIA E LE NAVI DEI VELENI.
TARANTO E VADO LIGURE. C’E’ INQUINAMENTO ED
INQUINAMENTO. E’ SALUBRE SE E’ DI SINISTRA.
DEPURATORI E SCARICO IN MARE DELLE ACQUE
REFLUE. A PROPOSITO DEL DEPURATORE CONSORTILE DI SPECCHIARICA.
I NOSTRI VELENI QUOTIDIANI.
GLI SCANDALI CHE HANNO SPAVENTATO L'ITALIA.
OGGETTI PERICOLOSI INTORNO A NOI.
ANTIBUFALA: LA BARRA COLORATA SUI DENTIFRICI.
ILVA, LE VERITA' NASCOSTE DELL'INCHIESTA.
LA LOTTA CON GLI IDOLI DELLA PIAZZA.
ILVA. TARANTO. TUTTI DENTRO.
TARANTO. CASO ILVA. TUTTI DENTRO. FLORIDO E GLI
ALTRI.
ILVA. SEQUESTRO RECORD. AI MAGISTRATI SEMPRE
L’ULTIMA PAROLA CON IL PARADOSSO DI FAVORIRE I RIVA.
LA TARANTO DEI TALEBANI E LA CADUTA DEGLI DEI.
CHI INQUINA PAGA?
L'AMBIENTALISMO E L'ECOLOGISMO DEI LUOGHI
COMUNI.
CONTRO L'AMBIENTALISMO DEL SEMPRE NO!
AUTO ELETTRICHE: LA MENZOGNA DELL’EMISSIONE
ZERO.
ENERGIA PULITA? SPORCO AFFARE.
CULTO E PARADOSSI DEL SALUTISMO.
I TALEBANI DEL SALUTISMO.
LE BUGIE DEGLI AMBIENTALISTI.
PORTA IL NIPOTE IN CAMPAGNA: MULTATO!!!
PARLIAMO DEI POZZI ABUSIVI.
PARLIAMO DELLA CACCIA. DOPPIETTA ASSASSINA.
PARLIAMO DI SCIENZIATI CON LA TOGA.
TERREMOTO DELL’AQUILA: CONDANNATI I MEMBRI
DELLA “COMMISSIONE GRANDI RISCHI”.
INQUINAMENTO AMBIENTALE: NON SOLO ILVA. C’E’
PIOMBO PURE NEL BIBERON.
CHI INQUINA PAGA? DIPENDE!
PARLIAMO DELL’ITALIA DEI VELENI: MORIRE DI FAME
O DI INQUINAMENTO?
ECOLOGISMO ED AMBIENTALISMO: LA TRUFFA IN DANNO
DELL’UMANITA’.
ECOLOGIA, AMBIENTE E MEDIA: LOTTA DI PARTE E DI
FACCIATA.
LE BUGIE DEGLI AMBIENTALISTI.
PARLIAMO DELL’ITALIA DEI VELENI.
PARLIAMO DI DISASTRI AMBIENTALI.
LA TRUFFA DEL FOTOVOLTAICO.
PARLIAMO DI ENERGIA ALTERNATIVA.
PARLIAMO DI INQUINAMENTO DI STATO.
PARLIAMO DI TUTELA DEI DIRITTI.
PARLIAMO DI DISASTRI IDROGEOLOGICI.
ECOMAFIE.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO.
INQUINAMENTO DELLE ACQUE.
IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN ITALIA.
INQUINAMENTO AMBIENTALE.
INQUINAMENTO ACUSTICO.
INCENDIOPOLI IN ITALIA.
CHI TUTELA LA SALUTE DEI CITTADINI ???
RACCOLTA DIFFERENZIATA: SI PARLA BENE, SI
RAZZOLA MALE.
EMERGENZA RIFIUTI.
CHI COMBATTE L'ABUSIVISMO EDILIZIO ???
CASE ABUSIVE E CONDONI EDILIZI.
XILELLA FASTIDIOSA: RESPONSABILITA' DI STATO.
NO TAP. VIOLENZA ED IPOCRISIA.
NO TAP E PROTESTA CONTRO IL DEPURATORE
CONSORTILE MANDURIA-SAVA AD AVETRANA. NON SONO FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA.
INTRODUZIONE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso.
Se si è omologati (uguali) o conformati
(simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita,
perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla
rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un
Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco
tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai
primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo.
Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si sentono alti anche i nani e dove anche
i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe
indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.
Il difetto degli intelligenti è che sono spinti
a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno
dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte.
Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato
ed amministrato da “coglioni”.
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio
di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a
spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola
gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra
dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo
facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo
facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione
di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica.
Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze
staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad
ascoltarci.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo
senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Da sempre diffido di chi, vestito da lupo, è
pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti giustizialisti dei 5 stelle che
provino a proporre la figura del difensore civico giudiziario con poteri di
magistrato, senza essere uno di loro, per poter metter le mani nelle carte dei
fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi batto inascoltato per questo. I
signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di rispondere ai messaggi degli
esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son bravi, ma a proporre leggi
sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà,
certificata dai loro magistrati, e mai parlano di libertà ed opportunità senza
concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione umana nefasta si trova sempre una
giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli animali...lo si fa
per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta che fa male al
prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito preso, noi siamo
tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli permettiamo di farle.
Parlare nei miei libri del caso singolo del
semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di mitomania, pazzia o
calunnia, oltre che ne disinteresse. Invece parlo di loro, delle istituzioni che
delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso dire di più di quello
che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto divulgato possa essere
di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere altro che quella in
questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di loro stessi e se ne
fottono degli altri.
TASSA AMBIENTALISTA. COME PRENDERLA
NEL…SACCHETTO.
Buste di plastica: chi le ammette e chi
le tassa ma lo stop trionfa. Due modi per impedire
l'impiego di uno strumento che ha contribuito a danneggiare l'ecosistema,
scriveva già Boris Bivona il 15 febbraio 2011 su "Fiscooggi". La prima al mondo
a vietare l'uso dei sacchetti di plastica è stata nel 2000 l'India a Mumbai. Due
anni dopo a proibire l'impiego è stato il Bangladesh nella sua capitale, Dhaka.
La decisione è stata adottata a seguito delle piogge monsoniche dopo che gli
shoppers hanno causato numerosi intralci al sistema di drenaggio. L'intervento
ha peraltro favorito la produzione locale di sacchi di iuta. Nel 2003 l'uso dei
sacchetti di plastica è stato vietato dal Sud Africa e da Taiwan mentre nel 2005
sono state introdotte normative per limitarne l'uso in Eritrea, Ruanda e
Somalia. Nel 2006, la Tanzania e nel 2007 il Kenya e l'Uganda hanno sancito il
divieto totale di uso.
L'Italia e il divieto di commercializzazione. Dal
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il divieto di commercializzazione dei
sacchetti di plastica. Nel decreto legge n. 225 del 2010 (cosiddetto
Milleproroghe) non sono stati previsti ulteriori differimenti dei termini
riguardanti la commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto
delle merci che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e
dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Più in particolare,
l'Unione europea non ha imposto la messa al bando delle buste di plastica ma ha
disposto con norma armonizzata del Comitato europeo di normazione, EN 13432, le
caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire
biodegradabile o compostabile.
La decisione impositiva. Ciò detto, occorre
rilevare come la decisione di imporre una tassa può rispondere a differenti
finalità. Quella principale è di concorrere alle spese pubbliche ma l'imposta
può avere anche lo scopo diretto di penalizzare un certo settore economico o
quello di colpire una tipologia di consumi. Esempio è dato dall'imposta di
fabbricazione che fu introdotta sui sacchetti di plastica dalla legge n.
478/1988 che all'articolo 1 prevedeva l'assoggettamento di 100 lire per ciascun
shoppers non biodegradabile (con evidente finalità ambientalista). La tassazione
dei sacchetti non biodegradabili è un meccanismo esclusivamente dissuasivo (la
minaccia di applicare nuove tasse ha lo scopo, in tal caso, di giungere a una
loro progressiva eliminazione). Infatti, le 100 lire sortirono un effetto
deterrente, tanto che l'uso dei sacchetti scese di oltre il 30%. La legge n. 427
del 1993, tuttavia, abrogò questa disposizione nonostante alcuni supermercati
continuarono (illegittimamente) a far pagare la busta (al prezzo di 5 centesimi
circa) traslando sul cliente finale la tassa che non era più dovuta all'erario.
A ogni modo, dal gennaio 2011 nei supermercati italiani si possono acquistare
sacchetti biodegradabili (il cui sovrapprezzo è pari a circa 20 centesimi)
mentre quelli di plastica sono usati fino a esaurimento scorte purché la
cessione degli stessi sia effettuata a favore dei consumatori ed esclusivamente
a titolo gratuito.
Le altre scelte europee. Oltre al caso italiano
occorre ricordare la scelta degli irlandesi. Nell'isola, infatti, dal 2002 è
stata avviata una campagna contro i rifiuti selvaggi e contro tutti i tipi di
imballaggio disseminati lungo le strade. Per ogni sacchetto di plastica
utilizzato negli stores è stata imposta una tassa di 15 centesimi al fine di
ridurne l'utilizzo ed evitare di contribuire all'inquinamento delle campagne
irlandesi. Il consumo è calato drasticamente del 90%. L'esperienza irlandese è
servita da modello per altri Paesi quali la Scozia, Malta e Gran Bretagna. Nel
Regno è stato Modbury il primo comune ha dichiarare fuorilegge i sacchetti di
plastica nel 2007. Il consumo è stato dimezzato pure in Spagna mentre in
Germania, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera per i sacchetti di plastica
si paga già una tassa aggiuntiva "punitiva".
La Francia e la tassa da 10 euro. Se l'Italia ha
messo il bando ai sacchetti di plastica non biodegradabili il Senato francese ha
fatto slittare dal 2011 al 2014 la loro tassazione. I parlamentari, infatti,
hanno votato un emendamento che dispone per i supermercati una tassa di 10 euro
per ogni kilo di sacchetti con decorrenza 2014 (mentre i deputati avevano
chiesto di anticipare il tutto al 2011).
La tassazione nel resto del mondo. La tassazione
come deterrente finalizzato a ovviare il problema dei rifiuti ambientali vige
anche negli USA. La Città di Washington DC, nel 2010, ha imposto una tassa pari
a 5 centesimi per ogni sacchetto di plastica ceduto al cliente che effettua la
spesa nei supermercati. La capitale non è la prima città a disincentivare l'uso
delle "plastic bags". La tassa sui sacchetti di plastica è in vigore a San
Francisco, dove già nel 2008 è stato vietato il loro utilizzo (nei supermarket e
nelle farmacie) e dove è stato imposta la sostituzione con materiali più
eco-friendly, come la carta (sebbene si sta sempre più diffondendo la popolarità
dei sacchetti di tela riutilizzabili). Anche in questo caso, la ratio della
tassa risponde non tanto all'esigenza di introdurre un nuovo onere tributario
quanto a quello di incoraggiare gli acquirenti a non essere ulteriormente
tassati (nel rispetto dell'ambiente). In oriente, la Cina ha deciso di porre al
bando i sacchetti di plastica nel 2009 istituendo un nuovo tributo sui sacchetti
ed emesso regolamenti per vietare quelli maggiormente inquinanti.
Fonti: ministero dell'Ambiente
Sui social arriva la "resistenza" contro
i sacchetti a pagamento. Renzi al contrattacco: "Così aiutiamo la green
economy", scrive Massimo Malpica, Giovedì 04/01/2018,
su "Il Giornale". Un sacco (bio) di proteste. La prima polemica dell'anno ha lo
spessore quasi impalpabile dei sacchetti per l'ortofrutta, quelli parzialmente
biodegradabili, che dal primo gennaio sono diventati - come noto - a pagamento.
Nei supermercati il prezzo varia tra uno e tre centesimi, ma nonostante
Assobioplastiche abbia stimato un costo annuo tra 1,5 e 4,5 euro pro capite, le
proteste dei consumatori dilagano. Soprattutto sui social network. A irritare
per cominciare è la scelta del governo di «portarsi avanti» nel recepire la
direttiva europea in materia (che permetteva di escludere dagli obbiettivi di
riduzione plastica proprio i sacchetti ultraleggeri), prevedendo da subito di
proibire la distribuzione gratuita delle bustine, oltre che la mancanza di
alternative: le buste non possono essere riutilizzate (ma si possono usare come
contenitori per l'umido a casa, se sono ancora integre) e non si possono
utilizzare sacchetti propri, quindi di fatto si è costretti a spendere quegli
eurocent in più ogni volta che si compra e si pesa ortofrutta, pesce o carne.
Anche questo dettaglio è diventato «virale» in rete in seguito al suggerimento
«risparmioso» di incollare lo scontrino della bilancia direttamente
sull'ortaggio pesato. Niente da fare: per semplificare il calcolo, il costo
della busta in bioplastica è aggiunto proprio al momento della pesata. Per cui
lo stratagemma di prezzare direttamente frutta e verdura non funziona, perché si
finisce per pagare il sacchetto anche se non lo si prende. Ma comunque le foto
di mele scontrinate una per una (con una conseguente moltiplicazione del costo
per i sacchetti) ieri andavano alla grande su Facebook, con migliaia di
condivisioni che spacciavano la trovata come «soluzione» per il boicottaggio
della nuova legge. L'altra polemica è squisitamente «antirenziana», e riguarda
l'azienda leader nella produzione di buste in mater-bi, una plastica
biodegradabile realizzata dal mais dalla Novamont, azienda novarese con
stabilimento a Terni il cui ad, Catia Bastioli, aveva partecipato alla Leopolda
del 2011, sei anni fa, come oratrice, invitata proprio dal rottamatore. Di qui
le critiche alla scelta «radicale» del governo guidato da Paolo Gentiloni
nell'imporre da subito un prezzo ai sacchetti ultraleggeri. Anche perché, sempre
online, non sono mancati i simpatizzanti dem che di bacheca in bacheca difendono
la scelta dell'esecutivo e la attribuiscono a un presunto obbligo italiano di
allinearsi all'Europa, mentre come detto le cose stanno diversamente, e di fatto
l'Italia è il solo Paese nel quale quei sottilissimi involucri tocca pagarli. In
Irlanda, invece, viene applicata una tassa sulla produzione degli shopper. «In
Italia ci sono circa 150 aziende che fabbricano sacchetti prodotti da materiale
naturali e non da petrolio, anziché gridare al complotto dovremmo aiutare a
creare nuove aziende nel settore della green economy senza lasciare il futuro
nelle mani dei nostri concorrenti internazionali», ha replicato Matteo Renzi
nell'ultimo numero delle sue Enews. E non manca nemmeno l'ironia a margine delle
polemiche. Come il meme del principino George, icona snob del web, che ammonisce
sorridente: «I sacchetti per la spesa ve li compro io. Poracci».
I sacchetti biodegradabili a pagamento
solo in Italia. Solo nel nostro Paese buste pagate
sullo scontrino. Fino allo scorso anno il costo era stato scaricato sui
prodotti, scrive Franco Grilli, Mercoledì 03/01/2018, su "Il Giornale".
I sacchetti per frutta e verdura si pagano, per il momento, solo in Italia. Il
nostro Paese ha scelto questa strada per adeguarsi ad una direttiva Ue del 2015.
Di fatto in Italia a partire dall'1 gennaio si pagano i sacchetti sotto i 15
micron che troviamo in tutti i supermercati per imbustare verdure o frutta da
pesare. In questo modo i sacchetti di questo tipo vengono uniformati a quelli da
50 micron, quelli in cui mettiamo materialmente la spesa che acquistiamo e che
da tempo si pagano in cassa. Di fatto finora il costo di queste piccole buste
veniva scaricato sul prezzo finale per i prodotti. La decisione dell'esecutivo
ha sostanzialmente invertito questa prassi. La novità tra gli scaffali dei
supermercati di fatto ha scatenato qualche protesta soprattutto sui social dove
qualcuno ha deciso di "ribellarsi" pesando ad esempio le arance una ad una senza
usare la busta. La direttiva europea comunque riguarda tutti gli stati membri e
probabilmente l'Italia ha semplicemente anticipato ciò che potrebbe accadere
altrove nei prossimi anni. In Irlanda, come riporta il Corriere, finora si è
deciso di predisporre una tassa sui sacchetti. Un altro modo per affrontare il
problema posto dalla direttiva Ue. Bruxelles di fatto ha scelto di dare il via
ad una stretta contro quei sacchetti di platica biodegradabili che vengono usati
da milioni di cittadini in tutta l'Ue. In Francia i sacchettini sono stati messi
al bando dal 2017. Niente buste di plastica gratuite in Paesi Bassi, Gran
Bretagna, Croazia e Svezia. Dovranno ancora allinearsi alla nuova direttiva (i
cui termini sono scaduti nel 2016) Danimarca, Grecia, Finlandia, Austria e
Germania.
Veritas vincit: Questa è la patria della
tassa sul macinato, scrive Rosanna Manzato mercoledì 3
gennaio 2018 su "Freeanimals". Allora, governo di merda, oggi sono andata al
supermercato ed ovviamente, nel reparto frutta e verdura, con dei cartelli, si
avvisa la clientela che i sacchetti per frutta e verdura, come da vostro ordine,
dal 1° gennaio 2018 sono a pagamento al costo di 1 cent di € cadauno. Ho preso 4
arance sfuse e ad una ad una le ho pesate ed etichettate. Vado alla cassa e dico
alla cassiera che ho fatto questo per non pagare il sacchetto. La poveretta mi
passa la prima arancia sul lettore dei codici a barre e mi dice esterrefatta:
"Signora, la bilancia è già tarata con il prezzo del sacchetto già compreso,
perché mi dà il costo del frutto più il prezzo del sacchetto". Io allora
rispondo gentilmente: "Ok va bene, le lascio qui le arance". La povera chiama il
direttore che, molto gentilmente, mi dice che il prezzo del sacchetto si può
stornare dal conto, ma solo per 2 capi e per le altre 2 arance mi verranno
restituiti i 2 cent dalla cassiera. Ho ricevuto un tripudio di elogi dai clienti
in coda alla cassa, mi sono scusata con i gentilissimi cassiera e direttore che
a loro volta erano d'accordo con me... Governo di m…! Credo che questa piccola
cosa, avrà un largo seguito: incularci un centesimo vale quanto incularci un
lingotto d'oro, tenetelo bene a mente, che tutto vi ritornerà con gli
interessi! Ps: in altre catene di supermercati, i sacchetti costano 3 centesimi
cadauno...fate voi!
Sacchetti biodegradabili per frutta e
verdure a pagamento, scoppia la rivolta sui social.
Arance pesate una ad una e altri trucchetti suggeriti dai consumatori per
evitare di pagare il costo dei sacchetti biodegradabili, obbligatori e a
pagamento dal primo gennaio 2018. La stima è di una spesa dai 4 ai 12,50 euro
all'anno, scrive Valentina Santarpia il 2 gennaio 2018 su “Il Corriere della
Sera”. «Non ci sono speculazioni ai danni del consumatore», dice soddisfatto il
presidente di Assobioplastiche dopo una prima ricognizione sui prezzi dei
sacchetti per frutta e verdura, che dal primo gennaio sono - per legge -
biodegradabili e a pagamento. Anche se la cifra per ogni sacchetto oscilla tra 1
e 3 centesimi, non la pensano allo stesso modo i clienti dei supermercati, che,
inviperiti dalla novità, hanno iniziato da ieri a postare sui social foto di
scontrini e sotterfugi per evitare quello che il Codacons ha già definito un
«balzello». «Fatta la legge, trovato l'inganno», scrive una consumatrice,
pubblicando la foto delle arance pesate ed etichettate una ad una, per evitare
di usare il sacchetto.
Il calcolo della spesa. Secondo l'Osservatorio di
Assobioplastiche, il costo annuale dei sacchetti per una famiglia dovrebbe
oscillare tra i 4,17 e i 12,51 euro. Come si arriva a questa stima?
L'Osservatorio stima che il consumo di sacchi per ortofrutta e per il cosiddetto
secondo imballo (quello dei prodotti che prima vengono incartati, come carne,
pesce, gastronomia, panetteria) si aggiri complessivamente tra i 9 e i 10
miliardi di unità, per un consumo medio di ogni cittadino di 150 sacchi
all'anno. Secondo i dati dell'analisi Gfk-Eurisko presentati nel 2017 le
famiglie italiane effettuano in media 139 spese all'anno nella Grande
distribuzione. Ipotizzando che ogni spesa comporti l'utilizzo di tre sacchetti
per frutta/verdura, il consumo annuo per famiglia dovrebbe attestarsi a 417
sacchetti, per un costo compreso tra 4,17 e 12,51 euro (considerando appunto un
minimo rilevato di 0,01 e un massimo di 0,03 euro).
Il prezzo di 12 minuti. La legge entrata in vigore
dal 1° gennaio del 2018 è l’articolo 9-bis della legge di conversione n. 123 del
3 agosto 2017 (il Decreto Legge Mezzogiorno) che stabilisce che «le borse di
plastica non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo
di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto
delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite». Per gli esercizi
commerciali che non applicheranno la nuova norma sono previste multe che vanno
da 2.500 a 25.000 euro. Ma le sanzioni possono arrivare anche fino a 100.000
euro in caso di «ingenti quantitativi» di buste fuorilegge. E per i consumatori
non c'è nessuna via facilitata, come il fai da te: il ministero dell'Ambiente ha
già fatto sapere che, per motivi igienici, i sacchetti non potranno essere
portati da casa o riutilizzati. Anche se le stime dicono che il tempo medio di
utilizzo di un sacchetto è 12 minuti. Una vita breve e costosa.
Sacchetti biodegradabili per la frutta a
pagamento, le polemiche sui social tra soluzioni green e lamentele.
Rivolta social per i sacchetti a pagamento per l'imballaggio alimentare. Sui
costi guerra di cifre tra associazioni dei consumatori e aziende. Su Twitter
appelli, battute e ironie, scrive il 3 gennaio 2018 “Il Corriere della Sera”. Il
provvedimento sui sacchetti biodegradabili per il primo imballo alimentare a
pagamento continua a scatenare furiose polemiche sui social media e non solo. Il
botta e risposta sulle spese aggiuntive per le famiglie si è consumato a colpi
di note tra associazioni dei consumatori e aziende produttrici: il Codacons ha
infatti affermato che i costi aggiuntivi potrebbero raggiungere i 50 euro a
famiglia; molto meno (cifre nell'ordine di pochi euro all'anno) per
Assobioplastiche, l’associazione di categoria delle aziende produttrici, che
sostiene che la spesa supplementare potrebbe essere compresa tra 1,5 euro e 4,5
euro all’anno (per persona, però, non per famiglia).
La furia dei consumatori. Nel frattempo, comunque,
la polemica è scoppiata, puntuale e furiosa, sui social media. Anche perché, a
quanto pare, i supermercati hanno applicato la tariffa per il «sacchetto bio» o
il «sacchetto orto» a scontrino emesso dalla bilancia e non a sacchetto
effettivamente consumato. Con il risultato che anche chi compra la frutta e la
etichetta a pezzo singolo paga per un sacchetto non utilizzato.
Buste biodegradabili per frutta e
verdura: cosa sono i bioshopper obbligatori dal 2018,
scrive Ida Artiaco il 3 gennaio 2018 su "Fan Page". Dall’1 gennaio 2018
diventano obbligatori per legge i sacchetti di plastica biodegradabile per
pesare e trasportare alimenti freschi e di macelleria nei supermercati e nelle
piccole botteghe. Molte le polemiche dei consumatori, dal momento che queste
buste sono a pagamento. La decisione rappresenta, tuttavia, un passo in avanti
dell’Italia per combattere l’inquinamento. Si tratta di un materiale
compostabile e riciclabile, capace persino di rendere fertile il terreno sul
quale viene depositato. Dall'1 gennaio 2018 in tutta Italia è obbligatorio
utilizzare sacchetti di plastica biodegradabile e compostabili per pesare e
imbustare al supermercato o nelle botteghe sotto casa frutta, verdura, carne,
pesce, pane e uova. Lo ha stabilito la legge, o meglio il cosiddetto Decreto
Mezzogiorno, secondo il quale i bioshopper devono diventare l'imballaggio
primario per i prodotti di gastronomia, andando a sostituire le buste
ultraleggere in plastica con spessore inferiore ai 15 micron, che utilizzavamo
solitamente per pesare gli alimenti, nel rispetto dello standard internazionale
UNI EN 13432. Una decisione, questa, amica dell'ambiente e a favore della lotta
all'inquinamento atmosferico e dei mari, ma che ha fatto infuriare, e non poco,
i consumatori che hanno parlato di "tassa sulla spesa", dal momento che questi
nuovi sacchetti saranno a pagamento: ogni esercente potrà, infatti, vederli a un
prezzo compreso tra 1 e 5 centesimi. Chi di loro non rispetterà la nuova
normativa, rischierà multe salate. Ma di cosa si tratta nello specifico?
Cosa sono e come sono fatti i bioshopper. Quando
si parla di bioshopper ci si riferisce a dei sacchetti di plastica
biodegradabile, compostabile e riciclabile, utilizzati per il trasporto degli
alimenti. Questo tipo di materiale, impiegato per la realizzazione dei prodotti
più diversi, non solo per le buste della spesa, deriva da materie prime vegetali
rinnovabili annualmente. Il tempo di decomposizione è di qualche mese in
compostaggio, contro i 1000 anni richiesti dalle materie plastiche sintetiche
derivate dal petrolio. Le bioplastiche che si trovano sul mercato sono
composte soprattutto da farina o amido di mais, grano o altri cereali. Oltre ad
essere biodegradabili, hanno anche il pregio di rendere fertile il terreno sul
quale vengono depositate. Dopo l'uso, consentono persino di
ricavare concime fertilizzante dai prodotti realizzati, come biopiatti,
biobicchieri, bioposate, e di impiegarlo per l'agricoltura, perché, a differenza
di quelli in polietilene e polipropilene, si decompone naturalmente sul terreno.
L'inquinamento da plastica: allarme per il suolo e
i mari. La plastica è tra i maggiori responsabili dell'inquinamento del suolo ma
anche e soprattutto dei nostri mari e degli altri corsi d'acqua, dai laghi ai
fiumi (il cosiddetto marine litter). Non solo enormi quantità fluttuano in
superficie, ma tantissimi prodotti realizzati con questo materiali restano
imprigionati anche in profondità e non sono dunque visibili a occhio nudo.
Secondo alcuni esperti, la massa di plastica galleggiante sugli oceani dovrebbe
essere tra le 93.300 e le 236 mila tonnellate. Numeri, questi, che aumentano di
anno in anno, a causa dell'alta durabilità nel tempo di questo materiale, sempre
più utilizzato per dare vita agli oggetti più diversi, tra cui proprio i
sacchetti per la spesa. Soltanto in Europa, come riscontrato dagli ultimi dati
diffusi dall’EPA, si stima un consumo annuo di 100 miliardi di buste di
plastica, di cui una parte finiscono direttamente in mare e sulle coste. Secondo
l’International Coastal Cleanup, nel Mediterraneo tra il 2002 e il 2006 le buste
di plastica sono risultate essere il quarto rifiuto più abbondante dopo
sigarette, mozziconi e bottiglie.
Italia virtuosa e all'avanguardia: le leggi
approvate. A dire il vero, tra i paesi dell'Ue l'Italia è tra i più virtuosi per
quanto riguarda il tema dell'inquinamento da plastica ed in particolare dei
sacchetti per la spesa. Il nostro Parlamento è infatti stato il primo ad
approvare nel 2011 la legge contro gli shopper non compostabili. Ad oggi, come
riferisce Legambiente, anche se la misura non è del tutto rispettata, c’è stata
una riduzione nell’uso di sacchetti del 55%. Se fosse esteso a tutti i Paesi del
Mediterraneo e non solo, i risultati in termini sarebbero molto più rilevanti.
Un ulteriore passo in avanti è rappresentato, nelle intenzioni dei legislatori,
dall'ultima norma riguardante i bioshopper per pesare e imballare frutta,
verdura e altri prodotti alimentari e di macelleria, nonostante le polemiche
nate sui social perché queste buste sono a pagamento, e obbligatorie, a partire
dall'1 gennaio 2018. L’articolo 9-bis della legge n.123/2017, il cosiddetto
Decreto Mezzogiorno, prevede che le borse di plastica non possano essere
distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola
unità debba risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei
prodotti trasportati. Mentre il Codacons accoglie i timori dei consumatori,
parlando di una "tassa sulla spesa" e di "stangata per le famiglie", Legambiente
usa toni più moderati. "L'innovazione – ha detto Stefano Ciafani, direttore
generale dell'associazione ambientalista – ha un prezzo ed è giusto che i
bioshopper siano a pagamento, purché sia garantito un costo equo che si dovrebbe
aggirare intorno ai 2/3 centesimi a busta". Si ricorda però che sulle nuove
buste con cui si trasporteranno ad esempio verdura o pane ci sarà incollata
l'etichetta con il prezzo termico che non è compostabile e dunque andrà
accuratamente tolta. Inoltre, per questioni igieniche non si potrà portare il
proprio sacchetto da casa.
Sacchetti bio a pagamento per frutta e
verdura, ecco quanto ci costeranno, scrive Cinzia
Arena mercoledì 3 gennaio 2018 su "Avvenire". Guerra di cifre su uno dei rincari
scattati con il 2018. Legambiente: l'Italia in prima linea nella lotta
all'inquinamento da plastica. Ma i consumatori replicano: a pagare saranno le
famiglie. Tra i rincari su tariffe e servizi che il 2018 ha portato con sè,
dalle bollette di luce e gas al capitolo trasporti ai ticket sanitari, c'è una
piccola tassa occulta sull'acquisto di frutta e verdura. L'anno nuovo si è
aperto infatti con una novità per chi va a fare la spesa: la messa al bando dei
sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri utilizzati per imbustare prodotti
ortofrutticoli ma anche carne, pesce e affettati. Al loro posto shopper
biodegradabili e compostabili, ma rigorosamente a pagamento (da 1 a 5
centesimi). Una misura che ha prodotto una serie infinita di polemiche sui
social (con tanto di foto di arance con le etichette attaccate direttamente alla
buccia per evitare il pagamento della bustina bio) e un duro scontro tra gli
ambientalisti e le associazioni di consumatori. "L'innovazione ha un prezzo ed è
giusto che si paghi purchè il costo sia equo, vale a dire 2-3 centesimi a busta
- è la posizione espressa da Legambiente per voce del suo direttore Stefano
Ciafani - È fondamentale continuare la strada iniziata nel 2011 dall'Italia
nella lotta all'inquinamento da plastica". In Europa, secondo i dati
dell'Agenzia perla protezione dell'ambiente, si stima un consumo annuo di
100miliardi di sacchetti, e una parte di questi finiscono in mare e sulle coste.
L'Italia è stato il primo Paese europeo ad approvare, nel 2011, la legge contro
i sacchetti non compostabili. Ad oggi anche se la misura non è del tutto
rispettata, c'è stata una riduzione nell'uso di sacchetti del 55%. E adesso fa
un altro passo in avanti.
Guerra di cifre sul costo annuo per le
famiglie. Ma quanto costerà la nuova norma agli italiani? Su questo punto è
guerra di cifre. Secondo l'Osservatorio di Assobioplastiche la spesa aggiuntiva
oscillerà fra 4,17 e 12,51 euro il prezzo che ogni famiglia dovrà aggiungere
quest'anno alla spesa alimentare fatta in supermercati e ipermercati. Nella
ricognizione compiuta dall'Osservatorio in una dozzina di grandi magazzini
alimentari, il costo di ogni singolo sacchetto è risultato compreso fra 1 e 3
centesimi. Assobioplastiche ricorda che il consumo di buste si aggira tra i 9 e
i 10 miliardi di unità, per un consumo medio di ogni cittadino di 150 sacchi
all'anno. Secondo i dati dell'analisi Gfk-Eurisko presentati nel 2017, le
famiglie italiane fanno in media 139 spese all'anno nella grande distribuzione.
Ipotizzando che ogni spesa comporti l'utilizzo di tre sacchetti per
frutta/verdura, il consumo annuo per famiglia dovrebbe attestarsi a 417
sacchetti, per un costo complessivo compreso tra 4,17 e 12,51 euro (considerando
appunto un minimo rilevato di 0,01 e un massimo di 0,03 euro). "Queste prime
indicazioni di prezzo ci confortano molto -spiega Marco Versari, presidente di
Assobioplastiche -, perché testimoniano l'assenza di speculazioni o manovre ai
danni del consumatore". Peraltro, i sacchetti "sono utilizzabili per la raccolta
della frazione organica dei rifiuti - aggiunge - e quindi almeno la metà del
costo sostenuto può essere detratto dalla spesa complessiva". Sul pagamento dei
sacchetti però le associazioni dei consumatori si sono scatenate. Per
il Codacons è "un nuovo balzello che si abbatterà sulle famiglie italiane, una
nuova tassa occulta a carico dei consumatori". Si tratterà di una spesa
aggiuntiva compresa tra i 20 e i 50 euro a famiglia a seconda della frequenza
degli acquisti. Una vera e propria tassa occulta. Differente la stima fatta
da Adoc che parla di un aggravio fra i 18 e i 24 euro l'anno per una media di
600 sacchetti a famiglia. Tra le soluzioni alternative c'è chi propone un
ritorno alle buste di carta e chi come, Coop Svizzera, lancia le buste
riutilizzabili per frutta e verdura, chiamate multi-bag.
Federdistribuzione: obiettivo sottocosto per
venire incontro ai consumatori. La grande distribuzione, chiamata a mettere in
pratica la normativa, non ci sta a considerarla una stangata. Federdistribuzione
parla di una norma che punta ad accrescere la sensibilità dei consumatori nei
confronti dei temi ambientali. "Stiamo parlando di miliardi di sacchetti
utilizzati nei supermercati è ovvio che contribuiscono all'inquinamento.
L'obiettivo è ridurne il numero e al tempo stesso contenere i costi: nelle
nostre aziende si sta facendo strada sempre di più il "sottocosto" vale a dire
la vendita del sacchetto ad un costo inferiore a quello di produzione. Mi sembra
che il disagio sia relativo per il consumatore e inoltre si tratta di una norma
europea alla quale bisognava adeguarsi" spiega il presidente Giovanni Cobolli
Gigli ricordando che il passaggio analogo, ai sacchetti per la spesa bio ha
prodotto nel giro di sei anni una netta riduzione. Conciliare ambiente e
risparmio insomma si può.
La norma inserita nel decreto
Mezzogiorno. L'obbligo di utilizzo dei sacchetti bio-degradabili e a pagamento è
entrato in vigore dal 1° gennaio del 2018. Si tratta dell’articolo 9-bis della
legge di conversione n. 123 del 3 agosto 2017 (il decreto legge Mezzogiorno) che
stabilisce che «le borse di plastica non possono essere distribuite a titolo
gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare
dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per
il loro tramite». Per gli esercizi commerciali che non applicheranno la nuova
norma sono previste multe che vanno da 2.500 a 25.000 euro. Ma le sanzioni
possono arrivare anche fino a 100.000 euro in casi estremi, di «ingenti
quantitativi» di buste fuorilegge. Per i consumatori non c'è possibilità di
scelta. Bocciato il fai da te: il ministero dell'Ambiente ha già fatto sapere
che, per motivi igienici, i sacchetti non potranno essere portati da casa o
riutilizzati. Ma la loro vita media è di appena 12 minuti.
Per capire. Legambiente: 4 domande (e
risposte) sui sacchetti biodegradabili, scrive
mercoledì 3 gennaio 2018 "Avvenire". È polemica sui nuovi bioshopper
biodegradabili e compostabili, a pagamento, per gli alimenti ed entrati in
vigore dall'1 gennaio 2018. Non tutte le notizie che circolano appaiono però
corrette. In questi giorni infatti gli italiani appaiono sempre più divisi sui
nuovi bioshopper biodegradabili e compostabili, a pagamento, utilizzati per gli
alimenti ed entrati in vigore dal 1 gennaio 2018. C'è chi li sostiene e che
invece ha molti dubbi al riguardo, e non mancano in queste ore il proliferare di
affermazioni inesatte su una novità che, invece, sostiene Legambiente, fa bene
all'ambiente e aiuta a contrastare in maniera efficace l'inquinamento da
plastica non gestita correttamente e il problema del marine litter. Per questo
Legambiente punta il dito contro le "bugie" che stanno circolando in questi
giorni: dalla cosiddetta "tassa occulta" alla questione del monopolio di
Novamont, azienda a cui si deve l'invenzione del Mater-Bi. Quindi l'associazione
affronta 4 punti fornendo alcune informazioni:
Perché questo provvedimento? L'inquinamento da
plastica è sempre più grave. "Le polemiche di questi giorni - dichiara Stefano
Ciafani, direttore generale di Legambiente - sono davvero incomprensibili: non è
corretto parlare di caro spesa né di tassa occulta o di qualche forma di
monopolio aziendale. Sarebbe utile che ci si preoccupasse dei cambiamenti
climatici e dell'inquinamento causato dalle plastiche non gestite correttamente,
e che si accettassero soluzioni tecnologiche e produttive che contribuiscono a
risolvere questi problemi, senza lasciarsi andare a polemiche da campagna
elettorale di cui non se ne sente il bisogno. È ora di sostenere e promuovere
l'innovazione che fa bene all'ambiente, senza dimenticare di contrastare il
problema dei sacchetti di plastica illegali. Circa la metà di quelli in
circolazione sono infatti fuorilegge, un volume pari a circa 40 mila tonnellate
di plastica, e una perdita per la filiera legale dei veri shopper bio pari a 160
milioni di euro, 30 solo per evasione fiscale".
Siamo di fronte a una tassa occulta? Tassa
occulta? Per Legambiente non è nulla di tutto ciò. Da sempre i cittadini pagano
in modo invisibile gli imballaggi che acquistano con i prodotti alimentari ogni
giorno. Nessun produttore o nessuna azienda della grande distribuzione ha mai
fatto ovviamente e naturalmente beneficenza nei confronti dei consumatori. Unica
differenza, è che questa volta il costo è visibile, perché l'obiettivo della
norma è aumentare la consapevolezza dei consumatori su un manufatto che se
gestito non correttamente può causare un notevole impatto ambientale.
La legge vieta il riutilizzo dei sacchetti? Questo
problema si può ovviare semplicemente con una circolare esplicativa del
Ministero dell'ambiente e della salute che permetta in modo chiaro, a chi vende
frutta e verdura, di far usare sacchetti riutilizzabili, come ad esempio le
retine, pratica già in uso nel nord Europa. In questo modo si garantirebbe una
riduzione auspicabile dell'uso dei sacchetti di plastica, anche se compostabile,
come già fatto coi sacchetti per l'asporto merci (che grazie al bando entrato in
vigore nel 2012 in 5 anni sono stati ridotti del 55%).
Una legge che favorisce il monopolio di
un'azienda? È una legge basata sul monopolio dell'azienda Novamont? Si tratta di
una fantasia di chi non conosce il mercato delle bioplastiche. Oggi nel mondo ci
sono almeno una decina di aziende chimiche che producono polimeri
compostabili con cui si producono sacchetti e altro. Basta andare sul web e si
possono trovare colossi della chimica italiana, tedesca, americana, del sud est
asiatico, che producono bioplastiche. Dove sarebbe il monopolio? Forse sarebbe
opportuno ricordare che tra le principali aziende della chimica verde una volta
tanto l'Italia ha una leadership mondiale sul tema, grazie ad una società che è
stata la prima 30 anni fa a investire in questo settore e che negli ultimi 10
anni ha permesso di far riaprire impianti chiusi riconvertendoli a filiere che
producono biopolimeri innovativi che riducono l'inquinamento da plastica. Un
problema di cui ormai si parla in tutto il mondo, come emerso chiaramente ad
esempio alla Conferenza mondiale sugli oceani che l'Onu ha organizzato nel
giugno scorso a New York, a cui Legambiente ha partecipato portando l'esperienza
di citizen science sul marine litter con Goletta verde e le campagne di pulizia
delle spiagge.
Quanto costa davvero il sacchetto della
spesa, scrive Maria Teresa Camarda Mercoledì 03
Gennaio 2018 su "Live Sicilia”. Alcune cifre che circolano sul web sono delle
bufale. E guardando un po' più a fondo, i sacchetti in questione si pagavano
anche prima. Sacchetti della spesa a pagamento nei supermercati a partire dal 1
gennaio. Un obbligo di legge che ha fatto scattare immediatamente accesissime
polemiche sui social network. I consumatori stanno vivendo questa decisione del
governo nazionale come un'ulteriore tassa da pagare allo Stato. Ma le cose non
stanno proprio così e i costi di questa misura non sono poi così esosi come si è
detto. Alcune delle cifre che circolano sul web se non sono bufale, poco ci
manca. Stando ai calcoli diffusi dall'Osservatorio di Assobioplastiche, la spesa
per i sacchetti igienici destinati all'acquisto di frutta, verdura, carne e
pesce oscillerà fra 4,17 e 12,51 euro l'anno. E non, quindi, la spesa di 50 euro
di cui tanto si parla su Facebook, Twitter & co. Il provvedimento è previsto
dalla legge 123/2017, il cosiddetto decreto Mezzogiorno, approvato lo scorso
agosto, in cui si indica che queste buste non possono essere gratis per via
delle misure europee che prevedono l’obbligatorietà in tutti i Paesi dell’Unione
della cessione degli shopper a pagamento. Questa misura, come recita la
direttiva, si è resa necessaria "per aumentare la consapevolezza del pubblico in
merito agli impatti ambientali delle buste di plastica per liberarci dall'idea
che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso". "Queste prime
indicazioni di prezzo ci confortano molto - spiega Marco Versari, presidente di
Assobioplastiche, in un'intervista al notiziario "Eco dalle città" -, perché
testimoniano l'assenza di speculazioni o manovre ai danni del consumatore".
Peraltro, i sacchetti "sono utilizzabili per la raccolta della frazione organica
dei rifiuti - aggiunge Versari - e quindi almeno la metà del costo sostenuto può
essere detratto dalla spesa complessiva". Ma anche su Assobioplastiche si è
scatenato un vespaio di polemiche: "Gli unici ad applaudire pubblicamente la
norma - scrive un attivista del Movimento 5 stelle su Facebook in un post che è
stato condiviso centinaia di volte dal suo profilo e altrettante da ogni altro
profilo - sono i vertici di Assobioplastiche, il cui presidente, Marco Versari,
è stato portavoce del maggiore player del settore, la Novamont, già nota per
aver inventato i sacchetti di MaterBi, il materiale biodegradabile a base di
mais". Ma, guardando un po' più a fondo, i sacchetti in questione si pagavano
anche prima, solo che erano inclusi nel costo complessivo del prodotto pesato.
Adesso, con la nuova norma i supermercati dovranno indicare esplicitamente il
costo del sacchetto e, anche su quelli, pagare le imposte. Quindi, la nuova
norma semplicemente considera il sacchetto come una cosa che il supermercato ti
vende e non come un semplice costo di gestione. Per il Codacons, comunque, è "un
nuovo balzello che si abbatterà sulle famiglie italiane, una nuova tassa occulta
a carico dei consumatori". Per Legambiente, invece, "non è corretto parlare di
caro-spesa. L'innovazione ha un prezzo, ed è giusto che i bioshopper siano a
pagamento, purché sia garantito un costo equo, che si dovrebbe aggirare intorno
ai 2-3 centesimi a busta. Così come è giusto prevedere multe salate per i
commercianti che non rispettano la vigente normativa". Le sanzioni per chi viola
o elude la legge vanno da 2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000 euro se
la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica
oppure un se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato
del trasgressore.
Dal primo gennaio sono obbligatori: i
bioshopper dividono gli italiani. Per legge devono
essere l'imballaggio primario per i prodotti di gastronomia, macelleria,
pescheria, frutta verdura e panetteria. Sono riciclabili e per questo piacciono
a molti; costano poco ma se si fa la somma alle casse si può avere qualche
sorpresa, e per questo una fetta di italiani parla di "tassa occulta", scrive
Giacomo Talignani il 2 gennaio 2018 su “La Repubblica”.
"GENTILE CLIENTE... ti comunichiamo che è in
vigore la legge che impone che vengano utilizzati sacchetti compostabili e
biodegradabili idonei al contatto alimentare in sostituzione dei sacchetti di
plastica". Questa la scritta che molti supermercati italiani recano all'ingresso
dei loro punti vendita da oggi, giorno di riapertura della maggior parte degli
store della grande distribuzione. Dal 1°gennaio è infatti scattato l'obbligo,
per il cosiddetto "Decreto mezzogiorno", di utilizzare ''bioshopper'' come
imballaggio primario per i prodotti di gastronomia, macelleria, pescheria,
frutta verdura e panetteria. Via dunque le buste ultraleggere in plastica (con
spessore inferiore ai 15 micron) che utilizzavamo solitamente per pesare gli
alimenti le quali saranno sostituite da quelle biodegradabili e compostabili,
nel rispetto dello standard internazionale UNI EN 13432. Una scelta, decisa
nella lotta all'inquinamento ambientale e al problema delle microplastiche nei
nostri mari, che peserà però sulle tasche degli italiani: ogni esercente venderà
infatti le singole buste a un prezzo compreso fra gli 1 e i 5 centesimi. Come
stabilito per legge, inoltre, per questioni igieniche non si potrà portare il
proprio sacchetto da casa e dunque, di fatto, sarà obbligatorio spendere qualche
centesimo nel caso si voglia acquistare frutta, verdura o altri prodotti. In
caso di inadempienze per i venditori - l’obbligo si estende dalla grande
distribuzione ai piccoli negozi - sono previste multe salate che vanno da 2.500
a un massimo di 25mila euro. La novità ha già diviso gli italiani fra coloro che
sono favorevoli all'iniziativa e chi invece punta il dito contro la "tassa
occulta" che dovremo pagare: ad ottobre un sondaggio Ispos Public Affairs
indicava che 6 italiani su 10 si dicono favorevoli al nuovo sistema.
LA POLEMICA SUI COSTI - La legge, che vieta
soluzioni diverse da quelle biodegradabili e compostabili con un contenuto
minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%, è stata accolta con
entusiasmo dalle associazioni ambientaliste mentre da quelle dei consumatori
arrivano forti critiche. Per Legambiente non è corretto parlare di caro-spesa:
perché" l’innovazione - dichiara Stefano Ciafani, direttore generale di
Legambiente - ha un prezzo ed è giusto che i bioshopper siano a pagamento,
purché sia garantito un costo equo che si dovrebbe aggirare intorno ai 2/3
centesimi a busta". Il Codacons parla invece di stangata sulle famiglie.
"Significa che ogni volta che si va a fare la spesa al supermercato occorrerà
pagare dai 2 ai 10 centesimi di euro per ogni sacchetto, e sarà obbligatorio
utilizzare un sacchetto per ogni genere alimentare, non potendo mischiare
prodotti che vanno pesati e che hanno prezzi differenti. Tutto ciò comporterà un
evidente aggravio di spesa a carico dei consumatori, con una stangata su base
annua che varia dai 20 ai 50 euro a famiglia a seconda della frequenza degli
acquisti nel corso dell'anno" dice il presidente Carlo Rienzi definendola una
"tassa occulta". Differente invece la stima di Adoc che prevede un aggravio fra
i "18 e i 24 euro l'anno per circa 600 sacchetti consumati a famiglia". A queste
cifre replica Assobioplastiche che stima un prezzo differente, al massimo fra
"1,50 e 4,50 euro l'anno a persona". In questa operazione di contrasto al
"marine litter" ogni supermercato della Gdo (la grande distribuzione) indicherà
il proprio prezzo per busta. Per ora sono in pochi ad essersi sbilanciati, fra
cui la Coop che ha fissato a 2 centesimi a busta il suo prezzo. Altri, come
Esselunga o Carrefour, stanno procedendo con la sostituzione dei sacchetti ma
devono ancora indicare con precisione la propria cifra.
RIUTILIZZO DEI SACCHETTI - Fra gli aspetti da
considerare nella "rivoluzione dei sacchetti" c'è quello del riutilizzo delle
buste biodegradabili per la raccolta dell'umido. In alcuni Comuni dove è in
vigore la differenziata le famiglie acquistano i sacchetti biodegradabili in
confezione con costi che oscillano fra i 10 e i 15 centesimi e dunque, se si
riutilizzassero quelli dei supermercati comprati a 1-2 centesimi, ci sarebbe un
risparmio. Ambientalisti e attenti osservatori ricordano però che sulle nuove
buste con cui trasporteremo ad esempio verdura o pane ci sarà incollato
l'etichetta con il prezzo termico che non è compostabile e dunque andrà
accuratamente tolta. Catene come Lidl pesano i prodotti direttamente in cassa
aggirando il problema dell'etichetta con prezzo e battendo direttamente sullo
scontrino.
SISTEMI ALTERNATIVI - Ogni novità, chiaramente,
scatena l'inventiva dei più creativi per trovare soluzione gratuite. Se come
detto non è possibile portarsi i propri sacchetti da casa c'è chi propone il
ritorno delle vecchie buste a rete o dei sacchetti di carta, questione però
ancora tutta da dibattere (per i distributori). Fra le soluzioni già in atto,
per esempio per frutta o ortaggi acquistati singolarmente, come un limone, un
avocado e via dicendo, c'è quella di attaccare l'etichetta direttamente sul
singolo prodotto (di solito sulla buccia che poi viene tolta). Altri esempi di
possibili soluzioni future arrivano poi da Coop Svizzera che da novembre ha
messo a disposizione buste riutilizzabili per frutta e verdura, chiamate
Multi-Bag, in alternativa ai sacchetti.
IN EUROPA - In Europa, secondo gli ultimi dati
diffusi dall'EPA, si stima un consumo annuo di 100 miliardi di sacchetti, molti
dei quali finiscono in mare e sulle coste. Legambiente ricorda che la messa al
bando degli shopper non compostabili è attiva in Italia, Francia e Marocco e
altri Paesi hanno introdotto delle tasse fisse (Croazia, Malta, Israele e alcune
zone della Spagna, della Grecia e della Turchia). Diverse iniziative sono in
atto in tutto il Vecchio continente per cercare di ridurre il numero delle
buste. Secondo un report della Marine Conservation Society in Gran Bretagna la
lotta ai sacchetti non biodegradabili ha portato a un drastico calo della
presenza di buste sulle coste, circa il 40% in meno.
Sacchetti biodegradabili per frutta e
verdure: una «tassa sulla spesa»? Dal primo gennaio
obbligatorio imbustare frutta e verdura acquistata nei supermercati in
sacchettini di plastica biodegradabile forniti a pagamento. Ma ambientalisti,
consumatori e industriali la pensano tutti in modo diverso, scrive il
03/01/2018 Andrea Zaghi su Sir Servizio Informazione Religiosa. Alcuni l’hanno
già chiamata «tassa sulla spesa». E in effetti così parrebbe l’obbligo, scattato
dallo scorso primo gennaio, di imbustare frutta e verdura acquistata nei
supermercati solo in sacchetti di plastica biodegradabile «nuovi» e forniti a
pagamento. La precisazione non è casuale: accanto all’obbligo dei supermercati,
c’è anche un altro obbligo, imposto ai consumatori, di non portarsi da casa
sacchetti biodegradabili usati. Tutto è contenuto nel DL Mezzogiorno e
precisamente nell’articolo 9-bis della legge di conversione n. 123 del 3 agosto
2017. Le regole appaiono piuttosto chiare, in ogni caso il ministero
dell’Ambiente ha inviato una lettera al sistema della grande distribuzione
organizzata. Dal primo gennaio è obbligatorio infilare frutta e verdura
acquistata nei supermercati solo in sacchetti di plastica biodegradabile che
dovranno essere pagati (si tratta dei sacchettini bianchi che fino a pochi
giorni fa erano forniti gratuitamente); oltre a questo, è vietato il riutilizzo
delle buste biodegradabili per motivi igienico-sanitari. Ugualmente è vietato
mettere in una sola busta prodotti ortofrutticoli diversi. Questo all’interno
del supermercato. C’è da immaginare, quindi, che tutto invece possa avvenire
appena fuori i centri commerciali e i punti vendita (con tanto di travasi di
prodotti nelle borse casalinghe). L’obiettivo è condivisibile – diminuire il più
possibile l’uso di plastica -, il percorso per raggiungerlo lascia perplessi
molti e ha del contraddittorio. Da un lato, infatti, si vuole ridurre l’uso
della plastica, dall’altro si vieta il riuso della plastica biodegradabile. Il
tema è solo apparentemente banale ed ha già prodotto schieramenti netti: da un
lato gli ambientalisti, dall’altro alcune associazioni dei consumatori. Senza
contare la deriva di polemica politica; c’è chi infatti vede dietro questa
norma, un favore fatto ad aziende i cui vertici sarebbero legati a filo doppio
al centrosinistra. Stando ai calcoli già fatti, comunque, la «tassa sulla spesa»
dovrebbe pesare dai due ai dieci centesimi per busta utilizzata. Parte del
ricavo dovrà essere versato dai supermercati allo Stato sotto forma di Iva e di
imposte sul reddito. Per chi sgarra ci sono le multe. I supermercati che usano
ancora buste non biodegradabili rischiano multe da 2.500 euro a 25.000 euro e
fino a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi
di borse di plastica oppure se il valore delle buste fuori legge è superiore al
10% del fatturato del trasgressore. Ed è naturalmente sul costo dei sacchetti
che pare crearsi la spaccatura fra ambientalisti e consumatori. Il Codacons ha
già parlato di una «stangata sulle famiglie». A conti fatti l’associazione
indica un aggravio di spesa annuo dai 20 ai 50 euro per nucleo familiare. Si
tratta, ha tuonato il presidente Carlo Rienzi, «di una vera e propria tassa
occulta a danno dei cittadini italiani che non ha nulla a che vedere con la
giusta battaglia in favore dell’ambiente». Più sfumata Legambiente il cui
direttore generale, Stefano Ciafani, ha spiegato che l’innovazione «ha un
prezzo» e che è «giusto che i bioshopper siano a pagamento, purché sia garantito
un costo equo che si dovrebbe aggirare intorno ai 2/3 centesimi a busta. Così
come è giusto – ha continuato -, prevedere multe salate per i commercianti che
non rispettano la vigente normativa». Per Assobioplastiche (l’Associazione
Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili), i
sacchettini di plastica biodegradabile costituiscono la «naturale conclusione di
un percorso virtuoso nel settore della bioeconomia e dell’economia circolare che
fa dell’Italia un modello per tutta l’Europa». Poi ci siamo tutti noi, quelli
che vanno a fare la spesa al supermercato. Che non la pensano poi tanto male. Da
un’indagine Ipsos, infatti, il 71% degli intervistati prevede una spesa notevole
ma solo il 28% è davvero contrario alle nuove regole. La «nuova tassa» è ben
accetta, servirà ad abbattere davvero il consumo di plastica e a migliorare
l’ambiente. Il 58% degli intervistati si è detto favorevole alla legge. D’altra
parte che qualcosa occorra fare ne sono consapevoli tutti. Sembra che in Europa
ogni anno siano consumati cento miliardi di sacchetti di plastica (Fonte: EPA),
e che una buona parte di questi finiscano in mare e sulle coste. Una situazione
non più sostenibile che vede però l’Italia fra i Paesi più virtuosi visto che
dal 2011 abbiamo una legge contro gli shopper non compostabili.
Fatti e misfatti della nuova legge sui
sacchetti ultraleggeri. C’è chi parla di tassa, c’è
chi chiama in causa il giglio magico e la lobby delle bioplastiche. Facciamo un
po’ di chiarezza sulla nuova norma che disciplina la vendita delle borse di
plastica per alimenti sfusi, scrive il 2 gennaio 2018 "Polimerica". Nonostante
sia nota dalla fine del 2016 l’intenzione del Governo di imporre misure
restrittive sulla commercializzazione di sacchetti ultraleggeri per ortofrutta
(leggi articolo), ufficializzata nell’agosto dell’anno scorso con l’approvazione
del decreto n. 91/2017(disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno), solo negli ultimi giorni i media e le associazioni dei consumatori
si sono scatenati, in modo spesso scomposto, su origine e impatti del
provvedimento, giudicato una sorta di tassa sui consumatori, sostanzialmente
inutile, introdotta al solo scopo di favorire Novamont e altri produttori di
bioplastiche. Per Codacons è “un balzello inutile che non ha nulla a che vedere
con l’ambiente e con la lotta al consumo di plastica”, che “determinerà un
aggravio di spesa che potrà raggiungere i 50 euro annui a famiglia, laddove il
costo degli shopper avrebbe dovuto essere interamente a carico dei supermercati
e dell’industria”. Contraria al provvedimento anche Federconsumatori, che
ritiene il nuovo provvedimento “importante e anche condivisibile, ma restano
alcuni dubbi sulla scelta di introdurne l’utilizzo esclusivamente a pagamento”.
Per il Giornale - in un articolo a firma di Giuseppe Marino (qui articolo
integrale) - si tratta di un regalo alla Coop e a Catia Bastioli, AD di
Novamont, definita “una capace manager che ha incrociato più volte la strada del
Pd e di Renzi”. A difendere la scelta del Governo - oltre ad Assobioplastiche -
c’è Legambiente: “L’innovazione – afferma il direttore Stefano Ciafani - ha un
prezzo ed è giusto che i bioshopper siano a pagamento, purché sia garantito un
costo equo che si dovrebbe aggirare intorno ai 2/3 centesimi a busta”. NON È UNA
TASSA. In realtà, non si tratta di una nuova imposta. I proventi - se non
indirettamente (IVA) - non finiranno nelle casse del tesoro, ma resteranno ad
esercenti e grande distribuzione, a copertura dei maggiori costi dei sacchetti
biodegradabili e biobased rispetto a quelli tradizionali. Per dare
un'indicazione di massima, un sacchetto ultraleggero costa alla grande
distribuzione tra i 2 e i 5 centesimi al pezzo, a seconda dei volumi e degli
accordi con i fornitori. Il prezzo del sacchetto al consumatore sarà deciso dal
singolo esercente: e se ciò potrebbe essere fonte di speculazioni, è anche vero
che nulla vieta ad un esercente di imporre un valore infinitesimale; l’unico
vincolo, secondo la legge è che “il prezzo di vendita per singola unità deve
risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti
imballati per il loro tramite”. In una circolare, il Ministero dello Sviluppo
economico ha confermato la liceità di vendere i sacchetti sottocosto, onde
evitare - come si legge nella nota - "di far ricadere sul consumatore finale il
costo derivante dall’introduzione e conseguente applicazione di una disposizione
avente quale finalità la tutela ambientale".
PERCHÈ SOLO A PAGAMENTO? Qui il tema si fa più
complesso. Per motivare l’obbligo di far pagare i sacchetti ultraleggeri è stata
chiamata in causa una direttiva europea (2015/720), diramata da Bruxelles per
ridurre il consumo di sacchetti monouso in plastica, che prescrive, come
opzione: "l’adozione di strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre
2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente
nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti
di pari efficacia”. Ma, una riga sotto si legge anche: “Le borse di plastica in
materiale ultraleggero possono essere escluse da tali misure”. In sostanza,
nulla vieta di adottare misure restrittive per i sacchetti con spessore
inferiore a 15 micron utilizzati a fini di igiene, compreso l’obbligo di far
pagare il sacchetto - come ha fatto l’Italia -, ma non è Bruxelles a imporle.
Infatti, come si legge nelle premesse della Direttiva: “gli Stati membri possono
scegliere di esonerare le borse di plastica con uno spessore inferiore a 15
micron (“borse di plastica in materiale ultraleggero”) fornite come imballaggio
primario per prodotti alimentari sfusi ove necessario per scopi igienici oppure
se il loro uso previene la produzione di rifiuti alimentari”.
QUANTO COSTANO ALLA CASSA? A poche ore
dall’entrata in vigore della legge, l’Osservatorio di Assobioplastiche ha svolto
una prima ricognizione sui prezzi applicati a questi sacchetti, per ora limitata
alla grande distribuzione. Auchan, Conad, Coop Italia, Coop Lombardia, Eurospar,
Gruppo Gros e Iper hanno fissato un prezzo di 2 centesimi a sacchetto. Costano
invece la metà, 0,01 euro, gli ultraleggeri commercializzati nei punti vendita
di Coop Toscana, Esselunga e Unes. Hanno deciso di applicare un prezzo di 3
centesimi di euro a sacchetto le catene Lidl, Pam e Simply.
QUANTO PAGHERA' IL CONSUMATORE? Indubbiamente
qualche centesimo moltiplicato per più sacchetti (uno per ogni alimento)
utilizzati per la spesa quotidiana o settimanale, alla fine dell’anno comporterà
un aggravio di costo per i consumatori. Ma quanto? Molto dipenderà dal costo
fissato dagli esercenti. Codacons stima un costo annuo per famiglia di 50 euro,
mentre Assobioplastiche ridimensiona la cifra a un ordine di di grandezza in
meno: considerando un consumo medio annuo per famiglia intorno a 150 sacchetti e
un costo unitario compreso tra 1 e 3 centesimi, si arriva ad un onere
complessivo di 2-4,5 euro l’anno. Secondo i dati
dell'analisi GFK-Eurisko presentati a Marca 2017, le famiglie italiane
effettuano in media 139 spese anno nella GDO. Ipotizzando che ogni spesa
comporti l'utilizzo di tre sacchetti per frutta/verdura, il consumo annuo per
famiglia dovrebbe attestarsi a 417 sacchetti, per un costo compreso tra 4,2 e
12,5 euro. Occorre anche considerare che il nuovo sacchetto ultraleggero
è compostabile: quindi, dopo essere stato utilizzato per la spesa può tornare
utile per il conferimento dell’umido, nei comuni in cui è in funzione la
raccolta differenziata dei rifiuti organici, evitando l’acquisto di sacchetti
specifici.
SI RIDURRÁ IL CONSUMO DI SACCHETTI
MONOUSO? Difficile dirlo, ma non essendoci sempre alternative disponibili - come
nel caso dei banconi ortofrutta dei supermercati - non è certo che la misura
servirà a ridurre il consumo di sacchetti ultraleggeri in plastica. In alcuni
casi, ove possibile, potrebbe favorire materiali alternativi come la carta, ma
la praticità e la leggerezza della plastica difficilmente può essere compensata
dall’aggravio di qualche centesimo di euro. C’è anche chi pensa che questa
misura favorirà la vendita di verdura e frutta confezionata rispetto a quella
sfusa: in realtà, il differenziale di prezzo a livello di packaging è a sfavore
degli imballi rigidi (vaschette in plastica).
PERCHÈ NON POSSO PORTARE LA BUSTA DA CASA? C’è chi
ha chiamato in causa la lobby dei produttori di bioplastiche per motivare la
decisione della Grande distribuzione di vietare al consumatore di portarsi da
casa il sacchetto per alimenti sfusi (verdure, frutta, carne, pesce), così come
avviene con le buste per la spesa. In realtà le ragioni sono altre: in primis
quella legata all’igiene, essendo questa tipologia di sacchetti destinata a
contenere alimenti sfusi non altrimenti imballati; il rischio di contaminazione
è reale ed è stato adombrato in passato anche per le buste per la spesa
riutilizzabili più volte. Poi c’è la questione della taratura delle bilance per
la pesa dei prodotti, che sono settate sui sacchettini distribuiti in prossimità
dei banchi ortofrutta. La legge, pur richiamando conformità alla normativa
sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti nel caso dei
sacchetti ceduti al pubblico, non norma espressamente questo punto. Tanto che il
consumatore potrebbe utilizzare le proprie sporte o retine per gli acquisti nel
negozio sotto casa, come per altro già avveniva in passato. Questa possibilità è
stata ammessa espressamente da una circolare del Ministero dello Sviluppo
economico, in attesa del pronunciamento del dicastero della Sanità. Tecnicamente
è possibile estendere questa pratica anche a livello GDO, come dimostra il caso
della Coop Svizzera con le sporte Multi-Bag.
FAVORIRÁ i PRODUTTORI DI BIOPLASTICHE? Senza
dubbio, ma in fondo potrebbe essere utile - a livello di sistema paese -
favorire un’industria nazionale con prospettiva di crescita rispetto ad un
prodotto - il sacchetto di polietilene - che può essere acquistato in ogni
angolo del pianeta a prezzi di commodities. Va anche detto che Novamont non è
l’unica azienda a produrre bioplastiche per film, anche se è il principale
fornitore di polimeri biobased e compostabili in Italia. Uno dei competitor -
solo per citare il più noto - è il gruppo tedesco BASF.
MA QUANTO VALE IL MERCATO? Non esiste (ancora) uno
studio specifico sul mercato italiano dei sacchetti ultraleggeri per il
confezionamento di alimenti sfusi, ma la società di consulenza Plastic Consult -
che da anni monitora il settore delle materie plastiche e, più recentemente,
l'evoluzione dei sacchetti monouso in plastica - stima che il consumo si attesti
tra 20mila e30mila tonnellate annue tra polietilene e bioplastiche.
COSA DICE LA LEGGE? Come indicato dalla
legge 123/2017 del 13 agosto scorso, dal 1° gennaio 2018 dovranno essere
biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 i sacchetti
ultraleggeri – con spessore inferiore a 15 micron - utilizzati per il
confezionamento di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio
primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria. Oltre
ad essere idonei per l’uso alimentare, con l’anno nuovo i sacchetti dovranno
avere un contenuto minimo di materia prima rinnovabile (secondo EN 16640:2017)
pari ad almeno il 40%, che salirà al 50% a partire da gennaio 2020 e al 60% dal
2021. La nuova norma impone anche che i sacchetti per ortofrutta, così come gli
shopper, non possano essere ceduti a titolo gratuito e che il prezzo di vendita
risulti dallo scontrino o dalla fattura di acquisto. Inoltre, sui sacchetti
dovranno essere apposti elementi identificativi del produttore e diciture idonee
ad attestare il possesso dei requisiti di legge. La sanzione per chi
contravviene alla norma, violando anche solo uno dei requisiti cumulativi, parte
da 2.500 e può arrivare fino a 100.000 euro se la violazione del divieto
riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il loro valore è
superiore al 10% del fatturato del trasgressore. Ma, va ricordato, la sanzione
riguarda solo distributori ed esercenti, non il consumatore trovato in possesso
di una borsa fuori norma.
La tassa sui sacchetti di plastica fa
ricca la manager renziana. Fregatura al supermercato. Oltre la nomina pubblica
Catia Bastioli guida pure la ditta che fabbrica l'80% delle buste bio,
scrive Giuseppe Marino, Domenica 31/12/2017 su “Il Giornale", ripreso in parte
da Affari Italiani. L'obbligo di comprarli scatta da domani, ma nei supermercati
si respira già il malumore dei clienti per la «tassa sui sacchetti». Quel che
non è ancora chiaro a chi fa la spesa, è chi incasserà i proventi della nuova
subdola imposta. Per capire chi in queste ore sorride al pensiero dei sacchetti
a pagamento bisogna mettere insieme alcuni fatti, qualche sospetto e un numero
impressionante di coincidenze. Che hanno una data d'inizio: 3 agosto 2017. È il
giorno in cui viene approvato in commissione, con voto compatto del gruppo del
Pd, l'emendamento che introduce il balzello. In pieno clima di ferie il
Parlamento sente l'esigenza di accelerare la norma infilandola in una legge che
c'entra ben poco, il Dl Mezzogiorno. Col paradosso che in un provvedimento che
dovrebbe portare sviluppo al sud compare un emendamento, firmato dalla deputata
Dem Stella Bianchi, i cui frutti saranno goduti molto più a Nord, e precisamente
in Piemonte. Vedremo dopo per quali strade. Prima è meglio dare un'occhiata a
come è stato congegnato l'emendamento. Da una parte si impone il divieto di
usare i sacchetti ultraleggeri di plastica, quelli che servono a pesare la
frutta o a incartare formaggi e salumi. Fin qui è l'attuazione di una direttiva
europea che ha uno scopo condivisibile, ridurre il consumo di plastica e il suo
impatto ambientale rendendo obbligatori i sacchetti con almeno il 40% di
componente biodegradabile. Il Pd aggiunge però un altro meccanismo diabolico: ai
supermercati è vietato regalarli ai clienti, pena una multa salatissima, fino a
100mila euro. Una misura spacciata per incentivo a ridurre il consumo di
sacchetti che, pur biodegradabili, sono per più di metà ancora composti di
plastica. Eppure il fine nobile della sanzione durissima è completamente
vanificato da un'altra norma: è vietato riciclare i sacchetti. Né, per motivi
igienici e di taratura delle bilance, è possibile portarsi da casa borse o
contenitori di tipo diverso che finiscano a contatto diretto con gli alimenti e
con le bilance. Dunque, se non posso portarmeli da casa e non ho altre
alternative che usare quelli forniti dal supermercato, il disincentivo del
pagamento, obbligatorio per legge, non può scoraggiare il consumo. I dirigenti
di alcune catene di supermercati, sentiti dal Giornale, confermano i dubbi sul
meccanismo cervellotico e sugli effetti perversi. E allora, chi ci guadagna? La
norma sgrava la grande distribuzione, che in Italia conta un player storicamente
legato alla sinistra, la Coop, dal costo degli shopper, riversandolo sul
cliente. Ma non è poi un grande vantaggio, perché i negozi dovranno fronteggiare
la rabbia dei clienti. C'è anche perplessità sulla scelta di non regolamentare
il prezzo dei bio-sacchetti che, essendo un bene ormai obbligatorio per legge, è
esposto a possibili speculazioni sul prezzo. Gli unici ad applaudire
pubblicamente la norma sono i vertici di Assobioplastiche, il cui presidente,
Marco Versari, è stato portavoce del maggiore player del settore, la Novamont,
già nota per aver inventato i sacchetti di MaterBi, il materiale biodegradabile
a base di mais. E infatti l'azienda di Novara sul suo sito, senza ironia,
pubblica un sondaggio secondo cui i consumatori italiani sarebbero in
maggioranza contenti di pagare. Intorno a Novamont si concentrano altre
coincidenze. L'amministratore delegato è Catia Bastioli, una capace manager che
ha incrociato più volte la strada del Pd e di Renzi. Nel 2011 partecipa come
oratore alla seconda edizione della Leopolda, quella in cui esplode il fenomeno
Renzi. Molti degli ospiti di quell'evento oggi occupano poltrone di nomina
politica. E Catia Bastioli non fa eccezione: nel 2014, pur mantenendo l'incarico
alla Novamont, viene nominata presidente di Terna, colosso che gestisce le reti
dell'energia elettrica del Paese. Con i buoni uffici del Giglio magico, si dice
all'epoca. A giugno 2017 Mattarella la nomina cavaliere del lavoro. L'azienda
che guida è l'unica italiana che produce il materiale per produrre i sacchetti
bio e detiene l'80% di un mercato che, dopo la legge, fa gola: inizialmente i
sacchetti saranno venduti in media a due centesimi l'uno. Le stime dicono che ne
consumiamo ogni anno 20 miliardi. Potenzialmente dunque, è un business da 400
milioni di euro l'anno. Il 15 novembre scorso Renzi ha fatto tappa con il treno
del Pd proprio alla Novamont. Ha incontrato i dirigenti a porte chiuse e
all'uscita ha detto ai giornalisti: «Dovremo fare ulteriori sforzi per
valorizzare questa eccellenza italiana». Promessa mantenuta.
Sacchetti frutta a pagamento, parla Catia
Bastioli, la produttrice assediata: «Brevetto nostro».
L’amministratrice delegata Novamont: «Vantaggi personali e favori politici? No,
è una tecnologia unica al mondo», scrive Fabio Savelli il 3 gennaio 2017 su “Il
Corriere della Sera”. «Forse avremmo dovuto investire altrove. Per trasformare
impianti vecchi in gioielli nella produzione di granuli da amido di mais e oli
naturali. Avremmo dovuto evitare di metterci 500 milioni, spendere risorse in
ricerca per brevettare una tecnologia senza eguali. Avremmo dovuto evitare di
assumere personale qui, nel nostro Paese». Catia Bastioli, amministratrice
delegata del gruppo Novamont, è furibonda. La polemica del costo scaricato su
chi fa la spesa per i sacchetti contenitori di frutta e verdura la trova
sconcertata. Novamont realizza il cosiddetto Mater-Bi, la materia prima con la
quale i produttori, circa 150 aziende in tutta Italia, realizzano sacchetti
biodegradabili ultraleggeri.
L’accusa che le muovono è che la scelta introdotta
dal governo di far pagare i sacchetti sia un regalo a lei che è a monte della
filiera della bioplastica.
«La ritengo una tesi oltraggiosa. Vergognosa. Che
si possa connotare politicamente la volontà del governo di recepire una
direttiva comunitaria denota a che punto siamo arrivati. Fare carne da macello,
per finalità prettamente elettorali, di un brevetto nostro e di una tecnologia
patrimonio per il Paese a livello mondiale, offende il lavoro di questi ultimi
venti anni».
Lei però ricopre la carica di presidente di Terna.
Una nomina al vertice di una società a controllo pubblico arrivata quando al
governo c’era Matteo Renzi. Non può nascondere la vicinanza all’ex premier.
«Ho accettato quella nomina dopo grandi
perplessità. Me l’hanno chiesto più volte. Ero scettica. Col senno di poi sono
orgogliosa di quello che abbiamo costruito. Ho compreso la necessità di una
contaminazione tra energia, chimica, agricoltura. È la rivoluzione dell’economia
circolare».
Ammetterà che questa misura la avvantaggia.
«Questo è un settore che sta crescendo. Ha
cominciato la Francia a permettere l’uso degli shopper biodegradabili nel 2011.
Perché sono riciclabili nella raccolta dell’umido. I nostri materiali sono in
grado di creare un compost con l’organico in grado di concimare i terreni. Senza
disperderlo nelle discariche, con un costo ambientale altissimo. Di smaltimento
e di produzione di anidride carbonica».
Caleo (PD): “Io padre della norma sui
sacchetti, la rivendico. Non conoscevo la Novamont”,
scrive il 24 Mattino il 3 gennaio 2018 su "Tiscali News". "Io mi aspetterei dai
commentatori su questa norma un inchino e un saluto importante". Rivendica
complimenti, ai microfoni di Luca Telese e Oscar Giannino, nel corso della
trasmissione 24 Mattino, Massimo Caleo, senatore del Pd e padre della norma sui
sacchetti biodegradabili a pagamento. "Ho fatto quest'emendamento per il
semplice motivo che era giusto proseguire su quella strada lì", continua, "io
non conoscevo nessun dirigente. So chi è Novamont ma all'epoca, mi creda, io non
conoscevo nessun dirigente di quest'azienda", dice rispondendo alle domande di
Telese e Giannino, sui rapporti del Pd con l'azienda, titolare del brevetto più
diffuso di sacchetti biodegradabili. "Quindi non sapeva che Catia Bastioli - la
dirigente di quest'azienda - è una delle relatrici della Leopolda?", insiste
Luca Telese. "Non la butti in politica", risponde Caleo, "l'azienda che voi mi
dite l'ho conosciuta dopo aver fatto l'emendamento e credo sia una verità
assoluta. E siccome siamo in libero mercato credo che sia importante, se
vogliamo andare in questa direzione, il mercato si allarghi e non si restringa".
Ma il costo, intanto, è giusto? Per Caleo sì: "Sono d'accordo che non bisogna
esagerare... ma uno o due centesimi credo che sia il valore giusto, non è una
tassa". Qualcosa si può migliorare, però: "Se la grande distribuzione - io
l'invito che faccio è questo - volesse regalarli ai propri clienti o anche il
singolo commerciante, ben venga ci mancherebbe altro", aggiunge il senatore per
cui questa è dunque "una norma di buonsenso, civile che premia l'innovazione e
anche l'intuizione che anche questo Paese ha".
I due centesimi che valgono meno di un
principio. Due centesimi per le buste biodegradabili.
Poca cosa: cinque euro in un anno se ne vengono consumate 250. Ma c'è un
principio che vale molto di più. e che non andava venduto per 0,02 euro, scrive
Lucio Marziale il 3 gennaio 2018 su "Alessioporcu.it. La normativa sui sacchetti
compostabili costituisce la “bustina al tornasole” della sinistra ambientalista
italiana e dei disastri che sta provocando. Fino al 31 Dicembre 2017, si poteva
imbustare la frutta e la verdura in sacchetti di plastica non biodegradabile e a
costo zero. Dal 1 Gennaio 2018, giustamente è stato previsto l’imbustamento in
sacchetti compostabili, ma incredibilmente: È stato previsto l’obbligo di usare
tali sacchetti, senza lasciare la scelta di servirsi di buste e retine proprie e
riutilizzabili, come avviene ormai da tempo per le classiche buste della spesa.
E’ stato imposto l’obbligo di pagare tali sacchetti: quindi mentre prima i
contenitori inquinanti erano gratis, adesso i contenitori biodegradabili e
compostabili sono a pagamento! Il problema non sono i due centesimi, pari a 5
euro all’anno se si ipotizza un uso di 250 sacchetti all’anno. Il problema è che
le normative che nascono illiberali producono effetti devastanti, e questa
problematica -solo apparentemente minore- riassume tutta una cultura autoritaria
ed autoreferenziale di un certo ambientalismo di sinistra, che sta provocando
danni devastanti innanzitutto all’ambiente e in special modo alla sinistra. I
comportamenti ritenuti virtuosi vengono imposti, e soprattutto tassati. Vale per
le inutili e ingenti somme impiegate a disinquinare siti come la Valle del
Sacco, e vale per quei protocolli internazionali come Kyoto, che si traducono
solo in ulteriore tassazione per le imprese del mondo occidentale, le quali già
investono autonomamente somme ingenti nella ricerca e nello sviluppo di fonti
energetiche alternative e in accorgimenti tecnico-scientifici che hanno ridotto
in maniera drastica i livelli di inquinamento. La cultura pseudo ambientalista,
invece, predica il catastrofismo, perché ha bisogno di incutere terrore per
garantirsi posizioni ben retribuite di autoreferenziale attività pseudo
scientifica “in difesa dell’ambiente”, nelle Università e negli Istituti di
Ricerca finanziati con le tasse “ambientali” imposte dalla medesima cultura
“pseudo ambientalista”. Questa deriva va fermata al più presto, e l’ambiente
deve tornare ad essere il motore della ricerca scientifica e della sua
applicazione industriale, con la detassazione e la gratuità dei comportamenti
virtuosi, e non con la imposizione di ulteriori e inaccettabili balzelli e
gabelle. Anche se di due centesimi.
Sacchetti biodegradabili. Arrigoni: tassa
“ambientalista” inaccettabile! Il senatore lecchese della Lega Nord: si tratta
di un inganno del Governo, scrive il 3 gennaio 2018
"Resegoneonline.it". “Ho fortissimi dubbi sulla reale sostenibilità delle
attuali bioplastiche, ma ho la certezza che non risolvano problemi come la
dispersione dei rifiuti in terra e nei mari (littering), e che questo sia un bel
business fatto sulla pelle dei consumatori, per la gioia della Novamont cara al
PD e al parolaio Renzi”. Così interviene il senatore lecchese della Lega Paolo
Arrigoni, membro della Commissione parlamentare Ambiente e Territorio, sulla
norma che dall’1 gennaio ha imposto ai consumatori italiani che acquistano
frutta e verdura di confezionarle in sacchettini di plastica biodegradabile
rigorosamente usa e getta e a pagamento. “La direttiva comunitaria, recepita con
un emendamento al Decreto legge Mezzogiorno, consentiva di esonerare
dall'obbligo di compostabilità gli involucri destinati agli alimentari, ma in
Italia per volere del Governo Gentiloni dal primo gennaio è scattato nei
supermercati l’obbligo per legge all’uso di costosissimi sacchetti “naturali”
per l’acquisto di frutta e verdura; peraltro preceduto dall’introduzione nelle
mense di molte scuole (come quelle di Milano) dello stop all’uso di piatti e
bicchieri in plastica tradizionale a favore di quelli realizzati in materiali
compostabili, con significativi aumenti dei costi (solo per le scuole di Milano
sono stati stimati almeno 300 mila euro in più all’anno…)”. “Il risultato? – fa
notare il Senatore - Nonostante in Italia la plastica grazie alla raccolta
differenziata abbia ormai raggiunto percentuali elevate di recupero e riciclo,
si spinge ora sempre più per sostituirla con plastica biodegradabile, molto più
costosa, di precaria funzionalità e che crea problemi di funzionamento a
numerosi impianti di compostaggio!”
Un Paese nel sacchetto,
scrive Anna Lombroso per "Il Simplicissimus" il 2018/01/03. Con sollievo leggo
della crisi dei centri commerciali, coi loro smisurati parcheggi ormai deserti,
i lungi corridoi espositivi polverosi, dell’abbandono in cui versano le nuove
cattedrali dove si officiava la liturgia del consumo, che avevano sostituito
piazze e corsi di paese dove la gente si incrociava e si dava appuntamento in
scenari di cartapesta e stagioni artificiali e sempre uguali. E allo stesso modo
non mi piacciono i supermercati: meglio il mercato di rione scomparso, perfino
la botteguccia sotto casa, sguarnita e cara come bulgari dove con la serranda
mezza abbassata implori il cingalese ermetico di darti le sei uova per una
frittata d’emergenza, di gran lunga preferibili a quella colonna sonora di
annunci e musiche ambient, a quelle luci che confondono, a mappe incerte che
rendono irrintracciabili prodotti e merci tra meste coppie con lei che vieta
al marito l’acquisto di salamini punendo l’eterno fanciullino che risiede in
ogni maschio, bimbi che strepitano e il panorama avvilente di carrelli colmi di
4 salti in padella e patatine surgelate raccomandate da masterchef
acchiappacitrulli. E adesso ci andrò ancora più malvolentieri: dall’1 gennaio è
entrata in vigore la norma inquattata nel Il decreto Mezzogiorno approvato in
agosto, grazie alla quale quei sacchetti leggerissimi di plastica in cui si
raccolgono, si pesano e si prezzano i prodotti venduti sfusi come frutta,
verdura o affettati devono essere di plastica biodegradabile, devono essere
monouso, devono essere a pagamento a differenza che in gran parte degli altri
Paesi europei. Il provvedimento avrebbe una duplice vocazione: quella
pedagogica, per stimolare i consumatori a comportamenti più sostenibili, e
quella di dare sostegno alle imprese italiane del settore, penalizzate dalla
massiccia importazione di shopper da partner europei come Francia e Spagna. E ad
una in particolare, ma si tratta certamente di una malignità, che agisce in
regime di monopolio, Novamont, e che fa riferimento a un soggetto ben
identificato che gravita con entusiasmo intorno alla cerchia renziana, in veste
di testimonial e sponsor. Ora non c’è da avere dubbi che la decisione di far
pagare ai consumatori i sacchetti biodegradabili per la spesa, compresi perfino
quelli delle farmacie, nasca da un intento esplicitamente speculativo,
altrimenti sarebbe la prima volta che un governo dei tanti che si sono
avvicendati non assecondi e appaghi gli avidi appetiti di lobby e imprese a
cominciare da eccellenti norcini fornitori delle real case. E dovremmo esserci
abituati. Ma non si è mai abbastanza assuefatti alla ipocrita speculazione
morale che ben i colloca nel contesto della necessaria e doverosa ubbidienza ai
diktat europei, pera poco sentiti nel caso di tortura, norme antiriciclaggio
e corruzione, traffico di rifiuti anche a mezzo navi. È che la pretesa e la
rivendicazione di tenaci convinzioni ecologiche da parte del partito unico suona
davvero come un’offesa per chiunque si senta in bilico su una fragile palla
appesa e pericolate, e in un paese assoggettato all’impero delle puzze e dei gas
in guerra con popoli e col pianeta che li ospita, con governi che hanno
licenziato leggi in favore di condoni infausti per il territorio, che hanno
bloccato da anni qualsiasi seria misura per il contenimenti del consumo di
suolo, che scelgono ostinatamente di investire in grandi e pesanti opere invece
di mobilitare risorse per la salvaguardia e il risanamento idrogeologico e per
gli interventi antisismici, che autorizzano le maledette trivelle. Che
concedono licenze premio per lo sfruttamento delle spiagge con annesse
costruzioni mai abbastanza effimere, manomettono le regole nazionali e europee
con l’infame Decreto legislativo 104, che rende la valutazione di impatto
ambiente un affare contrattato tra imprese e governo. Coi sindaci del Pd in
prima fila nella cura del ferro perfino sotto le piazze di Firenze e le regioni
che come in Sardegna approvano il maxi aumento di volume per hotel e
lottizzazioni sul mare, a imitazione del piano casa di Berlusconi. Perfino in
questo caso l’ambientalismo di governo si mostra per quello che è. Una montatura
retorica a copertura di opachi interessi privati: in barba ai capisaldi
ecologici del riuso e del riciclaggio, i sacchetti sono monouso e – se resistono
– possono essere usati unicamente per la raccolta domestica dell’umido con gli
esiti che qualsiasi regine dalla casa conosce. Ci si accontenta di poco. Gli
shopper dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo le norme UNI EN
13432 con un contenuto di materia prima rinnovabile di solo il 40%, che
diventerà del 50% dal 2020 e del 60% dal 2021, (proprio quella dei sacchetti
Novamont?). Sicché viene meno gran parte dell’obiettivo ambientale: la loro vita
è lunghissima e pure questi come quelli dell’ancien règime ce li ritroveremo
sull’Everest o a soffocare gli atolli tra qualche secolo, ammesso che la terra e
noi resistiamo a certi ambientalismi. Un gran numero di anime belle è molto
attivo sul web, chi per raccontarci delle sue abitudini virtuose grazie a
acquisti equi nel mercatino solidale, chi con la sporta di rete nel biologico a
km zero e perfino chi con l’orticello sul terrazzo dell’attico. Poi ci sono
quelli che insorgono: vi siete bevuti tutte le baggianate e avete subito tutti
gli affronti inferti a lavoro, scuola, pensioni, cure e diritti e adesso
improvvisamente vi svegliate per un furtarello che vi costerà 7 euro l’anno?
Sarò pure un’arcaica anarchica arruffona, ma in mancanza d’altro vedo come un
segnale positivo anche i fermenti per il pane e l’assalto ai forni, considero un
risveglio modesto ma non trascurabile quello di gente che dopo essere stata
convertita in merce da essere comprata e venduta, con l’unico superstite
diritto, quello di consumare, non ha più i beni per esercitarlo e magari si
ricorda degli altri perduti, espropriati. E si arrabbia.
Sacchetti frutta biodegradabili, il
paradosso della balena. Piangiamo se muore, non
spendiamo per salvarla. Siamo pronti a tutto per costringere la Cina a inquinare
di meno, ma quando tocca a noi le cose cambiano. La soluzione è un patto tra
ambientalismo e modernità, scrive Antonio Pascale il 3 gennaio 2018 su "Il
Corriere della Sera". L’ambientalismo esiste perché c’è benessere. O meglio
esiste laddove è arrivata la modernità. Ambientalismo e modernità non dovrebbero
quindi essere nemici, sono gemelli, due facce della stessa medaglia. Entrambi si
preoccupano di introdurre buone pratiche per risolvere alcune questioni molto
seccanti. La fame, la malattia, la carestia sono tra queste e se per esempio ora
avevamo lo stomaco vuoto di certo non avremmo dato credito né alle battaglie né
al buon senso ecologista. Il diciannovesimo secolo è stato meraviglioso, ripete
spesso Robert Fogel. Come meraviglioso? Due guerre e un olocausto. Si, vero ma
siamo riusciti e con poche innovazioni a sconfiggere la fame la malattia e le
carestie. Dunque, con un corpo meglio nutrito e con buone pratiche igieniche
abbiamo raddoppiato l’aspettativa di vita e triplicato la popolazione (nei primi
anni del Novecento eravamo due miliardi), abbassato in gran parte del mondo e
quasi a zero la mortalità infantile. Si segnalano poi incoraggianti progressi
per la mortalità delle donne per parto (in discesa) e per l’alfabetizzazione
femminile (in alcuni Paesi africani è il doppio di quella maschile). Se non è
progresso questo allora tocca metterci d’accordo sulla parola. Il benessere ha
dato spazio all’ecologismo, se hai fame bruci le foreste per coltivare, se sei
molto povero, se troppo ricattato dalle contingenze per permetterti uno sguardo
lungimirante. Quindi vista la fratellanza è un peccato che spesso
l’atteggiamento ecologista sembri (culturalmente) fondato sui bei tempi andati,
oppure, nei casi estremi, esprima una sorta di disgusto per l’uomo: l’uomo è
corrotto e la sua impronta ecologica ci distruggerà (che poi forse distruggerà
la specie umana ma non la natura nel suo complesso). Da questo atteggiamento
derivano alcune fisime, calcoli ad libitum su quanto inquiniamo e su quale
pratiche adottare per salvaguardare il nostro habitat. E toccherà prima o poi
ammetterlo, spesso l’atteggiamento ecologista è normativo sì ma con il nostro
vicino. Quando tocca a noi le cose cambiano. Voglio dire, spinti come siamo dal
furore vogliamo risolvere tutto è subito, purificare ogni luogo senza tenere a
mente la complessità geopolitica e altri e importanti fattori. Cosi andiamo in
Cina per annunciatore agli inquinatori l’aumento di 0,8 gradi della temperatura
globale, spingiamo per norme e limiti e ci sentiamo rispondere: d’accordo ma
l’avete fatto voi. Vi perdoniamo perché non lo sapevate ma ora dateci la
possibilità di raggiungere il benessere così che possiamo impegnarci nelle
pratiche ambientaliste. Ambientalismo e modernità sono nati insieme e insieme
dovrebbero affrontare le sfide. Invece notiamo sempre più spesso che il
benessere ci isola dal mondo e l’ambientalismo pure. Va di moda o rischia di
diventare di tendenza un atteggiamento schizofrenico. Piangiamo per varie ed
esotiche specie di animali o per le balene vittime della plastica ma ci facciamo
afferrare per pazzi qualora ci accorgiamo che il sacchetto bio costa (nemmeno
tanto). Salviamo il mondo, la nostra specie o il nostro portafoglio? Ecologismo
e modernità devono siglare un patto. Un mondo più pulito (è un mondo più pulito
è di fondamentale importanza) necessità di innovazione e ricerca. Il fatto è che
entrambe non solo costano ma richiedono collaborazione su vasta scala. La mole
di problemi da affrontare è enorme e profonda è la specificità degli stessi,
dunque un solo uomo al comando trionfo di buoni propositi pubblicitari non serve
allo scopo. Come non serve un ecologismo sempre contro o che si affida a
strumenti poco efficaci. Siamo 7, 4 miliardi e presto arriveranno un miliardo di
africani e un miliardo di asiatici. Cambierà tutto, e se andrà meglio o peggio
dipenderà da noi ma meglio saperlo subito: un nuovo mondo possibile sì certo ma
costa.
Eco-tasse. E siamo sempre più poveri e
meno liberi, scrive Nicola Porro, Il Giornale 31
dicembre 2017. Siamo arrivati alla tassa sul sacchetto di plastica. Più che al
ridicolo, di cui i nostri governanti si rendono poco conto, siamo scesi
nell’inferno della schiavitù economica. Un tempo, ahinoi molto lontano, le
imposte venivano intese come un corrispettivo per alcuni servizi che lo Stato
forniva. La tutela dei più deboli era uno di questi. Era l’imposta di Luigi
Einaudi, ma anche del nostro Francesco Forte. Poi è arrivata la tassazione
punitiva: togliere ad alcuni per dare ad altri. Il mito della giustizia sociale
e della redistribuzione. Un’imposta del tutto velleitaria e fallimentare: le
tasse sono altissime, così come il numero dei poveri. Si è arricchito solo
l’intermediario, cioè lo Stato. Non funzionando più l’inganno della
redistribuzione, si persegue oggi il fine «etico» dell’imposta. Il consumo viene
tassato non per fare cassa (che è il vero motivo), ma per il nostro bene, per il
futuro green del pianeta. La grande, mostruosa, prova si è avuta con gli
incentivi alle energie rinnovabili: sedici miliardi di euro che passano ogni
anno dalle tasche delle famiglie italiane a pochi soggetti incentivati. In
termini spiccioli su 500 euro di bolletta elettrica annua per una famiglia tipo
italiana, la bellezza di 139 euro sono rappresentati da oneri per la cosiddetta
sostenibilità. Cerchiamo di essere più chiari: senza pannelli e pale eoliche,
oggi gli italiani sopporterebbero una spesa annuale per l’elettricità di 360
euro invece che 500. Si tratta di una tassa occulta che porgiamo, senza
accorgercene, sull’altare di un mondo green. Il prossimo passo, non così
lontano, sarà di bastonare fiscalmente gli alimenti che il Soviet statale
stabilirà dannosi per la nostra salute. L’ipocrisia non vale solo per l’ambiente
e la salute. Abbiamo introdotto, praticamente unici in Europa, la Tobin tax. Con
l’idea che le speculazioni finanziarie, Soros, Paperon de’ Paperoni e Gordon
Gekko, siano dei cattivoni. Il risultato è che le Finanze di Roma hanno
incassato un quinto del previsto, ma in compenso abbiamo ucciso i nostri
intermediari finanziari e Londra e Francoforte hanno disintermediato l’Italia,
facendo affari dove la tassazione sulle speculazioni non ci sono. La morale è
che i nostri ricavi (stipendi, redditi da lavoro autonomo) restano stabili
mentre le nostre spese legate alla partecipazione alla comunità statale
crescono, con il risultato di renderci tutti più poveri e meno liberi. Ieri era
per liberare i più poveri dal disagio, oggi per consegnare un pianeta più pulito
ai nostri figli. Balle.
Ancora tasse. Lo Stato ci spreme come gli
agrumi, scrive Michel Dessi, il 30 dicembre
20127 su "Il Giornale".
Ora ci fanno pagare anche i sacchetti per la
frutta e la verdura. Si, avete capito bene, proprio quelli che utilizziamo per
le mele, le banane, i carciofi, le cipolle, le carote… Quei sacchetti ci
verranno addebitati sulla spesa di ogni giorno. Incredibile, ma vero. Dal primo
gennaio tutto cambia e nulla cambia: le tasse aumenteranno e i poveri rimarranno
poveri. D’altronde, cosa potevamo aspettarci da questo governo appena sciolto se
non la fregatura? In Italia troppe cose non vanno per il verso giusto. Troppi
cittadini Italiani sono stati abbandonati. Rita ne è un esempio, è costretta a
vivere con una misera pensione di 260 euro. DUECENTOSESSANTA, l’unica sua
entrata. Rita è affetta da mille patologie, eppure è costretta a marcire nella
sua povera casa popolare. Dimenticata da tutti. Ha provato a chiedere aiuto allo
Stato ma, chiaramente, non ha riposto. Non sa più a chi rivolgersi, è disperata.
Per lei non esiste il pranzo o la cena, mangia quello che le capita, quello che
le viene offerto. Ormai è abituata a razionare il poco cibo che riceve ad
intermittenza dalla Caritas parrocchiale: una piccola busta (tassata) con un
pacco di pasta, dei pomodori pelati (se le va bene), pane raffermo e qualche
pacco di biscotti. La carne? Non la mangia da mesi e il frigorifero resta vuoto.
Eppure a nessuno interessa, neanche al sindaco del suo piccolo paese alle
pendici dell’Aspromonte, Cittanova. Come lei tanti altri, anche troppi. La
povertà aumenta sempre di più e loro cosa pensano di fare? Aumentare le tasse.
Bollette, pedaggi, trasporti, Rc Auto… Tutto questo nonostante i servizi non
funzionino. Ne è un esempio la Messina – Palermo, la mulattiera delle
autostrade. Il pedaggio costa dieci euro e dieci centesimi. Un po’ troppo per
un’autostrada dissestata, piena di buche e trappole mortali. Quando piove si
trasforma in un torrente in piena e il rischio per gli automobilisti è sempre
dietro la curva. Ma come si può chiedere così tanto ai cittadini? Con quale
barbaro coraggio? Non riesco a darmi una risposta. Lo stesso vale per i
trasporti, soprattutto al Sud. Qui potremmo prendere come esempio la Calabria. I
treni, quando va bene, sono quasi sempre in ritardo. Lo Stato ci spreme proprio
come gli agrumi che mettiamo ogni giorno nel sacchetto.
"PADRI DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA
NOSTRA ROVINA.
Lettera da Crispi a Garibaldi - Caprera. Torino, 3
febbraio 1863.
Mio Generale! Giunto
da Palermo, dove stetti poco men che un mese, credo mio dovere dirvi qualche
cosa della povera isola che voi chiamaste a libertà e che i vostri successori
ricacciarono in una servitù peggiore di prima.
Dal nuovo regime quella popolazione nulla ha
ottenuto di che potesse esser lieta. Nissuna giustizia, nissuna sicurezza
personale, l'ipocrisia della libertà sotto un governo, il quale non ha
d'italiano che appena il nome. Ho visitate le carceri e le ho trovate piene
zeppe d'individui i quali ignorano il motivo per il quale sono prigionieri. Che
dirvi del loro trattamento? Dormono sul pavimento, senza lume la notte, sudici,
nutriti pessimamente, privi d'ogni conforto morale, senza una voce che li
consigli e li educhi onde fosser rilevati dalla colpa.
La popolazione in massa detesta il governo
d'Italia, che al paragone trova più tristo del Borbonico. Grande fortuna che non
siamo travolti in quell'odio noi, che fummo causa prima del mutato regime! Essa
ritien voi martire, noi tutti vittime della tirannide la quale viene da Torino e
quindi ci fa grazia della involontaria colpa. Se i consiglieri della Corona non
mutano regime, la Sicilia andrà incontro ad una catastrofe.
E' difficile misurarne le conseguenze, ma esse
potrebbero essere fatali alla patria nostra. L'opera nostra dovrebbe mirare ad
evitare cotesta catastrofe, affinchè non si sfasci il nucleo delle provincie
unite che al presente formano il regno di Italia. Con le forze di questo regno e
coi mezzi ch'esso ci offre, noi potremmo compiere la redenzione della penisola e
occupar Roma. Sciolto cotesto nucleo, è rimandata ad un lontano avvenire la
costituzione d'Italia. Della vostra salute,
alla quale tutti c'interessiamo, ho buone notizie, che spero sempre migliori. Di
Palermo tutti vi salutano come vi amano.
Abbiatevi i complimenti di mia moglie e voi continuatemi il vostro affetto e
credetemi. Vostro ora e sempre. F. Crispi.
La verità è
rivoluzionaria. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono
incommensurabili. Non credo di aver fatto del male. Nonostante ciò, non rifarei
oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate,
essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. Giuseppe
Garibaldi (da una lettera scritta ad Adelaide Cairoli, 1868)
Cronologia moderna
delle azioni massoniche e mafiose.
27 marzo 1848 - Nasce
la Repubblica Siciliana. La Sicilia ritorna ad essere indipendente, Ruggero
Settimo è capo del governo, ritorna a sventolare l'antica bandiera
siciliana. Gli inglesi hanno numerosi interessi nell'Isola e consigliano al
Piemonte di annettersi la Sicilia. I Savoia preparano una spedizione da affidare
a Garibaldi. Cavour si oppone perchè considera quest'ultimo un avventuriero
senza scrupoli (ricordano impietositi i biografi che Garibaldi ladro di cavalli,
nell' America del sud, venne arrestato e gli venne tagliato l'orecchio destro.
Sarà, suo malgrado, capellone a vita per nascondere la mutilazione) [Secondo
altre fonti l’orecchio gli sarebbe stato staccato con un morso da una ragazza
che aveva cercato di violentare all’epoca della sua carriera di pirata,
stupratore, assassino in America Latina, NdT]. Il nome di Garibaldi, viene
abbinato altresì al traffico di schiavi dall'Africa all'America. Rifornito di
denaro inglese da i Savoia, Garibaldi parte per la Sicilia.
11 maggio 1860 - Con la
protezione delle navi inglesi Intrepid e H.M.S. Argus, Garibaldi sbarca a
Marsala. Scrive il memorialista garibaldino Giuseppe Bandi: I mille vengono
accolti dai marsalesi come cani in chiesa! La prima azione mafiosa è contro la
cassa comunale di Marsala. Il tesoriere dei mille, Ippolito Nievo lamenta che si
trovarono pochi spiccioli di rame. I siciliani allora erano meno fessi! E'
interessante la nota di Garibaldi sull'arruolamento: "Francesco Crispi arruola
chiunque: ladri, assassini, e criminali di ogni sorta".
15 maggio 1860 -
Battaglia di Calatafimi. Passata alla storia come una grande battaglia, fu
invece una modesta scaramuccia, si contarono 127 morti e 111 furono messi fuori
combattimento. I Borbone con minor perdite disertano il campo. Con un esercito
di 25.000 uomini e notevole artiglieria, i Borbone inviano contro Garibaldi
soltanto 2.500 uomini. E' degno di nota che il generale borbonico Landi, fu
comprato dagli inglesi con titoli di credito falsi e che l'esercito borbonico
ebbe l'ordine di non combattere. Le vittorie di Garibaldi sono tutte una
montatura.
27 maggio 1860 -
Garibaldi entra a Palermo da vincitore!....Ateo, massone, mangiapreti, celebra
con fasto la festa di santa Rosalia.
30 maggio 1860 -
Garibaldi dà carta bianca alle bande garibaldine; i villaggi sono saccheggiati
ed incendiati; i garibaldini uccidevano anche per un grappolo d'uva. Nino Bixio
uccide un contadino reo di aver preso le scarpe ad un cadavere. Per incutere
timore, le bande garibaldine, torturano e fucilano gli eroici siciliani.
31 maggio 1860 - Il
popolo catanese scaccia per sempre i Borbone. In quell'occasione brillò, per un
atto di impavido coraggio, la siciliana Giuseppina Bolognani di Barcellona Pozzo
di Gotto (ME). Issò sopra un carro un cannone strappato ai borbonici e attese la
carica avversaria; al momento opportuno, l'avversario a due passi, diede fuoco
alle polveri; il nemico, decimato, si diede alla fuga disordinata. Si guadagnò
il soprannome Peppa 'a cannunera (Peppa la cannoniera) e la medaglia di bronzo
al valor militare.
2 giugno 1860 - Con un
decreto, Garibaldi assegna le terre demaniali ai contadini; molti abboccano alla
promessa. Intanto nell'Isola divampava impetuosa la rivoluzione che vedeva
ancora una volta il Popolo Siciliano vittorioso. Fu lo stesso popolo che unito e
compatto costrinse i borbonici alla ritirata verso Milazzo.
17 luglio 1860 -
Battaglia di Milazzo. Il governo piemontese invia il Generale Medici con 21.000
uomini bene armati a bordo di 34 navi. La montatura garibaldina ha fine. I
contadini siciliani si ribellano, vogliono la terra promessagli. Garibaldi,
rivelandosi servo degli inglesi e degli agrari, invia loro Nino Bixio.
10 agosto 1860 - Da un
bordello di Corleone, Nino Bixio ordina il massacro di stampo mafioso di Bronte.
Vengono fucilati l'avvocato Nicolò Lombardo e tre contadini, tra i quali un
minorato! L'Italia mostra il suo vero volto.
21 ottobre 1860 - Plebiscito di annessione della Sicilia al Piemonte. I voti si
depositano in due urne: una per il "Sì" e l'altra per il "No". Intimorendo, come
abitudine mafiosa, ruffiani, sbirri e garibaldini controllano come si vota. Su
una popolazione di 2.400.000 abitanti, votarono solo 432.720 cittadini (il 18%).
Si ebbero 432.053 "Sì" e 667 "No". Giuseppe Mazzini e Massimo D'Azeglio furono
disgustati dalla modalità del plebiscito. Lo stesso ministro Eliot, ambasciatore
inglese a Napoli, dovette scrivere testualmente nel rapporto al suo Governo che:
"Moltissimi vogliono l'autonomia, nessuno l'annessione; ma i pochi che votano
sono costretti a votare per questa". E un altro ministro inglese, Lord John
Russel, mandò un dispaccio a Londra, cosí concepito: "I voti del suffragio in
questi regni non hanno il minimo valore".
1861 - L'Italia impone
enormi tasse e l'obbligo del servizio militare, ma per chi ha soldi e paga,
niente soldato. Intanto i militari italiani, da mafiosi, compiono atrocità e
massacri in tutta l'Isola. Il sarto Antonio Cappello, sordomuto, viene torturato
a morte perchè ritenuto un simulatore, il suo aguzzino, il colonnello medico
Restelli, riceverà la croce dei "S.S. Maurizio e Lazzaro". Napoleone III scrive
a Vittorio Emanuele: "I Borbone non commisero in cento anni, gli orrori e gli
errori che hanno commesso gli agenti di Sua Maestà in un anno”.
1863 - Primi moti
rivoluzionari antitaliani di pura marca indipendentista. Il governo piemontese
instaura il primo stato d'assedio. Viene inviato Bolis per massacrare i patrioti
siciliani. Si prepara un'altra azione mafiosa contro i Siciliani.
8 maggio 1863 - Lord
Henry Lennox denuncia alla camera dei Lords le infamie italiane e ricorda che
non Garibaldi ma l'Inghilterra ha fatto l'unità d'Italia.
15 agosto 1863 -
Secondo stato d'assedio. Si instaura il terrore. I Siciliani si rifiutano di
indossare la divisa italiana; fu una vera caccia all'uomo, le famiglie dei
renitenti furono torturate, fucilate e molti furono bruciati vivi. Guidava
l'operazione criminale e mafiosa il piemontese Generale Giuseppe Govone. (Nella
pacifica cittadina di Alba, in piazza Savona, nell'aprile 2004 è stato
inaugurato un monumento equestre a questo assassino. Ignoriamo per quali
meriti.)
1866 - In Sicilia
muoiono 52.990 persone a causa del colera. Ancora oggi, per tradizione orale,
c'è la certezza che a spargervi il colera nell'Isola siano state persone legate
al Governo italiano. Intanto tra tumulti, persecuzioni, stati d'assedio,
terrore, colera ecc. la Sicilia veniva continuamente depredata e avvilita; il
Governo italiano vendette perfino i beni demaniali ed ecclesiastici siciliani
per un valore di 250 milioni di lire. Furono, nel frattempo, svuotate le casse
della regione. Il settentrione diventava sempre più ricco, la Sicilia sempre più
povera.
1868 - Giuseppe
Garibaldi scrive ad Adelaide Cairoli:"Non rifarei la via del Sud, temendo di
essere preso a sassate!". Nessuna delle promesse che aveva fatto al Sud (come
quella del suo decreto emesso in Sicilia il 2 giugno 1860, che assegnava le
terre comunali ai contadini combattenti), era stata mantenuta.
1871 - Il Governo, con
un patto scellerato, fortifica la mafia con l'effettiva connivenza della
polizia. Il coraggioso magistrato Diego Tajani dimostrò e smascherò questa
alleanza tra mafia e polizia di stato e spiccò un mandato di cattura contro il
questore di Palermo Giuseppe Albanese e mise sotto inchiesta il prefetto, l'ex
garibaldino Gen. Medici. Ma il Governo italiano, con fare mafioso si schiera
contro il magistrato costringendolo a dimettersi.
1892 - Si formano i
"Fasci dei Lavoratori Siciliani". L'organizzazione era pacifica ed aveva gli
ideali del popolo, risolvere i problemi siciliani. Chiedeva, l'organizzazione
dei Fasci la partizione delle terre demaniali o incolte, la diminuzione dei
tassi di consumo regionale ecc.
4 gennaio 1894 - La
risposta mafiosa dello stato italiano non si fa attendere: STATO D'ASSEDIO.
Francesco Crispi, (definito da me traditore dei siciliani a perenne vergogna dei
riberesi) presidente del Consiglio, manda in Sicilia 40.000 soldati al comando
del criminale Generale Morra di Lavriano, per distruggere l'avanzata impetuosa
dei Fasci contadini. All'eroe della resistenza catanese Giuseppe De Felice
vengono inflitti 18 anni di carcere; fu poi amnistiato nel 1896, ricevendo
accoglienze trionfali nell'Isola.
Note di "Sciacca
Borbonica": Sono molti i paesi del mondo che dedicano vie, piazze e strade a
lestofanti e assassini. Ma pochi di questi paesi hanno fatto di un pirata
macellaio addirittura il proprio eroe nazionale. Il 27 luglio 1995 il
giornale spagnolo "El Pais", giustamente indignato per l’apologia di Garibaldi
fatta dall’allora presidente Scalfaro (quello che si prendeva 100 milioni al
mese in nero dal SISDE, senza che nessuno muovesse un dito) nel corso di una
visita in Spagna, così gli rispose a pag. 6: “Il presidente d'Italia è stato
nostro illustre visitante...... Disgraziatamente, in un momento della sua
visita, il presidente italiano si è riferito alla presenza di Garibaldi nel Rio
della Plata, in un momento molto speciale della storia delle nazioni di questa
parte del mondo. E, senza animo di riaprire vecchie polemiche e aspre
discussioni, diciamo al dott. Scalfaro che il suo compatriota [Garibaldi] non ha
lottato per la libertà di queste nazioni come egli afferma. Piuttosto il
contrario". Il 13 settembre 1860, mentre l'unificazione italiana era in pieno
svolgimento, il giornale torinese Piemonte riportava il seguente articolo.
(1): «Le imprese di Garibaldi nelle Due Sicilie parvero sin da allora così
strane che i suoi ammiratori ebbero a chiamarle prodigiose. Un pugno di giovani
guidati da un audacissimo generale sconfigge eserciti, piglia d'assalto le città
in poche settimane, si fa padrone di un reame di nove milioni di abitanti. E ciò
senza navigli e senz'armi... Altro che Veni, Vedi, Vici! Non c'è Cesare che
tenga al cospetto di Garibaldi. I miracoli però non li ha fatti lui ma li fecero
nell'ordine: 1°)-L'oro con il quale gli inglesi comprarono quasi tutti i
generali borbonici e col quale assoldarono 20.000 mercenari ungheresi e slavi e
pagarono il soldo ad altri 20.000 tra carabinieri e bersaglieri, opportunamente
congedati dall'esercito sardo-piemontese e mandati come "turisti" nel Sud, altro
che i 1000 scalcinati eroi...... 2°)-il generale Nunziante ed altri tra
ufficiali dell'esercito e della marina che, con infinito disonore, disertarono
la loro bandiera per correre sotto quella del nemico eccovi servito un piccolo
elenco di traditori al soldo degli anglo-piemontesi, oltre al
Nunziante: Generale Landi, Generale Cataldo, Generale Lanza, Generale Ghio,
Comandante Acton, Comandante Cossovich,ed altri ancora; 3°)-i miracoli li ha
fatti il Conte di Siracusa con la sua onorevolissima lettera al nipote Francesco
II° (lettera pubblicata in un post a parte); 4°)-li ha fatti la Guardia
Nazionale che, secondo il solito, voltò le armi contro il re che gliele avea
date poche ore prima; 5°)-)li ha fatti il Gabinetto di Liborio Romano il quale,
dopo aver genuflesso fino al giorno di ieri appié del trono di Francesco II, si
prostra ai piedi di Garibaldi; 6°)- La quasi totalità della nobiltà siciliana.
Beh, Con questi miracoli ancor io sarei capace di far la conquista, non dico
della Sicilia e del Reame di Napoli, ma dell'universo mondo. Dunque non state a
contare le prodezze di Sua Maestà Garibaldi I. Egli non è che il comodino della
rivoluzione. Le società segrete (la massoneria) che hanno le loro reti in tutto
il paese delle Due Sicilie, hanno di lunga mano preparato ogni cosa per la
rivoluzione. E quando fu tutto apparecchiato si chiamò Garibaldi ad eseguire i
piani [...]. Se non era Garibaldi sarebbe stato Mazzini, Kossuth, Orsini o Lucio
della Venaria: faceva lo stesso. Appiccare il fuoco ad una mina anche un bimbo
può farlo. Di fatto vedete che dappertutto dove giunge Garibaldi la rivoluzione
è organizzata issofatto, i proclami sono belli e fatti, anzi stampati. In questo
modo credo che Garibaldi può tranquillamente fare il giro del mondo a piantare
le bandiere tricolori del Piemonte. Dopo Napoli Roma, dopo Roma Venezia, dopo
Venezia la Dalmazia, dopo la Dalmazia l'Austria, caduta l'Austria il mondo è di
Garibaldi, cioé del Piemonte! Oh che cuccagna! Torino capitale dell'Europa, anzi
dell'orbe terracqueo. Ed i torinesi padroni del mondo!». Dai Savoia agli
Agnelli, da una famiglia di vampiri ad un altra.....per il Sud sempre lo stesso
destino.......dar loro anche l'ultima goccia di sangue. Comunque la Giustizia
Divina arriva sempre........i savoia son finiti nella merda e nel ludibrio, gli
Agnelli nella tomba e nella droga che certamente sarà il mezzo con quale ci
libereremo di questa gente maledetta.
Gli eurobond che fecero l'Unità d'Italia
quando il Regno di Napoli era come la Germania, scrive
Giuseppe
Chiellino il 30 giugno 2012 su “Il Sole 24 Ore”. Il vertice europeo di
fine giugno ha cancellato gli eurobond dall'agenda. Almeno per ora. Angela
Merkel è stata drastica: «Mai finchè sarò viva» aveva detto in pubblico qualche
giorno prima. Chissà se la cancelliera tedesca aveva avuto il tempo di leggere
lo studio di Stéphanie Collet, storica della finanza della Université Libre de
Bruxelles che è andata a spulciare negli archivi delle Borse di Parigi e Anversa
per studiare l'unico precedente assimilabile agli Eurobond: l'unificazione del
debito sovrano dei sette stati che 150 anni orsono, su iniziativa del Piemonte e
sotto tutela di Francia e Inghilterra, costituirono il Regno d'Italia. Nella
storia dello stato moderno è l'esperienza storicamente più vicina al
faticosissimo tentativo di dare maggiore consistenza politica all'Unione
europea, anche attraverso l'integrazione delle politiche economiche e fiscali,
compresi debiti sovrani dei 17 paesi dell'euro. Un precedente prezioso, secondo
la Collet, per cercare di capire – mutatis mutandis - come potrebbero
comportarsi i mercati finanziari di fronte all'unificazione del debito pubblico
dei paesi della zona euro. «Come l'Italia di allora, l'Europa oggi è fatta da
stati eterogenei, con economie di dimensioni e condizioni diverse, che parlano
lingue diverse e hanno sistemi di imposizione fiscale separati» ricorda la
studiosa. Grazie al fatto che anche dopo l'unificazione i titoli del Regno
d'Italia conservarono fino al 1876 l'indicazione della loro origine (per
esempio, ad Anversa le emissioni del Regno delle Due Sicilie erano indicate come
"Italy-Neapolitean") la Collet è riuscita a ricostruire le serie storiche dei
prezzi settimanali tra il 1847 e il 1873. Un lavoro certosino di raccolta
manuale dei dati dagli archivi e dai database originali per capire come si sono
mosse le quotazioni, prima e dopo l'unità, politica ed economica. 25 emissioni
suddivise in quattro gruppi: Regno di Piemonte e Sardegna, Lombardo-Veneto, Due
Sicilie e Stato Pontificio. La prima cosa che balza agli occhi è lo spread
(anche allora!) tra i rendimenti dei diversi gruppi di bond prima e dopo
l'Unità. Quelli del Regno delle Due Sicilie (che erano un quarto del totale)
prima del 1861 pagavano i tassi più bassi: 4,3%, 140 punti base in meno delle
emissioni papali e di quelle piemontesi (che rappresentavano rispettivamente il
29% e il 44% del debito unitario dopo la conversione) e 160 in meno rispetto a
quelle Lombardo-Venete (che però erano solo il 2%). Insomma, a voler utilizzare
le categorie di oggi, il Regno di Napoli economicamente era per l'Italia quello
che oggi la Germania è per l'Eurozona. «Come il Regno di Napoli prima
dell'integrazione del debito sovrano, la Germania di oggi è l'economia più forte
dell'eurozona e beneficia del costo del debito più basso in assoluto» scrive
Collet. Considerazioni, queste, che faranno storcere il naso a molti, ma
sicuramente non di parte. Del resto, come ricorda Collet, Napoli era di gran
lunga la città più importante del neonato Regno d'Italia. E le regioni del Sud
avevano una discreta struttura industriale, un'agricoltura fiorente sia pure
basata sul latifondismo, e importanti porti commerciali. Subito dopo il 1861,
però, lo scettiscismo dei mercati nel processo unitario italiano impose un "risk
premium" comune a tutti i bond degli stati preunitari, anche a quelli che fino a
quel momento avevano goduto di maggiore fiducia e dunque di rendimenti più
bassi. Proprio quello che oggi la Germania teme possa avvenire con gli eurobond:
l'anno successivo, infatti, i rendimenti dei titoli convertiti in "Regno
d'Italia" si allinearono ben al di sopra dei tassi precedenti, al 6,9%. Per gli
"Italy – Neapolitean" 260 punti base in più che diventarono 460 nel 1870, per
poi cominciare a ripiegare dopo il 1871, quando cioè l'annessione di Venezia e
di Roma e il trasferimento della capitale nella città del papato convinsero gli
investitori, e non solo, che l'Unità era ormai irreversibile. L"Italia" non era
più una mera "espressione geografica", come l'aveva definita Metternich nel
1847, ma dopo tre guerre d'indipendenza e più di vent'anni di manovre
diplomatiche era diventata uno stato unitario. «L'integrazione dei debiti
sovrani era stato uno strumento per portare avanti l'integrazione politica, come
sarebbe oggi per l'Europa» afferma Collet, ma nota anche che «un aumento del
premio di rischio aggraverebbe la crisi del debito che sta vivendo l'Europa
piuttosto che risolverla. Significherebbe che, se fossero introdotti gli
eurobond, la Germania perderebbe il suo rating elevato». Questo portava Collet a
definire, già nei mesi scorsi, «remote» le speranze di vedere nel breve termine
un mercato integrato dei titoli di debito dell'eurozona. Nel lungo termine,
invece, i risultati della ricerca sul caso italiano dimostrano che «nel tempo i
rendimenti dei titoli diminuirono». Alla luce di questo, oggi la domanda è:
quanto tempo ci vorrà perché anche l'Europa sia considerata come un blocco unico
e in grado di dotarsi di un vero e proprio piano di salvataggio per l'euro? Per
l'Italia ci volle all'incirca un decennio. Considerato che quella italiana fu
un'annessione anche militare e quella europea è un'integrazione consensuale, e
che i mercati dei capitali si muovono a ritmi diversi rispetto alla seconda metà
dell'800, anche Collet concorda che un aumento del costo del debito nel breve
termine sarebbe un prezzo che potremmo permetterci di pagare se avessimo la
certezza di avere, tra qualche anno, un'Europa più unita. Ma questa certezza
nessuna ricerca, per quanto accurata, potrà mai darla. Serve, forse, la capacità
di andare oltre il breve periodo, di guardare un po' più lontano rispetto alla
prossima scadenza elettorale, superando la "veduta corta" che per Tommaso Padoa
Schioppa è stata «la radice» della crisi.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
Dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo
storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte
le Mafie.
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir
virtute e canoscenza". Dante, Inferno XXVI
Antonio Giangrande, scrittore, accademico senza
cattedra universitaria di Sociologia Storica, giornalista ed avvocato non
abilitato. "Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie
scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi i miei dolori, i miei
dubbi, le mie risate...vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono
caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno ha la propria storia. E solo
allora mi potrai giudicare." Luigi Pirandello.
Dapprima ti ignorano. Poi ti deridono. Poi ti
emarginano. Poi ti combattono. Tu sei solo, ma non per sempre. Loro sono tanti,
ma non per sempre. Ed allora sarai vincente, ma solo dopo la tua morte. I primi
a combatterti sono i prossimi parenti ed i compaesani ed allor "non ragioniam di
loro, ma guarda e passa" (Dante Alighieri). “Gesù, venuto nella sua patria,
insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli
vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua
madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e
Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora
tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un
profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa
della loro incredulità, non fece molti prodigi”. Mt 13, 54-58.
Se si disprezza quello che gli altri sono e fanno,
perché, poi, si è come gli altri e si osteggiano i diversi?
"C’è un’azione peggiore che quella
di togliere il diritto di voto al cittadino e consiste nel togliergli la voglia
di votare.” (R. Sabatier)
«La disperazione più grave che possa impadronirsi
di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile» - Corrado Alvaro,
Ultimo diario, 1961.
Vivere senza leggere, o senza sfogliare i libri
giusti scritti fuori dal coro o vivere studiando dai saggi distribuiti dal
sistema di potere catto comunista savoiardo nelle scuole e nelle università, è
molto pericoloso. Ciò ti obbliga a credere a quello che dicono gli altri
interessati al Potere e ti conforma alla massa. Allora non vivi da uomo, ma da
marionetta.
Se scrivi e dici la verità con il coraggio che gli
altri non hanno, il risultato non sarà il loro rinsavimento ma l’essere tu
additato come pazzo. Ti scontri sempre con la permalosità di magistrati e
giornalisti e la sornionità degli avvocati avvezzi solo ai loro interessi.
Categorie di saccenti che non ammettono critiche. Se scrivi e sei del
centro-nord Italia, i conterranei diranno: che bel libro, bravo, è uno di noi.
Se scrivi e sei del centro-sud Italia i conterranei diranno: quel libro l’avrei
scritto anch’io, anzi meglio, ma sono solo cazzate. Chi siamo noi? Siamo i
“coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare. Da bambini i
genitori ci educavano secondo i loro canoni, fino a che abbiamo scoperto che era
solo il canone di poveri ignoranti. Da studenti i maestri ci istruivano secondo
il loro pensiero, fino a che abbiamo scoperto che era solo il pensiero di
comunisti arroganti. Prima dell’ABC ci insegnavano “Bella Ciao”. Da credenti i
ministri di culto ci erudivano sulla confessione religiosa secondo il loro
verbo, fino a che abbiamo scoperto che era solo la parola di pedofili o
terroristi. Da lettori e telespettatori l’informazione (la claque del potere) ci
ammaestrava all’odio per il diverso ed a credere di vivere in un paese
democratico, civile ed avanzato, fino a che abbiamo scoperto che si muore di
fame o detenuti in canili umani. Da elettori i legislatori ci imponevano le
leggi secondo il loro diritto, fino a che abbiamo scoperto che erano solo
corrotti, mafiosi e massoni. Ecco, appunto: siamo i “coglioni” che altri
volevano che fossimo o potessimo diventare. E se qualcuno non vuol essere
“coglione” e vuol cambiare le cose, ma non ci riesce, vuol dire che è “coglione”
lui e non lo sa, ovvero è circondato da amici e parenti “coglioni”.
John Keating: Qualunque cosa si dica in giro,
parole e idee possono cambiare il mondo. Sono salito sulla cattedra per
ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni
diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a
vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che
dovete guardarla da un'altra prospettiva. Carpe diem. Cogliete l'attimo,
ragazzi... Rendete straordinaria la vostra vita!
Gerard Pitts: Cogli la rosa quando è il momento,
che il tempo, lo sai, vola e lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà.
John Keating: Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino: noi leggiamo e
scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena
di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni,
necessarie al nostro sostentamento; ma la poesia, la bellezza, il romanticismo,
l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. Dal film L'attimo
fuggente (Dead Poets Society), film del 1989 diretto da Peter Weir e con
protagonista Robin Williams.
Studiare non significa sapere, volere non
significa potere. Ai problemi non si è capaci di trovare una soluzione che
accontenti tutti, perché una soluzione per tutti non esiste. Alla fine nessuno è
innocente, perché in questa società individualista, violenta e superficiale
tutti sono colpevoli. Io ho preso la mia decisione mentre la totalità di voi non
sa prenderne alcuna (anche nelle cose più semplici). Come potreste capire cosa è
veramente importante nella vita? Non saprete mai se avete preso la decisione
giusta perché non vi siete fidati di voi stessi. Accusate il sistema, ma il
sistema è freddo inesorabile matematico, solo chi è deciso a raggiungere la riva
la raggiungerà. Vi auguro tutto il meglio per la vostra vita. “Class Enemy”, di
Rok Bicek film del 2013.
Dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo
storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte
le Mafie, destinatario delle denunce presentate dai magistrati per tacitarlo e
ricevente da tutta Italia di centinaia di migliaia di richieste di aiuto o di
denunce di malefatte delle istituzioni. Ignorato dai media servi del potere.
Come far buon viso a cattivo gioco ed aspettare
che dal fiume appaia il corpo del tuo nemico. "Subisci e taci" ti intima il
Sistema. Non sanno, loro, che la vendetta è un piatto che si gusta freddo. E non
si può perdonare...
Un padre regala al figlio un sacchetto di chiodi.
“Tieni figliolo, ecco un sacchetto di chiodi. Piantane uno nello steccato Ogni
volta che che perdi la pazienza e litighi con qualcuno perchè credi di aver
subito un'ingiustizia” gli dice. Il primo giorno il figlio piantò ben 37 chiodi
ma nelle settimane successive imparò a controllarsi e il numero di chiodi
cominciò piano piano a diminuire. Aveva infatti scoperto che era molto più
facile controllarsi che piantare chiodi e così arrivò un giorno in cui non ne
piantò nemmeno uno. Andò quindi dal padre e gli disse che per quel giorno non
aveva litigato con nessuno, pur essendo stato vittima d'ingiustizie e di
soprusi, e non aveva piantato alcun chiodo. Il padre allora gli disse:
“Benissimo figliolo, ora leva un chiodo dallo steccato per ogni giorno in cui
non hai perso la pazienza e litigato con qualcuno”. Il figlio ascoltò e tornò
dal padre dopo qualche giorno, comunicandogli che aveva tolto tutti i chiodi
dallo steccato e che non aveva mai più perso la pazienza. Il padre lo portò
quindi davanti allo steccato e guardandolo gli disse: “Figliolo, ti sei
comportato davvero bene. Bravo. Ma li vedi tutti quei buchi? Lo steccato non
potrà più tornare come era prima. Quando litighi con qualcuno, o quando questi
ha usato violenza fisica o psicologica nei tuoi confronti, rimane una ferita
come questi buchi nello steccato. Tu puoi piantare un coltello in un uomo e poi
levarlo, e lo stesso può fare questi con te, ma rimarrà sempre una ferita. E non
importa quante volte ti scuserai, o lui lo farà con te, la ferita sarà sempre
lì. Una ferita verbale è come il chiodo nello steccato e fa male quanto una
ferita fisica. Lo steccato non sarà mai più come prima. Quando dici le cose in
preda alla rabbia, o quando altri ti fanno del male, si lasciano delle ferite
come queste: come i buchi nello steccato. Possono essere molto profonde. Alcune
si rimarginano in fretta, altre invece, potrebbero non rimarginare mai, per
quanto si possa esserne dispiaciuti e si abbia chiesto scusa".
Io non reagisco, ma mi si permetta di raccontare
l'accaduto. Voglio far conoscere la verità sui chiodi piantati nelle nostre
carni.
La mia esperienza e la mia competenza mi portano a
pormi delle domande sulle vicende della vita presente e passata e sul perché del
ripetersi di eventi provati essere dannosi all’umanità, ossia i corsi e i
ricorsi storici. Gianbattista Vico, il noto filosofo napoletano vissuto fra il
XVII e XVIII secolo elaborò una teoria, appunto dei corsi e ricorsi storici.
Egli era convinto che la storia fosse caratterizzata dal continuo e incessante
ripetersi di tre cicli distinti: l’età primitiva e divina, l’età poetica ed
eroica, l’età civile e veramente umana. Il continuo ripetersi di
questi cicli non avveniva per caso ma era predeterminato e regolamentato, se
così si può dire, dalla provvidenza. Questa formulazione di pensiero è
comunemente nota come “teoria dei corsi e dei ricorsi storici”. In parole
povere, tanto per non essere troppo criptici, il Vico sosteneva che alcuni
accadimenti si ripetevano con le medesime modalità, anche a distanza di tanto
tempo; e ciò avveniva non per puro caso ma in base ad un preciso disegno stilato
della divina provvidenza.” Io sono convinto, invece, che l’umanità dimentica e
tende a sbagliare indotta dalla stupidità e dall’egoismo di soddisfare in ogni
modo totalmente i propri bisogni in tempi e spazi con risorse limitate. Trovare
il perché delle discrepanze dell’ovvio raccontato. Alle mie domando non mi do io
stesso delle risposte. Le risposte le raccolgo da chi sento essere migliore di
me e comunque tra coloro contrapposti con le loro idee sullo stesso tema da cui
estrapolare il sunto significativo. Tutti coloro che scrivono, raccontano il
fatto secondo il loro modo di vedere e lo ergono a verità. Ergo: stesso fatto,
tanti scrittori, quindi, tanti fatti diversi. La mia unicità e peculiarità, con
la credibilità e l’ostracismo che ne discende, sta nel raccontare quel fatto in
un’unica sede e riportando i vari punti di vista. In questo modo svelo le
mistificazioni e lascio solo al lettore l’arbitrio di trarne la verità da quei
dati.
Voglio conoscere gli effetti, sì, ma anche le
cause degli accadimenti: il post e l’ante. La prospettiva e la retrospettiva con
varie angolazioni. Affrontare le tre dimensioni spaziali e la quarta dimensione
temporale.
Si può competere con l’intelligenza, mai con
l’idiozia. L’intelligenza ascolta, comprende e pur non condividendo rispetta.
L’idiozia si dimena nell’Ego, pretende ragione non ascoltando le ragioni altrui
e non guarda oltre la sua convinzione dettata dall’ignoranza. L’idiozia non
conosce rispetto, se non pretenderlo per se stessa.
Quando fai qualcosa hai tutti contro: quelli che
volevano fare la stessa cosa, senza riuscirci, impediti da viltà, incapacità,
ignavia; quelli che volevano fare il contrario; e quelli, ossia la stragrande
maggioranza, che non volevano fare niente.
Certe persone non sono importanti, siamo noi che,
sbagliando, gli diamo importanza. E poi ci sono quelle persone che non servono
ad un cazzo, non fanno un cazzo e si credono sto cazzo.
Correggi un sapiente ed esso diventerà più colto.
Correggi un ignorante ed esso diventerà un tuo acerrimo nemico.
Molti non ti odiano perché gli hai fatto del male,
ma perché sei migliore di loro.
Più stupido di chi ti giudica senza sapere nulla
di te è colui il quale ti giudica per quello che gli altri dicono di te. Perché
le grandi menti parlano di idee; le menti medie parlano di fatti; le infime
menti parlano solo male delle persone.
E’ importante stare a posto con la propria
coscienza, che è molto più importante della propria reputazione. La tua
coscienza sei tu, la reputazione è ciò che gli altri pensano di te e quello che
gli altri pensano di te è un problema loro.
Le bugie sono create dagli invidiosi, ripetute dai
cretini e credute dagli idioti, perché un grammo di comportamento esemplare,
vale un quintale di parole. Le menti mediocri condannano sempre ciò che non
riescono a capire.
E se la strada è in salita, è solo perché sei
destinato ad attivare in alto.
Ci sono persone per indole nate per lavorare e/o
combattere. Da loro ci si aspetta tanto ed ai risultati non corrispondono elogi.
Ci sono persone nate per oziare. Da loro non ci si aspetta niente. Se fanno poco
sono sommersi di complimenti. Guai ad aspettare le lodi del mondo. Il mondo è un
cattivo pagatore e quando paga lo fa sempre con l’ingratitudine.
Il ciclo vitale biologico della natura afferma che
si nasce, si cresce, ci si riproduce, si invecchia e si muore e l’evoluzione fa
vincere i migliori. Solo a noi umani è dato dare un senso alla propria vita.
Ergo. Ai miei figli ho insegnato:
Le ideologie, le confessioni, le massonerie vi
vogliono ignoranti;
Le mafie, le lobbies e le caste vi vogliono
assoggettati;
Le banche vi vogliono falliti;
La burocrazia vi vuole sottomessi;
La giustizia vi vuole prigionieri;
Siete nati originali…non morite fotocopia.
Siate liberi. Studiare, ma non fermarsi alla
cultura omologata. La conoscenza è l'arma migliore per vincere.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso.
Se si è omologati (uguali) o conformati
(simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita,
perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla
rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un
Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco
tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai
primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo.
Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si sentono alti anche i nani e dove anche
i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe
indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.
Il difetto degli intelligenti è che sono spinti
a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno
dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte.
Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato
ed amministrato da “coglioni”.
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio
di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a
spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola
gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra
dei ciechi anche l’orbo è re.
Il ciclo vitale, in biologia, è l'intervallo tra
il susseguirsi di generazioni di una specie. L'esistenza di ogni organismo si
svolge secondo una sequenza ciclica di stadi ed eventi biologici, caratterizzata
in base alla specie di appartenenza. Queste sequenze costituiscono i
cosiddetti Cicli Biologici. Ogni essere vivente segue un ciclo vitale biologico
composto dai seguenti stadi: nascita, crescita, riproduzione, senescenza e
morte. Per quanto possa essere breve o corta la vita, nessun essere vivente
preso singolarmente è immortale. Ma la sua specie diventa immortale attraverso
la riproduzione e l'evoluzione. Gli esseri viventi si evolvono nel corso del
tempo per potersi meglio adattare alla natura che li circonda. Attraverso la
riproduzione le generazioni trasmettono i propri geni a quelle future. Durante
questo passaggio le nuove generazioni possono assumere caratteristiche nuove o
perderne alcune. Le differenze si traducono in vantaggi o in handicap per chi le
possiede, agendo direttamente sul processo evolutivo tramite la selezione
naturale degli individui. Le nuove caratteristiche che agevolano l'adattamento
all'ambiente offrono all'individuo maggiori probabilità di sopravvivenza e,
quindi, di riproduzione. E' innaturale non riprodursi. Senza riproduzione non vi
è proseguimento ed evoluzione della specie. Senza riproduzione il ciclo vitale
biologico cessa. Ciò ci rende mortali. Parlare in termini scientifici
dell'eterosessualità e del parto, quindi di stati naturali, fa di me un omofobo
ed un contrabortista, quindi un non-comunista? Cercare di informare i simili
contro la deriva involutiva, fa di me un mitomane o pazzo?
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo
facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo
facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione
di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica.
Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze
staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad
ascoltarci.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo
senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Da sempre diffido di chi, vestito da lupo, è
pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti giustizialisti dei 5 stelle che
provino a proporre la figura del difensore civico giudiziario con poteri di
magistrato, senza essere uno di loro, per poter metter le mani nelle carte dei
fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi batto inascoltato per questo. I
signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di rispondere ai messaggi degli
esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son bravi, ma a proporre leggi
sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà,
certificata dai loro magistrati, e mai parlano di libertà ed opportunità senza
concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione umana nefasta si trova sempre una
giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli animali...lo si fa
per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta che fa male al
prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito preso, noi siamo
tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli permettiamo di farle.
Parlare nei miei libri del caso singolo del
semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di mitomania, pazzia o
calunnia, oltre che nel disinteresse. Invece parlo di loro, delle istituzioni
che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso dire di più di
quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto divulgato possa
essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere altro che
quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di loro
stessi e se ne fottono degli altri.
Alle sentenze irrevocabili di proscioglimento del
Tribunale di Taranto a carico del dr Antonio Giangrande, già di competenza della
dr.ssa Rita Romano, giudice di Taranto poi ricusata perché denunciata, si
aggiunge il verbale di udienza dell’11 dicembre 2015 della causa n. 987/09
(1832/07 RGNR) del Tribunale di Potenza, competente su fatti attinenti i
magistrati di Taranto, con il quale si dispone la perfezione della fattispecie
estintiva del processo per remissione della querela nei confronti del dr Antonio
Giangrande da parte del dr. Alessio Coccioli, già Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto, poi trasferito alla Direzione
Distrettuale Antimafia di Lecce. Remissione della querela volontaria, libera e
non condizionata da alcun atto risarcitorio.
Il Dr Antonio Giangrande era inputato per il reato
previsto e punito dall’art. 595 3° comma c.p. “perchè inviando una missiva a
sua firma alla testata giornalistica La Gazzetta del Sud Africa e pubblicata sui
siti internet lagazzettadelsudafrica.net, malagiustizia.eu, e
associazionecontrotuttelemafie.org, offendeva l’onore ed il decoro del dr.
Alessio Coccioli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Taranto, riportando in detto su scritto la seguente frase: “…il PM Alessio
Coccioli, inopportunamente delegando i carabinieri di Manduria, quali PG, ha
reso lecito tale modus operandi (non rilasciare attestato di ricezione da parte
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Manduria ndr), motivandolo dal fatto che
non è dannoso per il denunciante. Invece in denuncia si è fatto notare che tale
usanza di recepimento degli atti, prettamente manduriana, può nascondere
alterazioni procedurali in ambito concorsuale e certamente abusi a danno dei
cittadini. Lo stesso PM Alessio Coccioli, inopportunamente delegando i
carabinieri di Manduria, quali PG, per la colleganza con il comandante dei
Vigili Urbani di Manduria, ha ritenuto le propalazioni del Giangrande, circa il
concorso per Comandante dei Vigili Urbani, ritenuto truccato (perché il medesimo
aveva partecipato e vinto in un concorso da egli stesso indetto e regolato in
qualità di comandante pro tempore e dirigente dell’ufficio del personale), sono
frutto di sue convinzioni non supportate da riscontri di natura obbiettiva e
facendo conseguire tali riferimenti, al predetto dr. Coccioli, ad altre
notazioni, contenute nello stesso scritto, nelle quali si denunciavano
insabbiamenti, o poche richieste di archiviazioni strumentali attribuite ai
magistrati della Procura della Repubblica di Taranto”.
Il Processo di Potenza, come i processi tenuti a
Taranto, sono attinenti a reati di opinione. Lo stesso dr. Alessio Coccioli, una
volta trasferito a Lecce, ha ritenuto che le opinioni espresse dal Dr Antonio
Giangrande riguardo la Giustizia a Taranto non potessero continuare ad essere
perseguite.
Ultimo atto. Esame di Avvocato 2015. A Lecce uno
su quattro ce l’ha fatta. Sono partiti in 1.108: la prova scritta è stata
passata da 275 praticanti. Preso atto.....
All'attenzione dell'avv. Francesco De Jaco.
Illustre avv. Francesco De Jaco, in qualità di Presidente della Commissione di
Esame di Avvocato 2014-2015, chi le scrive è il dr Antonio Giangrande. E’ quel
signore, attempato per i suoi 52 anni e ormai fuori luogo in mezzo ai giovani
candidati, che in sede di esame le chiese, inopinatamente ed invano, Tutela.
Tutela, non raccomandazione. Così come nel 2002 fu fatto inutilmente con l’avv.
Luigi Rella, presidente di commissione e degli avvocati di Lecce. Tutela perché
quel signore il suo futuro lo ha sprecato nel suo passato. Ostinatamente nel
voler diventare avvocato ha perso le migliori occasioni che la vita possa dare.
Aspettava come tutti che una abilitazione, alla mediocrità come è l’esame
forense truccato, potesse, prima o poi, premiare anche lui. Pecori e porci sì,
lui no! Quel signore ha aspettato ben 17 anni per, finalmente, dire basta.
Gridare allo scandalo per un esame di Stato irregolare non si può. Gridare al
complotto contro la persona…e chi gli crede. Eppure a Lecce c’è qualcuno che
dice: “quello lì, l’avvocato non lo deve fare”. Qualcuno che da 17 anni,
infastidito dal mio legittimo operato anche contro i magistrati, ha i tentacoli
tanto lunghi da arrivare ovunque per potermi nuocere. Chi afferma ciò è colui il
quale dimostra con i fatti nei suoi libri, ciò che, agli ignoranti o a chi è in
mala fede, pare frutto di mitomania o pazzia. Guardi, la sua presidenza, in sede
di scritto, è stata la migliore tra le 17 da me conosciute. Purtroppo, però, in
quel di Brescia quel che si temeva si è confermato. Brescia, dove, addirittura,
l’ex Ministro Mariastella Gelmini chiese scampo, rifugiandosi a Reggio Calabria
per poter diventare avvocato. Il mio risultato delle prove fa sì che chiuda la
fase della mia vita di aspirazione forense in bruttezza. 18, 18, 20. Mai
risultato fu più nefasto e, credo, immeritato e punitivo. Sicuro, però, che tale
giudizio non è solo farina del sacco della Commissione di esame di Brescia. Lo
zampino di qualche leccese c’è! Avvocato… o magistrato… o entrambi…: chissà? Non
la tedio oltre. Ho tentato di trovare Tutela, non l’ho trovata. Forse chiedevo
troppo. Marcire in carcere da innocente o pagare fio in termini professionali,
credo che convenga la seconda ipotesi. Questo è quel che pago nel mettermi
contro i poteri forti istituzionali, che io chiamo mafiosi. Avvocato, grazie per
il tempo che mi ha dedicato. Le tolgo il disturbo e, nel caso l’importasse, non
si meravigli, se, in occasione di incontri pubblici, se e quando ci saranno, la
priverò del mio saluto. Con ossequi.
Avetrana lì 26 giugno 2015. Dr Antonio Giangrande,
scrittore per necessità.
I mediocri del Politically Correct negano sempre
il merito. Sostituiscono sempre la qualità con la quantità. Ma è la qualità che
muove il mondo, cari miei, non la quantità. Il mondo va avanti grazie ai pochi
che hanno qualità, che valgono, che rendono, non grazie a voi che siete tanti e
scemi. La forza della ragione (Oriana Fallaci)
“L'Italia tenuta al
guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e
massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere.
La “Politica” deve
essere legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza
d’interessi, invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono
meritarlo il rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto
tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è
cogenza di legge, vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno
“Stato di Diritto” degrada in anarchia. In questo caso è palese la
responsabilità politica ed istituzionale per incapacità o per collusione. Così
come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per
codardia o emulazione."
TIRANNIDE indistintamente appellare si
debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi,
può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od
anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo
infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o
tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a
ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che
lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
"Quando si cerca di far progredire la
conoscenza e l'intelligenza umana si incontra sempre la resistenza dei
contemporanei, simile a un fardello che bisogna trascinare e che grava
pesantemente al suolo, ribelle ad ogni sforzo. Ci si deve consolare allora con
la certezza che, se i pregiudizi sono contro di noi, abbiamo con noi la Verità,
la quale, dopo essersi unita al suo alleato, il Tempo, è pienamente certa della
sua vittoria, se non proprio oggi, sicuramente domani."(Arthur Schopenhauer)
Il pregio di essere un autodidatta è quello che
nessuno gli inculcherà forzosamente della merda ideologica nel suo cervello. Il
difetto di essere un autodidatta è quello di smerdarsi da solo.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo con la discultura e la disinformazione. Ci si deve chiedere: perchè
a scuola ci hanno fatto credere con i libri di testo che Garibaldi era un eroe
ed i piemontesi dei salvatori; perché i media coltivano il luogo comune di un
sud Italia cafone ed ignorante; perché la prima cosa che insegnano a scuola è la
canzone “bella ciao”? Per poi scoprire da adulti e solo tramite il web: che il
Sud Italia è stato depredato a causa proprio di Garibaldi a vantaggio dei
Piemontesi; che solo i turisti che scendono a frotte nel meridione d’Italia
scoprono quanto ci sia tanto da conoscere ed apprezzare, oltre che da amare; che
“Bella ciao” è solo l’inno di una parte della politica italiana che in nome di
una ideologia prima tradì l’Italia e poi, con l’aiuto degli americani, vinse la
guerra civile infierendo sui vinti, sottomettendoli, con le sue leggi, ad un
regime illiberale e clericale.
Ad Avetrana, il paese di Sarah Scazzi, non sono
omertosi, sempre che non si tratti di poteri forti. Ma qualcuno certamente
vigliacco e codardo lo è. Sapendo che io ho le palle per denunciare le
illegalità, questi deficienti usano il mio nome ed appongono falsamente la mia
firma in calce a degli esposti che colpiscono i poveri cristi rei di abusi
edilizi o commerciali. I cretini, che poi fanno carriera politica, non sanno che
i destinatari dei miei strali sono magistrati, avvocati, forze dell’ordine, e
comunque pubblici ufficiali o esercenti un pubblico servizio. Che poi queste
denunce finiscono nell’oblio perché “cane non mangia cane” e per farmi passare
per mitomane o pazzo o calunniatore o diffamatore, è un’altra cosa. Però da
parte di questi coglioni prendersela con i poveri cristi per poi far addossare
la colpa a me ed essere oggetto di ritorsioni ingiustificate è da veri
vigliacchi. D'altronde un paese di coglioni sarà sempre governato, amministrato,
giudicato da coglioni.
È molto meglio osare cose straordinarie, vincere
gloriosi trionfi, anche se screziati dall'insuccesso, piuttosto che schierarsi
tra quei poveri di spirito che non provano grandi gioie né grandi dolori, perché
vivono nel grigio e indistinto crepuscolo che non conosce né vittorie né
sconfitte. (...) Non è il critico che conta, né l'individuo che indica come
l'uomo forte inciampi, o come avrebbe potuto compiere meglio un'azione. L'onore
spetta all'uomo che realmente sta nell'arena, il cui viso è segnato dalla
polvere, dal sudore, dal sangue; che lotta con coraggio; che sbaglia
ripetutamente, perchè non c'è tentativo senza errori e manchevolezze; che lotta
effettivamente per raggiungere l'obiettivo; che conosce il grande entusiasmo, la
grande dedizione, che si spende per una giusta causa; che nella migliore delle
ipotesi conosce alla fine il trionfo delle grandi conquiste e che, nella
peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno cade sapendo di aver osato
abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto a quelle anime timide che
non conoscono né la vittoria, né la sconfitta. Franklin Delano Roosevelt
Cari signori, io ho iniziato a destare le
coscienze 20 anni prima di Beppe Grillo e nulla è successo. Io non cercavo gli
onesti, ma le vittime del sistema, per creare una rivoluzione culturale…ma un
popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.
"Il popolo cornuto era e cornuto resta: la
differenza è che il fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e
la democrazia lascia che ognuno se l'appenda da sé, del colore che gli piace,
alle proprie corna... Siamo al discorso di prima: non ci sono soltanto certi
uomini a nascere cornuti, ci sono anche popoli interi; cornuti dall'antichità,
una generazione appresso all'altra...- Io non mi sento cornuto - disse il
giovane - e nemmeno io. Ma noi, caro mio, camminiamo sulle corna degli altri:
come se ballassimo..." Leonardo Sciascia dal libro "Il giorno della civetta".
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio
di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a
spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola
gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra
dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo
facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo
facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione
di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica.
Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze
staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad
ascoltarci.
In una Italia dove nulla è come sembra, chi
giudica chi è onesto e chi no?
Lo hanno fatto i comunisti, i dipietristi, i
leghisti, i pentastellati. Lor signori si son dimostrati peggio degli altri e
comunque servitori dei magistrati. E se poi son questi magistrati a decidere chi
è onesto e chi no, allora se tutti stanno dalla parte della ragione, io mi metto
dalla parte del torto.
Ognuno di noi, anziché migliorarsi, si giova
delle disgrazie altrui. Non pensando che a cercar l’uomo onesto con il
lanternino si perde la ragione. Ma anche a cercarlo con la lanterna di Diogene
si perde la retta via. Diogene di Sinope (in greco antico Διογένης Dioghénes)
detto il Cinico o il Socrate pazzo (Sinope, 412 a.C. circa – Corinto, 10
giugno 323 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Considerato uno dei fondatori
della scuola cinica insieme al suo maestro Antistene, secondo l'antico
storico Diogene Laerzio, perì nel medesimo giorno in cui Alessandro Magno spirò
a Babilonia. «[Alessandro Magno] si fece appresso a Diogene, andandosi a mettere
tra lui e il sole. "Io sono Alessandro, il gran re", disse. E a sua volta
Diogene: "Ed io sono Diogene, il cane". Alessandro rimase stupito e chiese
perché si dicesse cane. Diogene gli rispose: "Faccio le feste a chi mi dà
qualcosa, abbaio contro chi non dà niente e mordo i ribaldi."» (Diogene
Laerzio, Vite dei filosofi, Vita di Diogene il Cinico, VI 60). Diogene aveva
scelto di comportarsi, dunque, come "critico" pubblico: la sua missione era
quella di dimostrare ai Greci che la civiltà è regressiva e di dimostrare con
l'esempio che la saggezza e la felicità appartengono all'uomo che è indipendente
dalla società. Diogene si fece beffe non solo della famiglia e dell'ordine
politico e sociale, ma anche delle idee sulla proprietà e sulla buona
reputazione. Una volta uscì con una lanterna di giorno. Questi non indossava una
tunica. Portava come solo vestito un barile ed aveva in mano una lanterna.
"Diogene! - esclamo Socrate - con quale nonsenso tenterai di ingannarci oggi?
Sei sempre alla ricerca, con questa lanterna, di un uomo onesto? Non hai ancora
notato tutti quei buchi nel tuo barile?". Diogene rispose: "Non esiste una
verità oggettiva sul senso della vita". A chi gli chiedeva il senso della
lanterna lui rispondeva: "cerco l'uomo!". “... (Diogene) voleva significare
appunto questo: cerco l’uomo che vive secondo la sua più autentica natura, cerco
l’uomo che, aldilà di tutte le esteriorità, le convenzioni o le regole imposte
dalla società e aldilà dello stesso capriccio della sorte e della fortuna,
ritrova la sua genuina natura, vive conformemente a essa e così è felice."
PARLIAMO DI TERREMOTI.
TERREMOTO E STORIA. I terremoti più gravi
in Italia, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno” il 25
agosto 2016. Dal terremoto di Messina e Reggio, fino a quello dell’Emilia del
2012, passando per il sisma che ha distrutto l’Aquila nel 2009, ecco gli eventi
sismici più gravi avvenuti in Italia a partire dal 1908.
- 28 dicembre 1908: un terremoto di magnitudo 7,2
rade al suolo Reggio Calabria e Messina e tutti i villaggi nell’area, causando
quasi 100.000 morti. Si tratta della più grave sciagura naturale in Italia per
numero di vittime e per intensità sismica.
- 13 gennaio 1915: un sisma di magnitudo 6,8
distrugge Avezzano e tutto il territorio della Marsica. I morti sono circa
30.000.
- 26 aprile 1917: Umbria e Toscana sono colpite da
un terremoto di magnitudo 5,8. Distrutte Monterchi, Citerna e Sansepolcro. Danni
a tutti i centri urbani dell’alta valle del Tevere. Tra i 30 e 40 i morti.
- 7 settembre 1920: Sisma di magnitudo 6,5 in
Garfagnana e Lunigiana, in Toscana, con epicentro a Fivizzano. 300 i morti.
- 23 luglio 1930: terremoto di magnitudo 6,7 in
Irpinia, in Campania: 1.425 morti.
- 15 gennaio 1968: Nella Valle del Belice, in
Sicilia, vengono rasi al suolo da un terremoto di magnitudo 6,1 Gibellina,
Poggioreale, Salaparuta in provincia di Trapani, e Montevago in provincia di
Agrigento. Le vittime accertate sono 231.
- 6 febbraio 1971: nel Lazio la cittadina di
Tuscania viene semidistrutta da un terremoto di magnitudo 4,5. 31 i morti. - 6
maggio 1976: alle 21,00 un terremoto di magnitudo 6,1 nel Friuli provoca circa
1.000 vittime. La zona più colpita è quella a nord di Udine. Ulteriori scosse
l’11 e 15 settembre.
- 19 settembre 1979: un terremoto di magnitudo 5,9
colpisce la Valnerina, provocando gravi danni a Norcia, Cascia e le aree
limitrofe, tra Umbria e Marche. Danni a Rieti ma anche a Roma, dove subiscono
lesioni il Colosseo, l’Arco di Costantino e la colonna Antonina. Cinque i morti.
- 23 novembre 1980: alle 19,38 l’Irpinia viene
sconvolta per 90 secondi da un terremoto di magnitudo 6,5. Colpita un’area di 17
mila km quadrati tra Campania e Basilicata. I morti sono 2.914.
- 7 e 11 maggio 1984: Sisma di magnitudo 5,2 in
Molise, Lazio e Campania, con epicentro a San Donato Val di Comino. 7 i morti.
- 13 dicembre 1990: Sisma di magnitudo 5,1 a Santa
Lucia nella Sicilia sud-orientale. Gravi danni ad Augusta e Carlentini e nella
Val di Noto. 16 le vittime.
- 26 settembre 1997: Un terremoto di magnitudo
5,6, seguito da altre forti scosse nei giorni successivi colpisce di nuovo
l'Umbria e le Marche: danneggiate Assisi, Colfiorito, Verchiano, Foligno,
Sellano, Nocera Umbra, Camerino. 11 i morti.
- 31 ottobre-2 novembre 2002. Terremoto di
magnitudo 5,4 in Molise e Puglia. A San Giuliano di Puglia crollata una scuola
dove muoiono 27 bambini. In tutto i morti sono 30.
- 6 aprile 2009: Alle 3,32 L’Aquila e le zone
circostanti sono colpite da un sisma di magnitudo 6,3. La scossa principale è
seguita da decine di repliche di assestamento. 309 morti e 23 mila edifici
distrutti.
- 20 maggio 2012: Alle 4.04 un sisma di magnitudo
5,9 colpisce per venti secondi le province di Modena e Ferrara, provocando la
morte di sette persone. La scossa viene avvertita in tutto il Nord e parte del
Centro Italia. Il sisma, che era stato preceduto da due forti scosse nel gennaio
precedente, si ripete il 29 maggio con una magnitudo 5,8 e il 3 giugno con una
nuova forte scossa da 5,1. In tutto sono sette i terremoti con magnitudo
superiore a 5 e provocano complessivamente 27 morti e danni ingenti in tutta
l’area.
- 24 agosto 2016: È di 297 morti il bilancio del
sisma di magnitudo 6 che alle 3,36 della notte ha scosso il centro Italia,
devastando una serie di centri tra Lazio, Umbria e Marche. La prima
violentissima scossa ha colpito Amatrice, Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto
(Ascoli Piceno); una seconda di magnitudo 5.4 è stata registrata alle 4,33 con
epicentro tra Norcia (Perugia) e Castelsantangelo sul Nera (Macerata). Le scosse
sono state avvertite anche a molti chilometri di distanza, fino a Roma e Napoli.
Una devastazione «peggiore di quella dell’Aquila, mai vista una cosa così», è
stata la reazione dei soccorritori. Tra le vittime ci sono molti bambini.
Un secolo di terremoti. Da Messina ad
Amatrice, scrive Franco Insardà il 29 ago 2016 su “Il
Dubbio”. Gli eventi sismici più gravi, che hanno sconvolto il nostro paese dal
1908 al 2016. Paesi distrutti, facce tese, occhi persi nel vuoto e richieste di
aiuto. Poi gli appelli, i soccorsi e dopo un po' le polemiche. La storia si
ripete drammaticamente a ogni terremoto che, purtroppo, da secoli sconvolge la
nostra penisola. Dal Friuli alla Sicilia. Improvvisamente i nomi di piccoli
paesini come Gibellina, Montevago, Gemona, Conza della Campania, Lioni, Balvano,
Massa Martana, San Giuliano di Puglia, Mirandola, Medolla, diventano
drammaticamente famosi e familiari agli italiani e all'estero. Oggi tocca ad
Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto. Passata, poi, la prima onda
emotiva si comincia ad analizzare l'intensità della scossa, il luogo
dell'epicentro, le zone colpite e poi la pietosa conta dei morti, dei feriti,
dei dispersi dei senzatetto. Si fanno i confronti con quello che è successo
nelle altre zone, con i finanziamenti stanziati e a che punto è la
ricostruzione. E se il terremoto del Friuli, così come quello dell'Umbria e
delle Marche, viene ricordato come esempio di efficienza e serietà nell'utilizzo
dei fondi per la ricostruzione la stessa cosa non si può dire della Valle del
Belice, dell'Irpinia e di San Giuliano di Puglia. Dal 1908 a oggi la lista degli
eventi sismici è lunghissima, così come quella dei paesi distrutti e il numero
delle vittime è da brividi.
Quel 28 dicembre 1908 una
scossa di magnitudo 7,2 della scala Richter fece tremare per 37 secondi l'area
dello Stretto di Sicilia. Le scosse e il successivo maremoto rasero al suolo
Messina, Reggio e i paesi vicini. Centomila le vittime, 80mila nella sola
Messina, su 140mila abitanti.
13 gennaio 1915. Un
terremoto di magnitudo 7 sconvolse la valle del Fucino, distruggendo Avezzano e
molti paesi della Marsica, del Lazio e della Campania. Il bilancio fu pauroso
32.160 vittime, su circa 120mila residenti. 9000 solo ad Avezzano su una
popolazione complessiva di 11mila abitanti.
24 novembre 1918. Furono
cento i morti a Giarre, in provincia di Catania.
29 giugno 1919. Colpita
l'area del Mugello con una scossa di intensità 6,2. Circa cento le vittime.
7 dicembre 1920. Una
scossa di magnitudo 6,5 con epicentro a Fivizzano, provocò danni nell'area della
Garfagnana e oltre 300 morti.
23 luglio 1930. Terremoto
notturno nella zona del Vulture. Morirono 1404 persone nelle province di
Avellino e Potenza.
30 ottobre 1930. Le
Marche, e soprattutto Senigallia, furono interessate da una scossa di 5,9 con 18
vittime.
26 settembre 1933. Grazie
a una serie di scosse precedenti le popolazione abruzzesi della Majella furono
avvertite e la scossa più forte (5,7 della scala Richter) provocò solo 12 morti.
18 ottobre 1936. L'altopiano
del Cansiglio tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone furono interessate
da una scossa di 5,9 con 19 vittime.
13 giugno 1948. La
zona interessata fu quella dell'Alta valle del Tevere con una serie di scosse.
Morì per fortuna solo una donna.
21 agosto 1962. Una
serie di scosse, con epicentro tra Montecalvo e Savignano Irpino di 6,2, fecero
17 vittime, ma ad Ariano Irpino l'80% degli edifici furono danneggiati.
15 gennaio 1968. Gibellina,
Salaparuta e l'intera Valle del Belice furono interessati da un terremoto di 6,4
di magnitudo. 370 i morti, un migliaio i feriti e circa 70mila i senza tetto.
6 febbraio 1971. Il
centro di Tuscania fu parzialmente distrutto: 31 morti.
6 maggio 1976. Alle
21.06 un terremoto di intensità 6,4 sconvolse il Friuli. Il sisma fu avvertito
nell'Italia settentrionale e centrale, in Slovenia e Austria. Le vittime furono
989 e 75mila le case danneggiate. Per la prima volta venne organizzata la
Protezione civile e in cinque anni la zona fu ricostruita.
19 settembre 1979. Fu
la Val Nerina a essere colpita da una scossa di 5,9 di magnitudo, con epicentro
a Norcia. I danni più gravi li subirono gli edifici più antichi. Decine i feriti
e cinque i morti.
23 novembre 1980. In
Irpinia e in Basilicata si registrò il più grave terremoto dopo la Seconda
guerra mondiale. Alle 19,34 una scossa di magnitudo 6,9 di circa 90 secondi
provocò 2914 morti, 8848 feriti e 280mila sfollati. Dei 679 comuni delle otto
province interessate, 508 furono danneggiate. In 36 comuni della fascia
epicentrale circa 20mila alloggi andarono distrutti o divennero irrecuperabili.
I soccorsi in alcuni casi arrivarono dopo cinque giorni. Dal 7 aprile 1989.
Oscar Luigi Scalfaro guidò la Commissione parlamentare d'inchiesta della
ricostruzione.
13 dicembre 1990. Un
sisma al largo di Augusta, nel golfo di Noto, colpì la provincia di Siracusa,
Catania e Ragusa provocò 12 vittime e altre cinque persone morirono d'infarto
nei paesi vicini. Gli abitanti protestarono perché si sentirono abbandonati.
15 ottobre 1996. La
provincia di Reggio Emilia fu interessata da una scossa di magnitudo 5,1: due
morti e cento feriti.
26 settembre 1997. Il
terremoto colpì Umbria e Marche, anticipato da uno sciame sismico, che ebbe
inizio il 5 maggio con una scossa di intensità 3,7 e si concluse il 28 giugno
1998. Il 26 settembre una prima scossa fece crollare una casa di due anziani che
morirono. La mattina dopo alle 11,40 morirono 9 persone, quattro delle quali
sepolte dal crollo delle volte della basilica di San Francesco ad Assisi.
17 luglio 2001 Un sisma di magnitudo 5,2 colpì
Merano e interessò la provincia di Bolzano. Due persone furono uccise da una
frana e una donna morì d'infarto. Pochi i danni grazie alla solidità degli
edifici, molti dei quali in cemento armato.
31 ottobre 2002. San
Giuliano di Puglia (Campobasso) rimarrà nella memoria di tutti per il crollo
della scuola, dove morirono 27 bambini e una maestra in seguito a una scossa di
magnitudo 5,6. In paese ci furono altre due vittime. Sette persone furono
indagate e sei, dopo tre gradi di giudici, furono condannate.
6 aprile 2009. Una
scossa di intensità 5,8 alle 3.32 provocò vittime e danni a L'Aquila e in molti
paesi della provincia. Onna fu quasi rasa al suolo e la Casa dello studente de
L'Aquila crollò uccidendo otto ragazzi. In tutto i morti furono 308, i feriti
1600 e 65mila gli sfollati.
29 maggio 2012. La
zona compresa fra Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro in Emilia fu
interessata da una scossa di magnitudo 5,8. Il 31 maggio 2012 una nuova scossa
di magnitudo 4,0 fu colpita la zona della Bassa reggiana e dell'Oltrepò
mantovano. I due eventi sismici principali causarono 27 vittime (22 nei crolli,
tre per infarto e due per le ferite riportate).
Nel ’900 un terremoto ogni 3 anni. La
schiena fragile del Paese. Dal 1315 gli Appennini sono
stati scossi da 148 eventi sismici superiori a 5,5 della scala Richter. E dalla
prima casa antisismica di Pirro Ligorio (1570) si discute di regole, scrive Gian
Antonio Stella il 26 agosto 2016 su "Il Corriere della Sera". «La città è stata
cancellata di un soffio dalla superficie terrestre. Non esistono rovine; non
esiste che un immenso strato di polvere, da cui sbucano strani, esilissimi,
quasi trasparenti spettri di mura. Cancellate le case, cancellate le chiese,
cancellate le piazze, cancellate le vie. Avezzano non è che un cimitero su cui
mani pietose già incominciano a piantare croci». Era il 16 gennaio del 1915. E
Umberto Fracchia, sceso nella notte dal treno che lo aveva portato nella
cittadina della Marsica epicentro di un terremoto devastante e così vicina
all’Aquila e ad Amatrice, aveva la mano che tremava mentre scriveva il suo
reportage per «L’Idea Nazionale»: «Non un palmo di terra fu risparmiato: nessuno
riuscì a trovar salvezza nella fuga. Quelli che erano in casa ebbero tetti e
mura addosso; quelli che erano per le vie furono schiacciati tra il doppio
crollo degli edifici che avevano ai due lati. La città era costruita di fango; è
ritornata fango». È passato un secolo, da allora. E gli Appennini non hanno mai
smesso di dare spaventosi scossoni. La storica Emanuela Guidoboni, che con
Gianluca Valensise e altri studiosi ha raccolto in vari libri come «L’Italia dei
disastri, dati e riflessioni sull’impatto degli eventi naturali 1861-2013» la
memoria storica delle nostre calamità naturali (aggravate da superficialità,
incuria, sciatteria amministrativa e legislativa) ha fatto i conti. Da far
accapponare la pelle. La fragile spina dorsale del nostro Paese, dal 1315 quando
un sisma appena un po’ meno grave di quello del 2009 devastò l’area dell’Aquila,
ha fatto segnare (come spiega la mappa elaborata dal ricercatore Umberto
Fracassi) 148 terremoti superiori a 5,5 gradi della scala Richter. E quasi tutti
superiori all’VIII° grado di «intensità epicentrale». Per capirci: di uno
scossone non basta sapere la magnitudo. Occorre anche conoscere la quantità di
danni che ha prodotto. Un calcolo complicatissimo che si può riassumere così:
con l’ottavo grado di intensità epicentrale crolla o diventa inabitabile il 25%
degli edifici, con il nono la metà, con il decimo l’intero patrimonio
immobiliare. L’undicesimo è l’apocalisse. Come a Messina nel 1908. In pratica,
da quando la scienza ha potuto studiare più approfonditamente le attività
sismiche e più ancora da quando sono state conservate precise memorie storiche
dei disastri, la catena che, come scrisse Arrigo Benedetti, «si stacca dal colle
di Cadibona, arriva in Calabria, si immerge e riaffiora in Sicilia», ha dato 19
pesantissimi strattoni nel 1600, 33 nel 1700, 29 nel 1800, 30 nel 1900 e già
sei, con il cataclisma del 23 agosto scorso, in questo primo scorcio del secolo.
In pratica, gli Appennini cantati da Dante Alighieri come monti di grande
fascino ma impervi («Noi divenimmo intanto a piè del monte; quivi trovammo la
roccia sì erta, che indarno vi sarien le gambe pronte») sono stati squassati da
improvvisi e terrificanti sussulti, mediamente, una volta ogni tre anni. La
catena che scende dal Nord fino all’estremo Sud offre panorami di grandissima
bellezza. E prima di Francesco Guccini, che lì «tra i castagni» ha vissuto gli
anni più intensi della vita coltivando un amore sconfinato («La mia è una
montagna in cui la cima più alta arriva sui 2100 metri, dove non c’è roccia,
dove i boschi di castagno e faggio coprono tutto fino a duemila metri») hanno
affascinato molti viaggiatori. Come Wolfgang Goethe. «Gli Appennini sono per me
un pezzo meraviglioso del creato», scrisse nel suo «Viaggio in Italia».
Spiegando che «se la struttura di questi monti non fosse troppo scoscesa, troppo
elevata sul livello del mare e così stranamente intricata; se avesse potuto
permettere al flusso e riflusso di esercitare in epoche remote la loro azione
più a lungo, di formare delle pianure più vaste e quindi inondarle, questa
sarebbe stata una delle contrade più amene nel più splendido clima, un po’ più
elevata che il resto del Paese. Ma così è un bizzarro groviglio di pareti
montuose a ridosso l’una dell’altra; spesso non si può nemmeno distinguere in
quale direzione scorra l’acqua. Se le valli fossero meglio colmate e le pianure
più regolari e più irrigue, si potrebbe paragonare questa regione alla Boemia;
con la differenza che qui le montagne hanno un carattere sotto ogni aspetto
diverso. (…) I castagni prosperano egregiamente; il frumento è bellissimo e le
messi ormai verdeggianti. Lungo le vie sorgono querce sempre verdi dalle foglie
minute; e intorno alle chiese e alle cappelle agili cipressi». Montagne
stupende, montagne inquiete. Maledette troppe volte, giù per i secoli, dai nonni
dei nostri nonni. Costretti a ricostruire ciò che era stato raso al suolo.
Eppure già dal 1570, quando Pirro Ligorio presentò la prima casa «antisismica»
dopo il terremoto di Ferrara, i governanti più accorti avrebbero dovuto sapere
che il rischio andava affrontato con regole precise. Tant’è che nel 1783 la
Commissione Accademica napoletana denunciava che la popolazione calabrese, pur
«avvezza alle scosse di tremuoti», non capiva che occorreva «pensare ad un modo
onde formare le case in guisa che le parti avessero la massima coesione e il
minimo peso» mentre «qui si vedeva precisamente il contrario…». Passarono, le
borboniche «Normative Pignatelli» che puntavano a mettere ordine nel caos. Ma
solo per qualche anno. E quando Pio IX chiese nel 1859 ai suoi ingegneri di
predisporre un nuovo piano edilizio per Norcia, prostrata da un sisma, ci fu un
braccio di ferro fra le autorità e il Comune. Recalcitrante a rispettare le
regole perché vincolavano troppo i proprietari. Si è detto e ridetto anche in
questi giorni: occorre una svolta, bisogna adeguare le leggi a una realtà
difficile, è necessario intervenire con la prevenzione prima che le catastrofi
avvengano… Giusto. Sono passati però 107 anni da quell’aprile 1909 in cui
Vittorio Emanuele III firmò il primo decreto con alcune prescrizioni per le aree
a rischio sismico o idrogeologico. Vietava di «costruire edifici su terreni
paludosi, franosi, o atti a scoscendere, e sul confine fra terreni di natura od
andamento diverso, o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di
roccia compatta». Concedeva qualche deroga ma mai a edifici «destinati ad uso di
alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili». Ordinava che i lavori
dovessero «eseguirsi secondo le migliori regole d’arte, con buoni materiali e
con accurata mano d’opera» e proibiva «la muratura a sacco e quella con
ciottoli»… Puro buon senso. Eppure un secolo dopo, davanti alle macerie di
Pescara del Tronto, Accumoli, Amatrice e le sue contrade, siamo ancora a
chiederci: possibile? Possibile che per decenni si siano continuate a costruire
case destinate a crollare rovinosamente, magari sotto pesantissimi tetti in
cemento armato, al primo dei numerosi terremoti? Il guaio è, spiega Emanuela
Guidoboni, che già allora «non furono previste sanzioni. Dal 1909 ebbe sì inizio
la classificazione sismica del territorio italiano, ma questa classificazione si
faceva solo “dopo”. A disastro avvenuto». Peggio: per decenni «si è proceduto a
macchia di leopardo, con vicende alterne e clamorose retromarce. Vari comuni
classificati a rischio (come Rimini dopo il terremoto del 1916) chiesero infatti
negli anni ‘40 e nel dopoguerra di essere de-classificati. E sapete con che
scusa? Far crescere il turismo!» A farla corta: sì, forse sono necessarie nuove
regole per contenere i danni di questi Appennini stupendi ma collerici. Più
importante ancora, però, è farle poi rispettare. Gian Antonio Stella.
TERREMOTO: CORSI E RICORSI STORICI.
I Borbone? 200 anni fa sconfissero i terremoti, scrive il 30/08/2016
Flaminia Camilletti su “Il Giornale”. Sono passati 7 giorni dalla notte tra il
23 e il 24 Agosto, notte in cui la terra ha tremato così forte da far implodere
e scomparire due paesi ricchi di storia e tradizioni come Amatrice ed Arquata
del Tronto, portandosi via 292 vite umane e una decina di persone scomparse. I
danni agli edifici e i morti non sono confinati nei paesi sopracitati, ma si
diffondono in tutta la zona di confine tra Umbria, Marche e Lazio, tre regioni
diverse e numerosi comuni diversi, sintomo che se qualcosa è andato storto è da
ricondurre ad un sistema Italia che in questo momento così com’è, non funziona.
Neanche il tempo di levare le macerie e di salutare i propri cari, che già si
scoprono decine di casi di mala-gestione edilizia. Addirittura i pm sospettano
che i documenti che dichiaravano che le strutture fossero a norma, siano stati
falsificati. I casi più noti: la scuola Capranica e l’hotel Roma di Amatrice
indicati entrambi come punto di accoglienza del piano di protezione civile, e
invece venuti giù. E poi il campanile di Accumoli, come la Torre Civica e la
caserma dei carabinieri. Parallelamente alle inchieste, il tema principale del
dibattito verte sulla ricostruzione: è possibile rendere antisismici dei centri
storici così antichi, senza snaturarne l’identità ed il patrimonio
architettonico? Molti esperti e opinionisti rimandano all’esempio certamente
virtuoso del Giappone, ma qualcuno, in Italia, rende noto che anche la nostra
storia vanta modelli di ingegneria antisismica di livello, messa in atto già due
secoli fa. Uno studio condotto dal Cnr-Ivalsa (Istituto per la valorizzazione
del legno e delle specie arboree del Consiglio Nazionale delle Ricerche) di San
Michele all’Adige (Trento) in collaborazione con l’Università della Calabria ha
dimostrato che le tecniche antisismiche usate 200 anni fa dai Borbone sono
ancora attuali e che integrate con tecnologie moderne, potrebbero essere usate
per mettere in sicurezza il patrimonio edilizio esistente. Dopo il terremoto del
1783, che distrusse gran parte della Calabria meridionale e fece circa 30.000
vittime fu emanata una normativa estremamente di avanguardia per l’epoca.
L’efficacia di queste disposizioni è stata confermata dalla resistenza che
ebbero i palazzi costruiti con queste regole nei terremoti del 1905 e del 1908
che colpirono la Calabria. Il Cnr ha chiarito che gli edifici costruiti con
queste regole subirono danni non significativi, con limitate porzioni di
muratura collassate e nessun crollo totale. Ulteriore conferma è stata data
anche dal test antisismico condotto su una parete del palazzo del Vescovo di
Mileto (Vibo Valentia), ricostruita fedelmente in laboratorio. “L’invenzione” è
dell’ingegnere La Vega che con abilità di sintesi unisce le più avanzate teorie
antisismiche dell’Illuminismo e una diffusa e antica tradizione costruttiva
lignea presente in Calabria. Il sistema borbonico è caratterizzato infatti dalla
presenza di telai di legno.” “Le tecniche – continua Nicola Ruggieri
(l’architetto che ha prodotto lo studio) – si basavano sull’idea che la rete di
legno, in caso di scossa, potesse intervenire a sostegno della muratura. Adesso
quelle tecniche potrebbero ispirare sistemi antisismici per mettere in sicurezza
il patrimonio edilizio esistente «magari – ha rilevato l’esperto – sostituendo
il legno con alluminio e acciaio, per i quali l’industria è più preparata”.
La “casa baraccata”: il primo regolamento
antisismico d’Europa è dei Borbone, scrive il 25
agosto 2016 Claudia Ausilio su “Vesuvio on line”. Il territorio italiano e
soprattutto quello dei paesi a ridosso della dorsale appenninica sono tra i più
esposti al mondo ad attività sismica e da secoli hanno dovuto fare i conti con i
terremoti e i danni da esso causati. Pochi sanno che le prime case antisismiche
furono fatte costruire dai Borbone che redassero il primo regolamento
antisismico d’Europa. Tutto iniziò dopo il 5 febbraio del 1783, una data
terribile per la Calabria e per il sud intero. Uno degli eventi più tragici
della storia e un terremoto di un magnitudo elevatissimo, tra i più alti che
l’Europa abbia mai visto. Le zone colpite furono quelle di Reggio Calabria, Vibo
Valentia e Catanzaro che videro la morte di 30.000 persone. Il governo borbonico
subito si mise all’opera per la ricostruzione emanando un regolamento
antisismico, il primo della storia. Questo prevedeva la costruzione di una
muratura rinforzata da un telaio di elementi lignei “inventata” dall’ingegnere
Francesco La Vega, definita poi nel corso dell’Ottocento “casa baraccata”.
Questo sistema si basava sugli ultimi studi dell’ingegneria settecentesca e su
una tecnica costruttiva antica già in uso in Calabria. Ma l’ingegnere spagnolo
come ideò questa tecnica antisismica? In realtà non si trattava di niente di
nuovo, ci avevano già pensato gli antichi romani. Agli inizi del XVIII secolo
Carlo III di Borbone decise di avviare un’intensa campagna di scavo ad Ercolano
e successivamente a Pompei e Stabia. Le attività di recupero e lo studio dei
reperti archeologici furono dirette dal 14 marzo 1780 proprio da Francesco La
Vega. Durante queste operazioni l’ingegnere ebbe modo di osservare, proprio
nelle città vesuviane, il cosiddetto Opus Craticium (opera a graticcio) cioè
pareti intelaiate da elementi lignei. Grazie all’impiego di questa soluzione, le
costruzioni successive al 1738, tra le quali anche il Palazzo del Vescovo di
Mileto (Vv), riuscirono a resistere anche ai terremoti più devastanti, come
quelli che colpirono la Calabria nel 1905 e nel 1908 con magnitudo 6.9 e 6 della
scala Richter. Così come le abitazioni turche (Hımış) costruite con la tecnica
dell’intelaiatura lignea hanno sfidato il sisma del 1999.
TERREMOTO ED IMPREPARAZIONE. Mario Tozzi
sul terremoto: "Italia come il Medio Oriente. Una scossa di magnitudo 6 non
dovrebbe provocare questi disastri". Intervista di
Laura Eduati del 24/08/2016 su "Huffingtonpost.it". "Ormai abbiamo osservato che
ogni 4 o 5 anni c'è un sisma che colpisce la dorsale appenninica. Eppure gli
amministratori non fanno prevenzione. Il risultato è che l'Italia è arretrata
come il Medio Oriente: in un paese avanzato una scossa di magnitudo 6 non
provoca crolli e vittime". Mario Tozzi, geologo e noto divulgatore scientifico
in tv, non usa giri di parole contro la politica che a sette anni dal tragico
terremoto dell'Aquila non ha fatto quasi nulla per prevenire il disastro di
questo 24 agosto 2016. La terra ha nuovamente tremato violentemente devastando i
paesi vicini all'epicentro: Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto.
"Le zone dalla Garfagnana a Messina, e cioè la dorsale appenninica, sono tutte
sismiche e appartengono alla stessa regione geologica. L'Italia è un territorio
geologicamente giovane e perciò subisce queste scosse strutturali di
assestamento. Non stiamo dicendo che i terremoti sono prevedibili", puntualizza
Tozzi, "perché sappiamo che è una sciocchezza. Ma stupisce che in una zona
sismica non si faccia quasi nulla per impedire che una scossa di magnitudo 6
possa addirittura far crollare un ospedale come è accaduto ad Amatrice". Non
esiste alcun alibi, continua il geologo: "Non veniteci a dire che i paesini del
centro Italia sono antichi e perciò crollano più facilmente. Gli antichi
sapevano costruire bene e basta pensare che a Santo Stefano di Sessanio, vicino
l'Aquila, era crollata soltanto la torre perché restaurata con cemento armato,
mentre a Cerreto Sannita nel Beneventano quasi tutto era rimasto intatto dopo il
terremoto dell'Irpinia: non fu un caso, era stato costruito bene". Dunque
"siccome ormai è chiaro che dobbiamo avere a che fare con i terremoti dovremmo
costruire e fare una manutenzione antisismica di tutti gli edifici pubblici e
privati, i soldi devono essere impiegati in questo modo: è la priorità",
sottolinea ancora Tozzi, ricordando che "in Giappone e in California con una
scossa simile a quella di Amatrice c'è soltanto un po' di spavento ma non crolla
nulla". Mancati investimenti, fatalismo: il terremoto per Tozzi è soltanto una
delle cause delle decine di morti di questa notte. "Facciamo sempre i soliti
discorsi ma vediamo che non cambia nulla. Siamo il paese europeo con numero
record di frane e alluvioni, siamo territorio sismico eppure per chi ci governa
quando qualcosa succede è sempre una fatalità: bisognerebbe smetterla di pensare
in questo modo e cominciare a ripensare seriamente al territorio".
TERREMOTO E PREVISIONE.
Un sacco di scienziati e complottisti sono andati a letto ieri senza sapere
di aver previsto il terremoto che ha devastato il Centro Italia questa notte.
Oggi, con malcelata soddisfazione, ci comunicano che avevano ragione. Come
sempre. Scrive Giovanni Drogo mercoledì 24 agosto 2016 su "Next Quotidiano”.
Precisi come degli orologi svizzeri questa mattina sono arrivati quelli che
leggono – a posteriori – i dati che indicano chiaramente che la notte passata ci
sarebbe stato un forte terremoto. Dal momento che non è possibile prevedere il
giorno, l’ora o il momento esatto di una scossa (e la relativa magnitudo) si
tratta, nella migliore delle ipotesi, di cattiva informazioni (nella peggiore di
mistificazioni pure e semplici). Spiega infatti l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia che non è possibile fornire previsioni precise utili ad
avvertire per tempo la popolazione. Modelli teorici imprecisi non danno
previsioni precise. Esistono dei segnali, chiamati precursori sismici, che
consentono di poter formulare previsioni approssimative riguardo intervalli di
tempo, di spazio e di magnitudo entro i quali si può verificare con maggiore
probabilità della media un evento sismico. Ma non è detto che poi l’evento si
verifichi davvero o che sia dell’intensità “prevista”. Sono state invece
compilate delle mappe di pericolosità sismica che indicano quelle aree dove a
maggiore rischio (e la zona colpita stanotte è purtroppo una di quelle).
Utilizzando queste mappe è possibile adottare misure preventive (ad esempio
costruire edifici antisismici o mettendo in sicurezza quelli esistenti) per
limitare i danni di un eventuale terremoto. Tutto qui? Purtroppo al momento sì,
perché i modelli teorici non consentono di essere più precisi. I terremoti non
si prevedono, ma è invece possibile – anzi doveroso tenuto conto della
situazione geologica italiana – fare prevenzione. Eppure c’è chi già questa
mattina sottolineava come avesse già previsto la scossa. Spiegando di aver
individuato una ventina di giorni fa un’anomalia che oggi dimostra come al tempo
aveva previsto un terremoto. Ovviamente senza localizzarlo, senza indicare
l’orario o la magnitudo. Il che come previsione non risulta essere
sufficientemente precisa da poter sostenere di avere in mano una prova chiara
del rapporto causa-effetto. Tenendo conto che si sapeva già che la zona colpita
risulta essere ad alto rischio sismico non si tratta di previsioni accettabili,
soprattutto perché – caso comune a molte altre previsioni – vengono
fatte dopo l’evento. Che sulla catena appenninica si possano verificare scosse
di questo tipo è cosa quindi nota, quello che manca di sapere (e che fa la
differenza) è il momento preciso. E questo purtroppo non è possibile
determinarlo in base alle conoscenze scientifiche attuali. Vogliamo parlare di
quello “scienziato” che crede che i terremoti siano causati da perturbazioni
cosmiche e che la causa vada ricercata nel Sole (la soluzione sarebbe
spegnerlo). Un momento, forse potrebbe essere il fracking la causa! Ma ecco che,
quando la scienza non ci dà certezze, arrivano direttamente quelli che credono
nella magia. La grande fiera della cospirazione e della geoingegneria. Come già
accadde in occasione del sisma del 2012 in Emilia Romagna c’è chi crede che sia
possibile prevedere un terremoto guardando la conformazione delle nuvole. Si
tratta di tecniche degne degli antichi romani? Nulla di tutto questo perché c’è
chi ci spiega che le nuvole “orientate” in quel modo non sono naturali ma
vengono create grazie a esperimenti sul campo elettromagnetico, del tipo di
quelli svolti dal famigerato HAARP. Peccato che Terra Real Time, noto sito di
complottisti, indicasse come epicentro del fenomeno la Calabria e non il Centro
Italia. Cose che capitano quando si devono tenere sotto controllo le
macchinazioni del NWO. Curiosamente sul sito le “onde scalari” che hanno
provocato lo “tsunami elettromagnetico” venivano ritenute pericolose soprattutto
per i portatori di Pacemaker. Il loro scopo? Modificare il clima. Nessun accenno
ai terremoti in questa curiosa previsione. Ma naturalmente il NWO non vuole che
si sappia che nemmeno Terra Real Time ha previsto un terremoto. Sarebbe bastato
leggere il – breve – testo del comunicato per accorgersene ma dal momento che si
parla di tsunami e che il termine è associato ai terremoti, ecco servita la
previsione. In mancanza del nostro esperto di fuffa preferito (Rosario
Marcianò è momentaneamente assente da Facebook) non ci resta che consolarci con
le spiegazioni di Gianni Lannes che sul suo sito evoca scenari militari: C’entra
forse qualcosa il programma segreto di aerosolchemioterapia bellica che la NATO
– previo indottrinamento degli esperti civili – manda in onda dal 2002, a base
di irrorazioni aeree di alluminio e bario che rendono l’aria maggiormente
elettronconduttiva, in modo da consentire alle onde elf di colpire le faglie
sismiche attive? Scie belliche e sciami sismici: un distruttivo connubio
militare. […] I terremoti possono essere provocati anche dall’uomo con vari
mezzi e sistemi, soprattutto in aree notoriamente a rischio sismico che spesso
mascherano la reale dinamica dell’evento tellurico: esplosioni convenzionali e
nucleari, iniezioni elettromagnetiche nella crosta terrestre, riscaldamenti
ionosferici, ricerca ed estrazione di idrocarburi. Un terremoto indotto presenta
distintamente un ipocentro superficiale.
IL TERREMOTO E L'INFORMAZIONE. Il
terremoto e l'informazione: il coraggio del rigore.
Basta con la falsa par condicio: non ci interessano tutte le opinioni, ci
interessano le opinioni di chi sa di che cosa parla. Altrimenti, davvero, basta
un click: ma stavolta per spegnere questo frastuono assordante di falsità,
scrive Roberto Saviano il 30 agosto 2016 su “La Repubblica”. Ora che abbiamo
capito che sul web, insieme alla stragrande maggioranza di normalissimi
navigatori, ci sono anche "hater" e "webeti", odiatori e creduloni, possiamo
iniziare a fare il nostro lavoro. Possiamo recuperare una regola aurea, poco
cinica, quindi se volete poco in linea con i tempi, ma che io credo debba essere
il nostro punto di partenza e il nostro fine: avere rispetto per il lettore, per
il telespettatore, per il cittadino. E ora che abbiamo tutti riscoperto la
correttezza sui social, quella netiquette che sembrava ormai naufragata e
irrecuperabile, cerchiamo anche di applicarla dove veramente serve e dove può
fare la differenza: la televisione, la carta stampata, i siti di informazione e
il nostro modo di conoscere e interpretare il mondo. I social, si sa, mostrano
sempre reazioni schizofreniche quando commentano un avvenimento, perché non
hanno un'anima sola. Sui social c'è chi la pensa esattamente come me e chi la
pensa nel modo opposto. Sui social c'è chi legge e basta e chi non legge e
commenta. C'è chi ha un atteggiamento conciliatorio e chi cerca lo scontro. Non
è detto che sui social chi è combattivo e alza i toni lo faccia anche nella vita
relazionale, come è vero che ciascuno di noi cambia tono, argomenti,
comportamento a seconda della situazione in cui si trova, del contesto, degli
interlocutori. E i social, con la loro empatia, la loro rabbia, il loro livore,
la loro delicatezza e la loro violenza, si sono confrontati con le conseguenze
del terremoto. Ma come? Raccogliendo e rilanciando di tutto e di più, com'è
nella natura di questa "rete" senza rete: anche tante accuse, offese, notizie
non provate. Ma si può dire, forse, che tutto ciò che è venuto prepotentemente
fuori sui social dopo il terremoto possa essere letto, quasi fosse una cartina
di tornasole, come il conto presentato all'informazione italiana, cioè al modo
in cui ha trattato i suoi utenti, oltre che agli utenti stessi, che hanno
abdicato alla loro funzione di controllo. Sì, la realtà che il terremoto nel
centro Italia ha portato alla luce è amara e tragica, e lo è ancora di più
perché dopo la strage dell'Aquila (riesce qualcuno di voi ancora a chiamarlo
semplicemente terremoto?) tutti sapevamo quali fossero i rischi, le probabilità
che la strage si ripetesse, e nessuno, o quasi, ha fatto nulla. Certo, abbiamo
avvertito i nostri lettori, spettatori e navigatori sui rischi della
ricostruzione, abbiamo detto che si sarebbe dovuto mettere a norma gli edifici,
almeno quelli pubblici, nei territori a rischio. Ma, poi, chi è andato davvero a
controllare fino in fondo? Quanti di noi lo hanno fatto? Certo, un terremoto non
si può prevedere: ma i danni si possono e si devono arginare, si possono
prevedere i suoi effetti. E l'informazione ha avuto una progressione da manuale:
il "rispettoso silenzio" - e sacrosanto - la netiquette, mentre ancora si
estraevano i corpi dalle macerie, hanno lasciato il posto ai j'accuse soliti,
sempre uguali. Alle interviste agli esperti, alle omelie dai pulpiti. E nel
momento della caccia alle streghe non c'è nessuno che sappia riconoscere la
strega che alberga in se stesso. Ora tutti si affannano a dire che dopo L'Aquila
(quindi dal 2009) i soldi c'erano ma che sono stati spesi male. Ma questo lo
sapevamo già: lo immaginavamo. E lo sapevamo perché sapevamo che non c'è stato
alcun serio controllo, sapevamo che i controllori hanno rapporti con i
controllati, e che spesso hanno un tornaconto per cui quindi si chiude un
occhio, e a volte due. Domanda: perché è dunque successo tutto questo? Che cosa
non ha funzionato? Quali meccanismi sono scattati, o meglio non sono scattati,
nel nostro sistema di difesa, che nel nostro caso si chiama anche sistema di
informazione? Intanto, le vittime di oggi forse sono anche vittime della crisi,
perché solo in pochi hanno ammesso che la messa in sicurezza di Norcia è
avvenuta in un'altra epoca. Ma continuando ad analizzare il rapporto tra social
e informazione, è evidente che non possiamo affidare la correttezza della
seconda ai primi: sarebbe come voler arginare il mare, in mare. È ovvio che in
un Paese come l'Italia tutto deve ripartire necessariamente dall'autorevolezza
dei media. Ora che abbiamo evidenziato il webetismo ("webete", termine coniato
da Enrico Mentana) facciamo dunque un passo avanti, e smettiamo di dare voce
(non è censura, non lo è affatto) ai disinformatori di professione, a chi non ha
alcun talento se non quello di andare in televisione, fare polemica, alzare quel
tanto che basta la curva degli ascolti facendo danni che spesso sono
irreparabili. La televisione è un opinion maker importantissimo, imprescindibile
nel nostro Paese: si assumano allora le reti pubbliche e private la
responsabilità di dare voce a chi parla perché sa, a chi dà informazioni
verificate e verificabili. E si smetta di dare credito a chi diffonde leggende
metropolitane (Giorgia Meloni che invita alla donazione del jackpot del
Superenalotto per ricostruire Amatrice), a chi semina odio (Matteo Salvini sui
migranti e i loro falsi soggiorni in hotel a cinque stelle). Mentre seppelliamo
i morti di Amatrice, sta per iniziare una nuova stagione televisiva, un nuovo
anno per l'informazione e l'intrattenimento. Il mio invito, che è spero anche la
pretesa di chi mi legge, si chiama rigore: rigore nell'intrattenimento e rigore
nell'informazione. Certo, anche nell'intrattenimento: perché leggerezza e
evasione sono cose legittime, ma il rigore e la correttezza devono esserne
sempre la cifra. Il mio invito, e la pretesa di chi ci legge, è quello di
chiudere la porta alle leggende metropolitane in tv (vaccini che causano
autismo, scie chimiche, Club Bilderberg), a quei discorsi infiniti, a ore e ore
di parole che dette con leggerezza fanno danni incalcolabili. Il mio invito, e
la pretesa di chi ci legge, è la richiesta di una informazione che davvero
"serva": servizio privato e pubblico vero, orientato a un dibattito pubblico
oltre i dettami di questo storytelling forzatamente positivo, da strapaese, e
che tollera anche la fandonia, la falsa notizia, quella che fa più scalpore - e
magari più click. Se crollano interi paesi, è anche (sottolineo anche: stiamo
parlando di un terremoto) perché nonostante i fondi stanziati i lavori non sono
stati mai fatti, e non sono stati fatti a dovere, nel silenzio di chi avrebbe
dovuto controllare (e raccontare). Basta con la falsa par condicio: non ci
interessano tutte le opinioni, ci interessano le opinioni di chi sa di che cosa
parla. Altrimenti, davvero, basta un click: ma stavolta per spegnere questo
frastuono assordante di falsità.
TERREMOTO E SATIRA. «Terremoto
all’italiana», è un caso la vignetta di Charlie Hebdo.
Nel numero in edicola satira sulla tragedia di Amatrice: lasagne e pasta per
illustrare il dolore per le 300 vittime. La rete si indigna: «Io non sono
Charlie». L’ambasciata: «Non ci rappresenta». Poi la precisazione: «Italiani, a
costruire le vostre case è la mafia», scrive Antonella De Gregorio il 2
settembre 2016 su "Il Corriere della Sera". Oggi nessuno «è Charlie Hebdo». La
solidarietà dopo gli attentati che hanno colpito il giornale nel gennaio del
2015 si squaglia sui social, lasciando spazio all’indignazione più viscerale.
Scatenata dalla vignetta che il settimanale in edicola dedica al terremoto in
Italia. Nell’immagine, intitolata «Séisme à l’italienne» («Terremoto
all’italiana») le vittime del terremoto che ha sconvolto il nostro Paese vengono
paragonate a tre piatti tipici della nostra cultura: «Penne all’arrabbiata»,
illustrato con un uomo sporco di sangue; «Penne gratinate», con una superstite
coperta di polvere; mentre le lasagne sono strati di pasta alternati ai corpi
rimasti sotto alle macerie. La vignetta firmata dal vignettista Felix è
pubblicata nell’ultima pagina del numero in edicola della rivista satirica, che
ha in copertina una vignetta sul burkini: il «sacco di patate che unisce la
sinistra». In fondo al giornale, nella pagina tradizionalmente intitolata «le
altre possibili copertine», la sciagura in Italia viene affrontata con freddure
tipo: «Circa 300 morti in un terremoto in Italia. Ancora non si sa che il sisma
abbia gridato “Allah Akbar” prima di colpire». La polemica è esplosa. E a poco
sono valse le scuse ufficiali della diplomazia d’Oltralpe. «Il disegno
pubblicato da Charlie Hebdo non rappresenta assolutamente la posizione della
Francia» si legge in una nota dell’ambasciata francese a Roma, che sottolinea
che il terremoto del 24 agosto è «un’immensa tragedia» e rinnova le condoglianze
alle autorità e al popolo italiano, al quale «ha offerto il suo aiuto». Su
Twitter, tantissimi quelli che giudicano la vignetta «sconvolgente»,
«indecente», e chiedono rispetto per le vittime. C’è chi pubblica l’immagine a
fianco della scritta «Io non sono Charlie». Chi commenta: «Hebdo oggi ha toppato
alla grande», e «Cosa ci sia da ridere su questa vignetta poi ce lo spiegate».
Ma anche chi difende la scelta («Siamo tutti Charlie finché Charlie non sfotte
noi») e commenta: «Se non tocca alla pancia non è satira. È solo un disegno
insignificante». Trovando, magari, più scandalosi «le interviste sceme, lo show
morboso del dolore andato in scena in questi giorni». Si riapre insomma il
dibattito sui confini dell’ironia. Rispetto, cattivo gusto, libertà di
esprimersi, censura: ognuno in rete dice la sua. «Le vignette di #CharlieHebdo
servono proprio a far indignare chi viene “colpito”. Lo fanno per lavoro, non lo
scordiamo», sottolinea un utente di Twitter. Mentre un’interpretazione taccia di
«analfabetismo funzionale» tutti coloro che non han capitole intenzioni degli
autori della vignetta: «Edifici costruiti con la sabbia (“penne gratinées”) che
quando crollano si riducono e ti riducono a strati di lasagna. Ecco i sismi
all’italiana - scrive Pasquale Videtta - in cui nemmeno le scuole anti-sismiche
sono tali. L’analfabetismo funzionale è quella cosa che ti fa scambiare la
vignetta di Charlie Hebdo per una derisione delle vittime del terremoto e non
per una denuncia politica e sociale». Spiegazione «esegetica» che sono gli
stessi giornalisti della rivista francese a confermare, con un colpo a sorpresa,
a poche ore dal polverone mediatico. Nel pomeriggio, dopo la valanga di
contestazioni, sulla pagina Facebook ufficiale, Charlie Hebdo pubblica una
vignetta «di precisazione» firmata «Coco». Vi compare una persona insanguinata
sotto le macerie, come nel disegno contestato, che si rivolge al lettore:
«Italiani...non è Charlie Hebdo che costruisce le vostre case, è la mafia!». «È
una vignetta in cui non trovo niente da ridere», ha commentato il Commissario
per la ricostruzione post terremoto Vasco Errani. «Io sto vivendo questa
situazione con la popolazione - ha sottolineato - e sono certo che i cittadini
che stanno vivendo questa tragedia non trovino niente da dire e da ridere come
me. La vignetta aumenta la sofferenza di queste persone». Sconforto dal sindaco
di Amatrice, Sergio Pirozzi: «Ma come si fa a fare della satira sui morti? La
satira è satira quando fa ridere e qui mi sembra che non ci sia proprio nulla da
ridere, visto che è pieno di morti». Certo Charlie Hebdo non è il primo pensiero
del primo cittadino del comune sconvolto dal sisma. E per un po’ Pirozzi si è
disinteressato alla questione. Ma poi, davanti ai giornalisti che lo
incalzavano, è sbottato: «La satira è una cosa bella, ben venga l’ironia. Ma
come si fa... qui c’è soltanto del cattivo gusto». Con lui si esprime anche la
politica: «Vignetta lugubre, disumana, indegna, da rispedire al mittente»,
scrive in una nota la deputata Pd Vanna Iori. Giorgia Meloni, presidente di
Fratelli d’Italia, sul suo account Facebook liquida la vicenda così: «Non fa
ridere, non è sagace, non c’è neppure del “sarcasmo nero”. È solo brutta. Si
vede che l’ha fatta un cretino. Mi spiace non siano riusciti più a trovare
vignettisti capaci». E Michele Anzaldi (Pd), chiede scuse ufficiali: «Ci
aspettiamo che la Francia, a partire dalle sue istituzioni — dichiara — prenda
le distanze da una vignetta che rinnova il dolore nelle tante famiglie italiane
che hanno subito il grave lutto del terremoto». Scuse che l’ambasciatore
francese si è affrettato a trasmettere.
#JeSuis Charlie sempre. Anche se non ci
piace. Chi stabilisce i confini della decenza quando
si parla di satira? Perché non possiamo gridare alla censura nonostante i
contenuti oltraggiosi o che ci paiono una porcheria, scrive Pierluigi Battista
il 2 settembre 2016 su "Il Corriere della Sera". #JeSuisCharlie anche se
«Charlie Hebdo» pubblica vignette volgari e oltraggiose. Perché la libertà
d’espressione è anche diritto alla volgarità. Naturalmente deve esistere una
reciprocità di diritti: se la satira vuole vedere riconosciuto quello
dell’irriverenza assoluta e offensiva, deve anche riconoscere il diritto altrui
a criticare le schifezze che si pubblicano in nome della satira. Se noi
volessimo rispettare solo la libertà di ciò che ci aggrada, non ci vorrebbe un
grande sforzo. Lo sforzo è riconoscere la libertà di dire e disegnare e
rappresentare cose opposte a quelle che pensiamo e che consideriamo giuste,
buone, persino sacre. Dicono: ma non si oltrepassino i confini della decenza. Ma
chi stabilisce questi confini? La censura è per definizione il campo
dell’arbitrio, della discrezionalità, della prepotenza di chi pretende di
incarnare il Giusto e il Buono. E allora, dobbiamo accettare passivamente le
volgarità sui nostri morti sepolti dal terremoto? Certo che no, nessuna
passività. Possiamo dire attivamente che si tratta di una porcheria. Oppure
possiamo avvalerci di quell’altra fondamentale libertà che sarebbe da stolti
dimenticare, e cioè la libertà di non comprare un vignettificio che non ci
piace. Non vuoi «Charlie Hebdo»? Non andare in edicola a comprarlo. Questa è la
libertà, a meno che uno non sia costretto a pagare cose che non vuole vedere,
come avviene con il canone Rai. Quando c’è la sfida dei fanatici jihadisti che
vogliono toglierci ogni libertà, bisogna essere rigorosi nel difendere ogni
libertà. Compresa quella che non ci piace. Perciò #JesuisCharlie, anche se
stavolta sono stati dei veri farabutti.
Charlie Hebdo, perché li critico. «Non si
calpestano così 300 morti», scrive Giannelli il 2
settembre 2016 su "Il Corriere della Sera". La vignetta pubblicata in ultima
pagina dal settimanale satirico francese Charlie Hebdoa firma Felix non mi è
piaciuta. Mi perdonerà il collega vignettista ma, a mio parere, se pur sia ben
consapevole che la satira è trasgressione assoluta, tragedie come quelle del
terremoto che ha colpito il Centro Italia è obiettivamente difficile che possano
giustificare spunti satirici di questa specie. È trasparente il messaggio che la
vignetta vuole dare: una condanna degli italiani spaghettari. Ma per insistere
su questo consueto stereotipo, mi sembra sia stato di cattivo gusto calpestare
trecento morti. E che la critica non sia altro che una riaffermazione dei
consueti stereotipi sul nostro Paese, lo dimostra la seconda vignetta,
pubblicata nel pomeriggio sull’account Facebook del settimanale, nella quale il
disegnatore Coco Charlie Hebdo ha chiamato in causa la mafia. Niente di nuovo
quindi rispetto alla copertina di tanti anni orsono del settimanale tedesco Der
Spiegel che raffigurava l’Italia come un piatto di spaghetti con una rivoltella
sopra. È vero che una vignetta è solo uno scherzo, una irrisione e trovo quindi
sproporzionato e ridicolo che si parli di severa condanna e di giusta
indignazione, con l’ambasciata transalpina in Italia a puntualizzare che «non
rappresenta assolutamente la posizione della Francia». Ci deve essere però anche
libertà di critica perfino nei confronti della satira e da vignettista ammetto
che non sempre si possono avere idee felici; è fatale. Nel caso specifico, avrei
trovato più giusto che la prima vignetta fosse firmata Infelix.
Satira sul terremoto, Pennac: "Disegno
idiota, ma difendo ancora la libertà di Charlie Hebdo".
L'intervista. La bocciatura dello scrittore: "Non mi piace chi gioca con la
morte degli altri", scrive Francesca De Benedetti su "La Repubblica" il 03
settembre 2016. Una "connerie", uno scivolone in piena regola: così Daniel
Pennac, lo scrittore francese, commenta la vignetta di Charlie Hebdo sul
terremoto in Italia. Lui, l'autore della saga dei Malaussène e di altre opere di
successo, è abituato a giocare con ogni sfumatura del linguaggio. Ma stavolta
per commentare la satira dei suoi connazionali sul sisma non usa mezzi termini,
anzi si concede un paio di parole forti. Poi però conclude: "Anche oggi, "Je
suis Charlie". Una vignetta idiota non può togliere forza a quel messaggio, che
non va messo in discussione".
Pasta e sangue, poi la mafia: è la chiave con
cui Charlie "legge" il terremoto in Italia. Cosa ne pensa?
"La vignetta sulle vittime del terremoto è
stronzissima e basta. Non è divertente, non fa ridere nessuno se non chi l'ha
concepita, quasi non merita il nostro sdegno".
La satira non giustifica il ricorso agli
stereotipi e le provocazioni violente?
"Vede, io penso che neppure la satira dovrebbe
calpestare una cosa importante: l'empatia. Penso alle vittime delle scosse,
penso alle sofferenze di quelle terre, e non posso non concludere che quelle
vignette mancano di rispetto a quel dolore, a quelle storie. Non mi piace chi
gioca con la morte degli altri. Penso al fatto che proprio oggi avrei dovuto
essere in un paesino umbro per un'iniziativa culturale; Castello di Postignano
si trova non lontano dai borghi distrutti, la gente è andata via per paura di
nuove scosse. Abbiamo sospeso l'evento, perché la prima cosa da mostrare, di
fronte a tragedie come questa, è l'umanità, la solidarietà".
Fa bene l'ambasciata di Francia a prendere le
distanze dalle vignette? Hanno ragione gli italiani indignati?
"Se lo chiede a me, le dico di sì, perché non
gradisco né quella vignetta né in generale un certo humour sulla morte. Va detto
che con Charlie tutto ciò non è una novità. Non è una novità un certo stile, che
già altre volte mi ha suscitato una sensazione di disagio, anche se non detesto
il giornale in sé e non amo le condanne definitive".
Qualcuno è arrivato a dire: "Je ne suis pas
Charlie", "Non sto più con Charlie".
"L'espressione "Je suis Charlie" è diventata il
simbolo dell'opposizione radicale e senza mezzi termini all'assassinio di
giornalisti e disegnatori. Una vignetta, per quanto idiota, non giustifica
affatto la messa in discussione di questo principio. Con la stessa chiarezza con
cui dico che quel disegno non mi piace, sono pronto anche ad affermare senza
mezzi termini: "Io resto Charlie". A ognuno le sue responsabilità morali: chi
offende i morti ha le sue, e noi abbiamo le nostre. È nostro dovere ribadire
ogni giorno che nulla autorizza l'uccisione di chi fa satira e che niente può
giustificare un massacro come quello dei giornalisti e disegnatori di Charlie.
Non possiamo esserne complici: ecco perché io - anche oggi - sono Charlie".
La vignetta di Charlie Hebdo non mi
piace, ma difendo la libertà di espressione. Siamo una
civiltà superiore. Nessuno ucciderà chi sta dietro a quel disegno, scrive
Camillo Langone, Sabato 03/09/2016, su "Il Giornale". Quelli di Charlie Hebdo
vogliono proprio mettere alla prova il famoso detto di Voltaire: «Non sono
d'accordo con quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a
dirlo». L'affermazione del filosofo suona un po' troppo roboante (e infatti pare
che il testo originale, prima di diventare una formula, fosse più trattenuto),
però il concetto non può non essere condiviso da chiunque ami la libertà. Io per
Charlie Hebdo non sono disposto a morire, è inutile che faccia il gradasso, ma a
correre qualche piccolo rischio sì. Quando nel gennaio dell'anno scorso la
redazione del settimanale satirico francese venne sterminata dai coranisti a
colpi di fucile mitragliatore AK-47 scrissi che i caduti andavano considerati
martiri della libertà di espressione. Ne sono ancora convinto. E proprio perché
ieri ho preso le parti dei vignettisti contro gli islamisti e gli islamofili
oggi posso tranquillamente dirmi in disaccordo con le vignette sul terremoto di
Amatrice e di Arquata. Ammetto di essere poco spiritoso e sarà per questo che
poco ho apprezzato la vignetta intitolata «Sisma all'italiana» apparsa sul
settimanale: a sinistra un uomo insanguinato sotto la scritta «Penne al
pomodoro», al centro una signora bruciacchiata o impolverata o chissà (nella mia
vita ho visto vignette disegnate meglio) sotto la scritta «Penne gratinate», e
infine, a destra, quattro morti schiacciati fra strati di macerie e dunque posti
sotto la scritta «Lasagne». Qualcuno ha riso? De gustibus. Non che il dettaglio
abbia soverchia importanza, ma la grossolanità satirica stavolta si abbina alla
grossolanità gastronomica: non ci vuole una laurea all'università Slow Food di
Pollenzo per sapere che Amatrice con le penne c'entra poco e con le lasagne
nulla e che il famoso sugo che dal paese appenninico prende il nome condisce di
norma i bucatini. Meglio dirlo piano, non vorrei offrire spunti a uno dei loro
vignettisti senza scrupoli, settimana prossima non vorrei vedere stampato un
piatto di bucatini con un macabro ragù a base di terremotati macinati, e poi
magari ritrovarmi qui a discettare sul fatto che il sugo all'amatriciana non è
propriamente un ragù. Me la vorrei risparmiare una simile disquisizione e mi
sarei voluto risparmiare anche la presente su penne e lasagne non filologiche,
non tipiche, eppure qualcosa di buono da questo sgradevole episodio vorrei
ricavarlo. Ex malo bonum, dicevano gli antichi. Dall'ultima vignettaccia di
Charlie Hebdo traggo la dimostrazione della nostra appartenenza a una civiltà
superiore perché nessun terremotato italiano entrerà nella redazione parigina
sparando all'impazzata e gridando «Amatrice è grande». Ci sono state e ci
saranno reazioni critiche, e ci mancherebbe, ci sono state e ci saranno
manifestazioni di sdegno, legittime pure queste, ancor più se provenienti da
persone che nella tragedia hanno perso famigliari, amici, case. Ma niente di
più. Gli italiani sono dunque un popolo voltairiano? Non voglio esagerare, non
li direi così filosofici, ma senz'altro non sono capaci di meditare vendette
collettive (durante la Seconda guerra mondiale vennero invasi dai tedeschi e
bombardati dagli americani, eppure nel Bel Paese i turisti provenienti dalla
Germania e dagli Usa sono sempre stati accolti benissimo). Semplicemente,
stavolta, non sono Charlie.
Ma la vignetta non è piaciuta neppure a un maestro
della satira come Sergio Staino che, in un’intervista all’Ansa, ha commentato:
“Penso che sia una vignetta in linea con la storia di Charlie Hebdo. Non è la
prima volta che, per una scelta provocatoria, decidono di andare contro tutto e
tutti in momenti di grande dolore”. Per Staino il giornale “ha voluto legare il
vecchio stereotipo del paese dei maccheroni alla tragedia, ma il risultato è di
basso livello. Neanche un ubriaco o il pazzo di quartiere farebbe una cosa
simile, che senso ha? Prendo le distanze da un intervento creativo che non ha
alcun senso, almeno per come intendo io la satira”.
Mentana definitivo sulla
vignetta-vergogna: "Basta dire che...". Così chiude la bocca a tutti,
scrive “Libero Quotidiano" il 2 settembre 2016. La satira piace a tutti, almeno
finché non si è il soggetto preso di mira. Eppure sembra ieri che mezzo mondo
occidentale agitava la scritta #Jesuischarlie, poco dopo gli attentati islamici
del gennaio 2015 contro la rivista satirica francese. Stavolta quella stessa
rivista ha colpito gli italiani, in particolare le vittime del terremoto in
centro Italia raffigurati come una lasagna fatta di corpi e macerie. Contro
l'indignazione ad orologeria di tanti che sul web hanno insultato i vignettisti
francesi si è scagliato Enrico Mentana che sulla sua pagina Facebook ha scritto:
"Scusate, ma Charlie Hebdo è questo! Quando dicevate 'Je suis Charlie'
solidarizzavate con chi ha sempre fatto simili vignette, dissacrando tutto e
tutti. Le vignette su Maometto anzi facevano alla gran parte degli islamici lo
stesso effetto che ha suscitato in tutti noi questa sul terremoto. Fu Wolinski,
una delle vittime dell'attacco terrorista del gennaio 2015, a far capire ai
colleghi italiani quarant'anni fa che la satira poteva essere brutta sporca e
cattiva. Vogliamo rompere le relazioni con la Francia dopo aver marciato in loro
difesa? Basta più laicamente dire che una vignetta ci fa schifo".
La reazione. Libero Quotidiano del 3
settembre 2016: "Ci viene voglia di sparargli. Il Tempo pubblica un disegno.
La vignetta satirica che sfotte i morti del terremoto del Centro Italia
pubblicata dal settimanale satirico Charlie Hebdo ha sollevato moltissime
polemiche e reazioni. Libero in edicola oggi lancia una provocazione: "Viene
voglia anche a noi di sparargli" titola in prima pagina sopra la foto con la
disgustosa vignetta. Il Tempo, pubblica a sua volta una vignetta che fa
riferimento alle tante vittime del terrorismo che titola "Tartare à la
parisienne". Due titoli forti per rispondere a una vignetta che definire di
cattivo gusto è davvero poco.
Charlie Hebdo e la satira senza limiti.
Eccessi e pessimo gusto come regola. Il settimanale
satirico francese ha origine come foglio libertario negli anni Settanta. Da
rivista di nicchia, dopo l’attentato del gennaio 2015 è diventata nota
globalmente, scrive Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi, il 2 settembre
2016 su "Il Corriere della Sera". «Charlie Hebdo» torna a fare parlare di sé
anche fuori dalla Francia, come spesso gli accade dopo la notorietà planetaria
acquistata suo malgrado con i 12 morti del 7 gennaio 2015. Stavolta
l’indignazione riguarda una vignetta sul terremoto in Italia, pubblicata a
pagina 16, l’ultima, dedicata come sempre alle «copertine alle quali siete
sfuggiti», cioè ai disegni che sono stati valutati per la prima pagina ma poi
scartati. Nell’ultimo numero, la caricatura principale è dedicata al giornalista
Edwy Plenel, alla ministra Najat Vallaud Belkacem e all’ecologista Cécile Duflot
a braccetto sulla spiaggia sotto la scritta «Burkini - il sacco da patate che
unisce la sinistra». Il titolo è «Sisma all’italiana», sotto ci sono tre
versioni macabro-culinarie degli effetti del terremoto: penne al pomodoro, penne
gratinate e lasagne, giocando su sangue/salsa. La vignetta ha provocato reazioni
indignate su Twitter, molti hanno fatto sapere di «non essere più Charlie»,
ricordando l’ondata di emozione e solidarietà che avvolse la redazione dopo
l’attentato, quando milioni di persone proclamavano lo slogan «Je Suis Charlie».
La derisione verso tutto e tutti, anche le tragedie, è sempre stata una
caratteristica di Charlie Hebdo. Accanto alla vignetta sul terremoto, ce n’è una
sui migranti a Calais che ormai hanno superato quota 10 mila: una lunghissima
fila di persone davanti alla toilette, la scritta «le forze dell’ordine sono
travolte» e tre mosche che dicono «anche noi!». Poi, due vignette sul surfista
attaccato dagli squali alla Reunion. All’interno, a pagina 2, un grande disegno
sul rientro a scuola, con un esibizionista che apre l’impermeabile davanti ai
bambini e un agente della sicurezza che controlla lo zaino di un allievo:
«droga, cianuro, siringhe, alcol… niente cintura di esplosivo, potete andare».
Lo scorso gennaio, il direttore Riss (che ha preso il posto di Charb rimasto
ucciso nell’attentato) ha disegnato la figura riversa sulla sabbia di Aylan
Kurdi, il bambino siriano di tre anni morto a Bodrum, in Turchia, mentre cercava
con il padre e il fratello di raggiungere l’Europa. «Che cosa sarebbe diventato
il piccolo Aylan se fosse cresciuto?» si chiede il vignettista. La risposta: «Un
palpatore di sederi in Germania». Il riferimento è ai fatti del 31 dicembre di
Colonia, dove decine di donne sono state molestate da gruppi di stranieri. La
zia Tima Kurdi, che vive in Canada, protestò: «Speravo che le persone
rispettassero il nostro dolore. È stata una grande perdita per noi. Cerchiamo di
dimenticare e di guardare avanti. Ma ferirci un’altra volta è ingiusto». Pochi
mesi prima, a settembre 2015, il giornale aveva pubblicato altre due vignette su
Aylan. Non si contano i disegni su preti, suore, islamici, atei, omosessuali,
eterosessuali, politici, celebrità varie, persone comuni. Charlie Hebdo non si è
mai posto limiti. A settembre 2015 Luz, altro sopravvissuto del massacro del 7
gennaio, aveva preso le difese di Riss con una specie di editoriale a fumetti
intitolato «il disegno satirico spiegato agli idioti»: «Fai parte dei milioni di
“nuovi lettori” che hanno scoperto Charlie e il suo umorismo dopo gli attentati
di gennaio. Non avremmo mai immaginato che ti saresti interessato al nostro
lavoro». In effetti, Charlie Hebdo non è un pensoso, pacato e autorevole
settimanale di approfondimento dal quale pretendere senso di responsabilità o
eleganza, ma un foglio libertario fondato negli anni Settanta, che ha fatto
dell’eccesso e del pessimo gusto uno dei suoi tratti costanti. Per questo aveva
un pubblico di nicchia ma è diventato suo malgrado – c’è voluto l’attentato
islamista - una testata nota in tutto il mondo, scrutata e commentata da lettori
e osservatori che prima mai si sarebbero sognati di andare in edicola a
comprarne una copia. Lo slogan «Je Suis Charlie» non ha mai voluto dire adesione
incondizionata all’umorismo surreale di Charlie Hebdo, ma una scelta di campo
dalla parte della libertà di espressione e contro i terroristi. Liberi i
disegnatori di Charlie Hebdo di dissacrare tutto e tutti, liberi i lettori di
non amare le loro vignette e non comprare il giornale.
Ma quale satira? Questa è merda!
Scrive Emanuele Ricucci su “Il Giornale” il 2
settembre 2016. Adesso: quanti di voi sono Charlie? Quanti di voi si sentono
Charlie? Neanche il dramma colpisce la redazione della testata francese di
satira. Non la ferma, non la frena, in un vomitoso impeto infantile, frutto di
una comunicazione adolescente, pretenziosa, mai cresciuta, impulsiva. Così, dopo
essersi chiesti se il terremoto, prima di colpire “abbia urlato Allau Akbar”,
ecco comparire nell’edizione del 31 agosto di Charlie Hebdo, nella sezione “Le
altre possibili copertine”, la vignetta, “sisma all’italiana”: un ferito
insanguinato con la didascalia “Penne al pomodoro”, un’altra con quella “Penne
gratinate”, i corpi sepolti con la scritta “Lasagne”, così come riporta, fra gli
altri, Il Messaggero. Ah, che belle risate. E che riflessione arguta. Ma quale
satira? Questa è merda. Pura, purissima merda chic, partorita dalla mente del
democraticissimo progresso secondo cui non ci sono vincoli, nella comunicazione,
né tabù e la moralità, il buon senso, il buon gusto, ci stanno stretti, come
antichi orpelli ormai in disuso. Cosa voleva comunicare Charlie Hebdo? Forse
voleva solo incarnare il motto di un altro paladino delle Belle Menti, Dario Fò,
un proletario col culo degli altri: “Prima regola: nella satira non ci sono
regole”, fintanto che, ovviamente, non colpisce gli agitatori del politicamente
corretto. Cosa è satira nel grande mondo liberale e libertino, poco libero? E
cos’è oltraggio? Ma non è con i francesi che dobbiamo prendercela – vicini,
solidali: amico mio, connazionale, prova ora a sentirti un pochino CHARLIE
HEBDO, se ne hai il coraggio. Nota di servizio: Ah, scusate. Date ragione a
Charlie, andateci un pochino forzatamente contro corrente. Giusto un po’
coattamente come il giocatore di flipper di Carlo Verdone in Troppo forte; in
fondo noi, poveri, non abbiamo colto la sottigliezza alla base della vignetta di
Charlie Hebdo, di come le vittime siano cibo per speculatori e un sisma sia
appetitoso, oppure di come c’abbiano sparato la verità in faccia sulle case
fatte di merda (e dalla mafia), con la sabbia di mare anziché con i ciottoli di
fiume, nella seconda vignetta. La moralina d’oltralpe, esposta anche male, male,
è un po’ troppo. Scusate la nostra pressappochezza nazionalista nel vedere una
mano troppo pesante irridere con troppa facilità chi stava dormendo ed è morto
sfracellato, perdonate il nostro sdegno nel vedere cotanta filosofia espressa in
tratti di matita. Lasciateci essere dei vermiciattoli (o dei giornalai
imperfetti) della non comprensione e siate Charlie, siate un po’ quel che
caspita vi pare. A chi verrebbe in mente di irridere i migranti che si
abbandonano alle acque del Mediterraneo? Mi perdoneranno gli intellettuali, mi
perdonerà chi si è rotto la favetta della polemica o chi glissa elegantemente:
et voilà. Perdoneranno l’impeto del povero umile.
I fantasmi del politically correct,
scrive Luigi Iannone il 3 settembre 2016 su “Il Giornale”. Alcune anticipazioni
de L’ubbidiente democratico, il mio nuovo libro in uscita il 12 settembre. <<
(…) incantatori di serpenti, teologi del buonismo e della correttezza politica
sono la stragrande maggioranza e condizionano la formazione delle coscienze. Da
parte loro c’è un’ossessione continua perché, in genere, il politicamente
corretto si compone di fantasmi che si agitano al solo proferire delle ovvietà:
provate, provate a dire che Cécile Kyenge è stata fatta ministro per il colore
della sua pelle; che le quote rosa (e, in subordine, le donne capolista) sono
una stupidaggine, oltre che una forma di razzismo al contrario; che al Ministero
delle Pari opportunità ci va sempre una donna per fare la foglia di fico; che
Rosario Crocetta fece una campagna elettorale costruita anche sul fatto che in
una terra ‘arcaica’ come la Sicilia si presentava a Governatore un omosessuale,
mentre delle proposte programmatiche si sapeva poco o nulla; provate a dire che
i milioni gettati via per liberare ostaggi italiani in Paesi a rischio
potrebbero servire per il nostro welfare e coloro i quali (o le quali) girano in
zone di guerra come novelli San Francesco e pudiche Santa Chiara, potrebbero
qualche volta passare anche dalle mie parti, nella zona bassa dello Stivale.
Troverebbero in tante zone del Sud gli stessi problemi e tanto, ma proprio
tanto, da fare per poveri e diseredati. Provate a dire io non sono Charlie
Hebdo, perché per quanto rispetti la satira e mi risultino ripugnanti le azioni
terroristiche e bestiali le loro idee, faccio fatica ad essere blasfemo contro
qualunque Dio. Provate a dire queste e tante altre banali verità, e vi
subisseranno di ingiurie. Verrete subito cacciati dal consesso civile e additati
nella migliore delle ipotesi come degli intolleranti. Ma provate a dirle voi.
A me manca il coraggio e non le dirò>>.
E se la satira è nostrana?
“Scusate, avevo solo chiesto una amatriciana”,
dice una figura nera con la falce in mano, ovvero la morte. Questo recita
la vignetta in prima pagina, oggi, venerdì 26 agosto, su Il Fatto Quotidiano. Il
vignettista Mario Natangelo cerca così di ironizzare sulla tragedia del
terremoto di Amatrice, nel centro Italia. Sinceramente non se ne vedeva la
necessità.
La morte e l'amatriciana: la vignetta che
Travaglio doveva evitare, scrive il 25 agosto 2016
“Libero Quotidiano”. "Scusate, avevo solo chiesto una amatriciana", dice una
figura nera con la falce in mano, ovvero la morte. Questo recita la vignetta in
prima pagina, oggi, su Il Fatto Quotidiano. Il vignettista Mario Natangelo cerca
così di ironizzare sulla tragedia del terremoto di Amatrice, nel centro Italia.
Sinceramente non se ne vedeva la necessità. La freddura di oggi, il
direttore Marco Travaglio la poteva tranquillamente evitare.
TERREMOTO E SPETTACOLARIZZAZIONE. Cinismo
e retorica creano caccia alle streghe, scrive Piero
Sansonetti il 29 ago 2016 su "Il Dubbio". Le conseguenze più gravi del terremoto
si potevano evitare. Se ci sono responsabilità personali vanno accertate, e
invece è già iniziato il linciaggio. Il riflesso condizionato, si sa, è
ingovernabile. Difronte a una tragedia grande come quella di Amatrice, per
esempio, giornalisti e Pm (non tutti, ma molti) riescono a mantenere la calma
per un paio di giorni, e a far bene il proprio lavoro, e a raccontare - gli uni
- e a indagare con serietà e discrezione - gli altri. Poi al terzo giorno si
rompono gli argini e la necessità impellente di prendere i colpevoli e linciarli
subito subito, prevale su tutto. E così alcuni magistrati non riescono a
trattenere la propria pulsione a dichiarare, anche se ovviamente non sono in
grado ancora di sapere niente di quello che è successo, e delle cause. E i
giornalisti iniziano ad eseguire le sentenze, da loro stessi emesse, e a
scrivere tutto ciò che sentono dire in giro, nei vicoli, nei bar. C’è un
importante giornale nazionale che l’altro giorno informava - in prima pagina - i
suoi lettori, che le pareti della scuola di Amatrice erano di polistirolo.
Naturalmente è molto probabile che per il crollo della scuola esistano delle
responsabilità soggettive e personali, oltre alle responsabilità politiche delle
istituzioni. Ma è altrettanto probabile che ancora nessuno sia in grado di
conoscere queste responsabilità. Ed è molto, molto probabile che il polistirolo
sia stato usato per motivi di isolamento termico o acustico, e che non c’entri
proprio niente col crollo. Però scrivere che le mura erano di polistirolo fa
effetto, porta qualche lettore in più. Si fa. Così come fa effetto usare
l’espressione: “in odor di mafia”. Che non vuol dire assolutamente niente, ma
muove molte emozioni. E spesso quello “in odor di mafia” non è nemmeno la
persona di cui si sta parlando, ma un suo lontano parente. Ormai “essere
parente” - per la stampa italiana - è diventato uno tra i reati più frequenti.
Il Fatto, per esempio, l’altro giorno indicava al pubblico sospetto (e al
pubblico ludibrio) un tale gravato di due colpe evidenti e certe: essere
siciliano e - soprattutto - essere “imparentato” con una parlamentare del Pd. E
poi, ovviamente, ci sono gli sciacalli. La storia che raccontiamo nell’articolo
di Simona Musco in prima pagina è esemplare. La caccia allo sciacallo è un
“cult” dell’informazione, da noi. Come una volta era la caccia all’untore, della
quale vi abbiamo parlato molto, in questo agosto, ripubblicando la Colonna
Infame di Manzoni. E’ del tutto evidente, a chiunque, che le conseguenze
tragicissime, con trecento morti, del terremoto di Amatrice, sono in gran parte
dovute alla mancanza di prevenzione. Lo abbiamo scritto il primo giorno. Il
titolo del nostro giornale era: «Si poteva evitare?». Tutti gli esperti
rispondono di si. Che esistono ormai le possibilità tecniche non solo per
costruire con criteri antisismici tutte le nuove abitazioni, ma anche per
mettere, almeno in parte, in sicurezza, le costruzioni più antiche. E tutti gli
esperti ci dicono anche che l’Italia è la nazione più a rischio sismico
d’Europa, e dunque la necessità di mettere al sicuro i nostri paesi e le nostre
città è impellente. E invece, da diversi anni, si fa troppo poco. Esistono le
mappe delle zone a rischio e persino i censimenti dei singoli edifici a rischio.
Esiste anche una stima su quanto costa una azione di ristrutturazione generale.
Però la politica resta immobile e un po’ indifferente. Eppure tutti sanno che
sono altissime le probabilità che nei prossimi vent’anni ci siano in Italia
almeno tre o quattro terremoti gravi come quello di Amatrice. Perché non
concentrare su una gigantesca operazione antisismica tutte le risorse che è
possibile stanziare sulle opere pubbliche? Rinunciando, almeno per un decennio,
a ogni altra iniziativa. Concentrando una quantità molto grande di risorse su
questa impresa, e mettendo in moto anche un meccanismo probabilmente importante
di mobilitazione economica e dunque di sviluppo? Questa è la domanda che va
rivolta alla politica. Alla magistratura invece va chiesto di accertare con
serietà e certezza se ci sono responsabilità precise e personali per i crolli
provocati dal terremoto, e, se ci sono, di chi esattamente sono. Ma questo
lavoro va svolto con discrezione, serietà, prendendosi i tempi necessari, senza
creare mostri e senza lavorare suoi sospetti e basta, e senza - soprattutto -
cercare pubblicità e interagire con la stampa e i suoi clamori. Magari anche
rinunciando alle iniziative bislacche che qualche anno fa portarono
all’incriminazione (e persino alla condanna in primo grado) di un bel gruppetto
di valorosi scienziati accusati di non aver previsto il terremoto dell’Aquila.
Quegli scienziati poi furono assolti pienamente, dal momento che non ci vuole
una grande scienza per sapere che i terremoti non sono prevedibili da nessuno e
tantomeno è prevedibile la loro intensità. Ma furono assolti quando ormai la
loro reputazione e le loro carriere erano state già distrutte. Poi, certo, è
inevitabile, esiste dei pezzi del giornalismo e della magistratura italiana che
vivono di retorica e cinismo, e non sono molto interessati alle certezze e alla
verità: retorica e cinismo molto spesso si alleano e quando si alleano creano
disastri. Il meccanismo tradizionale della caccia alle streghe è sempre stato
quello: retorica e cinismo che si esaltano a vicenda.
Terremoto tra polemiche e apparenza al
tempo del dolore 2.0. Tutte le opinioni che abbiamo
letto in questi giorni ci inducono a riflettere e la verità è che ci attende una
battaglia lunga e faticosa, scrive Francesca Contino il 26 agosto 2016 su
"Irpinia 24". Avellino Guardo mia nonna e ho la percezione che tutto intorno
abbia assunto dei connotati stonati. La osservo guardare i TG, in preda a una
frenesia, con la necessità di cambiare canale e non certo per disinteresse, ma
perché delle immagini sono troppo crude e sanno di una tragedia, che lei, come
tanti, ha vissuto sulla sua pelle nel 1980. La vedo mentre sembra disegnare con
lo sguardo un terrore nascosto, a tratti inenarrabile. Quando le chiedo di
raccontarmi di quel 23 Novembre, le parole si accavallano e poi d’improvviso si
spezzano, come se si rinnovasse un dolore troppo grande anche da rispolverare.
Riemergono con più facilità i ricordi della solidarietà, dello stare insieme
delle famiglie, del buon cuore dei commercianti locali che donavano i loro
prodotti, di quelli che ospitavano la gente del paese nelle loro stalle. Avverto
il calore di quell’atmosfera, dove ogni contrasto si annienta e poi il freddo di
quell’inverno, che nelle sue parole, è ancora più rigido di quello che
probabilmente fu. Erano tempi diversi certo. Oggi apprendiamo molte più notizie,
corredate di immagini e video istantanei che niente lasciano all’immaginazione.
E ce ne serviamo, perché, talvolta, in questa società dormiente, un fotogramma
scuote una coscienza meglio di un racconto. Lo abbiamo fatto con le morti sui
barconi, con gli attentati terroristici e adesso con il terremoto di Amatrice.
Diamo letture differenti, eppure nella selezione delle immagini ricadiamo in una
volontà ambigua di spettacolarizzazione, che diventa una vera e propria
operazione di marketing, assuefatti alla forma più che al contenuto. E’ un
errore che abbiamo commesso, anche se alcuni di noi con ingenuità, con l’intento
di arrivare ai lettori in maniera più profonda. Noto con tristezza, come la
tradizione italiana si stia riducendo a un talk reality show, dove il phatos
sovrasta la professionalità, con schiere di giornalisti che pongono domande al
limite del tollerabile, anche per chi è fuori da certi drammi. Ma non è un
problema di categoria, semmai la categoria determina nello specifico la
tipologia di alcune involuzioni. Siamo circondati o addirittura siamo gli
stereotipi che condanniamo. Dagli sms per donare 2 euro, con tanto di prova
fotografica allegata sui social, alle rivalse razziste, travestite da
patriottismo di quelli che “la menano” sugli immigrati negli alberghi. Tristezza
a palate. Non solo per la violenza di certi pensieri che in rete vengono
espressi, quanto per l’insensibilità di chi ha bisogno di spostare sempre l’asse
della discussione, di chi si improvvisa costantemente esperto di politica
nazionale e internazionale. Dal montepremi del superenalotto che non si può
destinare ai terremotati, all’Italexit perché “l’Europa e l’America non soffrono
o non aiutano abbastanza”. E così via, fino alla ricerca spasmodica del
colpevole, che però è tale, per parte degli utenti guinness di presenze sul web,
solo quando si apre la stagione della caccia, solo quando qualcosa è andato
storto. E’ la società del dolore 2.0. Le case, le scuole, gli ospedali, tutto
crolla. Si comincia ad avere paura, a chiedersi come hanno ricostruito. Lecito,
giusto, comprensibile, purché non si lotti solo oggi o per qualche giorno, ma
quotidianamente. La buona edilizia, del resto, è una battaglia di legalità e di
civiltà. Noi in Irpinia lo sappiamo bene, ma non tutti hanno imparato la
lezione. Per citare mia nonna: “C’è chi non aveva nulla e ora ha la villa col
giardino e chi è ancora in attesa di una casa”. Ovviamente, per esaurire il
cerchio dell’opinabilità, non mancano i commenti alla foto del premier Renzi con
un vigile del fuoco, alle prese con le operazioni di salvataggio. “Attento non
manterrà le promesse”, “E’ una scenetta costruita a regola d’arte”, “Non ha
neanche un’unghia di Pertini”. Ecco, anche la scrivente, risaputamente
antirenziana, ha difficoltà a comprendere l’accanimento a priori in questi
giorni tremendi, che risucchia tutto e tutti nella spirale del tutto fa brodo.
E’ evidente che non siamo in presenza dello spessore morale dell’ex Presidente
della Repubblica, Sandro Pertini. Assodato ciò, lasciate le tastiere e riempite
i seggi, perché la rivoluzione si fa col voto pulito. Le fondamenta morali,
quanto quelle dei palazzi, reggeranno solo quando non si faranno più gare a
ribasso. E anche se in Irpinia non mancano i recidivi, noi non arrendiamoci,
avendo sempre a mente il monito pertiniano: “Il miglior modo di onorare i morti
è pensare ai vivi”. Francesca Contino.
Facciamo parlare una testimone di un lontano
disastro. Io la botta non la ricordo, scrive Cristina Cucciniello su
"L’Espresso” il 25 agosto 2016. Avevo un anno, non ricordo il momento della
scossa di terremoto, nel tardo pomeriggio del 23 novembre 1980. Era domenica,
passate le sette; mio padre ricorda la tranquillità del dopo-campionato davanti
alla tv: a quell'epoca, le partite di serie A venivano trasmesse in chiaro e -
come ora - subito dopo partiva la tiritera dei commenti. Se torno indietro con
la memoria, ho la vaga immagine di mia madre che mi appoggia sul sedile
posteriore della nostra automobile. E poi Dario (un volontario, amico dei miei)
che mi porta a cavalluccio sulle spalle, nei capannoni della Caritas vicino alla
nostra ex-casa. Arrivarono da tutto il mondo tanti di quei giocattoli, per noi
bambini sopravvissuti al terremoto, che io ancora ricordo il mio stupore per la
quantità; allora i miei erano due ventenni non particolarmente benestanti, in
una città rasa al suolo, che davano una mano a smistare gli aiuti umanitari:
così tanti peluche, in un colpo solo, non li avevo mai visti. A un anno non
capisci la tragedia e capita pure l'impossibile, l'assurda gioia di avere in
regalo un peluche enorme. I cazzi amari arrivano dopo, molto dopo. Il dolore, la
rabbia sorda, arriva dopo. Anche per gli adulti, intendiamoci: nei primi momenti
c'è la disperazione, lo stupore, la disgrazia della perdita dei propri cari e
dei propri averi. Ma la rabbia arriva a mente fredda, ti accompagna nel corso
degli anni, non va mai via. Non gliela voglio augurare, ma sarà così anche per
la popolazione di Amatrice ed è stato così anche per gli aquilani. Io, dopo 36
anni, sono ancora incazzata. Perché la tragedia che ci ha colpito non è
consistita solo nei 90 secondi della scossa, ma negli anni successivi: lo
scempio del mio territorio, la violenza del ricostruire interi paesi a valle,
rispetto agli insediamenti originari, la colata di cemento che ha preso il posto
dei materiali tradizionali, l'improvvida decisione di voler profittare della
ricostruzione per imporci una industrializzazione forzata che non era e non è
nelle corde di un'area collinare e montana, priva di adeguate vie di
collegamento. Ne discutevo giorni fa con un amico per metà irpino: chi ha in
corpo una goccia di sangue irpino, chi è lupo almeno in parte, davanti a quel
cemento soffre. Avellino oggi è una città di bruttezza devastante. Non ha filo
logico, non ha congruenza, non ha eleganza. Alterna costruzioni finto
ottocentesche a obbrobri ricoperti da vetro e marmo. Strade pavimentate a
lastroni lasciano il posto a piazze cementificate. E "buchi", palazzi ancora non
ricostruiti, perfino nel corso principale. Ed ecomostri, volgari ville a colori
sgargianti che punteggiano le colline intorno alla città - ne vedo una dalla
casa dei miei defunti nonni, un pugno nell'occhio fucsia in mezzo al verde.
Questa bruttezza mi perseguita, fin da bambina: a 14 anni sono entrata, per la
prima volta, in una scuola di mattoni, dopo aver frequentato elementari e medie
in orridi cubi di lastroni prefabbricati, che - peraltro - nascondevano fibre di
vetroresina e tracce di amianto; a 11 anni sono entrata in una casa "vera", dopo
8 anni in una casetta di legno. A 18 ho lasciato una città per la quale -
tuttora - non provo nulla, se non rabbia: solo qui a Roma posso alzare gli occhi
e venire sommersa dalla bellezza. Roma, perfino nei suoi angoli più beceri e
volgari, toglie il fiato. Roma ha una sua logica, ha una pianta circolare, che -
come una cipolla - mostra l'espansione della città nei secoli, con stili
architettonici diversi. Ma, ad Avellino, io non ho una storia da osservare, non
ho un quartiere del quale posso dire di essere parte: a Pianodardine, subito
accanto al Rione Ferrovia, dove mio padre è nato e dove faceva il bagno nel
fiume, oggi si susseguono capannoni industriali in parte abbandonati e si muore
per mesotelioma e leucemia (vi dice niente il nome Isochimica? Uno dei molti,
preziosi regali che una classe politica scellerata ha voluto fare alla nostra
comunità). Per provare un minimo di senso di appartenenza, devo andare sui
monti, in mezzo ai nostri boschi. Solo nel verde posso vedere la bellezza
dell'Irpinia. Perché racconto questa storia? Perché sia di monito, perché aiuti
a comprendere che non sarà solo in queste ore che le comunità di abitanti delle
zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 avranno bisogno di supporto,
solidarietà, attenzione. Vivranno anni in cui dovranno combattere per preservare
quel poco di storia e legami col territorio che il sisma ha lasciato in piedi.
Vivranno la tentazione di andar via (come ho fatto io). Vedranno l'arrivo di chi
vorrà speculare sul dramma: da noi è accaduto, è storia. Dite di no: è quel che
sento di dire a quelle persone. Dite di no quando qualcuno arriverà e vi
proporrà "dai, giacché ci siamo costruiamo qui la mega-fabbrica e la
mega-tangenziale". Dite di no, quando vi proporranno le new town. Dite di no,
quando arriveranno sciacalli pronti ad usufruire degli aiuti statali alla
ricostruzione per impiantare stabilimenti in mezzo al verde dell'Appennino: da
noi è accaduto, fate che non accada anche alla vostra terra.
LA LEZIONE DI L'AQUILA. L'avvertimento del
terremotato di Libero: "Attenti, ecco chi sono i veri sciacalli", scrive Miska
Ruggeri il 25 agosto 2016 su “Libero Quotidiano”. Dalle 3.32, ora del terremoto
dell'Aquila il 6 aprile 2009, alle 3.36, ora del sisma di Amatrice. In mezzo le
3.33, per il folklore cristiano «l'ora del diavolo», in contrapposizione alle
tre del pomeriggio, quando, almeno così vuole una tradizione, Gesù, la seconda
persona della Trinità, morì sulla croce (a 33 anni; e da qualche parte si legge
anche che era venerdì 3 aprile del 33 d.C.). Coincidenze e superstizioni. Ma in
molti nel cuore della scorsa notte, svegliati dalla terra che si muove - i
lampadari che iniziano a dondolare, i mobili che si spostano, l'intonaco che
cade - riversandosi in strada terrorizzati, ci hanno pensato. Nel capoluogo
abruzzese i (pochi) residenti del centro storico e i turisti alloggiati in
alberghi e bed and breakfast sono stati invitati a uscire all' aperto e le
manifestazioni della Perdonanza celestiniana sono state annullate (si manterrà
probabilmente solo l'apertura della Porta Santa a Collemaggio e il corteo della
Bolla, eventi clou previsti per domenica prossima). Qui, del resto, nessuno ha
dimenticato la tragedia di sette anni fa e a parecchi abitanti è sembrato di
rivivere l'incubo. Tanto che ore dopo in giro, nonostante la giornata di sole e
relativo caldo, non si vede gente a passeggio, chi gira a piedi lo fa con gli
occhi sbarrati come uno zombie, i negozi sono vuoti e il traffico inesistente,
anche in viale Croce Rossa tra Piazza d' Armi e lo stadio. Ora il pensiero va ai
conterranei di Amatrice (dal 1265 al 1861 parte del giustizierato d' Abruzzo e
della provincia Abruzzo Ultra II, con capoluogo L' Aquila; e fino al 1927
provincia dell'Aquila) e dei paesi vicini, ai numerosi morti e ai sopravvissuti.
Che avranno davanti anni e anni molto duri. Perché l'emergenza sarà gestita
ancora una volta benissimo (in Italia in questo siamo all' avanguardia nel mondo
e sono già a disposizione degli sfollati 250 appartamenti antisismici del
Progetto C.a.s.e.); Protezione civile, Vigili del Fuoco e volontari faranno
miracoli con abnegazione e spirito di sacrificio, lavorando 24 ore su 24. Ma
poi, inevitabilmente, arriveranno i mostri della burocrazia, gli sciacalli
pronti a rovistare tra le macerie degli edifici (per rubare non solo effetti
personali e preziosi, ma con il passare dei mesi persino le mattonelle dei
bagni), le cricche, le false promesse dei politici («Non lasceremo solo
nessuno», ha dichiarato a caldo il premier Renzi: figuriamoci, passata l'
emozione del momento, l' agenda del governo sarà riempita da mille altre
priorità), le lotte intestine per spartirsi i soldi, le imprese edili che
vincono l' appalto e poi falliscono all' improvviso lasciando i lavori a metà,
le infiltrazioni della camorra, le inchieste giudiziarie e i ricorsi al Tar, l'
esodo della popolazione, il frantumarsi del tessuto sociale, le dipendenze da
alcool e psicofarmaci, gli euro buttati via per i puntellamenti di palazzi
comunque destinati a essere abbattuti... Tutte cose che, purtroppo, all' Aquila
conosciamo bene. I miei genitori sono ancora fuori casa (l'apertura della
pratica per il progetto di ricostruzione sarà esaminata, se tutto andrà secondo
programma e non è scontato, nel 2017; poi passeranno altri due anni, di «tempi
tecnici», per la messa in opera del primo chiodo), in regime di «autonoma
sistemazione» dopo mesi passati in un albergo sulla costa adriatica. E io, pur
vivendo a Milano, mi ricordo bene, avendole raccontate su questo giornale, le
assurdità post sisma. Il Comune chiuso per il lungo ponte tra il 25 aprile e il
1° maggio 2009, l'ufficio Ricostruzione aperto due ore il martedì mattina e
altre due ore il giovedì pomeriggio, le dimissioni mille volte annunciate e poi
ritirate dal sindaco, la pantomima dei soldi stanziati o meno («Dateci fondi»,
«Ve li abbiamo già dati», «Non è vero»). Stavolta sarà diverso, diranno.
Speriamo. Miska Ruggeri
TERREMOTO E BUFALE. Tutte le bufale sul
terremoto. È l'ora delle panzane social. Dalla
magnitudo truccata alla prevedibilità dei terremoti fino al solito carillon di
fotografie fuori contesto e al jackpot del SuperEnalotto: il peggio sui sul web
a poche ore dalla tragedia, scrive Simone Cosimi il 26 agosto 2016 su "La
Repubblica". BUFALE E TRUFFE popolano puntuali i social network in queste ore di
dolore e di emergenza per il terremoto che ha colpito il Centro Italia. Come
sempre accade in occasione di fatti simili. D'altronde gli sciacalli non si
muovono solo fra le macerie reali ma saltano con agilità anche fra quelle
virtuali. Diffondendo notizie inventate di sana pianta, rilanciando bufale,
proponendo soluzioni impraticabili, sfruttando l'onda emotiva per rinforzare
tesi insostenibili. Sempre facendo leva su quei 268 morti e sulle centinaia di
feriti. Alcune sono, se possibile in un contesto tanto delicato, di scarsa
pericolosità, come il fraintendimento sull'hotel Mario di Cesenatico, che in
molti hanno ritenuto fosse della cantante Fiorella Mannoia. La quale aveva solo
copiato e incollato sul suo profilo l'appello (reale) di un albergatore, così
come ha fatto in altri casi. Altre posseggono invece una carica esplosiva che
vale la pena disinnescare senza indugio. Su tutte, quella del presunto
taroccamento della magnitudo del sisma (da 6.2 a 6.0) per evitare che lo Stato
debba accollarsi i costi della ricostruzione. La responsabilità sarebbe di una
presunta legge voluta dall'allora governo presieduto da Mario Monti che
fisserebbe la soglia del rimborso a 6.1 gradi. Nulla di più inventato. La
bufala, circolata già in passato, si aggancia a un articolo del decreto-legge
n.59 del 15 maggio 2012 poi convertito nella legge n.100 del 12 luglio 2012,
quello di riordino della Protezione civile. Quell'articolo, che prevedeva
l'assicurazione privata per i rischi derivanti da calamità naturali, fu
soppresso al momento della conversione. Nessun limite risulta da nessuna parte
del testo (approvato pochi giorni prima del terremoto che colpì
l'Emilia-Romagna) e in ogni caso i risarcimenti vengono calcolati sulla base di
un'altra scala, la Mercalli-Cancani-Sieberg, che valuta l'intensità del sisma in
termini di danni prodotti sul territorio e non in base alla magnitudo della
scala Richter. Sono nozioni che s'insegnano in terza elementare. Un'altra bufala
è quella del jackpot del SuperEnalotto da destinare alla ricostruzione. L'hanno
lanciata alcuni politici, contribuendo così alla confusione: su tutti Antonio
Boccuzzi del Pd e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Innescando anche numerose
petizioni su Change.org e Firmiamo.it e il coinvolgimento di star come Fiorello.
Peccato che la Sisal sia una società privata che gestisce il concorso su
concessione statale. Al massimo si potrebbe lavorare sulla tassazione collegata
(o spingere Sisal a una donazione indipendente) ma certo è impossibile sottrarre
quel montepremi maturato nel corso dei mesi in virtù delle puntate dei
giocatori, che scommettendo firmano di fatto un contratto con la società in base
al quale questa si impegna a redistribuirlo in caso di vittoria. Di sciacallaggi
digitali se ne stanno vedendo molti. Da personaggi di dubbia notorietà che non
riescono a contare fino a 10 prima di scrivere ad altri che utilizzano la
tragedia come pretesto da servizio fotografico fino, appunto, alle amarissime
panzane. Come quella sui rifugiati e sul loro "pocket money" (che alcuni, come a
Gioiosa ionica, hanno perfino deciso di donare): non si tratta certo dei 30 euro
al giorno (spesso soglia massima), che servono alla totalità delle spese per la
loro ospitalità, ma di 2,5. Affitto del locale, costi di gestione, pulizia,
vitto: c'è tutto, in quella quota giornaliera da 30 euro versata dallo Stato in
base a bandi locali dei comuni su indicazione ministeriale attingendo a fondi in
buona parte europei a ciò dedicati e non destinabili altrove. In queste ore si
sono poi registrate bufale sulle reti idriche danneggiate e sull'acqua non
potabile, smentite dalle aziende che se ne occupano, su presunti rischi di
tsunami elettromagnetici e sugli ormai tristemente noti terremoti artificiali,
oltre che su un altro motivo ricorrente delle situazioni post-sisma: la loro
prevedibilità e periodicità, visto che secondo molti stregoni "avverrebbero di
notte e col caldo". Una tesi che non ha alcun fondamento scientifico né nel
primo caso né nel secondo: basta sfogliare il drammatico catalogo dei terremoti
degli ultimi mille anni per coglierne l'assoluta casualità. Nullo anche il
collegamento con la meteorologia. Si possono al contrario elaborare mappe di
rischio, studiare le serie storiche, determinare aree e zone in maggiore
pericolo. Ma di modelli attendibili di previsione non c'è purtroppo alcuna
possibilità di stilarne. E la comunità scientifica internazionale è spesso
tornata sul punto. Quando ce ne sono - e in questo caso non ce ne sono state -
neanche le avvisaglie, i cosiddetti "foreshock", fanno fede e non possono che
essere collegati con nesso causale solo a posteriori. Intorno a queste grandi
bufale sui social network se ne sviluppano a decine, che ruotano sostanzialmente
intorno alla mistificazione di immagini di altri eventi, alla fantasiosa
variazione sulla solidarietà giunta dal mondo (è il caso dei 10mila uomini della
protezione civile russa in marcia verso il nostro Paese) o a varie tipologie di
fondamentalismo. È per esempio accaduto con la foto di un bimbo estratto dalle
macerie 22 ore dopo il sisma, in realtà presa dal terremoto di Katmandu del 25
aprile 2015. Oppure altre immagini, come quelle di una chiesa in Emilia
risalente al sisma di quattro anni fa. Anche sui social network è fondamentale
fare riferimento alle fonti tecniche, che (su
Twitter INGVterremoti, CNgeologi, Palazzo_Chigi, CroceRossa) e alzare al massimo
l'asticella su ciò che circola sulle nostre bacheche.
TERREMOTO E SOCCORSI. Terremoto,
polemiche sui ritardi soccorsi. La Protezione civile:
nessun ritardo, scrive Mercoledì 24 Agosto 2016 "Il Messaggero". «La macchina
dei soccorsi si è attivata subito, pur aver scontato ritardi dovuti al fatto
di dover arrivare in una zona di montagna, con la viabilità sconvolta:
raggiungere ogni singola frazione è difficile ma il sistema si è orma
completamente dispiegato». Lo ha detto a Uno Mattina Carlo Rosa, responsabile
Protezione Civile del Lazio, respingendo le accuse di ritardi nei soccorsi. E'
stato in particolare il sindaco di Accumoli ad accusare ritardi nei soccorsi,
sottolineando che la prima squadra dei pompieri è arrivata alle 7.40, oltre tre
ore dopo la prima scossa. I soccorritori hanno incontrato diverse difficoltà per
raggiungere Accumuli, uno dei comuni in provincia di Rieti più colpiti dal
terremoto che ha interessato la zona a cavallo tra Lazio, Marche e Abruzzo.
Diverse strade sono infatti interessate dai crolli e questo non consentiva
ai mezzi di soccorso di raggiungere il paese. Rabbia e sconcerto tra gli
abitanti di Illica, una frazione a pochi chilometri da Accumoli
(Rieti). «Vogliamo i militari, stiamo aspettando, noi paghiamo», ha denunciato
Alessandra Cappellanti, residente ad Illica, «c'è una caserma ad Ascoli, una
Rieti, una all'Aquila e non si è visto un militare, fate schifo!». La
disperazione anche nelle parole di Domenico Bordo, un altro abitante del
villaggio, «sono sotto le macerie, non ci è ancora andato nessuno, ci vogliono i
mezzi». Secondo un primo bilancio nella frazione di Illica, ci sarebbero almeno
altri 3 morti e 4 dispersi.
Scrive Mercoledì 24 Agosto 2016 "New Notizie".
Dopo il terribile sisma che ha coinvolto il centro Italia ed ha distrutto
diversi paesi in provincia di Rieti ed Ascoli Piceno, facendo finora più di
venti vittime, arrivano le polemiche per i soccorsi. Secondo molte persone, che
tenevano aggiornato il Paese in diretta sui social, i soccorsi sono arrivati
troppo in ritardo rispetto alle prime chiamate. Il sindaco di Amatrice, Pirozzi,
ha sostenuto che la macchina dei soccorsi è ritardata. “Ho chiamato i soccorsi
alle 4 ma ancora non abbiamo visto nessuno, è scandaloso” ha sostenuto il primo
cittadino. La giornalista Sabrina Fantauzzi ha invece denunciato ritardi nel
soccorso ad Illica. Su Facebook la donna ha scritto: “Illica, il paese della
nostra infanzia, non c’è più. La scossa terribile alle 3 e 40. I sopravvissuti
tutti in un campo all’aperto. Eravamo circa 300 persone, tutti romani, in
villeggiatura. Siamo rimasti in 30. Ancora nessuno è venuto a soccorrerci”. Sul
suo post la donna scrive: “Il 113 non risponde, non risponde nessuno”. Poco dopo
la Fantauzzi pubblica un altro post: “A Illica, vicino ad Accumoli (altro paese
gravemente colpito dal terremoto, ndr), sono arrivate solo due ambulanze, ci
sono 4 soccorritori, prendono feriti ma non stanno intervenendo sulle case
distrutte con dentro gente morente”.
Di seguito si riporta l’opinione di Vittorio
Feltri che non fa mancare le solite sue scivolature razziste e giustizialiste.
Vittorio Feltri il 28 agosto 2016 su “Libero
Quotidiano”: vi spiego perchè ci servirebbe un Bertolaso. Il più efficiente è
stato il ladro napoletano. Bisognerebbe metterlo a lavorare a Palazzo Chigi,
ramo interventi d' urgenza. Appena sentita la scossa, accertato qual era la
località più disastrata, si è attrezzato e ha organizzato la sua operazione di
pronto intervento. Da sotto il Vesuvio si è mosso verso Amatrice ed è arrivato
prima delle «colonne mobili» della Protezione civile. E dire che partiva da più
lontano. Il brigante partenopeo ha comprato da cittadino perbene il biglietto
del treno per Roma, mica da prendersi una multa, poi dalla Capitale si è
arrangiato con mezzi propri. Così nel primo pomeriggio è stato sventuratamente
(per lui) bloccato mentre già se ne stava andando dalle rovine dove aveva
scavato alacremente per riempire di bottino la valigia. Se lo avessero linciato,
troveremmo articoli pensosi sul diritto a un giusto processo anche per gli
sciacalli, non il mio però. Bisogna che qualcuno sia cattivo davanti ai morti.
Non faccio fatica ad assumermi il compito. In questi giorni è tutto un
sacrosanto commuoversi, e dappertutto in televisione e sui quotidiani sta
prevalendo il politicamente corretto: guai a chi scompiglia con un sassolino il
laghetto delle lacrime collettive. Ieri siamo stati criticati nel programma In
Onda di La7 perché abbiamo detto che oggi prevale nelle autorità dello Stato,
Boldrini in testa, il pensiero di come fare bella figura con i morti, visto che
tra i sopravvissuti non sono affatto popolari, poiché con i loro elicotteri e le
visite di cortesia hanno rotto non solo i gazebo. E qui, al diavolo se mi danno
del renziano, concordo con Marco Travaglio nel non associare al gruppazzo unto
dei propagandisti Matteo Renzi, il quale è corso a vedere, ha detto poche cose
oneste e senza trombe al seguito. Ma adesso non gliene risparmieremo una. Faccia
subito un esame di coscienza, alla sua e a quella dei suoi uomini, e non a
quella di Caino Monti e Adamo Berlusconi. Gli facilitiamo il compito. Infatti
anche se nessuno lo ha fatto notare, tranne il nostro Franco Bechis, la
Protezione civile è rimasta imbambolata e ha sottovalutato l'entità della
devastazione. Il testimone della lentezza e della disorganizzazione è proprio il
ladro terrone. Il sindaco di Napoli, Gigi De Magistris, ha annunciato che si
costituirà parte civile contro il concittadino reprobo che danneggia la
reputazione della città partenopea. Dovrebbero denunciarlo per diffamazione la
Protezione Civile e il ministro dell'Interno: perché con la sua rapidità ha
dimostrato che in Italia si può essere svelti. Solo a rubare però. Mi rendo
conto che butterà male per Libero. Questi sono i giorni della solidarietà. D'
accordo. Ma per mettere mano al portafogli ne basta appunto una, con l'altra
qualche pugno sul tavolo mi sento in obbligo di tirarlo. E sfido ad accusarmi di
immoralità o cinismo. Fu Enrico Berlinguer, il campione della questione morale
(la morale degli altri: infatti incassava ancora l'oro di Mosca), a rompere con
la Democrazia cristiana e a far andare in crisi il governo Forlani dopo il sisma
in Irpinia, dove si distinse tra i tuoni del terremoto la voce accusatoria di
Sandro Pertini. Il Capo dello Stato fece a pezzi tutto lo Stato, salvo, con
oculata scelta, se stesso, come fosse uno appena sceso dal cielo agitando le
alucce scandalizzate. Il Corriere della Sera gli prestò un altoparlante
formidabile, inveendo a ragione contro i ritardi dei soccorsi e la
disorganizzazione. Oggi né sul Corriere né altrove si osa dire un beh, in
compenso si odono belati complimentosi. Forse perché le comunicazioni per conto
della Protezione civile le fa la spigliata Titti Postiglione, che ha il merito
indiscutibile di essere sorella del vicedirettore del Corriere, il valente
Venanzio? Il familismo conta sempre in Italia. C' è però soprattutto un'altra
ragione, ritengo: e sta in quello che abbiamo denunciato prendendoci la ridicola
accusa di razzismo. La macchina del soccorso urgente in Italia ha il tom tom a
destinazione prioritaria se non unica: le coste della Libia, dove spediamo navi,
elicotteri in quantità e con lodevole velocità. Non fa niente se questa presunta
certezza spinge migliaia di persone a partire su gommoni sfasciati e predisposti
al naufragio, ma è un fatto. Per cui i radar del Pronto soccorso, che è il ramo
specifico della Protezione civile, sono tutti puntati verso i barconi e il mare
e non verso le nostre terre ballerine. Lo ha denunciato dalla Sierra Leone il
disgraziatissimo Guido Bertolaso, il quale ha notato da laggiù, dove si sta
dedicando a un ospedale, la discrepanza di trattamento tra migranti africani e
terremotati indigeni (nel senso di italiani). Il poveretto è stato subito
zittito a male parole. Bertolaso, basta parlare con chi l'ha osservato al
lavoro, è un fenomeno nell' organizzare i soccorsi degli altri, ma non di se
stesso, per cui si è trovato impiccato per essere stato oggetto di alcuni
delicati massaggi durante il giusto riposo del guerriero. Ora ce ne vorrebbe uno
così. Anzi, avrebbe dovuto essercene uno così. Poi si faccia fare tutti i
massaggi brasiliani e thailandesi che desidera, offro io. Invece... Invece hanno
dormito, eccome, se lo hanno fatto. Sono rimasti in bambola. Non dico i
volontari, quelli sono arrivati di corsa, e pure in troppi. Ma quelli pagati, i
capi, avevano la testa altrove o erano in ferie. O sono più bravi a comunicare
lestamente che a recarsi sul posto prontamente. Su youtube si può riascoltare la
telefonata del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, a Radio 24. C' è già stata
la seconda scossa. Le prime luci dell'alba mostrano la sciagura immane. Le sue
parole sono: «Guardi, servono unità speciali che tirino fuori le persone da
sotto le macerie. La nostra emergenza è che dobbiamo fare in modo tirar fuori da
sotto le macerie la gente». Lo ripete tre o quattro volte. Il giornalista gli
chiede se ci sono dei morti. Pirozzi è stupitissimo della domanda. Com' è
possibile che dopo tanto tempo non si abbia nessuna contezza della gravità
dell'accaduto: «Il paese non c' è più». Ripete: «Bisogna cercare di far venire
nelle nostre zone delle unità speciali. Anche elicotteri, abbiamo attrezzato i
campi. Stiamo cercando di far venire i pompieri...». Finalmente il conduttore
capisce: «Lanciamo l'appello». Risposta: «Grazie, grazie, grazie, Dio vi
benedica». Stupito il cronista chiede: «Ha ricevuto telefonate da Palazzo
Chigi?». Risposta: «No no no. Da Palazzo Chigi e dalla Protezione civile no.
Dalla Regione, ho parlato con la prefettura di Rieti». Continua: «Spero che
riusciate a darci una mano. Case non ce ne stanno più e la gente sta sotto». La
prima colonna mobile della Protezione civile del Lazio si è mossa - secondo
comunicato ufficiale - alle 9 e 40, quando lo sciacallo vesuviano era già per
strada da tre ore e passa (la prima scossa è stata alla 3 e 36). Se fosse stato
vicino alla battigia di Tripoli, in mezzora arrivava un incrociatore con
elicotteri. Noi non diciamo prima gli italiani poi i profughi. Ma almeno par
condicio. Ridateci Bertolaso. Vittorio Feltri
Terremoto, le due facce del volontariato.
Il dramma delle popolazioni investite dal sisma ha
mobilitato persone e comunità di tutta Italia. Che hanno assistito a questi
eventi non solo da spettatori, scrive Ilvo Diamanti il 29 agosto 2016 su “La
Repubblica”. L'altra faccia del terremoto, della tragedia che ha devastato
alcune zone dell'Italia centrale, è il ritorno del volontariato. Che ha
partecipato, attivamente, ai soccorsi. E continuerà anche domani e dopo. Nelle
aree colpite, in modo tanto violento e doloroso. Ma anche intorno. E per
"intorno" intendo l'intero Paese. Perché il dramma delle popolazioni investite
dal sisma ha mobilitato persone e comunità di tutta Italia. Che hanno
"assistito" a questi eventi non solo da "spettatori". Di uno spettacolo doloroso
riprodotto su tutti i media, ad ogni orario. Gli italiani, infatti, in gran
parte, si sono sentiti coinvolti - e sconvolti - dal dramma di Accumoli,
Amatrice, Pescara del Tronto. E degli altri paesi situati nell'epicentro del
terremoto. Al crocevia fra Marche, Lazio e Umbria. Così, in breve, si è diffusa
e allargata la partecipazione solidale dei cittadini di tutta Italia. Al punto
da costringere i coordinatori dei soccorsi a frenare questa spinta generosa.
Cercando, quantomeno, di regolare la qualità e la quantità dei contributi, in
direzione delle domande "locali". Per evitare l'eccesso di "doni" e di "beni" -
già eccedenti. Questa premessa permette di comprendere la complessità di quella
realtà che, nel discorso quotidiano, è riassunta con un solo termine. Una sola
parola. Volontariato. Pronunciato, spesso, senza precisazioni. Dato per
scontato. Mentre si tratta di un fenomeno distinto e molteplice. Che, nel tempo,
ha cambiato immagine e significato. Il volontariato. È un modello di azione,
individuale e sociale, orientato allo svolgimento di "attività gratuite a
beneficio di altri o della comunità". Per citare la prima indagine sul settore
condotta dall'Istat (nel 2014). La quale stima, il numero di volontari, in
Italia intorno a 6 milioni e mezzo di persone. Cioè, circa il 12,6% della
popolazione. In parte (4 milioni) coinvolti in associazioni e in gruppi, gli
altri (2 milioni e mezzo) impegnati in forme e sedi non organizzate. Ma, se
spostiamo l'attenzione anche su coloro che operano in questa direzione anche in
modo più occasionale, allora le misure si allargano sensibilmente. Il Rapporto
2015 su "Gli italiani e lo Stato", curato da Demos per Repubblica, infatti,
rileva come, nell'ultimo anno, quasi 4 persone su 10 abbiano preso parte ad
attività di volontariato sociale. Che si producono e si riproducono in base a
necessità e ad emergenze. Locali e nazionali. Come in questa occasione. Il
"volontariato", infatti, è utile. Alla società e allo Stato. Ai destinatari
della sua azione e alle persone che lo praticano. Il volontariato "organizzato",
d'altronde, ha progressivamente surrogato l'azione degli enti locali e dello
Stato. Si è, quindi, istituzionalizzato. In molti casi, è divenuto "impresa".
Sistema di imprese, che risponde a problemi ed emergenze. Di lunga durata oppure
insorgenti. Il disagio giovanile, le povertà vecchie e nuove. Negli ultimi anni,
in misura crescente: gli immigrati. E di recente: i rifugiati. Fra le
conseguenze di questa tendenza c'è la "normalizzazione della volontà". Che
rischia di venir piegata e di ripiegarsi in senso prevalentemente "utilitario".
Divenendo una risorsa da spendere sul mercato del lavoro e dei servizi. Il
"volontario", a sua volta, rischia di divenire un professionista. Una figura
professionale. E, non a caso, sono molti i "volontari di professione", che
operano in "imprese sociali". Il principale rischio di questa tendenza -
sottolineato da tempo - richiama, anzitutto, la dipendenza del volontariato e,
di conseguenza, dei volontari "di professione" da logiche prevalentemente
istituzionali. E dunque politiche. Visto che questo volontariato e questi
volontari dipendono, in misura determinante, da finanziamenti e contributi
"pubblici". Locali, regionali e nazionali. Talora, com'è noto, sono perfino
divenuti canali di auto-finanziamento. Per soggetti e interessi politici e
impolitici, non sempre leciti e trasparenti. Bisogna, dunque, diffidare del
"volontariato"? Sicuramente no. Perché il volontariato è, comunque, un fenomeno
ampio e articolato. In parte organizzato, in parte no. Espresso e praticato, in
molti casi, su base individuale. Un modo per tradurre concretamente la
solidarietà. Un'altra parola poco definita e molto usata. Perfino abusata. Ma
che riassume un fondamento della società. Perché senza "relazioni di
reciprocità", dunque, di solidarietà, la società stessa non esiste. Così, il
volontariato organizzato fornisce riferimento e continuità al volontariato
individuale. Al sentimento diffuso di altruismo che anche in questa occasione si
è manifestato. Il volontariato organizzato offre visibilità - e dunque sostegno
- al grande popolo del "volontariato involontario". Che fa solidarietà fuori
dalle organizzazioni, dalle associazioni. Dalle istituzioni e dalle imprese.
L’Italia… paese di furbi,
scrive Armida Tondo il 7 febbraio 2012 su “Italnews”. Noi italiani non
cambieremo mai, siamo pronti a sparare a zero su tutti, spesso senza conoscere i
fatti! L’ultima polemica, nata a causa del maltempo di questi giorni, è nata
sull’intervento dell’Esercito nelle zone più colpite. Ma andiamo ai fatti. Tutto
nasce dai sindaci alle prese con l’emergenza neve, chiedono e ottengono l’aiuto
dei militari dell’Esercito, fin qui nessun problema! Però i nostri
amministratori scoprono che gli uomini dell’Esercito hanno un costo. E allora,
qual è il problema? Se non vado errata, chi vuole mi potrà smentire, la
protezione civile, le associazione di volontariato, hanno contributi statali e
non solo, ogni singola sezione comunale ha contributi regionali, provinciali e
comunali, o sbaglio? Tornando al caso scoppiato stamattina, insomma
gli amministratori scoprono che la presenza degli uomini e mezzi dell’Esercito
ha un costo, dieci spalatori, soldati con una pala in mano, costano al giorno
700 euro. A far scoppiare il caso è il Presidente della Provincia di Pesaro
Urbino, Matteo Ricci, che ha dichiarato: “Non voglio fare polemiche, in un
momento così drammatico le istituzioni devono collaborare e non polemizzare, ma
non mi sembra giusto che lo Stato faccia pagare i Comuni in un frangente simile,
quando raggiungere o non raggiungere un’abitazione, un borgo sepolto dalla neve
è spesso questione di vita o di morte per anziani, malati, bambini. I Comuni e
le Province sono già strozzati dal Patto di stabilità, stanno spendendo milioni
di euro, che non hanno, per mettere in campo spazzaneve, pale meccaniche,
servizi di prima necessità, e devono pagarsi pure l’Esercito…”. E chi dovrebbe
pagare? Oppure i soldati non hanno un costo? Vorrei fare alcune
riflessioni. Premesso che ritengo giusto che chi lavora venga pagato,
analizziamo la situazione. Sono certa che i Vigili del Fuoco, il personale
dell’Enel, il personale della Protezione Civile, chiunque sia impegnato in
questi giorni nei luoghi più colpiti dal maltempo venga retribuito. Allora mi
chiedo: perché i soldati no? Forse sarebbe opportuno spiegare ai nostri lettori
che ogni movimento della protezione civile, così come altre associazioni di
volontariato, usufruisce di un contributo o “rimborso spese” che, senza entrare
nel merito di come viene calcolato, in ogni caso è comunque denaro! Cari
presidenti di regioni e sindaci perché non dite quanto vi costa, anzi, scusate,
quanto ci costa a noi contribuenti, avere un “volontario” della protezione
civile davanti alle scuole ogni mattina? O quanto ci costano i loro mezzi di
trasporto? E vogliamo parlare di volontari che pur avendo un posto di lavoro,
svolgono il volontariato con un contributo mensile che spesso si avvicina ad uno
stipendio… allora prima di sparare sul costo dell’Esercito, andiamo a vedere i
costi dei volontari! Ancora una volta riaffiora la mentalità retrograda e
faziosa di qualche decennio fa, quando si pensava che il soldato fosse a costo
“zero”, tanto dalla mattina alla sera bighellona in caserma. Oggi le Forze
Armate sono fatte di volontari professionisti, basta leggere le cronache
relative alle missioni fuori area, e, pertanto, come per tutti i professionisti,
la loro opera ha un costo. I mezzi non si muovono senza gasolio, gli
equipaggiamenti hanno un costo e si usurano, i soldati mangiano come tutti gli
esseri umani…e allora, perché è scandaloso pagarli? Forse il dott. Ricci
intendeva che a pagarli fosse lo Stato. Ma dov’è la differenza? O forse per
Ricci esiste ancora “pantalone”? Armida Tondo
MA I VOLONTARI A PAGAMENTO
SONO VOLONTARI? Si chiede Michela Scavo il 26 luglio
2012. Il volontariato è un’attività libera e gratuita svolta per ragioni
private e personali, che possono essere di solidarietà, di assistenza sociale e
sanitaria, di giustizia sociale, di altruismo o di qualsiasi altra natura. Può
essere rivolto a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli
animali, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale. Nasce dalla
spontanea volontà dei cittadini di fronte a problemi non risolti, o non
affrontati, o mal gestiti dallo Stato e dal mercato. Per questo motivo il
volontariato si inserisce nel “terzo settore” insieme ad altre organizzazioni
che non rispondono alle logiche del profitto o del diritto pubblico. Il
volontariato può essere prestato individualmente in modo più o meno episodico, o
all’interno di una organizzazione strutturata che può garantire la formazione
dei volontari, il loro coordinamento e la continuità dei servizi. Questa è la
definizione di Volontariato che possiamo trovare su Wikipedia. A Palazzago
ultimamente il tema “Volontari” è molto in voga. Pare ci siano volontari per
ogni cosa: per il volantinaggio, per l’assistenza allo spazio compiti, quelli
delle varie associazioni, quelli tanto ricercati per ripulire scuole e via
dicendo. Ma ci sono volontari e volontari. Ci sono quelli veri e ci sono quelli
con il rimborso spese da 5,16 euro all’ora. Premesso che poco mi importa se dei
cittadini vengono pagati miseramente per svolgere attività sul territorio, ma
perché continuiamo a chiamarli VOLONTARI? Non sarebbe più giusto definirli
collaboratori sottopagati? Già, non si può perché non sono sotto pagati,
percepiscono un rimborso spese. Allora la mia domanda è, se vengono rimborsate
delle spese dove possiamo trovare la documentazione, per ogni singolo presunto
volontario, che certifica queste spese? E se di rimborso spese si tratta per
quale motivo pare che ci siano dei volontari a rimborso che attendono da tempo i
soldi che gli spettano? Poi non stupiamoci se ci sono associazioni di volontari
da 1800 euro l’anno e associazioni da 26mila euro l’anno. I volontari vanno pure
spesati giusto? E non mi si venga a dire che senza il rimborso nessuno farebbe
il volontario a titolo gratuito, lo dimostrano tante associazioni sul territorio
e alcuni gruppi di recente formazione che il volontariato vero a Palazzago può
esistere tranquillamente. A questo punto sono proprio curiosa di capire perché
nessuno dei nostri amministratori, di fronte allo sdegno di alcuni per i
contributi alla Pro Loco non abbia menzionato la questione. Forse perché
nonostante la vagonata di soldi predisposta anche quest’anno sono in arretrato
con i rimborsi spese? O forse perché se non si decidono a tirare fuori le
quattro palanche che devono rischiano di trovarsi senza volontari sugli
scuolabus a settembre? Come è possibile che nella convenzione con la Pro Loco
non si accenni alla retribuzione di tali finti volontari? Forse perché in realtà
non si tratta di volontari ma di cittadini sottopagati praticamente al servizio
del comune, che camuffa dei compensi con il rimborso spese? Non sono proprio
sicura che sia una cosa fatta a regola d’arte ma c’è una commissione che si
occupa delle associazioni, qualcuno sicuramente saprà darci una risposta.
Michela Scavo
Fai il volontario e chiedi un rimborso?
Prima paga la tassa. I soccorritori che chiedono il
rimborso della giornata di lavoro devono allegare due marche da bollo da 16
euro, scrive Franco Grilli, Domenica 06/07/2014, su "Il Giornale". Ci può essere
una pretesa più assurda di quella di far pagare una tassa a chi presta il
proprio tempo per opere di volontariato? Temiamo proprio di no, eppure, a quanto
pare, si è verificato anche questo. Con un'interrogazione urgente il
parlamentare bellunese Roger De Menech (Pd) ha chiesto al governo di fare piena
luce su quanto gli è stato segnalato dal responsabile del Soccorso alpino, Fabio
Bistrot. "Voglio proprio sapere - dice il parlamentare - chi è il geniale
burocrate che pretende 32 euro da ciascun volontario ogni volta che fa un
intervento di soccorso e, di conseguenza, chiede il rimborso della giornata di
lavoro persa. Di certo non ha mai fatto il volontario". L'importo, a quanto si
apprende, corrisponde a due marche da bollo da 16 euro ciascuna da apporre a
ciascuna richiesta di rimborso presentata dai volontari. "E’ incredibile che
qualcuno voglia spremere soldi dai volontari", afferma sdegnato De Menech. "Se a
farlo è addirittura lo Stato, aggredisce la dignità dei volontari e mina il
principio di sussidiarietà. Questo increscioso episodio conferma l’urgenza non
solo di riformare la pubblica amministrazione ma anche di quanto sia necessario
e indispensabile il ricambio di personale all’interno della burocrazia italiana.
L’attuale burocrazia è ostile ai cittadini e ai contribuenti, e interpreta il
proprio ruolo non al servizio degli italiani ma come potere da usare contro i
nostri concittadini". Nell’interrogazione che ha presentato De Menech chiede ai
ministeri interessati cosa intendano fare per "superare un’interpretazione
giuridica che avvilisce la dignità stessa dei soccorritori, considerato peraltro
il ruolo fondamentale da essi svolto nella stagione estiva, sia sull’arco alpino
che su quello appenninico, volto a garantire la presenza dello Stato in tali
ambienti e a fornire quel supporto di sicurezza, prevenzione e soccorso alle
migliaia di turisti, italiani e stranieri, che decidono di trascorre le proprie
vacanze in tali luoghi". Con il rischio evidente che, l'assurda tassa, possa
scoraggiare i generosi volontari dal continuare a prestare la loro opera. I
volontari della protezione civile, se nella vita sono lavoratori dipendenti, in
caso di soccorso durante il terremoto o altre calamità naturali, hanno diritto
alla retribuzione. Sono pagati dal datore di lavoro con il normale stipendio e
hanno diritto la conservazione del posto di lavoro. L’azienda a sua volta può
chiedere il rimborso all’Inps. Ma è necessario effettuare alcuni adempimenti. Ai
volontari lavoratori autonomi spetta invece una indennità. Vediamo tutte le
informazioni.
Diritti dei lavoratori,
scrive Antonio Barbato il 30 agosto 2016. Gli eventi sismici che hanno colpito
l’Italia negli ultimi anni hanno evidenziato il ruolo chiave in Italia dei
Volontari della protezione civile, dei Vigili del Fuoco e degli appartenenti
alle forze armate e di polizia. Le attività di protezione civile sono
fondamentali in Italia, soprattutto per far fronte alle emergenze. L’attività
dei volontari è disciplinata dalla legge italiana soprattutto in termini di
diritti dei lavoratori. Il volontario che nella vita è lavoratore dipendente del
settore privato o pubblico ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e
allo stipendio. Il volontario che nella vita è lavoratore autonomo ha diritto ad
un indennità. Quando coloro che svolgono attività di volontariato sono impegnati
in operazioni di soccorso per calamità naturali o catastrofi o per attività di
addestramento e simulazione, pianificate dall'Agenzia Nazionale per la
Protezione civile o dalle altre strutture istituzionali, hanno diritto al
mantenimento del posto di lavoro, sia pubblico che privato e hanno diritto
inoltre al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del
datore di lavoro e alla copertura assicurativa secondo le modalità previste
dalla legge. Quindi alla domanda “i volontari di protezione civile sono pagati?”
la risposta è che il volontariato della protezione civile è un servizio gratuito
reso dal volontario ma spetta loro lo stipendio, se sono lavoratori dipendenti.
E spetta una indennità se sono lavoratori autonomi. Vediamo perché. Il
legislatore ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori che, in caso di
impiego nelle attività di Protezione civile a seguito della dichiarazione
dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, catastrofi o
altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con
mezzi e poteri “straordinari" (dall'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza,
fino all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi). In tali
casi, nonché a seguito dell’impiego in attività di pianificazione, soccorso,
simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, anche svolte all’estero,
hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro, al trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato, nonché alla
copertura assicurativa.
Diritti dei volontari di protezione civile. I
volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno
diritto:
al mantenimento del posto di lavoro pubblico o
privato;
al mantenimento del trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
alla copertura assicurativa secondo le modalità
previste dall’articolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti
ministeriali di attuazione.
Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001,
n. 194, l’obbligo del datore di lavoro è quello di permettere l'impiego del
volontario per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90
giorni nell'anno. Per le attività di simulazione i limiti si riducono a 10
giorni consecutivi e 30 nell'anno, e per emergenza nazionale i termini sono
rispettivamente di 60 e 180 giorni.
Quindi si viene dichiarato lo stato di emergenza
nazionale, i limiti possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi (e fino
a 180 giorni nell’anno). I limiti restano tali per tutta la durata
dell’emergenza nazionale e per i casi di effettiva necessità.
Il diritto allo stipendio. Nei periodi di assenza
del Volontario del servizio civile, il datore di lavoro deve mantenere il posto
di lavoro e la copertura assicurativa (Inail) e gli deve corrispondere il
normale trattamento economico e previdenziale (quindi stipendio e versamento dei
relativi contributi all’Inps). Nello specifico per ogni giornata di assenza
tutelata e retribuita spetta la retribuzione globale di fatto giornaliera, ossia
tutti quegli elementi della retribuzione che vengono corrisposti normalmente e
in forma continuativa (si pensi allo stipendio base, al superminimo,
all’indennità di contingenza, agli scatti di anzianità, ecc.). Per quanto
riguarda la tassazione in busta paga, non cambia nulla, nel senso che il
dipendente volontario della protezione civile riceve il normale stipendio
assoggettato alla ritenute fiscali, quindi all’Irpef al netto delle detrazioni
fiscali per lavoro dipendente, familiari a carico, ecc.
Il datore di lavoro ha diritto al rimborso Inps.
Il datore di lavoro può poi richiedere rimborso delle somme versate al
lavoratore impegnato come volontario. La richiesta va inoltrata all’Inps. I
contributi previdenziali versati durante l’assenza del lavoratore non sono però
rimborsabili. Al fondo per la retribuzione civile spetta quindi l'onere finale
della retribuzione erogata dal datore di lavoro al Volontario di Protezione
civile, mentre al datore di lavoro rimane il compito di avanzare richiesta di
rimborso all'Autorità della Protezione Civile competente nei due anni successivi
al termine dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività di formazione.
Nella richiesta vanno indicate in maniera analitica la qualifica professionale
del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettante, le giornate di
assenza dal lavoro, l'evento cui si riferisce il rimborso e le modalità di
accreditamento del medesimo.
La documentazione da presentare al datore di
lavoro. Prima di tutto il lavoratore che è impegnato come Volontario della
Protezione civile ha un obbligo comunicativo, che è quello di informare quanto
prima il datore di lavoro della sua partecipazione alle operazioni di soccorso.
Al termine delle operazioni stesse, il lavoratore, compatibilmente con le
esigenze del soccorso, deve consegnare la dichiarazione del sindaco (o di un suo
delegato) dalla quale risulti l'impiego come volontario nelle operazioni di
soccorso. La distribuzione dell’orario di lavoro dei volontari di protezione
civile. I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato hanno
diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di fruire di
un regime di orario di lavoro concordato nell’ambito di una distribuzione
flessibile degli orari (art. 17 L. 266/91). Tale disciplina non si applica a che
svolge attività di volontariato in modo occasionale, ma solo a chi l’esercita
nell’ambito delle associazioni di volontariato. Le predette disposizioni si
applicano anche nel caso in cui le attività interessate si svolgono all’estero,
purché preventivamente autorizzate dall’Agenzia. Detto regime è esteso anche
agli appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ai volontari che svolgono attività
di assistenza sociale ed igienico / sanitaria, ai volontari lavoratori autonomi
e ai volontari singoli iscritti nei “Ruolini” delle Prefetture, qualora
espressamente impiegati in occasione di calamità naturali.
Quali sono le associazioni di volontariato. Sono
considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle
associazioni che siano costituite liberalmente e prevalentemente da volontari,
riconosciute e non, e che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che
svolgono o promuovono attività di previsione e soccorso in vista od in occasione
di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione
nella suddetta materia. Presso l’Agenzia per la protezione civile è istituto
l’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile. Le organizzazioni di
volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall’articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione
civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il
tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate,
l’iscrizione in questo registro al fine di una più ampia partecipazione
alle attività di protezione civile.
Volontari di protezione civile lavoratori
autonomi: spetta un rimborso giornaliero fino 103,29 euro. Ai volontari
impiegati in attività di protezione civile che siano lavoratori autonomi e che
ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno
giornaliero fino a 103,29 euro al giorno. A chi esercita attività di
volontariato all'interno di un'associazione ed in modo non occasionale, il
datore di lavoro deve, compatibilmente con le esigenze aziendali, dare diritto
ad un orario di lavoro flessibile. Più precisamente, ai volontari lavoratori
autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente
impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è
corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base
della dichiarazione dei redditi (modello UNICO) presentata l'anno precedente a
quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro
103,29 giornalieri lordi. La misura effettiva dell’indennità, volta a compensare
il mancato reddito, è stabilita ogni anno con D.M. lavoro: dato che, per il
2016, la retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del
settore industria è pari a euro 2.127,39, su questa base va calcolata
l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui i
lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro. Tale importo deve essere diviso
per 22 o per 26, a seconda che la specifica attività di lavoro autonomo sia
svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana (Ministero del lavoro,
decreto 9 marzo 2016). Lavoratori autonomi: adempimenti per la richiesta del
rimborso. I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire
l'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n.
162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per
territorio. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine
del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di
soccorso o l'esercitazione. Alla domanda, che deve contenere le generalità del
volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve
essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei
comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto
impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la
personale dichiarazione dell'interessato di corrispondente astensione dal
lavoro, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.4. L'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, una volta determinato
l'ammontare dell'indennità spettante al volontario, sulla base dell'importo
fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale procede quindi al pagamento dell'indennità all'avente diritto. Ai fini
della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai
giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per
l'espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto
dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per
quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica
anche o prevalentemente nei giorni festivi.
Rimborso Inps: adempimenti del datore di lavoro.
Come abbiamo detto, il datore di lavoro è obbligato ad erogare al lavoratore
impegnato in operazioni di soccorso come Volontario della Protezione Civile la
normale retribuzione, salvo poi poter far richiesta di rimborso. A tal fine va
presentata apposita domanda all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del
mese successivo a quello dell'operazione. Quante giornate e ore sono
rimborsabili? Sono rimborsabili le giornate e le ore di effettiva astensione dal
lavoro del volontario di Protezione civile. Sono da escludersi le ore di lavoro
prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo
l'operazione di soccorso, nonché le giornate, di riposo settimanale, festivo, di
ferie, del sabato in caso di "settimana corta", eccetera. L’Inps rimborsa solo
per i lavoratori dipendenti iscritti presso le proprie gestioni. La domanda va
presentata online e deve contenere:
le generalità del lavoratore;
l'importo della retribuzione corrisposta;
l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei
Comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto
impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata;
una dichiarazione del datore di lavoro indicante
la corrispondente astensione dal lavoro;
la dichiarazione del lavoratore attestante
l'appartenenza al CNSAS.
Come diventare volontario della protezione civile.
In molti vorrebbero diventare Volontario della protezione civile: vediamo quali
sono i requisiti richiesti. Molti si chiedono come entrare nella protezione
civile. Riportiamo le disposizioni della Protezione civile. Per poter svolgere
attività di protezione civile come volontario a supporto delle istituzioni che
coordinano gli interventi, è necessario essere iscritti ad una delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile inserite negli elenchi
Territoriali o nell'elenco Centrale. Gli elenchi territoriali sono
consultabili presso la Regione o la Provincia autonoma nella quale si intende
svolgere – in prevalenza – l'attività di protezione civile e su questo sito,
nella sezione volontariato. L’elenco Centrale, composto da poche organizzazioni
nazionali di coordinamento, è consultabile sempre su questo sito nella
pagina elenco centrale delle Organizzazioni di volontariato. Chi desidera
diventare volontario di protezione civile può, al momento dell'iscrizione presso
un'organizzazione di volontariato di protezione civile, valutare una serie di
elementi che caratterizzeranno la propria attività nel settore scelto:
ambito territoriale di evento (nazionale,
regionale, comunale ecc.);
ambito dimensionale dell'evento (tipo a), tipo b),
tipo c) in base all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992);
eventuale specializzazione operativa
dell'organizzazione (sub, cinofili, aib);
livello di partecipazione con le attività
istituzionali;
disponibilità richiesta;
vicinanza della sede alla propria abitazione.
I regolamenti delle varie associazioni possono
prevedere adempimenti o limitazioni particolari (es. visita medica per lo
svolgimento di mansioni particolari o requisito della maggiore età ai fini
dell'iscrizione). Per un approfondimento sul ruolo del volontariato all'interno
del Servizio Nazionale di protezione civile è possibile visitare
la sezione volontariato. Un'altra possibilità di partecipazione è offerta (solo
per alcune fasce di età) dal servizio civile; per avere informazioni su
quest'ultimo, occorre consultare l'indirizzo serviziocivile.gov.it.
E per quanto riguarda i volontari dei vigili del
fuoco? Per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo dei Vigili del Fuoco
Volontari, allo stato attuale le iscrizioni del personale volontario sono
sospese, fino al 2014 ho sentito dire, ma di questo non ho conferma. Quello che
so di preciso è che la Legge n. 183 del 2011 (che sarebbe poi la Legge di
stabilità relativa al 2012) ha disposto, tra le altre cose, l'applicazione di un
tetto massimo di nuovi reclutamenti volontari. Di conseguenza tutti i Comandi
che hanno già in archivio un numero di domande superiore a quello previsto dalla
normativa, non possono nè istruire nuove pratiche, nè accettare ulteriori
domande di iscrizione. Quindi, non ti resta che andare al tuo Comando
Provinciale e chiedere se puoi almeno presentare la domanda. Per quanto riguarda
le retribuzioni, bisogna intanto fare una distinzione fra Vigile Volontario vero
e proprio e Vigile Volontario Discontinuo, che sono due figure diverse. Il
vigile volontario vero e proprio, quello che fa servizio nei distaccamenti di
personale volontario per intenderci, non percepisce uno stipendio ma prende
comunque qualcosa, anche se poco. Praticamente, i vigili del fuoco volontari
ricevono un compenso in base alle ore di intervento realmente prestate, nonchè
per ogni ora di addestramento obbligatorio, che si effettua presso un Comando o
comunque una sede con Vigili Permanenti. Quindi, alla fine prendi un tot ad
intervento: se fai 12 ore di servizio ma in quelle 12 ore non succede niente,
non guadagni niente. Se fai 4 ore di intervento, prendi per 4 volte il compenso
orario, che si aggira intorno ai 6 euro l'ora (o almeno era così fino all'anno
scorso, comunque il compenso non arriva a 7 euro l'ora). Poi c'è il Vigile
Discontinuo: se sei iscritto nei ruoli dei Vigili Volontari come Discontinuo,
quando c'è necessità vieni chiamato in servizio per un periodo che può essere di
20 giorni ma anche di 40 e anche, in certi casi, 100, se c'è necessità e se hai
la disponibilità per farlo... Comunque sia, i richiami sono sempre di 20 giorni,
quindi anche se fai 60 giorni di lavoro sono tre diversi contratti a termine.
Come Vigile Discontinuo prendi uno stipendio vero e proprio, per 20 giorni
prendi più o meno 1100 €, questo perchè prendi lo stipendio calcolato sui giorni
lavorati, ai quali si aggiungono il rateo di tredicesima e la quota t.f.r
(essendo un contratto a termine). Inoltre ti pagano eventuali straordinari e
reperibilità, che sei libero di dare o non dare.
E poi chiamali, se vuoi, volontari (con
contratto pubblico): I volontari della Croce Rossa.
Niente post terremoto per i soccorritori:
pagati per non fare nulla, rimangono a casa. Con le
scosse del 24 agosto pensavano di essere più utili in centro Italia che in
Lombardia. Ma non sono partiti. Sono gli effetti della privatizzazione della
Cri: esuberi e stipendi tagliati per alcuni addetti, mentre altri non escono più
in ambulanza. E per coprire i buchi di bilancio si cerca di vendere il
patrimonio immobiliare, scrive Michele Sasso e Monica Soldano il 31 agosto 2016
su “L’Espresso”. Dalla Lombardia alle zone colpite dal terremoto. Per non stare
con le mani in mano, per usare sul campo la propria esperienza di
soccorritore. Nei giorni del post-sisma che ha devastato Amatrice, Accumoli e
Arquata del Tronto per gli uomini della Croce rossa del comitato lombardo non
c’è però nessuna missione: «Non c’è bisogno di voi» è la risposta arrivata dal
presidente nazionale Francesco Rocca. I dipendenti che si sono fatti avanti sono
tra i 200 lavoratori che dopo la privatizzazione del 2014 hanno deciso di
mantenere il contratto pubblico. Da anni timbrano ma fanno poco. Le dieci
ambulanze non escono dai garage. Sono autisti e barellieri ma non fanno più la
loro professione. In quanto dipendenti pubblici, non possono fare servizi in
convenzione (come, ad esempio, le ambulanze per il 118 o il trasporto di malati
fuori dall’emergenza) perché esclusi dalla legge. E poi nel 2015 un altro passo
verso il paradosso. «Da inizio anno non lavoriamo più sulle ambulanze e giriamo
a piedi per Milano svolgendo un servizio di pochissima utilità, equipaggiati con
uno zainetto pieno di garze e cerotti», ha raccontato al Fatto quotidiano Mirco
Jurinovic, soccorritore e dirigente sindacale di Usb. Costano 4 milioni di euro
all’anno ma non vengono utilizzati. È il risvolto kafkiano della
privatizzazione. Ci sono voluti due anni per provare finalmente a trasformarsi
in una struttura efficiente, indossando il vestito nuovo dell’associazione
privata. Gli effetti non sono quelli sperati. Ecco come buttare al vento la
passione di 150mila volontari, quasi tremila dipendenti tra personale civile,
infermieri e dipendenti del Corpo, e impoverire il servizio d’emergenza in molte
Regioni. Il piano di riorganizzazione pensato dall’ex premier Monti ha provocato
evidenti cortocircuiti: esuberi e stipendi tagliati per una fetta di addetti,
mentre altri vengono pagati per non fare nulla. Oltre al tentativo di svendita
dell’immenso patrimonio di quasi 1.500 palazzi e terreni, il frutto di 150 anni
di donazioni di chi pensava di fare del bene. Nella fase di transizione è
intervenuto con due proroghe anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin
che ha messo sul piatto della finanziaria oltre 300 milioni di euro. Fondi
necessari a pagare i debiti e tenere in piedi l’esercito di barellieri e
operatori del primo soccorso. Emilia De Biasi, presidente Pd della commissione
Sanità al Senato è tranchant: «La Croce rossa italiana è ancora un carrozzone
con un patrimonio di sedi e competenze svilito. La riforma è un’urgenza: ci
vuole trasparenza per tutta la gestione, e invece il ministero della Salute
continua a prendere tempo». Nel 2012 si decide di dire basta alla crocerossina
di Stato. Privatizzando le organizzazioni provinciali, quindi sciogliendo gli
apparati centrali che non hanno mai conosciuto la spending review e «bruciato»
un miliardo di euro negli ultimi dieci anni. E qui viene a galla il primo
problema, la ricollocazione del personale: ancora adesso ci sono circa 2mila
persone da piazzare. Il decreto firmato nel settembre 2015 dal ministro della
pubblica amministrazione Marianna Madia prevedeva esclusivamente il
traghettamento verso i ministeri, o istituti come Inps o Inail. Un non sense
riparato con la finanziaria, che allarga la possibilità anche al servizio
sanitario nazionale, per gran parte degli interessati una collocazione naturale.
«Temiamo che il ministero non riesca a gestire il ricollocamento -
denuncia Nicoletta Grieco della Cgil - finora c’è stata una gestione scomposta e
nessun coordinamento con le Regioni ed Asl locali. Mancano otto mesi alla fine
dell’anno e il rischio è la mobilità, seguito dal baratro del licenziamento». In
tanti hanno preferito non abbandonare l’uniforme e sono passati ai nuovi
comitati. Con un salto all’indietro: lo status di associazione privata prevede
contratti targati Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) con
stipendi mensili decisamente inferiori, da 1.600 a 1.100 euro. Epicentro della
cura dimagrante il Lazio, dove sono concentrati oltre 1200 dipendenti, su un
totale nazionale di 2788 addetti. Disorganizzazione e casi-limite come quello di
D.M., operatrice precaria che per 25 anni ha lavorato al Centro di educazione
motoria (Cem) di Roma. Nel 2011 decide di fare causa per ottenere il tanto
agognato contratto a tempo indeterminato e il Tribunale dopo due anni le dà
ragione. «Con il nuovo corso mi è stato imposto di non mettere più piede al Cem.
Spostata al comitato metropolitano, ho seguito l’emergenza freddo: un campo di
tende per dare assistenza ai senzatetto. Il piano è durato dal 15 gennaio al 21
marzo e da allora ogni giorno timbro per non fare nulla». Mentre al centro per
la cura di pazienti con gravi disabilità diventato di eccellenza grazie ai
quattrini del leggendario canzoniere Mario Riva il personale è stato dimezzato e
l’assistenza ridotta ai minimi termini. La privatizzazione avrebbe dovuto
portare efficienza e risanamento economico. Nel primo anno - il 2014 - il
«disavanzo di cassa è perdurante, posizione debitoria è preoccupante e pesante
ricorso all’anticipazione bancaria», ha sottolineato la Corte dei conti. Così
per coprire i buchi di bilancio la soluzione è drastica, vendere i gioielli di
famiglia: 1.045 fabbricati e 413 terreni. Un’impresa non facile. L’ultimo
tentativo risale al maggio 2014, quando 19 lotti tra palazzi e appartamenti
vengono messi all’asta: da La Spezia a Schio, fino a Casale Monferrato e Pavia.
Finisce all’incanto anche la storica sede sul lungomare di Jesolo, Venezia, e
presto la stessa sorte toccherà al palazzetto ottocentesco del quartier generale
di Roma. In Laguna il prezzo precipita: da 42 milioni è sceso a 34.
Sull’eccessivo ribasso la deputata grillina Arianna Spessotto ha presentato
un’interrogazione parlamentare. La risposta del ministero della Salute è
arrivata il 17 marzo scorso. Per il sottosegretario Vincenzo De Vito “nessuna
svendita”: il ribasso di un quinto del valore è regolare, dopo che le prime due
sedute sono andate deserte. Dopo c’è stato un nuovo sconto sul valore
dell’immobile ma ancora nessun acquirente. Eppure, a Jesolo, partiti e sindacati
non si danno pace perché vedono il rischio di smobilitare i servizi, con 50
dipendenti a spasso. E il via libera alla speculazione. «Quel palazzetto sul
mare, con 18mila metri quadrati di spiaggia, ha dei vincoli ben precisi»,
attacca Salvatore Esposito di Sel. E anche per la Sovrintendenza dei beni
culturali si tratta di un edificio di interesse storico, in cui non si possono
rimuovere gli affreschi né alterare la struttura delle stanze. Per il conte
Ottavio Frova, la donazione del 1928 si vincolava alla cura della “fanciullezza
trevigiana”. Nel tempo è prima diventata una colonia per i malati di
tubercolosi. Oggi è anche un centro per i rifugiati. Fabio Bellettato, ex capo
della Cri Veneto, sul tema aveva lanciato un appello al presidente nazionale
Francesco Rocca. Era in disaccordo sulla vendita del patrimonio immobiliare come
unica possibilità di risanamento. La richiesta di Bellettato è rimasta
inascoltata, mentre lui si è dimesso. Mancanza di democrazia, centralizzazione
del potere e interesse solo per le missioni all’estero: sono le critiche mosse
dai comitati periferici verso Francesco Rocca, avvocato che gestisce l’ente
sinonimo di solidarietà ed aiuto come un padrone assoluto. Un esempio? Quando
nel 2011 la funzionaria Anna Montanile ha denunciato alla trasmissione tv
“Report” le incongruenze della gestione delle sedi è stata trasferita
all’archivio storico. A fare ricerche sulle bandiere. Oggi mentre la Cri è alle
prese con un serrato piano di risanamento, Rocca è spesso all’estero per
missioni che fanno bene alla sua immagine di numero due della federazione
internazionale: Iran, Siria, progetti post terremoto di Haiti ed emergenza
profughi. «Non ho rimborsi né indennità, mi viene pagato solo l’albergo quando
sono in missione», precisa Rocca a “l’Espresso”: «Da presidente non prendo
stipendio, sono totalmente volontario. Purtroppo veniamo da trent’anni di
assoluto abbandono. Abbiamo bisogno di dipendenti, ma non in quel numero e con
quello spreco». Il presidente-volontario è stato per più di quattro anni
commissario straordinario, voluto da Berlusconi (con un budget annuale di
320mila euro), da maggio 2015 è direttore dell’Idi di Roma, l’ospedale
dermatologico più grande d’Europa. Di proprietà della Congregazione dei Figli
dell’Immacolata Concezione è al centro di una storiaccia brutta di bancarotta
fraudolenta, fatture false e un passivo patrimoniale di 845 milioni di euro.
Ambulanze, il business delle onlus. E il
soccorritore lavora in nero, scrive Massimiliano
Coccia il 19/05/2014 su “Il Tempo”. La Regione non indice bandi ma si affida
unicamente a gettoni a chiamata. Gli operatori del 118 sfrecciano nel traffico a
sirene spiegate. Sono i primi ad essere colpevolizzati in caso di ritardi nei
soccorsi, sono gli ultimi ad abbandonare il mezzo a fine turno. Ma in tantissimi
casi per stare su quelle autoambulanze non hanno un regolare contratto di
lavoro. Colpa della crisi e dei tagli alla sanità. Ma, secondo molti, anche
della situazione venutasi a creare in seguito ad alcune delibere regionali
(271/2011 e 325/2011) che favoriscono nei servizi di trasporto extraospedaliero
di emergenza le onlus rispetto agli operatori privati. Queste delibere, che
violano il diritto europeo in materia (causa C113/13 della Regione Liguria),
creano un sistema, che se confermato, lede in maniera forte ai principi di
concorrenza tra privati e di tutela sia dei lavoratori che degli assistiti.
Inoltre, essendo le «onlus» enti associativi senza finalità di lucro, non
dovrebbero percepire lo stesso rimborso da parte di Ares che spetta ai privati e
dovrebbero basarsi solamente sul lavoro volontario. Invece, come ci racconta
G.A. (iniziali di fantasia), operatore del 118 dal 2008, molti di loro svolgono
un lavoro dipendente a tutti gli effetti, stando sui mezzi 5 giorni su 7 senza
assicurazione e senza contratto.
Come sei entrato a lavorare nel mondo del
trasporto extraospedaliero?
«Nel servizio di ambulanze in convenzione o a
chiamata "spot" per il servizio pubblico del 118 Lazio, ci sono entrato nel
2008, dopo aver perso l'ennesimo lavoro. Il mio contratto scade tra 15 giorni,
dopo aver lavorato per molti mesi in nero, come lavorano molti che vengono
chiamati per sopperire alle carenze dell'Ares 118».
E come venivi pagato in nero?
«Il gioco è semplice. Viene fatto firmare un
foglio per il cui il volontario dichiara di prestare la sua opera senza fini di
lucro, ma di fatto entra nel mondo perverso del lavoro in nero. Tutti
percepiscono un "rimborso spese" che va dai 50 euro al giorno per 12 ore fino ai
70/80 euro per gli infermieri. Qualsiasi volontario avrebbe diritto ad un
rimborso spese giornaliero che comprende il viaggio, il pranzo ed eventualmente
un caffè al bar, solo che gli "pseudo volontari" come me, dovevano rientrare la
sera a casa e procurarsi almeno 60 euro di scontrini o ricevute, altrimenti la
mia giornata lavorativa andava persa. Ci sono "pseudo volontari" che fanno 25
turni al mese, secondo il fisco, come possono mantenere una famiglia solo con i
rimborsi spesa?».
Ci spieghi il meccanismo di finanziamento di
una "onlus" che si occupa di trasporto ospedaliero?
«L'Ares 118, per sopperire alla carenza di
personale, incarica sia le "onlus" e sia le ditte di ambulanze private
riconoscendo alle prime un rimborso di circa 450 euro per 12 ore e ai privati di
circa 500 euro per 12 ore, con la differenza che i privati hanno i dipendenti in
regola. Pagando persone a nero o sottopagandole si avrà una scarsa qualità del
personale e del servizio. Vale la pena ricordare che in questo lavoro la parola
d'ordine dovrebbe essere professionalità. Più volte in ambulanza ho lavorato con
un infermiere neanche iscritto all'IPAVSI».
Quali rischi corri ogni giorno salendo su un
mezzo di fatto privo di ogni assistenza previdenziale e assicurativa?
«I rischi in questo lavoro sono molteplici dati
proprio dalla peculiarità del servizio, in particolare quelli infettivo ed
epidemiologico. E la tutela assicurativa è inesistente. Anni fa ebbi un
infortunio in servizio che fu refertato dal pronto soccorso del Pertini e
l'unica preoccupazione della finta associazione di volontariato per cui prestavo
servizio fu quella di farmi riferire che stavo svolgendo il turno da
volontario».
Possiamo parlare di un sistema pianificato a
tavolino per incassare i contributi pubblici sulla sanità e per fare cassa sulla
previdenza lavorativa?
«Non so se sia pianificato o meno, ma trovo
assurdo che la Regione non indica un bando per affidare la gestione di questi
servizi e vada avanti con lo spot o il gettone a chiamata».
La questione del risparmio non riguarda solo
voi operatori, anche il parco vetture è vetusto e non conforme alle direttive
regionali. Quanti sono i mezzi non a norma nella Regione Lazio?
«C'è una delibera della Regione Lazio che vieta la
circolazione dei mezzi di soccorso che abbiano maturato più di cinque anni di
immatricolazione e servizio, ma in realtà vedo in giro ambulanze da museo con la
totale indifferenza di tutti, in primis dalla centrale 118 che dovrebbe
immediatamente bloccare quei mezzi».
Avete cercato di esporre il caso alla
magistratura e alle forze dell'ordine?
«Io e altri colleghi abbiamo fatto denunce ed
esposti ma non hanno portato a nulla. Ci hanno detto che la giustizia farà il
suo corso, ma nel frattempo i primi a rischiare per questi disservizi sono i
cittadini trasportati in situazioni critiche su mezzi vetusti e con personale
sottopagato e non qualificato. A volte mi chiedo dove vadano a finire tutti i
soldi che si mettono a bilancio per la sanità».
TERREMOTO, RAZZISMO E SCIACALLAGGIO.
«Eravamo lì per aiutare, ci hanno trattato da sciacalli», scrive Simona
Musco il 29 ago 2016 su “Il Dubbio”. I giornali nazionali li hanno sbattuti in
prima pagina con accuse infamanti e senza lo straccio di una prova. «Volevamo
solo dare una mano a quelle persone disperate, ora, invece, ci additano come
sciacalli, solo perché veniamo da Platì: ma è tutto un equivoco». Rocco Grillo e
Pasquale Trimboli ci avevano provato. Erano saliti su una Suzuki Vitara, 48 ore
dopo quel terremoto che ha squarciato il centro Italia, pensando di «fare del
bene». Ma da Amatrice, simbolo del sisma, sono tornati giù con l'accusa
peggiore: quella di voler approfittare della tragedia per riempirsi le tasche.
La loro versione, fino ad ora, era un rigo nei giornali nazionali, che parlano
di loro come «malviventi» - i due hanno precedenti per furto - che si aggiravano
«tra le rovine di una casa diroccata» con «fare sospetto». Di passare per
avvoltoi, però, non ne hanno voglia. E raccontano quel viaggio, durato meno di
24 ore. «Ci siamo ritrovati al bar con degli amici, a parlare di tutta quella
gente disperata che avevamo visto in tv - racconta Trimboli, bracciante agricolo
di 36 anni -. Dovevamo partire tutti insieme, ma non abbiamo trovato un furgone.
Così abbiamo pensato di raccogliere viveri, coperte e vestiti in giro per il
paese e di partire con la mia auto. Ma visto che avevano bloccato l'invio dei
beni, abbiamo pensato di partire per dare una mano e basta». Prima di mettersi
in viaggio, alle sei del pomeriggio del 26 agosto, i due passano dalla caserma
dei carabinieri di Platì, paesino di poco meno di 4mila anime, arroccato
sull'Aspromonte, per tutti simbolo di una 'ndrangheta prepotente e sanguinaria,
ma che ha fatto vedere il suo volto migliore in più di un'occasione. «In caserma
ci hanno detto che stavamo facendo una cosa bella - spiega Grillo, 38 anni,
anche lui bracciante -. Siamo passati per capire se fosse il caso di andare e ci
hanno detto che il volontariato è libero». I due arrivano ad Amatrice alle 3.30,
nel cuore della notte. Incontrano la polizia, chiedono dove andare per dare una
mano e vengono indirizzati alla tendopoli. «Lontano, dunque, dalle case»,
sottolineano. I due passano da una divisa all'altra, cercando qualcosa da poter
fare, fino a quando un uomo della protezione civile, alle 6.30, dà loro dei
guanti e li mette a pulire i bagni. «Era pur sempre un lavoro da fare», dice
Trimboli. Poi vengono spediti a raccogliere la spazzatura dentro le tende. «Da
soli abbiamo raccolto circa trenta sacchi», spiega Grillo. I due si fermano per
la colazione e dopo aver preso un caffè in mensa tornano alla tendopoli, dove
incontrano il presidente Sergio Mattarella e il capo della protezione civile
Fabrizio Curcio. «Gli abbiamo detto che venivamo dalla Calabria - raccontano -.
Ci ha dato la mano e ci ha fatto i complimenti». Sono le dieci quando i due
decidono di spostarsi di qualche metro, all'ombra, vicino alla loro auto, per
fumare una sigaretta. «In quel momento - spiega Trimboli - è arrivato un ragazzo
del posto, in macchina, e ci ha chiesto chi fossimo e il tesserino. Noi però non
lo avevamo. Abbiamo spiegato che eravamo volontari ma una signora, arrivata poco
dopo, ha iniziato a inveire contro di noi. Ci gridava: "dovete andare via,
bastardi, infami". Abbiamo provato a spiegare che eravamo lì per dare una mano
ma ha continuato a urlare». È in quel momento che arriva una ventina di uomini
delle forze dell'ordine. Che avviano la procedura di rito: la consegna dei
documenti, la perquisizione dell'auto, domande sul come e il perché si trovano
lì. «I carabinieri hanno controllato l'auto ma non c'era nulla», spiega
Trimboli, parole confermate dal verbale firmato dai due. Che per farsi credere
mostrano i guanti e indicano chi li ha messi a lavorare. E pure lui, sostengono,
prova a dire come sono andati i fatti. «Ha spiegato che eravamo andati a
registrarci ma era tutto bloccato - racconta Grillo -. Ce n'erano tantissimi
come noi lì, non registrati ma che davano una mano». I carabinieri vogliono
sapere perché partire da Platì per un viaggio così lungo. Loro insistono: «per
noi era un onore poter aiutare qualcuno - sottolinea Trimboli -. Ho lasciato tre
bimbi piccoli a casa, solo per dare una mano. Non per sentirmi dire che sono uno
sciacallo». I due invitano i carabinieri a contattare la stazione di Platì ma i
loro precedenti bastano e avanzano: furto. Fatti troppo specifici per lasciar
correre. «È vero, ho sbagliato anni fa ma ho pagato i conti con la giustizia,
sono su una strada buona. A Platì abbiamo sempre dato una mano quando c'è stato
bisogno», conclude Trimboli. A loro carico, ora, c'è solo un procedimento
amministrativo presso la Questura di Rieti per il foglio di via, spiega il loro
legale, Domenico Amante. «Il problema è che ora, per tutti, sono due sciacalli.
Ma loro volevano solo aiutare».
E poi ci sono gli sciacalli mediatici.
Dapprima i media avevano diffuso le sue generalità e pareva fosse un
pregiudicato napoletano. Ma invece non è così. Si tratta infatti di un nomade di
etnia Rom arrivato appositamente da Napoli in Treno, scrive “La Voce del
Trentino” il 26 agosto 2016.
Arrestato sciacallo ad Amatrice: è un
pluripregiudicato napoletano, scrive “Il Mattino di Napoli” il 25-08-2016. I
carabinieri del comando provinciale di Rieti, nell'ambito dei servizi messi in
atto al fine di reprimere il fenomeno dello sciacallaggio a seguito del forte
sisma, hanno tratto in arresto un pluripregiudicato napoletano, Massimiliano
Musella, 41 anni, residente al Rione Alto. Una delle pattuglie poste in campo e
composta dal comandante della stazione di Leonessa e da un militare dipendente
dello stesso reparto, coadiuvati da militari del 7° rgt laives, nel pomeriggio
odierno, nella frazione «Retrosi» del comune di Amatrice, hanno colto
all'improvviso l'uomo che tentava di forzare con un cacciavite, la serratura di
un'abitazione colpita dal sisma e disabitata. I militari lo hanno sorpreso alle
spalle e l'uomo, vistosi braccato, ha tentato di divincolarsi ingaggiando con i
militari, una violenta colluttazione, ferendo con il cacciavite, uno dei
militari. I carabinieri al termine della breve colluttazione sono riusciti a
immobilizzarlo e ad ammanettarlo. Dopo averlo disarmato, lo hanno accuratamente
perquisito rinvenendo nella tasca dei pantaloni, un biglietto ferroviario datato
24 agosto 2016 tratta Napoli-Roma, confermando la tesi che il pregiudicato, era
giunto sul luogo del sisma, prima in treno e poi in pullman, con l'intento di
far razzie all'interno delle abitazioni colpite dall'evento tellurico. L'uomo,
gravato da numerosi precedenti penali per detenzione a fini di spaccio di
sostanze stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di armi è stato tratto in
arresto con l'accusa di rapina impropria e lesioni personali e tradotto presso
la casa circondariale di Rieti a disposizione dell'autorità giudiziaria locale.
I militari, ricorsi alle cure mediche da parte dei sanitari presenti nel campo
allestito per le vittime del sisma, sono stati giudicati guaribili in 6 giorni.
Il racconto degli angeli di Amatrice:
«Così abbiamo arrestato lo sciacallo», continua Ebe
Pierini su “Il Mattino di Napoli” il 26-08-2016. Lì dove non possono arrivare
con le auto perché ci sono solo macerie loro arrivano a piedi. Sono stati i
primi a giungere sul luogo del sisma ed ora sono 400 i carabinieri che
pattugliano il territorio di Amatrice ed Accumuli, 24 ore su 24, per impedire
che gli sciacalli entrino nelle case abbandonate per rubare. Com'è successo
giovedì quando a finire in manette è stato il 41enne napoletano Massimiliano
Musella. «Mentre transitavamo in auto per la frazione di Retrosi, vicino
Amatrice, io e il mio collega, l’appuntato scelto Gianni Reali, abbiamo notato
un uomo che armeggiava con un cacciavite nei pressi del portone di legno di
un’abitazione – racconta il maresciallo Mauro Margarito, comandante della
stazione di Leonessa – Siamo scesi dal mezzo. Io indossavo la pettorina dei
carabinieri. Abbiamo intimato l’alt e lui è fuggito. Lo abbiamo rincorso e
raggiunto e, mentre tentavamo di immobilizzarlo, ci ha offerto resistenza. Ne è
nata una colluttazione. Siamo finiti tutti e tre a terra. Il caso ha voluto che
in quell’istante passasse una pattuglia di colleghi del 7° reggimento Laives che
ci ha aiutati ad ammanettarlo». «L’uomo è stato poi condotto presso il carcere
di Rieti con l’accusa di rapina impropria e lesioni – aggiunge il capitano
Emanuela Cervellera, comandante della compagnia di Città Ducale, dipendente dal
comando provinciale di Rieti, che ha la competenza sulla zone di Amatrice ed
Accumuli – Il maresciallo ha infatti riportato una distorsione dell’avambraccio
sinistro, mentre l’appuntato scelto una ferita da taglio all’indice della mano
destra e una contusione al gomito». «L’uomo ci ha minacciato dicendo che ci
avrebbe denunciati perché quello che avevamo visto non corrispondeva al vero –
racconta ancora il maresciallo Margarito – Ad insospettirci è stato anche il
fatto che indossasse una pettorina con scritto security e che con sè avesse un
grosso sasso oltre a un borsone. In tasca aveva un verbale di accertamento di
violazione di 38 euro effettuato sul treno da Napoli a Roma in quanto non aveva
pagato il biglietto, datato 24 agosto, il giorno del sisma. In un primo momento
si è giustificato dicendo che era un soccorritore, ma ho comandato la stazione
di Amatrice per due anni e mezzo e conosco tutta la gente del posto. Se fosse
stato di lì lo avrei riconosciuto. Tra l’altro la mattina era stato già notato
mentre cercava di oltrepassare i varchi di accesso alla città dicendo di essere
un volontario». «La prevenzione dei furti fa già parte dei nostri compiti
quotidiani – assicura il capitano Cervellera - Tranquillizzare la gente
rappresenta un aiuto psicologico. Hanno lasciato tutte le loro cose
all’improvviso ed è nostro compito farle loro ritrovare».
Terremoto, lo sciacallo arrestato ad
Amatrice aveva annunciato l'impresa su Facebook: “Vado lì”,
affonda il colpo Stella Cervasio nel suo articolo del 27 agosto 2016 su "La
Repubblica". L'aveva scritto sul suo profilo Facebook il 24 agosto alle 18.48:
"Vado lì". Dopo si è capito che intendeva nei paesi del centro Italia colpiti
dal terremoto. M.M., 41 anni, di Chiaiano, ha preso un treno Napoli-Roma, è
sceso alla stazione Tiburtina ed è salito su una corriera che l'ha portato ad
Amatrice, quel nome di paese che aveva sentito in tv, spazzato via dal
terremoto. Nella frazione di Retrosi i carabinieri l'hanno trovato ad armeggiare
con un cacciavite al lucchetto di una porta di una delle case evacuate dopo il
sisma. Si è girato e ha colpito i due uomini dell'Arma, che hanno un referto
ospedaliero di cinque e sei giorni. "Che lavoro fa? Nessuno ", dicono al Comando
provinciale di Rieti, dove peraltro sono presi da ben altri impegni, in queste
ore. L'arresto di M.M., che è accusato di rapina impropria, lesioni e
resistenza, è stato eseguito dai carabinieri di Città Ducale e deve ancora
essere convalidato dal gip. L'uomo intanto è rinchiuso nel carcere di Rieti. Sul
suo profilo Facebook, dove annunciava la partenza per i paesi terremotati, sono
piovuti gli improperi di ogni genere, anche sotto le foto di statue di santi che
aveva postato in precedenza, e le accuse di aver fatto vergognare i cittadini
napoletani per aver battuto il peggiore dei record: è stato il primo (e finora
per fortuna l'unico) sciacallo del dopoterremoto del Lazio. E purtroppo è
targato Napoli, anche se il sindaco de Magistris, per segnare immediatamente la
distanza della città da quest'azione, ha annunciato la costituzione di parte
civile contro il responsabile. M.M è stato arrestato in precedenza una volta per
droga e due volte per furto, quindi non è nuovo a questo tipo di lavori. Ma, pur
vivendo ai Camaldoli, nel dominio del clan Polverino, non ne fa parte. M.M. ama
piuttosto montare sui treni e fare bravate. Lo avevano visto anche l'anno
scorso, alla prima udienza del processo contro Bossetti, accusato dell'omicidio
di Yara Gambirasio. Era arrivato con il gruppo innocentista che sui social ha
anche diversi sottogruppi per la verità con non numerosissimi iscritti. Reggeva
uno striscione che sosteneva che il carpentiere di Mapello, poi condannato
all'ergastolo, fosse innocente. Sui giornali l'avevano descritto come "l'autista
molto abbronzato, arrivato da Napoli ". E sarebbe andato anche a più di una
udienza del processo. Secondo quanto i giornali di Bergamo scrissero, all'epoca
avrebbe anche dichiarato davanti alle telecamere: "Un'accusa ingiusta e
totalmente infondata - sostiene Massimiliano M.M, il napoletano che ieri mattina
è arrivato in via Borfuro appositamente per seguire la prima udienza - non è lui
il colpevole. Gli autori del delitto sono ancora in circolazione. Purtroppo le
indagini non state condotte in modo adeguato".
Il video dello sciacallo: un falso
grossolano, scrive Ugo Maria Tassinari il 26 agosto
2016. Un video supporta da stamattina una campagna virale sullo sciacallo
napoletano a partire dalla notizia di stampa attivata da “Il Mattino” (proprio
contro un suo concittadino). Un’onda di indignazione tale che il sindaco De
Magistris ha annunciato la volontà di costituirsi parte civile. Peccato che il
video non c’entri niente. A trascinare il fermato, infatti, sono poliziotti. E,
a finale, arriva pure la smentita della Questura di Rieti, che racconta la reale
dinamica. La polizia ha scongiurato il linciaggio di un innocente. Ecco la nota
Agi: Roma – E’ polemica sullo sciacallaggio nelle aree devastate dal sisma: dopo
una serie di denunce di individui sospetti sorpresi a rovistare tra le macerie,
rilanciate anche dai media, la Questura di Rieti in un comunicato ha definite
“prive di ogni fondamento” queste notizie. “I servizi di vigilanza,
specificamente finalizzati al contrasto di possibili episodi di sciacallaggio,
sono stati infatti attuati sin dai primi istanti con personale delle forze
dell’ordine, e poi rafforzati nelle ore serali e notturne con l’arrivo dei
reparti organici”, ha assicurato la Questura. Allo stato, “sentite anche le
altre forze di polizia, non risulta alcun episodio di illegittima introduzione
di persone nelle abitazioni evacuate, tantomeno di furti perpetrati”. Sono stati
eseguiti controlli su persone sospette o “semplicemente presenti all’interno di
aree interdette o in procinto di entrarvi”, ma tutte le verifiche, conclude la
Questura, “hanno avuto esito negativo e le persone sono state indirizzate ai
competenti organismi di Protezione civile o semplicemente allontanate”. Tra gli
episodi segnalati c’era quello di un uomo identificato ad Amatrice perchè
sorpreso con un trolley e sospettato di aver sottratto oggetti da alcune
abitazioni. L’uomo ha rischiato il linciaggio da parte della folla, ma l’arrivo
dei poliziotti ha evitato l’aggressione. Sempre ad Amatrice tre persone sono
state fermate perché sorprese a rovistare nelle case abbandonate. Segnalazioni
sono arrivate anche nell’ascolano nel comune di Arquata, in particolare nella
frazione di Pescara del Tronto spazzata via dal terremoto. Secondo i
soccorritori, si sono verificati casi già nel corso della prima notte del sisma.
I carabinieri hanno intensificato i controlli in tutta l’area.
La versione corretta pubblicata dai media non ti
aspetti.
Fermato un presunto sciacallo: rischia il
linciaggio degli abitanti di Amatrice. Un presunto
sciacallo è stato fermato dalla polizia ad Amatrice, scrive Giuseppe De Lorenzo,
Giovedì 25/08/2016, su "Il Giornale". Un presunto sciacallo è stato fermato
dalla polizia ad Amatrice. Siamo nella zona alta vicino al giardino dove alcuni
degli sfollati del terremoto cercano riparo dal sole. Un gruppo di abitanti del
luogo ha notato un uomo di Napoli con una valigia piena e l'ha bloccato. Alla
richiesta di far vedere cosa c'era dentro la borsa, il napoletano si è
rifiutato. A quel punto sono intervenute le forze dell'ordine.
Il video che IlGiornale.it ha realizzato in esclusiva mostra il momento del
fermo. L'uomo grida aiuto dicendo "vi sbagliate, vi sbagliate". Le forze di
polizia lo portano allora in un angolo al riparo dalla furia della folla che
vorrebbe linciarlo. "Ma come si fa a rubare nelle case distrutte - dice molto
alterato un ragazzo - entrano e si portano via tutto. Perché gli edifici non
crollano quando ci sono queste persone dentro invece della gente perbene?". Alla
conclusione di lunghe perquisizioni e accertamenti, i poliziotti in borghese ci
fanno sapere che il presunto sciacallo "non è stato arrestato". Non sono stati
trovati elementi certi per accusarlo. "Questa persona - aggiunge un ispettore
della Digos - non ha commesso alcun reato a quanto pare". Ma è stato comunque
allontanato dalla città: "Qui non serve", conclude l'ispettore. Il dubbio che
fosse un delinquente rimane. Questa la ricostruzione dei fatti. Il presunto
sciacallo sarebbe stato visto la prima volta da un ragazzo a pochi passi da
un'abitazione dove si scavava tra le macerie. Avrebbe detto di dover riportare
il caschetto protettivo ad un amico che stava lavorando all'interno della casa
distrutta. Si sarebbe quindi spacciato per volontario. "Gli ho detto di darlo a
me - racconta un ragazzo che era nei paraggi - ma insisteva per portarlo
personalmente". Poco dopo l'episodio che ha scatenato il fermo. L'uomo, come
detto, è stato notato con una valigia da alcuni cittadini di Amatrice e poi
bloccato dalla Digos. "Diceva di essere un ingegnere", racconta il signore che
l'ha intimato ad aprire la borsa. "Ma come? - fa eco un altro ragazzo - prima
dice di essere un volontario e poi un ingegnere?". Durante il fermo avrebbe
anche sostenuto di essere di Amatrice. Ma tutti gli abitanti assicurano di non
conoscerlo. "Qui siamo tutti vicini - dice un signore - ci conosciamo bene". Il
presunto sciacallo per provare a fornire un alibi avrebbe fatto il nome di un
cittadino del luogo. Le forze dell'ordine lo hanno cercato per permettergli di
fare un riconoscimento. Si trattava di un carabiniere. Il quale, appurato di non
conoscerlo, ha avuto uno scatto d'ira. A raccontarlo è lo stesso militare. La
polizia ci fa sapere che il sospettato non è un volontario registrato. Per
questo motivo è stato allontanato dalla città. "Ci aspettiamo - conclude
l'ispettore - di doverne allontanare altri". L'allerta sciacalli è altissima.
«Dagli allo sciacallo!». Gli untori di
Amatrice, scrive Paolo Persichetti il 6 set 2016 su
"Il Dubbio". Il caso dei rumeni Ion C. e Letizia A, fermati con il nipote di 7
anni con l'infamante accusa di sciacallaggio denunciato dall'avvocato Luca
Conti, presidente dell'ordine di Rieti. Amatrice Oltre a provocare vittime e
distruzione i terremoti sembrano suscitare il malsano bisogno di capri
espiatori. Tra le pieghe del dolore e dello strazio di chi ha perso figli,
genitori, parenti o amici e ha visto la propria esistenza sbriciolarsi sotto il
crollo della propria casa, perdendo tutto ma forze più di ogni altra cosa le
tracce della propria memoria, ciò che compone l'io di ogni persona, ci sono
anche delle vittime "collaterali". L'allarme sciacalli ne ha provocate diverse
in questi giorni. Alimentata dai media con storie costruite a tavolino fin dalle
prime ore successive al sisma, la paura dello sciacallo si è insinuata
subdolamente, complice anche l'atteggiamento di alcune forze di polizia che
invece di infondere sicurezza e tranquillità nella popolazione scossa dalla
tragedia hanno moltiplicato paure, diffuso dicerie come quella del falso prete
che si aggira tra le frazioni colpite nascondendo sotto l'abito talare gli ori e
gli argenti sottratti dalle case danneggiate. Abbiamo tutti letto la storia del
pregiudicato napoletano che avrebbe preso il treno fino a Roma per poi recarsi
ad Amatrice ed essere qui scoperto, non si capisce come e dove. Una vicenda
confezionata ad arte al punto che lo stesso sindaco di Napoli aveva dichiarato
che il comune partenopeo si sarebbe portato parte civile contro l'uomo
arrestato. Peccato però che nessuno fosse finito in manette. A sole 24 ore di
distanza dal terremoto un quotidiano del Nord titolava "Maledetti sciacalli,
stanno già rubando tutto", narrando di tre arresti, tra cui ovviamente
l'immancabile «nomade», avvenuti tra le rovine di Pescara del Tronto, tanto che
la Questura di Rieti è dovuta intervenire con un comunicato nel quale si
riferiva che «allo stato non risulta alcun episodio di illegittima introduzione
di persone nelle abitazioni evacuate, tantomeno di furti perpetrati». Sono stati
eseguiti - proseguiva il testo - controlli su persone sospette o «semplicemente
presenti all'interno di aree interdette o in procinto di entrarvi», ma tutte le
verifiche «hanno avuto esito negativo e le persone sono state indirizzate ai
competenti organismi di Protezione civile o semplicemente allontanate».
Ovviamente il comunicato è servito solo a quei pochi che lo hanno letto, non
poteva certo arginare una psicosi da trauma se poi sul terreno c'è chi sobilla
il sospetto, attrezza campi che sembrano ghetti, infantilizza le persone. La
ricerca del capro espiatorio diventa allora un espediente rassicurante, una
tecnica di governo del territorio che compatta le comunità disorientate verso un
nemico esterno. Una ong francese ha rischiato di tornare indietro con il suo
carico di preziose tende se non fosse stato per il buon senso di alcuni
militari. L'esercito, oltre ai Vigili del fuoco sempre fedeli al loro motto ubi
dolor ibi vigiles, ha dimostrato sul terreno di essere il corpo con la mentalità
meno militare di tutti. Non stupisce dunque se due volontari di Platì, arrivati
ad Amatrice con i propri mezzi e tanta solidarietà - come hanno raccontato al
Dubbio - abbiano pagato il prezzo di questa fobia: accusati di esser dei
potenziali sciacalli dopo le grida di una donna anziana che non li conosceva,
nonostante lavorassero all'interno del campo messo in piedi dalla protezione
civile, sono stati allontanati da Amatrice con il foglio di via. Chi scrive ha
assistito ad un episodio grottesco: l'inseguimento da parte di sei motociclisti
dei carabinieri di un furgone, avvistato nei pressi della frazione di Preta, che
poi si è rivelato trasportare una salma. Non hanno avuto la stessa fortuna dei
volontari di Platì i due cittadini romeni di etnia Rom fermati nella tarda
mattinata del 29 agosto con l'infamante accusa di essere degli sciacalli. In un
comunicato dei carabinieri si legge che una pattuglia del nucleo radiomobile di
Roma avrebbe «sorpreso nella frazione di Preta del comune di Amatrice, un uomo
ed una donna rispettivamente di 44 e 45 anni, che a bordo di un'autovettura
Wolkswagen Passat con targa tedesca, avevano perpetrato poco prima, alcuni furti
nelle abitazioni distrutte dal terremoto». Dopo un'accurata perquisizione
«venivano rinvenuti svariati capi di abbigliamento, alcuni oggetti domestici, la
somma contante di oltre 300 euro, una pistola giocattolo sprovvista del
prescritto "tappo rosso" ed alcuni arnesi da scasso. I soggetti, entrambi di
nazionalità rumena e gravati da numerosi precedenti penali per reati contro il
patrimonio, sono stati tratti in arresto con l'accusa di furto aggravato e
trattenuti nelle camere di sicurezza dell'arma, in attesa della relativa
convalida da parte dell'autorità giudiziaria». La versione dei fatti fornita dai
carabinieri ha sollevato tuttavia alcuni dubbi, intanto perché il fermo di Ion
C. e Letizia A., che a bordo della loro macchina trasportavano anche il nipotino
di 7 anni, non è avvenuto nella frazione di Preta ma lungo la strada regionale
577 del lago di Campotosto, in uno slargo molto ampio nei pressi del bivio per
Retrosi. Dunque in un luogo lontano da centri abitati. La scena è stata vista da
chi scrive, insieme ad altre due persone, che dalla frazione di Capricchia,
immediatamente sotto Preta, scendevano in macchina verso Amatrice. La Passat era
ferma con il portellone posteriore alzato e gli stracci contenuti all'interno
gettati a terra. L'uomo e la donna erano accanto al carabiniere che controllava
i documenti. L'autorità giudiziaria dopo aver confermato il fermo ha disposto la
scarcerazione, sottoponendoli alla misura cautelare del divieto di entrare nelle
province terremotate. Nel corso del rito per direttissima, ha spiegato
l'avvocato Luca Conti, presidente dell'ordine degli avvocati di Rieti che ha
assunto la difesa dei due romeni, è emersa l'inconsistenza dei capi di accusa
(furto di biancheria e capi di abbigliamento). Gli arnesi da scasso si sono
rivelati nient'altro che il kit di soccorso presente in ogni autovettura e i
precedenti sono risultati inesistenti: la donna è sconosciuta ai servizi di
polizia mentre l'uomo aveva solo una vecchia denuncia per possesso di arma
impropria. Niente reati specifici come furti o rapine. I due non parlano
italiano, la donna è analfabeta. Nel corso della udienza la coppia, con molte
difficoltà espressive nonostante la presenza dell'interprete, ha dichiarato di
essere ignara del terremoto. In macchina avevano tutto il necessario per
dormire: un piccolo materasso, dei cuscini, coperte, biancheria varia e vestiti,
alcuni piatti, bicchieri, posate, e i giocattoli del nipotino (tra cui la
pistola di plastica), materiale privo di valore. Salta agli occhi l'assenza di
preziosi, gioielli, argenteria, materiale tecnologico? L'uomo possedeva appena
305 euro, il minimo indispensabile per affrontare un viaggio. A Preta, come
nella altre frazioni circostanti, nessuno ha lamentato furti. La coppia dopo
essere stata scarcerata non ha più ritrovato il nipotino, affidato ai servizi
sociali di Rieti che nel frattempo lo avevano trasferito a quelli di Roma. Il
terremoto può contare così un altro disperso. L'avvocato Conti ha sollecitato
l'ambasciata romena affinché il bimbo venisse restituito ai nonni, mentre il
consiglio dell'ordine di Rieti ha promosso una raccolta di fondi i cui proventi
verranno destinati ad opere di ricostruzione di edifici di interesse pubblico
nei territori colpiti dal sisma (conto corrente denominato "In aiuto delle
popolazioni colpite dal sisma" Iban: IT37O0306914601100000005558).
TERREMOTO E SOLIDARIETA’. Il delirio del
sito islamista: "Il sisma punizione di Allah". "Sì
all'Islam in Italia" è seguito da 43mila persone: "Un segno per convertire i
peccatori". E fioccano le adesioni, scrive Paolo Bracalini, Venerdì 26/08/2016,
su "Il Giornale". Non c'è solo la spiegazione scientifica dei sismologi e dei
geologi, c'è anche l'interpretazione islamica sulle vere ragioni del terremoto
che ha devastato il centro Italia. La teoria arriva da un sito di musulmani
residenti in Italia, «Sì all'Islam in Italia», che conta più di 43mila seguaci
su Facebook. «Indubbiamente i terremoti che stanno accadendo in questi giorni
sono tra i segni che Allah usa per spaventare i Suoi servi - si legge -. I
terremoti e tutte le altre cose che accadono e che provocano danni e ferite alle
persone sono a causa dello Shirk (l'idolatria, la falsa fede, ndr) e dei
peccati, come Allah dice: Qualunque sventura vi colpisca, sarà conseguenza di
quello che avranno fatto le vostre mani». La distruzione causata dal sisma non è
casuale, né un evento solamente naturale, dietro ci sono la volontà di Allah e
le colpe dei peccatori infedeli. Il post viene condiviso da centinaia di
persone: Ibrahim residente a Milano, Mohammed che vive a Parma, Hamza che invece
lavora a Padenghe sul Garda, Mehdi di Bergamo e molti altri. Il terremoto come
punizione di Allah del resto trova riscontri in diverse sure del Corano, citate
dal sito islamista a conforto della propria spiegazione. Una (Al-A'rf, 96) dice:
«Se gli abitanti di queste città avessero creduto e avessero avuto timor di
Allah, avremmo diffuso su di loro le benedizioni dal cielo e dalla terra. Invece
tacciarono di menzogna e li colpimmo per ciò che avevano fatto». Un'altra ancora
(Al-Ankabt, 40): «Ognuno colpimmo per il suo peccato: contro alcuni mandammo
ciclone, altri furono trafitti dal Grido, altri facemmo inghiottire dalla terra
e altri annegammo. Allah non fece loro torto: furono essi a far torto a loro
stessi». Il concetto è chiaro anche se non viene detto in modo esplicito dal
sito: chi è morto sotto le macerie si era macchiato di un grave peccato, non
credere in Allah, e quindi se l'è cercata. Il sito «Sì all'Islam in Italia» cita
a riprova un commentatore coranico del XIV secolo: «A volte Allah dà alla terra
il permesso di respirare, il che avviene quando accadono forti terremoti; questo
fa si che le persone si sentano spaventate, così si pentono, abbandonano i
peccati, pregano Allah e provano rammarico per i loro peccati». La soluzione per
evitare le catastrofi come quella che ha raso al suolo Amatrice e altri paesi
del centro Italia, più che costruire abitazioni antisismiche, è la conversione
all'islam: «Quello che devono fare i Musulmani e gli altri che sono responsabili
e sani di mente, è di pentirsi ad Allah, aderire fermamente alla Sua Religione
ed evitare tutto ciò che Egli ha proibito, in modo che possano essere indenni e
raggiungere la salvezza da tutti i mali di questo mondo e dell'Altro: è così che
Allah allontanerà da loro ogni male, e li benedirà con ogni bene». Nei commenti
alla pagina Facebook, oltre ai ringraziamenti ad Allah «che ci fa vedere questi
segni», c'è chi fa notare che tra i morti ci potrebbe essere anche qualche
italiano di fede musulmana. Risposta degli amministratori (ignoti) del sito
islamista: «L'articolo parla in generale. Si riferisce ai musulmani e ai non
musulmani». Il sito (che come immagine profilo ha una cartina dove il nome
«Israele» è barrato e al suo posto compare «Palestina») avvisa anche che «la
Moschea di Rieti ha offerto immediata accoglienza e supporto logistico ai
terremotati», mentre «Islamic Relief Italia sta già operando in coordinamento
con la Protezione Civile, per far affluire prontamente i primi soccorsi». La
spiegazione religiosa al terremoto non è peraltro prerogativa islamica. Anche
«Militia Christi» si avventura in un'interpretazione altrettanto sconcertante,
con un tweet («La tragedia del terremoto ci interroghi sui nostri peccati e
sull'abominio delle unioni civili») poi cancellato e goffamente smentito. Mentre
il post sul terremoto come castigo di Allah resta lì, senza che Facebook
(inflessibile sui contenuti politicamente scorretti) intervenga.
Ed a proposito di Islam. Sul terremoto che ha
straziato l'Italia prende la parola anche il presentatore Claudio Lippi. E'
indignato, e le sue parole vengono riportate da Lettera43 (mentre il suo profilo
Twitter risulta non accessibile). Lippi si riferisce alla diversità di
trattamento tra i terremotati italiani delle zone di Rieti e gli immigrati:
"Mettiamo 50 immigrati a Capalbio e i terremotati in una palestra? Non ho
parole".
Terremotati in tendopoli, immigrati in
hotel: perché gli italiani s'infuriano, scrive di
Fabio Rubini il 26 agosto 2016 su “Libero Quotidiano”. Prima le lacrime e
l'incredulità di fronte alle immagini che rimbalzavano dalle tv ai social e
viceversa. Poi, piano piano, tra politici e la gente comune s'è fatto strada un
dubbio: ma se ai clandestini lo Stato riserva alberghi con wi-fi e tv al plasma,
perché ai terremotati italiani dovrebbero toccare tende e unità abitative di
lamiera? È stato un attimo, la rete anche questa volta, è stata veicolo
imbattibile e inarrestabile e così il tam tam è partito. Corroborato anche dalle
notizie come quella apparsa sul sito dell'Huffington Post, secondo cui: «I
terremotati dovranno stare nelle tende almeno fino alla fine di settembre, poi
si vedrà». Qualcuno, come il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana, non l'ha
presa bene e ha polemizzato su quelli che facevano polemica: «è evidente che non
gli interessa né degli uni né degli altri. Vogliono solo contribuire a loro
modo, versando bile», scatenando un dibattito sulla sua pagina Facebook tra
quelli che erano d'accordo con lui e quelli che, più o meno velatamente, lo
accusavano di non stare dalla parte degli italiani. A rinfocolare le polemiche
ci ha pensato anche l'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, che con
una lettera inviata al Tempo spiega: «Conosco bene quella gente, nessuno vorrà
andarsene lontano dai loro paesi, vanno trattati come cittadini di serie A con
priorità assoluta» quindi «vanno piantate tendopoli nella zona colpita sperando
che non le abbiano usate tutte per gli extracomunitari». Poi c'è il parroco di
Boissano (Savona), don Cesare Donati, che in disaccordo con Bertolaso spiega:
«Adesso è il momento, vista la tragedia del terremoto, di mettere gli sfollati
nelle strutture e i migranti sotto le tende», raccogliendo anche il placet del
leader della Lega Matteo Salvini: «Questo parroco non ha per niente torto». Il
picco, però, è stato raggiunto a Milano. Il governatore della Lombardia, Roberto
Maroni, rilascia una dichiarazione per mettere a disposizione il campo base di
Expo sia «per ospitare in questi primi giorni i terremotati» sia «per inviare i
moduli abitativi nelle zone terremotate». E annuncia che «l'assessore Bordonali
è già in contatto con la protezione civile» ben contenta dell'aiuto ricevuto.
Tanto più che quel campo andrebbe comunque dismesso, per restituire l'area al
vicino comune di Rho. Quindi la Regione e la società Expo Spa potrebbero in un
sol colpo aiutare i terremotati e velocizzare lo smantellamento del Campo
Base. Sulla vicenda, però, è entrato a gamba tesa il neo sindaco di Milano, il
piddino Beppe Sala, ancora scottato dal «no» che lo stesso Maroni aveva posto
alla sua richiesta di trasformare il Campo base di Expo in un campo profughi.
Così, pensando di interpretare il pensiero del governatore come un dietrofront
«opportunistico», lo ha accusato a testa bassa: «Questo terremoto è un dramma da
non strumentalizzare - sbotta il sindaco -. La proposta di Maroni di utilizzare
il campo base o i suoi moduli per gli sfollati del terribile terremoto sembra
una delle tante dichiarazioni politiche che la Regione non ci fa mai mancare.
Questa volta tentando anche una strumentalizzazione su una tragedia come quella
che ha colpito il centro Italia». Un commento border line, come subito dopo gli
fa notare lo stesso Maroni: «Sono sorpreso dalle dichiarazioni del sindaco Sala.
In un momento così drammatico dobbiamo lasciare da parte le polemiche e fare
ogni sforzo per aiutare chi è stato colpito dal terremoto - ribadisce Maroni -.
Questo è il senso della mia proposta di mettere a disposizione il campo base
Expo. Proposta che, per altro, è stata condivisa dalla Protezione civile
nazionale. Intendo quindi procedere rapidamente in questa direzione per portare
aiuto concreto a chi ha subito questa immane tragedia». Con buona pace di Sala e
del Pd. Fabio Rubini.
Vittorio Feltri il 27 agosto 2016 su “Libero
Quotidiano”, la verità amara sul terremoto: "Perché pensano ai morti, ignorano i
vivi". Di solito succede questo: le grandi tragedie nazionali mobilitano i mezzi
di comunicazione, che per qualche giorno non fanno altro che parlarne in tutte
le salse fino alla saturazione. Le maratone televisive, che riprendono da ogni
angolazione i danni provocati dal terremoto, durano meno di una settimana,
sempre le stesse, i soliti cumuli di pietre, mani nude che scavano, cadaveri,
gente disperata, lacrime. D'altronde che altro potrebbero fare i giornalisti se
non raccontare ciò che hanno sotto gli occhi? Ma la ripetitività a lungo andare
spegne le emozioni che si tramutano in noia. Tra un po' i riflettori si
trasferiranno dall’Umbria, dalle Marche e dal Lazio in altri luoghi e anche
l'ultima sciagura sarà archiviata, salvo tornare a bomba quando si scoprirà che
qualche malfattore, approfittando del dolore altrui, avrà trovato il modo di
arricchirsi: appalti, stecche, prezzi gonfiati. C'è una regola che non muta mai:
le disgrazie sono occasioni d'oro per chi non ha scrupoli. L'esperienza ci ha
istruiti. Cosicché alla fine di settembre saranno pochi, oltre ai terremotati, a
ricordarsi del flagello che ha martoriato il Centro Italia. Compariranno qua e
là notizie riguardanti la ricostruzione, che tarderà a cominciare, il recupero
dei capitali necessari a finanziare le opere, le beghe tra le imprese che
cercheranno di accaparrarsi gli appalti. Nulla di appassionante. E le nostre
coscienze si quieteranno. Ecco quanto è sempre successo e succederà ancora. Le
brutte abitudini sono le più resistenti. Personalmente, in veste di cronista ho
seguito parecchie calamità: il sisma che distrusse il Friuli nel 1976, quello
che sbriciolò l'Irpinia nel 1980, quello di Perugia e dintorni nel 1997 e, assai
recente, quello che ha violentato l'Emilia. L'indomani di ogni catastrofe si è
assistito alle medesime immancabili scene e si sono uditi i medesimi discorsi
improntati a buone intenzioni, a prescindere dal colore del governo in carica:
faremo, brigheremo, ci impegneremo affinché le prossime scosse non ci colgano
impreparati. Parole, parole, soltanto parole. Esportiamo in vari Paesi le nostre
tecnologie da applicarsi agli edifici al fine di renderli sicuri, ma non le
applichiamo in Patria. Siamo bravi nella cura di ogni territorio tranne quello
che calpestiamo. Perché? Si possono avanzare soltanto ipotesi: non siamo capaci
di organizzarci, abbiamo una classe politica scucita e perennemente in polemica
con se stessa. Risultato, anziché fare, discutiamo. Si pensi che non abbiamo
ancora un piano per le zone attualmente disastrate. Le istituzioni, la Boldrini
in testa, si dannano per ottenere esequie collettive per le vittime. Sono più
preoccupate dei morti che dei vivi. Spendono molti quattrini per i profughi e
lesinano aiuti per i nostri connazionali bisognosi. Insomma, questa è la
situazione e non promette niente di buono. C'è il timore che i terremotati siano
costretti a stare in tenda mesi, mentre gli extracomunitari si crogioleranno in
belle camere d'albergo, ben pasciuti, nutriti e riveriti. L'accoglienza e la
solidarietà sono solo per individui di importazione. Vittorio Feltri.
LO STATO CRIMINALE. Lo sfregio dello
Stato ai terremotati. Profughi e sfollati: chi riceve di più,
scrive Roberta Catania, il 27 agosto 2016 su “Libero Quotidiano”. Ci sono oltre
5mila immigrati che dormono in hotel o in confortevoli appartamenti nel raggio
di 150 chilometri dalle cittadine distrutte dal terremoto del 23 agosto scorso,
mentre 2.500 sfollati italiani abitano nelle tende messe in piedi nei campi
vicini alle macerie di Amatrice, Accumoli e Pescara del Tronto, tra l'alto Lazio
e le Marche. Nessuno di questi 5mila stranieri vive in quei casermoni conosciuti
con i nomi di Cie o Cara, dove comunque vengono ospitati migliaia di
clandestini. Questi numeri si riferiscono esclusivamente al progetto Sprar
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), un programma
finanziato dal Ministero dell'Interno tramite il Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell'Asilo e che prevede l'accoglienza e la tutela dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti che sono soggetti ad altre forme
di protezione. In questi casi, le 2.545 strutture messe a disposizione in tutta
Italia sono di tre tipologie: l'82% sono appartamenti, poi ci sono alberghi
(12%) e infine le comunità di alloggio, per lo più destinate ai minori, appena
il 6%. Dati riferiti al 2015 e attuali fino all' aprile scorso, quando il
Viminale ha diffuso l'ultimo report. Così, mentre gli immigrati, divisi in base
all' età, alle parentele e ad altre necessità, hanno cucine, un bagno normale e
il riscaldamento d' inverno, i 2.500 sfollati che dormono nelle tende provano ad
arrangiarsi. Per ora lo fanno e va bene così, anche perché la maggior parte
vuole rimanere vicino a quello che gli è rimasto della loro casa e nessuno, a
così pochi giorni dai crolli, dormirebbe in una struttura dove, al primo
scricchiolio, sarebbe assalito per il terrore di sentire di nuovo le macerie
crollargli addosso. Ma tra qualche settimana, quando arriveranno le prime piogge
e poi la neve, anche i più legati al territorio inizieranno a sognare un letto
caldo, una cucina dove sia possibile preparare una minestra calda e un bagno
dove lavarsi senza soffrire temperature glaciali. Qualcuno, già ora, ammette di
temere l'arrivo del freddo. Alessandro, 67 anni, sfollato da Amatrice insieme
alla moglie e al cagnolino, oggi vive in una tenda al campo di Sant' Angelo.
Raggiunto dalle telecamere, l'uomo ha spiegato di avere «non avere paura di
rimanere nella tenda per troppo tempo», ma di aver «paura dell'inverno, che», ha
sottolineato, «è qui alle porte». Nessuno ha ancora pensato, invece, a ciò che
sarà nei prossimi anni. Giustamente questi sono i giorni del lutto per chi ha
perso i propri cari e dello choc per chi è sopravvissuto guardando la morte in
faccia. Eppure, quasi come un amaro presagio, quattro giorni prima del terremoto
tra Amatrice e Pescara del Tronto, un uomo sopravvissuto nove anni fa al sisma
dell'Aquila, ha fatto i conti con la dura realtà delle istituzioni, che spente
le telecamere ridimensionano anche il sostegno morale e - soprattutto -
economico. Quello sfollato dell'aprile 2009, il 18 agosto scorso era salito su
un cornicione al secondo piano di una palazzina del progetto Case di Cese di
Preturo, in provincia dell'Aquila, minacciando di gettarsi a causa delle maxi
bollette che stanno arrivando in questi giorni agli inquilini degli alloggi
costruiti per gli sfollati dopo il terremoto e per la chiusura dell'acqua calda
da parte del Comune nei confronti dei morosi. L' unico riuscito a far desistere
l'uomo è stato il sindaco, Massimo Cialente, che evidentemente ha promesso uno
sconto o la rateizzazione. Fatto sta che le collette e le donazioni a un certo
punto finiscono e queste persone si trovano a far il conto con le spese di tutti
i giorni, senza avere più un'attività o i risparmi di una vita. Il premier
Matteo Renzi non ha tardato a stanziare i primi soldi per aiutare i terremotati:
50 milioni di euro sono già stati destinati ad Amatrice e le altre località
colpite dal sisma di martedì notte. Però per i 5.845 immigrati ospitati negli
alberghi e negli appartamenti del progetto Sprar tra le Marche, il Lazio,
l'Umbria e l'Abruzzo, intorno cioè ai luoghi sbriciolati dalla scossa, sono
stati spesi quasi 75 milioni solo nel 2015. A voler fare i conti in difetto, si
tratta di 204.575 euro al giorno, senza cioè considerare che gestire i minori
costa di più. E l'anno scorso, per le 21.613 persone ospitate in tutta Italia
nel progetto Sprar il conto è stato salato: 276 milioni e 106mila euro. Troppo
in confronto a quei 50 milioni. Roberta Catania
TERREMOTO E SOCIAL NETWORK. "Tende no!
Alberghi per gli sfollati", il tweet di Rita Pavone infiamma il web,
scrive "L'Adnkronos.com" il 26/08/2016. "Tende no! Se ospitiamo in albergo
coloro che accogliamo quotidianamente, a maggior ragione lo si faccia per i
nostri connazionali terremotati". Con un tweet Rita Pavone scatena la polemica
sul web parlando dell'assistenza agli sfollati, dopo il sisma. "Una volta che
sono nelle tendopoli o nei containers, si rischia di veder passare anni prima
che diano a questa gente una casa" aggiunge. Ma la 'Gian Burrasca' della canzone
italiana, 71 anni appena compiuti, non si ferma: "Di cose ne ho viste. Si sono
salvati solo in Friuli perché la gente del posto si è tirata su le maniche e ha
fatto da sé". Per poi addolcirsi un po' per lasciarsi andare all'amarezza di chi
come un po' tutti si sente impotente di fronte a questa tragedia. "In momenti
come questi, le parole sono inutili - twitta con l'hashtag #terremoto -. Che il
Signore ascolti le nostre preghiere".
Rita Pavone, sottoposta ad un linciaggio
morale su Twitter, minaccia di lasciare il social,
scrive Manuela Valletti il 31 agosto 2016. Twitter non perdona: lo ha capito
Rita Pavone, sommersa da feroci commenti per aver preso le parti dei
terremotati. Rita Pavone dà battaglia sui social per i terremotati. #Rita
Pavone si è arrabbiata moltissimo per la reazione negativa che ha suscitato un
suo post su Twitter: preoccupata per la sorte dei terremotati rimasti senza
casa, ha scritto sul social questa frase:"Tende no! Se ospitiamo in albergo
coloro che accogliamo quotidianamente, a maggior ragione lo si faccia per i
terremotati". Non l'avesse mai fatto! È stata tacciata di
razzismo, di fascismo, di essere una fomentatrice delle masse e via di questo
passo. La cantante ha tentato di spiegare con pacatezza il suo pensiero, dicendo
che i terremotati nei containers ci rimangono per anni, e che di esempi di
questo genere ne abbiamo avuti in tutti i terremoti fino ad ora verificatisi in
Italia, ad esclusione di quello del Friuli, dove la gente del luogo non ha
aspettato la politica, ma si è tirata su le maniche e ha ricostruito. Non c'è
stato nulla da fare: le polemiche non si sono placate, e Rita era addirittura
intenzionata a chiudere il suo account. Convinta di non essere né razzista né
fascista, la Pavone è migrata su #facebookdove, senza demordere, ha provato a
raccontare che cosa le era accaduto su Twitter, chiedendo ai suoi nuovi
interlocutori se, secondo loro, aveva detto qualcosa di poco opportuno o di
offensivo. Si è sfogata affermando che voleva solo difendere i suoi
connazionali perché, anche se ora vive in Svizzera, si sente sempre italiana e
poi ha tutti i diritti di dire la sua opinione, visto che in Italia paga
regolarmente le tasse. Insomma, su Facebook Rita si è tolta qualche sassolino
dalle scarpe e ha tacciato i frequentatori di Twitter di intolleranza, visto che
non le hanno permesso di argomentare le sue ragioni e l'hanno anche apostrofata
in modo offensivo, dicendole che era "solo una cantante" e quindi non
all'altezza di intervenire in un dibattito così importante. Da Facebook è
inaspettatamente arrivato un sostegno totale e uno sprone a non mollare. Per
questo motivo Rita, anche se amareggiata, ha deciso di rimanere su Twitter.
Diversi fans le hanno scritto che Twitter è molto snob e che lì, più che su
altri social, vige il pensiero unico, quello dei cantanti "guru" che quando
esprimono un concetto diventa vangelo. La Pavone, rinfrancata dall'affetto e dal
sostegno dei suoi ammiratori, ha deciso di andare avanti con il dibattito per
battere la meschinità di certe persone: ha ripreso il portatile e si è detta
pronta a dare battaglia, anche se il campo questa volta non è "Ballando con le
Stelle", ma il quotidiano di tanta gente che merita anche il suo aiuto.
Direttamente dalla pagina Facebook
ufficiale di Rita Pavone: Ieri ho scoperto che i social sono molto
poco...social. Ho bloccato così tanta gente che
neppure l’ascensore rotto di un grattacielo…E sapete da cosa è nato il tutto? Da
questo mio semplice twitter: “Tende no! Se ospitiamo in albergo coloro che
accogliamo quotidianamente, a maggior ragione lo si faccia per i nostri
connazionali terremotati”. Ho detto qualcosa di poco opportuno? Ho detto
qualcosa di blasfemo? Ho detto qualcosa di offensivo? Beh… Eppure qui si è
scatenato l’inferno…! Mi sono beccata di tutto: da fascista, a schifosa
razzista, a fomentatrice di razzismo… Un delirio! Parrebbe un paradosso visto
che difendevo i MIEI di connazionali – dico MIEI perché, per chi non lo sapesse,
io ho un doppio passaporto, Svizzero e Italiano, ed essendo di origini italiane,
cosa di cui vado fiera! è ovvio che ci tenga molto alla mia gente e al mio
Paese, dove, tra l’altro, voto pure. Inoltre, pur abitando da quasi 50 anni in
Svizzera, pago regolarmente anche in Italia fior di tasse: il 30% alla Fonte!
Quindi, vedete, ho tutte le carte in regola per poter dire il mio pensiero senza
venire azzannata da idioti somari. Sapete perché ho scritto quel tw? Perché in
casi di cataclismi, si parla sempre di tendopoli o di containers che dovrebbero
servire SOLO ed esclusivamente per l’emergenza. Ma poi una volta che il momento
emotivo è passato, che non si contano più i morti, che non si fanno più servizi
televisivi sui superstiti e che quindi del terremoto non se ne parla più, ecco
che le tendopoli e i containers rimangono ma delle case da ricostruire neanche
l’ombra. Così come le donazioni che vengono fatte dalla gente e di cui poi non
si sa più nulla…Ho lavorato anni addietro nel Belice, e lì c’è gente che, 48
anni dopo (48 sic) vive ancora nei containers in attesa di una casa. Alla faccia
dello stato di emergenza! Stessa cosa vale per l’Aquila…Cosa hanno ricostruito
sino ad oggi? Niente! E sarà così, statene pur certi, anche negli anni a
venire…Si sono salvati solo i terremotati dell’Emilia Romagna e del Friuli,
poiché la loro gente si è tirata su le maniche e hanno ricostruito tutto da
soli. Se aspettavano che lo facesse lo Stato…campa cavallo che l’erba cresce….
E’ vero che la gente teme gli sciacalli, i quali, una volta presi con le mani
nel sacco dovrebbero essere buttati in una cella e gettata via la chiave per
sempre ! e quindi preferirebbero non abbandonare mai le proprie case per non
vedersi derubare del tutto, ma basterebbe una buona e stretta sorveglianza e
questa povera gente non si vedrebbe costretta a stare all’addiaccio di notte ma
potrebbe riposare in un comodo letto come fanno coloro che ospitiamo e che NON
sono tutti in fuga da paesi in guerra, come ci vogliono far credere, ma, la
maggior parte di loro, vengono da noi per trovare una situazione economica più
favorevole. E in questo io non ci trovo assolutamente nulla di male. Detto ciò,
sentirsi però poi dare dell’idiota e del “canta che è meglio”, che ho la …
“pappa” nel cervello ecc.ecc, credo non faccia piacere a nessuno. O addirittura
leggere “Si vergogni! Qui vengono fuori le sue vere origini …” come se io
provenissi da una famiglia di ladri. Delle mie origini, gente, io vado fiera!
Sono figlia di un operaio della Fiat, gran lavoratore, e di una casalinga…Sono
la terza di 4 figli, e a 12 anni già lavoravo. In nero !!! A questi poveri
schizzati, drogati nel cervello e fusi nell’anima, ho risposto: “Lavatevi la
bocca, gentaglia. E quando avrete fatto quello che ho fatto io, per me stessa e
da sola, solo allora forse potrete parlare!” Adesso avrete capito perché avevo
deciso di chiudere il mio tw. Ma voi, Amici miei, con il vostro affetto e con i
vostri bellissimi messaggi, mi avete indicato che non bisogna mai gettare la
spugna. Soprattutto davanti alle meschinità e alla malvagità di certe persone.
Allora ho rimesso i piedi per terra e mi sono rialzata, e adesso, credetemi,
sono più combattiva che mai. GRAZIE !!
Rita Pavone, la zanzara: dal buonismo
alla responsabilità, scrive Edoardo Varini su
“L’Inkiesta” il 31 Agosto 2016. Desta scalpore il tweet di Rita Pavone
sull'ospitare anche i terremotati – come gli immigrati – negli alberghi.
Testualmente: «Tende no! Se ospitiamo in albergo coloro che accogliamo
quotidianamente, a maggior ragione lo si faccia per i nostri connazionali
terremotati». Il ragionamento non fa una grinza. Ma il problema è che ad essere
terremotate, prima ancora delle aree colpite dal sisma, sono le teste dei nostri
governanti e di tutti coloro che credono sia ancora una cosa up to date,
emancipata, che "fa figo" ostentare la convinzione che gli uomini di colore sono
alla nostra stregua. Che se solo lo devi ostentare, perdonatemi, è perché non lo
pensi. È perché hai la coscienza sporca. Una frase di una tale lucidità non l'ha
detta un accademico, un politico, un giornalista di fama, no, l'ha detta Rita
Pavone, "Rita la zanzara", come dal titolo del film che la vede protagonista e
che echeggia una testata studentesca del milanese Liceo Parini, sequestrata per
oscenità pochi mesi prima dell'uscita del film. Tra i collaboratori del giornale
da 50 lire a copia vi erano futuri giornalisti quali Walter Tobagi e Vittorio
Zucconi, gente che sin da giovane con l'informazione ci sapeva fare. I soli che
non lo compravano, il giornale, erano quelli di "Gioventù studentesca": da
immaginarselo, la futura "Comunione e liberazione". Il testo incriminato era
un'inchiesta sulla sessualità giovanile, dove si leggevano frasi per l'epoca
intollerabilmente eversive quali: «Se potessi usare gli anticoncezionali non mi
porrei limiti nei rapporti prematrimoniali», detto da una studentessa.
Figuriamoci! Non è la prima volta che il nome di Rita Pavone si accosta a un
capovolgimento del modo di pensare: allora, dal moralismo al Sessantotto. Oggi
dal buonismo alla responsabilità.
Commentare le notizie senza leggerle,
quando Facebook è lo specchio dell’Italia di oggi. Cosa succede quando un gesto
di disperazione (non) è di un lavoratore italiano,
scrive Emanuele Capone il 29/07/2016 su "La Stampa". Ripubblichiamo l’articolo
comparso su Il Secolo XIX che ricostruisce la vicenda dei commenti all’articolo
pubblicato il 28 luglio sull’edizione online. Ieri mattina abbiamo pubblicato
sulla pagina Facebook del Secolo XIX la notizia dell’uomo di 38 anni che ha
cercato di darsi fuoco a Sarzana (foto) dopo avere perso casa e lavoro, ma senza
specificare che si tratta di un cittadino marocchino. Abbiamo scritto
semplicemente che «un uomo di 38 anni, sfrattato e senza lavoro, tenta di darsi
fuoco davanti alla moglie e ai figli». Il primo commento è arrivato 4 minuti
dopo la pubblicazione del post: «Diamo lavoro agli altri...», con tanto di “mi
piace” di un’altra persona che evidentemente ha la medesima opinione; poi, un
diluvio: «(con gli, ndr) immigrati non lo fanno», «aiutiamo gli italiani come il
signore», o anche, in rapida sequenza, «per lui non esistono sussidi, alberghi e
pranzi pagati, vero?» e «aiutiamo gli altri, noi carne da macello», «come mai
non gli hanno dato un albergo a tre stelle come ai (suoi, ndr) fratelli
migratori?», e i vari «ma noi... pensiamo a ‘sti maledetti immagrati (così nel
testo, ndr)» e «invece agli immigrati... » o il più articolato «ma perché,
perché... basta andare a Brindisi, imbarcarsi per l’Albania e fare ritorno a
Brindisi il giorno dopo... vestito male... e il gioco è fatto!». È solo quasi 4
ore dopo la condivisione del post che qualcuno legge la notizia e si accorge che
il 38enne è in effetti un cittadino straniero, e lo fa notare agli altri: «24
commenti e nessuno ha letto l’articolo, viste le risposte!». Proprio così: sino
a quel punto, evidentemente, moltissimi avevano commentato basandosi solo sul
titolo, senza nemmeno sapere su che cosa stavano esprimendo la loro opinione. Da
quel momento, il tenore degli interventi cambia, c’è chi fa notare a molti dei
primi commentatori che «guardate che è marocchino» e comunque il post perde
rapidamente d’interesse: il 38enne non è italiano e quindi, come fa notare
qualche irriducibile, «non avremo perso nulla...». Quel che è accaduto ieri
dimostra innanzi tutto qual è il rapporto degli italiani (di una parte, almeno)
con i cittadini stranieri: nessuna sorpresa qui, purtroppo. E nemmeno sorprende
quel che è diventato il rapporto degli (stessi?) italiani con l’informazione: se
prima si sfogliava velocemente il giornale al bar, si spiavano i titoli dalla
spalla del vicino in autobus, adesso il bancone del bar è diventato il News Feed
di Facebook e i titoli si scorrono ancora più velocemente, perché tempo da
perdere per leggere non ce n’è. Per commentare quello che non si è letto,
invece, sembra essercene in abbondanza. Ed è anche per questo, per la mancanza
di attenzione di chi legge, che da tempo il rapporto dei siti d’informazione con
commenti e commentatori è parecchio travagliato. E nell’ultimo anno non è
migliorato: «Spegniamo i commenti per un po’», aveva annunciato The Verge a
luglio 2015, più o meno nello stesso periodo in cui la Bbc si chiedeva se «è
iniziata la fine dei commenti online». In realtà, almeno per il momento, i
commenti sopravvivono, ma sempre più siti decidono di passare la “patata
bollente” (di chi insulta, offende, minaccia di morte, si esprime in modo
razzista e così via) a Facebook: sotto gli articoli non si può più commentare e
si è “costretti” a farlo sui social network, dove chi scrive è identificabile
con un nome e un cognome e soprattutto dove la responsabilità legale diventa
personale (perché anche i giornali devono tutelarsi): se offendi, vieni chiamato
tu a rispondere , non chi gestisce il sito. Pensateci, se siete fra le oltre
60mila persone che ieri si sono viste passare davanti su Facebook la notizia
dell’uomo (sì, un marocchino) che ha cercato di darsi fuoco a Sarzana e avete
lasciato un commento basandovi solo sul titolo. Se a scuola vi hanno insegnato a
leggere, prima che a scrivere, un motivo ci sarà. Abbiamo scelto di non
pubblicare qui i nomi dei commentatori, ma il post è pubblico: se siete curiosi,
potete trovare gli autori sulla nostra pagina su Facebook.
Filippo Facci censurato. Vittorio Feltri su
“Libero Quotidiano il 31 luglio 2016, la furia e lo sdegno: "Il popolo di fessi
e cretini". I social network talvolta possono essere divertenti, ma sono quasi
sempre dannosi. Amplificano i luoghi comuni, danno voce a chi di norma non ne ha
e ciò ha un valore democratico almeno apparente. Non serve combatterli e
chiederne l’abolizione. Chi non ha niente da dire di solito è molto ciarliero e
si esprime con veemenza verbale nella speranza - vana - di farsi sentire e di
avere udienza. La maggioranza dei fruitori dei social è costituita da gente
isterica che si sfoga insultando chiunque abbia un ruolo più o meno importante,
politici, uomini e donne sotto i riflettori, insomma i cosiddetti vip. I luoghi
di incontro telematico sono la versione moderna e ingigantita del bar commercio,
dove ciascuno dice la prima scemata che gli viene in testa, raramente
verificando l’attendibilità delle proprie sparate. Su Twitter e su Facebook
dominano il turpiloquio, l’invettiva e l’ingiuria. Persone anonime si divertono
un mondo ad avere accesso alla piazza web che consente loro di sparacchiare
giudizi anche temerari, comunque incauti, di sicuro poco ponderati. I social
permettono a tutti di porsi in evidenza, anzi di illudersi di contare qualcosa e
di orientare l’opinione pubblica. Però sul piano pratico non so fino a che punto
le idee della folla che usa internet per farsi notare incidano sulle decisioni
di chi ha in mano le leve del potere. Poco, suppongo. Anche perché l’uso del
computer in Italia è ancora limitato alle persone giovani che hanno
dimestichezza con le tecnologie avanzate. Osservando quanto avviene sui social
si ha poi la sensazione che essi siano un moltiplicatore di banalità atte ad
incrementare il conformismo. Chi esce dagli schemi più diffusi del pensiero
unico, quello di moda, si trova a dover combattere con una massa di disinformati
che però, essendo assai folta, si ritiene forte e invincibile. L’esempio più
eclatante lo si è avuto in questi giorni. Il nostro ottimo inviato Filippo
Facci, per aver scritto articoli documentati e vigorosi contro le violenze
islamiste, è stato confinato all’indice da Facebook, escluso dalla community
quale elemento indesiderabile. In altri termini, censurato, bocciato quale
disturbatore intollerabile di coloro che sono al servizio della divulgazione
convenzionale. Facci, giornalista eminente di Libero, come tutti può piacere o
no, ma è indubbio che sia un uomo di rara intelligenza e capace di interpretare
i fatti della vita in modo originale. Sull’islam egli ha scritto pagine che è da
fessi sottovalutare in quanto offrono spunti di riflessione profonda. Ebbene,
poiché le sue tesi non rientrano nel calderone delle insulsaggini correnti, i
guardiani di Facebook le hanno disinvoltamente oscurate, quasi si trattasse di
bestemmie. Ormai siamo a questo punto. Chi non sta con i musulmani, assassini o
no, in Italia è sgradito, considerato un reietto, un fascista, peggio, un essere
indegno di ospitalità. Fossi in Facci, mi vanterei di essere respinto dai
cretini. Libero è suo e lo sarà sempre. Vittorio Feltri
E poi la pietra tombale...
«I social media danno diritto di parola a legioni
di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza
danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo
stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli»,
scrive “La Stampa” il 10 giugno 2015. Attacca internet Umberto Eco nel breve
incontro con i giornalisti nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino,
dopo aver ricevuto dal rettore Gianmaria Ajani la laurea honoris causa in
“Comunicazione e Cultura dei media” perché «ha arricchito la cultura italiana e
internazionale nei campi della filosofia, dell’analisi della società
contemporanea e della letteratura, ha rinnovato profondamente lo studio della
comunicazione e della semiotica». È lo stesso ateneo in cui nel 1954 si era
laureato in Filosofia: «la seconda volta nella stessa università, pare sia
legittimo, anche se avrei preferito una laurea in fisica nucleare o in
matematica», scherza Eco. La sua lectio magistralis, dopo la laudatio di Ugo
Volli, è dedicata alla sindrome del complotto, uno dei temi a lui più cari,
presente anche nel suo ultimo libro `Numero zero´. In platea il sindaco di
Torino, Piero Fassino e il rettore dell’Università di Bologna, Ivano Dionigi.
Quando finisce di parlare scrosciano gli applausi. Eco sorride: «non c’è più
religione, neanche una standing ovation». La risposta è immediata: tutti in
piedi studenti, professori, autorità. «La tv aveva promosso lo scemo del
villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di
Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità»,
osserva Eco che invita i giornali «a filtrare con un’equipe di specialisti le
informazioni di internet perché nessuno è in grado di capire oggi se un sito sia
attendibile o meno». «I giornali dovrebbero dedicare almeno due pagine
all’analisi critica dei siti, così come i professori dovrebbero insegnare ai
ragazzi a utilizzare i siti per fare i temi. Saper copiare è una virtù ma
bisogna paragonare le informazioni per capire se sono attendibili o meno».
TERREMOTO E BENEFICENZA.
"Non darò nemmeno un euro per i terremotati: ci pensi lo Stato". Lino Ricchiuti,
il leader del Popolo delle Partite Iva, si oppone all'Italia in cui "la
beneficienza fa da pretesto" per non prevenire i disastri dei terremotati,
scrive Giuseppe De Lorenzo, Martedì 30/08/2016, su "Il Giornale". In molti in
Italia si sono mossi per fare qualcosa per gli sfollati del terremoto che ha
colpito sei giorni fa il Centro Italia. Tantissimi hanno donato 2 euro per i
terremotati attraverso il numero messo a disposizione dalla Protezione Civile.
Molti, ma non Lino Ricchiuti, il leader del Popolo delle Partite Iva. Persona
molto ascoltata da quelle persone vessate dal fisco e spesso minacciate da
Equitalia. "Non do una lira per i terremotati". Una posizione scomoda e
controcorrente. Che può essere apprezzata oppure no, ma comunque deve essere
ascoltata. "Scusate - ha scritto - ma io non darò neanche un centesimo di euro a
favore di chi raccoglie fondi per le popolazioni terremotate. So che la mia
suona come una bestemmia. E che di solito si sbandiera il contrario, senza il
pudore che la carità richiede. Ma io ho deciso. Non telefonerò a nessun numero
che mi sottrarrà due euro dal mio conto telefonico, non manderò nessun sms".
Lino Ricchiuti va a ruota libera. Non lo hanno "impressionato" le immagini del
disastro, "i palinsesti stravolti" e "il pianto in diretta" di Renzi. "Non do un
euro - dice - E credo che questo sia il più grande gesto di civiltà, che in
questo momento, da italiano, io possa fare". "Ecco perché non faccio
beneficienza per il sisma". Il motivo? L'Italia ha già i soldi per far fronte
alle emergenze. Ai terremotati ci dovrebbe pensare lo Stato con le tasse che
tanti italiani pagano ogni giorno. Ogni giorno. Ogni mese. Ogni anno. "Non do un
euro - continua Ricchiuti - perché è la beneficenza che rovina questo Paese, lo
stereotipo dell’italiano generoso, del popolo pasticcione che ne combina di
cotte e di crude, e poi però sa farsi perdonare tutto con questi slanci nei
momenti delle tragedie". Stanco di un'Italia in cui "la beneficienza fa da
pretesto" per non pensarci prima. Un Paese in cui è sempre meglio curare che
prevenire, perché in fondo la beneficienza smuove i cuori di tutti. "Soffriamo
(e offriamo) una compassione autentica. Ma non ci siamo mossi di un centimetro".
Uno Stato che incassa oltre il 50% di quello che produce un suo cittadino, non
merita altri soldi. "Non do una lira, perché pago già le tasse. E sono tante. E
in queste tasse ci sono già dentro i soldi per la ricostruzione, per gli aiuti,
per la protezione civile. Che vengono sempre spesi per fare altro". "Avrei
potuto scucirlo qualche centesimo - ammette Ricchiuti - (...) ma io non sto con
voi politici", perché "voi siete per una solidarietà che copra le amnesie di una
giustizia che non c’è. Io non lo do, l’euro. Perché mi sono ricordato che mio
padre, che ha lavorato per 40 anni in campagna, prende di pensione in un anno
meno di quanto un qualsiasi parlamentare guadagna in un mese. E allora perché io
devo uscire questo euro?". Il ragionamento, seppur emotivo, ha una sua logica.
Certo: forse le raccolte fondi per un terremoto simile le avrebbero fatte anche
nella efficientissima Germania. Però lì non è sempre un'emergenza. "Voglio solo
uno Stato efficiente, dove non comandino i furbi. E siccome so già che così non
sarà, penso anche che il terremoto è il gratta e vinci di chi fa politica". Un
fondo di verità c'è: l'Irpinia e L'Aquila insegnano. "Ci sono migliaia di
sprechi di risorse in questo paese ogni giorno - conclude Ricchiuti-. Se solo
volesse davvero, lo Stato saprebbe come risparmiare per aiutare gli sfollati". E
quindi "io non do una lira", ma "il più grande aiuto possibile: la mia rabbia,
il mio sdegno. Perché rivendico in questi giorni difficili il mio diritto di
italiano di avere una casa sicura".
Filippo Facci su “Libero Quotidiano” del 31 agosto
2016: perché non si dovrebbe dare un euro in beneficenza ai terremotati. Mandare
al diavolo questo clima solidaristico e dichiarare solennemente che non metterò
un euro per il terremoto, sostenere che nessuno in effetti dovrebbe metterlo
perché lo Stato ha tutti i fondi e le risorse per affrontare queste cose, non
cedere al ricatto emotivo di un Paese culturalmente imperniato sull’emergenza
anziché sull’organizzazione, votato al volontariato anziché al dovere
professionale e civico, fondato sulla beneficenza, sul numerino da chiamare,
l’sms da mandare, su giornali e telegiornali e cantanti e personalità che
mostrano immagini della catastrofe con sovraimpressi gli estremi per restare
arruolati al circo della fratellanza improvvisata: sì, la tentazione c’è, la
voglia di chiamarsi fuori è forte.
Fiorello posta un video su Facebook pubblicato da
“Corriere Tv” il 29 agosto 2016 per parlare della sua diffidenza nei confronti
dei concerti organizzati per beneficenza: «meglio fare in privato», dice. «Ieri
lutto nazionale, seguire i funerali è stata una cosa drammatica, genitori che
piangono i figli, quando si sopravvive ai propri figli, me lo diceva mio padre -
dice Fiorello - ...la macchina della solidarietà è partita alla grande, e occhio
attenzione, sono stato già invitato ad almeno quattro manifestazioni per
raccogliere fondi. Occhio a queste manifestazioni che facciamo noi del mondo
dello spettacolo. Perché se per organizzare le cose devi spendere soldi, non
devolvi tutto tranne le spese, allora non lo fai. O fanno tutti beneficienza o
non vale la pena. Occhio a chi organizza questi spettacoli. Visto che ho
ricevuto questi inviti - continua Fiorello - io mi fiderei di più se lo
spettacolo fosse organizzato da una onlus o da una organizzazione affidabile,
altrimenti la storia insegna...mi piacerebbe avere nome e cognomi. Spettacoli
che si faranno pro terremoto bisogna stare attenti. Troppa gente dietro, troppi
organizzatori, mi fanno paura. È meglio fare ognuno a modo suo, io preferisco
fare la beneficienza privata, dai i soldi direttamente e il gioco è finito».
TERREMOTO E TRUFFE. Terremoto, un affare
chiamato sisma: come evitare donazioni ai furbi.
Lucrare sulle tragedie - Attenti alle associazioni che chiedono soldi senza
indicare come verranno spesi, scrive Barbara Cataldi il 26 agosto 2016 su “Il
Fatto Quotidiano". Pannolini, spazzolini, assorbenti, ma anche piatti di
carta, sapone, scarpe: ieri beni di ogni genere sono stati raccolti in
circoscrizioni e parrocchie. Mentre la terra tremava e le vittime venivano
estratte dalle macerie, gli italiani si lanciavano in una commovente gara di
solidarietà. Ma è stato inutile: Fabrizio Curcio, il capo della Protezione
Civile ha stoppato i più generosi. “Non inviate cibo e indumenti, non abbiamo
carenze, il modo migliore di aiutare è l’sms solidale al 45500“. Alla
popolazione colpita servono solo soldi per la ricostruzione. Però si
moltiplicano le reti di solidarietà per la raccolta fondi. Solo nella prima
giornata la Croce Rossa ha raccolto 170mila euro (causale “sisma centro Italia”
(Iban IT40F0623003204000030 631681). Ma le donazioni più numerose stanno
arrivando attraverso il 45500 della Protezione Civile: due euro inviando ogni
sms o chiamando da rete fissa. Anche Poste Italiane, in collaborazione con Cri,
ha istituito un conto corrente ad hoc (causale “Poste Italiane con Croce Rossa
Italiana – Sisma del 24 agosto 2016”, Iban IT38R0760 10300000 0000900050). Non
sempre, però, le iniziative che vengono pubblicizzate, soprattutto su
Facebook o whatsapp con passaparola tra amici e conoscenti, brillano per
trasparenza. Spesso non si comprende chi tenga le fila dell’organizzazione
promotrice o a cosa davvero servano i soldi raccolti. Il rischio di incorrere in
un’associazione che utilizza il disastro per farsi pubblicità, o addirittura in
chi mette in piedi una vera e propria truffa, è concreto. In passato c’è stato
chi dopo il sisma in Emilia del 2012 ha intascato indebitamente 120.000 euro per
il sostentamento fuori casa, mentre non si è mai mosso dalla sua abitazione
inagibile di Crevalcore, chi dopo il terremoto dell’Aquila del 2009 ha percepito
più di 700.000 euro grazie a false dichiarazioni di danni mai subiti, o chi
a Monza nel 2013 ha distribuito volantini per la raccolta fondi per le vittime
dell’alluvione in Sardegna utilizzando il simbolo Cri, ma mettendo il proprio
nome e numero di telefono. “Associazioni di solidarietà come la nostra, non
devono raccogliere fondi – spiega Costas Moschochoritis, direttore di Intersos –
a questo pensano le istituzioni. Noi dobbiamo offrire il nostro contributo per
aiutare le persone colpite dal dramma, con servizi complementari, come il
sostegno psicologico”. Da oggi gli psicologi volontari di Intersos saranno
presenti nelle zone devastate dal sisma per aiutare bambini e anziani ospitati
nel campo di Accumoli. Se si dà uno sguardo ai profili Facebook di
tante associazioni, sorge il dubbio che il terremoto sia diventato un’occasione
per promuovere il proprio marchio e raccogliere fondi per il proprio
sostentamento, senza dare garanzie o spiegazioni su come i soldi verranno
spesi. Action Aid, associazione internazionale per le adozioni a distanza, ha
lanciato sui social il suo spot: “Emergenza terremoto Centro Italia. Non c’è
tempo da perdere abbiamo bisogno del tuo aiuto adesso. Dona ora”. Ma per fare
che? E così anche per Cesvi (cooperazione allo sviluppo dei Paesi più poveri).
Sulla sua homepage c’è una foto di una donna tra le macerie. Si parla di un
primo intervento per la distribuzione di beni di prima necessità. “Abbiamo
bisogno dell’aiuto di tutti, DONA ADESSO”. Ma sul campo non c’è già la
Protezione Civile? Inoltre il territorio colpito dal sisma è scarsamente
abitato, nelle tendopoli c’è un numero di persone relativamente piccolo. Con i
soldi delle donazioni, allora, cosa ci faranno? Ci piacerebbe saperlo prima di
mettere mano al portafoglio. Save the children ha istituito un Fondo emergenza
per l’allestimento di uno spazio a misura di bambino, che aiuti i più piccoli ad
affrontare il trauma subito con l’aiuto di educatori esperti. Se si compila il
form si scopre l’entità della donazione: 30 euro. Servirà solo per uno spazio
di sostegno psicologico, che gli operatori di Intersos hanno messo in piedi
gratuitamente? “Ad Amatrice abbiamo istituito uno spazio per ospitare i bambini
– spiega Giusy De Loiro di Save the children – e aiutarli con un laboratorio di
favole e disegni a superare il trauma. Le donazioni ci servono per pagare
materiali e i professionisti che lavorano per noi”. “Abbiamo chiesto al
ministero dall’Interno di gestire in modo centralizzato le campagne di
solidarietà e le raccolte fondi – afferma Carlo Rienzi, del Codacons – Ciò per
evitare gli errori del passato: quando i milioni di euro versati dagli italiani
per alluvioni e terremoti sono rimasti inutilizzati”. Per evitare inganni è bene
dare il proprio contributo sempre attraverso associazioni o enti che si
conoscono; se chi promuove l’iniziativa non è un’istituzione dello Stato, è
meglio donare solo quando è chiaro il progetto su cui i nostri soldi verranno
investiti, in modo da poter verificare la sua realizzazione. Meglio fare
la donazione solo dopo aver verificato l’esistenza dell’associazione e
attenzione alle mail con richiesta d’aiuto, il link potrebbe essere stato creato
per carpire i nostri dati.
ATTENZIONE ALLE TRUFFE SU DONAZIONI
FANTASMA. Scrive il 25 Agosto 2016 Dominella Trunfio.
C’è una mobilitazione generale nelle ultime ore perché davanti alle tragedie, il
popolo italiano si stringe sotto la parola solidarietà. Chiunque nel proprio
piccolo cerca di contribuire ad alleviare le sofferenze dei terremotati
attraverso donazioni di sangue, indumenti, alimenti e denaro. E la speranza è
sempre quella che effettivamente tutto vada a finire nelle mani giuste, ovvero
di chi è rimasto senza famiglia, senza casa e senza certezze. I social network
sono invasi da appelli e da eventi che parlano di centri di raccolta di beni di
prima necessità. Tutte iniziative lodevoli, ma anche in questo caso la parola
d’ordine è occhio allo sciacallaggio, per cui il consiglio è sempre quello di
fare donazioni tramite enti che riteniamo attendibili come Comuni, Protezione
Civile e associazioni fidate che hanno aperto conti iban dedicati all’emergenza
terremoto, mai quindi a singole persone che si spacciano per persone di
cuore. Lo scetticismo che spesso abbiamo nel donare, è dovuto principalmente a
fatti di cronaca negativi che ci hanno fatto perdere un po' di fiducia.
All’indomani del terremoto in Abruzzo, chi non ricorda lo scandalo dei 5 milioni
di euro di donazioni che non sono mai arrivati nelle tasche dei terremotati? Lì,
la questione era complessa e i soldi gestiti tramite sms, che sarebbero dovuti
servire per la ricostruzione dell’Aquila, sono finiti alle banche, grazie al
cosiddetto "metodo Bertolaso". Il paradosso era stato proprio il fatto che quei
soldi destinati ai terremotati erano stati gestiti come qualsiasi fondo, per cui
la condizione stessa di "terremotato" non andava a soddisfare i criteri di
solvibilità. Insomma, senza aprire un dibattito economico, la sostanza è che le
vittime del terremoto non avevano potuto accedere a quei fondi che erano stati
donati proprio a loro, perché già destinati a un consorzio finanziario di
Padova, l’Etimos con un fondo di garanzia bloccato per 9 anni, trasferito poi
alla Regione Abruzzo. Migliore sorte non era toccata poi ai terremotati
dell’Emilia Romagna, anche qui non si può dimenticare la lunga battaglia dei
sindaci emiliani che davanti alle telecamere gridavano di non "aver visto un
euro per la ricostruzione post terremoto". Dove erano (e sono) finiti i 15
milioni di euro che generosamente gli italiani e non solo avevano donato in
beneficenza? Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile, prova a dare una
spiegazione attraverso le pagine del Corriere: «Purtroppo l’iter non si può
comprimere più di tanto, se si vuole assicurare trasparenza. Innanzitutto una
precisazione sulla cifra, i 15 milioni non sono versamenti ma promesse di
versamento. La differenza è sottile ma decisiva. Nel senso che i vari gestori
(Tim, Vodafone, Wind eccetera) prima di versare alla Tesoreria dello Stato
l’importo corrispondente agli sms, devono effettivamente incassare la cifra. Io
posso anche inviare un messaggio ma se poi per qualche ragione non lo pago, il
gestore non versa».
TERREMOTO E BUROCRAZIA.
Un Paese fragile ed esposto con una folle burocrazia. Una cifra enorme è
stata spesa dallo Stato per le ricostruzioni post sisma. Ma secondo gli esperti
sono almeno 12 milioni gli immobili ad alto rischio, scrive Antonio Signorini,
Venerdì 26/08/2016, su "Il Giornale". Roma I terremoti hanno segnato l'Italia.
Colpa della posizione geografica, al confine tra la zolla africana e quella
euroasiatica, spiegano gli esperti. La frequenza è di un sisma distruttivo ogni
cinque anni. Cento all'anno di quelli innocui, percepibili dalla popolazione. Ma
la storia del nostro Paese è funestata anche dalle ricostruzioni. Processi
lunghi, complicati e frutto di scelte opache. Alle difficoltà di tipo fisico di
un post terremoto, ad esempio il recupero e la ricostruire centri storici
semidistrutti e la sostituzione di vecchie case con nuovi edifici antisismici,
si sommano gli effetti delle caratteristiche della nostra politica e della
burocrazia. Ricostruzioni dai tempi biblici, continui rifinanziamenti e spese
che aumentano di anno in anno senza controllo e senza che le popolazioni colpite
ne traggano beneficio. Mali antichi, riassumibili in due cifre contenute in un
rapporto del Consiglio nazionale degli ingegneri. Dal 1968 a oggi i terremoti
sono costati 121 miliardi e 608 milioni di euro. Attenzione, è spesa pubblica,
non gli effetti sul Pil che si sono fatti sentire su famiglie e imprese, che
sono un'altra storia. Soldi stanziati dal 1968 a oggi, attraverso un numero
incredibile di leggi e decreti, emanati anche a distanza di 40 anni dal
terremoto di cui si occupano. Sono 137 in tutto. La stima, a costi attualizzati,
è precisissima. Il terremoto più oneroso è stato quello dell'Irpinia del 1980.
In tutto 52 miliardi stanziati da 33 diverse leggi, che impiegheranno somme fino
al 2023. L'ultima legge sul terremoto campano varata è del 2008, 28 anni dopo la
tragedia. Ancora più longevo il terremoto del Belice. Prima legge varata nel
1968, anno della tragedia, ultimo provvedimento nel 2007. La spesa complessiva è
di 9 miliardi e 179 milioni e avrà effetti fino al 2018. Il sisma che ha
distrutto L'Aquila del 2009 è costato 13,7 miliardi, quello dell'Emilia del
2012, 13,3. Quello del Friuli del 1976, 18,5 miliardi, ma ha impegnato solo 9
leggi e gli effetti finanziari si sono fermati nel 2006. Le ricostruzioni dei
terremoti, senza contare le altre calamità naturali, rappresentano una voce
importante della spesa pubblica che ha più volte fatto sollevare la questione se
ne debba occupare lo Stato oppure, visto che le case sono beni privati, non sia
meglio percorrere la strada delle polizze assicurative obbligatorie. Soluzione
che finirebbe per fare aumentare le spese che devono affrontare i proprietari di
immobili e metterebbe nei guai anche le compagnie assicurative. L'alternativa è
quella di un piano generale di messa in sicurezza degli edifici che si trovano
nelle aree a rischio. Le più pericolose sono quelle costruite prima del 1974,
che sono il 50% del totale. Sempre secondo il Consiglio degli ingegneri,
servirebbero circa 93 miliardi per mettere in sicurezza 12 milioni di immobili
che si trovano in zone ad alto rischio terremoti. Meno di quanto ha speso lo
Stato per ricostruire.
Colpa di un funzionario distratto: così
Amatrice ha perso i contributi per salvare le case,
scrive “Libero Quotidiano” il 26 agosto 2016. La burocrazia, un funzionario
distratto, una legge sbagliata e addio contributi anti-terremoto. Spunta un
sinistro retroscena sul sisma di Amatrice e sulle macerie. Secondo La
Repubblica un dirigente distratto, che si dimentica di inviare in tempo l'elenco
dei (pochi) che hanno deciso di mettere in sicurezza la casa ha determinato la
perdita di due milioni di euro che sarebbero serviti per consolidare le
abitazioni fragili. Invece sono arrivati solo duecento mila euro. L'inchiesta
per disastro colposo aperta dal procuratore capo di Rieti Giuseppe Saieva dovrà
accertare le responsabilità. Di sicuro la burocrazia ha giocato un ruolo
letale. Subito dopo il terremoto dell'Aquila, i comuni di Amatrice e Accumoli
furono classificati "categoria 1", cioè massimo rischio sismico. L'allora
governo Berlusconi stanziò quasi un miliardo da utilizzare entro il 2016 per le
zone rosse: i soldi sono gestiti dalla Protezione civile, l'assegnazione ai
comuni passa attraverso una graduatoria regionale. Questi soldi servivano ai
privati cittadini per sistemare le loro case e renderle più sicure. Lo Stato
garantisce da 100 a 200 euro al metro quadrato, per piccoli interventi di
consolidamento. Interventi che magari non salvano una casa ma le vite sì. In
estate, la popolazione di Amatrice supera le 15mila persone, per l'ufficio
anagrafe i residenti effettivi non sono più di 2.750. Quindi quasi tutte le
abitazioni private sono seconde case. Ad Amatrice - secondo La Repubblica - è
accaduto che un dirigente poco solerte abbia spedito a Roma le richieste dei
suoi cittadini quando ormai erano scaduti i tempi di consegna, facendo perdere
così ogni diritto ai finanziamenti a chi (meno di dieci persone) che aveva fatto
domanda. Un caso emblematico di come fosse stata presa seriamente l'opportunità
del consolidamento antisismico. Ma c' è un altro motivo per cui fino ad oggi dei
10 milioni assegnati al Lazio ne sono stati spesi appena tre. La Regione Lazio
ha inserito tra i requisiti per accedere ai fondi, la "residenza", e non la
semplice proprietà della casa come invece prevede l'ordinanza della Protezione
civile. Risultato: su 1342 domande presentate per il 2013-2014 alla regione, ne
sono state accolte soltanto 191. Undici ad Amatrice per un totale di 124.700
euro, e sette appena ad Accumoli per 86.400. Diciotto piccoli interventi sull'
ordine dei 10-15 mila euro per diciotto case. Poco. Troppo poco.
Vittorio Feltri il 26 agosto 2016 su “Libero
Quotidiano” contro lo Stato criminale: "Chi ha i morti sulla coscienza". Abbiamo
svolto una breve ricognizione nei gangli della burocrazia e della politica e
siamo riusciti con rapidità a scoprire leggi formalmente complete che
disciplinano la materia edilizia antisismica. Non la facciamo tanto lunga per
evitare di annoiarvi e arriviamo subito al nocciolo della questione: quelle
leggi, approvate negli anni Ottanta (quindi in ritardo rispetto alla necessità),
sono quasi sempre state ignorate, e si è bellamente costruito dovunque lungo la
dorsale appenninica senza adottare le precauzioni fissate nero su bianco, come
se queste non fossero mai state vergate. Cosicché la stragrande maggioranza
degli edifici eretti negli ultimi decenni non è in grado di resistere alle
scosse telluriche. Tanto è vero che in occasione di terremoti molte case cadono
come foglie morte provocando stragi di umani, schiacciati dalle macerie. Non
solo. Stando alle opinioni degli esperti, anche gli stabili vecchi o addirittura
vetusti, con una spesa relativamente bassa, potrebbero essere messi in
sicurezza, così come buon senso suggerirebbe in un Paese ad alto rischio
sismico. Meglio prevenire una ferita che leccarsela. In sostanza, se le norme
sopra citate fossero state tradotte in pratica avremmo addirittura risparmiato
e, soprattutto, salvato migliaia di vite. Se poi si tiene conto dei miliardi
investiti in varie ricostruzioni l'indomani di ogni catastrofe naturale, non è
difficile capire che se quei capitali fossero stati utilizzati per rinforzare in
senso antisismico palazzi e palazzine, oggi non saremmo qui a disperarci per
quanto accaduto nelle Marche, in Umbria e nel Lazio, trascurando i tragici
precedenti dell'Aquila, dell'Emilia eccetera. Era preferibile sborsare per
proteggersi che non per finanziarsi le esequie. Ciò che sorprende e amareggia è
un fatto: il primo a non rispettare le leggi dello Stato è lo Stato stesso. Il
quale possiede una miriade di stabili non in regola con le disposizioni che ha
solennemente emanato: scuole, Poste, tribunali, enti di ogni specie. La cosa è
incredibile solo per chi non conosca lo stile della pubblica amministrazione,
che da lustri non versa neppure i contributi per i propri dipendenti, salvo
pensionarli ricorrendo al denaro della fiscalità generale. Una ingiustizia
raccapricciante. Figuriamoci se uno Stato furbetto e cialtrone quanto quello che
abbiamo descritto si preoccupa di controllare che i cittadini edifichino secondo
i criteri da esso stesso studiati, varati e violati. Se poi la gente muore sotto
il proprio tetto, pazienza, si parla di fatalità, di furia degli elementi e
altre simili stupidaggini. La verità è una e basta: il nostro Stato è criminale
e pretende correttezza dai “sudditi”. Il cattivo esempio viene sempre dall'alto.
Vittorio Feltri
Terremoti e norme, palude di regole e
regolette. Sette anni dopo il sisma dell’Aquila, i
cittadini ancora faticano a districarsi nella cervellotica poltiglia
burocratica. Per ricostruire Amatrice, sarebbe meglio non ripetere gli stessi
errori, scrive Gian Antonio Stella il 30 agosto 2016 su "Il Corriere della
Sera". I ceppi dell’umanità tormentata sono fatti di carta bollata», spiegò
Franz Kafka nelle sue Conversazioni con Gustav Janouch. Lo ricordino, quanti
stanno per mettere mano alle norme che guideranno la rimozione delle macerie, la
ricostruzione e il ritorno alla vita di Amatrice e gli altri paesi annientati
dal terremoto. Lo ricordino perché i cittadini aquilani sono ancora oggi, sette
anni dopo il sisma, impantanati in una poltiglia di regole e regolette così
cervellotiche da rendere difficile la posa di un solo mattone senza l’aiuto non
solo di un geometra ma di una équipe di azzeccagarbugli. Ricordate il dossier di
Gianfranco Ruggeri, l’ingegnere esasperato dalle demenze burocratiche che
bloccavano i cantieri? Nei primi quattro anni dopo la scossa del 6 aprile 2009
erano piovuti sull’Aquila «5 leggi speciali, 21 Direttive del Commissario
Vicario, 25 Atti delle Strutture di Gestione dell’Emergenza, 51 Atti della
Struttura Tecnica di Missione, 62 dispositivi della Protezione civile, 73
Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 152 Decreti del
Commissario Delegato e 720 ordinanze del Comune». «Confesso però», ammise, «che
nel casino qualche ordinanza municipale potrebbe essermi sfuggita». Totale:
1.109 lacci e lacciuoli. Aggiunte successive? Non si sa: «Mi sono stufato di
contarle». Ma non si tratta solo di numeri esorbitanti. Il problema è quel che
c’è dentro. La «scheda parametrica» varata dall’Ufficio speciale per la
ricostruzione dell’Aquila per accelerare i lavori si auto-loda come
«caratterizzata da norme innovative volte allo snellimento delle procedure» e
garantisce «tempi rapidi di istruttoria». Bene: la sola «Scheda Progetto - Parte
Prima» è corredata da un «Manuale istruzioni» con un indice di 114 capitoli per
un totale di 258 pagine. Pagine che nel manuale per la «Scheda progetto parte
prima aggiornato al Decreto n.4» salgono a 271. Auguri. Un esempio di
semplificazione? «Il Coefficiente topografico di amplificazione sismica St, per
configurazioni superficiali semplici, è determinato in base alla seguente
classificazione prevista da NTC 2008, 3.2.2. Categorie di sottosuolo e
condizioni topografiche “Le su esposte categorie topografiche si riferiscono a
configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali
allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se
di altezza maggiore di 30 m.”»...Un altro? «Ai sensi dell’art. 4 comma 8 del
DPCM 4 febbraio 2013 il contributo deve ridurre la vulnerabilità e raggiungere
un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una
struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per gli edifici con vincolo diretto di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Parte II…». Aveva ragione, tre secoli
fa, l’abate Ludovico Muratori: «Quante più parole si adopera in distendere una
legge, tanto più scura essa può diventare». Parole d’oro. Tanto da far sorgere
il sospetto che proprio quella slavina di Leggi speciali, Direttive del
Commissario Vicario, Atti delle Strutture di Gestione dell’Emergenza e così via
sia stata accolta a suo tempo non con preoccupazione ma con giubilo da chi
dietro le rovine vedeva l’occasione per fare affari. Come l’imprenditore che la
notte del terremoto del 2009 «rideva nel letto» o l’assessore aquilano che in
un’intercettazione (volgarotta, scusate) diceva: «Abbiamo avuto il culo del
terremoto e con tutte ‘ste opere che ci stanno farsele scappà mo’ è da fessi…».
Perché sempre lì si torna: nella fanghiglia creata da un diluvio di regole,
ammoniscono le cronache di questi anni, il cittadino perbene impossibilitato a
destreggiarsi senza violare questa o quella norma affoga, tanto più dopo che la
sua vita è già stata devastata da un trauma spaventoso quale il terremoto. Al
contrario, in quella fanghiglia, il faccendiere con le amicizie giuste e magari
un retroterra mafioso sguazza come nell’oro. Oro alla portata degli imprenditori
più spregiudicati. Al punto che nel caos generale, come denunciarono Don Luigi
Ciotti e Libera, ci fu chi riuscì a piazzare all’Aquila perfino una quantità
così esagerata di Wc chimici (34 milioni di euro!) che nelle tendopoli ogni
sfollato avrebbe potuto produrre «fino a un quintale al giorno di pipì e di
popò». Molto più di un elefante adulto. Anche ad Amatrice, in parallelo a una
consolante efficienza e ad una straordinaria generosità dimostrate da tutti gli
uomini dello Stato arrivati in soccorso alle popolazioni colpite, non è che la
burocrazia sia ancora riuscita a cambiar passo. La prima ordinanza 388 della
Presidenza del Consiglio, prima di arrivare al nocciolo, conteneva 7 «visto» e
«vista», 1 «considerato», 1 «ritenuto», 1 «rilevato», 1 «ravvisata», 1 «atteso»,
1 «acquisite»… Nella seconda i «visto» sono saliti a 9 più 1 «ritenuto», 1
«sentito», 1 «acquisite». Vecchi vizi. Per carità, amen. Non si può chiedere ai
burosauri di cambiare di colpo in piena emergenza. Ma le regole per consentire
ai cittadini rimasti senza casa di tornare a progettare il loro futuro devono
essere radicalmente diverse da quelle elaborate in questi anni per altri
sfollati. Devono essere chiare, severe nel pretendere il rispetto delle norme
antisismiche, attente a evitare gli abusi del passato. Guai, però, se fossero
così astruse da intimidire. E da aggiungere nuovi tormenti a questa nostra
umanità tormentata.
TERREMOTO COME VOLANO DELL'ECONOMIA.
La puntata di Porta a Porta andata in onda il 25 agosto 2016 dal titolo “Il
cuore dell’Italia con loro Speciale Porta a Porta” che ha approfondito il
disastro del terremoto del centro Italia, si è detta una grande verità, però sta
facendo infuriare molti italioti benpensanti.
Bruno Vespa: “Questa sarebbe una bella botta di
ripresa per l’economia perché pensi l’edilizia che cosa non potrebbe fare”;
Graziano Del Rio: “Adesso L’Aquila è il più grande
cantiere d’Europa e anche l’Emilia è un grandissimo cantiere in crescita, farà
PIL”; Bruno Vespa: “Darà lavoro ad un sacco di gente”. «Il Friuli era povero e
col terremoto è diventato ricco». «Io incontrai un industriale davanti alle
macerie della sua fabbrica. Era felice. Dico "ma scusi, le è crollata la
fabbrica…". "Ma adesso la rifaccio più bella". Ecco, l’ottimismo, questo ci
serve. Sarebbe una bella botta di ripresa per l’economia».
Catastrofi naturali e salute. Fatalismo e
prevenzione. La demagogia degli scienziati e la
sicurezza impossibile. Prevenzione. Costi e burocrazia: la protezione
irrealizzabile. Inchiesta del Dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo
storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte
le Mafie. Nelle tv salottiere e sui giornali gli “Esperti” si cimentano a dare
le loro opinioni. "Ormai abbiamo osservato che ogni 4 o 5 anni c'è un sisma che
colpisce la dorsale appenninica. Eppure gli amministratori non fanno
prevenzione. Il risultato è che l'Italia è arretrata come il Medio Oriente: in
un paese avanzato una scossa di magnitudo 6 non provoca crolli e vittime". Mario
Tozzi, geologo e noto divulgatore scientifico in tv, non usa giri di parole
contro la politica che a sette anni dal tragico terremoto dell'Aquila non ha
fatto quasi nulla per prevenire il disastro di questo 24 agosto 2016 ad Amatrice
e dintorni.
Scrive Maurizio Ribechini il 25 agosto 2016: “Un
interessante studio su questo circa un anno e mezzo fa è stato effettuato dal
"Consiglio Nazionale degli Ingegneri", il quale con una precisa valutazione dei
costi economici, ha calcolato che, fino al novembre 2014, ammontavano a più di
120 miliardi di euro gli stanziamenti dello Stato per i terremoti verificatisi
in Italia negli ultimi 50 anni: da quello siciliano del Belice nel 1968,
all’ultimo del maggio 2012 in Emilia Romagna, passando per quello del Friuli del
1976, quello dell'Irpinia del 1980, il primo avvenuto in Umbria e Marche del
1997, quello del Molise del 2002 e quello dell'Aquila nel 2009. Per una spesa
media annua di circa 2,5 miliardi di euro. Cifre ancora più elevate sono quelle
che fornivano, ormai quattro anni fa (quindi senza considerare i costi del sisma
del 2012 in Emilia) Silvio Casucci e Paolo Liberatore nel saggio dal titolo "Una
valutazione economica dei danni causati dai disastri naturali", dove hanno
stimato un costo di ben 147 miliardi di euro, per una spesa media annua di 3,6
miliardi. Tale stima arrivava da un dossier sul rischio sismico redatto dal
Dipartimento della Protezione Civile che recitava "i terremoti che hanno colpito
la Penisola hanno causato danni economici valutati per gli ultimi quaranta anni
in circa 135 miliardi di euro (a prezzi 2005), che sono stati impiegati per il
ripristino e la ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le
conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico,
artistico, monumentale". Attualizzando tale valore al 2012, si otteneva un
totale complessivo pari a circa 147 miliardi. Ma appunto tale cifra non
considerava i costi della ricostruzione in Emilia. Se vogliamo contare anche
questi, possiamo prendere dei dati ufficiali diffusi dalla Regione Emilia
Romagna nel maggio 2015, che parlavano di 1 miliardo e 770 mila euro
di contributi concessi. Ecco pertanto che la somma complessiva dei costi per i
terremoti lievita a circa 149 miliardi complessivi. Ma quanto sarebbe costato
mettere in sicurezza il territorio? L’ex capo della Protezione Civile, Guido
Bertolaso, nei mesi scorsi aveva dichiarato che per mettere in sicurezza tutto
il nostro paese occorrerebbero tra i 20 e i 25 miliardi di euro. Mentre proprio
ieri, l’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha dichiarato: "Nel 2012
presentai un piano da 40 miliardi per la prevenzione, oltre all'assicurazione
obbligatoria per il rischio sismico. Non se ne fece nulla, ma quegli interventi
sono la grande opera di cui abbiamo bisogno". Numerose altre stime tecniche ed
economiche parlano tutte di cifre che oscillano appunto fra i 25 e i 40 miliardi
di euro. Ovvero fra circa 1/3 e 1/4 di quanto abbiamo speso in 50 anni per
ricostruire dopo i terremoti.”
Detto questo gli esperti omettono di dire che il
costo della prevenzione va quasi tutto a carico del privato, salvo quella minima
parte a carico del pubblico, secondo la sua pertinenza, mentre la ricostruzione,
con tutte le sue deficienze, è tutta a carico del pubblico. Bene. Si dimenticano
i cosiddetti esperti che i cittadini italiani non sono come i profughi, ospitati
negli alberghi a 5 stelle e con vitto gratis. I cittadini italiani hanno bisogno
di un tetto sulla testa, anche abusivo e prevedibilmente pericolante. Abusivo,
stante l’incapacità degli amministratori locali di prevedere un Piano
Urbanistico Generale. I soldi son pochi e non ci sono per lussi, burocrati e
prevenzione. L'alternativa al tetto insicuro sono le arcate dei ponti. Spesso i
cittadini italiani, se non ci fossero i morti a corredo, sarebbero contenti dei
terremoti, in quanto gioverebbero della ricostruzione delle loro vecchie case.
Lo stesso vale per le alluvioni ed altri eventi naturali.
Ed ancora in tema di prevenzione non bisogna
dimenticare poi gli esperti sanitari che ci propinano consigli sulla prevenzione
delle malattie, specie tumori ed infarti. Impossibile da seguire. E non stiamo
parlando delle vecchie ed annose liste di attesa o dell'impedimento al ricorso
del pronto soccorso ormai solo aperto ai casi pre-morte.
Il 21 gennaio 2016 è entrato in vigore il
cosiddetto “decreto Lorenzin” sull’appropriatezza delle prescrizioni approvato
il 9 dicembre 2015. Il decreto che porterà alla stretta sulle prescrizioni di
visite mediche ed esami a rischio di inappropriatezza ed il giro di vite
riguarderà oltre 200 prestazioni di specialistica ambulatoriale, scrive Rai
News. E' stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale il 20 gennaio il decreto
"Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle
prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale". Si tratta di prestazioni di Odontoiatria, Genetica,
Radiologia diagnostica, Esami di laboratorio, Dermatologia allergologica,
Medicina nucleare. Il decreto Enti locali da cui scaturisce il DM
appropriatezza, prevede che le 203 prestazioni se prescritte AL DI FUORI DELLE
CONDIZIONI DI EROGABILITA' contemplate dal DM saranno poste A TOTALE CARICO DEL
PAZIENTE. Esempio. "Ai fini dell’applicazione delle condizioni di erogabilità
nella prescrizione delle prestazioni di radiologia diagnostica di cui al
presente decreto, per la definizione del «sospetto oncologico» di cui
all’allegato 1, note n. 32, 34, 36, 38 e 40 devono essere considerati i seguenti
fattori: 1) anamnesi positiva per tumori; 2) perdita di peso; 3) assenza di
miglioramento con la terapia dopo 4-6 settimane; 4) età sopra 50 e sotto 18
anni; 5) dolore ingravescente, continuo anche a riposo e con persistenza
notturna. Altro esempio. L'esame del colesterolo totale: le condizioni di
erogabilità dell'esame a carico del Ssn prevedono che sia da eseguire come
screening in tutti i soggetti di età superiore a 40 anni e nei soggetti con
fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per dislipidemia o eventi
cardiovascolari precoci. Ma in assenza di valori elevati, modifiche dello stile
di vita o interventi terapeutici, si precisa, l'esame è da ripete a distanza di
5 anni. Per quanto riguarda poi le condizioni di erogabilità delle prestazioni
odontoiatriche, si valuteranno le condizioni di "vulnerabilità sanitaria"
(condizioni sanitarie che rendono indispensabili le cure odontoiatriche) o di
"vulnerabilità sociale" (ovvero di svantaggio sociale ed economico). Anche per
l'erogazione delle dentiere sono previsti gli stessi criteri. Secondo Costantino
Troise, segretario del maggiore dei sindacati dei medici dirigenti,
l'Anaao-Assomed, "da oggi, per sapere come curare, i medici dovranno leggere la
gazzetta ufficiale e non più i testi scientifici".
E dulcis in fundo ci sono gli esperti dei sinistri
stradali. Quelli che dicono è sempre colpa dell'insobrietà, della disattenzione
e della velocità dell’autista. Questi signori probabilmente non conoscono le
cause dei sinistri:
riconducibili al conduttore (inabilità alla guida
permanente o temporanea);
riconducibili al mezzo (malfunzionamento delle
componenti tecniche per tutti i veicoli o bloccaggio del motore per le moto);
riconducibili alla strada (sconnessione o ostacoli
improvvisi o non segnalati);
riconducibili ad eventi atmosferici che limitano
visibilità o aderenza.
In conclusione la prevenzione spesso e volentieri
è impossibile attuarla per l’imprevedibilità degli eventi, ma ancor di più per i
costi e per la burocrazia esosa ed assillante ed è inutile che in tv gli esperti
ce la menano sulla prevenzione: la realtà la impedisce.
TERREMOTO ED ADEGUAMENTO ANTI SISMICO.
L'Italia dei terremoti, l'ingegnere: "Case antisismiche necessarie, le spese non
sono il problema". Francesco Sylos Labini:
"Ricostruire sullo stesso posto dal punto di vista ingegneristico potrebbe
essere una follia, ma si può fare perché la decollocazione non funziona. Le
norme tecniche per le costruzioni sono obbligatoria dal 2009, e sono ottime",
scrive Katia Riccardi il 26 agosto 2016 su "La Repubblica". A guardarla bene, la
mappa sismica dell'Italia dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(ordinanza Pcm del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b), resta impressa come una foto
dai colori troppo accesi. Il viola al centro come un'arteria a rischio, i bordi
più chiari, arancioni, gialli, verdi. L'Italia è un Paese ad alto rischio.
Altissimo in alcune zone, in altre medio, solo una minuscola porzione si salva
dai terremoti. Siamo capaci di guardare lontano da qui, in California o in
Giappone, invece anche lo stivale scalcia spesso, una volta ogni 4-5 anni una
catastrofe distrugge tutto, eppure, riesce ancora a sorprenderci. L'Abruzzo è la
regione storicamente più colpita dai terremoti: L'Aquila 1786, la Marsica e
Avezzano 1904, Messina 1908, 1915 di nuovo la Marsica e Avezzano. Nel 1919 il
terremoto al Mugello, 1930 l'Irpinia, la prima volta in questo secolo, poi ce ne
fu un altro. Nel 1933 la Maiella, 1943 Marche e Abruzzo, 1958 L'Aquila, 1963
secondo terremoto in Irpinia, 1968 il Belice, 1976 il Friuli con mille morti e
nel 1980 di nuovo l'Irpinia, la provincia di Salerno e un pezzo della
Basilicata. Poi tre giorni fa, il 24 agosto. E se le case normali crollano con
scosse di intensità 5-6 della scala Richter, solo negli ultimi 16 anni in Italia
ci sono stati oltre 110 terremoti di varia intensità, da 4 fino a quel 6,3 che
ha raso al suolo L'Aquila nel 2009. Le case non costruite a norma, collassano. I
muri mal collegati ai solai cadono lateralmente, i solai precipitano nel vuoto e
schiacciano tutto. La scossa da sottoterra muove le fondamenta, i piani bassi
oscillano e fanno traballare quelli superiori. Ma è la seconda scossa, che
arriva in senso inverso, a spezzare l'edificio come ossa sul ghiaccio. Ci
vogliono gomma, legno, un certo tipo di acciaio più plastico per ammorbidire una
costruzione e consentirle di ballare. Ci vogliono colonne, pilastri di cemento
armato piazzati in punti specifici. Il risultato dipende sia dalle
caratteristiche della casa che dai tipi di intervento. Che vanno dal
rafforzamento della struttura, per esempio con gabbie in cemento armato,
all'applicazione di isolatori, dissipatori e smorzatori, ad altre ancora. E
questo costa, fino al 10, al 20 per cento in più del costo base. C'è una
differenza importante tra prevedibilità di un terremoto e la sua inevitabilità.
Prevedere consente di scappare, forse di non morire, ma ricostruire resta
comunque inevitabile. Ripartire dalle briciole è certo più oneroso che
aggiustare. "Costruire una casa antisismica costa di meno che aggiustarne una,
un edificio esistente deve mantenere le sue origini storiche", spiega
l'ingegnere Francesco Sylos Labini, professore all'università la Sapienza di
Roma, progettista dell'intervento di recupero del Palazzo del governo a
L'Aquila. "Il Friuli dopo il sisma è stato ricostruito dov'era e com'era, con
materiali nuovi, ma le piazze, le strade sono invariati. Anche nel centro Italia
si può fare, certo, contrasterebbe contro tutti i criteri di ingegneria, e
ricostruire nello stesso posto dal punto di vista ingegneristico potrebbe essere
considerata una follia. Nello stesso tempo, gli italiani sono legati ai loro
paesi, è difficile delocalizzarli, le New Town non sono state un esperimento
riuscito. E ricostruire si può", dice. Aggiungendo che, tutto sommato, la spesa
non è poi così sconvolgente. Insomma non è la scusa. "Ora va fatta l'analisi
degli edifici, alcuni, quelli storici, sono rimasti in piedi, ma l'attenzione è
su quelli che sono crollati, ci sono interi pezzi di paesi spariti. Un tempo si
costruiva bene, bisogna analizzare perché. E dare i numeri è difficile. Diciamo
che dai 100 ai 300 euro a metro quadrato è una valutazione plausibile. La
struttura è il costo minore, perché è povera di materiali, quello che pesa sul
totale sono pavimenti, finestre, impianti. E si deve pagare comunque. Lo scopo è
ricostruire un edificio che non uccida, con scale e le strutture che restino in
piedi. Per semplicità diciamo che se un edificio costa 100, la struttura 30-35,
il resto è costo fisso" continua Sylos Labini, "che si possa costruire e
consolidare, che si possano fare le cose bene, come a Norcia, è un dato di
fatto". Arquata del Tronto è a pezzi, Norcia, poco distante, ha qualche
ammaccatura ma è restata in piedi. "Dopo il terremoto del 1979 è stata messa in
atto una ristrutturazione di Norcia e di tutte le frazioni, non è stato
semplice, ci sono voluti anni, ma abbiamo voluto ricostruire tutto rispettando
le norme antisismiche", racconta l'assessore del Comune di Norcia, Giuseppina
Perla. "Dopo le scosse di ieri, le lesioni e i crolli più importanti li abbiamo
avuti solo negli edifici vecchi non ristrutturati. Certo, questo non vuol dire
che le case costruite con criteri antisismici non abbiano subito lesioni, ma
sono lesioni contenute, che hanno salvato tante vite umane". Le case nuove
devono essere costruite, per legge, secondo norme anti sismiche, gli edifici
vecchi possono essere adeguati. Ma l'intervento è carico dei proprietari. In
California e in Giappone lo Stato offre incentivi fiscali, ma lì buttano giù
tutto e ricostruiscono. Riparano assi di legno, sostituiscono pezzi. Noi abbiamo
case in pietra, patrimoni culturali, rocche, castelli, chiese, campanili. In
alcuni casi viviamo in equilibrio su angoli di montagne. Sporgiamo in bilico.
Costruiamo case una sopra l'altra, conviviamo con monumenti e conserviamo
medioevo. Anche in città abbiamo palazzi in muratura, che se scossi diventano
briciole in pochi secondi. L'Italia dal 2013 prevede il rimborso del 65% delle
spese in 10 anni. Eppure ci vorrebbero 36 miliardi affinché il 70 per cento dei
nostri 32 milioni di edifici ancora non adeguato al rischio, lo diventi. Che si
adegui. La Protezione civile definisce normativa antisismica "l'insieme dei
criteri per costruire una struttura in modo da ridurre la sua tendenza a subire
un danno, in seguito a un evento sismico. "Dire che la normativa di
ricostruzione e adeguamento sia stata disattesa è troppo generico - continua
l'ingegnere - perché il non aver rispettato regole coinvolge singole
responsabilità. Le norme ci sono, e sono ottime norme, in linea con l'Europa.
L'attenzione o meno non è stata un'evasione di massa alla ricostruzione". Dal
1908, anno del devastante terremoto di Messina e Reggio Calabria, fino al 1974,
in Italia i comuni sono stati classificati come sismici e sottoposti a norme
restrittive per le costruzioni. Il 63, 8 per cento dei nostri edifici sono stati
costruiti prima che entrasse in vigore, nel 1971, una più efficace normativa
antisismica. Dopo il terremoto del 2002 in Puglia e Molise viene emanata
l'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n.3274 del 2003, che
riclassifica l'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa
pericolosità, eliminando le zone non classificate. Da quel momento nessuna area
del nostro Paese può ritenersi non interessata al problema sismico. Il problema
non sono i costi, ma i tempi. "Io di terremoti ne ho visti tanti", spiega Sylos
Labini. "La cosa che mi ha sempre turbato erano le tendopoli, ora ci sono i
mezzi e la tecnologia per diminuire i tempi e rifare rapidamente un tetto di una
casa, è necessario stabilizzare le persone, anche psicologicamente, la normativa
ha fatto passi enormi, e per ora la prevenzione è l'unico mezzo che abbiamo e
che dobbiamo attuare. La burocrazia frena i tempi, all'Aquila ha rallentato
tutto, ma c'è bisogno di un controllo per quanto possibile, che le cose non
sfuggano in queste maglie capillari". Che le persone capiscano l'importanza di
una ricostruzione sensata". I ministri delle Infrastrutture e dell'Interno
insieme al Capo Dipartimento della Protezione civile emanano il 14 gennaio 2008
il decreto ministeriale che approva le nuove norme tecniche per le costruzioni.
L'applicazione diventa obbligatoria dal 1 luglio 2009, come previsto dalla legge
n.77 del 24 giugno 2009. Oltre la legge, che dovrebbe obbligare un intervento,
restano le pietre a terra, per non dimenticare, per non trovare scuse. E per
rimettere in piedi case in grado di ballare, non tombe.
Le cittadelle fanno risparmiare il 50%
L'esperto: costruire ex novo costa meno. I casi
Messina e San Francisco. Il sindaco Pirozzi: si deve radere al suolo, scrive
Giuseppe Marino, Sabato 27/08/2016, su "Il Giornale". Ricostruire dov'era e
com'era. Un mantra che torna dopo ogni terremoto. Ma il sindaco di Amatrice,
Sergio Pirozzi, va controcorrente: «Amatrice è da radere al suolo
completamente», ammette dopo aver partecipato a riunioni con i vertici di vigili
del fuoco e Protezione civile. Il sindaco forse non lo sa, ma ha sfidato le ire
dei venerabili maestri dei beni culturali. Dopo il sisma del 2012 un assessore
provinciale di Mantova ventilò l'ipotesi di mettere in moto la ruspa sui ruderi
delle chiese e Salvatore Settis, ex direttore della Normale di Pisa e archeologo
con fama mediatica, lo paragonò ad Attila. Sta di fatto che il dibattito è
aperto e che il restauro può essere costosissimo. Per L'Aquila ad esempio, si
sono spesi 12 miliardi in 7 anni, e c'è ancora tanto da fare. Si va verso una
Nuova Amatrice, magari costruita altrove? Pirozzi è pronto a demolire, ma non a
spostare: «A parte la chiesa romanica di San Francesco, tutto il resto non c'è
più. Vorremmo però ricostruire Amatrice nello stesso posto, magari con la stessa
forma e con la stessa estetica». Per Gian Michele Calvi, direttore del Centro di
ricerca in ingegneria sismica e sismologia dello Iuss di Pavia che ebbe un ruolo
di primo piano nella costruzione delle «new town» dell'Aquila, «costruire da
zero costa molto meno, indicativamente una stima del 50% di risparmio non la
trovo azzardata». Calvi cita come principale caso di spostamento di centri
abitati e ricostruzione i villaggi coinvolti nel devastante sisma di Messina del
1908. «E nel 1906 a San Francisco - spiega - scelsero invece di far costruire
rapidamente a privati new town affittate a un prezzo salato mentre si
ricostruiva e poi ricomprate dalla mano pubblica e demolite, per spingere la
popolazione a tornare al suo posto». Ci sono naturalmente anche esempi di
restauro: «Sant'Angelo dei Lombardi in Irpinia e Gemona in Friuli sono i più
citati - ricorda l'ingegnere - ma il primo fu lungo e costosissimo, il secondo
fu frutto di una scelta drastica: si decise di privilegiare la ricostruzione
delle attività produttive sulle residenze. Ad Amatrice il restauro è fuori
luogo, ma si può anche scegliere di ricostruire nello stesso posto. Ma replicare
tecniche ed estetica del passato è un'idea figlia di decenni bui
dell'architettura in Italia. Costruire ex novo e bene si può». Nella scelta del
luogo pesa anche un altro fattore praticamente dimenticato, con esiti
disastrosi: i cosiddetti «effetti di sito», cioè caratteristiche del terreno che
sono in grado di accelerare l'onda sismica o attenuarla. «Le norme tecniche
recenti - dice Raffaele Nardone, consigliere nazionale dell'Ordine dei geologi -
richiedono l'analisi geologica del sito, ma ammettono che eccezioni. Che in
Italia sono diventate la regola. Ad Accumoli ad esempio non si è tenuto conto
del rischio rappresentato dal terreno che è franato all'ingresso del paese,
lambendo alcuni edifici. E la natura del terreno potrebbe aver influito anche
nel crollo ad Amatrice. Non sempre è necessario spostare le case altrove, ma è
indispensabile conoscere la natura del terreno. Magari investendo di più nella
sicurezza della casa e meno nella bellezza, se bisogna scegliere».
Ristrutturazioni anti sismiche? Lo Stato
penalizza i poveri. Le norme sulle detrazioni Irpef
per gli adeguamenti anti-sismici hanno molte falle. Meno sgravi a chi è in
difficoltà economiche, scrive Giuseppe De Lorenzo, Sabato 27/08/2016, su "Il
Giornale". Dopo il terremoto che ha abbattuto Amatrice, Accumoli e Pescara del
Tronto ci si chiede: lo Stato incentiva i cittadini ad adeguare le loro case
alle nuove norme anti-sismiche? La risposta è semplice: sì, ma solo i ricchi.
Chi guadagna 1.000 euro al mese, invece, si deve accontentare delle briciole. Vi
sembra strano? Lo è. Anzi: è una follia. Cerchiamo di capire meglio. Sul sito
dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un documento che spiega nel dettaglio
quali sono gli sgravi fiscali che il governo ha istituito nella speranza di far
diventare a prova di terremoto gli edifici antiche. Le detrazioni per le
ristrutturazioni anti-sismiche. In sintesi funziona così: il privato cittadino
paga di tasca sua i lavori. Poi lo Stato concede uno sconto sulle tasse (Irpef)
pari al 50% dell'importo speso (se fatto a partire da giugno 2012). Ovviamente
c'è un tetto massimo, pari a 96mila euro. Bene. Nel caso in cui la casa sia
costruita in una zona considerata "ad alta pericolosità" sismica, la detrazione
sale fino al 65%. Ma c'è da affrettarsi, perché l'offerta scade il 31 dicembre
2016. Dall'anno prossimo potremo sperare di ottenere solo il 36% con un tetto
massimo di 48mila euro. Son tempi di vacche magre: anche per proteggerci dal
terremoto. Una volta ristrutturata la casa, comunque, al cittadino la detrazione
non viene "regalata" in unica soluzione, ma in 10 comode rate annuali di pari
importo. Ma c'è l'inghippo: "Ciascun contribuente - si legge - ha diritto a
detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'Irpef dovuta per l'anno
in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta". In
sostanza lo sconto non può essere superiore alle tasse da versare e quindi meno
Irpef paghi e minori sgravi puoi ottenere. In questo modo le persone in
difficoltà economica hanno uno sconto Irpef inferiore. E così non sono
incentivate ad adeguare gli edifici alle norme sismiche, col rischio di morirci
dentro. Il pensionato prende meno sgravi del Vip. Facciamo un esempio. Il signor
Mario ha una pensione pari a 12.000 euro all'anno. Pochi: parliamo di 1.000 euro
al mese. Con il lavoro di una vita mette da parte un bel gruzzoletto e un giorno
decide di spendere 50mila euro per rendere la casa anti-sismica. A quel punto
chiede la detrazione di 32.500 euro (il 65% di 50mila) che divisi in 10 anni
significano 3.250 euro all'anno di quote detraibili. Ma visto che di Irpef
(lorda) Mario deve pagare solo 2.760 euro (inferiori ai 3.250 euro di sgravio
fiscale), perderà la differenza di 490 euro. E non può nemmeno chiedere un
rimborso o farli diventare una diminuzione di imposta nell'anno successivo.
Cornuto e mazziato. Quei 5mila euro a Mario avrebbero fatto sicuramente comodo.
Se lo Stato fosse stato più generoso, forse, la casa l'avrebbe ristrutturata. Ma
così sa di beffa: meno guadagni e maggiore sarà l'ingiustizia. Al contrario, chi
è ha un reddito alto (e quindi paga più Irpef) s'intascherà per intero la
detrazione. Se non basta, ecco la seconda anomalia: lo sgravio fiscale "extra"
per le zone sismiche vale solo per la prima casa. Ma ad Amatrice, Accumuli e via
dicendo, molti degli edifici erano abitazioni per le vacanze. Che quindi non
avrebbero potuto ottenere la detrazione.
Adeguamento sismico, quanto costa
l'edilizia che può salvare la vita. Si va da 100 a 300
euro a metro quadro. Per un palazzo di medie dimensioni si tratterebbe di una
spesa di circa mezzo milione. Una cifra vicina a quelle spesso impiegate per
interventi di altro tipo. Le detrazioni fiscali ci sono, ma parziali e spalmate
nel tempo. E così i lavori per la messa in sicurezza sono una rarità, scrive
Paolo Fantauzzi il 25 agosto 2016 su "L'Espresso". L'Italia ha una delle
legislazioni più all'avanguardia, in tema di normativa antisismica. Il problema
è che interessa solo le nuove costruzioni. E in un Paese dove l'edilizia storica
di vario tipo rappresenta l'80-90 per cento, è come dire che - se i lavori sono
eseguiti come si deve - solo una piccolissima fetta di edifici è davvero al
sicuro. Oltre il 40 per cento del territorio italiano è a rischio sismico
elevato e il 60 per cento degli edifici è stato costruito prima del 1974, quanto
sono entrate in vigore le prime norme antisismiche. Almeno un terzo degli
immobili andrebbe adeguato. Sulla base di questi parametri nel 2013 l'Oice,
l'associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza
tecnico-economica, stimava che il mercato per questo tipo di interventi
valesse 36 miliardi. Perché pure se l'adeguamento costa salato, può salvare la
vita. Ma di che cifre parliamo? “Con una spesa compresa fra 100 e 300 euro a
metro quadro è possibile mettere al sicuro un edificio” spiega Camillo Nuti, a
lungo docente di Tecnica delle costruzioni in zona sismica alla facoltà di
Ingegneria di Roma Tre e attualmente ordinario di Progettazione strutturale ad
Architettura: “Vuol dire 30 mila euro per appartamento di dimensioni
medio-grandi e 200-600 mila euro per un classico condominio di quattro piani.
Non poco ma si tratta di cifre che spesso, a pensarci, nel complesso vengono
spese per una serie di interventi di tanti alti tipi ma assai meno importanti.
Bisogna mettersi in testa che non ha senso rifare la cucina se poi le strutture
della casa sono a rischio”. Il campionario dei lavori che si possono effettuare
è lungo: isolatori o cuscinetti antisismici da disporre alla base degli edifici,
l’utilizzo della fibra di carbonio attorno ai pilastri che riduce notevolmente
il rischio di fratture, la disposizione di controventi dissipativi tra un piano
e l'altro per ammortizzare le scosse, rinforzi tramite l’installazione di catene
o il risarcimento delle murature. L’ultimo ritrovato, ancora allo studio, sono
particolari pannelli in legno che coprono le tamponature all'interno e che sono
in grado di fare da dissipatori. “È la dimostrazione che abbiamo un grande
patrimonio di conoscenze e che le tecnologie esistono. Tutto sta a favorirne
l’impiego” sintetizza Nuti. Ma ecco sorgere il problema economico. Chi effettua
lavori di adeguamento sismico in zone a elevata pericolosità può recuperare il
65 per cento della spesa, ma in dieci anni. Proprio come previsto per gli
interventi per il risparmio energetico. Il problema così è che, trattandosi di
somme ingenti, in pochi vi ricorrono. Anche perché si tratta di un investimento
sul futuro che non dà ritorni immediati in bolletta, né estetici, come nel caso
di una ristrutturazione. Così, se la proposta di ricorrere ai margini di
flessibilità concessi dalla Ue potrebbe essere una soluzione, si potrebbe
pensare anche a un’altra strada: una detrazione immediata o quanto meno in un
arco di tempo assai più ristretto rispetto a quello attuale. E le mancate
entrate potrebbero essere compensate dal gettito Iva derivante dagli incentivi e
dalle tasse pagate da imprese e progettisti. Con un mercato dei lavori stimato
in 36 miliardi, solo l’imposta sul valore aggiunto potrebbe portarne sette nelle
casse dell’erario. A meno che non si voglia pensare che la vita di una persona,
dal punto di vista fiscale, valga quanto una caldaia a condensazione.
Come rendere antisismica la tua vecchia
abitazione. Un sismologo ha ristrutturato la sua casa,
costruita sessanta anni fa, rendendola sicura. Ecco come e con quali costi,
scrive il 25 agosto 2016 Nadia Francalacci su Panorama. Il terremoto che
devastato l'Italia centrale, distruggendo completamente interi paesi e
estinguendo quasi intere comunità, ha riportato al centro del dibattito la
necessità di adeguare le abitazioni agli eventi sismici. L'Italia, purtroppo,
come viene ribadito in queste ore dall'Ingv, è un Paese che per sua natura è
altamente a rischio eventi sismici. E la storia sia recente che passata ce lo ha
ricordato. Dunque, si può trasformare le vecchie case in edifici antisismici? Lo
si può fare e anche prezzi contenuti. Non occorre demolire e ricostruire ma
solamente apportare piccole modifiche strutturali tali da rendere
l’edificio “dinamico” alle scosse sismiche. Con questo articolo scritto a
seguito del sisma che colpì l'Emilia Romagna nel 2012, Panorama.it, si era già
occupato dell'argomento. Ecco che cosa ci suggerì l'esperto contattato. E i suoi
suggerimenti sono sempre attuali. Paolo Frediani,
sismologo e direttore dell’Osservatorio Sismico Apuano, dodici anni fa, ha
ristrutturato la propria abitazione, una struttura costruita negli
anni Cinquanta, rendendola “resistente” al terremoto con un investimento
di "soli" 48 milioni di lire che grazie alle detrazioni, sono diventati poco più
di 20 milioni. In sostanza,10-13 mila euro circa.
Geometra Paolo Benvenuti, lei ha progettato e
seguito la ristrutturazione dell’abitazione del sismologo Paolo Frediani. Com'è
riuscito a trasformare la vecchia villetta in un’abitazione che non uccide?
«I cedimenti
strutturali che si verificano durante un sisma sono dovuti in gran parte
all'enorme quantità di peso che la struttura “portante” dell'edificio deve
sopportare. In particolare, mi riferisco al tetto. Durante un evento sismico
tutti questi carichi passano da una situazione “statica” ad una “dinamica” in
modo repentino ed è questo che ne favorisce il crollo. La problematica
principale della villetta del sismologo Frediani costruita circa sessanta anni
fa, era quella innanzitutto di legare le quattro pareti costruite in epoche
diverse e con materiali differenti. Quindi, per rendere l’edificio dinamico,
capace di assorbire il sisma, abbiamo dovuto costruire un cordolo all’altezza
del solaio e lo abbiamo fissato alla muratura verticale, ovvero alle pareti, con
tondini di acciaio e collante chimico. Poi abbiamo realizzato ex novo una
struttura in acciaio per la copertura. Questo ha permesso di alleggerire il
tetto».
Ma nel dettaglio quali sono state le fasi
principali della ristrutturazione antisismica?
«Volendo
mantenere nel locale sottotetto, un vano fruibile, si è pensato di modificare la
struttura come da classica capanna con le falde a pendenza diversa, ad una
copertura mista a capanna e a padiglione, questo ultimo fatto dovuto anche ad
esigenze urbanistiche. Per realizzare il progetto occorreva un materiale
leggero, maneggevole, coibentante e facilmente sagomabile proprio considerando
la forma della copertura. L'abbinamento che abbiamo scelto è stato
tra acciaio e pannelli autoportanti ardesiati. In questo modo si è evitato di
aggiungere le tegole che sono pesanti e durante il sisma diventano pericolose.
Le travi, invece, sono state collegate tramite idonee piastre di distribuzione
ad un cordolo in calcestruzzo armato in modo da scaricare il peso di tutta la
struttura sulla sottostante muratura. E’ fondamentale sottolineare che durante
tutta la durata del cantiere, non è stato demolito il solaio e questo ha
permesso a coloro che vi abitavano di non lasciare mai la villetta».
Con questo metodo di quanto è riuscito ad
alleggerire il tetto?
«Di circa due
terzi. In sostanza, con il metodo classico, il solaio in laterocemento e
calcestruzzo avrebbe avuto un peso medio per metro quadrato di circa 290
chilogrammi mentre con il metodo antisismico abbiamo ridotto il peso a 100 kg
per metro quadrato».
Oggi, quanto può costare un intervento come
quello appena descritto?
«Calcolando una
superficie di circa 90-100 metri quadrati, realizzare una ristrutturazione
antisismica, può costare da 20 e 30 mila euro circa».
Ed è possibile intervenire con altrettanta
facilità anche negli appartamenti? E con che costi?
«Negli
appartamenti è più impegnativo anche perché il progettista deve necessariamente
verificare e analizzare tutta la struttura portante dell’edificio e poi
intervenire eventualmente sulla singola unità. Ma ad esempio l’istallazione di
una catena che serve per collegare ovvero tenere unite, le due facciate opposte
di un palazzo il costo può variare dagli 800 ai 1.200 euro a seconda della
dimensione. Anche questo è un intervento antisismico, certamente minimo, ma pur
sempre funzionale».
TERREMOTO E LOBBY.
Il Fascicolo del fabbricato: Ecco poi, come la lobby degli ingegneri specula e
tira acqua al suo mulino per creare burocrazia ed a loro ulteriore lavoro.
Terremoto: norme permissive, poche
risorse e niente mappatura. “In zone a rischio l’80%
dei fabbricati crollerebbe”. Alessandro Martelli, ingegnere sismico, e
presidente del Glis: "L'enorme patrimonio edilizio del Paese, che è vecchio, non
è in grado di sostenere questi sismi. La normativa però non impone né
l’adeguamento né il miglioramento sismico e i finanziamenti che il governo
dovrebbe stanziare arrivano con il contagocce". In più non esiste una vera mappa
dei fabbricati (almeno quelli pubblici) più vulnerabili, scrive di Melania
Carnevali il 25 agosto 2016 su "Il Fatto Quotidiano". “L’80% dei fabbricati
nelle zone ad alto rischio non reggerebbe un terremoto come quello della scorsa
notte (leggi). Crollerebbero tutti”. Incluso scuole, ospedali, caserme,
prefetture, ossia i luoghi considerati strategici in caso di emergenza, come un
terremoto. A dirlo è Alessandro Martelli, ingegnere sismico, presidente del
Glis (istituito dall’associazione nazionale italiana di ingegneria sismica),
docente a cui nei primi anni Duemila venne tolta la cattedra ad architettura
all’università di Ferrara in Costruzioni in zona sismica: “Dissero che era
inutile nella regione”, racconta ailfattoquotidiano.it. Poco dopo ci fu il
terremoto in Emilia. L’80% è la percentuale di costruzioni storiche in Italia,
realizzate prima del 1981, anno in cui – dopo il sisma che devastò Irpinia –
venne introdotto l’obbligo del rispetto di specifiche norme antisismiche per le
costruzioni. Da allora la normativa viene aggiornata sisma dopo sisma, strage
dopo strage, alzando di volta in volta l’asticella di sicurezza. E – salvo
lavori non eseguiti come da progetto – le nuove costruzioni risultano sicure.
“Il problema grave di questo territorio – spiega a ilfattoquotidiano.it Martelli
– è l’enorme patrimonio edilizio del Paese, che è vecchio e non è in grado di
sostenere questi terremoti”. Secondo il sismologo Massimo Cocco, dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ben il 50% delle scuole è stato
costruito prima del 1981. La normativa però non impone né l’adeguamento sismico,
né il miglioramento sismico, se non nel caso di lavori che interessino le parti
strutturali. E questo riguarda sia i privati sia il pubblico. I Comuni e le
Regioni sono obbligati solo – da una legge introdotta nel 2002 dopo il terremoto
in Molise, dove crollò una scuola, e operativa solo dal 2012 – a uno studio di
vulnerabilità dei palazzi di loro proprietà. Ossia a verificare se sono sicuri o
meno. Punto. Poi, di fatto, possono rimanere come sono: sicuri o no. Perché?
I finanziamenti: nel Paese più insicuro d’Europa dal punto di vista sismico
(insieme a Grecia e Turchia), si contano con il contagocce. “Il governo dovrebbe
stanziare ogni anno una somma nella sua Finanziaria per arrivare alla sicurezza
nel giro di un decennio – commenta Martelli, ingegnere sismico – E invece ogni
anno dicono che non ci sono soldi, aggravando la situazione. Poi, quando ci sono
terremoti di questo tipo, si spende tre volte tanto di quello che si saprebbe
dovuto spendere. In Giappone, un sisma del genere, non avrebbe fatto notizia
perché hanno investito molto nell’edilizia”. Ma il punto poi è anche un altro e,
se possibile, peggiore: una vera mappa dei fabbricati (almeno quelli pubblici) a
rischio non esiste. Quanti ospedali o quante scuole rischiano di crollare in
Italia? Quante prefetture rischiano di non poter svolgere la loro funzione in
caso di emergenza? Non si sa. Da anni il Consiglio nazionale dei Geologi si
sgola per chiedere un “fascicolo del fabbricato”, ma la politica ha sempre
risposto picche. “Noi lo definiamo ‘libretto pediatrico’ – spiega Domenico
Angelone, consigliere nazionale dei geologi – perché conterrebbe tutte le
informazioni del fabbricato: dalla nascita agli ultimi interventi, incluso la
collocazione. Un fabbricato spesso può essere infatti considerato a norma dal
punto di vista sismico, ma magari è situato su una frana. A noi mancano tutte
queste informazioni. Ci sono costruzioni di cui non sappiamo proprio nulla”.
L’unico dato certo, fornito dai geologi, è che in Italia circa 24 milioni di
persone vivono in zone ad elevato rischio sismico: è la cosiddetta zona 1 (le
zone sono 4), quella che prende parte dell’Appennino, dal sud dell’Umbria fino
alla Calabria e una parte di Sicilia. Ma la prevenzione, secondo i geologi, è
pari a zero. “Da anni diciamo che in Italia siamo ben lontani da una cultura di
prevenzione – spiega il presidente del Consiglio nazionale dei
Geologi, Francesco Peduto – Innanzitutto sarebbe necessaria una normativa più
confacente alla situazione del territorio italiano: oltre al fascicolo del
fabbricato chiediamo un piano del governo per mettere in sicurezza tutti
gli edifici pubblici. Inoltre, affinché cresca la coscienza civica dei cittadini
nell’ambito della prevenzione sismica, bisognerebbe cominciare a fare anche una
seria opera di educazione scolastica che renda la popolazione più cosciente dei
rischi che pervadono il territorio che abitano. Non dimentichiamo – continua il
presidente dei geologi – che, secondo alcuni studi, una percentuale tra il 20 e
il 50% dei decessi, in questi casi, è causata da comportamenti sbagliati dei
cittadini durante l’evento sismico”. Prevedere un terremoto, secondo i geologi,
è impossibile. “Sappiamo che l’Italia è un territorio a rischio – spiega Peduto
– ma non è possibile sapere in anticipo dove verrà e di che intensità”. Quello
che rimane quindi è la prevenzione. “Che, in Italia – chiosa il geologo -, è
proprio ciò che manca”.
E dopo la lobby degli ingegneri ecco le pretese
della confedilizia.
Terremoto, ingegneri: "La messa in sicurezza delle
case italiane costa 93 miliardi. Il 50% non adeguate per un sisma", scrive
"L'Huffington Post" di ANSA il 25/08/2016. "Per la messa in sicurezza del
patrimonio abitativo degli italiani da eventi sismici medi" il costo complessivo
è "pari a circa 93 miliardi di euro". E' uno dei dati forniti dal Consiglio
nazionale degli ingegneri (su elaborazione del suo Centro studi), a seguito
degli eventi tragici nell'Italia centrale. Il complesso delle abitazioni
residenziali, recita il dossier, "si presenta particolarmente vetusto e, per
questa ragione, potenzialmente bisognoso" di interventi: circa "15 milioni di
case (più del 50% del totale) sono state costruite, infatti, prima del 1974, in
completa assenza di una qualsivoglia normativa antisismica". E, inoltre, almeno
"4 milioni di immobili sono stati edificati prima del 1920 e altri 2,7 milioni
prima del 1945". Secondo i professionisti, la quota di immobili da recuperare,
sulla base dell'esame dei danni registrati alle abitazioni de L'Aquila e delle
condizioni del patrimonio abitativo raccolte dalle indagini censuarie, "è pari a
circa il 40% delle abitazioni del Paese, indipendentemente dal livello di
rischio sismico". Politiche di incentivazione, soprattutto fiscale, degli
interventi per la tutela del patrimonio immobiliare e per la prevenzione dei
danni da calamità. E' questa, secondo Confedilizia, la strada da seguire alla
luce del terremoto nel centro Italia. Secondo l'associazione, "quel che
certamente non serve - e che, anzi, porta danni - è ipotizzare obblighi
generalizzati di intervento o di redazione di improbabili certificati ovvero
riesumare proposte bocciate dalla storia: come quella di un obbligo
assicurativo, contrastata anche dall'Antitrust, o quella del fascicolo del
fabbricato, libretto cartaceo dichiarato illegittimo dai giudici di ogni ordine
e grado e avversato anche dal Governo Renzi, che ha tempo fa impugnato una legge
regionale in tal senso". Quanto al post-terremoto, il Governo in carica, con un
provvedimento previsto dall'ultima legge di stabilità e attuato con una delibera
pubblicata in Gazzetta Ufficiale proprio venti giorni fa, ricorda Confedilizia,
"ha varato un sistema di gestione delle calamità naturali che permette a
cittadini e imprenditori danneggiati di ottenere considerevoli aiuti per la
riparazione o ricostruzione delle case e per il ripristino delle attività
produttive. Confidiamo che le relative risorse siano incrementate, a beneficio
delle popolazioni colpite dal sisma che ha colpito Lazio e Marche".
TERREMOTO E SPRECHI. I fondi per la
ricostruzione spartiti in “consulenze d’oro”. Così dal
’97 i partiti hanno gestito i soldi pubblici del dopo-terremoto. 790
professionisti. Ingegneri, geometri, architetti e geologi che hanno avuto
consulenze nella ricostruzione, scrive Paolo Festuccia il 31/08/2016 su "La
Stampa". La caccia agli appalti è cominciata. La sta facendo la Guardia di
Finanza su delega della procura di Rieti. Obiettivo: accertare quali ditte,
quali tecnici e con quali criteri sono stati concessi soldi pubblici per la
ricostruzione post sisma del 1997. A cominciare dai lavori svolti nei Comuni di
Accumoli ed Amatrice dove le opere rifatte e realizzate per il miglioramento
sismico sono crollate nuovamente. Ma Amatrice e Accumoli, in questa storia di
crolli e ricostruzioni, rappresentano solo una piccola parte del fiume di denaro
pubblico che con il sisma umbro-marchigiano sono piovuti sull’intera provincia
di Rieti. Non solo, il reatino ha beneficiato anche di un’altra cospicua
iniezione di denaro pubblico anche per lo sciame sismico del 2001. Risultato:
tra il primo stralcio e il secondo i soldi pubblici spesi per riedificare gli
immobili lesionati, chiese, scuola e abitazioni private sono stati 61 milioni e
625 mila euro. A questi si devono aggiungere altri 5 milioni (sempre di euro) e
il totale arriva a 66 milioni di opere finanziate. Una vera manna per
costruttori, professionisti, ingegneri e architetti. A vigilare sulla doppia
ricostruzione, soprattutto nella prima fase dell’emergenza, in tempi diversi e
in base alle alternanze di governo alla Regione Lazio, si sono avvicendati tre
sub commissari: il primo l’ex presidente della Provincia di Rieti Giosuè
Calabrese (Ppi all’epoca), il secondo con l’avvento della giunta Storace, l’ex
assessore regionale (reatino) di Alleanza nazionale al Turismo e alla Cultura
Luigi Ciaramelletti. Infine nel 2005 l’allora presidente della provincia, oggi
parlamentare del Pd, Fabio Melilli, quando già molto ormai era stato
assegnato. Calabrese ha affidato lavori e incarichi per oltre 30 milioni,
Ciaramelletti per poco meno. Sotto il loro scettro si sono alternati oltre 790
professionisti della zona: geometri, ingegneri, architetti, geologi. Tanti anche
per «dividersi» consulenze minori e appalti di lieve entità. Ma molti, come
elencato nel piano di attuazione del programma stralcio, hanno lavorato su
diversi fronti contemporaneamente, e quindi a piccole dosi «hanno portato a casa
cifre interessanti», afferma una fonte ben informata. In molti casi nella lista
ci sono pure ex sindaci, ex consiglieri comunali di vari Comuni, figli di:
alcuni tra questi sono passati da un municipio all’altro. Del resto i Comuni
beneficiati dalla manna pubblica (tra il primo e il secondo stralcio) sono stati
49 su 72 e molti professionisti sono stati chiamati come progettisti in un luogo
e come collaudatori in un altro. Per ogni lavoro «sono stati impiegati tre
professionisti… E va da sé che anche nelle opere minori questo ha in un certo
senso - riprende la fonte - abbassato anche il valore di prestazione d’opera
circa la qualità del rifacimento». Un’accusa pesante, dunque. Non solo, se si
osservano i documenti balza subito agli occhi come i 33 milioni di euro
stanziati siano stati frazionati in interventi, (soprattutto tra Amatrice e
Accumoli dove si è verificato il sisma e i palazzi sono crollati nuovamente),
con importi non oltre i 150 mila euro, cifra entro la quale appalti e incarichi,
all’epoca, potevano essere affidati a trattativa privata. Chi conosce quegli
atti, insomma, assicura che la pioggia finanziaria è scesa sui Comuni «mettendo
d’accordo tutti: sia la destra che la sinistra, sia i liberi professionisti di
destra che quelli di sinistra». Da Amatrice a Fiamignano, passando per
Cittaducale e Rieti. Stime alla mano, l’incidenza delle consulenze progettuali
ha pesato sull’opera per il 40 per cento dei lavori (Iva compresa). Insomma, su
125 mila euro stanziati 45 mila sono andati ai tecnici e solo 75 mila al
rifacimento dei lavori. Se il nodo si affronta da questa prospettiva, allora, è
probabile che gli inquirenti nel sequestrare le carte degli appalti affidati
vogliano anche accertare se le imprese si siano limitate solo al rifacimento
della parti crollate, oppure abbiano anche provveduto al miglioramento sismico
così come previsto nel capitolato. Non quindi all’adeguamento ma almeno al
miglioramento. «Un fatto è chiaro - riprende la fonte - da tutta questa vicenda
si evince che dare lavori a tre progettisti significa poi tagliare i costi sui
lavori effettivi». Tanto per citare un esempio, tra Amatrice e Accumoli, dove
quasi tutto ciò che è stato rifatto è inagibile, crollato o fortemente
compromesso dal terremoto del 24 agosto scorso, su un importo vicino ai tre
milioni di euro stanziati tra integrazioni e fine lavori sono stati ben 72 i
tecnici incaricati con l’aggiunta di geologi e collaudatori. Se il tariffario
indica il 40% per la progettazione, questo significa che su 3 milioni circa un
milione 200 mila euro è finito nelle consulenze mentre il restante milione e 800
mila euro in cemento armato e ferro. Che spalmato su 21 immobili fortemente
danneggiati fa una media di poco più di 85 mila euro. Dentro questa cifra ci
dev’essere il guadagno per impresa e operai.
Terremoto: costruiscono, ricostruiscono,
consulenti…stessa casta, scrive Riccardo Galli su
“Blitz Quotidiano” il 31 agosto 2016. Terremoto, quelli che costruiscono prima
del terremoto (male molto male) sono quasi sempre gli stessi che nel dopo
terremoto riparano e ricostruiscono (finora ancora male). E sono gli stessi,
proprio gli stessi che intercettano i fondi per la ricostruzione e li
trasformano in buona parte in consulenze. Un’altra casta, fatta di geometri e
asri, consiglieri comunali e ingegneri, avvocati, commercialisti, imprenditori,
notai, perfino parroci. “Non sono i terremoti ad uccidere, ma i palazzi che
crollano”, diceva e continua a dire Giuseppe Zamberletti, papà della nostra
Protezione Civile, trovando una forse inaspettata eco nelle parole dal Vescovo
di Rieti durante i solenni funerali di ieri. Ma di terremoto, e soprattutto di
ricostruzione, si vive anche. Al punto che intorno all’emergenza vive e
prolifera una vera e propria piccola casta. Una casta fatta di ditte e
professionisti che costruiscono (male) e ricostruiscono dopo i crolli, dando tra
la prima e la seconda cosa consulenze sui lavori da fare. Sempre le stesse
persone. “Capita dunque che lavorino sempre gli stessi professionisti del sisma
– scrive Sergio Rizzo sul Corriere della Sera -. Tanto più nei piccoli centri:
quando si tratta di tirare su un muretto o una palazzina, ci pensa il geometra
autoctono. E ci pensa pure se quel muretto o la palazzina crolla causa movimento
tellurico imprevisto. Figuriamoci se poi il tecnico ha le mani in pasta
nell’amministrazione comunale. Niente di illegittimo, ovvio. Ma qualche domanda
è giusto farsela. Il fatto è che soprattutto nei piccoli centri la commistione
fra la politica e certe figure professionali risulta inevitabile. Quello che un
tempo in una comunità rappresentavano il farmacista e il notaio, ora è in molto
casi il geometra. Meglio se con un incarico politico. Ha raccontato Mariano
Maugeri sul Sole 24 ore che ad Amatrice il vicesindaco Gianluca Carloni è un
geometra che continua a lavorare nello studio tecnico con il fratello Ivo, un
ingegnere che ha costruito mezza Amatrice e negli anni 90 aveva ristrutturato la
caserma dei carabinieri di Accumoli, fortemente danneggiata dal sisma’”. Se
tutto sia legittimo e legale ora, almeno nel caso dei comuni e dei lavori
effettuati sugli immobili venuti giù col terremoto del 24 agosto, lo
stabiliranno le inchieste e, come hanno ricordato i Finanzieri incaricati delle
indagini dalla procura di Rieti: “Ora andremo a vedere perché sono sempre le
stesse ditte ad effettuare i lavori, certo è strano, forse qualche dipendente
pubblico non ha fatto benissimo il suo lavoro”. Il dis tra legale e illegale è
in questi casi però sottilissimo e, in verità, per raccontare questo mondo che
di terremoto e soprattutto emergenza vive, nemmeno rilevante. Perché come
racconta Paolo Festuccia su La Stampa il 31 agosto 2016 parlando della
ricostruzione post sisma del ’97: “Da Amatrice a Fiamignano, passando per
Cittaducale e Rieti. Stime alla mano, l’incidenza delle consulenze progettuali
ha pesato sull’opera per il 40 per cento dei lavori (Iva compresa). Insomma, su
125 mila euro stanziati 45 mila sono andati ai tecnici e solo 75 mila al
rifacimento dei lavori. Se il nodo si affronta da questa prospettiva, allora, è
probabile che gli inquirenti nel sequestrare le carte degli appalti affidati
vogliano anche accertare se le imprese si siano limitate solo al rifacimento
della parti crollate, oppure abbiano anche provveduto al miglioramento sismico
così come previsto nel capitolato. Non quindi all’adeguamento ma almeno al
miglioramento. (…) Tanto per citare un esempio, tra Amatrice e Accumoli, dove
quasi tutto ciò che è stato rifatto è inagibile, crollato o fortemente
compromesso dal terremoto del 24 agosto scorso, su un importo vicino ai tre
milioni di euro stanziati tra integrazioni e fine lavori sono stati ben 72 i
tecnici incaricati con l’aggiunta di geologi e collaudatori. Se il tariffario
indica il 40% per la progettazione, questo significa che su 3 milioni circa un
milione 200 mila euro è finito nelle consulenze mentre il restante milione e 800
mila euro in cemento armato e ferro. Che spalmato su 21 immobili fortemente
danneggiati fa una media di poco più di 85 mila euro. Dentro questa cifra ci
dev’essere il guadagno per impresa e operai”. Si tratta, specie nelle piccole
realtà e in un Paese dove le occasioni per i progettisti non sono all’ordine del
giorno, anche di guerre fra poveri. Non è, o almeno non sempre, una rete votata
al malaffare ma uno spaccato di quell’Italia che vive e sopravvive grazie al
denaro pubblico, che considera questo alla stregua di un diritto e ha una
capacità di prevenire tendente allo zero. Una casta che non gode di quell’aura
negativa che circonda, ad esempio e purtroppo molte volte a ragione, i politici.
E’, al contrario, una casta di cui la gente si fida: si ricorre sempre alle
stesse ditte e agli stessi professionisti certo perché i lavori non vengono
affidati attraverso gare d’appalto, ma anche perché il geometra fratello del
sindaco, cugino della ditta che ha ristrutturato casa rappresenta una sorta di
garanzia. Come dicono a Napoli: “però sparti ricchezza e addiventa puvertà”, e
se sui fondi messi in campo per ogni ricostruzione quasi la metà finisce in
consulenza, è conseguenziale che i lavori dovranno essere fatti al risparmio.
Tanto ci sarò sempre tempo per rifarli, forse meglio, al prossimo crollo.
TERREMOTO E MONOPOLIO. Terremoto, i
«professionisti» della ricostruzione. Lavorano sempre
gli stessi, tirano su muretti e palazzine e li riparano se crollano. Il
meccanismo che ha portato tanti affari in poche mani ha rallentato il dopo
sisma, scrive Sergio Rizzo il 30 agosto 2016 su "Il Corriere della Sera". C’era
la fila, davanti alla porta di Pasqualino Fazio. Perché fratello del sindaco,
Mariano Fazio? Oppure in quanto fratello di Antonio Fazio, altissimo dirigente
della Banca d’Italia? Macché. Semplicemente perché era l’ingegnere di Alvito,
paese di tremila abitanti in Ciociaria. I paesani lo conoscevano e si fidavano
di lui. Non che l’essere fratello del sindaco e del futuro governatore della
banca centrale rappresentasse un handicap, intendiamoci: il cognome Fazio ad
Alvito è sempre stato una garanzia. E Pasqualino era gettonatissimo. Suo il
progetto delle case popolari, prima del terremoto. Suoi anche i progetti per gli
edifici pubblici, dopo il terremoto: il municipio del fratello e il convento di
San Nicola. E le abitazioni private di quelli in fila davanti alla sua porta,
lesionate dal terremoto. Perché nella dorsale appenninica perennemente
martoriata da sisma ci fu una scossa anche ad Alvito, nel 1984. Che si portò via
un bel po’ di calcinacci restituendoli poi con gli interessi: 10 miliardi di
lire per la ricostruzione. Per come hanno sempre funzionato le cose in questo
Paese è normale che andasse così. E così è sempre andata anche dopo. È il
sistema. Il privato che ha la casa danneggiata con i contributi statali fa quel
che vuole. Dà l’incarico a chi preferisce: non ha l’obbligo di fare una gara.
C’è chi la considera un’anomalia. Ma di fronte alle obiezioni i governi di turno
hanno sempre deciso che quei soldi pubblici vadano considerati come quattrini
privati a tutti gli effetti. Fra chi intercettato definisce il disastro «una
botta di culo» (L’Aquila), chi ride nel letto di notte mentre una intera città
si sbriciola (ancora l’Aquila) e chi spera «in una botta forte» perché «in un
minuto ne fa di danni e crea lavoro» (Mantova), capita dunque che lavorino
sempre gli stessi professionisti del sisma. Tanto più nei piccoli centri: quando
si tratta di tirare su un muretto o una palazzina, ci pensa il geometra
autoctono. E ci pensa pure se quel muretto o la palazzina crolla causa movimento
tellurico imprevisto. Figuriamoci se poi il tecnico ha le mani in pasta
nell’amministrazione comunale. Niente di illegittimo, ovvio. Ma qualche domanda
è giusto farsela. Il fatto è che soprattutto nei piccoli centri la commistione
fra la politica e certe figure professionali risulta inevitabile. Quello che un
tempo in una comunità rappresentavano il farmacista e il notaio, ora è in molto
casi il geometra. Meglio se con un incarico politico. Ha raccontato Mariano
Maugeri sul «Sole 24 ore» che ad Amatrice «il vicesindaco Gianluca Carloni è un
geometra che continua a lavorare nello studio tecnico con il fratello Ivo, un
ingegnere che ha costruito mezza Amatrice e negli anni 90 aveva ristrutturato la
caserma dei carabinieri di Accumoli, fortemente danneggiata dal sisma». Intrecci
all’ordine del giorno, nell’Italia dei campanili. Quando c’è di mezzo un
terremoto, però, le cose si vedono sotto una luce leggermente diversa.
All’Aquila le pratiche per la ricostruzione private erano finite in pochi studi
professionali. Il più noto, quello dell’ex autorevole presidente del locale
ordine degli architetti, Gianlorenzo Conti, peraltro prematuramente scomparso
poco tempo fa. Perché questa concentrazione di incarichi, che allora preoccupò
non poco il responsabile della struttura di missione Gaetano Fontana? Forse
l’idea che affidare l’incarico a uno studio locale conosciuto e ben introdotto
con l’amministrazione potesse costituire una sorta di corsia preferenziale per i
finanziamenti. Poco importa se l’ingegnere o il geometra è magari il
responsabile del disastro. Di sicuro, questo meccanismo che ha portato tanti
affari in pochissime mani ha finito per rallentare la ricostruzione. Aumentando
i costi: quando all’Aquila si è passati dalle pratiche singole agli aggregati il
fabbisogno finanziario si è ridotto di oltre il 20 per cento. Senza dire che in
un Paese così carente di occasioni per i progettisti anche le catastrofi possono
scatenare guerre fra poveri. Il 4 settembre 2012, tre mesi dopo il terremoto
emiliano, l’ex presidente dell’ordine nazionale degli architetti Leopoldo
Freyrie fece approvare un codice etico per i professionisti volontari iscritti
al suo albo, che prevede dure sanzioni per chi sfrutti economicamente questa sua
posizione. Era successo che all’Aquila qualche architetto che aveva verificato
«volontariamente» le lesioni di un edificio, fosse tornato alla carica con il
proprietario proponendosi per pro-gettare la ristrutturazione. Il terremoto
abruzzese è stato un formidabile banco di prova per i professionisti delle
catastrofi: progettisti e imprese. Si andò avanti fin da subito con le procedure
straordinarie della Protezione civile, e le scelte erano puramente
discrezionali. Venne poi deciso di far lavorare prevalentemente le ditte locali,
il che ha ristretto ancor più l’area dei partecipanti. La cosa non mancò di
avere pesanti ripercussioni. Ci fu uno scontro interno all’Ance fra la struttura
centrale e l’associazione territoriale delle imprese abruzzesi, che avrebbe
voluto norme per limitare la partecipazione di concorrenti provenienti da altre
Regioni. Per non parlare delle infiltrazioni della ‘ndrangheta, registrate anche
per i lavori del dopo terremoto nell’Emilia-Romagna. Ma questa è decisamente
un’altra storia, rispetto al groviglio di fortissimi interessi locali. Certe
imprese che hanno lavorato in Abruzzo sono le stesse già comparse nella
ricostruzione del terremoto dell’Umbria e delle Marche. Con significative
diramazioni nella provincia di Rieti, perché fin lì è arrivato il cratere del
sisma abruzzese: quindi i relativi fondi. E se lo schema resterà questo anche
dopo Amatrice, il gioco è destinato a continuare. Nell’ambiente dei costruttori
qualcuno ha già cominciato a far girare l’idea che si debbano precostituire
liste di imprese pronte a lavorare nel reatino. Dove le ditte iscritte
all’associazione dei costruttori non sono che una ventina. Idea, per fortuna,
prontamente messa da parte. Almeno per il momento. C’è solo da augurarsi che
tutto ciò serva ora d’insegnamento…
TERREMOTO E FONDI PER LA RICOSTRUZIONE.
L'affare terremoto: morti, politica e banche, scrive
Andrea Spartaco Martedì 06/01/2015 su "Basilicata 24". Storia di disastri
finanziari e strani intrecci che portano alla Basilicata. Nel giugno 2006,
appena un anno dopo il mandato elettorale, la giunta regionale lucana presieduta
da Vito De Filippo (Pd) firmò due contratti di interest rate swap (Irs, ndr) con
Dexia Crediop spa e Ubs Warburg. Bisognava finanziare opere e interventi nelle
zone colpite dal terremoto del '98. Una cosa decisa velocemente. Del resto con
Crediop il contratto di mutuo ventennale era già stato firmato sei anni prima da
un'altra giunta Pd, quella del predecessore Filippo Bubbico. Si tratta d'un
volume complessivo di circa mezzo miliardo di euro di contratti di emissione,
acquisto, vendita e trasferimento di strumenti finanziari siglati al di fuori
della Direttiva europea in materia di Appalti Pubblici di Servizi, sebbene a
copertura di soldi pubblici. In Basilicata però, la storia del rapporto tra
terremoti, fondi pubblici, Regione e banche, comincia prima. Ed è molto
interessante.
Banche e morti. Nel
periodo successivo al sisma dell'80 una rilevante massa di soldi (10mila
miliardi di lire, ndr), disse la Commissione che s'occupò del terremoto,
transitò attraverso istituti di credito di Campania e Basilicata. Soldi di terzi
in amministrazione presso le banche locali in cui si contabilizzavano i fondi
pubblici erogati per la ricostruzione, che partiti da 160 miliardi (mld, ndr) di
lire nell'83, nell'87 erano lievitati a 800. “I ritardi in alcuni Comuni
dell'opera di ricostruzione – scrisse – hanno procurato un ulteriore vantaggio
agli istituti di credito delle zone, rappresentato dalle giacenze presso gli
stessi di notevoli somme accreditate ex legge 219/81 e non ancora utilizzate”.
Cosa restava di quei novanta secondi che colpirono tra Campania e Basilicata
provocando 2.914 morti? Che alcune banche, ribadì la Commissione, avevano tratto
da tale “tristissimo evento un rilevante tornaconto, realizzando in pochi anni
incrementi di portata assolutamente eccezionale”. Le amministrazioni pubbliche
avevano lasciato che ciò accadesse mentre la gente aspettava in containers (e
aspetta ancora) che la propria abitazione venisse riparata o ricostruita. Tra
'80 e '84 su un totale di 3.400mld spesi, 921mld erano i soldi trasferiti ai
comuni. La Commissione puntualizzò il ruolo distorto avuto spesso da sindaci e
banche locali nella gestione, e l'assenza di controllo pubblico. Nel luglio '90
il presidente Antonio Boccia (Pd) dichiarò che per la 219/81 la Regione non
aveva avuto, e non aveva, “nessuna competenza in materia di insediamenti
industriali”. Ma quanti soldi s'erano tenuti le banche per quel loro “rilevante
tornaconto”? A settembre '90 ammontavano a 907mld.
Cosche, politica e appalti. Per
la Guardia di Finanza il terremoto del '80 “costituì l’occasione per risolvere i
problemi sia di reinvestimento sia di riciclaggio, ma anche della ricerca di
nuovi spazi territoriali ed economici d’azione e dell’appoggio o della
contiguità con pezzi delle istituzioni e in particolar modo con la politica”. A
soli tre anni dal terremoto a Potenza i sindacati lanciavano un allarme,
sollecitando l'applicazione della legge antimafia per le irregolarità nei
pubblici appalti. L'allora vicepresidente del Consiglio Regionale Mario Lettieri
affermò che c'erano processi assai preoccupanti “legati agli appalti pubblici e
alla ricostruzione”. C'era una criminalità economica che scaturiva da “un
intreccio tra affari e politica per cui gli appalti di opere pubbliche, gli
incarichi di progettazione e le agevolazioni per gli investimenti industriali,
stimolavano gli appetiti di cosche e gruppi locali e no protetti dai partiti di
governo”. Nell '84 a Balvano, definita vicenda esemplare dalla Commissione
terremoto per l'evidente disprezzo dei piani naturali nei lavori di
infrastrutturazione, e i problemi di carattere idrogeologico provocati, per
l'area industriale era stato fatto un progetto di partenza costato circa 33mld
di lire, cifra nella quale “stranamente” non erano compresi 5,8mld per i costi
dell'impianto di depurazione per le acque nere e per quelle industriali, né i
costi per l'impianto di potabilizzazione, sollevamento e diramazione dell'acqua
verso l'area industriale (passati da 3 a 6mld per difficoltà tecniche, ndr), né
circa 8mld del movimento terra quota parte finita in discarica a costi
esorbitanti e fuori da ogni regola di mercato si disse. Si parlò di 60mld spesi
per una zona priva dei requisiti minimali per ospitare siti industriali, e di
modifiche risultanti solo da spinte di progettisti, imprese e controllori “a
scopo evidente di lucro”.
Soldi e coma profondo. Certo
nel settembre del '98, pochi giorni dopo il nuovo terremoto, il Procuratore di
Potenza Gelsomino Cornetta raccontò in una Commissione parlamentare “il
problema” delle immense aree industriali create dopo il terremoto del '80.
“Abbiamo indagato – dichiarò – e alle nostre modestissime forze è stato
riconosciuto di aver fatto tutto ciò che era possibile, tant'è che il ministero
competente ha recuperato parecchie centinaia di miliardi”. Si trattava d'un
patrimonio aziendale costituito in gran parte da imprese che erano "scatole
vuote", e che avrebbe creato “un problema di abbattimento e di eliminazione di
rifiuti di natura industriale”. Quello stesso '98 una determina dirigenziale del
Dipartimento programmazione economica regionale assegnava ancora al Comune di
Balvano mille milioni di lire per infrastrutturazione della zona P.I.P (legge
64/86, ndr). Nonostante lo sforzo economico nel 2012 in un Consiglio regionale
si presentò, per l'area di Balvano, una interrogazione all'allora assessore alle
attività produttive Marcello Pittella. Lì, soldi del terremoto o meno, i
disoccupati aumentavano, le opere infrastrutturali non erano finite, e la
situazione della zona industriale era di “coma profondo”.
Meno male che c'è il sisma. "Per
fortuna" dopo il sisma dell'80 arrivò quello del '98. Così non dovemmo solo
ridare soldi al ministero, perché lo Stato ne portò altri. A occuparsi del mutuo
firmato nel 2000 dalla Regione per gestire i 42mld di lire statali annui per
ricostruire, fu appunto Crediop, capofila di un pool composto da Banco di
Napoli, Banca Mediterranea, Banca Opere pubbliche e delle infrastrutture (Opi,
ndr), Monte dei Paschi, e Banca di Roma (BdR, ndr). La partner lucana del pool,
Banca Mediterranea, che proprio nel 2000 si fuse con BdR, era nata nel '92 da
una precedente fusione tra Banca di Pescopagano e Brindisi (Bpb, ndr) e Banca di
Lucania (Bdl, ndr) con uno spropositato aumento di capitale, da 4,5mld a ben
130. Eppure nel '91 l'Organo di vigilanza (OdV, ndr) aveva definito critica la
situazione patrimoniale della Bpb accertando che “il controllo della Banca di
fatto dal Presidente del Consiglio di amministrazione”, poi presidente di
Mediterranea (con sede pure a Pescopagano, ndr), aveva favorito l'ingresso di
gruppi a lui vicini come i Casillo, il cui fondatore Gennaro, ricorda Rocco
Sciarrone in “Mafie vecchie mafie nuove”, era legato tramite il nipote Vincenzo
ai boss Raffaele Cutolo e Carmine Alfieri. Vincenzo che, con Alvaro Giardili,
scrive Nicola Tranfaglia in “Cirillo, Ligato e Lima”, fu il tramite per gli
affari post-terremoto '80 del pidduista Francesco Pazienza. Giardili e Pazienza
che s'incontravano con Antonio Gava (Dc, ndr), e Alphonse Bove, boss
italo-americano legato al Sismi e “procacciatore d'affari per la ricostruzione”.
Il sistema terremoto. Del
resto il presidente di Bpb fu definito nell'88 dalla stampa nazionale
"uomo-chiave" d'un certo sistema di potere politico-finanziario che vedeva
coinvolti il ministro Emilio Colombo e il sottosegretario Angelo Sanza. Lucani
entrambi. All'epoca un uomo di fiducia del presidente disse a un notaio
azionista di minoranza della Bpb "zitto sulla banca se non vuoi guai". Il motivo
stava nella sua curiosità di volerci veder chiaro sui rapporti tra il presidente
di Bpb e una delle imprese del terremoto. C'erano poi guarda caso quei rapporti
tra direttore generale di Bpb e un'impresa di consulenza finanziaria che sempre
guarda caso teneva i libri contabili dell'impresa con cui il presidente avrebbe
avuto rapporti. Tre anni prima la Guardia di Finanza aveva spedito una bella
documentazione a una procura lucana. Veniva fuori che i responsabili
dell'impresa con cui il presidente avrebbe avuto rapporti, assieme ai
responsabili di altre quattro imprese del medesimo "giro" erano stati denunciati
dal Nucleo di Polizia Tributaria per emissione di fatture false e associazione
per delinquere. Nell '86 il titolare di una impresa aveva denunciato d'esser
stato costretto a "sfornare centinaia di fatture false" nei confronti di tali
società perché aveva bisogno di lavorare. Dell'impresa con cui il presidente Bpb
avrebbe avuto relazioni la Gdf aveva sottolineato che nel prendere gli appalti
violava la legge antimafia. Certo in quel 1986 Banca d'Italia lo mandò un
ispettore, ma l'anno dopo ricevette un incarico "ben retribuito" dalla banca
ispezionata. Emblematico per capire l'andazzo di quegli anni è la condanna, in
veste di direttore d'una banchettina che di quel fiume di soldi del terremoto
aveva beneficiato, del presidente di Confindustria di Potenza a 3 mesi di
reclusione per appropriazione indebita. Aveva lasciato un buco di 50mld di lire.
A che servono le banche? Il
presidente della Bpb intanto, fedelissimo Dc, secondo l'OdV avrebbe pure
favorito altri gruppi “coinvolti in oscure vicende post-terremoto” 1980 come
Pafi, Baricentro e quell'Icla spa che ebbe in concessione 616mld di lire. Il
parlamentare Enrico Iandelli in un'interrogazione parlò d'operazioni societarie
e finanziarie come l'aumento di capitale della Bdl “sottoscritto in gran parte
da compiacenti persone assai vicine” al presidente, la fusione con Bdl e il
successivo aumento di capitale della Mediterranea “senza che la Banca d'Italia
intervenisse come suo dovere, e supportata talora da anomale decisioni
giudiziarie”. Comunque nel '94 pure Banca d'Italia non potè astenersi dal
valutare in 508mld le perdite previste su crediti alla clientela. Tra le perdite
c'erano pure 73,7mld per l’ammortamento della posizione del Gruppo Casillo.
Banca d'Italia accertò “diffuse irregolarità” e pure che “possessori di
significative quote del capitale della banca erano beneficiari di rilevanti
finanziamenti erogati dall'azienda”. I rinvii ai problemi economici del
Mezzogiorno usati come scusa dal presidente di Mediterranea (prima di Bpb, ndr),
ricorda la memoria difensiva presentata contro BdR/Capitalia spa nel 2005 dagli
azionisti di minoranza della Mediterranea dopo il suo crack, non avrebbero
dovuto essere condivisi dall’azionista di controllo BdR (anch'essa dentro il
pool Crediop quando la Regione firmò nel 2000 il mutuo per il terremoto del '98,
ndr), ma Generoso Puzio, rappresentante BdR, era pure titolare del 50,03% delle
azioni di Mediterranea.
Pareggiare i conti a Roma lasciando buchi
altrove. In quello stesso 2000 BdR aveva rappresentato
ai sindacati che stavano determinando il valore di stima delle attività di
compendio di Mediterranea, non ancora incorporata, da conferire nella
Mediterranea Servizi 2000 spa, società costituita immediatamente dopo la stipula
nel 2000 dell’atto di fusione tra il presidente di Capitalia Cesare Geronzi e
Leonardo Di Brina della controllata-incorporata Mediterranea, presto rinominata
Nuova Banca Mediterranea. Per il pool di avvocati che rappresentò gli azionisti
di minoranza della Mediterranea, BdR già nell'esercizio finanziario del '98
“preconizzava nel suo bilancio quello che un anno dopo sarebbe stato il valore
di concambio fissato per la fusione”. Dall’attuazione di quel progetto di
vendita di Mediterranea, scrivono, “Banca di Roma ha conseguito un corrispettivo
di 284mln di euro, una plusvalenza di circa 202mln, utile a sanare, portandolo
in attivo, il bilancio 2001”. La costruzione della nuova holding BdR/Capitalia
avvenne proprio dopo la vendita di Nuova Banca Mediterranea per 284mln alla
Popolare di Bari, altra consorella del circuito delle banche cooperative a
responsabilità limitata che avevano fatto affari col precedente terremoto del
1980 (tipo la Banca Popolare dell'Irpinia, ndr), come se Mediterranea Servizi
2000 sin dall'inizio fosse stata destinata a una operazione da cui attendere un
“lucroso corrispettivo e una cospicua plusvalenza”. Certo senza vendita,
specificarono gli avvocati, il bilancio della BdR si sarebbe chiuso con una
perdita di 120mln di euro.
Public finance? Crediop,
capofila del mutuo firmato nel 2000, diventò società per azioni nel '90,
iniziando un tour di quote societarie per banche che si concluse con
l'acquisizione da parte della franco-belga Dexia Crédit Local de France, del
Crédit Communal de Belgique, e dalla Banque Internationale à Luxembourg, e la
partecipazione del circuito delle popolari con Banca popolare di Milano, Banco
popolare, e via Em.Ro Popolare Società Finanziaria di Partecipazioni spa, della
Banca popolare dell'Emilia-Romagna. Ancora nel 2009, stando alla Guida agli
operatori al project financing, Dexia risultava il secondo operatore in Italia
per volume complessivo di finanziamenti concessi, e primo a finanziare opere
pubbliche. Quando finisce indagata nel 2010 dalla Procura di Bari per bond
ventennali da 870mln di euro sottoscritti dalla Regione Puglia per ristrutturare
il debito della sanità, Dexia in Basilicata ha in mano la rinegoziazione di
sette mutui contratti dall'85 all'89 per circa 23,5mln di euro con scadenza nel
2019, e via Crediop (anche se non esiste più) e sempre con scadenza 2019, un
altro mutuo da 10.329.137 di euro in cui capofila è la Banca popolare di Bari. E
ancora, 18mln sempre via Crediop con capofila Banca infrastrutture innovazione e
sviluppo (Biis, ndr) con scadenza 2020 per “finanziamento spese di investimento
esercizio finanziario 2000”. E ancora circa 31mln di euro per investimenti nel
settore trasporti con scadenza 2018. E ovviamente è capofila come istituto
mutuante per quei fondi del terremoto del '98 con scadenza 2019, per 358.479.577
euro in cui compare anche la Banca Opi che nel novembre 2007 firmava a Milano
proprio con Biis un piano per creare un polo unico nell'ambito della public
finance, deliberando dal 1 gennaio 2008 la scissione per incorporazione del ramo
aziendale di Opi a favore della Biis.
L'indebitamento perverso. Intrecci
bancari o meno a fine giugno 2011 il gruppo Dexia era a rischio di
smantellamento e i governi francese e belga, co-azionisti, si impegnarono a
“fornire la loro garanzia ai finanziamenti”. Pochi mesi dopo la Commissione
europea diede via libera con riserva alla nazionalizzazione di Dexia Bank
Belgium, precisando che l'operazione costata quattro miliardi di euro era stata
necessaria per la stabilità del sistema finanziario, ma che al momento non era
in grado di valutare se fosse stata in linea con le norme Ue sugli aiuti
pubblici. Due anni dopo Dexia, che aveva già beneficiato tra 2008-2009 di
“sostanziali sostegni”, finisce assieme a Ubs in un'altra storia di contratti
tossici di cui Angelo Canale, Procuratore regionale della Corte dei conti
Toscana, aveva delineato gli effetti perversi sull'indebitamento del Comune di
Firenze. Si scoprirono costi non documentati né dalle banche né dagli advisor,
spesso le banche medesime, di cui il Comune s'era avvalso per le consulenze. Già
nel 2008 il giornalista Nicola Piccenna aveva provato a spiegare in modo
informale a diverse Procure che una banca come Dexia non poteva reggere, e fatto
presente che di 12mld di euro di crediti solo 300mln erano garantiti, c'erano
invece 12mld di debiti.
Storie di consuetudine. Guarda
caso anche in Basilicata Dexia e Ubs, per la Corte dei conti, sul mutuo per i
fondi del terremoto '98 avevano “svolto sia attività di consulenti finanziari
dell’ente sia quella, successiva, di firmatari del contratto in derivati”. I
contratti con Dexia e Ubs erano stati inoltre stipulati in inglese, “criticità
di non poco rilievo” per la Corte dei conti lucana, e oltre a “diminuire la
trasparenza del regolamento negoziale” la pubblica amministrazione si trova oggi
ad applicare regole diverse da quelle dell’ordinamento interno. In una nota del
novembre 2008 la Regione dichiarò d'essere in possesso delle traduzioni dei
documenti, d'aver preso visione del contenuto degli stessi prima della loro
sottoscrizione e aver richiesto un “parere” all'Ufficio legale dell'Ente sia
riguardo alla tutela che la sottoscrizione di tale schema poteva garantire, sia
alla interpretazione di alcuni istituti contenuti nell'accordo (legge e
giurisdizione competente, ndr). Non si specificava l’esito della richiesta. Nel
“Prospetto delle clausole specifiche” accettate dalla Regione Basilicata,
continua la Corte, c'è scritto che “sarà regolato e interpretato in conformità
alle leggi in vigore in Inghilterra” e che i contraenti sono obbligati “a
sottomettersi alla giurisdizione dei tribunali del Regno Unito”, rinunciando “a
qualsiasi eccezione di incompetenza per territorio in qualsiasi data, e per
qualsiasi Procedimento aperto presso uno di tali tribunali”.
Beata vigilanza. Abbiamo
dunque ricostruito il tessuto socio-economico talmente bene in Basilicata dopo
due terremoti che la Regione non solo può permettersi di firmare a nome di tutti
i cittadini debiti rinunciando alla giurisdizione italiana, ma disinteressarsi
del precedente contratto, il debito residuo di 211,820mln di euro verso il pool
di banche attaccate a Crediop (ancora in essere, ndr), e collocarsi in una
“singolare” posizione contrattuale con gli Istituti firmatari dell’operazione in
derivati. “Uno degli stessi, Dexia Crediop – scrive la Corte – è lo stesso
istituto firmatario, sia pure in qualità di capogruppo e mandatario di una
Associazione Temporanea di Imprese (in cui figuravano Banca Mediterranea e BdR
appena fuse, ndr), dell’originario contratto di mutuo, e quindi viene a trovarsi
sia pure in parte, nella posizione di creditore e debitore”. Si fa notare che
nella relazione sull'esercizio finanziario 2013, la Regione non ha fornito
“evidenza contabile” dell'ammontare ipotetico che deve incassare (se positivo) o
pagare (se negativo) per uscire dal mutuo, specificando che verrebbe
contabilizzato nel bilancio dell'Ente “solo” se fosse deliberata la chiusura del
contratto. Valore che, sottolinea la Corte, tra 2007 e 2013 è costantemente
negativo. La Regione ha dunque già sborsato parecchi milioni di euro. La Corte
ricorda la natura “fortemente aleatoria” di tali contratti per le finanze di
un’amministrazione pubblica, e insiste sul fatto che la Regione non ha indicato
le “unità previsionali di base” e i “capitoli di spesa” sui quali ricade la
gestione del mutuo. Fatti “pregiudizievoli degli equilibri dell’esercizio in
corso e di quelli futuri”. Ma nel 2006 quando si firmavano swat per il terremoto
del '98, una legge assegnava ancora un contributo quindicennale di 3,5mln di
euro a decorrere dal 2007 per la prosecuzione nei territori colpiti dal
terremoto '80-'81, e due anni dopo in un rapporto della Sezione di controllo
della Corte dei conti sulla gestione dei fondi per il terremoto del '80, in
relazione a quel rifinanziamento s'affermò che per “le opere in corso e da
completare” il Dipartimento di protezione civile aveva inviato una nota nella
quale aveva fatto presente che le Regioni interessate curavano “in toto” gli
adempimenti relativi all’utilizzazione dei fondi, ma che al Dipartimento non era
stato assegnato alcun potere di indirizzo, vigilanza, e controllo. Un fatto
“grave” aver trascurato “semplici compiti di vigilanza”.
Quello che "sapevano tutti". Nel
settembre 2007 il pm Annunziata Cazzetta, su procedimento penale aperto nel 2003
nei confronti della Banca popolare del Materano (Bpm, ndr), inviava al giudice
Angelo Onorati la richiesta di rinvio a giudizio di 35 persone, tra cui
funzionari della stessa e imprenditori locali, accusati di una serie di reati
bancari. Una storia che si chiude anni dopo con l'assoluzione degli indagati e
la fusione di Bpm con la Banca popolare del mezzogiorno. Tra gli indagati c'è
Guido Leoni, all'epoca amministratore delegato della Bper, vicepresidente
dell'Istituti banche popolari italiane, e consigliere di amministrazione di
Em.Ro popolare, Banca popolare di Crotone, e infine Dexia Crediop. A Milano
invece, sempre in quel 2007, viene aperto un fascicolo nei confronti dalla Banca
Italease. Nelle intercettazioni autorizzate nel procedimento penale
sull'aggregazione Banca popolare di Milano-Bper, il gip Cesare Tacconi
sottolinea una telefonata tra Leoni (quello a cui nel 2004 Giovanni Conforti
della scalata occulta Unipol diceva al telefono che “gli immobiliaristi sono
inaffidabili e ricattano”, ndr), e Sergio Iotti (vicedirettore, ndr). “Pare ci
siano buchi paurosi” dice Leoni a Iotti, “c'è un buco pauroso... lo sapevano
tutti che vendevano questi derivati”. L'anno dopo Claudio Calza, consigliere del
cda del Banco popolare del Materano, della Bper, e ovviamente pure della Dexia,
è arrestato, nell'ambito dell'indagine sui derivati di Banca Italease, per
associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita. Questa storia
finanziaria finisce che nonostante chi vendeva questi derivati sapeva i “buchi
paurosi” che creavano (e chi li firmava? sapeva?), in Basilicata fino al
dicembre 2019, per i derivati dell'ultimo terremoto la Regione deve sborsare a
Dexia 11.250.000euro l'anno. Quali benefici ne abbiano tratto i terremotati lo
sanno solo loro.
TERREMOTO E RESIDENZE. Terremoto
Amatrice, boom di richieste residenza. Fondi ricostruzione fanno gola,
scrive il 4 settembre 2016 Spartaco Ferretti su “Blitz Quotidiano”. Ci sono gli
sciacalli che cercano di intrufolarsi nelle case inagibili dopo il terremoto per
rubare quello che è rimasto intatto. Poi ci sono gli sciacalli che cercano di
mettere le mani anche sui giocattoli mandati per beneficenza ai bambini. E
ancora ci sono gli imbucati, sciacalli di serie B, che cercano di scroccare
pasti alle mense riservate a chi nel terremoto ha perso cari e casa. E infine ci
sono i furbetti del terremoto. Quelli che cercano, se non di guadagnarci, almeno
di non rimetterci. Funziona così: se ti crolla la casa ed è la tua prima e unica
casa, quella fino a dove ieri vivevi, Stato come è normale ti aiuta per primo.
Se poi avanza qualcosa si dà qualche incentivo anche a chi la casa la aveva ma
non era la prima, era un di più, una seconda casa per le vacanze. Non sono e non
possono essere loro, per forza di cose, i primi a essere aiutati. E così,
racconta Il Messaggero, ad Accumoli, Amatrice e negli altri luoghi squassati dal
terremoto, dopo il 24 agosto è successo qualcosa di strano: tante, troppe,
persone, hanno chiesto la residenza in uno dei comuni distrutti. Facile capire
che qualcosa non torni. Prima, quando casa ce l’avevi agibile, ad Amatrice non
vivevi. Ora che la casa è inagibile o crollata, dichiari e chiedi di viverci. Il
perché è presto spiegato da Valentina Errante per Il Messaggero: il procuratore
Giuseppe Saieva, numero uno della procura di Rieti, ha aperto un altro fascicolo
che questa volta non riguarda gli sciacalli responsabili di furti nelle case
distrutte, quanto piuttosto quelli che sperano di lucrare sui contributi statali
destinati a chi abbia subito danni dal terremoto del 24 agosto scorso. Ossia
chi, dopo il sisma, ha chiesto il trasferimento di residenza, da Roma ai centri
colpiti. All’attenzione della magistratura, che ha aperto un altro fascicolo,
sono finite le anomale richieste di cambio di residenza, inoltrate il 31 agosto
nei centri temporanei aperti, in sostituzione degli uffici dichiarati inagibili,
per accogliere le istanze dei cittadini. Secondo i sospetti dei pm, le richieste
sarebbero arrivate proprio al fine di ottenere contributi per la ricostruzione
degli immobili, previsti, secondo la legge, solo per le prime case. Alcuni
episodi, già confermati, riguardano il trasferimento da Roma ad Accumoli. Ma
adesso gli accertamenti riguarderanno anche le altre amministrazioni. Alla
polizia giudiziaria spetterà anche la verifica delle pratiche presentate da
quanti hanno sostenuto di essere residenti da tempo e di avere soltanto tardato
nella regolarizzazione con l’ufficio Anagrafe. L’ipotesi è che sia in atto una
forma di speculazione per ottenere i contributi che saranno stanziati per la
ricostruzione. Nei casi ritenuti sospetti, chi ha inoltrato la domanda, ha
indicato come indirizzo case distrutte, strade oramai inesistenti e quartieri
ridotti in macerie.
Terremoto: non solo sciacalli, si indaga su
furbetti di residenza, scrive il 5 settembre 2016 Alberto Battaglia su
"Wallstreetitalia.com". La Procura di Rieti ha aperto un fascicolo
sulle richieste di residenza sospette che sono giunte al Comune di Amatrice nei
giorni successivi al terremoto che ha devastato la città. Un volume di domande
poco chiaro che potrebbe nascondere il tentativo di accaparrarsi una fetta dei
contributi pubblici che saranno affidati ai residenti del paese per la
ricostruzione degli immobili. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, non teme
che i “furbetti della residenza”, così battezzati dai media, possano farla
franca: “Gli uffici dell’anagrafe hanno avuto disposizione di informare i
carabinieri e i vigili ogni volta che arrivano richieste di questo tipo”, ha
detto. Alcuni “furbi” sono già stati individuati in un altro dei centri
terremotati, Accumoli. Non è detto che dietro a ciascuna richiesta di residenza
si celi un proposito fraudolento: la polizia giudiziaria avrà, appunto, il
compito di discernere le domande di coloro che semplicemente si erano attardati
a regolarizzare presso l’Anagrafe una residenza in atto già da tempo, da quanti
si trovino in posizioni più dubbie. E’ il caso di coloro che reclamano una
residenza presso immobili o strade ormai completamente distrutte dal sisma.
Furbetti ad Amatrice: è corsa alla
residenza per avere i fondi statali, scrive il 4
settembre 2016 Adriano Scianca su "Intelligonews.it". Perché uno dovrebbe,
proprio adesso che il paese, di fatto, non esiste più, affrettarsi per prendere
la residenza ad Amatrice o ad Accumoli? Semplice: per godere dei fondi stanziati
dallo Stato per il terremoto. È su questo terribile sospetto che sta indagando
la procura di Rieti. Il procuratore Giuseppe Saieva ha aperto un altro fascicolo
che sugli “amatriciani dell'ultim'ora”, quelli che sperano di lucrare sui
contributi statali destinati a chi abbia subito danni dal terremoto del 24
agosto scorso. La procura ha chiesto ieri il sequestro di tutti i registri
anagrafici dei comuni interessati dal terremoto, materiale che si aggiunge alla
documentazione acquisita dai Carabinieri negli uffici della Provincia di Rieti e
in quelli regionali del Genio civile sugli immobili che avevano subito migliorie
antisismiche e sono crollati dopo le scosse. All'attenzione della magistratura,
che ha aperto un altro fascicolo, sono finite le anomale richieste di cambio di
residenza, inoltrate il 31 agosto nei centri temporanei aperti, in sostituzione
degli uffici dichiarati inagibili, per accogliere le istanze dei cittadini.
Secondo i sospetti dei pm, le richieste sarebbero arrivate proprio al fine di
ottenere contributi per la ricostruzione degli immobili, previsti, secondo la
legge, solo per le prime case. Alcuni episodi, già confermati, riguardano il
trasferimento da Roma ad Accumoli. Ma adesso gli accertamenti riguarderanno
anche le altre amministrazioni. Alla polizia giudiziaria spetterà anche la
verifica delle pratiche presentate da quanti hanno sostenuto di essere residenti
da tempo e di avere soltanto tardato nella regolarizzazione con l'ufficio
Anagrafe. L'ipotesi è che sia in atto una forma di speculazione per ottenere i
contributi che saranno stanziati per la ricostruzione. Nei casi ritenuti
sospetti, chi ha inoltrato la domanda, ha indicato come indirizzo case
distrutte, strade oramai inesistenti e quartieri ridotti in macerie.
TERREMOTO: ANTE E POST DI ILLEGALITA'.
Terremoto, il videoracconto di Gatti: il rischio ad Amatrice era scritto, ma
è stato ignorato. Il documento del Comune, obbligatorio per legge, prevede
con precisione le conseguenze catastrofiche provocate dal sisma del 24 agosto.
Descrive anche la zona dell'hotel Roma come un'area ad alta instabilità
geologica. E indica lo stesso hotel, ora crollato, al primo posto tra i luoghi
dove ospitare eventuali sfollati, scrive Fabrizio Gatti il 26 agosto 2016 su
“L’Espresso”. Il piano di protezione civile del Comune di Amatrice già prevedeva
la distruzione del paese e i potenziali rischi per la popolazione: «Soprattutto
nei piccoli borghi e anche nel capoluogo, caratterizzati da vie strette senza
slarghi». È tutto scritto a pagina 18 del documento che per legge ogni
amministrazione municipale deve predisporre. Si sapeva cioè dei pericoli. E come
si è visto con il terremoto del 24 agosto, non si è fatto nulla per evitarli.
«Si deve rilevare altresì che l'edilizia abitativa e non del territorio comunale
è per lo più risalente all'Ottocento e ristrutturata con vari interventi
risalenti al Novecento», è scritto nel piano di Amatrice tra non pochi errori di
sintassi che abbiamo corretto: «Gli interventi in cemento armato e la sua
diffusione sono sicuramente riconducibili agli interventi realizzati dopo il
1960, pertanto il rischio sismico è alto e lo testimoniano i danni riportati
dall'edilizia pubblica e privata causati dal sisma del 1979 e da ultimo del 2009
che interessò la città dell'Aquila. Senza dubbio la tipologia costruttiva
(muratura portante in pietrame locale) influenza in maniera determinante la
vulnerabilità degli edifici esistenti con potenziali rischi per la popolazione».
Il Comune di Amatrice ha il suo piano di protezione civile. Il documento,
obbligatorio per legge, prevede con precisione le conseguenze catastrofiche
provocate dal terremoto del 24 agosto. Descrive anche la zona dell'hotel Roma
come un'area ad alta instabilità geologica. E indica lo stesso hotel, ora
crollato, al primo posto tra i luoghi dove ospitare eventuali sfollati. Nemmeno
le strade sono sufficienti in caso di calamità: «Nelle frazioni spesso la
viabilità di accesso e di esodo è garantita da una unica strada. Va pertanto
opportunamente monitorata la viabilità in caso di eventi calamitosi». Il piano
indica tra l'altro la zona dell'hotel Roma tra quelle a maggiore instabilità
idrogeologica: «Le caratteristiche dei terreni alluvionali sabbiosi limosi
depositatesi su formazioni più consolidate li rendono infatti generalmente
instabili. Si segnala tuttavia la necessità, da parte dell'amministrazione
comunale, di porre particolare attenzione nell'approvazione di progetti pubblici
e privati, subordinando gli stessi agli esiti di una relazione geotecnica e
geologica che garantisca la funzionalità del complesso opere-terreni per il
mantenimento della sua stabilità». I geologi sanno bene che nei terreni
alluvionali le onde sismiche amplificano i loro effetti sulle costruzioni
sovrastanti. Il sito del Comune distrutto dal terremoto del 24 agosto pubblica
il piano di protezione civile del Comune di Amatrice. Con i rischi, le misure di
emergenza, gli indirizzi, le vie, i punti di raccolta per gli abitanti di
Amatrice. Quindi per i residenti di Accumoli è un piano completamente inutile.
Un caso di copia-incolla? Arquata del Tronto ha invece un piano di protezione
civile, ma introvabile sui canali istituzionali sia del Comune sia del
dipartimento nazionale della Protezione civile. Come edificio strategico per il
paese il piano di Amatrice indica il municipio di corso Umberto 70, che però non
ha retto alle scosse evidentemente per scarsa resistenza antisismica. Come luogo
dove riparare eventuali sfollati, al primo posto è invece indicato proprio
l'hotel Roma, nella zona segnalata poche pagine prima tra le aree più instabili:
lo stesso piano di protezione civile, insomma, non tiene conto di quanto
prescrive. Anche il Comune di Accumoli, dove la caduta del campanile ha ucciso
un'intera famiglia, ha il suo piano di protezione civile. E lo pubblica sul suo
sito Internet istituzionale. Però il documento è copiato integralmente da quello
di Amatrice, comprese l'intestazione, le vie, le piazze, i nomi dei referenti,
le caratteristiche del territorio. Un errore oppure un maldestro copia-incolla.
Nel piano obbligatorio per legge, Accumoli è citata soltanto due volte come
paese confinante di Amatrice. Quindi è uno strumento accessibile ai cittadini,
ma completamente inutilizzabile. Il piano di protezione civile di Arquata del
Tronto resta invece un mistero. Il sito del dipartimento nazionale della
Protezione civile include il Comune tra quelli che hanno rispettato la legge. Ma
non c'è modo di raggiungere il piano. E cercando sulla pagina del Comune non si
trova. Non deve stupire, purtroppo. Gran parte dei sindaci italiani sono nella
stessa situazione. E in Calabria, regione esposta a terremoti molto più potenti
del sisma del 24 agosto, un terzo delle amministrazioni comunali è del tutto
privo di un piano di protezione civile. E generalmente i paesi e le città che lo
hanno adottato non lo rendono pubblico e facilmente accessibile ai cittadini.
Nel frattempo, nell'importante periodo di pace tra un terremoto e l'altro,
proprio nelle province più lacunose raramente le agenzie di protezione civile
regionali e il dipartimento nazionale hanno esercitato i loro poteri-doveri di
controllo per spingere i sindaci a rispettare la legge.
Terremoto, lo scandalo-fondi: i soldi
c'erano ma non furono spesi. Ad Amatrice ed Accumuli i
4 milioni di euro messi a disposizione negli ultimi due anni per la messa a
norma degli edifici privati non sono mai stati spesi, scrive Ivan Francese,
Giovedì 25/08/2016, su "Il Giornale". Un terremoto giudiziario originato dal
terremoto vero: è questa la prospettiva che si apre nell'ambito dell'inchiesta
per disastro colposo che sarà aperta dal procuratore di Rieti dopo il sisma che
nella notte fra martedì e mercoledì ha devastato Amatrice, Accumuli e Pescara
del Tronto, al confine fra Lazio, Umbria e Marche. Un'inchiesta che con ogni
probabilità parlerà di fondi pubblici stanziati per la messa a norma degli
edifici, pubblici e privati, e mai spesi. Come è successo ad Amatrice, la
città-simbolo che piange oltre duecento morti e che presto chiederà verità e
giustizia. Non c'è solo la scuola "Romolo Capranica", restaurata nel 2012 e
crollata come un castello di sabbia. C'è anche l'ospedale, per il cui restauro
erano pronti due milioni di euro che non sono stati mai spesi. C'è il municipio,
crollato anch'esso, per cui erano stati messi a disposizione fondi provinciali
poi dirottati altrove. Tanti casi che lasciano sgomenti, altrettante domande a
cui bisognerà trovare una risposta. E purtroppo il conto dei danni, in termini
umani e materiali, non si ferma solamente agli edifici pubblici. Dopo il
terremoto dell'Aquila del 2009, racconta Repubblica, la Protezione Civile ha
messo a disposizione 965 milioni di euro per la messa a norma degli edifici
privati secondo le direttive antisismiche. Fondi che prevedevano contributi
statali dai cento ai duecento euro al metro quadro per la ristrutturazione degli
immobili dei centri storici, generalmente quelli più a rischio. Eppure
moltissimi di quei fondi non sono stati nemmeno richiesti, a causa
dei bizantinismi della burocrazia, che imponevano ad esempio la gestione
regionale dei fondi, ma tramite sportelli organizzati dai Comuni. Fra Amatrice
ed Accumuli, dove il rischio sismico era pure altissimo (e tutti lo sapevano),
non è stato speso nemmeno un euro dei quattro milioni stanziati fra 2014 e 2015.
Una circostanza che grida vendetta.
Ricostruzione, soccorsi, polemiche.
La maledizione del post-terremoto. Dalla catastrofe di
Messina nel 1908 a quelle del dopoguerra, il susseguirsi di errori e ritardi ha
caratterizzato quasi ogni sisma che ha colpito il Paese. Al punto da imporsi
come un vero e proprio genere della letteratura e della pubblicistica italiana,
scrive Dino Messina il 28 agosto 2016 su "Il Corriere della Sera”. Appena
passata l’onda devastatrice del terremoto, si pensa al dopo. Le esperienze
possono servire per non ripetere gli errori e per rendersi conto dei passi
compiuti. La storia del dopo terremoto è diventata un vero e proprio genere
della letteratura e della pubblicistica italiana, soprattutto da quando la
stampa liberale ha assunto un ruolo centrale di stimolo e denuncia.
Basilicata, 1857.
In questo senso è emblematica la vicenda del terremoto della Basilicata che nel
1857 distrusse i paesi della Val d’Agri e colpì severamente quelli della Valle
di Diano. Lo Stato unitario non era ancora nato. E ai nostalgici del Regno delle
Due Sicilie (ce ne sono ancora!) vanno ricordati i ritardi nei soccorsi più
elementari dopo il sisma che il 16 dicembre 1857 provocò oltre diecimila morti
(fonti ufficiali dello Stato borbonico) e secondo altri studi fece invece 19
mila vittime. Un fotogiornalista francese, Alphonse Bernard, arrivò nei luoghi
del disastro ben prima dei soccorritori e dell’esercito e documentò la
distruzione in fotoreportage i cui introiti furono in parte destinati alla
popolazione decimata dalla catastrofe. Un pubblicista come Teofile Roller sulla
stampa britannica denunciò che nel febbraio 1858, oltre due mesi dopo il sisma
sotto le macerie di alcuni paesi come Montemurro non erano ancora stati
disseppelliti i cadaveri.
Messina 1908.
Il terremoto del 1857 era stato classificato come il terzo più grave della
storia, ma quello del 28 dicembre 1908 che colpì Messina e fece 80 mila morti su
una popolazione di 172 mila abitanti fu una vera ecatombe (foto sotto). Il
tragico evento ebbe testimoni illustri come Giovani Pascoli e lo storico Gaetano
Salvemini, che in quella giornata perse la moglie e cinque figli. Presidente del
Consiglio era Giovanni Giolitti, ci furono ritardi ma non certo paragonabili a
quelli borbonici. I primi importanti soccorsi arrivarono tuttavia dai marinai
delle navi russe e inglesi oltre che dal personale della Marina italiana. In
quella grave calamità ci fu un concorso di aiuti internazionale. Villaggi di
baracche vennero donati dal re di Prussia Guglielmo II e dal presidente degli
Stati Uniti, Theodore Roosevelt. Quando nel gennaio 1975 nella zona ci fu un
altro non rilevante sisma l’inviato del Corriere della sera Antonio Padellaro
documentò che ancora esistevano cinque quartieri di baracche risalenti al
terremoto del 1908 in cui vivevano circa 25 mila persone. Nel 2002 un reportage
di Alessandro Trocino rilevò che la popolazione nelle baracche del terremoto era
scesa a 3.500 abitanti, ma che c’erano generazioni di famiglie per niente
disposte a mollare la baracca del 1908, anzi la tramandavano di padre in figlio
perché abitare lì dava il diritto di avere una abitazione nuova. Il più lungo
post terremoto della storia.
Marsica 1915.
Le ruberie compiute dopo il terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915 furono
denunciate dal giovane Ignazio Silone, che all’epoca ancora si chiamava
Secondino Tranquilli, in articoli scritti per l’Avanti!. Anche ad Avezzano, che
fu il centro più colpito dal sisma che precedette di pochi mesi la nostra
entrata nella Grande Guerra, vennero costruite delle baracche. I cronisti che
andarono sul posto per il terremoto del 1983 scoprirono che alcune di quelle
casupole erano ancora occupate, da locali o da turisti romani che avevano
trovato una sistemazione per le vacanze invernali e non erano affatto disposti a
lasciarle. Così alcune delle roulotte per il terremoto del 1983 vennero piazzate
accanto alle baracche superstiti del 1915.
Vulture 1930.
Si parla poco del terremoto del Vulture del luglio 1930 (foto sotto), che
provocò 1.404 morti e che coinvolse 50 comuni in cinque province della
Basilicata, della Puglia e della Campania. Il regime fascista non perse
occasione per trasformare la tragedia in un’occasione di propaganda, sicché si
vantò di aver costruito in pochi anni 3.746 case e di aver riparato 5.190
abitazioni. Il coordinamento della ricostruzione e dei soccorsi venne affidato
ad Araldo di Crollalanza.
Belice 1968.
Nel secondo dopoguerra il terremoto del Belice del 14 gennaio 1968, che causò
300 morti e 80 mila senzatetto, rimane come un simbolo negativo non soltanto per
il ritardo nei soccorsi ma per una politica di ricostruzione sbagliata. Secondo
la vasta letteratura di quel terremoto, sul posto arrivarono prima i cronisti
dei soccorritori. La prima casa venne ricostruita nel 1977, nove anni dopo la
tragedia! Sbagliata fu anche la scelta di ricostruire Gibellina (foto sotto), il
centro maggiormente danneggiato, a 18 chilometri dal sito storico. La chiesa di
quel nuovo paese crollò nel 1994 e il lago progettato per il recupero delle
acque piovane rimase a lungo non funzionante. È stato calcolato che questa
mancata ricostruzione sia costata allo Stato italiano non meno di sette miliardi
di euro.
Friuli 1976. Un
modello del tutto diverso venne riproposto per la ricostruzione dei paesi del
Friuli devastati dal terremoto del 6 maggio 1976 (foto sotto), che provocò 989
vittime. Tra i paesi più colpiti, Osoppo, Gemona, Trasaglio, Buja, Maiano,
Colloredo, Spilinbergo, Forgaria, Venzone. Un appello lanciato nell’agosto 1977
dagli abitanti di quest’ultimo centro riassume la filosofia del modello Friuli:
«Respingiamo una ricostruzione standardizzata che certamente ci renderebbe
estranei nella nostra stessa patria». I friulani sconfissero così l’Orcolat,
l’Orco, come in lingua locale chiamano il terremoto, con una ricostruzione che
teneva conto delle esigenze della popolazione, partiva dal basso, a differenza
di quel che era avvenuto in Belice dove erano stati calati megaprogetti
dall’alto. I paesi vennero ricostruiti pietra su pietra secondo una scala di
priorità riassunta bene dal vescovo Alfredo Battisti: «Prima le fabbriche, poi
le case, poi le chiese». Nel 1983, sette anni dopo il terremoto, l’80 per cento
della ricostruzione era stata ultimata.
Irpinia e Basilicata 1980.
Il terremoto più grave nella seconda metà del Novecento, per
numero di vittime ed estensione dell’area danneggiata, rimane quello
dell’Irpinia e della Basilicata, che il 23 novembre 1980 provocò quasi tremila
morti, poco meno di novemila feriti e 280 mila senza tetto. Tutto l’Italia si
mobilitò in una gara di solidarietà. Chi scrive, allora giovane cronista, arrivò
a Balvano, in provincia di Potenza (foto sotto), la sera del 24 novembre, in
tempo per vedere i 77 sacchi che contenevano i corpi dei fedeli uccisi dal
crollo della chiesa. Così assistette al dramma di un padre, un vecchio medico, a
Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, che aveva ingaggiato delle
ruspe per far scavare sotto le macerie dell’ospedale dove giacevano i corpi dei
due figli. Partirono diverse denunce per gli edifici nuovi che erano crollati
perché i tecnici avevano ignorato le norme antisismiche. Numeri irrisori in
confronto alle 382 persone arrestate per le vicende legate alla ricostruzione.
Una ricostruzione che è costata ai contribuenti italiani più di 60 mila miliardi
di lire. Una voragine provocata da contributi distribuiti a pioggia: gli aiuti
invece di essere concentrati nei paesi seriamente danneggiati vennero esteri a
687 Comuni. Scandalosa anche la lievitazione di costi di alcune opere che
talvolta superò il mille per cento. Una commissione d’inchiesta parlamentare
denunciò inoltre che erano state consapevolmente finanziate imprese
fallimentari.
Umbria e Marche 1997.
Un veloce ritorno alla normalità ha caratterizzato la
ricostruzione nel dopo terremoto che il 26 settembre 1997 fece undici morti e 32
mila senza tetto nell’Umbria (foto sotto, Assisi) e nelle Marche. La
ricostruzione certosina della Basilica di San Francesco d’Assisi è lì a
dimostrarlo. Un piccolo sisma, quello del 31 ottobre 2002 in Molise, causò una
grande tragedia: il crollo di una scuola a San Giuliano che uccise 27 bambini e
una maestra. Un processo dimostrò che quell’edificio era stato costruito in
spregio alle più elementari norme di sicurezza.
L’Aquila 2009 ed Emilia 2012.
Il sisma di questi giorni nel Centro Italia è stato definito un
terremoto gemello di quello che il 6 aprile 2009 provocò all’Aquila (foto sotto)
e nei comuni vicini 309 morti e 60 mila sfollati. Anche in questo caso si sono
dimostrate fallimentari la filosofia e la pratica delle New Town. Il business
della ricostruzione ha attirato personaggi senza scrupoli sia all’Aquila, dove
qualcuno rideva per i soldi che avrebbe fatto con la catastrofe, sia in Emilia,
sconvolta dal terremoto del 20 e 29 magio 2012. La rapida ricostruzione di
questo cruciale territorio è stata inquinata dalla presenza di cosche di
‘ndrangheta calabresi infiltratesi al Nord.
Terremoto, crollate Torre civica e chiese
dichiarate a norma. Terremoto, lo scandalo dei fondi
antisisma deviati. Dai ponti non ristrutturati perché la Provincia aveva finito
i suoi soldi agli stanziamenti deviati per altri scopi. Ecco come si sprecano le
risorse destinate a evitare stragi, scrivono Dario Del Porto e Fabio Tonacci il
30 agosto 2016 su “La Repubblica”. Due terremoti, quello dell'Umbria nel 1997 e
quello dell'Aquila nel 2009, hanno fatto piovere sul territorio della provincia
di Rieti 84 milioni di euro di fondi per la ricostruzione. Negli anni se ne sono
aggiunti altri, di milioni. Della Regione, dello Stato, della Chiesa. Sette
giorni fa, però, un altro sisma ha sollevato una verità che era sotto gli occhi
di tutti: parte di quel denaro non è stato ancora speso, o è stato speso male,
o, ancora, non è stato utilizzato per rendere gli edifici sicuri. E le rovine di
Amatrice e Accumoli sono lì a testimoniarlo. Sei ponti in cerca di
autore. Prendiamo i ponti. Due fondamentali vie di accesso ad Amatrice, la
strada provinciale 20 e la statale 260, sono interrotte dal 24 agosto perché si
sono danneggiati i ponti "Rosa" e quello di "Tre Occhi". Che ne è dei 611.000
euro che la Regione ha erogato nel 2014 "per interventi di mitigazione del
rischio sismico" di sei ponti tra cui il "Rosa"? Rimasti nel cassetto. La
provincia di Rieti non ha più un soldo in bilancio, e non riesce a trovare i
175mila euro della sua quota parte dell'intervento progettato. Dunque non può
utilizzare i 611mila della Regione perché non ha i suoi 175mila da spendere. Il
presidente della giunta Giuseppe Rinaldi, temendo di perdere i fondi, è stato
costretto a inviare una lettera alla direzione regionale, nella quale spiega che
"l'amministrazione intende confermare il proprio impegno al cofinanziamento", ma
che per farlo dovrà "alienare immobili". Insomma, per aggiustare un ponte coi
fondi del terremoto la provincia di Rieti si deve vendere un palazzo. Il
campanile killer. Dopo il sisma del 1997, il Genio civile individuò sul
territorio reatino 300 interventi di ricostruzione e miglioramento sismico per
un totale di 79 milioni di euro messi a disposizione dallo Stato. Tra Accumoli e
Amatrice c'erano 11 immobili e 10 chiese da sistemare. Prendiamone una diventata
tragicamente famosa: il complesso parrocchiale San Pietro e Lorenzo ad Accumoli.
È la chiesa con accanto un campanile costruito sopra il tetto di una casa: la
notte del 24 agosto, quella torre campanaria di sassi, crollando, ha ucciso la
famiglia Tuccio che abitava lì sotto, padre, madre e due bambini. Una grossa
fetta dei fondi per gli edifici religiosi è stata gestita direttamente dalla
Curia di Rieti, attraverso un ufficio tecnico creato ad hoc presso la diocesi,
che ha predisposto le gare di affidamento. Il geometra che ha seguito tutte le
pratiche si chiama Mario Buzzi, e adesso è in pensione. "Per il campanile non
c'è stato mai alcun finanziamento specifico né alcun lavoro di
ristrutturazione", spiega a Repubblica. Aggiungendo: "Non è vero che sono stati
dirottati soldi per il miglioramento sismico dal campanile alla chiesa". La
chiesa di Accumoli. E però nella lista delle opere finanziate del post-sisma 97
il nome della chiesa di San Pietro e Lorenzo, c'è. "Intervento sul complesso
parrocchiale da 116mila euro". Si tratta del rifacimento del tetto di 200 mq
della chiesa accanto al campanile, la cui gara d'appalto è stata vinta nel 2008
dalla Steta di Stefano Cricchi, uno dei figli di Carlo Cricchi, l'imprenditore
reatino che si è aggiudicato commesse anche a L'Aquila. Per i lavori in Abruzzo,
l'altro figlio, architetto, è sotto inchiesta per tangenti. "Chiariremo tutto,
la nostra azienda non c'entra". Oggi Cricchi senior, cavaliere del lavoro, ha di
che lamentarsi: "Noi non abbiamo fatto niente su quel campanile". Seduto al
tavolo nel salotto della sua ditta, mostra disegni e capitolati. "Ci arrivano
minacce di morte su Facebook e via mail perché tutti ormai credono che siamo
stati noi a ristrutturarlo, ma non è vero". L'appalto per "riparazione e
miglioramento sismico" della chiesa valeva 75mila euro (il resto, 41 mila euro,
era per la progettazione). Steta lo vince con un ribasso del 16 per cento,
dunque 59mila euro. Nel capitolato si scopre una cifra sorprendente: "Per il
miglioramento antisismico c'erano appena 509 euro", spiega Cricchi. "Il progetto
imponeva di inserire nella muratura 33 euro di ferro, praticamente una sola
barra, e di fare alcuni fori da riempire non con il cemento, ma con la calce".
Il grande equivoco. Eccolo il grande equivoco della ricostruzione dopo ogni
disastro. La confusione tra il "miglioramento sismico" (piccoli interventi che
non modificano sostanzialmente la stabilità dell'immobile) e l'"adeguamento",
molto più costoso. Quasi tutto ciò che è stato fatto coi fondi dei terremoti,
per forza maggiore scarsi e non sufficienti a coprire ogni spesa possibile, è
miglioramento: i 200mila euro investiti nella scuola Capranica, in parte
crollata; i 250mila euro messi nella Chiesa Santa Maria Liberatrice, inagibile;
i 400mila del Teatro all'inizio del corso principale di Amatrice, distrutto; i
90mila della Torre Civica di Accumoli, lesionata; i 260mila euro della Chiesa di
Sant'Angelo, venuta giù due settimane dopo l'inaugurazione. Fabio Melilli,
deputato del Pd, è stato dal 2006 al 2010 il sub-commissario di Rieti per il
terremoto dell'Umbria: "Quando mi sono insediato, era stato ultimato appena il
20 per cento dei lavori, nonostante fossero passati quasi dieci anni dal sisma".
La normativa era fatta male: lo stesso progetto doveva superare due volte lo
stesso esame. "Per dare il via alla gara di appalto - ricorda Melilli -
servivano le autorizzazioni del Genio civile, del comune, della Soprintendenza.
Una volta avute, il progetto andava in commissione dove c'erano gli stessi
rappresentanti del Genio civile, del Comune, della Soprintendenza. Si perdeva un
sacco di tempo". Tant'è che dei 5 milioni arrivati dopo L'Aquila, ne sono stati
spesi appena tre. Il denaro immaginario. Una coperta quasi sempre corta. Si tira
da una parte, ci si scopre dall'altra. Per il consolidamento del municipio di
Amatrice c'erano 800mila euro, ma l'amministrazione guidata da Sergio Pirozzi ha
deciso di spostarli sull'istituto alberghiero. Questo è rimasto in piedi, il
municipio è franato. Coperta corta, che a volte si sfalda nelle mani di chi la
vorrebbe usare. L'ospedale "Francesco Grifoni" da sette anni attendeva un
intervento "urgente" di messa in sicurezza. I soldi, 2,2 milioni di euro,
vengono pescati dal fondo per l'edilizia scolastica. Si è fatta anche la gara di
appalto, vinta dal Consorzio cooperative costruzioni. Ma quel denaro, hanno
scoperto i dirigenti della Asl di Rieti quando tutta la procedura era ormai
avviata, esisteva solo sulla carta. Il fondo statale, per il Lazio, si era
prosciugato.
Le carte riservate sui lavori eseguiti
nei paesi del sisma e i certificati di chi ha fatto i collaudi su edifici
pubblici. Gli «ancoraggi» dichiarati e mai fatti,
scrivono Ilaria Sacchettoni e Fiorenza Sarzanini il 29 agosto 2016 su “Il
Corriere della Sera”. C’è un documento riservato che dimostra le irregolarità
compiute nella ristrutturazione degli edifici pubblici di Amatrice e Accumoli
dopo il sisma del 1997 dell’Umbria. È la relazione dell’ente attuatore su 21
appalti assegnati per la messa a norma degli stabili. E svela nei dettagli anche
alcuni casi clamorosi, come quello della Torre Civica di Accumoli, manufatto del
XII secolo che è il più antico del paese, gravemente danneggiato dalla scossa
della notte del 24 agosto scorso. E quello della caserma dei carabinieri,
crollata per il terremoto. Ma anche le procedure seguite per numerose chiese e
complessi parrocchiali. Si tratta di 2 milioni e 300 mila euro, soldi pubblici
che si aggiungono agli altri 4 milioni spesi dopo il 2009. Il dossier elenca i
soldi stanziati, gli interventi effettuati, il nome dei progettisti, le ditte
incaricate. Indica anche l’effettuazione dei collaudi per la convalida di quanto
era stato fatto. Interventi per una spesa ingente, che evidentemente non erano
stati svolti adeguatamente, visto che alcuni edifici sono stati distrutti dal
sisma di sei giorni fa e altri risultano gravemente lesionati. E questo avvalora
il sospetto dei magistrati: alcuni certificati sono stati falsificati. Atti che
riguardano le strutture pubbliche, ma pure le abitazioni private. Ai Vigili del
fuoco sono già arrivate numerose segnalazioni di cittadini che raccontano di
aver acquistato la casa con la certificazione dell’avvenuto «ancoraggio» proprio
per scongiurare il pericolo di crolli. E invece, dopo la scossa che ha devastato
interi paesi, si è scoperto che nulla del genere era mai stato fatto. Controlli
saranno effettuati anche dai magistrati di Ascoli che indagano sui crolli
avvenuti ad Arquata e Pescara del Tronto. In particolare bisognerà verificare
come mai alcuni edifici di Arquata — l’ufficio postale, la scuola, il Comune e
la caserma dei carabinieri — dovranno essere demoliti perché dichiarati
inagibili nonostante dovessero essere perfettamente a norma. Caso esemplare è
quello della Torre Civica di Accumoli, edificio storico conosciuto anche a
livello internazionale. Lo stanziamento iniziale di 100 mila euro viene ridotto
a poco più di 90 mila. L’impresa individuata è la «Giuseppe Franceschini».
Responsabile del procedimento è l’architetto Cappelloni. È l’esperto che segue
altri progetti, compreso quello del complesso parrocchiale in cui è inserita la
chiesa di San Francesco, dove il campanile è crollato e ha travolto un’intera
famiglia. Vengono effettuati due collaudi: uno l’11 ottobre del 2012, l’altro il
28 maggio 2013. Non vengono evidenziati problemi e la verifica concede il via
libera. Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato: le scosse di sei giorni fa
non hanno lasciato scampo e la Torre risulta gravemente lesionata. L’edificio è
venuto giù. Storia analoga è quella della caserma dei carabinieri di Accumoli.
Dopo il terremoto dell’Umbria si decide di effettuare lavori di ristrutturazione
e vengono stanziati 150 mila euro. La ditta prescelta è la «Impretekna».
Responsabile del provvedimento è il geometra Granato che risulta aver seguito
ben nove progetti. Anche in questo caso i lavori sono classificati come
«ultimati e collaudati». Sembra che sia tutto regolare, almeno a leggere le
carte. E invece la sede dei carabinieri ha subito danni gravissimi. Sono i
documenti ufficiali a dimostrare che la chiesa di Accumoli e il campanile erano
stati inseriti in un «sistema» ben più ampio che prevedeva la ristrutturazione
dell’intero complesso parrocchiale. Spesa prevista: 125 mila euro che scendono a
116 mila. L’appalto se lo aggiudica la «Ste.Pa» che evidentemente poi concede
alcuni subappalti. Alla fine arriva il collaudo e la pratica si chiude. Nessuno
immagina che in realtà i soldi stanziati per il campanile siano stati utilizzati
per la chiesa. E soprattutto che non sia stato effettuato alcun adeguamento
antisismico, ma semplici migliorie che nulla garantiscono. La notte del 24, dopo
la prima fortissima scossa, il campanile si sbriciola e uccide quattro persone.
Viene giù anche la chiesa di San Michele Arcangelo di Bagnolo, frazione di
Amatrice. A disposizione erano stati messi 100 mila euro. Ente attuatore in
questo caso era la Curia vescovile di Rieti che aveva indicato anche gli esperti
responsabili dei lavori. E adesso saranno proprio gli ingegneri e gli architetti
incaricati di occuparsi del controllo delle attività a dover chiarire ai
magistrati che cosa sia accaduto tra il 2004, quando si decide di mettere a
norma gli edifici, e il 2013 quando risultano effettuati gli ultimi collaudi.
Nei prossimi giorni i magistrati coordinati dal procuratore di Rieti Giuseppe
Saieva — i pubblici ministeri Cristina Cambi, Lorenzo Francia, Raffaella
Gammarota e Rocco Marvotti — acquisiranno la documentazione su tutti gli stabili
crollati. La decisione è quella di aprire un fascicolo su ogni edificio in modo
da poterne ricostruire la storia ed effettuare le eventuali contestazioni a chi
ha seguito le ristrutturazioni. Per questo verranno interrogati gli architetti e
gli ingegneri indicati nella relazione sui lavori decisi dopo il sisma
dell’Umbria. Saranno loro a dover chiarire come mai si decise di effettuare —
nella maggior parte dei casi — soltanto delle «migliorie», chi diede le
indicazioni sugli interventi e soprattutto che cosa fu scritto nelle relazioni
finali per ottenere il via libera dei collaudatori. Questi ultimi dovranno
invece chiarire che tipo di controlli furono svolti, consegnando anche la
documentazione relativa a ogni progetto seguito. L’attività dei pubblici
ministeri in questa prima fase dell’inchiesta si muove su un doppio binario: da
una parte gli edifici pubblici e dall’altra le abitazioni private. In questo
secondo caso l’attenzione si concentra soprattutto sui cosiddetti «ancoraggi».
Nei giorni successivi al terremoto sono arrivate numerose segnalazioni di
persone che hanno raccontato di aver comprato il proprio immobile e di aver
ricevuto — al momento dell’acquisto — la certificazione sulla messa in sicurezza
rispetto al rischio sismico. Quando i palazzi sono crollati è apparso evidente
come non fosse stato effettuato alcun intervento mirato. Per questo bisognerà
confrontare gli atti di compravendita con quelli registrati nei Comuni. Partendo
naturalmente dagli edifici crollati che hanno provocato morti e feriti.
Al setaccio incarichi e consulenze sui
fondi del dopo terremoto 1997. Gli inquirenti vogliono
capire come sono stati spesi tre milioni di euro. Indagini sui collaudi che
mancano e sui lavori che non sono stati ultimati, scrive Paolo Festuccia il
30/08/2016 su “La Stampa”. Quasi tre milioni di euro. Per la precisione 2
milioni 995 mila euro. A tanto ammontano i finanziamenti che sono piovuti su
Accumoli e Amatrice per i danni subiti dal sisma del 1997. A questi si deve
aggiungere il finanziamento - ma fuori dal sisma dell’Aquila - che la Regione
Lazio elargì al comune di Amatrice al fine di migliore la sicurezza della scuola
«Romolo Capranica» e di altre strutture presenti sul territorio. Intorno a
questo fiume di denaro, nelle prossime ore, si concentrerà l’attenzione della
Procura di Rieti. L’obiettivo, è quello di accertare come siano stati elargiti i
contributi pubblici, e soprattutto come sono stati conferiti gli incarichi a una
quarantina di professionisti tra ingegneri, architetti e geometri. È questo il
dubbio che anima l’iniziativa degli inquirenti. Un interrogativo che incontra
anche le richieste dei cittadini, sia quelli che hanno o non hanno subito danni,
sia soprattutto i familiari di chi, proprio sotto quelle strutture appena
restaurate, ha perduto la vita. A cominciare dalla famiglia Tuccio di Accumoli
(mamma, papà e due figli piccoli) annientata dal crollo del campanile del
complesso parrocchiale di San Pietro e Lorenzo restaurata con 125 mila euro con
tanto di collaudo. Insomma a distanza di quasi vent’anni, dunque, quel sisma che
colpì duramente e tragicamente l’Umbria e alcuni luoghi simbolo come Assisi o
Camerino nelle Marche, torna protagonista insieme al terremoto dello scorso 24
agosto. Nel territorio di Amatrice le strutture restaurate sono state tredici
per un milione 860 mila euro. Ben 630 mila euro di «questi fondi - assicurano
fonti - sono stati elargiti alla Curia… e mai rendicontati…». Solo due opere al
maggio di quest’anno erano state collaudate. Si tratta della Chiesa di San
Michele Arcangelo (100 mila euro) e di Icona Passatore per 200 mila euro. Le
altre tre strutture, per un valore in euro di altre 330 mila euro (affidate come
Ente attuatore alla Curia di Rieti) non risultano ancora restaurate. C’è poi il
singolare caso delle caserme dei Carabinieri. Quella di Accumoli, nei fatti, è
andata completamente distrutta. Ad Amatrice i lavori della caserma non sono
ancora ultimati (150 mila euro) e anche l’altro edificio preso in affitto in
attesa del rientro nella caserma principale è di fatto ancora inutilizzato. È
davanti a queste cifre e alla presenza di tante consulenze che la procura vuole
andare fino in fondo. Capire non solo come gli incarichi siano stati conferiti
ma soprattutto quali rapporti sono intercorsi tra chi ha ricevuto e chi ha
conferito l’incarico. Affidi più volte distribuiti a stesse persone che in
talune circostanze figuravano come progettisti e in altri come collaudatori. In
tutto sono una quarantina i professionisti che a vario titolo hanno partecipato
alla distribuzione dei lavori che solo in parte a distanza di quasi vent’anni
sono stati collaudati. In un caso, addirittura, la chiesa di Sant’Angelo di
Amatrice i lavori sono ancora in fase di esecuzione. Capitolo a parte, invece,
merita la scuola «Romolo Capranica» di Amatrice. La città fu tagliata fuori dai
finanziamenti per il sisma aquilano del 2009. Ottenne allora una finanziamento
ad hoc dalla Regione Lazio (5 milioni di euro) per una serie di lavori da
svolgere sia nel palazzo che comunale che nella scuola alberghiera. Per la
«Romolo Capranica» ci fu un accordo di programma in base al quale il commissario
per il sisma Fabio Melilli rese ente attuatore il comune stesso per una cifra di
170 mila euro. Soldi che si aggiunsero ai circa 500 mila che lo stesso sindaco
Pirozzi aveva ottenuto dalla Regione e che il comune appaltò autonomamente per i
lavori.
39 anni fa l'assassinio del colonnello
Russo e del prof. Costa, scrive il 20 Agosto 2016
AMDuemila. L’omicidio avvenne in modo plateale perché la “mafia voleva una
esecuzione spettacolare ed esemplare”. Così scriveva il giornalista Mario
Francese, che da quella stessa mafia fu assassinato il 25 gennaio 1979. Il 20
agosto del 1977, alle ore 22.00, in contrada Ficuzza di Corleone un commando
formato da Totò Riina, Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Pino Greco, Filippo
Marchese e Giuseppe Agrigento uccise il tenente colonnello dei
Carabinieri Giuseppe Russo e l'amico Filippo Costa. Secondo gli inquirenti
quella sera a sparare fu Leoluca Bagarella, mentre Pino Greco e Giovanni
Brusca rimasero da appoggio, e Agrigento e Marchese erano all'interno delle auto
parcheggiate, pronti per la fuga. Russo fu sicuramente tra i primi investigatori
a comprendere la necessità di spostare l’attività investigativa sui grandi
appalti e sull’interesse che avrebbero inevitabilmente suscitato nel sodalizio
criminale che stava per assumere il controllo di Cosa nostra nelle province di
Palermo, Trapani e Agrigento, che proprio in questa terra avrebbe avuto il suo
centro nevralgico intono alle figure di Riina e Provenzano. Giuseppe Russo,
secondo gli investigatori, fu tra i primi a capire le potenzialità dei
corleonesi di Riina e Provenzano e a studiare le contromosse per arginarli. Così
come fu pioniere nell'individuare gli interessi e le attività del gruppo mafioso
che si stava organizzando intorno alle figure di Michele Greco, Riina,
Provenzano e Bagarella, negli anni in cui si sarebbe consolidato il controllo
della mafia sui finanziamenti pubblici e i grandi appalti per la ricostruzione
del Belice, dopo il devastante terremoto del 1968. Quando fu assassinato, Russo
era il comandante del Nucleo Investigativo del capoluogo siciliano, l'organo di
punta nella lotta alla mafia, e uomo di assoluta fiducia dell'allora comandante
della Legione carabinieri di Palermo, il colonnello Carlo Alberto dalla Chiesa.
Grazie al suo costante impegno furono realizzate con successo diverse operazioni
investigative contro ogni forma di criminalità e, in particolare, contro le
varie organizzazione mafiose. Per l’omicidio del tenente colonnello e del suo
amico professore furono inizialmente condannati tre pastori: Salvatore Bonello,
Rosario Mulè e Casimiro Russo; quest’ultimo, autoaccusatosi, aveva chiamato in
causa gli altri due; ma nel ‘97 vengono assolti e la II sezione della Corte di
Assise di Appello di Palermo condanna definitivamente all’ergastolo Leoluca
Bagarella, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano per l’assassinio di Giuseppe
Russo e Filippo Costa. Così il giornalista Mario Francese, sul “Giornale di
Sicilia”, ricordò quel tragico omicidio: “Al bar entrò soltanto Russo per fare
una telefonata, Costa attese fuori. Un minuto dopo i due amici riprendevano la
loro passeggiata… Nello stesso momento vi fu chi si accorse di una ’128’ verde
che procedeva lentamente per il viale principale, evidentemente controllando i
movimenti di Russo e Costa... L’auto continuò la sua marcia fino alla parte alta
della piazza, effettuò una conversione ad ’U’ e si fermò proprio davanti
all’abitazione del colonnello Russo. I due amici erano vicini alla macchina
degli assassini. Non se ne resero conto. Non potevano. Si fermarono, Russo tirò
fuori dal taschino della camiciola una sigaretta e dalla tasca dei pantaloni una
scatola di ’Minerva’. Russo non ebbe il tempo di accendere la sua ultima
sigaretta. Erano le 22,15. Dalla 128 scesero tre o quattro individui, tutti a
viso scoperto. Lentamente, per non destare sospetti, camminavano verso i due.
Appena furono vicini aprirono il fuoco con le calibro 38. Sparavano tutti contro
Russo, tranne uno, armato di fucile che aveva il compito di uccidere Costa.
Erano killer certamente molto tesi. Al punto che uno di loro lanciandosi contro
Russo per finirlo, gli cadde addosso. Si rialzò immediatamente e, come in preda
ad un raptus, imbracciò il fucile sparando alla testa. Fu il colpo di grazia. Il
killer voleva essere certo che l’esecuzione fosse completa e mirò anche alla
testa dell’insegnante Filippo Costa. Fu il secondo colpo di grazia. Si poteva
andar via. Ma l’ultimo killer nella fuga perse gli occhiali che saranno
ritrovati sotto il corpo senza vita del colonnello Russo. Ci si convinse subito
che si trattava di un duplice delitto di mafia. Un agguato preparato nei
dettagli almeno da 26 giorni. La 128, trovata abbandonata a tre chilometri da
Ficuzza, è stata rubata infatti a Palermo il 25 luglio, appunto 26 giorni prima.
Non sarebbe stato più semplice per la mafia uccidere il colonnello Russo in via
Ausonia sotto casa a Palermo e il professor Costa a Misilmeri, dove abitava? -
si chiede ancora il giornalista - No, perché la mafia voleva un’esecuzione
spettacolare ed esemplare”.
La ricostruzione in Emilia e quello che
il governo non dice. Un modello di gestione. Zero
infiltrazioni mafiose e illegalità arginata. La narrazione ufficiale del Pd
nazionale e regionale esclude ogni tipo di anomalie durante la fase post sisma
emiliano. Eppure le inchieste giudiziarie e giornalistiche dicono altro, scrive
Giovanni Tizian il 31 agosto 2016 su “L’Espresso”. Sulla via Emilia messa in
ginocchio dal sisma del maggio 2012 è nata la narrazione della ricostruzione
pulita. Nella roccaforte del Pd, del resto, tutto deve procedere secondo le
regole. Criminali, mazzette e clan, non avrebbero trovato spazi, recita questa
narrazione. Frammenti di questo racconto trionfalistico giungono anche in queste
ore, a pochissima distanza dalla notizia che Vasco Errani sarà con tutta
probabilità il commissario del post terremoto che ha ridotto in un cumulo di
macerie i borghi storici di Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto.
Errani, appunto, scelto in virtù dell'esperienza emiliana. Dove, però, non tutto
è come sembra. E sono molte le cose che il governo centrale e quello regionale
non dicono. «Ha saputo garantire rigore, serietà, legalità e trasparenza. E noi
oggi abbiamo ricostruito il 70 per cento di quello che avevamo, evitando
infiltrazioni mafiose», intervistato da Repubblica Bologna il sindaco di San
Felice Sul Panaro, Alberto Silvestri, mostra tutto il suo entusiasmo per la
nomina decisa da Matteo Renzi. San Felice è il paese del cratere sismico tra i
più colpiti. Il primo cittadino della bassa modenese, però, sa bene che non
tutto è andato per il verso giusto. Soprattutto in tema di illegalità e
inquinamento mafioso. Vicino a San Felice, per esempio, si trova Finale Emilia.
Lasciamo per un momento da parte la questione mafia, perché l'ultimo episodio
che ha riguardato questo comune ha a che fare con un fatto di ordinaria furbizia
imprenditoriale. Al centro dello scandalo una scuola media da 5 milioni di euro,
nuova di zecca e pronta per essere inaugurata. A distanza di quattro anni
esatti, però, nella ricostruzione qualcosa non ha funzionato. Chi ha realizzato
l'opera, per limare sui costi, avrebbe utilizzato cemento cosiddetto
“depotenziato”. Materiale fragile. Così per inquirenti e investigatori la
struttura della scuola media Frassoni non sarebbe sicura. Il paradosso è che il
luogo scelto per edificare l'istituto era considerato tra i più sicuri del
paese. Tanto, spiegano gli inquirenti, da indicare l'area come luogo di rifugio
per la popolazione nel caso di terremoti. Cittadini beffati due volte, quindi.
Perché avrebbero raggiunto una zona con un edificio, dicono i pm, per nulla
sicuro. L'inchiesta “Cubetto” - termine che indica i campioni di calcestruzzo da
sottoporre ad analisi di resistenza - è ancora in corso. Bisognerà attendere i
risultati delle analisi del materiale sequestrato, e poi l'incidente probatorio.
Coinvolte due importanti aziende. Entrambe con un ruolo in Confindustria. C'è la
Betonrossi Spa, per esempio, attiva in tutta Italia e leader del settore. E la
A&C di Mirandola, il cui proprietario Stefano Zaccarelli era presidente
dell'associazione costruttori di Confindustria Modena, ha lasciato dopo la
notizia dell'indagine a suo carico. L'inchiesta non è finita. Il prossimo atteso
passaggio sarà l'incidente probatorio. Sarà questo il momento decisivo per
verificare effettivamente la tenuta della struttura. La procura vorrebbe
ottenerlo prima del prossimo anno scolastico. Tra gli indagati anche il
direttore dei lavori, un tecnico della Regione, Antonio Ligori. In realtà, si
legge nel suo curriculum, è collaboratore di una società “In house”, la
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. Durante la ricostruzione post-sisma,
ancora in corso, è stato incaricato della Direzione Lavori di numerosi cantieri
per realizzare edifici pubblici, «per conto del Commissario Delegato alla
Ricostruzione (cioè Vasco Errani ndr)». Ligori, 51 anni, negli ultimi quattro
anni ha ottenuto la direzione di 33 strutture, più tre progettazioni. È
responsabile di cantieri che valgono in tutto 75 milioni di euro. Ma non è la
prima ombra che si addensa sulla ricostruzione post sisma. Anzi, è solo l'ultima
di una lunga serie di anomalie. Prima, come documentato da “l'Espresso” ormai
tre anni fa, l'intromissione della 'ndrangheta nella filiera dello smaltimento
delle macerie. Poi i subappalti finiti ad aziende legate ai clan e i sospetti su
una cricca di professionisti che si sarebbero arricchiti con i fondi per la
ricostruzione. E infine il caso del cemento “fragile” usato per una scuola
pubblica. Per quanto riguarda le macerie, il meccanismo con cui la 'ndrangheta
ha potuto lavorare è molto semplice. In piena urgenza con la catena del
subappalto, le strade dei paesi terremotati sono state battute dai camion dei
clan. Hanno smaltito una quantità importante di detriti, non residuale, stando a
quanto scritto dagli investigatori del Gruppo interforze guidato dal poliziotto
Cono Incognito. Un team, questo, costituito ad hoc per vigilare sulle opere da
realizzare nella ricostruzione. Hanno lavorato sodo, e prodotto decine di misure
interdittive, escludendo numerose aziende, alcune delle quali già attive nei
cantieri emiliani, dalla “White list”, gli elenchi della Prefettura ai quali è
necessario iscriversi per poter lavorare nella ricostruzione. C'è stato poi il
caso della Bianchini costruzioni. Leader nel territorio della bassa. Fino a
quando la procura antimafia di Bologna e i carabinieri di Modena non hanno
scoperto la sua vicinanza alla 'ndrangheta emiliana. Così prima è scattata
l'interdittiva antimafia, e due anni dopo i proprietari sono finiti nella maxi
indagine Aemilia (oltre 200 indagati, ora imputati) sui clan calabresi emigrati
nelle province di Modena, Reggio, Parma e Piacenza. La vicenda Bianchini conduce
esattamente al cuore della ricostruzione. Alle cose che non hanno funzionato in
materia di prevenzione. La società ha continuato a lavorare anche dopo il blocco
della prefettura. Con un'altra società, è stato sufficiente cambiare il nome.
Per queste anomalie la prefettura di Modena aveva disposto persino l'accesso nel
Comune di Finale Emilia. La commissione scrisse una relazione in cui evidenziava
diverse criticità nella gestione degli appalti. Il Prefetto chiese lo
scioglimento, ma il Viminale archiviò il caso. A luglio del 2012 il commissario
per l’emergenza Vasco Errani, aveva stanziato l’ingente somma di 56 milioni di
euro, al fine di ricostruire entro la fine di settembre, edifici scolastici
temporanei, a seguito della rovina di quelli esistenti. Ecco comparire di nuovo
la società di San Felice (finita sotto sequestro e adesso gestita da un
amministratore giudiziario per conto del tribunale), guidata all'epoca da
Augusto Bianchini - ora imputato per concorso esterno. In questo caso è
sospettata di aver smaltito amianto in alcuni cantieri della ricostruzione.
Nelle strade, ma anche in una scuola di Reggiolo. È emerso, inoltre,
dall'indagine Aemilia che nei cantieri di Bianchini lavoravano maestranze
assunte grazie all'intermediazione dei boss delle 'ndrine emiliane. Trattati
come schiavi. Con il salario decurtato per pagare il “pizzo” ai padroni
delinquenti. Sfruttamento in piena regola, che ha spinto i sindacati a
costituirsi parte civile nel maxi processo in corso a Reggio Emilia. In Emilia,
dunque, la ricostruzione è stata inquinata. Non sveliamo nulla riportando
un'intercettazione tra due affiliati che nei giorni successivi al sisma ridono
alla grande, e sui morti, per le opportunità di lavoro che si prospettavano.
Come fu per L'Aquila, anche qui gli affaristi hanno visto nelle macerie nuove
opportunità. Ma la ’ndrangheta si è infilata nella ricostruzione anche ad un
altro livello. Ci sono indagini che tuttora proseguono, e puntano verso le
figure dei tecnici. Collaboratori o assunti da imprese contigue alle cosche. Il
sospetto è raccolto dall'Arma dei Carabinieri che ricevono la segnalazione di
una donna sfollata. Si era rivolta a loro perché non la convinceva la dinamica
in cui era finita: l’ingegnere incaricato di redigere il progetto di
ricostruzione aveva assoldato un professionista di fuori regione, facendo
lievitare le spese. Quell’ingegnere ha rapporti con uomini del clan. Ed è socio
di uno studio tecnico della bassa emiliana, tra i lavori ottenuti anche la
progettazione della sicurezza di un cantiere post sisma a Finale Emilia. Tutto
questo -tralasciando episodi minori di truffe e raggiri - nella narrazione
renziana della ricostruzione emiliana non può esistere. Il rischio è di passare
dalla parte dei “gufi”.
Terremoto: la mafia è già pronta a
guadagnare. Fermate subito quelle mani. Dobbiamo
imparare dalle ferite ancora aperte dell'Aquila e dell'Emilia, e dalla storia
del Belice e dell'Irpinia. Per impedire alle organizzazioni criminali e a
imprenditori-sciacalli di brindare sul dolore del 24 agosto. Perché la
ricostruzione non sia un business. Ma un valore, scrive Lirio Abbate il 29
agosto 2016 su “L’Espresso”. La ricostruzione post terremoto è il punto da cui
adesso si deve ripartire. Potranno speculazioni e criminalità restare fuori da
questa tragedia? Si riuscirà a non fare business sulla morte e il dolore? Dovrà
pur servire a qualcosa l’esperienza amministrativa e giudiziaria fatta su un
territorio altamente sismico. E queste nuove vittime non dovranno servire a
sostenere vecchi business e nuovi appetiti per le mafie e i mafiosi. Questa
tragedia che ha colpito l’Italia centrale dovrà necessariamente attingere
all’esperienza fatta dopo il sisma dell’Aquila e dell’Emilia. Ferite ancora
aperte, anche per il dolore inflitto da imprenditori-sciacalli e organizzazioni
criminali che su queste tragedie non hanno visto la morte come sofferenza, ma un
motivo, spesso illegale per arricchirsi. La storia italiana di ogni
ricostruzione ci ha consegnato non solo sofferenza e dolore, ma soprattutto
malaffare. A cominciare dal Belice, passando per l’Irpinia, fino ad arrivare in
Abruzzo e in Emilia Romagna. Le mafie si sono lanciate sui ruderi dei paesi
distrutti come se i cocci caduti dalle abitazioni in cui sono morti donne e
bambini, studenti e pensionati, fossero pepite d’oro da raccoglie. A tutti i
costi e con tutti i mezzi irregolari. I protocolli di legalità pensati e firmati
in questi decenni si sprecano. Qualcuno ha funzionato, altri sono stati
raggirati. Ad ogni modo, sul dopo terremoto si è sempre trovato un prestanome di
mafiosi, un’impresa irregolare che ha messo le mani sugli appalti. È stata
ancora una volta fotografata un’Italia illegale che si contrappone alla grande
solidarietà che questo Paese è capace di offrire a chi ne ha bisogno.
L’esperienza quindi ci dice che il grande business della ricostruzione non viene
mai ignorato dalla criminalità organizzata, e per questo motivo occorre attuare
tutti gli strumenti necessari per evitare l’inquinamento mafioso. Perché sulle
emergenze è più facile che le organizzazioni trovino spazi e modi per
infiltrarsi e lucrare. E guadagnare sulla morte. Negli ultimi vent’anni è stata
combattuta la mafia, ma meno efficacemente la corruzione. E mafia e corruzione
sono sempre più intrecciate. Lo ha dimostrato l’inchiesta “mafia Capitale” che
ha messo in luce un modello tipicamente mafioso; un modello, come ripete il
procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, «che già aveva funzionato per
gli appalti post terremoto in Campania» e che vede un intreccio tra mafia,
politica e imprenditoria. La caratteristica della criminalità mafiosa è la
mimeticità nell’area grigia: ovvero esponenti delle istituzioni,
dell’imprenditoria, delle professioni. Non basta intervenire con la repressione
ma bisogna prevenire: l’educazione ai valori della Costituzione è fondamentale
per recuperare il rispetto della legge. Soprattutto dopo una nuova tragedia come
questa del terremoto.
"La ricostruzione post terremoto boccone
ghiotto per la mafia". Il procuratore antimafia
Roberti: "Non si ripeterà lo scandalo Irpinia. Abbiamo il modello dell'Aquila,
che ha funzionato. Siamo pronti", scrive Luca Romano, Domenica 28/08/2016, su
"Il Giornale". "I rischi ci sono, inutile nasconderlo. E la ricostruzione
post terremoto è storicamente il boccone ghiotto di consorterie criminali e
comitati d'affari collusi". A dirlo, in una intervista a Repubblica, è il
procuratore Antimafia Franco Roberti, che aggiunge: "Però va detto che abbiamo
alle spalle gruppi di contrasto consolidati, esperienza, attività importanti. E
abbiamo il modello dell'Aquila, che ha funzionato. Siamo pronti". Secondo il
procuratore, che seguì in prima persona come pm di Napoli il terremoto
dell'Irpinia oggi "l'esperienza e le acquisizioni scientifiche e giudiziarie ci
dicono che se una casa è costruita bene, se sono state rispettate le norme anti
sismiche, di fronte a un evento drammatico quel corpo di fabbrica può
lesionarsi, incrinarsi: ma non può polverizzarsi e implodere. Ecco perché, senza
azzardare previsioni, immagino ci sia molto da approfondire". I rischi di
infiltrazioni mafiose, perché sottolinea Roberti "i guadagni dei clan cominciano
proprio dal calcestruzzo scadente", "sono sempre alti ma l'esperienza drammatica
del sisma a L'Aquila ci lascia anche un modello importante che ha funzionato
bene". Il magistrato parla infatti di "un modello costruito da tutti insieme,
dal lavoro della Procura distrettuale della città colpita, dal monitoraggio
della Procura nazionale antimafia, dagli uffici giudiziari competenti e
naturalmente dall'Anticorruzione ". Sulla collaborazione con l'Anac infine
precisa "l'Anticorruzione fa bene il suo lavoro di prevenzione della corruzione,
nella acquisizione e gestione degli appalti. Mentre la procura nazionale svolge
il suo monitoraggio sugli eventuali collegamenti mafiosi delle imprese che
concorrono agli appalti".
La sfida di Cantone: "Modello Expo per
ricostruire senza mafia e ladri". L'intervista. Il
presidente dell'Autorità anticorruzione: "Non sarà una grande abbuffata", scrive
Liana Milella il 27 agosto 2016 su "La Repubblica”. "Vedo due pericoli, tutti
italiani, anche in questo terremoto, la mafia che ne approfitta e s'infiltra
nella ricostruzione e le grandi abbuffate dei soliti speculatori". Ma Raffaele
Cantone, il presidente dell'Autorità anticorruzione, prim'ancora di suggerire la
sua strategia per evitare entrambe le minacce, vuole raccontare cos'ha provato
alle 3 e 36 di mercoledì notte: "Per chi, come me, ha vissuto il terremoto del
1980 in Irpinia, pur abitando in una zona non direttamente colpita, la prima
cosa è il grande dolore che provo e la solidarietà forte per chi si è visto
crollare addosso la casa. Poi c'è la preoccupazione per gli speculatori in
agguato".
L'Italia è questo purtroppo. Solidarietà e
malaffare...
"Sì, vedo due Paesi inconciliabili. Quello dei
volontari che arrivano da tutta Italia e scavano fino allo sfinimento con una
gara di solidarietà che coinvolge l'intero paese. Ma poi si fa fatica a pensare
che è lo stesso paese delle grandi abbuffate, di chi ne approfitta e specula, di
chi, quella famosa notte del terremoto dell'Aquila, rideva pensando agli affari
che avrebbe fatto. Da un lato c'è un pezzo d'Italia bellissimo, dall'altro c'è
chi pensa che sui morti si possono fare più affari".
Renzi ha citato lei e l'Anac. Un'altra grana?
"La vedo come un'importante manifestazione di
fiducia, che mi inorgoglisce sia a titolo personale che per il lavoro svolto
dall'Autorità in questi due anni. E poi già penso al futuro e a cosa potremmo
fare".
Ha già un'idea?
"Dipende dalle scelte politiche. L'Anac può avere
una funzione proficua se riesce a ricreare una situazione analoga a quella di
Expo o del Giubileo. Ma perché ciò avvenga gli organi decisionali che gestiscono
gli appalti devono essere uno solo o al massimo pochi. Un'attribuzione
polverizzata a vari soggetti impedirebbe o renderebbe difficile un controllo a
360 gradi. Per le risorse che abbiamo non possiamo seguire 50 stazioni
appaltanti".
Il terremoto però ha distrutto molte case
private.
"È molto importante capire quale parte della
ricostruzione sarà oggetto di interventi pubblici. Se si decide di seguire il
modello aquilano - contributi singoli e lavori a cura dei privati - l'Anac potrà
avere un ruolo relativo. Potrà seguire soprattutto la ricostruzione delle
strutture pubbliche".
Lei cosa suggerisce?
"Esempi possibili ci vengono dagli ultimi
terremoti. All'Aquila si è optato per le new town in attesa della ricostruzione.
Un'opzione criticabile, ma che al momento sembrava razionale perché funzionale a
un'intera città caduta. In alternativa bisogna comunque trovare formule per
ricostruire rapidamente e questa è l'opzione decisamente preferibile".
Ma qual è quella di Cantone?
"Il modello Expo, sperimentato anche in altre
situazione note e meno note. La vigilanza collaborativa, oggi prevista pure nel
codice dei contratti, utilizzata tra l'altro per Bagnoli e per il Giubileo. Ma
le soluzioni vanno calibrate sulle tipologie degli eventi. La priorità è dare
subito le case, perché adesso vanno bene le tende, ma ad Amatrice tra poco farà
freddo, quindi l'urgenza è sistemare 2mila persone. La logica delle new town fu
quella, anche se poi fallì del tutto perché non furono ricostruite le vecchie
case".
Lei ricordava l'intercettazione della notte
dell'Aquila. Teme anche ora la grande abbuffata?
"Bisogna evitare che i soldi pubblici finiscano in
operazioni illecite. Ma quando Renzi parla di modello Anac pensa anche al
rischio di infiltrazioni mafiose, perché tra le imprese che provvedono alla
rimozione dei detriti e al movimento terra il rischio di infiltrazioni è
altissimo. È necessario un controllo preventivo come avvenne per il terremoto in
Emilia. Bisogna evitare il grande bubbone del sisma in Irpinia, non solo per il
clamoroso spreco di denaro pubblico, ma perché proprio allora la camorra, da
associazione dedita ad affari tradizionali, divenne imprenditrice".
Il codice degli appalti, su cui si riversano
tante critiche, potrà creare difficoltà?
"Mi sento di escluderlo. Il codice consente di
fare qualsiasi tipologia di appalti. Comunque sarà una delle priorità dell'Anac
verificare se possono esserci provvedimenti attuativi da emettere che potrebbero
incidere sulla ricostruzione".
Ad Amatrice crolla una scuola costruita senza
garanzie sismiche. Non è anche questa una minaccia?
"Su quell'appalto bisogna accendere subito una
luce. Sarebbe ingiusto dare giudizi su due piedi, ma se il terremoto fosse
avvenuto in un altro momento dell'anno finiva come a San Giuliano di Puglia. Una
strage di bambini. La scuole di Amatrice era stata ristrutturata nel 2012 ed è
caduta. In teoria anche un edificio perfetto può cadere per un terremoto
fortissimo. L'Autorità giudiziaria e noi dell'Anac ce ne occuperemo per
individuare le responsabilità".
Repubblica ha scoperto che ci sono fondi per il
rischio sismico neppure spesi...
"Non è il momento di fare polemiche perché il
dolore deve prevalere su tutto, ma bisogna individuare le responsabilità di chi
avrebbe potuto utilizzare quel denaro e non lo ha fatto e se questo incide sulla
capacità di questi amministratori di gestire la ricostruzione".
Renzi e il terremoto in Centro Italia:
«Prendiamo esempio dall’Emilia», scrive il 29 agosto
2016 “La Repubblica”. Il presidente del Consiglio non parla di Errani
commissario ma cita la ricostruzione dopo il sisma del 2012. Ma i Cinque Stelle
attaccano. Non parla di Vasco Errani come commissario per la ricostruzione in
Centro Italia, ma designa l’Emilia-Romagna come un modello per il
post-terremoto. Matteo Renzi, nella enews pubblicata lunedì, fornisce le
coordinate per l’immediato futuro delle zone terremotate. «La storia italiana -
scrive il presidente del Consiglio - ci consegna pagine negative nella gestione
del dopo-terremoto, come l’Irpinia, ma anche esempi positivi. Su tutti il Friuli
del 1976, certo. Ma anche l’Umbria di vent’anni fa. E soprattutto penso al
modello emiliano del 2012». Quel territorio, sottolinea il premier, «ha `tenuto
botta´, come si dice da quelle parti, ricostruendo subito e bene. Le aziende
sono ripartite, più forti di prima. E la coesione mostrata è stata cruciale per
raggiungere l’obiettivo». Secondo Renzi «dovremo prendere esempio da queste
pagine positive. E fare del nostro meglio - senza annunci roboanti - per
restituire un tetto a queste famiglie e restituire un futuro a queste comunità».
Ma i grillini partono all’attacco. Il deputato Michele Dell’Orco lancia un primo
tweet in cui accosta il nome del «disoccupato» Errani all’inchiesta Aemilia. «Il
Governo — ha rincarato poi via web Dell’Orco — chiama Vasco #Errani per la
ricostruzione: “verrà adottato il modello Emilia’” Modello Emilia??! Dal
processo Aemilia emerge che la movimentazione della terra nel post-terremoto ha
visto un coinvolgimento di aziende direttamente o indirettamente vicine alla
criminalità mafiosa; c’è stata una sottovalutazione del problema da parte delle
pubbliche amministrazioni. Insomma- rimarca il parlamentare M5s- la mafia si è
infiltrata a piene mani nella ricostruzione. E Renzi nomina Errani? Vogliamo
ripetere gli stessi errori? Io no». In casa Pd scatta il contrattacco. «Il
deputato 5 stelle Dell’Orco- reagiscono in una nota i parlamentari dem Davide
Baruffi, Manuela Ghizzoni, Maria Cecilia Guerra e Stefano Vaccari- straparla, o
peggio, se parla con convinzione allora diffama. Perché se c’è un aggettivo che
chi lo conosce associa al nome Vasco Errani è onesto, oltre che competente». E,
dunque, «far intendere, come fa il collega Dell’Orco con il suo tweet, che ci
sia una qualsivoglia connessione tra la nomina di Errani a commissario
straordinario per il sisma nel 2012 e l’inchiesta Aemilia è mistificare la
realtà. Perchè se c’è una cosa per cui Errani ha lavorato, in questi anni, è
proprio l’obiettivo per cui ogni euro speso per il cratere sismico fosse
rintracciabile e impiegato in maniera legittima».
Cinque Stelle e leghisti contestano
Errani e la validità del "modello Emilia". M5S e
centrodestra bocciano la scelta dell'ex governatore come commissario per la
ricostruzione e citano le infiltrazioni della criminalità emerse dal processo
Aemilia. Di Maio: "Renzi usa il terremoto per ricucire il Pd". La replica di
Guerini, scrive il 29 agosto 2016 “La Repubblica”. La tregua e l'unità nazionale
sul terremoto è già finita. Il Movimento Cinque Stelle, infatti, non ha
gradito la scelta di Vasco Errani come commissario per la ricostruzione delle
aree devastate dal sisma. E lo stesso atteggiamento di chiusura adottano anche
Lega e Forza Italia. Il primo affondo è lanciato dal deputato grillino emiliano
Michele dell'Orco. "Il governo - dice il parlamentare - chiama Errani per la
ricostruzione e verrà adottato il modello Emilià. Modello Emilia? Ma dal
processo Aemilia emerge che la movimentazione della terra nel post-terremoto ha
visto un coinvolgimento di aziende direttamente o indirettamente vicine alla
criminalità mafiosa; c'è stata una sottovalutazione del problema da parte delle
pubbliche amministrazioni. Insomma - conclude Dell'Orco - la mafia si è
infiltrata a piene mani nella ricostruzione. E Renzi nomina Errani? vogliamo
ripetere gli stessi errori?" Un attacco durissimo che viene rilanciato anche da
Laura Castelli, capogruppo grillina alla Camera: "Quanto accaduto in seguito al
commissariamento di Errani in Emilia lo conosciamo tutti, arriva anche a
includere inchieste che hanno sottolineato quanto la 'ndrangheta entri in questi
appalti e in queste ricostruzioni", dice Castelli. Poi arriva l'affondo di Luigi
Di Maio, membro del direttorio M5S che scrive su Facebook: "Mi lascia sgomento
un presidente del Consiglio che poche ore fa ha guardato negli occhi i
sopravvissuti dell'ennesimo terremoto e adesso pensa di sfruttare la tragedia
per ricucire il Pd affidando l'incarico di commissario per la ricostruzione a
Vasco Errani. Gestisce un'emergenza con le logiche del congresso di partito.
Vasco Errani non può essere il commissario al terremoto del Centro Italia. Ora
serve un profilo al di fuori del sistema dei partiti". Un altro colpo al clima
di unità arriva dalla Lega. "In Emilia Romagna Errani ha fallito completamente,
vorremmo evitare un fallimento due. Chiediamo a Renzi di non fare nomine in base
a logiche di equilibrio interne" dice il senatore leghista Gian Marco Centinaio.
Poi tocca al leader Matteo Salvini: "La Lega è pronta ad aiutare e collaborare
con tutti per il bene delle persone colpite dal terremoto ma non a guardare in
silenzio il ripetersi di vecchi errori, sprechi e ruberie. Il fallimento e la
lentezza della ricostruzione in Emilia non si devono ripetere". E critiche
arrivano anche dal centrodestra. Il consigliere regionale di An-Fdi Tommaso Foti
accusa: "Neppure abili prestigiatori possono nascondere che, nella bassa
modenese in particolare, si registrano ritardi gravissimi nella ricostruzione".
E da Roma Maurizio Gasparri fa sapere: "Nessuna apertura nei confronti di Renzi
e della sua fallimentare politica". Secondo il vicepresidente forzista del
Senato "FI farà proposte per la ricostruzione delle zone terremotate e darà
piena disponibilità in ogni passaggio parlamentare con uno spirito di coesione
che è doveroso e che altri non sempre hanno dimostrato in occasioni analoghe a
ruoli inversi. È però certamente un avvio sbagliato quello della nomina di
Errani a commissario". A Di Maio ha replicato Lorenzo Guerini, vicesegretario
del Pd: "Mi spiace che Di Maio utilizzi una tragedia come quella del terremoto
per aprire un'inutile polemica con il Pd e il presidente del consiglio - ha
detto Guerini - . Errani è un ottimo amministratore che ha già dato prova di
capacità, competenza ed efficienza come commissario per il terremoto in Emilia,
esperienza che potrà mettere a disposizione per la delicata opera di
ricostruzione delle zone del Centro Italia colpite dal sisma. È tempo di unità e
responsabilità per dare risposte alle popolazioni colpite così duramente e non
di polemiche".
TERREMOTO E GIUSTIZIA. Per i morti
dell'Aquila solo 9 colpevoli. E ora a fermare i processi arriva la prescrizione.
Responsabilità difficili da stabilire. Perizie contrastanti. Vecchi edifici
costruiti da tecnici ormai defunti. Per il sisma del 2009 sono stati condannati
in via definitiva una manciata di imputati. E fra poche settimane un colpo di
spugna finale cancellerà le ultime inchieste. Uno scenario che rischia di
ripetersi col terremoto di Amatrice, scrive, nascondendo le responsabilità delle
toghe e da antiberlusconiano, Paolo Fantauzzi il 2 settembre 2016 su
"L'Espresso". Le indagini della Procura di Rieti. Quelle della Procura di Ascoli
Piceno. Gli accertamenti dell’Anticorruzione. L’opinione pubblica che chiede,
come sempre in questi casi, “pene esemplari”. Dopo il sisma che ha colpito
Amatrice, Accumoli e Borgo Arquata, la macchina della giustizia si è subito
messa in moto per individuare i responsabili dei crolli. La speranza è che non
finisca come all’Aquila: nel capoluogo abruzzese i condannati per il terremoto
sono stati una manciata. Per la difficoltà di accertare le colpe, innanzitutto.
Ma anche per effetto della prescrizione, i cui tempi sono stati generosamente
accorciati nel 2005 dal governo Berlusconi. Così fra poche settimane (il 6
ottobre) un definitivo colpo di spugna cancellerà tutti i processi non ancora
terminati. Compreso quello al più noto degli imputati, Guido Bertolaso, a
giudizio per omicidio colposo plurimo. A meno che non intenda rinunciare al
“salvataggio” come ha detto nei mesi scorsi. Anche all’Aquila la magistratura si
mise subito al lavoro con grande impegno. Su circa 200 fascicoli d’indagine
aperti dopo il sisma, però, solo una quindicina hanno raccolto elementi
sufficienti per arrivare a dibattimento. E soltanto pochissime inchieste si sono
concluse in Cassazione con delle condanne, nove in tutto: quattro per il crollo
della Casa dello studente (costato la vita a otto ragazzi), due per il Convitto
nazionale (in cui persero la vita tre minorenni), altrettante per il collasso
della facoltà di Ingegneria, più l'ex vice capo della Protezione civile Bernardo
De Bernardinis , cui sono stati inflitti due anni di reclusione per
l’informazione “imprudente” e “scorretta” che rassicurando immotivatamente i
cittadini fece aumentare il numero delle vittime. Circostanza che non gli ha
impedito di essere in prima linea nella macchina dei soccorsi nei giorni scorsi,
essendo la sua pena stata sospesa. Nelle aule di giustizia molti altri casi si
sono conclusi con l’assoluzione, spesso chiesta direttamente dall’accusa.
«Processi del genere sono molto complessi» spiega il sostituto procuratore Fabio
Picuti, che li ha seguiti tutti: «Molte case erano costruite con tecniche di un
secolo fa, quando le norme antisismiche non erano ancora in vigore, e questo ci
ha spinto a chiedere l’archiviazione. In altri casi si trattava di edifici
realizzati male in partenza ma decenni fa, e i progettisti erano morti o molto
anziani e quindi incapaci di affrontare i processi. E poi non bisogna
dimenticare che per giungere a una condanna bisogna dimostrare un nesso causale
fra i crolli e i lavori di ristrutturazione: si rivelano fondamentali le perizie
e non sempre si riescono a provare condotte colpevoli». A questo complicato
groviglio si aggiunge la prescrizione. Giovedì 6 ottobre si estingueranno tutti
i processi non ancora conclusi. Secondo quanto previsto dalla legge ex Cirielli,
infatti, i delitti con pena massima di cinque anni, come l’omicidio colposo, si
estinguono dopo sei anni. Se c’è stata qualche interruzione, si può ottenere un
altro 25 per cento di “bonus”. Totale: sette anni e mezzo dal sisma del 6 aprile
2009. Senza la riforma del governo Berlusconi sarebbero stati cinque in più:
fondamentali per accertare tutte le responsabilità. Il risultato è che andrà
sicuramente in fumo il processo per il crollo del palazzo di via D’Annunzio, che
costò la vita 13 persone. A maggio la Cassazione ha annullato con rinvio la
condanna dell’ingegnere che restaurò l’edificio (costruito negli anni ’60 con
calcestruzzo scadente) e non si accorse dei rischi: tre anni e mezzo di
reclusione in primo grado, ridotti a 22 mesi in appello e adesso tempi
insufficienti per affrontare nuovamente due gradi. Situazione identica per i due
palazzi gemelli che in via Sturzo provocarono 29 vittime. Anche in questo caso,
a causa del calcestruzzo di scarsa qualità ed errori di progetto. Solo che
quattro presunti responsabili sono deceduti e l’unico superstite ha quasi 90
anni. Così, dopo i tre anni comminati in primo grado, il giudizio si è fermato a
causa delle sue condizioni di salute. E si salveranno pure i due imputati per il
crollo di due palazzi in via Milonia, condannati a due anni di carcere: il
processo è ancora in Corte d’Appello. Ci sono poi le inchieste finite nel nulla.
Magari perché la Cassazione ha ribaltato i verdetti precedenti: nel crollo del
condominio di via Rossi morirono in 17 e l’amministratore e direttore dei lavori
di rifacimento del tetto (che sotto le macerie perse la figlia), dopo essere
stato condannato in primo e secondo grado per disastro e omicidio colposo
plurimo, a giugno è stato assolto con formula piena: “il fatto non sussiste”.
Per il collasso dello stabile di via XX Settembre 123 (cinque morti), invece,
l’unico imputato ancora in vita, il collaudatore oggi 91 enne, è stato assolto
in tutti i gradi di giudizio. In altri casi i palazzi erano talmente mal
costruiti, secondo le perizie, da rendere impossibile addebitare alcunché alle
ristrutturazioni. Tanto da spingere l’accusa a chiedere l’assoluzione, come
per gli edifici di via XX Settembre 79 (nove morti) e via Persichetti (due
vittime). E nessuno ha pagato nemmeno per i danni subiti dall’ospedale, reso
inagibile dal sisma al punto che quel 6 aprile i feriti dovettero essere
medicati sul piazzale antistante: quattro imputati tutti assolti. La Procura,
che aveva chiesto tre condanne, non ha nemmeno impugnato la sentenza. Anche chi
ha pagato spesso se l’è cavata con poco. Oltre al già citato vice di Bertolaso,
De Bernardinis, ci sono i quattro tecnici ritenuti colpevoli per il crollo della
Casa dello studente (otto morti): pene comprese fra due anni e mezzo e quattro
anni per accuse che vanno dal disastro alle lesioni all’omicidio colposo, ma
pure a due di loro il provvedimento è stato sospeso per motivi di salute.
Ventidue mesi di reclusione (quattro anni inizialmente) e interdizione
quinquennale dai pubblici uffici, invece, per il direttore di cantiere e il
direttore dei lavori della facoltà di Ingegneria, che collassò e non uccise
nessuno solo perché era notte: qualche ora dopo sarebbe stata una tragedia.
Infine i due responsabili del crollo del Convitto (tre vittime), accusati di
inerzia anche per non aver fatto evacuare la scuola, frequentata da minori, dopo
la prima forte scossa che precedette di poco quella fatale: il dirigente della
Provincia con delega all'edilizia scolastica (due anni e mezzo di reclusione) e
l’ex rettore Livio Bearzi (quattro anni). Per quest’ultimo dopo l’arresto si
sono mobilitati il sindacato dei presidi, gli enti locali, vari parlamentari. La
governatrice Debora Serracchiani ha addirittura scritto a Sergio Mattarella.
Tutti concordi nell’ingiustizia di mandare in prigione un preside. Dopo 44
giorni Bearzi, che ha anche chiesto la grazia al Quirinale, è stato scarcerato.
Ora è ai servizi sociali.
Dopo l’assoluzione definitiva in Cassazione, Enzo
Boschi scrive al Corriere della Sera, scrive "Il Foglietto" il 26 Novembre 2015.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera inviata dal geofisico Enzo
Boschi al direttore del Corriere della Sera, all’indomani della sua piena
assoluzione in Cassazione. “Caro Direttore, a pagina 25 del suo giornale del 21
novembre 2015, in basso a destra, in una decina di righe di una piccola frazione
di colonna, con il titolo "Sisma all'Aquila. Assolti gli Scienziati", è apparsa
la notizia che la Cassazione ci ha assolto definitivamente. Eravamo già stati
assolti con formula piena un anno fa nel processo d'appello. Ovviamente lei è
padrone di pubblicare come meglio crede ciò che crede opportuno. Tuttavia,
giornali prestigiosi come La Repubblica, La Stampa e Il Messaggero ... hanno
dato un adeguato risalto alla notizia. Lo scopo di questa mia lettera non è
quindi di recriminare con lei, ci mancherebbe. Piuttosto vorrei farle notare la
sproporzione fra il trafiletto di sabato e il lungo articolo apparso
sul Corriere della Sera del 28 ottobre 2012, all'indomani della nostra condanna
nel processo di primo grado. È un articolo scritto da un'anziana Signora,
autrice di libri dimenticabili e dimenticati. Non ha mai seguito il processo
svoltosi a L'Aquila, dove peraltro non mi sembra siano capitati giornalisti
del Corriere. Ciononostante, la Signora sembra far fatica, nell'empito del suo
sfogo, nel trattenersi dal chiedere per noi la pena di morte per impiccagione.
Ebbene, se avesse seguito il processo, cioè se avesse provato l'esperienza di
scrivere di cose a lei note, forse si sarebbe accorta di qualche incongruenza.
Per esempio, il Sindaco Cialente durante la sua deposizione al processo dichiara
che era rimasto fortemente impressionato dalle mie dichiarazioni sulla
pericolosità sismica abruzzese, tanto da prendere misure cautelari. La cosa può
essere verificata senza dubbi di sorta! Lo dichiara anche in un’intervista
successiva alla deposizione, che può essere trovata sul web. Addirittura
arriverà a chiedere lo stato di emergenza per la sua città. Il 2 aprile 2009,
quattro giorni prima del terremoto, Il Centro, il più importante giornale
abruzzese, dedicherà a questa sua richiesta un'intera pagina. L'incongruenza,
che poteva esser compresa anche dalla Signora, risiede nel fatto che il PM e il
Giudice di primo grado hanno ignorato le dichiarazioni di Cialente mentre sono
state uno degli argomenti che hanno portato il Giudice del processo d'appello ad
assolverci con formula piena. Inoltre, se la Signora era così convinta
nell'accusarci di aver rassicurato gli aquilani, l'avrà senz'altro fatto sulla
base di riscontri. Strano che nessuno abbia trovato alcunché che giustifichi la
sua indignazione. Mi rendo conto che a una certa età anche un viaggio
Roma-L'Aquila-Roma può essere faticoso ... Potrebbe allora coltivare il dubbio
come fanno le persone colte e intelligenti e di conseguenza informarsi. Invece,
nell'articolo, la Signora ci indica come riferimento morale la Senatrice
Pezzopane, all'epoca, credo, Presidente della Provincia de L'Aquila. Ebbene la
invito, caro Direttore, ad ascoltare sul web alcune conversazioni fra la
Pezzopane e la Stati, all'epoca Assessora per la Protezione Civile della Regione
Abruzzo, cioè (titolo V della Costituzione) la massima e unica autorità in
materia di sicurezza dei cittadini abruzzesi. Per sua comodità le allego una
pagina della trascrizione del dialogo "illuminante" Pezzopane-Stati ...Mi
farebbe piacere che anche la nostra spietata accusatrice ne prendesse visione
... forse potrebbe anche trovarne una qualche ispirazione per uno dei suoi
romanzetti. Non credo che lei pubblicherà questa mia lettera. In fondo quando
uscì l'articolo, il Corriere era diretto da altri. Mi piacerebbe tuttavia
conoscere la sua opinione su un fatto: perché, secondo lei, la richiesta di
stato di emergenza non fu concessa? Se fosse stata concessa forse non ci
sarebbero state vittime ... o sarebbero state molte meno. E perché, secondo lei,
nessun giornale si è posto questa domanda? Una ragione ci sarà, c'è sempre una
ragione ...Grazie per l'attenzione. Enzo Boschi”.
TERREMOTO DELL’AQUILA. C’E’ IL
COLPEVOLE! CAMORRISTI, SCIENZIATI & FACCENDIERI TUTTE VIOLE MAMMOLE. Scrive il 9
dicembre 2015 Paolo Spiga su "La Voce delle voci". Dentro il primo! Terremoto
dell’Aquila, 309 corpi sotto le macerie quel maledetto 6 aprile 2009. Finalmente
la implacabile giustizia comincia a colpire, il pugno di ferro dei magistrati a
farsi sentire. In galera i progettisti che hanno inventato case di cartone? I
costruttori che hanno usato materiali scadenti? Chi ha impugnato compassi, ruspe
e betoniere per la ricostruzione post sisma? Casalesi arrivati in un baleno a
impastare calcestruzzo, subappalti e milioni di euro? Politici collusi? Colletti
bianchi? Scienziati della commissione “Grandi Rischi” che non hanno allertato
sugli imminenti pericoli? No. La mannaia è scesa sul capo di Livio Bearzi, il
preside del convitto “Domenico Cutugno” dove persero la vita tre studenti e
altri due rimasero feriti. Condannato a 4 anni per omicidio colposo, avendo
“omesso di valutare l’enorme pericolo incombente” e colpevole – secondo gli
ermellini del palazzaccio di Roma – di non aver fatto uscire in tempo i ragazzi
dal convitto killer. Eccolo, dunque, il Grande Colpevole, Bearzi. E chi se ne
frega se più volte, nei mesi precedenti, aveva denunciato alla Provincia –
proprietaria dell’istituto – tutte le insidie rappresentate da una struttura
costruita addirittura duecento anni prima, e con tutti i segni dell’età nelle
strutture! “Non c’è alcun pericolo – avevano rassicurato – prima o poi daremo a
sistematina. Ma per ora potete stare sereni”. Renziani ante litteram, i solerti
amministratori della Provincia? Ma per fortuna oggi giustizia è fatta. Il mostro
di Cividale è assicurato alle patrie galere. Forse perchè – avranno pensato i
togati – porta anche sfiga. Si era salvato per miracolo, quasi quarant’anni fa,
nel 1976, dal terremoto che sconvolse il Friuli: era con i calzoncini corti,
allora, studente del convitto. I terremoti, forse, sono nel suo Dna: e anche per
questo la galera è sacrosanta. Un fesso pericoloso, il preside, secondo la
giustizia di casa nostra: non fu in grado di capire quanto i cervelloni, gli
Einstein della commissione “Grandi Rischi” potevano tranquillamente non sapere,
come ha poche settimane fa stabilito la stessa Cassazione. Ergo: i geni come
Franco Barberi ed Enzo Boschi, che conoscono ogni piega del territorio e
“ascoltano” il nostro suolo come neanche una mamma con il bimbo in grembo, sono
giustificati circa il loro clamoroso flop e, per di più, non sono colpevoli di
aver in somma incoscienza “rassicurato” i cittadini e tranquillizzato il popolo
bue aquilano (giusta vittima sacrificale). Il preside Bearzi, invece, doveva
“prevedere” il futuro: gli è mancata – gigantesca colpa – la palla di
vetro…Caritatevole, corre in soccorso del condannato a 4 anni di galera il
procuratore capo dell’Aquila Franco Cardella: “posso soltanto esprimere la mia
solidarietà per il dramma della persona. Un uomo di scuola che perde i propri
studenti è come il capitano che vede affondare i marinai”. Uno Schettino sulle
scole d’Abruzzo: solo che il comandante, che ha sulla coscienza i 32 morti del
Giglio, è libero (per ora) come un fringuello. Ma il lavoro, a quanto pare,
ferve nel foro dell’Aquila. Un iper attivismo per far luce su tanti altri
colpevoli di quelle morti sotto le macerie del sisma. Alcuni avvocati parlano di
“oltre 200 procedimenti aperti”. Un pò – c’è chi racconta – “come quando
Fantozzi dava i numeri sui gol per le partite della Nazionale, 15 a 7 o 24 a 12.
Solo che qui la situazione non è tragicomica, ma solo tragica, perchè si tratta
di giustizia finora negata ai familiari delle vittime”. Numeri a parte (la quota
di 200 sembra davvero campata per aria, a meno che non vengano comprese
eventuali – e poco immaginabili – liti condominiali post sisma) è la qualità
delle inchieste e dei relativi processi che desta non poca preoccupazione. “Una
delle indagini cardine riguarda la malcostruzione dei balconi per il progetto
Case – racconta un architetto – alcune centinaia di situazioni. Ma con tutto
quello che è successo sembra il classico topolino…”. Tutto quello che concerne
la malcostruzione di prima, la prevenzione zero, la non informazione dei
cittadini sui rischi, i soccorsi e l’emergenza, le varie fasi della
ricostruzione post sisma…, su tutto questo – un vero ben di Dio – non si muove
una foglia. Affaristi, politici, camorristi, faccendieri d’ogni specie possono
dormire sonni tra tanti morbidi guanciali. Perchè la giustizia di casa nostra
funziona così: basta un preside in galera perchè non ha suonato la campanella…
Magistrati al posto di scienziati.
Pontificano su terremoti, su ogm, su stamina, su Xylella, su prospezioni, su
onde herziane. Fanno spesso buchi nell'acqua, sprecando tempo e risorse, scrive
Domenico Cacopardo. Se David Bowie, il duca bianco, che aveva raffigurato se
stesso nei panni di un marziano che cade sulla terra, si reincarnasse in Italia
avrebbe di che rimanere, nel giro di qualche ora, stupificato (magnifico
neologismo attribuibile alla rabbina Barbara Aiello). Nel mondo della
tecnologia, figlia della scienza, in Italia scoprirebbe che gli scienziati non
vanno di moda, né vanno di moda i termometri. Il potere giudiziario, infatti,
conferendo a se stesso un esercizio del potere che va al di là del sapere
scientifico, ama aprire e condurre processi alle fonti del sapere, spesso
contestate, per meri interessi di botteguccia da chi la scienza non sa dove sta
di casa. Pensiamo al caso L'Aquila con i sismologi condannati e assolti in
appello. Pensiamo al caso Stamina, una ciarlateneria che, per alcuni anni, è
stata presa sul serio da magistrati che hanno creduto alla pietra filosofale,
più che alle valutazioni del Consiglio superiore di sanità, contribuendo alle
illusioni di ammalati e loro familiari sulle virtù terapeutiche di un metodo
inesistente sul piano scientifico e su quello dei risultati. A quanto è dato di
capire da un breve giro sul web, Stamina esiste ancora ed è illegalmente
praticato nel territorio della Repubblica italiana. Pensiamo al caso della
Xylella (Xylella fastidiosa, batterio Gram negativo che vive e si riproduce
all'interno dell'apparato conduttore della linfa grezza) che ha colpito grandi
superfici pugliesi coltivate a olivi. Per combatterla, l'Unione europea e lo
Stato italiano, hanno avviato un programma di abbattimenti di essenze malate e
di essenze sane, in prossimità, appunto, di quelle colpite per realizzare una
specie di cortina sterile a difesa del resto delle piantagioni. Ovviamente, sono
sorti subito comitati e comitatini di oppositori della misura profilattica,
supportati da sedicenti tecnici o da tecnici veri che, tuttavia, non hanno
responsabilità specifiche nella gestione del problema. Ebbene, anche in questo
caso non si trova di meglio che processare gli scienziati che hanno identificato
il batterio e che hanno indicato le terapie difensive da attuare. Anche per il
Muos siciliano, alcuni magistrati, in contestazione degli studi del Consiglio
superiore di sanità (con il Cnr), hanno avviato un procedimento nei confronti
dei realizzatori dell'opera, vitale per la sicurezza dell'Occidente e
dell'Italia, sulla base di non dimostrate né dimostrabili conseguenze nei
confronti della popolazione civile. In Puglia, l'ipotesi di ampliare le aree di
prospezioni petrolifere in mare Adriatico, nell'interesse primario della
bilancia dei pagamenti italiani e dell'economia nazionale e regionale, incontra
l'opposizione di Notriv, una specie di Notav, mobilitati nella ingiustificata
opposizione a una possibile via di rilancio economico. Il presidente della
Regione, Emiliano, i cui passi da borghese da grand-élite non disdegnano le vie
della smaccata demagogia, indulge nell'appoggio ai Notriv, per ricostruirsi
un'immagine, dopo il deterioramento provocato da anni di potere. La Lucania,
ora, gode degli effetti positivi dei ricavi da estrazione di petrolio, dopo
avere combattuto tale possibilità. Messina è governata da un desperado agitatore
che è riuscito a convincere l'elettorato della città a eleggerlo sindaco sulla
stupida e autolesionistica promessa Noponte. Anni di studi di scienziati buttati
nel cesso da un professore di ginnastica con la vocazione del protestatario.
Certo, onesto rispetto ai soldi, ma privo dell'onestà intellettuale di ammettere
che chi sa più di lui, sa più di lui. Vedrà anche il nostro David Bowie,
marziano in Italia, che si processano i termometri non le febbri. In passato, da
una procura italiana furono mandati avvisi di garanzia o mandati di comparizione
a Reagan, Gorbaciov, Mitterand per commercio di armi nucleari. Il commercio di
armi è stato anche il settore elettivo di alcuni magistrati per avviare
procedimenti nei confronti di capi di governo e ministri della difesa. Tutti
finiti in una bolla di sapone. In tema di termometri, sembra di questo genere il
processo alle agenzie di rating in relazione al quale si sarebbero svolti
costosi (e di dubbia utilità) accessi in uffici americani. La prima vittima di
questo caos, è il sistema giudiziario italiano: migliaia di magistrati tessono
la tela per una giustizia operosa e tempestiva, in silenzio facendo senza
apparire, mentre altri appaiono senza fare (il caso de Magistris e le recenti
assoluzioni di tutti coloro che lui aveva accusato di vari reati contro
l'amministrazione). Eppure ci vorrebbe poco, se il governo Renzi, che si
autoqualifica governo del fare, decidesse di mettere alla prova la capacità
dell'Associazione nazionali magistrati di convenire una piattaforma di
iniziative amministrative e legislative per dare ai processi tempi normali,
analoghi a quelli degli altri paesi. Con ciò getterebbe un bel guanto di sfida.
Per quel che riesco a capire, la sfida sarebbe accolta e dal caos creativo (e
distruttivo) passeremmo a un ordine creativo, capace di battere la strada della
certezza del diritto, della pena e della sentenza, un qualcosa che sembra,
appunto, appartenere più a Marte che all'Italia repubblicana e democratica.
Basterebbe riflettere sul felice esito della questione della caserma Manara,
finalmente ceduta - ma solo dopo l'avvio di un'azione di coordinamento e pungolo
della presidenza del consiglio - all'amministrazione della giustizia che lì
concentrerà gli uffici giudiziari civili, lasciando l'infelice pseudobunker di
Piazzale Clodio a quelli penali in una purtroppo ritardata razionalizzazione del
sistema giustizia romano. Non è infatti vero che in Italia non si può cambiare
nulla: fa solo comodo a pochi non cambiare nulla. Per gli altri, per la
collettività cioè il cambiamento è vitale. Basterebbe pensare com'è cambiato il
paese per la semplice (mica tanto) costruzione dell'Alta velocità
Torino-Milano-Salerno per capire come serve intervenire nelle arterie della
penisola rendendole tal quali la modernità pretende. Il nostro Bowie, infine,
rimarrebbe senza parole osservando come una parte della sinistra storica
italiana è fisiologicamente conservatrice e combatta tutto ciò che comporta, in
fin dei conti, nuova occupazione (il ponte sullo Stretto) e futuri benefici per
la collettività. La vecchia psicopatologia, tutti uguali, perciò poveri e
disperati che ispirò le politiche economiche dell'Urss, continua ancora a
colpire nella Corea del Nord e, per fortuna solo in modo marginale, in Italia.
ItaliaOggi. Numero 016, pag. 5 del 20/01/2016.
Giustizia folle dopo L'Aquila: 200
inchieste, poche condanne. Anche in Abruzzo il sisma
del 2009 scatenò le procure. Ma il bilancio è un flop: 19 processi e assolti a
pioggia, scrive Giuseppe Marino, Mercoledì 31/08/2016, su "Il Giornale". Il
dolore causato dal terremoto dell'Aquila, così come quello di Amatrice, non è
risarcibile, eppure è nella natura umana cercare un colpevole. Ma a nessuno
gioverà il tormento ricaduto sulle spalle di decine di persone finite nel mirino
della magistratura dopo la tragedia. Spesso con risultati modesti, un copione da
non ripetere ad Amatrice e dintorni. All'indomani del terremoto del 6 aprile
2009, proprio come sta accadendo ora tra Ascoli e Rieti, cominciò a spirare un
potente vento giustizialista e non solo tra chi aveva legittimamente diritto a
chiedere conto delle morti. La Procura dell'Aquila avviò duecento fascicoli di
inchiesta sui crolli. A distanza di sette anni, i dibattimenti che risultano
effettivamente aperti sono solo 19 e le condanne una manciata. Ci sono poi altri
processi collaterali, come quello contro la Commissione Grandi rischi, terminato
con una sola condanna. Ma è anche sul piano della «qualità» delle condanne che
si può nutrire qualche dubbio visto l'esito di tanto sforzo giudiziario. Anche
allora, come oggi, giornali e tv diedero in pasto all'opinione pubblica notizie
di losche macchinazioni per appropriarsi cinicamente di soldi pubblici in barba
ai rischi per gli edifici, sospetti su clamorose truffe nelle costruzioni che
poi furono causa di morti. A guardare bene però, fin qui a pagare sono state un
pugno di uomini, a loro volta spesso già colpiti personalmente dal terremoto.
Sono due i casi clamorosi che hanno condotto a condanne definitive. Per i
ragazzi morti alla Casa dello studente sono stati ritenuti colpevoli tre tecnici
che eseguirono un restauro e il presidente della commissione di collaudo. Per il
crollo del Convitto nazionale dell'Aquila, sotto le cui macerie morirono tre
studenti, è stato condannato a 30 mesi un ingegnere della Provincia, ma in
carcere è finito solo il povero preside Livio Bearzi, che in quell'edificio
viveva con la sua famiglia, incolpato di «aver omesso di valutare l'enorme
pericolo incombente» e non aver evacuato preventivamente l'edificio. Un caso
umano, che ha spinto anche una richiesta di grazia e si è presto tramutato in
servizi sociali per Bearzi. Tutti assolti in Cassazione invece per uno dei
crolli più letali, quello dell'edificio di via XX Settembre, che provocò nove
vittime. Bearzi non è l'unico caso umano tra i condannati. Ci sono anche un
80enne e un 84enne, accusati di aver conferito l'incarico di direttore dei
lavori di restauro di un palazzo nel quartiere di Pettino a un geometra anziché
a un ingegnere: quattro anni di carcere, nonostante il palazzo abbia retto al
sisma dando modo a tutti gli inquilini di salvarsi e sia crollato solo dopo nove
giorni. Ed è stato invece prosciolto il geometra. Ci sono poi tecnici che hanno
dovuto combattere anni in tribunale. Come l'ingegner Diego De Angelis. Fu
processato per il crollo di un palazzo di cui aveva curato gratis il restauro
del tetto. Era il condominio in cui viveva e in quel disastro morì la figlia
Jenny. Sette anni con il tormento per la perdita e per le accuse infamanti per
poi essere assolto in Cassazione. «In una città come L'Aquila, con un sisma così
forte molti crolli erano inevitabili - dice Gianluca Racano, avvocato aquilano
che ha seguito alcuni processi - ma concentrare tutte le energie sulla caccia al
colpevole è fuorviante, il problema della cultura anti sismica è politico».
Nordio, il pm contro: "Trovare i colpevoli? Una
caccia alle streghe". "La nostra società non ammette l'imponderabile, non sarà
facile dimostrare chi e se ha sbagliato", scrive Stefano Zurlo, Mercoledì
31/08/2016, su "Il Giornale". La caccia alle streghe non gli è mai piaciuta e la
rotta non cambia nemmeno oggi. Anche se ci sono i morti, i crolli, le rovine.
«Dopo il terremoto - dice Carlo Nordio - si è scatenata una corsa spasmodica
alla ricerca del colpevole, si additano presunti responsabili di qua e di là, ma
questo meccanismo mi lascia perplesso. Mi pare che la società contemporanea,
laicizzata, cerchi il capro espiatorio per superare tragedie che altrimenti
sarebbero insuperabili, con il loro carico di morte e di dolore». Va
controcorrente anche questa volta il procuratore aggiunto di Venezia, uno dei
magistrati più famosi d'Italia, prima con un editoriale per il Messaggero, poi
con questa intervista al Giornale.
Dottor Nordio, che cosa non la convince?
«Viviamo in un mondo che non accetta più il lutto,
il cataclisma, il terremoto che ci annichilisce e annulla le nostre presunte
certezze. Un mondo che ha perso il senso del sacro».
Certo, ma qui parliamo di costruzioni
inadeguate, di ritardi, di soldi mal spesi o dimenticati.
«Un attimo, questo viene dopo».
E prima cosa c'e?
«Se la società non ammette più che ci sia qualcosa
che sfugge al proprio controllo, allora subito dopo il disastro parte la caccia
al colpevole. Per forza. A prescindere».
Scusi ma l'Italia è piena di tecnici che hanno
chiuso gli occhi e di collaudatori che hanno certificato ristrutturazioni che
gridavano vendetta.
«Non sono nato ieri e faccio di mestiere il
pubblico ministero, ma segnalo un modo di ragionare che secondo me è distorto.
Si parte in automatico alla ricerca del colpevole e, siccome siamo in Italia e
tutto viene giurisdizionalizzato, il colpevole diventa imputato a furor di
popolo e va alla sbarra. Mi pare che in questi giorni si stia assistendo allo
stesso fenomeno».
Guardi che sono stati i suoi colleghi a
denunciare anomalie, stranezze, incongruenze. Dovrebbero forse fingere che tutto
è stato fatto a regola d'arte?
«Ovviamente no, ma ci vuole cautela, non si può
procedere impulsivamente, sulla base di sentimenti e risentimenti».
Si faranno indagini e verifiche e alla fine chi
non ha rispettato la legge sarà punito. Non è giusto che sia così?
«Si, purché si sappia che sarà molto difficile
dimostrare le colpe che tutti oggi danno per sicure».
Perché?
«Perché non è affatto semplice arrivare a una
condanna per omicidio colposo o per disastro colposo, il reato classico del
terremoto. Attenzione: nel processo non basta stabilire che i lavori siano stati
fatti male, no si deve dimostrare che se fossero stati eseguiti nel migliore dei
modi quella casa oggi non sarebbe in macerie, quel campanile non sarebbe venuto
giù, quella chiesa sarebbe ancora al suo posto. Capisce?»
Non si può andare avanti per slogan o tesi
semplicistiche?
«L'Italia è un Paese complesso, parliamo di un
patrimonio che ha centinaia di anni, parliamo di beni che hanno avuto una vita
lunga e travagliata, parliamo di opere con vincoli di ogni tipo. Naturalmente
per gli edifici costruiti negli ultimi anni il discorso è più facile, ma molte
abitazioni sono il risultato finale di interventi spalmati nel tempo».
Il paragone con il Giappone non regge?
«Non sono mai stato in Giappone ma mi pare che i
nostri borghi e le nostre città abbiano una fisionomia assai diversa dalla
loro».
L'indignazione di oggi lascerà il posto ad
un'interminabile guerra di perizie?
«È un rischio concreto: perizie e controperizie in
un estenuante duello fra le parti. Con un ulteriore problematica: se scopriamo
che i privati per risparmiare non hanno effettuato le migliorie previste che
facciamo, mettiamo sotto inchiesta le famiglie dei morti?».
D'accordo, ma l'Italia è il Paese delle
tangenti, delle abitazioni realizzate più con la sabbia che con il cemento,
dello scandalo dell'Irpinia. Vuole forse passare con la spugna su decenni di
ruberie?
«No, dobbiamo perseguire la tangente, il falso,
l'abuso, ma il disastro colposo non ammette scorciatoie. E poi dobbiamo metterci
in testa che nel codice penale non esiste l'imponderabile, anche se nel nostro
Paese sono stati processati perfino i professori che non avevano previsto,
poveretti, il terremoto dell'Aquila».
PARLIAMO DI RIFIUTI.
Rifiuti in viaggio nell'estate del caos:
il Sud li esporta, il nord ci guadagna. L'inchiesta di
Paolo Griseri del 26 luglio 2016 su “La Repubblica”. Nel Mezzogiorno gli
impianti scarseggiano e l'immondizia emigra a spese dei cittadini. Alle 8 del
mattino del 7 gennaio 2012, al molo 44 del porto di Napoli l'attracco della nave
olandese Nordstream portò sollievo all'intera città. La nave avrebbe infatti
trasportato all'inceneritore di Rotterdam qualcosa come 250mila tonnellate di
rifiuti così liberando l'area vesuviana da un'emergenza che durava da anni. Ma a
che prezzo? Le indiscrezioni dell'epoca parlarono di 100 euro a tonnellata. In
tutto un contratto da 25 milioni tra l'amministrazione comunale e la società
olandese. Molti gridarono al successo: i 100 euro erano quasi la metà dei 173 a
tonnellata pagati all'epoca per trasferire la stessa immondizia in Emilia o in
Puglia. Il turismo dei rifiuti, da allora, non si è certo fermato ed è un ottimo
indicatore per misurare il tasso di inefficienza e di populismo della classe
politica italiana. Risale ad appena due settimane fa un accordo tra le Regioni
Puglia ed Emilia Romagna per portare da Sud a Nord 20mila tonnellate di rifiuti
al costo di 192 euro a tonnellata. Di quel costo, 60 euro sono per il trasporto,
118 andranno agli inceneritori di Bologna e Ferrara che smaltiranno il rifiuto e
altri 14 euro a tonnellata saranno destinati ai due Comuni che ospitano gli
impianti. Che cosa giustifica i lunghi viaggi dei rifiuti attraverso l'Italia? E
chi ci guadagna? I casi più recenti sono quelli di Puglia e Sicilia. In ambedue
le Regioni la chiusura di discariche, private delle autorizzazioni necessarie
per problemi ambientali, ha fatto crescere il livello di allarme. "Non farò la
fine di Bassolino", ha promesso il governatore pugliese, Michele Emiliano,
evocando proprio l'emergenza rifiuti a Napoli nei primi anni Duemila. Se
l'Emilia accoglierà (e si farà pagare) i rifiuti pugliesi, Toscana e Piemonte
sono i candidati più probabili per trattare quelli siciliani. Filippo
Brandolini, romagnolo, presidente nazionale di Federambiente, l'associazione
delle società che trattano i rifiuti, spiega che "in generale i problemi sono
legati al fatto che nel Sud gli impianti di smaltimento sono meno numerosi che
al Nord". "Basta molto poco - aggiunge - perché il sistema vada in crisi. La
scarsità di impianti è legata al fatto che spesso le amministrazioni locali
preferiscono portare altrove i rifiuti, pagando, piuttosto che affrontare le
proteste dei cittadini per la realizzazione degli impianti di smaltimento.
L'emergenza maggiore oggi è quella dei rifiuti organici che derivano dalla
raccolta differenziata. Un recente inconveniente proprio a un impianto pugliese
ha finito per mettere in difficoltà l'intera rete italiana". Ormai, sottolinea
Federambiente, dei trenta milioni di tonnellate di rifiuti che ogni anno produce
in media la Penisola, la parte maggiore, 13,5 milioni, proviene dalla raccolta
differenziata. Dodici milioni di tonnellate finiscono invece in discarica. Gli
inceneritori bruciano circa 5 milioni di tonnellate. Sono infine 300mila le
tonnellate che ogni anno finiscono all'estero, anche partendo da Regioni del
Nord: "Si tratta di un residuo secco che viene ridotto in coriandoli e diventa
combustibile", spiega Brandolini. Il sistema italiano è particolarmente
frammentato. La raccolta e lo smaltimento sono affidati a 463 aziende sul
territorio nazionale, ma a queste vanno aggiunti circa 1.000 Comuni che
smaltiscono in proprio, su terreni talvolta demaniali ma spesso di proprietà di
privati. La frammentazione è molto spinta, al punto che il 4 per cento delle 463
aziende realizza il 40 per cento del fatturato del settore. Uno dei risultati
della grande dispersione di aziende, anche qui soprattutto al Sud, è l'aumento
dei costi a carico dei cittadini. Non solo perché gli oneri industriali
aumentano, ma anche perché aziende con limitata capacità di trattamento
finiscono per conferire nelle discariche o creare le condizioni per dover
trasferire altrove i rifiuti, con un ulteriore aumento della spesa. Senza
considerare l'effetto ricatto di quei privati che, proprietari di un terreno in
un piccolo Comune, possono proporre tariffe fuori mercato sapendo che
l'amministrazione non ha alternative. Così, nel 2015, la spesa media italiana
per i rifiuti in una famiglia di tre persone che vive in un appartamento di 80
metri quadrati è stata di 271 euro. Ma si tratta di una media. Perché la stessa
famiglia al Nord ha speso 239 euro, al Centro 279 e al Sud addirittura 317. La
strada per abbattere i costi dovrebbe essere quella della concentrazione delle
aziende e di una migliore distribuzione geografica degli impianti alternativi
alle discariche. Secondo i dati del rapporto Ispra, nel 2014, dei 44
inceneritori italiani, 29 erano al Nord, otto al centro e sette al Sud. Insomma,
tutto fa pensare che il "turismo dei rifiuti" sia destinato a proseguire anche
negli anni a venire.
LE TERRE DEI FUOCHI. “L’Italia è una
terra dei fuochi”. Lo rivela l’Istituto Superiore della Sanità. Ma
l’informazione balbetta, scrive Marco Mastrandrea su
"Articolo 21" il 13 gennaio 2016. «’O vogl’ squartat viv’», «‘o giurnalist’ je a
spacc a cap’», «ve ne dovete andare». Sono solo alcune delle parole dei
camorristi che hanno minacciato e aggredito fisicamente diversi giornalisti che
hanno solo svolto il proprio mestiere nella Terra dei Fuochi. Nello Trocchia,
Marilena Natale, Sandro Ruotolo, per fare qualche nome. Ed è proprio Ruotolo che
attualmente vive sotto scorta dopo le minacce di Michele Zagaria, numero uno del
clan dei Casalesi, a scrivere dal proprio profilo facebook: con la pubblicazione
dell’11 gennaio a cura dell’Istituto Superiore di Sanità emerge «il più grande
atto di accusa contro lo Stato, lo si aspettava da 20 anni, ora è arrivato:
l’Italia è una terra dei fuochi». Il rapporto dell’ISS giudica «in eccesso
rispetto alla media regionale» il tasso di mortalità, ricoveri e tumori
nell’area. L’allarme drammatico riguarda anche i bambini: «si osservano eccessi
di bambini ricoverati nel primo anno di vita per tutti i tumori e eccessi di
tumori del sistema nervoso centrale, questi ultimi anche nella fascia 0-14
anni». Dopo tante difficoltà e tante battaglie condotte da giornalisti,
studiosi, comitati e società civile finalmente una notizia che determina la
gravità in cui versa un’area dove è presente un’importante fetta della
popolazione campana. Ma se alcuni si sono sacrificati per raccontare una terra
in difficoltà e soggiogata alla camorra, i quotidiani del 12 gennaio non
sembrano ritenere i dati del rapporto ISS un caso grave, al punto tale da
compiere una scelta editoriale di rilievo. Per “Il Mattino”, storico quotidiano
partenopeo, la notizia va collocata nella sezione locale e solamente dopo il
dibattito attorno alle comunali 2016 e la “festa dall’avvocato al barista” in
doppia pagina sul Napoli, infatti, la squadra di calcio ha vinto il cosiddetto
“campionato d’inverno”. E pensare che gli ultimi giorni del 2015 “Il Mattino”
aveva rivelato con un’inchiesta di Gigi Di Fiore in parte le cifre contenute nel
rapporto dell’ISS. Per il “Corriere della Sera” la notizia va posta nella
sezione cronache a pagina 22 e dedica un minibox nella parte inferiore della
prima pagina; la vicenda non viene menzionata affatto dalla prossima quarantenne
“La Repubblica”. “Il Tempo” si arrischia con il titolo ad effetto: “La Terra dei
Fuochi rom: 2000 roghi”, un’inchiesta in cui dall’area campana si fa un balzo
nella Capitale con tanto di mappa corredata. Il lavoro del quotidiano si
concentra su “la Terra dei Fuochi de’ noantri” con il dito puntato nei confronti
della situazione “esplosiva nei campi rom”: appena citata la vicenda campana che
funge da allaccio per l’inchiesta romana. D’altra parte, le parole di Sandro
Ruotolo spingono ad approfondire il lavoro giornalistico e l’impegno di tutti
attorno alla vicenda come necessità da cogliere in quanto sfida quotidiana non
solo per chi abita queste terre: «Sono incazzato nero e tutto questo non lo
accetterò più. Non sono Howard Beale del Quinto potere. E non sono uno
scienziato. Ma un giornalista che ha raccontato la terra dei fuochi. Accusato di
aver “esagerato”, di essere un catastrofista. Il rapporto dell’istituto
superiore della sanità è una pessima notizia per tutti, perché purtroppo
certifica quello che tutti sapevano e che in tanti hanno finta di non sapere. La
terra dei fuochi è diventata la terra dei morti per avvelenamento. Noi che siamo
vivi non lo possiamo sopportare più».
Il poliziotto comunista che ha scoperto
la terra dei fuochi. Roberto Mancini è l'investigatore
che per primo si è messo sulle tracce dei veleni sversati in terra di Gomorra.
"Io morto per dovere" è il libro in uscita la prossima settimana che racconta la
sua storia: dal collettivo comunista alle informative in cui descriveva il
sistema camorra- massoneria- politica che ha ucciso un'intera regione. Fino alla
sua morte, stroncato da un tumore contratto durante i sopralluoghi sui terreni
colmi di veleni, scrive Giovanni Tizian il 5 febbraio 2016 su “L’Espresso”.
Dalla barricate degli anni '70 alla trincea della terra dei fuochi. Sempre in
prima linea. Sempre a sinistra e per la giustizia sociale. Nel collettivo
studentesco del liceo Augusto di Roma all'alba degli anni di piombo, e poi
poliziotto col Manifesto sotto braccio. Con o senza divisa, Roberto Mancini non
ha mai abdicato ai suoi ideali. A 17 anni lottando con i “compagni” per una
società più giusta, a 20, con il tesserino da sbirro, indagando sui crimini più
squallidi. Il poliziotto Mancini non è un eroe. Negli ultimi anni della sua vita
ha tentato in tutti i modi di sfuggire a questa etichetta. Lui sapeva bene che
gli eroi servono a pulire la coscienza di chi non si sporca le mani. È comodo
indicare l'eroe e poi starsene sul divano a guardare le imprese dei tanti
paladini che salveranno questo mondo. Mancini è stato il primo poliziotto a
investigare sui rifiuti tossici. Le sue indagini hanno anticipato di quasi due
decenni la scoperta del disastro ambientale in alcune zone della Campania, la
cosiddetta Terra dei fuochi. Quando era nella Criminalpol, a metà degli anni
Novanta, Mancini ha smascherato la connivenza tra imprenditoria e camorra; tra
politica, massoneria e bassa manovalanza criminale. Il risultato della sua
inchiesta è scritto nero su bianco in un’informativa che, per qualche
sconosciuto motivo, è rimasta chiusa in un cassetto per più di dieci anni.
Mancini ha completato quel documento ormai storico senza mai curarsi dei rischi
che correva. «Voglio credere che allora non fossero ancora maturi i tempi e
l’opinione pubblica non fosse pronta» ha detto il poliziotto poco prima di
morire commentando il fatto che le sue indagini fino a quel momento fossero
state ignorate. I suoi sopralluoghi sui terreni inquinati e l'aria avvelenata
respirata durante l'inchiesta sono stati la causa della malattia che lo ha
ucciso lentamente. La storia di Roberto adesso è un libro dal titolo "Io, morto
per dovere" in uscita il 12 febbraio. Scritto dai giornalistiLuca Ferrari e
Nello Trocchia, edito da Chiarelettere, con la prefazione di Beppe Fiorello e la
postfazione della moglie Monika Dobrowolska Mancini. La vita del poliziotto che
scoprì la terra dei fuochi sarà anche un fiction (in onda il 15 e il 16 febbraio
su Rai Uno), e sarà proprio Fiorello a interpretare Mancini. Il libro è un
racconto intimo della gioventù di Roberto. Gli scontri coi fascisti e le
sassaiole negli anni caldi delle rivolte, il sogno della rivoluzione, la
vicinanza a Democrazia proletaria, la ferma condanna della lotta armata. E
infine, quando il sogno di un mondo migliore era ormai stato distrutto dal
piombo dei terroristi rossi e neri e dal compromesso storico, la scelta di
entrare in polizia, «perché bisogna provare a cambiare il sistema dall'interno»,
tenendo sempre ben distinte la parola legalità dal concetto di giustizia
sociale, che non sempre coincide con la prima. Frammenti di vita, speranze e
illusioni, che gli autori riportano fedelmente facendo parlare i testimoni di
quel periodo e gli amici più cari di Mancini. La prima parte del libro è un
flusso di emozioni. La passione politica e l'impegno che pagina dopo pagina si
trasformano in delusione per come evolve la società, stretta tra violenza e
ingiustizia sociale. Ma “Io morto per dovere” è soprattutto un focus sul lavoro
del poliziotto comunista. Le sue inchieste, le sue informative, i suoi rapporti
inediti inviati alla procura antimafia di Napoli. Nomi, cognomi, affaristi dei
rifiuti, massoni, politici complici che negli anni sono stati promossi a
incarichi di prestigio. Un buco nero della democrazia dove regna il malaffare.
Tutto questo, Roberto, l'aveva scritto prima di tutti gli altri detective.
L'aveva intuito e indagato. L'informativa più importante di tutte è quella dei
primi anni '90. Lì, tra quelle pagine intestate Criminalpol, c'era già tutto il
sistema svelato dalle inchieste del 2000. Gomorra, Mancini, l'aveva conosciuta e
raccontata due decenni fa. Ma nessuno lo ascoltò. Fino a quando un magistrato di
Napoli non ha alzato il telefono e lo ha chiamato nel suo piccolo ufficio del
commissariato di San Lorenzo. La richiesta del pm è semplice: gli chiede di
sbobinare tutte quelle telefonate della sua vecchissima informativa perché gli
servono nel processo contro Cipriano Chianese, l'inventore dell'ecomafia, il
broker dei veleni, ora sotto accusa per disastro ambientale. Finalmente,
l'impegno di Mancini viene riconosciuto. Chianese ha lavorato indisturbato fino
ai primi anni del Duemila. Nelle discariche gestite da Chianese sono finite le
schifezze d'Italia. Rifiuti industriali delle aziende del Nord. E rifiuti
“legali” con l'autorizzazione dello Stato. Eppure, quel Chianese è lo stesso che
Mancini descriveva, già nel '90, come un pezzo grosso del business illegale
della “monnezza”. Quando era un avvocato, di Forza Italia, candidato al
Parlamento. A metà tra massoneria, camorra e politica. Una cerniera tra tre
mondi, i cui interessi stavano avvelenando una terra bellissima e fertilissima.
Se solo quel documento eccezionale fosse stato considerato nella sua importanza
probabilmente quei territori non sarebbero stati uccisi. Ormai è tardi per
impedirlo. L'omicidio ambientale è compiuto. Roberto Mancini è morto di tumore.
I complici insospettabili del clan dei rifiuti hanno fatto carriera. Ma non
tutto è finito, non tutto è perso. C'è ancora una speranza per Roberto. È
nell'opera di verità che sta cercando di compiere il pool antimafia della
procura di Napoli. Il magistrato Alessandro Milita rappresenta l'accusa contro
Chianese. In quel processo i rapporti firmati Mancini stanno giocando un ruolo
decisivo. Dà fastidio alla camorra anche da morto. E in fondo, il compagno
Roberto è contento così.
La fondina a destra e «il Manifesto»
sotto braccio. Pubblichiamo un capitolo tratto dal
libro 'Io, morto per dovere' di Luca Ferrari e Nello Trocchia, sulla storia del
poliziotto Roberto Mancini. La storia è diventata anche una fiction,
interpretata da Giuseppe Fiorello, in onda su Raiuno il 15 e il 16 febbraio,
scrive il 5 febbraio 2016 “L’Espresso”. In libreria dal 12 febbraio per
Chiarelettere il libro "Io morto per dovere, la vera storia di Roberto Mancini,
il poliziotto che ha scoperto la Terra dei fuochi" di Luca Ferrari, Nello
Trocchia con Monika Dobrowolska Mancini. La storia è diventata anche una fiction
per la televisione, interpretata da Giuseppe Fiorello, che sarà trasmessa su
Raiuno il 15 e il 16 febbraio. Quando Roberto parte per Trieste per seguire un
corso di sei mesi, mamma Giovanna alla stazione Termini lo stringe in un forte
abbraccio. Non una lacrima di fronte a lui, ma a casa afferra i panni del
ragazzo, li annusa, se li passa sul viso e scoppia in un pianto dirotto. «Robe’,
sei nato per farmi soffrire» ripeterà per giorni nella sua solitudine. Un nuovo
cambiamento radicale, l’arruolamento in polizia dopo gli anni del liceo vissuti
con la paura costante guardando in tv gli scontri di piazza e pregando perché il
figlio «ribelle», come lo chiamava una delle sue docenti, tornasse a casa sano e
salvo. E pensare che poco dopo sarebbe arrivata anche l’assunzione da parte
delle Ferrovie dello Stato, ma Roberto ha fatto ormai la sua scelta definitiva:
sarà uno sbirro in prima linea e non un capotreno. In quel periodo Mancini tiene
un fitto carteggio con Gianni Angelici e la corrispondenza con l’amico scolpisce
il suo stato d’animo. «Il mio allontanamento altro non è stato che il “frutto
dei tempi”, non trovarsi più a proprio agio nell’ambiente nel quale sono
cresciuto, in cui ho passato i momenti più belli e divertenti nonché i più
tristi. Ho condiviso con tutti voi i miei pensieri, i miei stati d’animo di
persona triste, ma a un certo momento mi sono reso conto che quelle cose erano
ormai superate, storicamente determinate, e che era inutile continuare a vivere
situazioni ormai passate, che era futile impegnarsi per ricercare episodi e
momenti che, a loro tempo, avevano suscitato emozioni originalissime, ma che ora
risultano assiduamente patetiche e nostalgiche.» E ancora: «La tristezza sale
sempre più, il senso di nullità pervade tutto il mio essere». Roberto rimugina i
pensieri mentre li scrive, quel cambiamento in atto lo sta mettendo senz’altro a
dura prova: «Sono privo di qualunque certezza. Mi aiuterebbe molto in questo
momento, e anche in altri, averti vicino per cercare di capirci fino al limite
del possibile. [...] Erro misero e solo». Al giuramento la famiglia arriva al
completo. La madre lo ritrova, fiero, dopo pochi mesi, nella sua divisa di
ordinanza. C’è anche lo zio Betto, quello che era stato pestato dai neri, che si
guarda intorno attonito e che mai avrebbe immaginato di trovarsi in quel luogo
ad applaudire, orgoglioso, il nipote comunista e guardia. Di lì a poco Roberto
sarebbe diventato il più giovane viceispettore di polizia d’Italia. Tornerà
presto a Roma, al ministero dell’Interno. Come al solito testardo, capace. Sarà
lui stesso, sul letto d’ospedale, poco prima di morire, a enfatizzare lo spirito
che l’ha sempre contraddistinto, scrivendo: «L’essere quel che sono mi ha
penalizzato. La professionalità dovrebbe essere l’unico elemento di giudizio,
dovrebbe essere sempre presente nella valutazione delle capacità di un
investigatore. E invece no! È obbligatorio obbedire agli ordini superiori al di
là di ogni logica, al di là di ogni buon senso e così la carriera è assicurata».
E ancora: «Per fare carriera devi essere quel che non sei. Devi uniformarti al
comportamento della massa. Non devi discutere le decisioni dei superiori.
Soprattutto non devi dimostrare che ne sai di più di chi deve decidere!». Sono
queste le regole per avere successo in polizia, ma Roberto non si piega e
qualcuno nell’ambiente non gli perdona il suo odio per la neutralità. «Il
manifesto» sotto braccio procura la reazione di alcuni colleghi: «Ci siamo messi
il nemico in casa» è la frase che serpeggia nei corridoi, e Roberto finisce a
mettere in ordine le auto di servizio nella rimessa. All’Ucigos – l’Ufficio
centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali – dura
poco: quello strazio, quell’ordine rarefatto, quella disciplina finta,
quell’imposizione, quella boria, quel retaggio fascista non fanno per lui.
Roberto parte di nuovo, inizia il suo giro per l’Italia, passerà diversi anni
tra la Toscana e l’Umbria. Ogni città amori e sogni, divisa e conflitti. Tornerà
a Roma alla Criminalpol per iniziare a occuparsi di crimine organizzato, siamo a
metà degli anni Ottanta. Quell’esperienza lo porterà a indagare poco dopo
sull’organigramma imprenditoriale, affaristico e politico che ha saccheggiato
risorse pubbliche e devastato territori.
Tra roghi e indifferenza la Terra dei
Fuochi continua a bruciare, scrive Marco Cesario il 3
Agosto 2015 su “L’Inkiesta”. Napoli. Il viaggio nella Terra dei Fuochi comincia
quasi sempre qui, lungo una tetra strada che serpeggia tra caseggiati, pescheti
e campi coltivati che s'estendono a perdita d'occhio. L’asse mediano è una
strada a scorrimento veloce che collega Napoli e i comuni dell'hinterland
partenopeo ai paesi del casertano. Basta percorrerne pochi chilometri per essere
investiti dal lezzo acre e pungente dei roghi che spuntano qua e là nel
territorio appestando l’aria di chi ci vive. Le rare piazzole di sosta che
costeggiano la strada sono trasformate in improvvisate discariche a cielo
aperto. Giuseppe Ruggiero, dirigente campano di Legambiente, fu il primo nel
2003 a coniare il termine “Terra dei Fuochi” in riferimento ai roghi di
pneumatici e di materiali tossici che tempestavano la zona. Oggi come allora
niente è cambiato e l’aria continua ad essere irrespirabile. Ogni giorno decine
di segnalazioni vengono raccolte sulla pagina Facebook “La Terra dei Fuochi”
mentre i riflettori su queste terre si sono quasi spenti, salvo riaccendersi
improvvisamente quanto si torna a parlare di tumori che colpiscono gli abitanti
della zona. Percorrendo questa strada, viene improvvisamente in mente quanto
nota Alessandro Iacuelli nel suo libro-inchiesta “Le vie infinite dei rifiuti”.
C'è stata una vera e propria mutazione del registro dello smaltimento dei
rifiuti tossici. La tecnica di smaltimento con grossi camion e ruspe all’interno
di cave abusive o laghi artificiali, dopo le decine di inchieste della
magistratura, le dichiarazioni dei pentiti e i successivi scavi, è stata oramai
accantonata e rimpiazzata da una nuova tecnica, più leggera ma ugualmente nociva
perché costante. Il “piccolo smaltimento”. Piccoli furgoni o motocarri con fusti
che vengono lasciati in un posto e poi bruciati con una tecnica rudimentale ma
molto efficace: una base di pneumatici fuori uso sui quali vengono deposti i
rifiuti tossici ricoperti di benzina. Spesso ad appiccare questi roghi sono
poveri diavoli che non sono altro che l’ultima catena del processo. I roghi
sprigionano alte colonne di fumo nero e altamente tossico. Ecco cosa rende
l’aria qui completamente irrespirabile. I fusti vengono bruciati con una tecnica
rudimentale ma molto efficace: una base di pneumatici fuori uso sui quali
vengono deposti i rifiuti tossici ricoperti di benzina. A Frattamaggiore, Luigi
Costanzo è medico di famiglia ISDE Napoli, e fa parte di una rete di medici che
lavora per la creazione di un registro tumori del territorio. «Io sono medico di
famiglia – spiega a L’Inkiesta Costanzo - e ho circa 1600 assistiti. Il medico
di famiglia è quello che tocca con mano le realtà del territorio e conosce da
vicino le patologie che ne colpiscono gli abitanti. Con altri colleghi abbiano
cercato di raccogliere dei dati che noi come medici di famiglia abbiano nei
nostri database. In questi database è già presente un piccolo registro tumori.
Se incrociamo i dati di tutti i medici di famiglia del territorio possiamo, a
tempo zero e a costo zero, effettuare una fotografia del territorio. Un progetto
del genere è stato fatto a Casoria e si chiama EPI.CA (EPIdemiologia
CAncro ndr). Sia i pediatri sia i medici di famiglia hanno estrapolato dei dati
ed hanno dimostrato che c’è un aumento d’incidenza di tumori nel territorio dove
questi medici di famiglia esercitano la propria professione. Io, per quanto
riguarda la mia esperienza, ho assistito ad un aumento di patologie tumorali che
colpiscono soprattutto giovani. Nello specifico per quanto riguarda il tumore
alla mammella, su 1600 pazienti, ho cinque donne che sono al di sotto dell’età
dello screening della mammella, che è i 45 anni, affette da patologie tumorali.
Oltre a questo però, possiamo anche agire ad un secondo livello, ovvero quello
della geo-localizzazione. Conoscendo dove abitano i pazienti possiamo anche
geo-localizzare la malattia ovvero sapere se in una determinata area c’è una
concentrazione maggiore di patologie rispetto ad un’altra. È un’operazione
importante perché in quelle aree in cui ci sono picchi di malattia possiamo
stabilire se è stato commesso anche qualche delitto ambientale e lasciare in
seguito gli scienziati e gli epidemiologi studiare i nostri dati grezzi e
stabilire il nesso e l’impatto sulla salute umana. In attesa del famoso registro
tumori dunque possiamo già fornire delle prime risposte a quelli che sono i
problemi che attanagliano il nostro territorio». Luigi Costanza è un medico di
famiglia: «Per quanto riguarda la mia esperienza, ho assistito ad un aumento di
patologie tumorali che colpiscono soprattutto giovani». Era il lontano 1991
quando un certo Mario Tamburino, camionista italo-argentino, correva in ospedale
a Pozzuoli per un improvviso bruciore agli occhi che gl’impediva anche di
vedere. Di li a poco sarebbe diventato completamente cieco. Quel bruciore era
provocato da gocce di una sostanza corrosiva fuoriuscita dai fusti tossici (ben
571) che lui stesso aveva caricato a Cuneo, in Piemonte, presso un’azienda
specializzata nello smaltimento di rifiuti pericolosi, e aveva scaricato in una
fossa nelle campagne di Sant’Anastasia, a Nord di Napoli. Dall’inchiesta che ne
scaturì nacque la parola “ecomafia” e si palesò un business di miliardi tra
l’imprenditoria del Nord Italia e la classe politica campana. Due anni prima,
nell’albergo ristorante ‘La Lanterna’ di Villaricca, un conciliabolo di
politici, camorristi, mafiosi, esponenti della Loggia Massonica P2 e servizi
deviati stringevano un patto diabolico per sotterrare nella Campania Felix
milioni di tonnellate di rifiuti tossici. Ma gli scavi sarebbero iniziati molto
tempo dopo grazie anche ad un metodo innovativo. A raccontare i passi salienti
che hanno portato ai primi scavi è Sergio Costa, generale e comandante Regionale
in Campania del Corpo Forestale dello Stato. «È accaduto circa quattro anni fa –
dice a L’Inkiesta - quando io sono stato nominato Comandante provinciale di
Napoli del Corpo Forestale dello Stato. Essendo considerato un esperto di
investigazioni antimafia ambientali, ho iniziato, con quella nomina, a studiare
fascicoli, a raccogliere dati e a elaborare un metodo investigativo innovativo:
ho messo in relazione tutte le ortofotogrammetrie, le foto aeree degli ultimi
vent’anni, le banche dati italiane, le ho raffrontate con ogni singola zona
della superficie della Campania, soprattutto le zone di Napoli e Caserta, ed ho
avuto l’idea di incrociarle con lo studio dei campi magnetici della crosta
terrestre. Mettendo insieme foto in cui è palese che ci sono stati determinati
movimenti e dati che dicono che non c’è un campo magnetico normale ma c’è
qualcosa di anomalo ho tratto certe conclusioni. In più c’è stata l’attività di
polizia info-investigativa (testimoni, denunce, prove sul territorio). Mettendo
insieme tutti questi elementi e grazie anche alla creazione di un’équipe di
esperti siamo riusciti a convincere il giudice ad effettuare il sequestro ed il
successivo scavo. Col tempo abbiamo individuato le discariche di Caivano, Casal
di Principe, Castel Volturno, Villa Literno, fino a quest’ultima recentissima di
Calvi Risorta che potrebbe essere forse la più grande d’Europa (è grande circa
25 ettari). Finora abbiamo disseppellito circa 5 milioni di metri cubi di
rifiuti tossici ma questo potrebbe essere solo il 25% del totale. Il resto è
ancora da disseppellire». E i roghi quotidiani? «I roghi - spiega il generale
Costa - dal punto di vista criminale, hanno la stessa matrice delle discariche
abusive. Si tratta di rifiuti che attività in nero in regime di evasione fiscale
ed evasione contributiva smaltiscono, seppelliscono o accatastano e bruciano. Si
tratta di aziende che producono in nero e dunque smaltiscono in nero. Se non si
aggrediscono queste aziende non si possono ottenere risultati di nota».
Come se non bastassero le tonnellate di rifiuti
tossici seppelliti in queste terre oggi il ‘biocidio’ continua dunque sotto
forma di roghi, che proliferano a tutte le ore del giorno e della notte, come
ricorda l'attivista Vincenzo Petrella dei Volontari Antiroghi di Acerra. «Noi
siamo un gruppo di volontari che nasce dalla necessità di dare un freno a tutti
questi roghi appiccati a tutte le ore del giorno – spiega Vincenzo – e
soprattutto la sera e a notte inoltrata. Giriamo la sera dalle 23 in poi facendo
il giro di tutta la periferia a caccia di roghi appiccati, soprattutto in quelle
campagne isolate dove potrebbero bruciare per tutta la notte e nessuno se ne
accorgerebbe. Noi segnaliamo subito i roghi alle autorità e aspettiamo l'arrivo
dei vigili del fuoco. Ma teniamo sott'occhio anche gli sversamenti». Enzo Tosti
è un attivista che conosce molto bene le zone e fa parte del Coordinamento
Comitati Fuochi. Davanti alla chiesa di Caivano, dove padre Maurizio
Patriciello, simbolo della battaglia per la rinascita di un territorio inquinato
dai rifiuti versati, s’appresta ad accompagnare un gruppo di missionari nella
zona della discarica Resit di Giugliano, spiega: «Quando Legambiente parlò per
la prima volta di Terra dei Fuochi parlava di un’area molto circoscritta, ovvero
del cosiddetto triangolo della morte tra Nola e Marigliano. Oggi dobbiamo
renderci conto che l’area non è soltanto circoscritta a quel triangolo ma è
molto più vasta. Partiva da quelle zone per arrivare all’agro aversano e fino al
litorale domizio, ovvero un’area che interessa milioni di abitanti. La zona è
stata declassata da SIN (sito d’interesse nazionale) a SIR (sito d’interesse
regionale) ma non perché la situazione sia migliorata ma perché lo stato se n’è
voluto semplicemente lavare le mani. La Campania è soltanto la punta di un
iceberg che evidenzia un sistema produttivo italiano ed internazionale non
sostenibile e che non tiene conto né della vita umana né dell’ambiente. Il rogo
poi non ha una matrice diversa da quella del seppellimento dei rifiuti tossici
ed è strumentale ad un indotto industriale che lavora localmente al nero.
Parliamo dell’industria tessile e calzaturiera locale collegata con le grandi
griffe nazionali ed internazionali. A che punto siamo oggi? Tutto quello che ha
sbandierato il governo non è servito a nulla perché i roghi continuano. La Terra
dei Fuochi continua a bruciare». «A che punto siamo oggi? Tutto quello che ha
sbandierato il governo non è servito a nulla perché i roghi proseguono. La Terra
dei Fuochi continua a bruciare». Enzo Tosti, padre Maurizio Patriciello ed un
gruppo di missionari si recano dunque in prossimità della discarica Resit. Qui
la camorra ha sversato tonnellate di rifiuti pericolosi. Il 23 luglio scorso un
incendio è divampato all’interno della discarica. Dietro le transenne ancora
s’intravede un cumulo fumante. «È una sorta di autocombustione interna - nota
padre Maurizio Patriciello - Chissà cosa ci hanno seppellito, qui è proprio un
inferno e lo stato ci ha completamente abbandonati. Ricordo quando scoppiò il
problema dei rifiuti in Campania. Ne hanno approfittato per mettere a tacere il
problema più grosso e grave, ovvero quello delle discariche di rifiuti tossici».
Enzo Tosti spiega che quando sei sotto vento e quell’aria ti entra nei polmoni
stai male. «Io ho avuto conati di vomito e sono stato male tutto un pomeriggio
dopo aver respirato quell’aria». È necessario allontanarsi dalle transenne,
troppo pericoloso restare li. Dopo qualche minuto, proprio a fianco alla
discarica, un contadino passa in auto. Si ferma a parlare con il parroco. «Don
Maurizio - dice - qui potete aiutarci solo voi». Fa riferimento non solo alla
discarica fumante che intossica l’aria ma anche a quei prodotti che non sono
inquinati ma che nessuno compra più. Oramai oltre i danni ambientali ci sono
anche quelli collaterali. Anche se i prodotti ortofrutticoli sono controllati e
sani è difficile piazzarli sul mercato. Il vento spinge le esalazioni lontano
eppure l’odore acre è insostenibile. Per evitare spiacevoli conseguenze, il
gruppo si muove poche centinaia di metri più in là per un’altra visita
sorprendente. Attaccato ad un'altra discarica e a poche centinaia di metri da un
sito dove rifiuti pericolosi continuano a bruciare, sorge un campo rom dove
risiedono settanta famiglie (circa trecento persone) di cui duecento bambini. I
bambini giocano tra i rifiuti di una discarica a cielo aperto e respirano a
pieni polmoni le esalazioni della discarica che pure quando il vento soffia in
una certa direzione giungono fino a qui. Difficile non chiedersi come si possa
lasciare vivere dei bambini in mezzo a discariche e esalazioni tossiche. È quasi
come lasciarli in mezzo alle bombe. I missionari abituati a luoghi poveri
d'Africa e del Sudamerica forse non si aspettavano di vedere tanta miseria e
abbandono in un paese “civilizzato” come l'Italia. Uno dei responsabili del
campo racconta che è lo Stato ad averli messi li dopo successivi sgomberi da
altri campi. «Ci hanno messo qui per far morire i nostri bambini di tumore»
protestano. Dopo un po’ il gruppo di missionari viene circondato da un gruppo di
bambine. Sono incuriosite dai nuovi arrivati. Alcune sono bellissime, dagli
occhi verdi ed i capelli arruffati. Altre camminano con i piedi scalzi nella
melma sorridendo. Sguardi speranzosi ed innocenti il cui futuro è più cupo che
mai. Il pensiero va subito ad Anna Magri, che qui, nella Terra dei Fuochi ci ha
perso un figlio, il piccolo Riccardo, di soli ventidue mesi. Coi suoi grandi
occhi verdi che si velano di tristezza nel ripercorrere le tappe di quella
tragedia, Anna racconta la diagnosi, le cure e poi il terribile epilogo. Da
allora, una ricerca continua delle cause e poi l’amara scoperta, quella Terra
dei Fuochi e quelle discariche di rifiuti tossici disseminate ovunque. Dal
dramma però nasce anche l’esigenza di federarsi con altre mamme, altri
cittadini, attivisti per proteggere altre vite innocenti, per scoprire la
verità, per aiutare questa terra martoriata a risorgere. Ultime tappa del
viaggio a Villaricca. Maura Messina è nata qui ed ha solo ventisei anni quando
le diagnosticano un tumore. Ha un’energia contagiosa e gli occhi che sprizzano
una gioia quasi incontenibile. «Da quando sono guarita ogni giorno per me è
Capodanno» dice sorridendo. Basta guardarla negli occhi per crederle. Ma la sua
è stata una battaglia dura, che continua tutt’oggi. Maura racconta le cure, la
paura, la difficoltà di mantenere le amicizie, il sostegno della famiglia e del
ragazzo che l’hanno aiutata ad affrontare questa dura tappa della sua esistenza.
Cosi, decisa a combattere contro il suo personale e terribile nemico, s'imbarca
nella prova più dura e dolorosa della sua vita usando anche i mezzi della
letteratura e del disegno per sopravvivere. Ne nasce così un diario che, con
delicatezza, sensibilità e un tocco d'ironia, racconta per parole e per immagini
la storia di una viaggiatrice in un altro mondo, quello difficile e oscuro della
chemioterapia, da cui deriva il titolo del suo libro “Storia di una kemionauta”
(Homo Scrivens). Non so se è la battaglia contro la malattia ad averla forgiata,
la catarsi della letteratura oppure è proprio la sua natura gioiosa ma
sentendola ridere di gusto tra le mura serene della sua casa è come se la Terra
dei Fuochi tutta intera ridesse. Dei suoi mali, delle sue paure, della sua
insospettabile forza.
Il Sud avvelenato dalla “monnezza di
stato”: un nuovo libro sulla terra dei fuochi. Antonio
Giordano, oncologo e docente alla Temple University di Philadelphia, e il
giornalista Paolo Chiariello firmano un libro che ripercorre la storia dello
scempio che ha portato alla terra dei fuochi tra le provincie di Napoli e
Caserta, tra stato colluso, politica inerte, scienza negazionista e stampa
omertosa, scrive Nunzia Marciano il 22 gennaio 2015 su “La Voce di New York".
Monnezza di stato: è già nel titolo, esplicativo, diretto, duro, drammatico e
paradossale che ben si comprende il lavoro dovizioso che diventa denuncia di
Antonio Giordano, oncologo e direttore dello Sbarro Institute for Cancer
Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia (oltre
che columnist di recente acquisizione de La VOCE di New York), che, a quattro
mani con il giornalista Paolo Chiariello, ripercorre lo scempio che ha portato
alla terra dei fuochi, al disastro tra le provincie di Napoli e Caserta. Le
Terre dei Fuochi nell’Italia dei veleni, questo il sottotitolo del libro con
prefazione a cura di Franco Roberti, procuratore nazionale Antimafia edito dalla
Minerva Edizioni. Le “terre”, perché non c’è solo la Campania, la morte non c’è
solo tra Acerra, Giugliano e Casal di Principe. Il libro va oltre. Scoperchia i
legami fittissimi tra la Camorra senza scrupoli, la politica inerte, lo stato
connivente, la scienza negazionista e la stampa silente. La strada per uscirne
c’è, “la strategia”, ci dice Giordano, “è nelle bonifiche di quei territori e
soprattutto nella prevenzione per la popolazione (3,5 milioni di abitanti, nda)
che vive quelle zone. Cittadini che sono suscettibili a sviluppare patologie in
maniera più elevata rispetto ad altre zone”. Tra gli aspetti clamorosi poi, c’è
l’atteggiamento della scienza “omertoso”, come lo definisce Giordano, su
qualcosa che si sapeva da 40 anni. E neppure la necessità di non creare
allarmismo può giustificare un atteggiamento del genere, poiché, continua
l’oncologo, “l’allarmismo vale se si dicono cose non vere”.
Antonio Giordano: prima la conoscenza, poi la
protesta. Quante sono le terre dei fuochi? L'Italia è tutta avvelenata?
«Nel libro
analizziamo la realtà campana che, grazie all’attività della magistratura, della
stampa, ma anche dei cittadini che si sono riuniti, spontaneamente, in
associazioni, hanno portato alla ribalta un problema che affligge quel
territorio così come altre zone d’Italia e, più in generale, del mondo.
Pensiamo, ad esempio, all’Africa diventata la discarica dei Paesi più
industrializzati, ma anche all’America. È evidente che il business dei rifiuti
tossici è globale e che non conosce confini, tuttavia diversi sono i rimedi. In
Texas, per esempio, sono state effettuate opere di bonifica che hanno
drasticamente ridotto il problema e l’impatto sulla salute dei cittadini. In
Italia troppo poco è stato fatto».
Nel suo libro ha evidenziato i legami
strettissimi tra camorra, politica, imprenditoria e, persino scienza. Legami
strettissimi, dicevamo. Come combatterli se anche la scienza diventa connivente
quando nega l’evidenza?
«Il problema,
come diceva, investe differenti categorie sociali. Questo è il motivo per cui
non mi stanco di profondere il mio impegno all’interno delle scuole e delle
università. La nostra generazione e quella precedente hanno fallito. La speranza
del mondo sono i giovani di oggi».
Nel libro si parla di camorra e di mafia, ma
anche di terrorismo. Qual è la differenza tra questi due tipi di criminalità?
«Sinteticamente
possiamo dire che il terrorismo ha combattuto e combatte lo Stato dall’esterno
mentre la camorra, così come la mafia, ha le sue estensioni e ramificazioni
negli organi dello Stato attraverso referenti insospettabili e di spicco».
Il suo libro è molto divulgativo. Crede che
basti scrivere per diffondere l'informazione? Crede nelle manifestazioni di
piazza, nei cortei, nelle associazioni? È quella la strada da imboccare, quella
della protesta?
«Credo che la
protesta fine a se stessa debba essere definita sterile. La conoscenza dei
problemi, invece, e la conseguente protesta, possono accendere i riflettori
sulla questione ambientale e sconfiggere l’immobilismo in cui ci hanno costretti
a vivere per oltre quarant’anni. Oggi i cittadini vogliono sapere, sono
desiderosi di informarsi e di contare nelle decisioni che riguardano se stessi e
le loro famiglie. Un esempio recente è quello dei cittadini di Ercolano che si
sono stretti intorno al loro parroco, Don Marco Ricci, per raccogliere le firme
e denunciare l’aumento delle patologie tumorali in una zona dove insiste una
discarica di rifiuti tossici. Ecco l’opinione pubblica ha finalmente coscienza
del problema e si unisce per denunciare. Dove i politici non provvedono,
tradendo il mandato che gli hanno conferito gli elettori, si trovano di fronte
alle proteste. È finito il tempo in cui ci si affidava alla classe politico
dirigenziale. Oggi la gente ha capito che deve muoversi in prima persona».
L'America è oramai la sua seconda patria. Ma ci
sono anche lì "terre dei fuochi" o è un fenomeno made in Italy?
«È innegabile
che anche l’America viva il problema dell’inquinamento. La differenza rispetto
all’Italia consiste nella certezza della pena. I colpevoli, una volta assicurati
alla giustizia, pagano anche attraverso importanti risarcimenti ai danneggiati e
alle loro famiglie. Inoltre, la classe politica americana così come quella
amministrativa è più sensibile ed educata alla tutela del territorio. Forse
perché beneficia, da sempre, di un maggiore e più costante ricambio
generazionale».
Nel 1992, ha individuato e clonato il gene
oncosoppressore RB2/p130, che ha una funzione di primaria importanza nel ciclo
cellulare dal momento che controlla la corretta replicazione del DNA e, quindi,
previene l'insorgenza del cancro. Lei, ad oggi, dirige lo Sbarro Istitute di
Philadelphia: quali passi avanti sono stati fatti dalla sua scoperta? Ci sarà
davvero un giorno la cura per il cancro? E, infine, crede che se ci fosse una
cura "alternativa" questa potrebbe essere ostacolata dalle multinazionali
farmaceutiche che non avrebbero interesse a diffonderla?
«I passi fatti
dagli scienza dagli anni Novanta ad oggi sono immensi e sono sicuro che nel
prossimo futuro ci saranno delle cure sempre più specifiche e tagliate su misura
rispetto al male del paziente. Del resto questo già sta accadendo. Relativamente
alle multinazionali posso dire che il condizionamento della ricerca da parte
loro si concretizza maggiormente in quei Paesi in cui la ricerca è poco
finanziata dal Governo, come ad esempio avviene in Italia. In America, invece,
questo fenomeno è fortemente ridotto. Le grandi scoperte avvengono all’interno
delle Università da sempre sostenute dal Governo Federale Americano. Mi auguro,
quindi, maggiori investimenti nel settore della ricerca scientifica in Italia.
Nessuno è immune, nessuno è innocente, nessuno che può tirarsene fuori. Tra gli
attori del disastro sinonimo di morte che ha infangato anche l’immagine di ciò
che ancora c’è di buono, c’è anche la stampa. E senza nascondersi dietro ad un
dito, lo sottolinea il giornalista Chiariello: “Il ciclo dei rifiuti – spiega –
era in mano ad aziende proprietarie di importanti testate nazionali ed è per
questo che i messaggi in passato non sono stati divulgati, anche perché allora
senza i social network, non c’era interesse a che le informazioni passassero.
Oggi c’è un bel pezzo di società che ha capito che bisogna liberarsi da
un'informazione non corretta”».
Una criminalità onnipresente, uno Stato inerme,
una politica collusa, un'imprenditoria malsana, una scienza negazionista. E
un'informazione che tace. Questi gli attori dello scempio, come descriveresti le
responsabilità di ciascuno?
Qualunque discorso serio intorno ai veleni che
respiriamo, alle acque avvelenate, alle terre che hanno ingoiato rifiuti d’ogni
genere, non può prescindere da una premessa: non esiste solo una terra dei
fuochi in Campania. È un dramma che colpisce anche altre regioni dove però si
finge che il problema non esista. L’Italia è un Paese che deve sciogliere un
nodo serio: ogni anno il giro d’affari in euro del traffico di rifiuti speciali,
ossia della sola produzione industriale, si aggira sui sette miliardi di euro.
Quel che inquieta è la discrasia nei dati tra rifiuti industriali prodotti e
quelli smaltiti. In pratica sappiamo che produciamo un tot di tonnellate di
rifiuti industriali, ma poi di fatto legalmente abbiamo dati secondo cui vengono
smaltite decine di migliaia di tonnellate in meno. Che fine fanno questi rifiuti
industriali che mancano all’appello? Dove vanno a finire? Chi li smaltisce? Dove
vengono smaltiti? Molte tonnellate le stiamo trovando sotto terra tra Napoli e
Caserta. Noi lo sappiamo. Sappiamo che questi rifiuti sono stati affidati a
cifre irrisorie da imprenditori del Nord ai camorristi del clan dei Casalesi che
hanno fatto fortune incredibili interrando tutto in Campania e in altre regioni
del Sud. Se ne parla poco inspiegabilmente ma Lazio, Molise, Puglia hanno subito
lo stesso affronto, le stesse ferite. E ora veniamo al resto della domanda.
Tutto questo è potuto succedere perché Stato e Antistato spesso sono andati a
braccetto. Negli anni passati si è realizzato tra Napoli e Caserta un patto
scellerato tra Stato, Camorra e imprenditoria deviata, sulla pelle dei cittadini».
L’informazione è stata silente, ha taciuto?
«I fatti dicono
che un giornalista è stato ucciso (Giancarlo Siani) perché voleva fare luce sui
rapporti Stato-camorra. I fatti dicono che uno scrittore, Roberto Saviano, vive
scortato, da fantasma, ed è costretto a stare fuori dai confini nazionali perché
vogliono ucciderlo in quanto colpevole di aver acceso un faro permanente sui
loschi traffici del clan dei Casalesi, quelli che hanno accumulato miliardi di
euro con i rifiuti interrati sotto i nostri piedi. I fatti dicono che senza
questi giornalisti e senza la gente che è scesa in piazza, si è ribellata, il
dramma della terra dei fuochi non avrebbe mai avuto l’attenzione che meritava.
Quanto alla scienza negazionista o positivista, non amo partecipare ai dibattiti
sul nulla. La scienza si fa nei laboratori e negli istituiti specializzati, dove
nasce una sana competizione. Quando la scienza esce da questi ambiti, diventa
marketing e spesso fa anche cattiva comunicazione non è più scienza ma
qualcos’altro. Non ne posso più di politici che parlano di scienze, scienziati
che fanno politica, giornalisti che dicono messa e preti che fanno i reporter».
Vittime delle terre dei fuochi sono i
cittadini. Quanta consapevolezza credi ci sia oggi rispetto al passato?
«Credo che
l’attenzione e la consapevolezza della gente sia massima in questo momento.
Troppi morti per tumori, troppa disattenzione dello Stato hanno costretto la
gente a documentarsi, a confrontarsi anche con esperti per capire che cos’è
successo, che cosa sta succedendo nella loro terra, perché tanti di loro muoiono
di tumori, che cosa c’è di vero nella questione delle falde acquifere
avvelenate, dei camorristi che hanno interrato i veleni».
Molti studi sulla terra dei fuochi, che in
realtà sono "le" terre dei fuochi, partono dall'America: credi che all'estero ci
sia una diversa libertà di ricerca e di conoscenza e, soprattutto, di
espressione?
«In Italia
libertà e indipendenza della ricerca scientifica, così come la libertà
d’espressione e d’informazione sono aspetti della nostra quotidianità da
incentivare, migliorare. C’è sempre troppa politica dietro scienza e
informazione. Se siamo arrivati tardi a stimolare una sensibilità seria rispetto
ai temi dell’ambiente forse la responsabilità è stata anche di una informazione
un po’ superficiale e di una scienza che non sempre ha brillato per indipendenza
dal potere politico. Sapere che il Governo federale americano trova risorse per
finanziare una ricerca sulla salubrità dell’ambiente e delle acque in un pezzo
d’Italia (la zona tra Napoli e Caserta) dove ci sono suoi concittadini che
lavorano (militari e civili delle basi USA) fa piacere, fa rabbrividire che
l’Italia non usi la stessa attenzione per i suoi cittadini sul suo territorio».
Molto spesso la stampa tace perché (come
sottolineavi) è condizionata da chi ne detiene la proprietà. Questo significa
che in Italia non esiste un'informazione libera? Come può un cittadino fidarsi
degli organi di informazione?
«La libertà
d’informazione quando è condizionata non la si può più definire libertà, proprio
perché ha un limite nel momento in cui può essere condizionata. Dire che dietro
certi gruppi editoriali importanti ci sono gruppi economici o anche politici è
la rappresentazione di una verità fattuale che rende il nostro Paese una sorta
di unicum nella comunità internazionale occidentale. In fondo quando parliamo di
confitto di interessi, concentrazioni editoriali, a questo ci riferiamo. Poi
però devo aggiungere che anche in questi gruppi editoriali, è il giornalista che
può e anzi deve ritagliarsi il massimo della libertà. È qui, in questi contesti,
che un giornalista italiano riesce a stabilire se è un cane da guardia delle
istituzioni piuttosto che un cane da salotto o da riporto dei potenti di turno».
Monnezza di Stato descrive meccanismi e
collusioni. Quali sono le difficoltà che incontra chi vuole raccontarli?
«L’Italia è un
grande Paese, una grande democrazia e qualunque difficoltà incontri sul tuo
cammino per raccontare una tragedia come quella della terra dei fuochi, dei
veleni interrati, del futuro dei nostri figli avvelenato da camorristi e
imprenditori senza scrupoli può essere superata grazie alla grande capacità che
abbiamo di raccontare la realtà. Non esiste alcun impedimento se non la tua
intelligenza nel cogliere il dramma, la tua capacità nel trovare le fonti giuste
per raccontarlo e soprattutto il modo per illuminare pagine buie della nostra
storia recente. Nella questione terra dei fuochi lo Stato ha avuto gravi
comportamenti omissivi e commissivi. Lo Stato è andato a braccetto con i mafiosi
in alcuni frangenti. Lo Stato ha agevolato l’esportazione verso la Campania di
rifiuti industriali smaltiti illegalmente. Lo Stato ha ora l’obbligo di
bonificare e controllare che le risorse usate non finiscano nuovamente nelle
mani dei camorristi che hanno sporcato».
Carpiano, la terra dei fuochi in versione
lombarda. Veleni oltre i limiti di legge: contaminati
ettari di terreni tra il Pavese e il Milanese, scrive Patrizia Tossi il 16
settembre 2015 su “Il Giorno”. Dodici ettari di terreni contaminati dai
veleni, un’area agricola coltivata tra il Sud Milano e il Pavese piena zeppa
di metalli pesanti, diossina e sostanze potenzialmente pericolose per i geni
umani. Secondo il dossier dell’Agenzia di ricerca europea di Ispra, i livelli di
diossina presenti nel suolo sarebbero 25 volte superiori ai limiti di legge a
causa di presunti «sversamenti pirata». Tutti sapevano da anni: il primo dossier
europeo risale al 2007 e poi ce n’è stato un altro nel 2011, ma finora una fitta
coltre di silenzio ha avvolto quel «quadrilatero nero» tra Carpiano, Landriano,
Pairana e Bascapè. «L’ennesima terra dei fuochi lombarda», denuncia
la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Iolanda Nanni, prima firmataria
di un’interrogazione al Pirellone: «Ho iniziato a scavare tra le carte a seguito
di una segnalazione dei cittadini – spiega Nanni, da tempo in prima linea per
denunciare i problemi ambientali del territorio lombardo – ed è emersa una
situazione inquietante. Le due ricerche Ispra attestano la contaminazione oltre
i limiti di legge dei terreni da metalli pesanti, Pcb, furani, composti
geno-tossici (vale a dire in grado di alterare il Dna, scatenando nel
medio-lungo periodo l’insorgenza di tumori), che avrebbero inquinato i suoli con
ricadute tossiche e nocive sulla catena agro-alimentare. Le istituzioni sapevano
da anni, ma nessuno è mai intervenuto». Il dossier dell’Agenzia europea per
l’ambiente non lascia spazio a dubbi e parla di un’area, per la maggior parte,
«direttamente e soprattutto indirettamente pericolosa per la salute degli
animali e dell’uomo». Ma non solo. «Ispra ipotizza uno ‘spargimento pirata’ di
rifiuti tossici sui terreni – continua Nanni – e nello studio 2011 denuncia uno
“stato di compromissione del suolo e della stessa vita degli organismi vegetali
e animali che sono presenti nel suolo” della zona. È un’emergenza sanitaria
gravissima, la Regione non può più tacere. Alla nostra interrogazione devono
seguire risposte concrete». La cosa assurda è che quei terreni sono coltivati
con prodotti destinati alla vendita, senza che nessun ente abbia mai imposto la
sospensione dell’attività agricola, almeno a livello precauzionale. «Mi domando
come sia possibile che le istituzioni competenti non abbiano immediatamente
denunciato la situazione alla Procura competente – conclude Iolanda Nanni –
affinché si verificassero le responsabilità penali, allertando
contemporaneamente la Procura Antimafia di Milano. E come sia possibile che, dal
2007 a oggi, le istituzioni non abbiano vietato la coltivazione dei terreni
contaminati, al contempo ingiungendo in modo perentorio all’azienda proprietaria
dei terreni l’immediata e tempestiva bonifica dei terreni stessi, nonché il
sequestro di qualsiasi prodotto agro-alimentare frutto dei terreni contaminati
già presente sul mercato». E il sindaco di Carpiano? Nessuna denuncia, nessuna
ordinanza per vietare la coltivazione dei terreni, nessun allerta per i
cittadini. «E' vero che il caso è noto da tempo –risponde il primo
cittadino Paolo Branca – ma la competenza sulla materia ambientale è del
Pirellone. La Regione ha aperto un tavolo tecnico per approfondire la vicenda e
noi, come Comune, abbiamo partecipato. È stata chiesta all’Arpa
un’attualizzazione dei dati con nuove analisi sull’eventuale presenza di
sostante inquinanti sui terreni, ma non ha ancora risposto». E prosegue: «Non mi
risulta che esista un esposto in Procura. Come Comune non possiamo fare nulla.
Il nostro è un territorio molto vasto, quei terreni si trovano lontano dal
centro abitato e riguardano più da vicino gli abitanti di Landriano. Non ci sono
odori, il caso è talmente datato che la componente volatile di eventuali
sostanze inquinanti è già evaporata anni fa. Penso che sia più probabile che ci
siano più metalli pesanti e sostanze tossico nocive nel terreno». E la falda?
«Difficile valutare se sia stata contaminata la falda, bisognerebbe fare
un’indagine accurata. L’agricoltore è attento a non coltivare una determinata
area, ma 12 ettari sono tanti, non si tratta di un fazzoletto di terra, non
posso dire se i veri perimetri sono gli stessi di quelli indicati
dall’agricoltore».
Rifiuti, è qui la terra dei fuochi.
Cinque volte più della Campania. La denuncia
di fondatore di Marino Ruzzanenti, ambientalista fondatore di «Cittadini per il
riciclaggio»: «La provincia di Brescia smaltisce 57 milioni di metri cubi di
rifiuti tossici, quella di Caserta, nella Gomorra di Saviano, 10 milioni»,
scrive Bruna Bianchi il 5 giugno 2015 su “Il Giorno”.
Terra dei Fuochi del Nordè un’espressione
che fa inorridire.
«E allora chiamiamola l’immondezzaio
d’Italia». Marino Ruzzenenti ha l’età della memoria storica, quella di chi ha
accumulato la lunga esperienza di cittadino di Brescia e la forza morale di un
ambientalista convinto. Non è fanatico, non fa barricate: mette in fila i fatti
e i dati. «La provincia di Brescia smaltisce 57 milioni di metri cubi di rifiuti
tossici, quella di Caserta, nella Gomorra di Saviano, 10 milioni».
La verità fa male se si mettono in fila altri
dati: l’incanto delle colline moreniche dei laghi, quelle dolci e succose di
Franciacorta, le bellezze della Brescia antica attorniate da cave piene di
amianto, pcb, metalli ferrosi. Ogni tanto qualcosa si incendia, i fumi neri
escono dai comignoli degli impianti di trattamento e poi tutto tace e il lavoro
dei camion e dello smaltimento prosegue, un tempo selvaggio, ora approvato a
suon di piani e delibere.
«La situazione del Bresciano è del tutto
eccezionale. Noi tumuliamo in discarica circa il 70 per cento dei rifiuti
speciali della Lombardia. Questo territorio è diventato di rifiuti per
vocazione»
Torniamo indietro nel tempo.
«Fino agli anni ’80 non c’era una legge sullo
smaltimento dei rifiuti speciali e le cave di terra e sabbia erano buche
perfette. Le aziende pagavano il proprietario e buttavano tutto lì».
Che tipo di scorie?
«Il 50 per cento dei rottami dell’industria
siderurgica ha trovato posto in tutta la provincia di Brescia».
Altro?
«Non ci manca proprio niente! Abbiamo anche
quattro discariche di scorie radioattive. Per una sola, a Lumezzane, è stato
costruito un bunker».
E sottoterra c’è quello che ancora non è stato
trovato...
«Decine e decine di cave chiuse nascondono rifiuti
fantasma ricoperti da terra e erba. Sappiamo che esistono ma non sappiamo dove
siano».
Signor Ruzzenenti, lei, insieme a Legambiente e
altre associazioni ha fatto un lavoro certosino di denuncia.
«C’è un’indagine in corso alla procura di Brescia
sui rifiuti tossici provenienti dall’estero. Come si dice? Rifiuto chiama
rifiuto. Ormai qui è stata fatta una scelta produttiva, come le armi. Ad
esempio, lo smaltimento dell’amianto a Montichiari in teoria è legale, ma quando
un camion si è rovesciato è stato scoperto che non era trattato come avrebbe
dovuto essere prima di finire in discarica. I controlli sono praticamente
impossibili. Con l’autocertificazione si possono trasformare rifiuti pericolosi
in non pericolosi».
È un bell’affare, no?
«Lo stanno facendo a spese nostre. Compreso Manlio
Cerroni, il re della monnezza di Roma».
I bresciani cosa dicono?
«Cominciano a ribellarsi, osteggiano le nuove
discariche. Hanno già dato tanto».
C’è anche l’inceneritore più potente d’Europa.
«Anche quello. In una città già avvelenata dalla
Caffaro...»
Pure la Valcamonica ha scoperto la sua gatta da
pelare...
«Il sindaco di Berzo Demo si è ritrovato in casa
migliaia di metri cubi di scarti di alluminio provenienti dall’Australia».
Cosa chiede ai politici?
«Basta discariche e almeno una mappatura per
sapere dove sono nascosti altri veleni. Non è tutto inquinato, sia chiaro:
dobbiamo solo individuare il marcio per evitare che si estenda».
"Terra dei fuochi" alle porte di Torino,
scoperta una discarica con 450 tonnellate di veleni. I
finanzieri torinesi nella discarica abusiva a ridosso dell'abitato. Blitz della
Guardia di finanza a San Gillio, alle porte del capoluogo: denunciato il
titolare di un'immobiliare proprietaria dell'area dove erano stoccati rifiuti
industriali pericolosi di ogni tipo compresi 120 quintali di amianto. I
complimenti del ministro Galletti: "Liberiamo l'Italia dagli inquinatori",
scrive il 28 agosto 2015 “La Repubblica". C'erano 450 tonnellate di rifiuti
speciali pericolosi in un capannone industriale abbandonato a San Gillio, nel
Torinese, alle porte del capoluogo e a ridosso del centro abitato. A scoprire la
"terra dei fuochi" piemontese sono stati i militari del Comando provinciale
della Guardia di Finanza di Torino. I finanzieri hanno notato sul piazzale,
visibile anche dall'esterno, "cumuli disomogenei" di rifiuti in evidente stato
di abbandono. Dopo aver individuato il proprietario e l'utilizzatore dell'area,
che si estende per circa cinquemila metri quadrati, i "baschi verdi" sono
entrati per le verifiche sui materiali eseguite insieme all'Arpa Piemonte. E'
stata confermata la grave pericolosità dei materiali, riconducibili in parte
all'attività di officina meccanica ed elettromeccanica e di stampaggio di
materiali a freddo, svolta negli anni scorsi da una ditta di San Gillio
dichiarata fallita nel maggio 2006, e in parte ad una società immobiliare
attuale proprietaria del sito. Al termine delle attività di rilevazione, spiega
la Finanza, sono stati sequestrati rifiuti speciali e pericolosi per circa 450
tonnellate, delle quali 430 provenienti da lavori di demolizione, 12 da fibra
d'amianto e la restante parte, per oltre 6 tonnellate, di prodotti chimici da
decontaminare. Il percolato dei materiali rinvenuti dai finanzieri, in parte,
avrebbe potuto finire negli scarichi per il recupero dell'acqua piovana. Al
momento l'amministratore unico dell'immobiliare proprietaria del sito è stato
denunciato per deposito incontrollato di rifiuti; è anche stato segnalato al
Comune per le violazioni in materia di edilizia e urbanistica, per avere
effettuato lavori di demolizione in assenza di autorizzazione. Proseguono gli
accertamenti per la messa in sicurezza del sito e per verificare eventuale
contaminazione ambientale. "Liberare l'Italia dagli inquinatori": ribadendo
questo obiettivo il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, si è
complimentato con la Guardia di finanza. "Le mie congratulazioni - ha detto -
per l'importante operazione che ha permesso il sequestro di 450 tonnellate di
rifiuti pericolosi nel Torinese. Contro chi avvelena il nostro territorio
abbiamo scelto di condurre una battaglia senza quartiere, affiancando al tenace
lavoro di magistrati e forze dell'ordine l'introduzione degli ecoreati nel
Codice penale: una vera svolta per restituire la certezza ai cittadini di vivere
in zone sicure sotto il profilo ambientale e liberare l'Italia dagli
inquinatori".
Duemila incendi l’anno, ecco la terra dei
fuochi de’ noantri, scrive Grazia Maria Coletti il 12
gennaio 2016 su “Il Tempo”. Situazione esplosiva nei campi rom. I romani
stremati dal fumo si ribellano. E in Campania l’Istituto di Sanità accerta
aumento di tumori in 55 comuni La mappa dei roghi. Se ogni porta di casa deve
essere una Porta Santa, tuteliamo anche le porte sante delle case dei romani,
soffocate dal fumo dei rom. È questo il messaggio che arriva dagli esposti
piovuti sui tavoli del prefetto di Roma, Franco Gabrielli e del commissario
Francesco Paolo Tronca, impegnati nei giorni del Giubileo e dell’allarme
terrorismo. Duemila roghi tossici in un anno e un solo arresto (due rom fermati
dai carabinieri a Castel Romano a settembre), è questa la caporetto delle pene
esemplari del decreto "terra dei fuochi" che non hanno fermato la terra dei
fuochi "de’noantri". E i romani esasperati, chiedono un piano di salvataggio dai
"terroristi-rom", «gli unici al momento - dicono - ad attentare alla vita di
adulti, vecchi e bambini». Hanno ragione di temere? I risultati drammatici della
ricerca dell’Iss sui 55 comuni della "Terra dei fuochi" campana ci dicono che in
quella zona «si muore di più che in altre zone d’Italia», ci si ammala «più di
cancro», anche tra i «bambini» nella fascia «0-14», e si «registrano più
ricoveri». L’Europa ha condannato Roma più volte. 172mila390 i metri quadri di
terreno, l’equivalente di 40 campi da calcio, sequestrati come discariche
abusive dallo Spe della polizia locale del vicecomandante del Corpo Antonio Di
Maggio. Interpellanze del parlamentare europeo Giovanni La Via e della
Angelilli. Ma a Roma nessuno ha ancora monitorato l’aria prodotta dai quasi
2mila roghi, contati da Il Tempo con l’aiuto dei cittadini di ogni quadrante,
perché una mappa ufficiale ancora non c’è. Considerando una media di 3-4 roghi a
settimana, tutti i giorni d’estate, e giorno e notte, accesi anche più volte al
dì, nei campi legali e tollerati - che ci costano 24 milioni di euro l’anno - si
arriva a quasi mille. Altrettanti nella miriade di accampamenti abusivi, nella
riserva delle Valle dell’Aniene, sotto i cavalcavia, sgomberati e ripopolati,
con fonderie illegali in ogni quartiere: da Magliana a Tor Sapienza, da Ponte di
Nona, a Ciampino, dal Nuovo Salario a Ciampino, da La Rustica fino alla
provincia romana, specialmente a est. Come racconta la mappa pubblicata qui a
fianco. E quando tira il vento non si salvano nemmeno i Parioli, come aveva già
denunciato su queste pagine anche il comico Enrico Montesano. Mentre il web fa
il pieno di post sulla pagina facebook "richiesta la chiusura del campo di via
di Salone", dove i vigili del fuoco di La Rustica vengono presi sempre a
sassate, che porterà alla manifestazione popolare in primavera per chiedere la
chiusura anche di via Salviati, La Barbuta, vicino all’aeroporto di Ciampino,
Castel Romano sulla Pontina, la Monachina, sull’Aurelia, Lombroso a
Torrevecchia. Ma gli inceneritori a tutti gli effetti di rifiuti tossici
speciali, da cui si sprigiona diossina, sono presenti anche in centinaia di
microaccampamenti nelle radure del Pratone delle valli, nelle valli di
Quartaccio, segnalazioni nel quartiere Quintiliani, Pietralata, via dei
Durantini. Il comitato di quartiere Tor Sapienza è stato il primo a contare i
roghi: «155 roghi in 15 mesi da via Salviati», con il presidente Roberto Torre
che nei giorni scorsi lanciava l’anatema contro l’immobilismo. «152 roghi
tossici in un anno da via di Salone» dice Franco Pirina, del Caop Ponte di Nona
- qui i roghi, ultimamente, durante la notte e solo al mattino la gente si rende
conto dell’aria irrespirabile». Il conto sale vertiginosamente con il campo di
via Candoni, alla Magliana, e Candoni bis, fucina che arde, notte e giorno, e
avvelena l’aria dei quartieri Marconi, Magliana, Casetta Mattei, Muratella, agli
autisti della rimessa Atac servono gli antinebbia. Il capogruppo di Forza Italia
in XI Municipio, Marco Palma, ha chiesto «l’esercito» al posto dei vigili
urbani. «Già messi "ko" da schiere di minorenni». Aperte le «indagini» a un anno
dall’esposto in Procura presentato dal consigliere regionale Fabrizio Santori.
Brucia la città, ma nessuno spegne i
roghi, scrive Maria Lombardi il 4 febbraio 2016 su “Il
Messaggero". Il fumo s'alza sulla via Olimpica, poco prima dello svincolo per
Tor di Quinto, e disegna un arcobaleno nero. Dalla nuvola bassa e puzzolente
sbucano comitive di rom, scavalcano il guardrail e attraversano la strada anche
se non ci sono strisce pedonali, lasciandosi alle spalle il villaggio di lamiere
che perennemente arde. C'è una Roma che brucia senza sosta, ignorata, ci sono
intere zone della città condannate ai roghi, un inferno velenoso, peggio di
qualsiasi altro inferno. C'è un'altra terra dei fuochi a dieci chilometri dal
Quirinale e si va allargando. Quartieri soffocati dalle nubi pesanti delle
baraccopoli. Magari ci fossero solo le polveri sottili, qui si respira aria
ancora più malata e non si sa di che. Anneriranno in fretta le lenzuola bianche
che i cittadini hanno appeso alle finestre, verranno presto corrose dai vapori
di diossina. «Basta roghi criminali», c'è scritto. Decine e decine di striscioni
nei palazzi di Conca d'Oro, Tiburtina, San Basilio, Casal Bertone, La Rustica,
Tor Sapienza, Ponte di Nona. Chi abita in queste zone si sente perduto, il fumo
dei rifiuti bruciati nei campi per prendere il rame può uccidere. Gli appelli
finora non sono serviti, adesso è il momento della protesta corale, l'urlo
esibito ai balconi. Roghi criminali, appunto, perché di crimini si tratta. Il
reato esiste dal dicembre 2013 «combustione illecita di rifiuti», prevede il
carcere dai 2 ai 5 anni, stessa pena per chi trasporta gli scarti con
l'intenzione di dargli fuoco. Eppure gli incendi di Roma nessuno riesce a
spegnerli.
Terra dei Fuochi, il sequel. Terni, Rieti
e Viterbo nuova frontiera per rom e colletti bianchi,
scrive “Libero Quotidiano” il 5 febbraio 2016. Terra dei Fuochi, il sequel. Come
al cinema, il cancro criminale che affligge la Campania ha un seguito... a Roma
e non solo. A raccontarlo è il giudice Mauro Santoloci, gip di Terni, membro
della Commissione ministeriale per la revisione del Testo Unico ambientale e
autore, con Valentina Vattani, di una collana di pubblicazioni sul tema delle
eco mafie, intervenuto a Corretta informazione sui temi ambientali. Fonti
ufficiali e fonti ufficiose, corso di aggiornamento promosso dall'Ordine dei
Giornalisti dell'Umbria. "Sorvolando Roma di notte – ha spiegato Santoloci – non
è difficile individuare un corollario di fuochi, in particolare nei pressi della
tangenziale. Sono i roghi appiccati nei campi rom, destinati a smaltire rifiuti.
Un meccanismo pericoloso, per la salute e per l'ambiente, nonché nocivo per le
attività legali di smaltimento". Secondo le informazioni in possesso del
magistrato "i rom si appoggiano ad una flotta di furgoni, guidati talvolta
da schiavi bianchi, vale a dire persone disagiate, ad esempio immigrati, che per
pochi euro ti smontano un pannello di amianto senza rispettare alcuna regola di
sicurezza, lo caricano su un camion, lo portano alla discarica abusiva. Una giro
per orchestrato, grazie anche alla conoscenza delle lacune (buchi neri, li
chiama il gip, ndr) della nostra giustizia. Ad esempio, un vigile urbano mi ha
raccontato che, in due mesi, ha fermato lo stesso mezzo trentasette volte, senza
riuscire però a sequestrarlo". Il sequestro non è possibile, perché? La risposta
è nell'ex art. 240 co. 1 c.p., che elenca i requisiti di confiscabilità di un
autoveicolo usato per un illecito e la cui applicazione potrebbe sollevare
incertezze sul nesso di asservimento/strumentalità che deve legare la cosa al
reato. Interpretazioni normative a parte, ciò che lascia basiti è la
ramificazione di questa piccola criminalità: seppure non classificabile come eco
mafia, infatti, la rete rom è estesa è guarda già oltre la Campania e la zona di
Roma. Ad esempio, Rieti, Viterbo, Terni sono "candidate" ad diventare una nuova
Terra dei Fuochi. Santoloci: "In seguito ad azioni di repressione delle forze
dell'ordine, è plausibile che l'attenzione dei criminali si sposti altrove, in
città poco distanti dalla Capitale come questa (Terni, ndr) o come il reatino e
il viterbese. Dopo aver appurato, chiaramente, che le aree interessate siano più
'tranquille', gli illeciti potrebbero trovare nuovi siti". I campi nomadi nei
quali si "accendono" i fuochi sono un problema, vero, ma ostacolo non inferiore
è quello dei colletti bianchi, vale a dire professionisti ed imprenditori
insospettabili che alimentano il giro di affari che ruota intorno allo
smaltimento abusivo. Il gip: "Alla Guardia Costiera chiedo di controllare non
solo la bolla di carico, ma anche di aprire i container: i documenti sono in
regola, però a bordo della nave hai tonnellate di materiale che poi viene
trasformato e che torna, in Italia, sotto forma di prodotto per il mercato".
Ecco cosa significa "colletto bianco": far apparire corretto ciò che non lo è.
Come uscirne? Fra le soluzioni, il giudice propone anche una "formazione
continua" sul tema dei rifiuti per le forze dell'ordine, sia per capire le
modalità di gestione del traffico illegale, sia per rendersi conto che la
domanda "è di mia competenza"? di fronte ad un potenziale illecito non è
assolutamente da porsi. Nessun riferimento, invece, alla questione inceneritori
che, proprio in queste settimane, ha ri-assistito a polemiche e manifestazioni
di protesta dei comitati ambientalisti. In particolare, nelle ultime ore, il
Comitato No Inceneritori di Terni ha aspramente criticato il voto favorevole
all'articolo 35 dello Sblocca Italia, che permette la creazione di una rete di
smaltimento a livello nazionale. Secondo il Comitato, infatti, ciò andrebbe a
scapito di Terni i cui due impianti si troverebbero così a bruciare consistenti
quantitativi di immondizia. Una circostanza che nulla ha a che vedere con la
lotta al malaffare, ma che tuttavia lascia perplesse le organizzazioni
cittadine, preoccupate per le eventuali conseguenze a livello ambientale e
sanitario.
Terra dei Fuochi in Toscana,
scrive Vanessa Roghi, storica, l'11 luglio 2015 su “Internazionale". Hai mai
visto Bormida? Ha l’acqua color del sangue raggrumato, perché porta via i
rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle rive non cresce più un filo d’erba.
Un’acqua più porca e avvelenata, che ti mette freddo nel midollo, specie a
vederla di notte sotto la luna. Quando Beppe Fenoglio scrive Un giorno di fuoco,
negli anni della sua giovinezza, l’acqua del fiume Bormida è già rossa, porca e
avvelenata, ma la parola ambientalismo, in Italia, non esiste o è patrimonio di
illuminate minoranze. Non si pronuncia mai, tuttavia, in presenza di un’altra
parola: lavoro. Semmai fabbrica, ma lavoro no. Perché, come nella morra cinese,
lavoro spazza via ambiente; che, come la carta, avvolge il sasso, la fabbrica.
Ma è sempre meno forte della forbice, il lavoro appunto. Quando Beppe Fenoglio
descrive il fiume Bormida, l’Acna di Cengio la conoscono solo i suoi abitanti e
gli operai che ogni giorno timbrano il cartellino e producono coloranti e gas
tossici, da più di mezzo secolo. Quando nel 1963 esce Un giorno di fuoco, Beppe
Fenoglio è morto di cancro, ed è passato solo un anno dalla sentenza che ha
costretto i contadini della val Bormida a risarcire l’Acna, ora di proprietà
della Montecatini, per le spese di un processo durato 24 anni nel quale gli
abitanti della valle hanno osato far notare che in effetti va bene l’acqua
rossa, ma il fatto che nei campi non cresca un filo d’erba non va bene, o no? La
Montecatini è cresciuta negli anni del fascismo, ha allargato la sua attività in
vaste aree del Piemonte, della Liguria, della Toscana, dell’Emilia Romagna:
risorse da sfruttare, acqua, manodopera a basso costo e sono nate alcune delle
industrie più importanti della chimica italiana. “Montecatini”, scrive Alberto
Prunetti Amianto “non è quella famosa delle terme e di Miss Italia, ma la
Montecatini aspra delle Colline metallifere della Val di Cecina, in alta
Maremma. La Montecatini che diventerà Edison, poi Montedison, poi si smembrerà
in altre società, svenderà alcuni stabilimenti (…)”. La Montecatini, dalla quale
sgorgheranno fiumi e fiumi di storie, storie di minerali e di fabbriche, storie
di lavoro, scrive ancora Prunetti, “che hanno avvelenato e rovinato i polmoni
con la silicosi, per poi impestare di fanghi rossi il mare di fronte
all’arcipelago toscano e alla Corsica, smaltire ceneri di pirite nelle miniere
scavate decenni prima e intossicare di metalli pesanti i fiumi e il mare”.
Risorse naturali, acqua, manodopera a basso costo: vengono scavate nuove
miniere, ampliate quelle esistenti: rame, zolfo, piriti, fino al grande
incidente, quello del 1954, quando a Ribolla, vicino Grosseto, esplode il pozzo
Camorra e muoiono 43 minatori. La storia è nota. Luciano Bianciardi e Carlo
Cassola sulla tragedia pubblicano I minatori della Maremma. Poi arriva la prima
grande crisi industriale dopo gli anni del boom, la crisi che porta l’Eni a
rilevare la Montecatini, è il 1966, nasce la Montedison, l’Italia è in fase di
“congiuntura”, ma l’industria chimica continua a crescere, a creare centinaia di
posti di lavoro. La parola ambientalismo è sempre poco usata, poco la usa anche
Antonio Cederna, pure tra i pochi in Italia a porre all’attenzione della
politica il problema della tutela dell’ambiente insieme a quello della qualità
della vita dei cittadini. Proprio nel 1966 pubblica su L’Espresso un’inchiesta
sulla distruzione delle coste italiane, la sua attenzione è rivolta
principalmente alla speculazione edilizia, nessuno ancora si pone il problema di
come ben più grave sia la questione dell’inquinamento. Eppure gli abitanti della
val Bormida continuano le loro battaglie, denunciano l’Acna, ancora non
esiste l’orrenda espressione nimby (non nel mio giardino) e nessuno si permette
di trattarli come dei terroristi, come succederà anni dopo ai loro omologhi
della val Susa; ma in quei primi anni settanta lavoro vince su fabbrica che
vince su ambiente. Questo fino al 1976 quando esplode a Seveso un reattore
chimico destinato alla produzione di triclorofenolo, parola incomprensibile, ma
tutti, dai quarant’anni in su ne ricordano un’altra: diossina. Ascoltatelo Marco
Gisotti che racconta quel 10 luglio e la diossina sprigionata nell’aria che
ricopre tutta la Brianza. Bisogna ricordarsele queste tappe, partire da lontano,
allargare lo sguardo nel lungo periodo se vogliamo ricucire le tappe che da
Seveso e diossina, e Acna e Cengio, portano a un altro luogo della memoria del
movimento ambientalista italiano, ovvero l’incidente della Farmoplant che oggi
possiamo ricordare attraverso un libro, La terra bianca, chi l’ha scritto si
chiama Giulio Milani, la storia che racconta è questa. 17 luglio 1988. Il
serbatoio Rogor della Farmoplant esplode. Tutti ricordano la nube nera che si
solleva dalla fabbrica e spinge le persone a fuggire dalla città avvelenata.
Quasi un anno prima, il 25 ottobre del 1987 il 75 per cento degli aventi diritto
aveva votato per il referendum che chiedeva la chiusura immediata della
fabbrica. È il primo referendum consultivo d’Europa per chiedere la chiusura di
una fabbrica. L’eco ormai attutita di Seveso è appena stata risvegliata dal
boato di Cernobyl. Risponde sì il 71,69 per cento, la fabbrica deve essere
chiusa, perché dall’anno della sua apertura, il 1976, ci sono stati quaranta
incidenti, il più grave, un incendio nel 1980 al magazzino esterno del Mancozeb
– un pesticida cancerogeno tutt’ora impiegato in viticoltura. Segue la revoca
immediata delle licenze per la produzione di Rogor e di Cidial, i due
insetticidi considerati più pericolosi. Il 2 novembre 1987, scrive Milani, “la
gerenza della Farmoplant licenzia in tronco tutti i dipendenti, perché afferma
che senza la produzione di queste due richiestissime sostanze non ci sono le
condizioni per proseguire l’attività”. Ma la Farmoplant vince il ricorso e tutti
i lavoratori sono di nuovo assunti. Lo stabilimento riprende la produzione.
“Naturalmente il Comune di Massa, Lega ambiente e i Verdi fanno ricorso al
Consiglio di Stato contro la sospensione del Tar, e a marzo del 1988 il
Consiglio di Stato sospende la sospensione”. Seguono mesi di commissioni,
ricorsi e controricorsi. Il ministro dell’ambiente è Giorgio Ruffolo, la persona
giusta al posto sbagliato, come titolerà il mensile di Legambiente, per la sua
inerzia nell’affrontare il disastro che gli si riversa addosso. E arriva
l’estate del 1988: gli ambientalisti propongono di impiegare gli operai,
“durante la riconversione dell’impianto, nella bonifica dei 65 ettari di terreno
contaminato dal complesso industriale, ma il progetto non viene neppure preso in
considerazione dalla Montedison”. Nessuno si pronuncia, né il sindaco, né il
ministero, né il consiglio dell’azienda. “In questa attesa il 17 luglio esplode
proprio il serbatoio dei formulati liquidi che conteneva Rogor e cicloesanone”.
L’annuncio del tg diffonde il panico nelle regioni confinanti malgrado il tono
pacato al telegiornale di Luigi Frajese. Muoiono i pesci, muoiono le anguille,
il divieto di balneazione appare sulle spiagge di Massa. Ma cresce la
consapevolezza che senza determinate condizioni di sicurezza lavorare uccide,
non stanca, come scrive nel suo libro un altro figlio di queste terre, Marco
Rovelli. Un disastro ambientale che riguarda però anche un altro fondamentale
settore produttivo, e questa è l’altra grande storia che Milani ricostruisce: “È
stata Tangentopoli a indicare in che misura anche per il versante ligure-apuano
e apuo-versiliese l’infiltrazione mafiosa – insieme all’arrivo della chimica di
Raul Gardini – abbia accompagnato la nascita di un’economia di rapina a
esclusivo appannaggio delle multinazionali del carbonato di calcio, fondata sul
riciclaggio di proventi al nero e il commercio di rifiuti pericolosi”. Salvatore
Calleri è il presidente della fondazione Caponnetto e, racconta Milani, ha
denunciato come la Toscana, con trentacinque diverse organizzazioni criminali
censite, non sembrasse rendersi conto di rappresentare una potenziale terra di
conquista delle mafie. La chiama, Calleri, auto-omertà. Un silenzio indotto
dalla paura di andare a incidere negativamente sulla rappresentazione pubblica
della Toscana, marchio nel mondo, di buongoverno unito ad assenza di
inquinamento del territorio, ma la “terra dei fuochi”, dice uno dei testimoni
del libro di Milani “è anche qui, da noi e da ben prima”. Decidere quale sia la
vocazione di un’area non è cosa semplice: polo chimico o cave di marmo, o
addirittura turismo, o altro? “La Farmoplant”, scrive Milani, “chiude nel 1988.
La Dalmine nel 1990, è l’ultima grande industria ad andarsene dalla zona. Gli
operai della Dalmine sono l’aristocrazia. Ma dalla sera alla mattina perdono il
lavoro in 1.500”. A quel punto la vocazione sembra essere una e una solo, quella
del marmo: “Adesso i sindaci si stracciano le vesti per i lavoratori del
lapideo”, dice a Milani un operaio in pensione, “ma in tutta la provincia è un
miracolo se contano ancora duemila occupati con l’indotto e sono disposti a
perdere la ricchezza delle montagne e dell’acqua, a sborsare cifre colossali per
il continuo ripristino del dissesto prodotto dall’escavazione, dai trasporti su
camion e dalla strozzatura della rete fluviale, a mettere a repentaglio la vita
delle persone sotto le alluvioni e le frane pur di salvarli: chiediamoci come
mai”. Qualche anno fa Roberto Barocci ha pubblicato un prezioso libretto, ormai
esaurito, per Stampa alternativa, si intitolava ArsENIco. Come avvelenare la
Maremma fino alla catastrofe ambientale. In questo si faceva la stessa, identica
domanda: perché le istituzioni avevano accettato l’inquinamento delle zone
minerarie della bassa Toscana, il colpevole ritardo delle bonifiche ambientali,
ritardo che aveva finito per avvelenare terreni e corsi d’acqua, e corpi, dalle
Colline Metallifere giù fino alla costa? Si domandava l’autore
nell’introduzione: “Chi governa nel nostro paese? Nella Regione Toscana? Dove
vengono prese le decisioni importanti che riguardano le risorse strategiche,
dalla salute alle risorse idriche, al lavoro, alla qualità dell’ambiente…? Chi
sono i mercificatori che si piegano a interessi di pochi e riescono ad imporre
queste scelte anche agli onesti? Come può avvenire tutto ciò?”. “Avevamo bisogno
di lavorare e le cose che dicevano sulla pericolosità delle produzioni ci
parevano esagerate. Le istituzioni, i partiti, i sindacati, i tecnici: per tutti
l’insediamento era sicuro, anzi, una vera benedizione per la zona industriale e
per il nostro avvenire. I quadri dell’azienda abitavano nei dintorni della
fabbrica, ma anche i politici abitavano non lontano. Se il pericolo c’era, c’era
per tutti. Come si poteva pensare di essere ingannati fino a questo punto?”.
Alla fine, comunque, questo rimane l’interrogativo più lacerante lasciato aperto
dall’inchiesta di Milani, non le mafie, non le morti, non la fine del lavoro, ma
questo: se il pericolo c’era, c’era per tutti, perché inquinare, avvelenare,
uccidere? Mi raccontava qualche anno fa Sandro Veronesi una scritta che aveva
visto una volta su muro: “Chi inquina l’acqua beve pure lui”. Ci ho pensato
tutto il tempo a questa scritta mentre leggevo il libro di Milani, così come ho
pensato alle acque rosse del fiume Bormida, all’arsenico della Maremma. Chi
inquina la terra ci vive pure lui. Deve essere dunque solo una questione
d’amore, senza altre spiegazioni, come suggerisce nella sua recensione a
Milani, Annalisa Andreoni, parafrasando Brecht: “Sventurata la terra che non è
amata dai suoi”.
Cantone: “Balle spaziali sulla Terra dei
fuochi, mai trovato un fusto radioattivo”. “Vivo a
Giugliano, piena Terra dei fuochi. E su questa storia so con cognizione di causa
che si sono dette balle spaziali. Si è andati dietro alle parole di un pentito,
Carmine Schiavone, che dal 1993 noi magistrati consideravamo inattendibile su
questo argomento”. “Mai trovati fusti radioattivi. Mai, nemmeno un fusto. Quella
del traffico dei rifiuti è una faccenda seria. Lei crede che le zone più
industriali della Pianura padana siano meno inquinate della Terra dei fuochi?
Nessuno si è occupato di queste faccende per decenni. Poi all’improvviso si è
creato un mostro mediatico, tutto suggestione, umori, sensazionalismo, pigrizia,
ignoranza, si è fatto confusione tra la spazzatura bruciata, quella seppellita e
quella che appesta certe zone della campagna. Un polverone inutile, che adesso
ovviamente si è depositato. Nel silenzio e nell’inazione”. “Io rispetto don
Patriciello. Ma lui non è un medico, non è uno scienziato e non è nemmeno un
poliziotto. Si è fatto un collegamento acrobatico tra i rifiuti interrati e
l’insorgenza dei tumori. Un collegamento smentito dai tecnici. Ne è venuto fuori
un pasticcio imprendibile. Lei pensi che alle ultime elezioni, lì dove abito io,
si è persino presentata una lista che si chiamava ‘Terra dei fuochi’”. Raffaele
Cantone (da un’intervista di al quotidiano Il Foglio – di Salvatore Merlo).
Lo smacchiatore d'Italia.
Renzi e De Magistris, la politica e la giustizia, le banche popolari e
l’antimafia, la simpatia per il Msi e il rischio di fallire. A tu per tu con
Raffaele Cantone. Scusi dottore, lei è un moralista? “Ebbene sì”, scrive
Salvatore Merlo il 2 Gennaio 2016 su “Il Foglio”. L’immagine suggerisce
confidenza. Quante volte al giorno sente Renzi?
“Poche. Usiamo WhatsApp”. Ovviamente lei è un
elettore del centrosinistra, si sente dire questo gran togato che gode della
massima fiducia di Matteo Renzi. Silenzio. Occhi in movimento, come seguissero
di soppiatto qualche orbita segreta, ticchettando calcoli occulti. Sorriso
appena diffidente. Poi tutto d’un fiato: “Veramente ho votato anche altro”. Non
mi dica Berlusconi. “Questo non dovrei dirglielo, ma una volta da ragazzino a
Napoli feci ‘filone’ a scuola…”. E che sarà mai. “… E andai con gli amici a
sentire un comizio di Gianfranco Fini che era allora il capo del Fronte della
gioventù”. Ma va’. Poi Alleanza nazionale? “Movimento sociale. La mia
collocazione è la destra”. Legge e ordine, dunque. Nulla a che fare, come si
vede, con la formazione politico giudiziaria di Pietro Grasso o di Luciano
Violante, più Antonio Di Pietro che Gian Carlo Caselli. “Ma non ho mai fatto
politica, nemmeno all’università. Credo di non aver mai nemmeno votato per i
rappresentanti d’istituto al liceo. Non mi sono mai iscritto a un partito”. E
adesso? “Adesso faccio il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione”,
trecento persone impiegate in un labirintico palazzo che si affaccia su Galleria
Sciarra, a un passo dalla Fontana di Trevi, un luogo che per sapienza del
destino fu anche l’epicentro del primo grande scandalo di corruzione della
storia d’Italia: nel 1893 il padrone di casa, principe Maffeo Barberini-Colonna
di Sciarra, fu implicato nell’affaire della Banca Romana. Così Raffaele Cantone,
questo signore magro, di media altezza, semplice nel vestire (con un tocco
eversivo: calze a rombi colorati in campo verde), cade ironicamente dalle
nuvole: “Lei apre nuovi orizzonti alla mia fantasia”. L’autorità Anticorruzione
nel palazzo del primo grande scandalo di corruttela. “E’ un divertente
contrappasso”. Ma viene pure da pensare che altro stile non ci sia stato mai,
sotto sotto, nelle cose d’Italia. “La corruzione è un fatto sistemico,
fisiologico”, arieggia lui, con l’espressione dell’entomologo che descrivendo
gli insetti giustifica anche la propria esistenza. “Nel 1900, il presidente del
Consiglio Giuseppe Saracco istituì una commissione per indagare sulla corruzione
e il clientelismo nel comune di Napoli. Gli atti di quella commissione sembrano
scritti oggi”. Manzoni diceva che l’Italia è “pentita sempre e non cangiata
mai”. E Cantone: “Se dovessimo ritenere che l’illegalità è immanente, dovremmo
dire che c’è un tratto antropologico nel nostro paese. E io questo non posso
accettarlo”. Renzi ha caricato di aspettative salvifiche totali questo
magistrato che molti anni fa fece condannare all’ergastolo il boss della camorra
Francesco Schiavone (“mai fatto il giudice, soltanto il pubblico ministero”). E
già qualcuno lo chiama lo “smacchiatore”, come fosse un prodotto per lavanderia,
da supermercato, da banco, è pronto all’uso e non c’è nemmeno bisogno di
agitarlo: l’Expo (“è stato un successo, potremmo vivere di rendita ma non lo
facciamo”), Mafia Capitale, poi le ecoballe in Campania, e ora anche le banche
popolari, dopo il fallimento di Banca Etruria e di Banca Marche. “La storia
degli arbitrati apparentemente non c’entra niente con l’Autorità
anticorruzione”, ammette l’uomo della renziana provvidenza. Ma poi aggiunge: “Il
nostro compito è di creare un meccanismo, un sistema per stabilire chi avrà
diritto agli indennizzi e chi no”. Ma non tocca alla Banca d’Italia? “Quando
avremo finito questa nostra conversazione dovrò incontrare il governatore
Ignazio Visco. Ma guardi che l’Autorità è già dotata di una camera arbitrale.
Voglio dire che non ci occupiamo di una faccenda completamente estranea alle
nostre competenze. Insomma, non ci è stato mica chiesto di riformare il
calcio!”. E appena pronuncia queste parole Cantone si blocca, come sfiorato da
un’inafferrabile ombra associativa, da un dubbio… E se succede? Mai dire mai,
dottore. Non sia precipitoso. E d’altra parte lui è stato investito del ruolo di
autorità morale, di vestale della legalità, di salvifica fatalità dell’italico
destino, anche se dice che non è vero, che è una supersemplificazione rozza,
persino inquietante. “Cercare un salvatore è molto deresponsabilizzante per una
società”, dice. “Sono le democrazie poco mature che cercano demiurghi e
super-eroi”. Il Foglio lo ha spiritosamente eletto uomo dell’anno appena
trascorso: il suo nome rimbalza ogni giorno e più volte al giorno tra i più alti
seggi dell’empireo politico nazionale. Cantone è stato candidato a tutto:
sindaco di Roma, presidente della Campania, sindaco di Napoli, e persino
presidente della Repubblica. “La invito a verificare l’abisso che c’è tra le
funzioni che i giornali tendono ad attribuirmi e quelle che effettivamente
esercito”. E allora gli si riferiscono alcuni commenti ironici che lo
riguardano, su Twitter. “Anche io vado a dormire. #Cantone mi rimbocchi le
coperte?”, scrive @ValentinaMeiss. Poi un falso e ironico Gianni Cuperlo: “Dalle
urne spagnole esce un paese ingovernabile. L’unica è chiamare Cantone”. E
ancora: “Stanotte l’ho visto finalmente. Cantone Natale che scendeva per i
camini a portare i regali”. E poi @FabrizioRoncone: “L’Inter ha chiesto a
Cantone di seguire dal punto di vista psicologico Melo. Cantone, all’inizio un
filo riluttante, ha accettato”. Persino Mara Maionchi, la madrina di “X Factor”,
alla domanda su chi secondo lei dovrebbe essere il prossimo giudice nel reality
show di Sky ha risposto così: “Ma che domande sono? Cantone, ovviamente”. Lui
ascolta e sorride, con un atteggiamento di ritegno che pare allo stesso tempo di
allerta. “Di tutto questo colgo l’aspetto ironico e positivo”, soffia, con una
limatura di sorriso. “Ma respingo l’idea che io sia una specie di mister ‘Wolf’
o peggio una fogliolina di fico. E poi, guardi, che essere evocato per un
compito non significa che lo stai svolgendo”. Sindaco di Roma? “Nessuno me lo ha
mai chiesto, e io non avrei mai nemmeno accettato”. Sindaco di Napoli? “Me lo
chiesero”. Eh, allora vede. Ora a Cantone tocca occuparsi anche delle banche,
degli indennizzi, degli arbitrati… “Non sfuggo alle responsabilità, se sono
confacenti alle funzioni della struttura che presiedo. Sarebbe sbagliato tirarsi
indietro. Ma non sono disposto a fare cose per le quali mi sento inadatto. Roma,
per esempio, non è la mia città. Non farei mai il sindaco”. E insomma ad
animarlo è la certezza di essere attore e non agito. E c’è d’altra parte una
foto, scattata da Filippo Sensi, il portavoce di Palazzo Chigi, nella quale
Renzi è ripreso di spalle mentre Cantone gli sussurra qualcosa all’orecchio.
L’immagine suggerisce confidenza, un rapporto intimo e segreto. Quante volte vi
sentite al giorno? “Quasi mai”. Mai? “Ogni tanto un messaggio su WhatsApp”. E
all’orecchio di Renzi lei cosa sussurra? “Davvero non sono in grado di
sussurrare nell’orecchio del presidente del Consiglio… Che peraltro è uno che
non si fa sussurrare nell’orecchio da nessuno”. Non ascolta. “Tiene in
considerazione le opinioni”. Diciamo così. Anche nel governo Berlusconi, con le
dovute differenze, s’intende, c’era una specie di Raffaele Cantone. Era uno che
faceva tutto, risolveva problemi, si chiamava… “Guardi che faccio gli scongiuri,
se mi paragona a Guido Bertolaso”, ride. Perché gli scongiuri? “Perché è finito
male. Bertolaso è stato molto a lungo un personaggio positivo. Poi è andata
com’è andata. Alla fine, gratta gratta, questo è sempre il paese dell’osanna e
del crucifige, è sempre il paese di Masaniello. C’è una parte d’Italia che prova
una contorta soddisfazione a veder cadere un simbolo nella polvere. La caduta
permette poi di dire che nei comportamenti borderline siamo tutti uguali”. Ma in
realtà la storia politica d’Italia è piena di tecnici finiti malissimo, e non
per comportamenti borderline. Persino Mario Monti oggi si aggira per il Senato
con la maestà malinconica delle rovine. E lo stesso vale per i troppi commissari
alla spending review, per i super prefetti delle mille emergenze italiane e per
tutti i salvatori della patria che con indifferente pendolarità questo paese ha
masticato e sputato via in sembianze tragiche, o macchiettistiche. Tutte falene
che si accostano al freddo fuoco del linguaggio politico e vengono
immancabilmente e cinicamente buttate via dai loro sfruttatori non appena le
loro grazie appassiscono. Dottor Cantone, per lei sarà diverso? “La tendenza a
nominare commissari ogni volta che c’è un guasto è la prova che il sistema non
funziona. Ma io non sono chiamato a gestire un’emergenza, non sono il tipico
commissario, parola che evoca l’idea della straordinarietà. Il mio è un compito
che sta nella fisiologia dell’amministrazione”. E davvero tutto in lui svela
l’impegno di una vocazione stabilita fin dalla sua nomina, mantenuta
nell’intonazione libera, ma accordata sui tempi musicali del renzismo, persino
nel sorriso, che in lui non è raro ma è attento, come studiato. Lei è un
moralista, dottor Cantone? “La parola morale non mi dispiace. Preferisco però la
parola ‘etica’, quell’insieme di principi ai quali ancorare la propria attività.
Dunque se con moralista si vuol intendere qualcuno che crede nella forza
dell’etica, allora sì, sono un moralista”. In un paese in cui tuttavia i
moralisti sono finiti troppo spesso moralizzati. L’Antimafia sociale, politica e
giudiziaria è precipitata in una nera pozza con l’affaire dell’ex presidente
delle Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Silvana Saguto, indagata
per corruzione e abuso d’ufficio a Caltanissetta. “L’incarnazione più completa e
sorprendente, preoccupante, del professionismo descritto da Sciascia”, dice
Cantone. La morale è dovunque conforme ai valori mutevoli nello spazio e nel
tempo: con la prerogativa però, in Italia, di essere di generale convenienza. Si
fanno anche carriere politiche così. “Perché l’Italia ha sete di legalità.
Dunque ci sono anche i cinici, gli opportunisti, o gli sciocchi, come viene
spesso raccontato, che la utilizzano. Ma io mi chiederei perché esiste questa
patologia politica”, la patologia dei magistrati che per esempio fanno grandi
inchieste pirotecniche, poi le abbandonano prima della sentenza come Antonio
Ingroia, e ancora prima che un giudice smonti tutto in tribunale si candidano
alle elezioni. “Questa patologia esiste perché c’è una domanda forte di legalità
nel paese, che si esprime anche in questo modo. Con tutti gli inestetismi del
caso. Luigi De Magistris, quando venne eletto deputato europeo, fu tra i più
votati in assoluto. E a Napoli, quando si è candidato sindaco, è stato un
plebiscito. La domanda da farsi è: perché De Magistris prese tutti quei voti?”.
E perché li prese? “Li prese perché le persone ritengono che quello della
legalità sia un nervo scoperto del paese. Se la gente vuole l’angelo vendicatore
c’è un motivo. Può essere che sia immaturità dell’elettorato, ma può darsi che
invece sia soprattutto un fortissimo desiderio di legalità. Allora la politica
invece di lamentarsi della patologia, dovrebbe domandarsi perché la patologia ha
grande successo. E porvi rimedio”. L’inchiesta che rese famoso De Magistris, la
notissima Why not, si è poi afflosciata come un pallone sgonfio, anzi alla fine
a essere condannato dal tribunale di Roma è stato proprio De Magistris: un anno
e tre mesi per abuso d’ufficio. “Il paese accetta gli errori, le contraddizioni,
gli inestetismi e le cadute di stile, come quella di candidarsi nello stesso
collegio in cui si è indagato con grande clamore. Accetta persino il sospetto
della strumentalità, e lo fa perché questi aspetti sono considerati meno
importanti di una battaglia di principio. Della battaglia per la legalità”. E
lei dottore, lei ritornerà a fare il magistrato? “Ad oggi la mia idea è di
tornare in magistratura, ma il mio incarico all’Autorità anticorruzione scade
nel 2020”. E insomma c’è tempo. E mai Cantone è stato iscritto a un partito,
come dice. Ma a una corrente della magistratura, sì. “Al Movimento per la
giustizia, che era la corrente di Giovanni Falcone. Sono stato presidente
dell’Anm regionale in Campania. Sono stato segretario del Movimento per la
Giustizia a Napoli, ho sempre fatto parte attiva nel mondo della magistratura
organizzata. A Napoli creammo una lista che si chiamava “Primo maggio”, c’era
anche De Magistris”. Siete amici. “Con Luigi? Eravamo amici, anche se lui mi ha
un po’ punzecchiato di recente. Aveva la stanza accanto alla mia in procura”. E
De Magistris, o’ sindaco di Napoli, è uno dei tanti magistrati contagiati
dall’infezione della politica, uno di quelli che ha fatto “l’operazione”,
contribuendo non poco all’ambiguità dei tempi. “De Magistris si è dimesso dalla
magistratura”. Ma non sono troppi i magistrati in politica e nelle
amministrazioni, persino quelli in aspettativa? “E’ un diritto che non si può
negare, e un sistema che non garantisca il libero accesso alle cariche
amministrative o rappresentative sarebbe un sistema ben poco democratico. Certo,
ci vogliono regole d’accesso, ma il pluralismo delle provenienze arricchisce la
democrazia. Il problema vero è il periodo successivo, sono le cosiddette porte
girevoli”. Cioè i magistrati che dopo aver fatto politica tornano a indossare la
toga, e senza passare dal via. “Alfredo Mantovano oggi è giudice in tribunale”,
ricorda Cantone. E Michele Emiliano, da pubblico ministero di Bari, nel 2004 si
fece eleggere sindaco della città in cui aveva indagato. Oggi è presidente della
regione Puglia. Emiliano è un politico o è un magistrato? “La scelta delle
dimissioni è un fatto personale. Non può essere obbligatorio”. Tuttavia Pietro
Grasso si è elegantemente dimesso dalla magistratura. “Ma era prossimo alla
pensione!”. Pausa. Sorriso. “Guardi, una cosa è sicura: chi ha fatto politica,
poi non può tornare a fare il giudice esattamente come gli altri”. Sabino
Cassese ne ha scritto sul Corriere di recente, persino il Csm ha evidenziato il
problema. “Ma non può essere il Csm a intervenire. Sono la politica e il
Parlamento che devono fare una scelta di fondo. La magistratura ordinaria ha già
fatto molto, come organismo, nel “self-restraint”: ha rinunciato agli arbitrati,
alla giustizia sportiva… Tocca alla politica assumersi la responsabilità di una
scelta. Non si può prevedere per legge che un certo ruolo all’interno del
ministero della Giustizia sia riservato a un magistrato, e poi stupirsi con
recitato scandalo se è un magistrato a ricoprirlo”. E forse vuole dire che in
questo astratto paese il nodo pratico e urgente delle questioni si diluisce
sempre in dosi omeopatiche tra sguaiatissimi dibattiti da talk-show serale, tra
furbizie e urlanti sceneggiate. E un motivo c’è se Cantone non è precisamente
amato dai suoi colleghi dell’Associazione nazionale magistrati. La sua è una
lingua basica, apparentemente priva di trappole, trabocchetti, doppi fondi.
Sulla Terra dei fuochi, per esempio, Cantone non liscia il pelo del senso
comune: “Vivo a Giugliano, piena terra dei fuochi. E su questa storia so con
cognizione di causa che si sono dette balle spaziali. Si è andati dietro alle
parole di un pentito, Carmine Schiavone, che dal 1993 noi magistrati
consideravamo inattendibile su questo argomento”. Fusti radioattivi, inferno
atomico nelle campagne intorno Casal di Principe. “Mai trovati. Mai nemmeno un
fusto. E quando sono stati trovati rifiuti interrati, non erano mai dove diceva
lui”. Ma la televisione sparava forte, per mesi, ci fu anche una prima pagina
del New York Times. “Quella del traffico dei rifiuti è una faccenda seria. Lei
crede che le zone più industriali della Pianura padana siano meno inquinate
della Terra dei fuochi? Nessuno si è occupato di queste faccende per decenni.
Poi all’improvviso si è creato un mostro mediatico, tutto suggestione, umori,
sensazionalismo, pigrizia, ignoranza, si è fatto confusione tra la spazzatura
bruciata, quella seppellita e quella che appesta certe zone della campagna. Un
polverone inutile, che adesso ovviamente si è depositato. Nel silenzio e
nell’inazione”. A Caivano, padre Patriciello, prete di strada e di popolo,
malediva i pomodori dal pulpito. “Io rispetto don Patriciello. Ma lui non è un
medico, non è uno scienziato e non è nemmeno un poliziotto. Si è fatto un
collegamento acrobatico tra i rifiuti interrati e l’insorgenza dei tumori. Un
collegamento smentito dai tecnici. Ne è venuto fuori un pasticcio imprendibile.
Lei pensi che alle ultime elezioni, lì dove abito io, si è persino presentata
una lista che si chiamava ‘Terra dei fuochi’”. E insomma, dice Cantone,
l’emotività è gratuita, fine a se stessa, il suo proposito non è la risoluzione
dei problemi (che per loro natura sono pratici, non filosofici né sentimentali),
ma soltanto di creare sempre nuovi pretesti al suo libero e spensierato gioco ai
danni dell’azione e persino dell’efficienza. E queste sono evidentemente
posizioni che gli condensano attorno al capo vaste nubi di antipatia. Come
quando, a Milano, presentando il libro dell’ex magistrato Piero Tony, disse che
le correnti della magistratura “sono un cancro”. E Md? “Non mi piace l’utilizzo
della giustizia come lotta di classe”. E l’Anm? “Non mi sento rappresentato”. E
il Csm? “Un centro di potere vuoto”. Oggi Cantone dice che “molti di quei
giudizi erano semplificati, perché si trattava della presentazione di un libro.
E forse certe parole non le avrei dovute utilizzare, anche se esprimevano
concetti di cui sono ancora persuaso. Per quelle frasi ho ricevuto attacchi
violentissimi sulle mailing list della magistratura, ma ho anche ricevuto un
numero rilevante di messaggi privati, di mail di incoraggiamento personale, da
parte di moltissimi colleghi, attestati che ritengo importanti”. Anche l’Anm
l’ha criticata. “Persino in questi giorni leggo giudizi molto severi nei miei
confronti sulla questione degli arbitrati, critiche da parte di colleghi che a
Napoli appartengono alla lista dalla quale anche io provengo, magistrati che
forse mi votarono persino. Vede, l’Anm non è la magistratura. E la magistratura
non è un monolite. E’ un potere diffuso che rozzamente alcuni politici pensano
si muova come un partito. E’ ridicolo. E’ una cosa tecnicamente impossibile. La
magistratura è composta da molti uomini e molto diversi. E anche l’esercizio di
critica, la vivacità persino dura con la quale si discute, ne è una prova, oltre
a essere un sintomo di salute democratica”. Berlusconi parlava di partito dei
giudici. “Non solo Berlusconi. Ci sono uomini politici che pensano di poter
influenzare un tribunale o una procura favorendo delle nomine, ingraziandosi
alcune personalità della magistratura. Ma non è così che funziona. Questa è
un’idea sciocca. Con tutti i suoi difetti la magistratura italiana non soltanto
è un’istituzione libera da condizionamenti, ma è un fondamentale presidio di
legalità”. Con tutti i suoi difetti. “La magistratura ha spesso esorbitato, ci
sono stati esempi di protagonismo esasperato. Ma l’umanità, si sa, è un legno
storto”. E bene ancora non si capisce quale ruolo lui sia destinato a giocare in
quel labirinto di specchi, strumentalizzazioni e furberie che da circa vent’anni
è il conflittuale e intrecciato rapporto tra politica e giustizia. Mezzo
politico e mezzo magistrato, un po’ tecnico e un po’ no, attore del renzismo e
agito da Renzi, sottoposto alla maledizione che sempre grava sugli uomini della
provvidenza, Cantone è una delle creature più enigmatiche della nuova era
italiana: non è Di Pietro e non è nemmeno De Magistris, non è uno di quei pm che
ha indagato la politica e ha poi indossato la pelle dell’imputato. “Faccio solo
il mio mestiere”, dice lui, gettando uno sguardo distratto all’orologio, nel suo
studio ammobiliato come un ministero di fascia alta, divano e poltrone come si
deve, l’arazzo settecentesco, il ritratto del presidente della Repubblica. “E’
mezzogiorno, devo scappare”, dice. Va dal governatore della Banca d’Italia. Come
un ministro. Forse di più.
CHI TUTELA LA SALUTE DEI CITTADINI ???
RIFIUTI IN ITALIA. RACCOLTA DIFFERENZIATA: SI
PARLA BENE, SI RAZZOLA MALE
Nei sacchi neri del Palazzo del potere finiscono
carte intestate, caffè e avanzi di salame
Gigi D’Alessio, mito pop della cultura musicale
partenopea, t-shirt gialla in posa davanti al Castel dell’Ovo di Napoli,
esortava «Anche tu fai come me» e prestava così il suo volto alla campagna per
la raccolta differenziata che il ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo
aveva fortemente voluto insieme al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
Da lì è ripartita «Striscia la notizia», che il 22 settembre 2008, per
inaugurare la 21ª serie, ha mandato in onda lo «scoop» dell’inviato Valerio
Staffelli proprio sul comportamento dei palazzi del potere in materia di
differenziata.
Le telecamere nascoste frugano nei sacchi di
immondizia davanti a Palazzo Chigi (sede del Governo) e Palazzo Madama (Senato):
ne escono pomodori, salame, caffè, bottiglie di plastica, carta intestata
«Governo italiano». E il camioncino dell’immondizia riversa il suo contenuto in
un camion più grande; di differenziata neanche l’ombra.
EMERGENZA RIFIUTI
Gestione ''arretrata'' dei rifiuti, ''grave
emergenza'' in cinque regioni (Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia),
produzione boom con 32 milioni di tonnellate nel 2005 contro i 26 milioni del
'96, ancora primato assoluto della discarica con il 54% dei rifiuti urbani
raccolti. Intanto la raccolta differenziata divide l'Italia in tre con il 38,1%
al nord, il 19,4% al centro e l'8,7% al sud. Grave il quadro sulla gestione dei
rifiuti speciali e pericolosi: ''Ben 26 milioni sono scomparsi nel nulla nel
2004''. Commissariati per l'emergenza ''un fallimento costato 1,8 miliardi dal
'97 al 2005''.
Questa la fotografia scattata in un dossier al
centro dell'VII Congresso nazionale di Legambiente presentato a Roma il 4
dicembre 2007 al convegno dal titolo ''Emergenza rifiuti, fuori dal tunnel - Le
luci, le ombre e le proposte per superare la crisi''.
In particolare dal Congresso di Legambiente
emergerebbe un'Italia con molte ombre e qualche luce. Ecco il
pacchetto-immondizia che contraddistingue il nostro Paese:
Produzione: 32 milioni nel 2005 contro poco meno
di 26 milioni nel '96.
Gestione: 54% dei rifiuti urbani prodotti finisce
in discarica.
Raccolta differenziata: Italia a tre velocità. Nel
2005 il nord a 38,1% con punte record in Veneto con 47,7% e in Trentino Alto
Adige con il 44,2%; il centro al 19,4% e solo in alcune aree allo standard del
nord; il sud all'8,7%. Per le città, la prima su 103 capoluoghi di provincia è
Novara con 66,9%, ultima con 1,8%. Milano è 43° con il 30,5%, Roma 64° con
16,2%, Napoli 94° con 6,1%.
Rifiuti pericolosi: 26 milioni di tonnellate
scomparsi nel nulla nel 2004.
Ombre: in 4 anni la novità negativa più importante
è il Codice ambientale (ora in revisione dall'attuale Governo); mancato avvio
operativo per il sistema di raccolta dei rifiuti hi-tech; "incomprensibili
proroghe" sul divieto di smaltire in discarica rifiuti indifferenziati non
pretrattati, divieto previsto inizialmente dal 1° gennaio 2000.
Luci: crescita del numero dei comuni "ricicloni".
Quelli con oltre il 35% di differenziata premiati nel 2007 sono stati 1.150
contro i 300 del 2000.
Emergenza: ancora in 5 regioni, Calabria,
Campania, Lazio, Puglia e Sicilia.
In Puglia e Sicilia il regime commissariale non è
stato prorogato.
Commissariamenti: "Un fallimento da 1,8 miliardi
di euro" spesi tra il 1997 e il 2005 senza alcun sostanziale miglioramento della
gestione dei rifiuti.
Proposte: modifica del Codice ambientale; ecotassa
con aumento dei costi smaltimento in discarica; raccolta porta a porta per
spingere su differenziata; politiche e incentivi per riduzione di rifiuti e
imballaggi; regime ordinario nelle regioni commissariate; premio economico all'
attività dei Consorzi per il riciclaggio dei rifiuti.
PARLIAMO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI
I rifiuti solidi urbani (umido, carta, vetro,
alluminio, ecc.) ed i rifiuti speciali sono una risorsa che può creare lavoro e
ricchezza. Il valore del materiale raccolto ed il risparmio sul suo smaltimento
porterebbe benefici per tutti:
ai cittadini che pagherebbero meno la tassa sui
rifiuti;
ai disoccupati che troverebbero lavoro per la
raccolta porta a porta;
alle amministrazione che coniugherebbero lavoro,
risparmio, tutela ambientale;
alle imprese specializzate per il riutilizzo che
avrebbero una vera raccolta differenziata.
Questo perché spesso non è raccolta differenziata
quella che si fa. Tutti gli errori e gli orrori del riciclo spiegato da Anna
Tagliacarne.
Differenziare è fondamentale, ma l’errore è sempre
in agguato. Gettate i giornali nel cassonetto condominiale per la carta e
trovate residui di pizza in un cartone? In quello del vetro adocchiate un piatto
di ceramica e una pirofila in frantumi? Sono gli errori più comuni. Come la
Barbie in mezzo alle bottiglie dell’acqua. O i vasi sporchi di terra. Ma cosa
succede quando ciò che gettiamo in pattumiera non è adatto al riciclo?
VETRO - «Si crea un grosso danno al ciclo
produttivo, soprattutto buttando ceramica e pirex in mezzo al vetro. I detector
non riconoscono le particelle di ceramica, pur essendo macchine molto
sofisticate, e quando il vetro viene triturato e compresso, anche la ceramica,
che fonde a una temperatura differente dal vetro, viene inglobata nelle nuove
bottiglie», spiega Walter Facciotto, direttore generale del Conai, Consorzio
nazionale imballaggi. «Queste bottiglie però, che contengono particelle
differenti dal vetro, possono scoppiare, sono a rischio». Quindi dipende da noi
la qualità delle nuove bottiglie in circolazione. Riciclando un chilo di vetro
si evitano le emissioni di CO2 di una utilitaria che percorre quasi 10
chilometri, secondo i dati del Coreve (Consorzio recupero vetro), mentre grazie
al recupero e al riciclo di carta e cartone tra il 1999 al 2011 il Comieco
(Consorzio nazionale recupero e riciclo imballaggi a base cellulosica) ha
evitato la formazione di 222 discariche.
CARTA - «Per quanto riguarda la carta, l’errore
più comune è buttare gli scontrini, carta termica che contiene solventi e
aumenta lo scarto, oppure cartoni sporchi, con avanzi di cibo, che fermentano»,
continua Facciotto. Bisogna sottolineare che la raccolta differenziata è
strettamente limitata ai soli imballaggi: e in questo senso gli errori più
vistosi li registriamo tra i manufatti in plastica: giocattoli, articoli per la
casa, articoli di cancelleria, da ferramenta e giardinaggio, piccoli
elettrodomestici, qualsiasi oggetto in plastica o con parti in plastica, viene
erroneamente buttato nella raccolta differenziata ma, per fare un esempio, una
bambola o un gioco in generale, è prodotta con differenti polimeri, non
riciclabili.
PLASTICA - Lo stesso vale per il vaso o la penna
sfera, anche se privata del refill. Nella fase di selezione i singoli polimeri
vengono separati prima del riciclo, e ciò che viene scartato va ai
termovalorizzatori e recuperato energeticamente». Se con venti bottiglie di
plastica (Pet) si fa una coperta in pile, con sette vaschette portauova si può
tenere accesa una lampadina per un’ora e mezza, e le tonnellate di rifiuti in
plastica raccolte in Italia lo scorso anno (dati Corepla, Consorzio raccolta
recupero riciclaggio rifiuti imballaggi in plastica) sono pari a sette volte il
volume della Grande Piramide in Egitto e a due volte il peso dell’Empire State
Building. Considerando la mole dei rifiuti prodotti è quanto mai opportuno
separare e riciclare al meglio. Anche perché i rifiuti «migliori» hanno più
valore. Maggiore è la qualità del materiale che scartiamo, maggiore è il
corrispettivo riconosciuto ai Comuni.
METALLI - Per l’acciaio, ad esempio, si va da un
minimo di 38,27 euro a tonnellata a un massimo di 83,51 euro, per l’alluminio da
un minimo di 173, 96 euro a tonnellata a un massimo di 426,79. L’Italia è al
primo posto in Europa per il riciclo dell’alluminio: secondo dati Ciai
(Consorzio imballaggi alluminio) nell’ultimo anno è stato recuperato l’80% degli
imballaggi in alluminio circolanti nel Paese, mentre in più di dieci anni
secondo il Consorzio nazionale acciaio sono state recuperate quasi 3 milioni di
tonnellate di acciaio, l’equivalente in peso di 300 torri Eiffel. «Le buone
ragioni per differenziare correttamente non mancano: tutto ciò che scartiamo è
riutilizzabile come materia prima, se lo buttiamo correttamente», conclude
Walter Facciotto. «Per questa ragione, dovremmo andare periodicamente alle isole
ecologiche e smaltire là le lampadine, i piccoli elettrodomestici, i cellulari,
il legno. È un piccolo gesto che ognuno di noi può fare per l’ambiente senza
troppa fatica».
Ci siamo mai chiesti se e quanto convenga al
cittadino fare la raccolta differenziata della spazzatura, anziché buttare il
“tal quale” nel cassonetto?
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ha un
costo per la comunità: per le aziende di raccolta e per l’ecotassa di
smaltimento alle discariche.
Il riciclaggio è più complesso dello smaltimento
in discarica o negli inceneritori, cui non si sostituisce, ma che ne limita
comunque l'utilizzo. Si parla di sistema di riciclaggio riferendosi all'intero
processo produttivo, e non soltanto alla fase finale; questo comporta la
raccolta differenziata dei rifiuti, passaggio fondamentale del processo. Per
realizzare una raccolta differenziata efficace è di grande importanza la fase di
differenziazione attuata dai singoli utenti. Il riciclaggio apre un nuovo
mercato, in cui nuove piccole e medie imprese recuperano i materiali riciclabili
per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici di
beni. Un mercato che si traduce pertanto in nuova occupazione. Se al ricavo
effettuato dalla vendita dei materiali riciclati si destinasse anche il
risparmio effettuato dalla mancata raccolta e smaltimento dei medesimi
materiali, vi sarebbe un incentivo per nuovi posti di lavoro e una raccolta più
efficace porta a porta. Invece le amministrazioni comunali, anziché programmare
una raccolta intelligente e vantaggiosa dal punto di vista economico, la
disincentivano, invitando i cittadini alla raccolta differenziata, senza
diminuire, però, (anzi si aumenta), il costo TARSU pro capite. Probabilmente non
è solo incompetenza, ma un rapporto losco di affari e corruttela, che non deve
essere tranciato tra amministratori ed aziende di raccolta e smaltimento.
Non solo. Ci siamo mai chiesti chi decide gli
aumenti e i ribassi delle nostra bolletta della luce?
Si tratta dell’Autorità per l’energia e il gas
(AEEG), competente nella determinazione delle tariffe della luce e del gas. Non
sono più Eni e neppure Enel a fissare il prezzo e le accise che andiamo a
pagare, come spesso erroneamente ci comunicano i diversi call center. La AEEG
con scadenza trimestrale pubblica sul suo sito diverse delibere contenenti i
valori aggiornati delle componenti che andranno ad imbellettare la nostra
bolletta. La bolletta italiana, anche se ai più non piace e non si fa capire,
può almeno definirsi democratica, poiché sia a nord sia a sud i suoi costi
rimangono invariati: c’è un’unica tariffa nazionale regolata. I costi della
bolletta cambiano a seconda dell’utenza: pagherete la tariffa D2 se siete un
consumatore residente con fabbisogno casalingo che non supera i 3 kW di potenza.
Nel caso invece non siate residenti oppure nel caso i vostri consumi domestici
superino una capacità di 3 kW pagherete automaticamente una tariffa più cara,
chiamata tariffa D3.
Ma andiamo ad analizzare le voci segrete della
bolletta: si parla di costi di trasporto, prezzo energia ed accise, ma in realtà
le voci sottintese sono molte di più.
Quando accendiamo la luce, in realtà paghiamo:
una quota potenza, che rappresenta un fisso
all’anno da moltiplicare al valore della propria potenza casalinga; il valore di
tale quota varia a seconda della tariffa utilizzata;
una quota fissa, un fisso da pagare una volta
all’anno;
una quota energia, ancora un fisso da pagare in
base ai propri consumi, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture
dedicate al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura;
un prezzo energia, che è la componente che ci
interessa di più, poiché va a coprire i costi di approvvigionamento dell’energia
elettrica. Quando i fornitori di energia elettrica ci parlano di sconti si
riferiscono solo a questa componente. Questo costo influisce per il 60%
sull’intera bolletta della luce. E’ solo su questa voce che si devono fare i
calcoli per eventuali sconti derivanti da impianti fotovoltaici domestici;
il prezzo dispacciamento, un piccolo costo che si
riferisce alla gestione della trasmissione giornaliera di energia;
la componente Disp.BT, che va a coprire ulteriori
costi del dispacciamento;
la componente UC1 che copre i costi dovuti
all’acquisto dell’energia elettrica, tale componente non viene pagata se si è
già passati al mercato liberalizzato.
Ora seguono le componenti chiamate oneri generali
di sistema che incidono per l’8% sulla bolletta:
la componente UC3 è prevista per la perequazione
dei costi di trasmissione e di distribuzione;
la UC4 è per le imprese elettriche minori;
la componente MCT è a favore dei siti che ospitano
centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, fino al
definitivo smantellamento degli impianti (anche se in realtà ora non si parla
più di smantellare ma di ricostruire centrali nucleari);
la AS è una componente introdotta il 1° ottobre
2008 per compensare le agevolazioni previste per quei clienti che usufruiranno
della tariffa sociale;
la A2 è un’ulteriore componente per lo
smantellamento delle centrali nucleari;
la A3 è per la promozione della produzione di
energia da fonti rinnovabili;
la A4 copre i tariffari speciali, previste per
esempio per le Ferrovie dello Stato;
la A5 è per il finanziamento delle attività di
ricerca e sviluppo;
infine la A6 è dovuta ai costi sostenuti dalle
imprese in seguito alla liberalizzazione. Tale componente è al momento uguale a
zero.
E ancora le tasse chiamate imposta erariale e
accisa comunale che vanno a coprire il 14% dei costi totali della bolletta. E
infine c’è l’immancabile l’Iva del 10% - 20%. È stata una lunga apnea, ma ora
possiamo leggere con occhi più consapevoli la nostra bolletta della luce, e
comunque capire che i costi fissi, rimangono tali, mentre solo i costi
variabili, diminuiscono con l’uso del fotovoltaico, salvo che non diventa un
onere il suo mancato uso.
Inceneritori, termovalorizzatori e
discariche: che impatto hanno sulla salute? Dal
pericolo delle discariche ai rischi della presenza di inceneritori, dal
collegamento tra rifiuti e malattie alle raccomandazioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità: quanto è necessario sapere per capire i danni che può
arrecare l’immondizia all’uomo e all’ambiente, scrive Margherita De Bac il 18
novembre 2018 su "Il Corriere della Sera".
Cosa sono le discariche?
Sono in genere vecchie cave impermeabilizzate dove
vengono stipati a vari strati i rifiuti compattati. L’immondizia produce
percolato, liquido della decomposizione che se non viene raccolto bene e
trattato in impianti di depurazione può inquinare le falde acquifere. Quando la
falda si riempie possono essere autorizzati i sopralzi, le montagne di rifiuti
che «ornano» alcuni panorami.
E gli inceneritori?
Quelli degli anni 50-70 bruciavano materiali
eterogenei, in assenza di filtri, e rilasciavano dai grandi camini emissioni in
grande quantità su aree ristrette con formazione e dispersione di diossina, una
sostanza cancerogena. Gli inceneritori di seconda generazione (o
termovalorizzatori) dovrebbero seguire le Best Available Techiques europee degli
anni 90. Dovrebbero essere bruciati, in condizioni ben definite, materiali
selezionati in modo da prevenire o ridurre la formazione di una serie di
inquinanti. I camini sono alti e le emissioni si diffondono su aree vaste.
Perché la Terra dei fuochi è chiamata così?
È un’espressione degli anni Duemila che indica una
vasta area della Campania, a cavallo tra Napoli e Caserta. I comuni all’interno
del perimetro sono elencati in una legge del 2014: sono 55, poi estesi a 90. La
denominazione si riferisce all’interramento di rifiuti tossici speciali e
all’innesco di numerosi fuochi per eliminarli con conseguenze sulla salute della
popolazione circostante.
Cosa si sa del rapporto tra rifiuti e malattie?
L’Istituto superiore di sanità con una legge del
2014 è stato incaricato di effettuare un aggiornamento della situazione. I dati,
rilevati tra 2010 e 2011, sono stati pubblicati nel 2015 e, secondo quanto ha
riferito il sottosegretario alla Salute Bartolazzi rispondendo a
un’interrogazione parlamentare, hanno «evidenziato che il profilo di salute
della popolazione residente nella Terra dei fuochi è caratterizzato da una serie
di eccessi della mortalità, incidenza di tumori e ricoveri in ospedali per
diverse patologie. Queste patologie fra i fattori di rischio includono
l’esposizione a inquinanti rilasciati da siti di smaltimento illegale di rifiuti
o alla combustione incontrollata». Nessuna ulteriore richiesta di
approfondimenti è arrivata all’Istituto.
Esistono studi sull’eventuale impatto sulla salute
dei termovalorizzatori?
Uno dei più completi è il progetto Moniter
(pubblicato nel 2013 sulla rivista Epidemiology) che riguarda gli inceneritori
di seconda generazione dell’Emilia-Romagna. Gli impianti moderni e ben
controllati hanno un impatto molto minore sulla salute dei residenti, anche se è
stato rilevato un eccesso di nascite pretermine.
Il tema del rischio legato ai rifiuti pericolosi
come viene affrontato a livello europeo?
Nel giugno 2017 a Ostrava i 53 Paesi della Regione
europea dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno per la prima volta
inserito fra le priorità il tema dei rifiuti pericolosi e dei siti contaminati.
L’Oms già nel 2015 ha approvato un documento che insisteva sulla necessità di
ridurre il più possibile la produzione di rifiuti e potenziare il riciclo e il
riuso.
L’Oms come si è espresso sui rifiuti?
L’agenzia mondiale ha rilevato che resterà sempre
una frazione di immondizia da smaltire ed è preferibile che ciò non avvenga
nelle discariche ma negli inceneritori di nuova generazione costruiti secondo
le Best Available Techniques, capaci di produrre energia. (Hanno risposto alle
domande Pietro Comba, direttore del reparto di epidemiologia ambientale e
sociale dell’Istituto superiore di sanità e Michele Conversano, direttore
dipartimento prevenzione Asl Taranto).
Perché i rifiuti in Italia sono ancora un
problema, scrive domenica 18 novembre 2018 "Il Post".
Con pochi impianti adeguati e proteste che bloccano quelli nuovi, anche
l'aumento della raccolta differenziata finisce per produrre guai: il risultato
sono i roghi nei capannoni. Da un paio di settimane si è tornati a discutere
della difficile situazione in cui si trova la gestione dei rifiuti in Italia. Il
problema è che ci sono pochi impianti adeguati e c’è troppo materiale da
smaltire, e la combinazione di questi due fattori – che ha varie cause – sta
portando tutto il sistema in una situazione di stallo, non riuscendo più a
sostenere lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti in Italia. Non si parla
soltanto dei cassonetti stracolmi di alcune città che tante volte hanno fatto
parlare di “emergenza rifiuti”, ma di un problema a monte che riguarda tutto il
sistema nazionale della gestione dei rifiuti e che ha come conseguenza i sempre
più frequenti incendi dolosi nei capannoni, le discariche abusive e gli impianti
sovraccarichi di materiale, insieme alle nuove discussioni sugli inceneritori e
sui termovalorizzatori.
Dove finiscono i rifiuti in Italia. Per capire da
dove arrivino tutti i problemi bisogna prima spiegare rapidamente come funziona
la gestione dei rifiuti in Italia. In generale la gestione dei rifiuti si può
suddividere in due grandi blocchi distinti: operazioni di recupero e operazioni
di trattamento-smaltimento. Delle prime si occupano principalmente gli impianti
che gestiscono i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, mentre delle
seconde si occupano discariche, inceneritori, impianti di trattamento
meccanico-biologico: lo smaltimento viene definito tale anche se successivamente
può avere come risultato secondario il recupero di sostanze o di energia. Per
quanto riguarda il recupero dei rifiuti, l’Italia è un paese piuttosto virtuoso:
eppure non basta a tenere in piedi tutto il sistema di smaltimento. Ogni anno
più del 50 per cento dei rifiuti urbani – quelli prodotti dai singoli cittadini,
e non dalle industrie – viene riciclato: un dato sopra la media dell’Unione
Europea, dove viene sottoposto a riciclo il 47 per cento dei rifiuti urbani. Il
25 per cento dei rifiuti finisce ancora in discarica, un valore che il
Parlamento Europeo ha stabilito debba essere limitato al 10 per cento entro il
2035. Nel 2016, secondo il rapporto del 2017 dell’ISPRA sui rifiuti
urbani (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), in Italia
sono stati prodotti 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, mentre sono
state 135 milioni le tonnellate di rifiuti speciali (cioè i rifiuti
industriali), a loro volta divisi in pericolosi e non pericolosi. A occuparsi
del riciclo dei rifiuti urbani frutto della raccolta differenziata sono gli
impianti di recupero, mentre per i rifiuti indifferenziati ci sono gli impianti
di smaltimento. Tra quelli più utilizzati ci sono gli inceneritori (chiamati
anche termovalorizzatori quando il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti
viene utilizzato per produrre energia) dove finiscono anche diverse tipologie di
rifiuti speciali, come quelli ospedalieri e industriali.
La raccolta differenziata è un mercato chiuso. La
raccolta differenziata è, paradossalmente, uno dei fattori principali che stanno
causando questa situazione di stallo nella gestione dei rifiuti. In Italia se ne
fa sempre di più – nel giro dieci anni si è passati dal 28,5 per cento del 2006
al 52,5 per cento del 2016 – ma succede che spesso venga fatta male, mischiando
rifiuti che non andrebbero messi insieme. Gli impianti di riciclo che ricevono
questi rifiuti dividono quelli riciclabili da quelli non riciclabili, e
finiscono per riempirsi di materiale di scarto da avviare a smaltimento. C’è poi
un altro problema che riguarda la raccolta differenziata, e cioè che se ne fa
troppa rispetto alla domanda del mercato. I materiali derivati dal riciclo hanno
sempre meno spazio sul mercato, e quello che non si riesce a vendere si prova a
mandarlo in discariche o inceneritori. Quando questi ultimi sono pieni, però,
può succedere quello che racconta Jacopo Giliberto sul Sole 24 Ore a proposito
della plastica: «La plastica che non riesce a finire negli inceneritori viene
accumulata dai riciclatori che non trovano acquirenti del prodotto finito, con
un rischio grande di incidenti. Oppure finisce in mano alla malavita, che
riempie di plastica di capannoni che bruciano».
La questione cinese. Non è l’unica, ma una delle
cause principali del sovraccarico degli impianti è la decisione presa dal
governo cinese l’estate scorsa di diminuire le importazioni dei rifiuti plastici
e cartacei: una scelta che ha messo in crisi non solo l’Italia ma tutta
l’Europa, che vendeva alla Cina gran parte dei suoi rifiuti differenziati. In
Italia questa decisione ha riguardato soprattutto il settore della carta e in
particolare quella da macero, cioè i residui impuri della carta riciclata: il
blocco delle importazioni da parte della Cina infatti non ha riguardato tutti i
materiali plastici e cartacei, ma solo quelli con impurità superiori allo 0,5
per cento. Nel 2016 l’Italia esportava 1,9 milioni di tonnellate di carta e più
della metà finiva in Cina, che poi la riconvertiva in carta da imballaggio; ora
che le nostre esportazioni di rifiuti sono in calo, il ciclo dei rifiuti ha
avuto un improvviso rallentamento e gli impianti italiani si sono trovati con un
surplus di carta da macero da smaltire.
“Not in my backyard”. A complicare questa
situazione c’è lo stato attuale degli impianti italiani, sia di riciclo che di
smaltimento. Per quanto riguarda i primi, alla buona notizia dell’aumento
progressivo dei materiali da riciclare non è seguito nel corso degli anni un
aumento del numero degli impianti, costringendo l’Italia a esportare sempre più
rifiuti all’estero, in particolare verso Austria e Ungheria. Nel rapporto
dell’ISPRA si nota infatti come nel 2016 i rifiuti esportati siano stati il
doppio di quelli importati: 433mila tonnellate contro 208mila. La soluzione
sarebbe la costruzione di più impianti, ma negli anni amministrazioni locali e
proteste dei cittadini hanno rallentato l’espansione, chiedendo in molti casi la
chiusura degli impianti esistenti. Si tratta del cosiddetto fattore nimby
– acronimo per not in my backyard (“non nel mio cortile”) – ovvero l’ostilità
della popolazione alla presenza nel proprio territorio di opere pubbliche, come
appunto gli impianti di recupero o smaltimento, per la preoccupazione dei loro
effetti negativi sulla salute o sul territorio. Questa ostilità ha riguardato
trasversalmente tutta l’Italia e amministrazioni di tutti gli schieramenti
politici, seppure con intensità e frequenze diverse. Possono succedere quindi
cose bizzarre come le proteste per la presenza di un impianto di riciclo TMB
(trattamento meccanico-biologico) nel quartiere Salario a Roma, di cui un
comitato cittadino appoggiato dal PD chiede la chiusura a causa delle emissioni
maleodoranti, e che è invece difeso dal Movimento 5 Stelle; lo stesso Movimento
5 Stelle che ne chiedeva la chiusura prima di governare la Capitale. Quelle per
gli impianti di riciclo, però, sono solo una piccola parte delle proteste
dei nimby. A creare più divisioni e scontri negli anni sono stati gli
inceneritori/termovalorizzatori, le cui emissioni sono state il principale
motivo di preoccupazione. Il dibattito sull’utilità o pericolosità degli
inceneritori va avanti da anni, e anche in questo caso i partiti politici si
sono dichiarati favorevoli o contrari, a seconda della situazione. Lo scontro
più recente è avvenuto nei giorni scorsi all’interno del governo, in seguito a
una visita del ministro dell’Interno Matteo Salvini in Campania. Salvini ha
parlato della necessità di avere più inceneritori per lo smaltimento, sostenendo
che «occorre il coraggio di dire che serve un termovalorizzatore per ogni
provincia, perché se produci rifiuti li devi smaltire». A Salvini ha risposto il
ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, secondo cui in Campania «gli
inceneritori non c’entrano una beneamata ceppa e tra l’altro non sono nel
contratto di governo». Ai due si è aggiunto poi il ministro dell’Ambiente Sergio
Costa, anche lui contrario a nuovi inceneritori, con una risposta piuttosto
semplificatoria: «Quando arriva l’inceneritore, o termovalorizzatore, il ciclo
dei rifiuti è fallito». Il “contratto di governo” parla di rifiuti solo in modo
molto vago, con i soliti richiami a “incentivare la raccolta differenziata”, ma
senza essere più precisi: lo ha ricordato ieri Di Maio, aggiungendo che in
Campania «non bisogna fare il business degli inceneritori ma bisogna fermare il
business dei rifiuti». A proposito degli inceneritori, nel 2014 il governo Renzi
inserì nel cosiddetto decreto “Sblocca Italia” un articolo, il 35, che prevedeva
la costruzione di 12 nuovi impianti – da aggiungere ai 42 attualmente attivi – e
la decisione fu molto contestata dalle opposizioni e dalle associazioni
ambientaliste. Lo scorso aprile un ricorso presentato da alcuni comitati è stato
accolto dal TAR del Lazio, che ha bloccato l’attuazione del decreto rinviandone
la valutazione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea; alcuni giorni fa il
ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha fatto sapere che ne proporrà la modifica
in Parlamento. La proposta di Renzi, però, già all’epoca aveva trovato
l’opposizione del suo stesso partito a livello regionale. È il caso del Lazio,
dove nel 2016 l’allora ministro dell’Ambiente Galletti chiedeva la costruzione
di un nuovo inceneritore per migliorare la gestione dei rifiuti, e a cui si
oppose il suo collega di partito, il presidente della regione Nicola Zingaretti,
oggi candidato alla segreteria del PD. Non solo alla fine il nuovo inceneritore
non si è fatto, ma il 16 ottobre per decisione di Zingaretti è stato chiuso
l’inceneritore di Colleferro, che era rimasto fermo per oltre un anno a causa
delle proteste dei cittadini.
I roghi nel Nord Italia. E arriviamo così ai molti
roghi di rifiuti avvenuti negli ultimi mesi nel Nord Italia, una delle
conseguenze più tangibili della grave situazione in cui versa il sistema della
gestione dei rifiuti. Per capire la causa di così tanti roghi bisogna fare un
passo indietro: con l’articolo 35 del decreto “Sblocca Italia” non si è solo
proposta la costruzione di nuovi inceneritori, ma si è anche introdotta una
nuova norma sulla gestione dei rifiuti urbani tra le varie regioni. Se prima
dello “Sblocca Italia” i rifiuti urbani indifferenziati potevano essere smaltiti
solo nelle zone in cui venivano prodotti, ora è possibile portarli in altre
regioni. Questo ha aiutato le regioni del Centro e del Sud – con impianti e
discariche spesso piccoli e tecnologicamente arretrati, e che rifiutano più
delle altre di costruirne di nuovi – a portare i loro rifiuti nei più grandi
impianti del Nord, ovviamente pagando, ma ha avuto diverse altre conseguenze. La
prima è che gli impianti che si occupano di smaltimento al Nord si sono
ritrovati saturi di materiale da gestire, e per poter continuare a ricevere
rifiuti hanno dovuto alzare le tariffe; la seconda è che, con gli impianti pieni
e i costi aumentati, sono diventati sempre più frequenti, specialmente in
Lombardia, i casi di roghi in discariche abusive e capannoni abbandonati. Quello
che succede è che alcuni imprenditori, piuttosto che cercare di portare i
rifiuti in un impianto di smaltimento a prezzi elevati, preferiscono pagare
qualcuno perché stipi i rifiuti in uno dei tanti capannoni vuoti del Nord
Italia, a cui poi viene dato fuoco per liberarsi del problema. Ovviamente quello
dei roghi non è un fenomeno che riguarda solo il Nord, visto che dal 2014 si
sono contati più di 300 casi in tutta Italia, ma – come dice il ministro
dell’Ambiente Sergio Costa – sarebbe ormai «qualcosa di strutturale».
Dalle città d'arte alle metropoli, tutti
i volti (e i costi) della raccolta differenziata.
L’analisi promossa da Utilitalia e realizzata da Bain, scrive il 16/02/2017
Adnkronos. Porta a porta o stradale con campane e cassonetti, monomateriale o
multimateriale. Non c’è un modo unico per fare la raccolta differenziata in
Italia dove, complici le caratteristiche geografiche, la gestione dei rifiuti e
relativi costi sono influenzati da diverse variabili e ogni città è una storia a
sé. Dalla raccolta delle grandi città come Milano o Torino, a Venezia dove i
rifiuti si raccolgono con le barche nei canali; dalle città balneari come Rimini
che vivono volumi differenti di rifiuti a seconda della stagione turistica, alle
città d’arte con la loro viabilità limitata dal patrimonio architettonico; per
non parlare di comuni montani e delle isole. La scelta degli enti locali e il
lavoro delle aziende di igiene urbana può presentare scenari totalmente
differenti, che vengono studiati da alcuni anni e lo scenario è tracciato dai
risultati dello studio "Analisi Costi Raccolta Differenziata Multimateriale",
promosso da Utilitalia, la federazione delle imprese dei servizi ambientali,
idrici ed energetici, e realizzato da Bain, su un campione rappresentativo del
Paese, pari al 24% della popolazione italiana. Secondo la ricerca, le imprese
che utilizzano almeno una modalità di raccolta multimateriale sono il 94%. I
modelli di raccolta sono principalmente cinque divisi in leggero
(plastica-metalli e carta-plastica-metalli) e pesante (vetro-metalli,
vetro-plastica-metalli, carta-vetro-plastica-metalli). Il modello leggero incide
per il 47%, quello pesante per il 53%. In tutti e cinque i modelli è presente la
raccolta di metalli. Quelli più diffusi sono: plastica-metalli (42%),
vetro-plastica-metalli (25%), vetro-metalli (23%). Guardando alla categoria di
rifiuto, per il vetro il modello più diffuso è quello ‘vetro-metalli’ (23%), per
la plastica è plastica-metalli (62%), per i metalli è plastica-metalli (36%). Il
porta a porta vince, sia pur di poco, con il 51% sulla raccolta stradale (49%).
Nello specifico, quando il modello è il multimateriale leggero prevale il porta
a porta con il 56%; quando invece il modello è ‘pesante’ la raccolta stradale
arriva al 60%. Oltre il 30% dei rifiuti della differenziata sono raccolti con
modalità multimateriale: circa 1,9 milioni di tonnellate all’anno (6% della
produzione totale di rifiuti urbani) su un totale di oltre 6,3 milioni di
tonnellate. Sono oltre 119 mila le tonnellate di carta e cartone (pari al 4% del
totale) raccolte; più di 839 mila quelle di vetro (48%); quasi 819 mila di
plastica (70%); oltre 132 mila di metalli (51% del totale). La percentuale sale
al 56% escludendo dal computo carta e cartone. Perciò considerando soltanto
plastica, vetro e metalli sono quasi 1,8 milioni le tonnellate raccolte con
modalità multimateriale su un totale di quasi 3,2 milioni di tonnellate. “Non
c’è un unico modo di fare le cose – osserva il vicepresidente di Utilitalia,
Filippo Brandolini – ci sono delle variabili che cambiano in base alle
caratteristiche del territorio, della popolazione, della stagionalità. Le
aziende, in generale, sono attente a tutti i modelli che si stanno sviluppando
perché soltanto da un’analisi comparata di dati effettivi, riscontrabili e
statisticamente rappresentativi, si riescono a fare scelte di efficienza
industriale e di riduzione dei costi di gestione”. Il costo di raccolta del
multimateriale in Italia è pari a 185 euro a tonnellata. In generale per la
raccolta multimateriale il porta a porta costa di più con una differenza che
oscilla tra il 30 e il 40%. Costi maggiori che vengono riassorbiti però dal
trattamento industriale successivo, che è naturalmente più basso quando
concentrato su un'unica tipologia. Guardando invece alla comparazione dei costi,
emerge mediamente una maggiore convenienza della raccolta con il sistema
multimateriale rispetto a quello monomateriale. La ricerca rileva anche come, a
fronte di una maggiore efficienza, i valori di intercettazione della
differenziata pro-capite siano mediamente più bassi.
Rifiuti: costi e modelli della raccolta
differenziata in Italia, scrive il 16 febbraio 2017
confservizi.emr.it. Non c’è un modo unico per fare la raccolta differenziata.
Raccolta porta a porta o raccolta stradale con campane e cassonetti, ma anche
raccolta monomateriale o raccolta multimateriale. In Italia, anche per le sue
caratteristiche geografiche, la gestione dei rifiuti è influenzata da diverse
variabili e ogni città è una storia a sé. Dalla raccolta delle grandi città come
Milano o Torino, si va alle peculiarità di Venezia dove i rifiuti si raccolgono
con le barche nei canali; dalle città balneari come Rimini che vivono volumi
differenti di rifiuti a seconda della stagione turistica, si passa alle città
d’arte con la loro viabilità limitata dal patrimonio architettonico; per non
parlare di comuni montani e delle isole. Come è meglio raccogliere il vetro, la
plastica, la carta, il metallo e le frazioni umide dei nostri rifiuti? Come
cambia il costo del servizio di raccolta se basato su un unico cassonetto
stradale, o anche sulle campane per il vetro e sui cassonetti per la carta o il
ferro? È più utile la raccolta monomateriale, che segmenta ogni tipologia di
rifiuto o quella multimateriale che accorpa nello stesso cassonetto
vetro-plastica-metalli oppure carta-vetro-plastica-metalli? Quale è la scelta
migliore perché un Comune raggiunga gli obiettivi di raccolta differenziata
previsti dalla legge? La scelta degli enti locali e il lavoro delle aziende di
igiene urbana può presentare scenari totalmente differenti, che vengono studiati
da alcuni anni e lo scenario è tracciato dai risultati dello studio ‘Analisi
Costi Raccolta Differenziata Multimateriale’, promosso da UTILITALIA – la
federazione delle imprese dei servizi ambientali, idrici ed energetici – e
realizzato da BAIN, su un campione molto rappresentativo del Paese, pari al 24%
della popolazione italiana. Dopo l’analisi che nel 2013 Utilitalia e Bain hanno
presentato sui costi della Raccolta Monomateriale dei rifiuti da imballaggi e
quella del 2015 sulla Raccolta Differenziata della frazione organica (con
un’appendice sulla raccolta indifferenziata) nel 2017 è la volta di uno studio
sui diversi costi sostenuti dalle imprese sulla base delle diverse combinazioni
e modalità di raccolta (stradale e/o domiciliare). La fotografia scattata dalla
ricerca – presentata il 16 febbraio a Roma – offre alcuni dati su composizione,
modelli, sistemi e analisi dei costi della raccolta differenziata, facendo anche
una comparazione tra ritiro stradale e domiciliare. Le imprese che utilizzano
almeno una modalità di raccolta multimateriale sono il 94%. I modelli di
raccolta sono principalmente cinque, divisi in leggero (plastica-metalli e
carta-plastica-metalli) e pesante (vetro-metalli, vetro-plastica-metalli,
carta-vetro-plastica-metalli). Il modello leggero incide per il 47%, quello
pesante per il 53%. In tutti e cinque i modelli è presente la raccolta di
metalli. Quelli più diffusi sono: plastica-metalli (42%), vetro-plastica-metalli
(25%), vetro-metalli (23%). Guardando alla categoria di rifiuto, per il vetro il
modello più diffuso è quello vetro-metalli’ (23%), per la plastica è
plastica-metalli (62%), per i metalli è plastica-metalli (36%). Il porta a porta
vince, sia pur di poco, con il 51% sulla raccolta stradale (49%).Nello
specifico, quando il modello è il multimateriale leggero prevale il porta a
porta con il 56%; quando invece il modello è pesante la raccolta stradale arriva
al 60%. Oltre il 30% dei rifiuti della differenziata – spiega il documento –
sono raccolti con modalità multimateriale: circa 1,9 milioni di tonnellate
all’anno (6% della produzione totale di rifiuti urbani) su un totale di oltre
6,3 milioni di tonnellate. Sono oltre 119 mila le tonnellate di carta e cartone
(pari al 4% del totale) raccolte; più di 839 mila quelle di vetro (48%); quasi
819 mila di plastica (70%); oltre 132 mila di metalli (51% del totale). La
percentuale sale al 56% escludendo dal computo carta e cartone. Perciò
considerando soltanto plastica, vetro e metalli sono quasi 1,8 milioni le
tonnellate raccolte con modalità multimateriale su un totale di quasi 3,2
milioni di tonnellate. “Non c’è un unico modo di fare le cose – osserva il
vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini (nella foto) – ci sono delle
variabili che cambiano in base alle caratteristiche del territorio, della
popolazione, della stagionalità. Le aziende, in generale, sono attente a tutti i
modelli che si stanno sviluppando perché soltanto da un’analisi comparata di
dati effettivi, riscontrabili e statisticamente rappresentativi, si riescono a
fare scelte di efficienza industriale e di riduzione dei costi di gestione”. Il
costo di raccolta del multimateriale in Italia è pari a 185 euro a tonnellata.
In generale per la raccolta multimateriale il ‘porta a porta’ costa di più con
una differenza che oscilla tra il 30 e il 40%. Costi maggiori che vengono
riassorbiti però dal trattamento industriale successivo, che è naturalmente più
basso quando concentrato su un’unica tipologia. Guardando invece
alla comparazione dei costi, emerge mediamente una maggiore convenienza della
raccolta con il sistema multimateriale rispetto a quello monomateriale. La
ricerca rileva anche come, a fronte di una maggiore efficienza, i valori di
intercettazione della differenziata pro-capite siano mediamente più bassi.
Riciclare ma non troppo: ecco i paradossi
della differenziata. La ricerca: se si arrivasse al
70% sarebbe insostenibile. Ma gli esperti insistono: “I benefici per l’ambiente
non hanno prezzo”, scrive Elena Dusi su "La Repubblica" il 23 ottobre 2015. Ma
quanto conviene fare la differenziata? Nel 2001, quando solo il 20% della
spazzatura veniva selezionata, il costo di ogni tonnellata era di 12 euro ad
abitante. Oggi che il tasso di differenziazione ha superato il 42%, il costo del
servizio è quasi quadruplicato: 46 euro per tonnellata ad abitante. Secondo i
dati Nomisma Energia del 2014, quella del riciclaggio non sembra un’economia di
scala. I costi aumentano con il giro d’attività, mentre i ricavi - che coprono
solo un quarto dei costi - sono rimasti fissi, o quasi, negli ultimi anni.
L’impennata dei costi è in parte dovuta al porta a porta, sistema adottato per
raccogliere il 49% di carta, plastica e vetro. Nel 2007 il dato era solo del
28%, secondo un rapporto di Bain & Company per Federambiente. Il servizio di
raccolta a domicilio richiede personale, camion e benzina assai più del singolo
compattatore che ingurgita tutto. Uno studio del gruppo Hera sui “Modelli
territoriali a confronto” ha calcolato nel 2013 che il porta a porta costa più
del triplo rispetto ai cassonetti, anche se garantisce percentuali di
differenziazione più alte. Ed è soprattutto grazie a questo metodo che la
raccolta di materiali riciclabili è balzata in su nonostante il calo della
produzione di spazzatura provocato dalla crisi economica (meno 8% tra il 2007 e
il 2012). Oltre ai costi del porta a porta, il problema di una differenziata
molto spinta è la qualità dei rifiuti raccolti. Più si seleziona, più nei
sacchetti colorati finiscono materiali spuri o scadenti. E i benefici della
differenziata finiscano per diluirsi soprattutto nelle grandi città, dove più
difficile è controllare la qualità dei rifiuti riciclabili. «Oltre una certa
percentuale di differenziazione, i costi aumentano vertiginosamente», conferma
Giovanni Fraquelli, economista dell’Università del Piemonte Orientale e del Cnr
di Torino, autore nel 2011 di uno studio sui costi del riciclaggio con Graziano
Abrate, Fabrizio Erbetta e Davide Vannoni. «Piccole realtà entro i 200-300 mila
abitanti possono raggiungere percentuali del 70% senza enormi aggravi» aggiunge
Fraquelli. «Ma se si cerca di spingere oltre la differenziata si incappa in
costi insostenibili». I dati di Nomisma Energia confermano l’esistenza di un
“confine” oltre il quale non è più conveniente andare. «In Emilia Romagna —
spiega il presidente Davide Tabarelli — abbiamo fatto dei tentativi di fare una
raccolta differenziata molto spinta, ma questo si è tradotto in maggiori costi,
e quindi in aumenti per le bollette, anche del 20%». Abrate e i suoi colleghi
sono molto schietti nel considerare un’altra componente di costo per alcuni
comuni: la corruzione. “Riducendo il loro livello di corruzione a quello medio
del campione — scrivono nello studio The costs of corruption in the italian
solid waste industry — i due più grandi comuni italiani, Milano e Roma,
risparmierebbero rispettivamente 10 e 50 milioni di euro all’anno, pari all’8,8%
e 14% della spesa per i rifiuti”. Per Rosanna Laraia, responsabile del servizio
rifiuti di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)
il riciclaggio resta comunque un impegno imprescindibile: «È vero che i suoi
costi aumentano con la crescita della differenziazione, ma il riuso permette di
risparmiare sulla voce delle discariche». E i benefici ambientali restano
importanti anche quando i prodotti da riciclare sono venduti a paesi dall’altra
parte del mondo. Secondo l’Epa (l’Environmental Protection Agency americana), il
materiale più proficuo da riutilizzare è l’alluminio: riciclarne 500 tonnellate
permette di risparmiare 2mila tonnellate di CO2 equivalente (pari a 1.569 auto),
seguito da carta e cartone (700 tonnellate) e dalla plastica di tappi e
detersivi (192 tonnellate).
Raccolta differenziata, tra conflitti di
interesse e dati segreti: “Costi a carico delle casse pubbliche”.
Tra opacità e critiche dell'Antitrust, il sistema Conai non
garantisce la copertura dei costi di raccolta a carico dei Comuni con i prezzi
di fatto definiti dai produttori di imballaggi. Una situazione capovolta
rispetto a quella di altri Paesi europei, scrive Luigi Franco l'8 ottobre 2016
su "Il Fatto Quotidiano". Domanda numero uno: quanta plastica, carta o vetro
da riciclare ha raccolto il tal comune? Domanda numero due: lo stesso comune
quanti contributi che gli spettano per legge ha incassato a fronte dei costi
sostenuti per la raccolta differenziata degli imballaggi? Due domande le cui
risposte sono contenute nella banca dati Anci–Conai prevista dagli accordi tra
l’Associazione nazionale dei comuni italiani e il Conai, ovvero il consorzio
privato che è al centro del sistema della raccolta differenziata degli
imballaggi. Numeri non diffusi ai cittadini, che possono contare solo su
un report annuale con dati aggregati. Ma i dati aggregati non sempre vanno
d’accordo con la trasparenza. E soprattutto non rendono conto
delle incongruenze di una situazione su cui l’Antitrust di recente ha espresso
le sue critiche, mettendo nero su bianco che “il finanziamento da parte dei
produttori di imballaggi dei costi della raccolta differenziata non supera il
20% del totale, laddove invece, dovrebbe essere per intero a loro carico”. Con
la conseguenza che a rimetterci sono le casse pubbliche, visto che tocca ai
comuni coprire gran parte di quei costi. I dati sulla raccolta differenziata? In
mano a un privato pagato dal Conai – Il sistema Conai, creato alla fine degli
anni novanta per recepire la direttiva europea in materia e per soddisfare il
principio del “chi inquina paga”, funziona così: per ogni tonnellata di
imballaggi immessa sul mercato i produttori di imballaggi versano un contributo
(cac, contributo ambiente Conai) al Conai, che poi distribuisce ai vari consorzi
di filiera le quote spettanti. Per gli imballaggi di plastica il consorzio di
riferimento è il Corepla, per quelli di carta il Comieco, e così via. Tutti
consorzi che fanno capo al Conai e che sono controllati dagli stessi produttori
di imballaggi e da chi li immette sul mercato. Il sistema Conai, che tra le sue
entrate può contare anche sui ricavi ottenuti con la vendita dei materiali
conferiti dai comuni, riconosce a questi un corrispettivo a tonnellata che
dovrebbe compensare gli extra costi sostenuti per la raccolta differenziata
degli imballaggi rispetto a quella dei rifiuti generici. “Solo che ad oggi –
spiega Marco Boschini, coordinatore dell’Associazione dei comuni virtuosi – non
esiste ancora uno studio che stabilisca quali sono realmente in media gli extra
costi sostenuti dai comuni per ogni tipologia di tonnellata di materiale
raccolta”. E così il corrispettivo dovuto ai comuni viene stabilito da
una trattativa effettuata ogni cinque anni nell’ambito del rinnovo dell’accordo
tra Anci e Conai, dove finora hanno prevalso gli interessi del sistema Conai.
Con un particolare: i dati relativi alla raccolta differenziata sono custoditi
nella famosa banca dati, che viene gestita a spese del Conai da Ancitel Energia
e Ambiente (Ancitel E&A), a cui è stata affidata in modo diretto da Anci, senza
alcun bando di gara. Ancitel E&A è una società che, al di là di una quota del 10
per cento in mano ai comuni attraverso Ancitel spa, è al 90 percento
di proprietà di privati. Con un primo conflitto di interessi che salta subito
all’occhio, come fa notare Boschini: “Il Conai e i suoi consorzi di filiera
pagano ad Ancitel E&A la gestione della banca dati e sono quindi i suoi
principali clienti, clienti che hanno garantito finora quasi per intero il
fatturato di tale società. Se dall’elaborazione dei dati dovesse emergere, cosa
peraltro in linea con quanto rilevato dall’Antitrust, che i sovra costi della
raccolta differenziata degli imballaggi sono ben più elevati di quelli
riconosciuti attualmente ai comuni, si verrebbe a determinare un aumento di
costi a carico proprio dei clienti più importanti e decisivi di Ancitel E&A”. Le
critiche dell’Antitrust: “Il sistema Conai copre solo il 20% dei costi di
raccolta” – Quando nel 2013 l’Associazione dei comuni virtuosi ha affidato alla
società di ingegneria Esper (Ente di studio per la pianificazione ecosostenibile
dei rifiuti) la redazione di un’analisi sugli effetti degli accordi tra Anci e
Conai, ecco cosa è saltato fuori: “Analizzando gli ultimi dati disponibili nel
2013 – spiega Ezio Orzes, uno dei curatori della ricerca e assessore
all’Ambiente di Ponte alle Alpi, comune più volte premiato da Legambiente per i
risultati raggiunti nella raccolta differenziata – si è visto che ai comuni
italiani il Conai riconosceva solo il 37% di quanto incassato grazie al cac e
alla vendita dei rifiuti raccolti, mentre i corrispettivi per tonnellata
raccolta ricevuti dai nostri enti locali erano tra i più bassi in Europa. Così,
a fronte dei circa 300 milioni versati dal Conai ai comuni, questi ne spendevano
almeno tre volte tanto per la raccolta degli imballaggi”. Da allora, seppur con
qualche miglioramento dovuto anche alle prese di posizione dell’Associazione dei
comuni virtuosi, lo sbilanciamento a favore dei privati (sistema Conai) rispetto
al pubblico (Anci) è rimasto. Così nel 2015 il sistema Conai ha incassato 593
milioni di euro grazie al cac e circa 225 dalla vendita dei materiali conferiti
dagli enti locali. Valore, quest’ultimo, che potrebbe essere ancora più alto
visto che, per fare un esempio, il consorzio Comieco vende sul mercato libero
solo il 40% della carta recuperata, quota a cui è salito dopo un impegno preso
nel 2011 con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva
censurato l’“opacità gestionale” determinata dalla pratica di cedere alle
cartiere consorziate i materiali raccolti a prezzi inferiori a quelli di
mercato. In ogni caso, a fronte delle somme incassate, nel 2015 il Conai ha
versato ai comuni, secondo quanto comunicato a ilfattoquotidiano.it, solo 437
milioni. Numeri che contribuiscono a creare la situazione che – come detto –
l’Antitrust lo scorso febbraio ha descritto così: “Il finanziamento da parte dei
produttori (attraverso il sistema Conai) dei costi della raccolta differenziata
non supera il 20% del totale, laddove invece, dovrebbe essere per intero a loro
carico”. Una situazione capovolta rispetto a quella di altri Paesi europei,
evidenzia Attilio Tornavacca, direttore generale di Esper: “In Germania e in
Austria i costi di raccolta degli imballaggi domestici sono a carico
esclusivamente di chi produce e commercializza imballaggi. In Francia, secondo
un rapporto del 2015 di Ademe (un’agenzia pubblica di controllo a supporto
tecnico del ministero dell’Ambiente, ndr), la percentuale dei costi di gestione
degli imballaggi domestici a carico di Ecomballages e Adelphes, consorzi che
svolgono una funzione similare a quella del sistema Conai in Italia, nel 2014 è
stata pari al 74,8%”. Un unico sistema, tanti conflitti di interesse – I
conflitti di interesse non si limitano alla gestione della banca dati
Anci-Conai. “Il cac versato in Italia dai produttori di imballaggi è mediamente
tra i più contenuti tra quelli applicati in Europa – spiega Tornavacca -. Ad
esempio in Francia per il cartone si pagano 163 euro a tonnellata, mentre in
Italia solo 4”. E chi decide a quanto deve ammontare il cac? “Il Conai stesso. E
quindi, in definitiva, lo decidono gli stessi produttori di imballaggi che
pagano il cac e che nel consorzio detengono l’assoluta maggioranza delle quote”.
C’è poi un altro punto. Il corrispettivo versato ai comuni dal sistema Conai
dipende dalla percentuale di impurità del materiale raccolto: quante più
frazioni estranee sono presenti per esempio in una tonnellata di imballaggi
plastici conferiti, come può essere un giocattolo che non è classificato come
imballaggio, tanto più bassa è la somma riconosciuta al comune dal consorzio di
filiera Corepla. A valutare la qualità del materiale raccolto sono alcune
società scelte e pagate dal Conai, che potrebbe quindi decidere di rinnovare o
meno il contratto a seconda che siano state soddisfatte o meno le proprie
aspettative. Il che basta a spiegare questo altro potenziale conflitto di
interessi presente nel sistema all’italiana di gestione della raccolta
differenziata. Sebbene infatti l’analisi di qualità possa essere eseguita in
contraddittorio tra le parti, una cosa è chiara: un corrispettivo più basso
versato al comune in seguito al risultato dell’analisi corrisponde a un esborso
inferiore da parte del Conai. E ancora. Che fine fa la differenza tra quanto
incassato dal Conai grazie al cac e alla vendita del materiale raccolto e quanto
versato ai comuni? “In parte viene accantonata a riserva per esigenze di anni
successivi – spiega Tornavacca – in parte viene utilizzata per finanziare la
struttura e tutte le attività promozionali del Conai e dei consorzi di filiera”.
E anche qui casca l’asino su un altro bel conflitto di interessi. Perché nelle
sue campagne promozionali il Conai si guarda bene dal promuovere pratiche che
porterebbero a una riduzione del consumo di imballaggi, come la diffusione
delvuoto a rendere, cosa che avrebbe conseguenze negative sui fatturati dei
produttori suoi consorziati. Conai e Anci: “Siamo per la trasparenza”. Ma la
banca dati resta chiusa a chiave – Tra conflitti di interesse e costi di
raccolta degli imballaggi che pesano soprattutto sulle casse pubbliche, anziché
sui produttori, forse un po’ più di trasparenzaci vorrebbe. Magari rendendo
visibile a tutti i cittadini il contenuto della banca dati da cui siamo partiti.
Che ne pensa il Conai? “La banca dati Anci-Conai – risponde il direttore
generale del consorzio Walter Facciotto – è uno strumento introdotto dal
precedente accordo quadro Anci-Conai (2009-2013) ed è un sistema gestito
direttamente da Anci. Restiamo convinti che sia il primo strumento per
trasparenza e completezza nel settore dei rifiuti, a completa disposizione di
chi ne ha la proprietà (i comuni) e la gestione (società e/o comune medesimo)”.
E siccome la palla viene passata ai comuni, non resta che sentire il parere
di Filippo Bernocchi, delegato Anci alle politiche per la gestione dei rifiuti e
fino a pochi mesi fa presidente di Ancitel E&A: “Io sono sempre stato per il
green open data. Le regole per rendere visibili i dati della banca dati sono
definiti dal comitato di coordinamento Anci-Conai, ma ogni singolo comune
dovrebbe dare il suo consenso perché possano essere pubblicati i dati che lo
riguardano”. In attesa che Anci e Conai chiedano questo consenso, quei numeri
continuano a essere chiusi a chiave nella banca dati.
Lite fra Salvini e Di Maio sui
termovalorizzatori. Salvini, uno per provincia. Di Maio, non c'entrano una
ceppa, scrive l'Ansa" il 15 novembre 2018. Salvini,
serve un termovalorizzatore per ogni provincia. "Occorre il coraggio di dire che
serve un termovalorizzatore per ogni provincia perché se produci rifiuti li devi
smaltire". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno, a Napoli per il
Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. "A metà gennaio va in
manutenzione l'unico termovalorizzatore della regione - ha affermato - è in
pratica una emergenza annunciata". "C'è veramente una incapacità folle - ha
aggiunto - dall'emergenza del 2008 siamo tornati indietro, ma nessun
miglioramento". Di Maio, gli inceneritori non c'entrano una ceppa. "Quando si
viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la
storia e le difficoltà di questo popolo. La terra dei fuochi è un disastro
legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta Italia) non a quelli
domestici. Quindi gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa e tra
l'altro non sono nel contratto di Governo". Lo scrive su Facebook il vicepremier
Luigi Di Maio che fa riferimento, senza citarlo, a quanto affermato da Matteo
Salvini sui rifiuti in Campania. Costa, termovalorizzatore è fallimento del
ciclo dei rifiuti. "Quando arriva l'inceneritore, o termovalorizzatore, il ciclo
dei rifiuti è fallito". Lo ha detto in una nota il ministro dell'Ambiente,
Sergio Costa, dopo che Salvini ha proposto un impianto per ogni provincia della
Campania. "Stiamo lavorando - ha aggiunto - ogni giorno per portare l'Italia, e
non solo la Terra dei Fuochi, fuori dall'ormai cronico ritardo nella gestione
del ciclo dei rifiuti. Riduzione, riuso, recupero, riciclo, sono le quattro R
che devono diventare un mantra per tutti. Chi non è in sintonia con queste
direttrici vive in un'epoca passata". M5S, in contratto esclusa costruzione
inceneritori. "Sia il Contratto di Governo che punta al superamento degli
inceneritori non a costruirne di nuovi, che i numeri della produzione dei
rifiuti in Campania e lo stato d'avanzamento della raccolta differenziata nella
Regione, escludono industrialmente la realizzazione di nuovi impianti
incenerimento". E' quanto si legge in una nota dei parlamentari del Movimento 5
Stelle della Commissione Ambiente della Camera con la capogruppo Ilaria Fontana.
De Magistris, Salvini fra i responsabili dell'emergenza. ''Ricorderei a Salvini
che ha sostenuto un Governo, quello Berlusconi, che è stato tra i principali
responsabili dell'emergenza rifiuti. Credo che si debba lavorare con spirito di
leale collaborazione senza fare battaglie di religione o i professorini e credo
che realizzare un termovalorizzatore in ogni angolo della Campania non sia la
risposta''. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha replicato alle
parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il sindaco ha inoltre
sottolineato che ''di quell'emergenza rifiuti il Comune di Napoli paga anche la
calamità finanziaria perché il debito del Comune è così alto anche a causa di
quell'emergenza''. Salvini, facciamo gestire rifiuti a camorra? "Io sono per
costruire e non per i no, perché con i no non si va da nessuna parte. Questo
vale soprattutto per gli enti locali, penso a tutti quei sindaci e alla stessa
regione Campania che ha sempre detto no, no, no e i rifiuti cosa facciamo? Li
facciamo gestire alla camorra?". Lo ha detto il ministro degli interni Matteo
Salvini rispondendo a Napoli ai cronisti che gli chiedevano della replica di
Luigi Di Maio alla sua proposta di un termovalorizzatore in ogni provincia in
Campania.
Tecnica, paura e fede: lo strabismo dei
grillini. Rifiutano la modernità e sognano l’Eden. La
contraddizione dei 5 Stelle emerge per esempio nel caso dei rifiuti campani con
il no Di Maio ai termovalorizzatori, scrive Antonio Polito il 19 novembre 2018
su "Il Corriere della Sera". Una paura irrazionale del futuro e una fede
incrollabile nell’avvenire possono convivere. Il comunismo ne fu una grande (e
fallimentare) prova. Allo stesso modo il crogiolo di culture che si è fuso nel
Movimento Cinquestelle sembra rifiutare la modernità in cui vive proprio mentre
sogna un Eden post moderno da venire. È singolare il rapporto che i
pentastellati intrattengono con la tecnologia. Ciò che è rimasto del messaggio,
insieme visionario e apocalittico, di Gianroberto Casaleggio, li spinge a
credere che il progresso della tecnica possa risolvere gran parte dei problemi
umani, e questo è un atteggiamento positivo. Ma della tecnica che già esiste
oggi e che fa funzionare, anche meglio della nostra, tutte le altre società
complesse e moderne, diffidano con tutte le loro forze, al punto da tentare di
impedirne l’utilizzo. Il caso dei termovalorizzatori è emblematico. Ci sono in
tutta Europa, in grandi metropoli come Parigi, Vienna e Copenaghen; ci sono
nelle regioni, come la Lombardia o l’Emilia, che hanno risolto da tempo il
problema dei rifiuti. Ma Di Maio dice che non li vuole in Campania perché sono
«vintage», e un giorno non saranno più necessari, quando la raccolta
differenziata e l’«economia circolare» trionferanno. In effetti nessuno può
essere contro il riciclo: è la strada da seguire. Ma anche ammesso che un giorno
nei vicoli di Napoli (dove si differenzia oggi solo il 38% dei rifiuti), si
possa trattare in casa l’immondizia come non si fa ancora neanche in Svezia, un
po’ ne resterebbe sempre da interrare o da bruciare. E intanto, nel frattempo
che non entriamo nel futuro, la «monnezza» che non si può né interrare né
bruciare finisce all’aperto, per strada, sotto i ponti, accatastata su grandi
piattaforme, in siti cosiddetti di stoccaggio, dove il primo che passa può darle
fuoco. Così, in attesa dell’Eden, la gente della Terra dei Fuochi vive
all’Inferno. E i rifiuti viaggiano vorticosamente in giro per l’Italia in cerca
di smaltimento. Dalla sola Roma partono 170 camion al giorno per il Veneto:
inquinano di meno? Ieri a Caserta il governo ha promesso di usare anche i droni,
oltre ai militari, contro i roghi. Bene (anche perché l’impiego dei soldati è
già stato annunciato una volta all’anno da ognuno degli ultimi governi). Ma se,
nel frattempo che non arrivano i droni, si rimuovesse la materia prima
dell’incendio, e cioè l’immondizia parcheggiata in attesa? Già quattordici anni
fa si facevano manifestazioni per impedire la costruzione del termovalorizzatore
di Acerra con lo stesso argomento: che era obsoleto e che in breve tempo non
sarebbe stato più necessario. Pensate dove sarebbe oggi la Campania senza
quell’unico impianto, che oggi smaltisce settecentomila tonnellate di
immondizia, più della metà di quella prodotta ogni anno nella regione. E la cosa
più singolare è che i Cinquestelle si oppongono spesso anche alle soluzioni
alternative da essi stessi proposte. Per esempio a Pomigliano d’Arco, patria di
Di Maio, dove dovrebbe andare uno di quegli impianti per il trattamento
dell’organico (compostaggio) appena sollecitati dal Presidente Fico.
L’immondizia non è però il solo campo di applicazione di questo singolare
strabismo. Sono molti i casi in cui l’attesa di un avvenire migliore si
trasforma nel rifiuto di gestire il presente. Uno degli argomenti usati contro
l’Alta Velocità Torino-Lione è che a breve non ci sarà più bisogno di spostare
tutte queste merci, perché — è stato detto — saranno trasportate dalle stampanti
a tre D. È possibile: chi può dire che cosa ci riserverà il futuro? Ma se si ha
tutta questa fiducia in una tecnologia che non è ancora tra noi, come se ne può
avere così poca in un’altra che usiamo da secoli, e cioè la perforazione della
montagna per fare un tunnel (il Buco del Viso risale al 1480)? Allo stesso modo
si ostenta sfiducia verso le banche che muovono i nostri soldi ma si scommette
sulla tecnologia blockchain, forse nella convinzione che rischieremo di meno
convertendo i nostri risparmi in una moneta virtuale. Oppure si diffida della
democrazia rappresentativa, al punto di immaginare un tempo in cui non ci sarà
più bisogno del Parlamento eletto a suffragio universale; ma si affida quella
«diretta» a una piattaforma dove possono votare non più di centomila persone e
che si è rivelata non esente da rischi di hackeraggio. Cambiare il mondo è
l’aspirazione di tutte le rivoluzioni. Ma nel frattempo? In questa domanda si
misura il divario tra un movimento utopico e una forza di governo. I
Cinquestelle sono ancora lontani dal colmarlo.
L’ITALIA PIÙ PULITA CON I
TERMOVALORIZZATORI, scrive Donato Bonanni il 19
novembre 2018 su L’Opinione. In questi giorni il Movimento 5 Stelle e la Lega
(senza sottovalutare gli altri scontri sulle materie importanti per il nostro
Paese) stanno litigando sull’utilità o meno dei termovalorizzatori. In
particolare, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che tali impianti sono
fondamentali per chiudere il ciclo dei rifiuti e necessari per contrastare
l’affarismo malavitoso. Sono d’accordissimo. Insomma, il tema rifiuti diventa il
detonatore che fa esplodere le contraddizioni della maggioranza parlamentare. I
termovalorizzatori (da non confondere con i classici inceneritori che hanno la
funzione solamente di bruciare i rifiuti) sono impianti ad alta tecnologia, a
impatto zero e rappresentano una parte dell’economia circolare dei rifiuti.
Ovvero, i rifiuti non riciclabili vengono utilizzati per la produzione di
energia elettrica e calore per le comunità locali. Un vantaggio importante per
la collettività. In molte città europee come Vienna, Parigi, Barcellona, Malmoe,
Stoccolma, Copenaghen (ma anche nel Nord Italia), i termovalorizzatori sono
situati nel pieno centro della città e producono vantaggi ambientali ed
economici molto significativi, in grado di soddisfare le comunità locali. In
particolare, il nuovo impianto di Copenaghen, Amager Resource Center (nella
foto), fornisce energia elettrica a più di 60mila abitazioni e acqua calda ad
altre 160mila e mette a disposizione dei cittadini una pista sci realizzata con
materiale innovativo prodotto (guarda caso) da una società italiana. Un grande
capolavoro di progresso tecnologico e ambientale e un modello di gestione
sostenibile dei rifiuti da prendere in considerazione. Perché in Italia, ma
soprattutto, nel Centro e nel Sud non è possibile? A Roma l’emergenza rifiuti è
oramai sotto gli occhi di tutti ed è causata dalla mancanza di impianti quali
quelli di compostaggio, di ammodernamento di Tmb (trattamento meccanico
biologico) dell’azienda municipalizzata Ama e soprattutto dei
termovalorizzatori. Questi ultimi, sono previsti non solo dal Piano regionale
dei rifiuti, ma anche dal Dpcm attuativo dell’articolo 35 del decreto legge n.
133/2014 (il cosiddetto “Sblocca Italia”). La Regione Lazio e il Comune di Roma
non hanno voluto assumersi la responsabilità di realizzare e sbloccare i
termovalorizzatori. Ad esempio, il termovalorizzatore di Colleferro (Rm) è stato
bloccato dalla Regione Lazio (con la complicità del sindaco di quel Comune) e i
lavoratori di quell’impianto gestito da Lazio Ambiente, quale società
controllata dalla Regione Lazio, sono in forte difficoltà economica. La stessa
Regione (e non mi capacito) vuole, invece, incenerire i rifiuti non riciclabili
nei cementifici con conseguenze negative per l’ambiente e per la salute dei
cittadini e riapre nella stesso Comune di Colleferro una grande discarica. La
de-responsabilizzazione politica ha comportato il trasferimento di tante
tonnellate di Css (combustibile solido secondario ricavato dal trattamento dei
rifiuti indifferenziati da parte dei 4 Tmb presenti a Roma) nei
termovalorizzatori di altre Regioni, come in Emilia-Romagna, in Lombardia e
persino in Austria con costi notevoli per la collettività, ossia facendo alzare
di molto la tariffa rifiuti dei romani che è tra le più alte d’Italia. Gli enti
pubblici locali hanno il dovere di investire in un mix equilibrato di
trattamento e smaltimento dei rifiuti: i termovalorizzatori sono una soluzione
innovativa e ambientale fondamentale per spazzare via le organizzazioni
criminali che fanno dei roghi tossici il loro business sporco e dannoso per
l’ambiente e la salute dei cittadini.
Termovalorizzatori, perché ha ragione
Salvini (e i Cinque Stelle fanno un danno enorme all’ambiente).
Prima si eliminano le discariche, poi si può discutere dei termovalorizzatori:
questa è la strategia sullo smaltimento di rifiuti di qualunque Paese serio.
Evidentemente, noi non lo siamo, scrive il 19 novembre 2018 L’inkiesta. 64-35-1.
No, non sono i numeri da giocare al lotto, ma le percentuali di rifiuti che, in
Germania, vengono riciclate, termovalorizzate e mandate in discarica. Se c’è un
modello da cui partire, nel definire il ciclo dei rifiuti in Europa, è questo.
Un modello in cui la totalità (o quasi) degli scarti che produciamo viene
reimmesso nel ciclo economico: due volte su tre come materia prima, una volta su
tre come energia. Se si vuole parlare di rifiuti, cari Di Maio e Conte,
partiremmo da qui. O, se vi sono antipatici i tedeschi, da Paesi come Austria,
Olanda, Belgio, Svezia che non sanno più cosa sia una discarica e non sotterrano
più nulla di ciò che scartano. Di sicuro, eviteremmo di parlare di quanto sono
brutti e cattivi i termovalorizzatori, contro cui i Cinque Stelle hanno messo in
piedi una surreale crociata, ancora di più in un Paese come l’Italia in cui in
discarica ci finisce ancora il 32% dei rifiuti. O in cui il 7% nemmeno viene
trattato e messo su un camion verso il nord Europa.
Se parliamo di malagestione, di costi alle stelle,
di pericolo per la salute e di criminalità organizzata è alle discariche e alle
emergenze che bisogna guardare, non certo ai termovalorizzatori. Ancora di più
eviteremmo di farlo nel Mezzogiorno, dove la gestione dei rifiuti è a livelli
bulgari - letteralmente: le percentuali sono quelle - con una percentuale di
raccolta differenziata quasi dimezzata rispetto al nord Italia (37% contro 64%),
con la totale assenza di impianti di termovalorizzazione e un processo di
smaltimento che, se parlassimo di uno Stato sovrano, si fonderebbe quasi
interamente sulle discariche e sull’esportazione dei rifiuti all’estero. A cui
si aggiunge, ciliegina sulla torta, una gestione carissima rispetto al Nord - la
Tari al sud è del 33,6% più alta rispetto alla media nazionale -, lo
“spettacolo” dei rifiuti abbandonati in strada e l’enorme business che tutta
questa inefficienza genera per la criminalità organizzata. Giova ricordare come
dei 26mila crimini ambientali scoperti ogni anno in Italia, quasi seimila
riguardano la gestione dei rifiuti. E che dietro questi reati, oltre ai roghi
illegali, c’è il pericolosissimo business del giro-bolla per declassare la
pericolosità dei rifiuti e consentirne l’impiego in cantieri e opere (pubbliche
e private) infrastrutturali. In altre parole: se parliamo di malagestione, di
costi alle stelle, di pericolo per la salute e di criminalità organizzata è alle
discariche e alle emergenze che bisogna guardare, non certo ai
termovalorizzatori. Che forse ne sono l'anello meno pregiato, ma che sono
comunque economia circolare, a differenza delle discariche. Non a caso,
all’estero non se ne costruiscono più: una volta eliminate le discariche, la
strategia di gestione dei rifiuti si fonda sulla riduzione, sul riciclo e sul
riuso. Una volta eliminate le discariche, lo ripetiamo. È così che nascono le
terre dei cuori dalle terre dei fuochi, non con i proclami a vanvera e con
l’esercito che controlla che nessuno bruci le pile di monnezza a cielo
aperto. Così dovrebbe affrontare il problema un Paese serio. Evidentemente non
lo siamo.
Così la scienza incenerisce i “no termo”.
Lo scontro sui termovalorizzatori nel governo Lega-M5s e l'idea (sbagliata) che
la raccolta differenziata sia l’alternativa. Stefano Consonni del Politecnico di
Milano spiega dati, sistema lombardo e idee del centro studi MatER, scrive
Daniele Bonecchi il 22 Novembre 2018 su Il Foglio. Il dubbio resta. Lo scontro
sui termovalorizzatori è la nascita dei no termo (un po’ come i no vax e i no
tav) o più semplicemente l’iniziativa “vintage” dell’allegra brigata Di
Maio-Casaleggio per recuperare il terreno elettorale perduto su un Salvini
quotidianamente all’attacco? Il dubbio resta, ma la Lombardia che crede ai fatti
più che alle parole va avanti. Coi suoi termovalorizzatori che macinano rifiuti
(il 34 per cento di tutta Italia) e distribuiscono calore a Milano e Brescia,
con il marchio di efficienza di A2A. E c’è anche chi, come il governatore
lombardo Attilio Fontana, dissotterra l’ascia di guerra dell’antica Lega Nord,
spiegando a Di Maio che “se dice che gli inceneritori inquinano, io rilancio con
questa mezza provocazione e mezza proposta, dicendo che iniziamo a smettere di
bruciare rifiuti di altre regioni” (leggi il Sud). E’ così che inizia la caccia
alle streghe contro i termovalorizzatori. Anche al Pirellone scattano le mozioni
pro e contro, proprio mentre a Brescia il ministro dell’Ambiente Sergio
Costa ostenta le certezze targate Cinque stelle: “Una cosa è aprire
termovalorizzatori, una cosa è chiuderne. Aprirne è antieconomico. Se il primo
gennaio del 2019 dovessimo mai autorizzare un termovalorizzatore ci vogliono non
meno di 7 anni per costruirlo e il businessplan prevede non meno di 20 anni per
il recupero economico. Saremmo nel 2046, quando avremo percentuali tra 90 per
cento e 95 per cento di differenziata e di riciclo e quindi non ci sarà più
nulla da bruciare. Ecco perché dico che è una questione economica, tanto è vero
che le gare vanno tutte deserte”. Non succederà, la competenza scientifica non è
un punto di riferimento per questo governo, ma se il ministro dovesse mai
passare per le aule del Politecnico di Milano gli infilerebbero un bel paio di
orecchie d’asino. “Da molto tempo passa il messaggio che la raccolta
differenziata sia l’alternativa alla termoutilizzazione e alla discarica, ma non
è così”, spiega Stefano Consonni, professore di Sistemi per l’energia e
l’ambiente al Politecnico. “Un equilibrato e moderno sistema di gestione dei
rifiuti necessita della raccolta differenziata, dei termoutilizzatori, di una
piccola quota di discarica (materiale inerte da mettere a riposo al sicuro).
Quindi nel sistema integrato ciascuna tecnologia deve fare la sua parte. Se ne
togliamo una, tutto il sistema non sta in piedi e va in emergenza”. “La
tecnologia della termovalorizzazione – ma possiamo anche chiamarli inceneritori
perché il principio di funzionamento è comunque quello di sottoporre a
trattamento termico di combustione i rifiuti – è nata 150 anni fa con il
primario obiettivo, allora, di sterilizzare, ridurre il volume dei rifiuti e
renderli inerti. Nel corso di oltre un secolo e mezzo di storia questa
tecnologia si è evoluta cambiando radicalmente le sue caratteristiche. Se
potevano essere giustificate le preoccupazioni di oltre un secolo fa per le
emissioni in atmosfera e per l’impatto sull’ambiente, queste preoccupazioni non
sono più giustificate oggi. Diciamo che i termovalorizzatori di oggi sono molto
diversi da quelli che si realizzavano fino a 50 anni fa, hanno anche cambiato
nome non a caso perché mentre gli inceneritori di una volta avevano il mero
obiettivo di smaltire. I termoutilizzatori di oggi hanno un effetto utile: la
produzione di notevoli quantità di elettricità e calore che possono sostituire
combustibili fossili e altre fonti da cui tutt’ora dipendiamo in modo
massiccio”, spiega paziente e puntuale il professore. Ma come stanno in salute
gli impianti italiani? “Gli impianti di termoutilizzazione in Italia sono di
buona qualità, non sono per nulla obsoleti, sono buoni. La Lombardia, quasi
completamente autonoma nel trattamento dei rifiuti, è un esempio con un sistema
integrato ben equilibrato che recupera sia la materia che l’energia. Al Sud
situazione assolutamente insoddisfacente. Roma poi è l’unica capitale europea
senza un impianto di termoutilizzazione. Ci sono ad Amsterdam, a Parigi, a
Stoccolma, a Londra, a Berlino, a Zurigo. Ne hanno tutti. Dove ci sono alte
concentrazioni di popolazione è indispensabile provvedere a una civile e
ordinata gestione dei rifiuti che consiste nel recupero di materia (riciclaggio,
ndr) e recupero di energia”. In questi giorni ha fatto la sua comparsa
l’impianto di Copenaghen, con tanto di pista da sci sul tetto “l’ho visitato
mentre era in costruzione – spiega Consonni – sostituisce un impianto vecchio di
trent’anni. Ma i termovalorizzatori che abbiamo a Milano, Torino e Brescia dal
punto di vista tecnologico e delle prestazioni non hanno nulla da invidiare a
quello di Copenaghen”. I ricercatori del Poli non si meravigliano della sagra
delle bufale promossa da Grillo e soci, che accompagna innovazione e ricerca,
soprattutto in campo ambientale. “Mi sembrano paure medioevali, demoniache, ma
non hanno nulla a che fare con la tecnologia attuale”, protesta il professore. E
poi spiega: “Abbiamo costituito al Politecnico il centro studi MatER (materia ed
energia), che da molti anni si occupa di questi temi nell’ottica di individuare
tecnologie e pratiche che possano garantire la sostenibilità di tutto il sistema
di gestione dei rifiuti”. E’ istruttivo aprire la hompage del sito
(mater.Polimi.it) dove campeggia una frase da “Le città invisibili” di Italo
Calvino: “Una volta buttata via la roba, nessuno vuole più averci da pensare”.
Più avanti c’è una rubrica dal suggestivo titolo: “Rifiutiamo le bufale” e poi
“facciamo chiarezza. Grazie all’aiuto di ricercatori e ricercatrici del Centro
studi MatER, usiamo la scienza per sfatare i falsi miti sul recupero di materia
ed energia dai rifiuti”. Studiare per credere.
Quello che di Maio e Salvini non vi
dicono su rifiuti e termovalorizzatori, scrive Marco
Esposito il 22 novembre 2018 su nexquotidiano. Diceva il buon Einstein che solo
due cose sembravano non avere limiti: l’Universo e la stupidità umana, ma mentre
sulla prima questione aveva dei dubbi della seconda asseriva una certezza. Per
confermare questa dichiarazione di Einstein (da cui ci dissociamo) in questi
giorni hanno parlato di “rifiuti” i due vicepremier che l’Italia ha avuto in
dote: Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il primo ha parlato, a proposito della
Regione Campania e della gestione rifiuti, di “un termovalorizzatore in ogni
provincia”, da cui si evince che, essendocene uno solo al momento, la Campania
avrebbe bisogno di ben 4 termovalorizzatori, sparando una fesseria immane, il
secondo, per non essergli da meno ha detto che “i termovalorizzatori sono una
tecnologia superata”. Forse pensava alla Biowash di Beppe Grillo o al “ponte
dove si mangia” di Toninelli e non sapeva come superarli in fesserie. Se c’è una
cosa su cui il mondo economico-scientifico-tecnologico è abbastanza d’accordo è
la gestione del ciclo dei rifiuti, il luogo di discussione è l’ISWA,
l’associazione internazionale del “waste management”, e in tutto il globo
terracqueo si parla di un ciclo di rifiuti basato su:
1. Biodigestori per l’umido.
2. Recupero metalli, carta, vetro e alcuni tipi di
plastica (in particolare PET e PA6).
3. Recupero dell’energia (termovalorizzazione) da
tutto il resto.
L’accordo è talmente ampio che anche l’Unione
Europea ha emanato una direttiva in tal senso, come anche l’EPA (Ente per la
Protezione dell’Ambiente negli USA): all’interno di queste tre aree esistono
varie tipologie d’impianto, ma nessuno mette in dubbio che da qui si parte, e in
particolare che il punto 3 è fondamentale. Sì, ma quanto e cosa recuperare di
energia? Beh, se ci concentriamo sulla Campania, visto che i due vicepremier di
quello parlavano, la Campania produce circa 2 mln di tonnellate di rifiuti
urbani, di cui il 35% circa di “organico”, ovvero oltre 700.000 tonnellate di
umido. La sola Napoli ne produce circa 500.000 tonnellate. Indovinate Napoli
quanti biodigestori ha? Ve lo dico io: ZERO. Indovinate chi si oppone alla
costruzione di un biodigestore a S. Pietro a Patierno (NA)? Ve lo dico di nuovo
io: il Movimento 5 Stelle. Indovinate cosa fanno oggi di quell’umido? Ve lo dico
io per la terza volta: viene “stabilizzato” e mandato a incenerimento. Di Maio
spara cavolate a raffica, si oppone agli impianti che renderebbero inutili o
quasi altri termovalorizzatori (ne servirebbe un altro, ma son calcoli
economico-scientifici complessi, oltre a coinvolgere problematiche legislative e
di altro tipo che richiederebbero un articolo a parte, per cui credetemi sulla
parola). Ma perchè anche Salvini ha detto una fesseria? Perchè i
termovalorizzatori si reggono solo se bruciano una quantità X di rifiuti con
potere calorifico Y e la Campania non ne produce abbastanza per giustificare
simili sforzi economici, ovvero anche Salvini chiacchiera “a vanvera”. Potrei
adesso annoiarvi con varie considerazioni, ma ve ne sottopongo una sola: il
Movimento 5 Stelle si oppone ai biodigestori “anaerobici” per motivi ideologici,
e dice che quelli “aerobici” sono migliori (se volete vedere un biodigestore
anaerobico digitate su Google “biodigestore di Augusta” e poi preparate le
ghiandole salivari per quando incontrate un pentastellato). Comunque alla
conferenza del clima di Parigi si è deciso di chiedere il bando per un tipo di
digestori, in quanto “fortemente inquinanti”. Indovinate quale tipo…sì, esatto,
quelli che piacciono a Di Maio. Colui che vive in una cabina telefonica a
gettoni.
Le fake news (smontate) sui
termovalorizzatori, scrive Raffaella Tregua su
Quotidiano di Sicilia il 20 novembre 2018. Giuseppe Mancini, docente di Impianti
chimici di UniCT spiega i luoghi comuni in cui è facile cadere. Dopo che lo
scontro tra i leader del governo Giallo-Verde, i ministri Luigi Di Maio e Matteo
Salvini, ha riacceso il dibattito sui termovalorizzatori, per sfatare le false
notizie che impazzano in questi giorni, soprattutto sul web, abbiamo
intervistato Giuseppe Mancini, docente di Impianti chimici del Corso di laurea
in Chemical engineering for industrial sustainability dell’Università degli
studi di Catania. Ecco alcuni luoghi comuni in cui è facile cadere:
La raccolta differenziata risolve tutti i
problemi (FALSO). La raccolta differenziata è uno
strumento, non il risultato finale da raggiungere. Se per anni hai raccontato
alla gente che i termovalorizzatori sono brutti e cattivi e che facendo la RD
risolvi completamente il problema dei rifiuti, quando la gente inizia a farla
sul serio e con fatica, pretende che il problema sia risolto mentre del tutto
risolto non è perché c’è ancora tutto il rifiuto residuale ancora da gestire ed
è tantissimo. A meno che non lo si voglia continuare a mandare in discarica o
peggio spedire all’estero. E se non si mette in moto, parallelamente e nel lungo
periodo, un mercato dei materiali riciclati che assorba veramente tutti i flussi
(quindi anche cartiere, vetrerie, impianti per la produzione di prodotti in
plastica riciclata) che sia in loco (meglio) o anche all’estero, la sola corsa
all’aumento della RD, con o senza qualità, porterà comunque ad un sistema
industriale insostenibile e dovremo accumulare il materiale raccolto a caro
prezzo in mega depositi come abbiamo fatto per le eco-balle di Napoli. Lo sapete
che queste, di sole multe, continuano a costare un caffè all’anno a tutti gli
italiani, bambini compresi? Certo mi si dirà: cosa vuoi che sia un caffè
all’anno? Ma 60 milioni di caffè all’anno per decine di anni, dico io, non fanno
male?
I termovalorizzatori non producono
energia (FALSO). Ogni singolo chilogrammo di rifiuto
residuale possiede circa 10 Mega Joule di energia che se immessa in discarica
andrebbe persa producendo emissioni sul lunghissimo periodo. Se si realizzano
impianti di giusta taglia parte di questa energia viene recuperata sia sotto
forma elettrica che di calore e non persa. Poca, molta? Moltissima. Anche se
l’efficienza è solo un poco più bassa di una centrale a combustibile fossile,
non stiamo bruciando un combustibile fossile ma stiamo recuperando l’energia da
qualcosa, il rifiuto residuale, che andrebbe altrimenti solo a mangiarsi altre
porzioni del nostro bellissimo territorio producendo molte ma molte più
emissioni. Recuperando le sue scorie in prodotti certificati, un moderno
termovalorizzatore permette di ridurre il fabbisogno di discarica almeno ad un
ventesimo. Quindi nei prossimi vent’anni una sola discarica invece che 20. E
questo è un guadagno immenso che si somma all’energia recuperata.
I termovalorizzatori inquinano più di
altri sistemi (FALSO). Non conosco impianti che
funzionando non hanno degli impatti. Ma i termovalorizzatori non sono più quelli
di un tempo. L’avanzamento tecnologico e la grande attenzione agli stessi in
passato li rende oggi sistemi avanzatissimi in grado di trattare i rifiuti con
bassissime emissioni per kg di rifiuto trattato, molto ma molto inferiori a
quelle prodotte in discarica dallo stesso chilo di rifiuti. è tutto qui il
punto; bisogna fare il confronto quando devi scegliere. Non guardare solo a
quello che produce un termovalorizzatore in termini di emissioni ma verificare
quelle che evita. è un po' come dire che l’impianto di depurazione dei reflui
produce CO2 ed acqua non pulitissima al suo scarico senza tener conto che
l’alternativa è mandare la fogna tal quale in mare (cosa che mi pare succeda
proprio in Sicilia). Come lo si spiega che moltissimi impianti di trattamento
termico dei rifiuti siano stati costruiti proprio nel centro delle capitali
europee o nelle più grandi città dell’avanzatissimo Giappone? Asserire che gli
inceneritori inquinano senza tener conto che mandare il rifiuto residuale in
discarica inquina molto di più i terreni, le falde e l’atmosfera, come tante
inchieste sui giornali e della magistratura purtroppo ci ricordano ogni giorno,
è una ulteriore balla che vi raccontano.
Il trattamento meccanico biologico “TMB”
è utile (FALSO). è un trattamento che non recupera
praticamente niente sull’indifferenziato mandandolo tutto in discarica ed è del
tutto inutile se si fa a monte una buona raccolta differenziata dell’umido.
Pertanto quando si parla con grande fantasia di “piattaforme” o “impianti
tecnologici” da realizzare, informatevi se non è semplicemente previsto un
impianto TMB che è indissolubilmente (per legge) legato ad una discarica (per
quanto chiamata allegramente “di servizio”). Il recupero di materia di un TMB è
di pochi punti percentuali (2-4%), quindi state nei fatti ributtando tutto in
discarica e continuando a favorire l’indifferenziato.
I termovalorizzatori contrastano la
Raccolta differenziata (FALSO). Nei termovalorizzatori
non va immesso il rifiuto organico che è composto prevalentemente da acqua e
ostacolerebbe la combustione. Quindi asserire che l’inceneritore è in
competizione con la digestione anaerobica o il compostaggio nel recupero di
questa importante frazione (35%) è una balla. Non va neanche immesso il rifiuto
riciclabile, ma solo il rifiuto residuale che non ha altre soluzioni di
smaltimento se non la discarica o il trasporto fuori regione o peggio
all’estero. In tutti i paesi che hanno termovalorizzatori il riciclo è altissimo
ed è la discarica ad essere stata ridotta a zero. è la discarica che si mangia
la raccolta differenziata. Asserire che l’inceneritore è in competizione con il
recupero di materia e la raccolta differenziata è ancora un’altra delle balle
che vi raccontano.
Bisogna fare tantissima raccolta
differenziata (FALSO). Aumentare la RD oltre certi
limiti ti porta necessariamente ad una sua scarsa qualità perché aumentano le
impurezze al suo interno e ti costa molto di più raffinarla. Se non si ammette
per tempo che anche nel sistema industriale del recupero dei rifiuti occorre la
qualità richiesta dal mercato, puntando su una RD di qualità, si fallirà come
sono fallite in passato tante aziende in Sicilia e nel paese che hanno puntato
solo sulla quantità e non sulla qualità dei loro prodotti. è chiaro che per ora
in Sicilia di arrivare al 65% ce lo sogniamo e quindi occorre ancora spingerla
questa raccolta differenziata ma facendola di qualità.
L’energia al Sud non si può recuperare
perché fa caldo (FALSO). Se è vero che è difficile
ipotizzare di realizzare ormai reti per l’utilizzo del calore a livello
domestico nelle città del nostro Sud e collocare i termovalorizzatori al centro
della città stesse (riducendo quindi le percorrenze dei compattatori e relative
emissioni, quelle sì molto inquinanti) come ha fatto per tempo Parigi o appena
ri-fatto Copenaghen, è molto semplice ipotizzare di realizzare le stesse reti
nelle nostre aree industriali dove non solo l’elettricità ma anche il calore può
essere ampiamente utilizzato in un’ottica di piena simbiosi industriale. Oggi
gli avanzamenti tecnologici permettono anche di fare il freddo dal calore quindi
l’energia termica viene utilizzata sia d’estate che di inverno. Che l’energia
recuperata non possa essere utilizzata anche nelle regioni del Mezzogiorno è
un'altra balla che vi raccontano.
Con compostaggio e selezione risolviamo
tutto (FALSO). Ci vogliono gli impianti giusto, ma
tutti gli impianti, anche quelli che ti fanno perdere voti all’inizio ma
guadagnarne tanti dopo. Il compostaggio richiede molta energia, va bene per i
piccoli centri ma dobbiamo pensare a soluzioni industriali più sostenibili con
grandi impianti a servizio del territorio provinciale che utilizzino la
combinazione di processi anaerobici – aerobici e che ci permettano di estrarre
l’energia dalla frazione organica sotto forma di biogas ed eventualmente
biometano. E lo scarto prodotto anche da questi impianti va a recupero
energetico portando la discarica gradualmente a zero come fanno tutti i paesi
più civili, ma come fa anche Milano.
E quindi? Qual è la soluzione? Se non iniziamo, e
abbiamo perso tanto ma tanto tempo, a programmare soluzioni capaci di chiudere
veramente la filiera, come si fa in qualunque comparto industriale, prevedendo
una soluzione anche per gli scarti non recuperabili, ci troveremo nei prossimi
dieci anni ad affrontare la solita continua e insopportabile emergenza. Perché
anche recuperando la metà o poco più dei nostri rifiuti dovremmo sempre gestirne
un’altra metà. E metà emergenza sarà comunque una emergenza.
Termovalorizzatori e inceneritori, ecco
verità e bufale, scrive Nino Galloni su Starmag il 19
novembre 2018. Perché si confondono termovalorizzatori e inceneritori? Ha
ragione Matteo Salvini, per due ordini di motivi:
1) né le discariche né la differenziata
rappresentano la soluzione del problema;
2) il patto o contratto di governo è fondamentale
(come rispettare il sabato) ma se ti cade l’asino nel pozzo lo vai a tirar fuori
anche se è sabato.
Tuttavia, sia Salvini, sia la stampa e la
televisione hanno parlato di termovalorizzatori e di inceneritori. Bene,
quarant’anni fa c’erano gli inceneritori e una discreta mafia se ne interessò,
ma la loro capacità di inquinare e rilasciare diossina quando gli impianti si
raffreddavano era massima. Vent’anni fa arrivarono i termovalorizzatori – dotati
di filtri – riducevano l’inquinamento del bruciare, ma non abbastanza, in cambio
fornivano energia elettrica da combustione (legno, rifiuti, gasolio, tutto può
bruciare). Oggi esistono gli Apparati di Pirolisi; due brevetti italiani,
Italgas e Ansaldo. Oggi, dunque, esistono Pirolizzatori di cui un tipo che
emette gas combustibile, inerti ed anidride carbonica; ed un altro che non
emette l’anidride carbonica perché svolge al chiuso i processi. Perché non si
parla di dotare l’Italia di questi apparati attuali? Perché si confondono
termovalorizzatori e inceneritori? Perché la mafia non solo non si è interessata
ai Pirolizzatori, ma anzi, li ha osteggiati in tutti i modi entrando nella
politica e nell’economia per impedirne la diffusione? Perché a Roma Virginia
Raggi ed il suo staff non hanno voluto prendere in considerazione tale proposta?
Ci sono anche altre tecniche non aerobiche – in cui, sempre al chiuso,
intervengono i batteri – e che consentono di trasformare la risorsa “rifiuti” in
concimi, fertilizzanti e gas naturali, combustibili, a impatto ambientale
negativo (cioè risolvono più problemi dell’abbandonare i rifiuti – come tali – a
sé stessi o cercare di riciclarli in modo non efficiente). Intendiamoci, la
differenziata e l’economia circolare sono buonissime idee; ma perché vetro,
metalli, plastica eccetera vengano recuperati occorre dotare le città di
industrie adeguate, non mandare tali risorse in Svezia o in Germania (che,
invece, al pari di alcuni lodevolissimi comuni italiani – ma l’eccezione
conferma la regola- sanno approfittare di tali opportunità. Credo che
dell’ambiente – e non solo – si debba ragionare in modo non propagandistico,
valutando bene, di ogni cosa, l’impatto economico, finanziario e sociale.
(Estratto di un articolo tratto da Scenari economici)
Termovalorizzatori o inceneritori:
dannosi per la salute? Scrive il 19.11.2018 Eleonora
Lorusso su Donna Moderna. Che differenza c’è tra i due tipi di impianti, come
funzionano, servono davvero o inquinano? Fanno male alla salute? Ecco le
risposte, proprio mentre è di nuovo emergenza rifiuti. Inceneritori sì o no? Che
differenza c’è con i termovalorizzatori? Quando e per cosa si usano, ma
soprattutto: è vero che inquinano e producono sostanze nocive? In questi giorni
di (nuova) emergenza rifiuti si torna a parlare di queste strutture, che
rappresentano ad oggi il principale sistema di smaltimento di rifiuti non
riciclabili, in alternativa (o insieme) alle discariche. In Italia ci sono 41
impianti, dei quali la maggior parte è di nuova generazione, dunque in grado di
produrre energia dalla combustione di rifiuti, riutilizzata sotto forma di
elettricità o calore per riscaldare altre strutture, come ospedali o abitazioni.
Si trovano, però, quasi tutti in Lombardia.
Inceneritori e termovalorizzatori. Entrambi gli
impianti servono a bruciare rifiuti ed esattamente quelli solidi urbani (come
piccoli imballaggi, carta non riciclabile perché sporca, piatti e bicchieri di
plastica anch’essi non destinati a seconda vita) e gli “speciali”, frutto di
attività produttive per lo più industriali. La principale differenza tra
inceneritori e termovalorizzatori consiste nel fatto che i secondi sono in grado
di sfruttare il calore prodotto dalla combustione, ad esempio per
distribuire acqua calda anche alle abitazioni civili, contribuendo al
riscaldamento domestico (teleriscaldamento), come nel caso di Brescia, la città
più teleriscaldata d’Italia. La possibilità di utilizzare energia elettrica
prodotta mediante la combustione dei rifiuti ha anche permesso al comune
lombardo di essere quello con le bollette per la luce e la Tari più basse del
Paese (in media del 35% in meno). I termovalorizzatori, infatti, hanno più
radiatori nei quali portare a ebollizione l’acqua, dispongono di turbine a
vapore e alternatori che producono energia.
La polemica sull’inquinamento. Se da un lato i
termovalorizzatori sono fondamentali per lo smaltimento di rifiuti che
altrimenti finirebbero in discarica, dall’altra gli oppositori sottolineano i
possibili effetti negativi sulla salute e l’ambiente. La legge prevede che la
temperatura di combustione debba essere superiore agli 850 gradi, per evitare la
formazione di diossine. Al di sotto di questo valore, infatti, si attivano
bruciatori a metano. Studi del Cnr, il Consiglio nazionale della ricerca, e
Ispra hanno mostrato come l’inquinamento prodotto da questi impianti è
sostanzialmente inesistente. Per gestire gli scarti di combustione, i
termovalorizzatori moderni hanno mediamente 4 livelli di filtraggio per i fumi e
sistemi di trattamento e sistemi di riciclo delle ceneri molto sofisticati. Le
analisi sulla qualità dell’aria e di tipo epidemiologico sulle popolazioni che
si trovano nei pressi di impianti di moderna generazione, come nel nord Europa,
non hanno evidenziato un aumento di patologie nelle zone dove sorgono questi
termovalorizzatori. Trattandosi di strutture che funzionano a combustione, però,
contribuiscono all’effetto serra, al pari degli impianti di riscaldamento o dei
veicoli circolanti su strada, perché producono anidride carbonica.
Servono davvero? «Serve davvero un impianto di
incenerimento in ogni provincia? Secondo noi no. Questo non vuole dire opporsi a
qualsiasi termovalorizzatore» spiega Barbara Meggetto, responsabile di
Legambiente Lombardia. «Le realtà sul territorio sono molto differenti tra loro:
in alcuni casi, come in Lombardia, la dotazione è sufficiente, in altre no.
Servirebbero più impianti, ma questa non è comunque la soluzione definitiva:
negli anni ’90, in piena emergenza rifiuti nel milanese, si è messo in moto un
meccanismo per cui si sono costruiti impianti di incenerimento, ma si è anche
potenziata la raccolta differenziata. È su questo punto che bisogna agire, anche
perché per realizzare un termovalorizzatore occorrono anni: nel frattempo? Per
questo dobbiamo prima di tutto potenziare la differenziata, poi capire
esattamente quanti impianti occorrono per arrivare a chiudere le discariche. In
Lombardia i rifiuti che vi finiscono sono meno dell’1%» aggiunge Meggetto. «No
rifiuti, sì impianti. Economia circolare per la sostenibilità» sostiene
FISE-Assoambiente, che riunisce le imprese che operano nel campo dei servizi
ambientali: «Oggi l’attenzione è focalizzata tutta sui termovalorizzatori, ma il
discorso è più ampio. L’Europa ci ha indicato alcuni obiettivi importanti: il
65% di raccolta differenziata e non oltre il 10% dei rifiuti da conferire in
discarica. Avanza dunque una quota che quindi è logico pensare sia la
termovalorizzare. Noi però riteniamo che i passaggi fondamentali siano tre: per
prima cosa ridurre i rifiuti; in secondo luogo riciclarli, riportandoli nel
mercato sotto forma di materie prime secondarie; in terzo luogo, cercare di
portare il meno possibile in discarica, ricorrendo all’incenerimento per la
quota residuale di rifiuti che non possono essere destinati a nuova vita,
sfruttando l’energia che se ne può ricavare. I termovalorizzatori, dunque,
servono ma devono essere parte di un sistema completo, una economia circolare»
spiega il direttore della Federazione Imprese di Servizi-Assoambiente.
Come funzione all’estero? In Europa si producono
in media 480 chili di rifiuti all’anno a testa. L’Italia è in linea con quasi
mezza tonnellata (495 chili) per ciascun abitante. Il record negativo spetta
a Danimarca (770 kg), Svizzera e Norvegia (circa 700 kg). Secondo il recente
rapporto Eurostat, a fare la differenza sono però le quote riciclate: in
Germania, ad esempio, dove si producono in media 600 chili di rifiuti per
abitante, la differenziata si attesta intorno al 75%, mentre il resto viene
bruciato e in discarica finiscono appena 9 kg, a fronte dei 123 kg dell’Italia.
Complessivamente in Europa si ricicla circa il 30% di carta, vetro e plastica,
mentre il compostaggio della frazione umida è pari al 17%. Sono 125 milioni,
però, le tonnellate che in Europa finiscono agli inceneritori e in discarica,
dove però la quantità di rifiuti che viene conferita è calata negli ultimi 23
anni da 145 milioni a 59 milioni di tonnellate.
Inceneritori in Europa. Sono oltre 350 gli
impianti di termovalorizzazione o incenerimento che si trovano in 18 Paesi
europei. Il report Ispra (2015) indica la Danimarca come Stato col maggior
quantitativo di rifiuti bruciati (415 kg/abitante per anno), seguita da Paesi
Bassi (245 kg), Finlandia (239 kg), Svezia (229 kg), Lussemburgo (213 kg),
Austria (212 kg) e Germania (196 kg). L’Italia brucia appena 99 chili pro capite
all’anno, meno anche rispetto a Paesi come l’Estonia (185 kg), il Belgio (181
kg), la Francia (174 kg) e il Regno Unito (152 kg). «Il paradosso è che noi
portiamo all’estero una quota di rifiuti da bruciare, perché da noi non è
possibile farlo. Sono Paesi definiti “virtuosi”, come Olanda, Svezia o Germania,
dove esistono inceneritori e cosiddette ‘miniere di sale’, ex cave oggi riempite
di rifiuti per evitare che collassino e che dunque si sono trasformate in
discariche» spiega Elisabetta Perrotta, direttore di FISE-Assoambiente.
Dove sono gli inceneritori? Oltre al caso di
Brescia (con 880 mila tonnellate di rifiuti all’anno smaltiti), che rappresenta
un’eccellenza italiana nel settore ed è nata dopo l’emergenza rifiuti degli anni
'90, per via delle discariche piene, la maggior parte degli impianti che
bruciano rifiuti in Italia si trova al Nord: secondo il Rapporto rifiuti urbani
2017dell’Ispra, dei 41 complessivi ben 14 sono in Lombardia. A seguire ci sono
l’Emilia Romagna (con 8 strutture) e la Toscana (5 sulle complessive 9 del
centro Italia), seguite da Veneto (2), Piemonte, Trentino Alto Adige e Fiuli
Venezia Giulia, con uno per ciascuna regione. I più importanti sono quelli di
Torino, Milano, Brescia e Parma. Sono solo 7 invece gli inceneritori al Sud:
solo in Sardegna sono due, ma l’unico impianto di dimensioni adeguate è quello
ad Acerra (Napoli), dove si bruciano 600mila tonnellate all’anno di rifiuti.
Sicilia e Abruzzo ne sono completamente sprovviste. I cosiddetti “inceneritori
senza recupero energetico” sono pochi: i principali sono a Marghera (Venezia),
disattivato di recente, San Vittore (Frosinone), Colleferro (Roma), Gioia Tauro
(Reggio Calabria), Capoterra (Cagliari), Melfi (Potenza), Statte (Taranto). Sono
strutture dalle dimensioni ridotte (sotto le 100 mila tonnellate di rifiuti
smaltiti all’anno), più costose e destinate alla dimissione, come nei casi di
Vercelli, Ospedaletto (Pisa), Tolentino (Macerata), Statte (Taranto) o Macomer
(Nuoro).
Effetto B.A.N.A.N.A (e NIMBY) ed esempi virtuosi.
L’emergenza rifiuti in Italia deve fare i conti con l’effetto NIMBY, acronimo
inglese di Not In My Back Yard ("non nel mio giardino"). A questo di recente se
ne è aggiunto un altro: il cosiddetto B.A.N.A.N.A, ossia Built Absolutely
Nothing Anywhere Near Anything: "non costruire assolutamente nulla da nessuna
parte vicino a niente". Un paradosso, se si pensa che esistono esempi virtuosi
di impianti realizzati nel centro di capitali europee, come la Danimarca. Qui,
dove la quantità di rifiuti smaltiti tramite combustione è elevata, lo scorso
anno è stato inaugurato un termovalorizzatore nel centro della capitale,
Copenhaghen, e sul suo tetto a dicembre sarà aperta una pista da sci. Costato
670 milioni di dollari, l’impianto di Amager Bakke - CopenHill ha sostituito il
vecchio inceneritore: brucia circa 400mila tonnellate di rifiuti all’anno e
secondo le autorità danesi emette solo vapore acqueo, perché i filtri
trattengono polveri e fumi. Permette di produrre elettricità, destinata a 62.500
abitazioni, e acqua calda a 160.000 unità.
Le materie prime secondarie. «Per fare questo
occorre però anche creare un mercato delle cosiddette "materie prime seconde":
sono quelle realizzate con il trattamento dei rifiuti, lavorati e trasformati in
materiali riutilizzabili, che possono fare concorrenza a quelli primari. È il
caso della carta riciclata o delle bottiglie in Pet riciclato, o ancora di
alcuni materiali ricavati dal riciclo dei cellulari: contengono materiali anche
preziosi che, se riutilizzati, ci permettono di ridurre l’importazione di
materie prime dall’estero, in modo da essere più autosufficienti, e di ridurre i
costi» conclude Perrotta.
Inceneritori in Italia, dove sono e qual
è la differenza coi termovalorizzatori. Diversamente
dai primi, i termoutilizzatori producono elettricità e non inquinano. Ma c'è il
problema CO2. Da Nord a Sud, la mappa completa, scrive Paco Misale il 19
novembre 2018 su Quotidiano.net. Inceneritori e termovalorizzatori. In molti li
identificano come la stessa cosa. In realtà, non è così. I primi sono impianti
che bruciano i rifiuti e basta, mentre i secondi sono impianti che bruciano i
rifiuti per generare energia. Gli inceneritori sono impianti vecchi, che oggi
non si costruiscono più: si preferiscono i termovalorizzatori, che permettono
non solo di distruggere i rifiuti, ma anche di produrre elettricità.
DOVE SONO - In Italia gli inceneritori senza
recupero energetico sono pochi e soprattutto al Sud: i principali sono a Porto
Marghera (Venezia), San Vittore(Frosinone), Colleferro (Roma), Gioia
Tauro (Reggio Calabria), Capoterra (Cagliari),
Melfi (Potenza), Statte (Taranto). Gli impianti che bruciano rifiuti in Italia
sono complessivamente 56, e per la maggior parte termovalorizzatori collocati al
Nord (28 in tutto). Per quanto riguarda il Centro Italia, il numero maggiore di
termovalorizzatori è in Toscana (5 su 9). L’intero Mezzogiorno che deve
esportare l’immondizia ha appena 8 termoutilizzatori, di cui uno solo, quello
di Acerra (Napoli), ha dimensioni efficienti. I più grandi d’Italia sono
a Brescia (A2a, 880mila tonnellate l’anno) e Acerra (A2a, 600mila tonnellate
l’anno). Di dimensioni industrialmente interessanti sono
anche Milano (A2a), Torino (Iren), Parona Pavia (A2a), Padova (Hera), Granarolo
Bologna(Hera), San Vittore del Lazio (Acea). Infine, ci sono decine di
impiantini costosi, la cui ragione economica è sorretta dai vecchi incentivi
Cip6 che stanno uscendo di scena insieme con gli inceneritori di cui sostengono
il pareggio di bilancio. Diversi impianti di capacità inferiore alle 100mila
tonnellate l’anno infatti sono spenti o funzionano in modo marginale, come
quelli di Vercelli, Ospedaletto (Pisa), Tolentino (Macerata), Statte (Taranto)o
Macomer (Nuoro).
IL BUSINESS DEI RIFIUTI AL SUD - Il fatto che la
maggior parte di impianti sia al Nord non è senza conseguenze. Il caso di studio
più importante è la Campania: con pochi e malfunzionanti impianti, nel 2016
(ultimo dato disponibile) la regione ha esportato 258 mila tonnellate di rifiuti
urbani, arricchendo i consorzi di autotrasportatori e le municipalizzate
settentrionali, proprietarie di impianti altrimenti affamati dall’aumento
della raccolta differenziata (al Nord oltre il 64%, al Sud 37,6%; la Campania è
al 52%, Napoli al 38%). Altre 103 mila tonnellate sono andate dalla Campania
all’estero. In questa fase, il mercato paga 200 euro a tonnellata. Il conto è
facile: il business dei rifiuti che la Campania non riesce a trattare vale
almeno 70 milioni l’anno. Che consentono ai Comuni del Nord di calmierare le
tasse sui rifiuti, a spese dei cittadini campani (ma anche dei romani, il
meccanismo è analogo).
QUALI EFFETTI PER AMBIENTE E SALUTE - Inceneritori
e termovalorizzatori bruciano lo stesso tipo di rifiuti, quelli solidi
urbani (piccoli imballaggi, carta sporca e stoviglie di plastica, ad esempio)
e quelli speciali (derivanti da attività produttive di industrie e aziende). Per
legge la temperatura di combustione deve essere sopra gli 850 gradi, per evitare
la formazione di diossine. Se la temperatura scende, si attivano bruciatori a
metano. Rispetto agli inceneritori, i termovalorizzatori hanno in più
radiatori dove l'acqua viene portata ad ebollizione, turbine azionate dal vapore
e alternatori mossi dalle turbine che producono energia. Gli impianti più
moderni distribuiscono anche acqua calda per i termosifoni delle case. Anche se
l'impatto zero non esiste, come evidenziato da studi del Cnr e dell'Ispra,
questi impianti sostanzialmente sono non inquinanti, ma hanno il problema degli
scarti, in particolare ceneri e fumi. Per sopperire a questa complicazione, i
moderni termovalorizzatori hanno 4 livelli di filtraggio per i fumi e sistemi di
trattamento e riciclo delle ceneri molto avanzati. Anche per questo tutte le
analisi epidemiologiche recenti condotte intorno agli impianti moderni non hanno
evidenziato un aumento di patologie. Nel paesi del Nord Europa i
termovalorizzatori sorgono in mezzo alle città. La combustione tuttavia produce
CO2 e contribuisce all'effetto serra.
Copenaghen, l'inceneritore con pista da
sci sul tetto. Di Maio: "Ce la vedo ad Acerra..."
Tutto pronto per il nuovo termovalorizzatore costato 670 milioni di dollari.
Produrrà energia a impatto zero. Attorno un parco con piste ciclabili e impianti
sportivi. Sul lato più alto della struttura la parete artificiale
d'arrampicata più alta del mondo, scrive Paco Misale il 19 novembre 2018 su
Quotidiano.net. Da un lato il Movimento cinque stelle con Di
Maio apertamente contrario agli inceneritori. Dall'altro Salvini, sicuro che su
questo tema l'Italia non tornerà indietro. La gestione dei rifiuti è ormai
diventata un enorme problema globale, tanto da entrare prepotentemente nella
dialettica di governo con i contrari e i favorevoli. Ma se l'Italia si scopre
(in parte) spaventata da questi impianti che bruciano rifiuti e preoccupano per
a loro incompatibilità con la salute pubblica, c'è chi va dritto per la propria
strada e sposa la filosofia degli inceneritori senza avere paura. E' la
Danimarca: a Copenaghen sta infatti per entrare definitivamente in funzione
un termovalorizzatore che non solo brucia i rifiuti della città scandinava,
ma produce energia sorgendo al centro di un parco pubblico e ospitando sul suo
tetto una pista da sci, in funzione da dicembre. L'impianto della capitale
danese (citato da Salvini e che brucia 400.000 tonnellate di rifiuti all'anno) è
costato 670 milioni di dollari, ha cominciato i test di funzionamento nel 2017
ed è in fase di ultimazione. Di Maio, sul collega vicepremier che ha chiamato in
causa l'esempio di Copenaghen, si è lasciato scappare una battuta. "Sì, ce la
vedo proprio la pista di sci ad Acerra", ha detto a Caserta dopo la firma
del protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi.
I SEGRETI DEL TERMOVALORIZZATORE - La struttura
sorge in un’area verde 5 chilometri a nord della città e sarà gestito da un
consorzio pubblico di 5 comuni a cominciare dal municipio di Copenaghen.
L’impianto ne sostituirà uno già in funzione, fornirà energia elettrica a 62.500
mila abitazioni e acqua calda a 160mila. Di più. Funzionerà a impatto zero: dai
camini uscirà infatti solo vapore acqueo. Non basta: attorno all’inceneritore di
Copenaghen un parco con piste ciclabili e impianti sportivi, mentre sul tetto
dell’impianto progettato dallo studio di architettura Bjarke Ingels Group, sarà
realizzata una pista da sci lunga 200 metri mentre su uno dei lati dell’edificio
è prevista una parete per l’arrampicata libera. Per quanto riguarda la prima
novità, si tratta di un pendio lungo 200 metri sul tetto, con un grande tornante
e una pendenza che arriva al 45%. Su questo pendio, che scende da un'altezza
di 90 metri, è stata realizzata una pista da sci larga 60 metri con fondo in
plastica, fornito dalla Neveplast di Nembro (Bergamo). Un ascensore e tappeti
mobili permetteranno agli utenti di risalire. La struttura può accogliere fino
a 200 sciatori e il biglietto dovrebbe costare 9,50 all'ora. Intorno alla pista
verranno piantati alberi e realizzati sentieri per trekking e jogging e aree
picnic. Sul lato più alto dell'impianto è in corso di costruzione una parete
artificiale d'arrampicata alta 85 metri, la più alta del mondo. L'offerta
"turistica" dell'impianto (chiamato Copenhill) sarà completata da un grande
caffetteria con vista sul porto e da un ampio parcheggio, utilizzabile anche per
eventi di pattinaggio.
Rifiuti. Cosa fanno a Parigi. Scrive il
Consorzio Recuperi Energetici. Un termovalorizzatore
in parte interrato che tratta 460 mila tonnellate di rifiuti l’anno sull’argine
della Senna. Vi sembra una fantasia? No è la realtà dell’impianto di Syctom
Isseane, a Issy -les- Moulineeaux, un Comune della cintura di Parigi. Il
progetto raggruppa 48 Comuni che hanno aderito ad un medesimo piano e si sono
messi insieme per smaltire i rifiuti, realizzando quest’impianto. Dal 2007 il
centro tratta i rifiuti prodotti di circa un milione di abitanti...Un’apposita
carta della qualità ambientale è stata sottoscritta con il comune di Issy che
garantisce le condizioni di qualità, di sicurezza e di protezione dell’ambiente.
L’impatto sulla salubrità dell’ambiente è regolato da limiti rigorosissimi. Un
impianto simile e forse anche più avanzato è quello di Firenze almeno sul ciclo
dei rifiuti. Qui si raggiunge il 54% della raccolta differenziata ed entro il
2020 è previsto il 70%. Il termovalorizzatore di Case Passerini eviterà che i
rifiuti residui, ossia quelli non riciclabili, siano inviati altrove producendo
energia elettrica equivalente al fabbisogno annuo di 40 mila persone,
climatizzando l’intero aeroporto ed eliminando lo smog causato dai camion che
trasportano rifiuti nelle discariche.
Sta per entrare in funzione la nuova
struttura, che produrrà energia a impatto zero: dai camini uscirà solo vapore
acqueo. Attorno un parco con impianti sportivi, scrive
Claudio Del Frate 19 novembre 2018 "Il Corriere della Sera". Chi ha paura degli
inceneritori? Di sicuro non la Danimarca: a Copenaghen sta per entrare
definitivamente in funzione un impianto che non solo brucia i rifiuti della
città, non solo produce energia ma che sorge al centro di un parco pubblico e,
dulcis in fundo, ospiterà sul suo tetto una pista da sci. Un altro mondo
rispetto all’Italia dove in queste ore ci si interroga se continuare a far
funzionare i termovalorizzatori già esistenti. Una sfida aperta a chi teme che
questa attività sia incompatibile con la salute pubblica.
Energia elettrica e acqua calda. Il nuovo forno
della capitale danese - citato anche da Salvini per ribadire che sui rifiuti
«non si torna indietro» - è costato 520 milioni di euro, ha cominciato i test di
funzionamento nel 2017 ed è in fase di ultimazione in tutti i suoi dettagli:
sorge in un’area verde 5 chilometri a nord della città e sarà gestito da un
consorzio pubblico di 5 comuni a cominciare dal municipio di Copenaghen.
L’impianto ne sostituirà uno già in funzione, fornirà energia elettrica a 65
mila abitazioni e acqua calda a 150mila. Le tecnologie d’avanguardia consentono
all’inceneritore di funzionare a impatto zero: dai camini uscirà infatti solo
vapore acqueo.
Parco e pista da sci. Ma la vera sfida è quella di
far convivere smaltimento dei rifiuti e presenza degli abitanti di Copenaghen:
attorno all’inceneritore c’è un parco con piste ciclabili e impianti sportivi,
la progettazione è stata affidata a uno dei più prestigiosi studi di
architettura del paese in modo da ridurre l’impatto urbano. Fino all’obiettivo
più ambizioso. La pendenza del tetto dell’impianto verrà sfruttata per
realizzare una pista da sci lunga 600 metri mentre su uno dei lati dell’edificio
è prevista una parete per l’arrampicata libera. Anche in questo caso, i rifiuti
serviranno a generare profitto: per accedere all’impianto - ribattezzato
Copenhill - occorrerà pagare un pass di circa 10 euro giornalieri.
GIORNALISMO A LIBRO PAGA DEGLI INQUINATORI.
Emiliano follie: “Cantiere TAP sembra
Auschwitz”. Poi il governatore si scusa, scrive il 14
dicembre 2017 "Il Corriere del Giorno". La replica di Calenda è arrivata via
twitter: “Dire che sostengo il Tap per favorire le lobby e trovarmi un posto di
lavoro è infantile e volgare ma tutto sommato innocuo, dire che il cantiere è
uguale ad Auschwitz è grave e irrispettoso. Cerca di rientrare nei limiti di un
confronto civile”. Ennesimo scontro tra Michele Emiliano, presidente
della Regione Puglia, e Carlo Calenda ministro per lo Sviluppo
Economico. Emiliano arriva a definire il cantiere Tap di Melendugno ad
Auschwitz. “Se vedete le fotografie – ha detto – è proprio identico. Hanno
alzato un muro di cinta con filo spinato, è impressionante”. Immediata la
replica del ministro per lo Sviluppo Economico che ritiene le accuse molto
gravi. Poi il governatore fa marcia indietro, probabilmente ben consigliato
questa vota, e si scusa: “Il paragone tra il cantiere Tap e Auschwitz – si è
giustificato Emiliano – è oggettivamente sbagliato e mi scuso per averlo
inopportunamente utilizzato questa mattina in radio durante una
diretta”. “Stanno militarizzando inutilmente una zona – aveva detto Emiliano – e
i cittadini si sentono coartati e vedono in quella struttura qualcosa che
ricorda cose tristi della storia”. “Noi siamo favorevoli al Tap – ha aggiunto
Emiliano – ma con approdo a Brindisi. Io non sono il ‘Signor No’, perché
propongo sempre alternative e in questo caso ho indicato Brindisi come approdo
migliore per il gasdotto”. “Calenda – continua l’attacco di Emiliano – parli di
come prevenire incidenti come quello in Austria. Il Tap non è stato assoggettato
al Decreto Seveso, perché sennò avrebbe rallentato i lavori. Io segnalo che il
comandante dei Vigili del Fuoco che a Lecce disse che si doveva applicare la
Seveso fu trasferito nel giro di pochi giorni”. Calenda parla di
pseudo-guerriglia urbana a Melendugno? “Se io guidassi la guerriglia la
vincerei– risponde con la solita presunzione il Presidente della Regione Puglia
– ma io sono magistrato (ma si dimentica di dire che è sotto inchiesta
disciplinare del Csm n.d.r.) e non guido guerriglie. Sono lontanissimo da chi
pensa di usare la violenza anche di fronte a un sopruso di Stato. Calenda parla
così perché cerca una collocazione futura, visto che tra qualche mese sarà senza
lavoro”. Il ministro Calenda replica duramente ma civilmente: “Caro Michele
Emiliano dire che sostengo il TAP per favorire le lobby e trovarmi un posto di
lavoro è infantile e volgare ma tutto sommato innocuo, dire che il cantiere è
uguale ad Auschwitz è grave e irrispettoso. Cerca di rientrare nei limiti di un
confronto civile”.
La storia infinita sull’ ILVA di Taranto.
E qualche sospetto…, scrive il 14 dicembre 2017 "Il
Corriere del Giorno". Tutelare contestualmente l’occupazione e la salute non è
operazione facile ed agevole come dimostra il discutibile ricorso strumentale
presentato dal Comune di Taranto e dalla Regione Puglia, fortemente osteggiato e
criticato da Governo e sindacati insieme, che rischia di bloccare di nuovo la
produzione ed il rilancio dell’occupazione ed economia dell’indotto tarantino.
Nelle ultime settimane si è tornati a parlare della ipotesi fortemente cavalcata
da Emiliano, improvvisatosi manager ed ambientalista, che lo stabilimento
dell’ILVA di Taranto possa essere chiuso, facendo saltare l’acquisizione da
parte della cordata Am InvestCo Italy, ma anche il posto di lavoro di 14 mila
dipendenti (e circa 4.000 dell’indotto) e soprattutto la bonifica dell’area
inquinata limitrofa al quartiere Tamburi di Taranto. L’ultimo problema nella
prolungata difficile vita dell’acciaieria tarantina è un ricorso presentato
irresponsabilmente al TAR Lecce dal Comune di Taranto e dalla Regione
Puglia contro l’autorizzazione che il Governo ha dato all’azienda per
consentirle di continuare a produrre fino al 2023, in cui devono essere
terminati i lavori di bonifica dell’impianto. Il decreto di Palazzo Chigi di
fatto consente allo stabilimento di continuare a produrre nelle condizioni
attuali per cinque anni, in vista della bonifica degli impianti pronta a
partire. Secondo il Comune di Taranto e la Regione, sostenuti da circa un
migliaio di persone aderenti ai vari comitati di cittadini e dalle associazioni
pseudo-ambientaliste, sarebbe un periodo di tempo troppo lungo, soprattutto per
una città come Taranto che da anni è colpita dalle emissioni fuori misura
dell’enorme stabilimento costruito a ridosso del centro urbano. Ma i due ultimi
“populisti” pugliesi e cioè il governatore Emiliano ed il “fido” sindaco di
Taranto Melucci hanno osteggiato la decisione, trovandosi contro il Governo ed
sindacati, alleati a difesa del lavoro, sostenendo unitariamente che il ricorso
alla magistratura è la strada sbagliata per poter migliorare la situazione. La
travagliata vicenda dell’ILVA di Taranto ha origine nel 2012, quando una certa
magistratura fortemente “politicizzata” e soprattutto alla spasmodica ricerca di
protagonismo e visibilità nazionale, aveva disposto il sequestro dell’acciaieria
e l’arresto di alcuni suoi dirigenti, tra cui i proprietari, la famiglia Riva,
per violazioni ambientali affidandoli a commissari giudiziari che definire
incompetenti e pericolosi è dir poco. Nell’ordinanza di sequestro della
magistratura tarantina era scritto: “Chi gestiva e gestisce l’Ilva ha continuato
nell’attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto,
calpestando le più elementari regole di sicurezza”. Nei successivi due anni
prima il governo Letta e poi quello guidato da Matteo Renzi hanno cercato di
mantenere aperta almeno una parte dell’acciaieria, per poter proseguire nella
produzione (che si è dimezzata a seguito anche dei lavori di risanamento ad
alcuni altoforni), che è molto importante per diversi settori dell’industria
italiana. La via per ottenere questo risultato fu l’approvazione di una serie di
decreti leggi che, in pratica, consentivano all’ILVA di produrre inquinando
oltre i livelli consentiti e prolungando il termine entro il quale l’impianto
doveva essere riportato a norma. Operazione per cui occorrevano ingenti somme
che neanche il Governo poteva stanziare a causa del divieto comunitario di
“aiutare” finanziariamente le aziende. Nel 2014 l’ILVA venne posta dal Governo
in amministrazione straordinaria ed affidato agli amministratori nominati dallo
Stato venne affidato il compito di iniziare il risanamento ambientale ed
economico, e successivamente metterla in vendita. Nel gennaio 2016 venne
pubblicato il bando per la messa in vendita di Ilva, e ad aggiudicarselo è stato
il consorzio Am InvestCo Italy, costituito dalla multinazionale
franco-indiana Arcelor Mittal (85%) leader mondiale nella produzione di acciaio,
e dal Gruppo Marcegaglia (15%) che finora era stato il principale cliente di
acciaio prodotto nello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo scorso 29
settembre 2017 il Governo Gentiloni ha approvato una nuova Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), con cui autorizza lo stabilimento di Taranto a
continuare a produrre alle attuali condizioni fino al 2023, allorquando le opere
di bonifica e riduzione delle emissione dovranno essere definitivamente
ultimate. Nello scorso mese di novembre 2017 la cordata Am InvestCo Italy ha
illustrato e reso noto in una serie di incontri con il Governo e con i
sindacati, le procedure e tempistiche con cui si intendeva procedere alla
definitiva agognata bonifica dell’impianto di Taranto e conseguentemente
all’attesa diminuzione delle sue emissioni dannose, impegnandosi a
investire 1,15 miliardi di euro per il risanamento ambientale degli impianti
dal 2018 al 2023, cioè anno in cui scadrà l’AIA approvata dal governo. I
sindacati a partire dai leader nazionali della FIOM insieme a quelli di UILM, il
più grande sindacato tra i lavoratori di Taranto, e di FIM CISL, sono sembrati
abbastanza soddisfatti. Ma al Comune di Taranto guidato da Rinaldo Melucci un
“neofita” della politica (con un recente passato di operatore portuale dai
risultati non esaltanti, anzi deficitari) eletto per puro caso, ed alla Regione
Puglia nelle mani dell’ex-magistrato Michele Emiliano, due “politicanti” che non
hanno entrambi alcuna esperienza manageriale e soprattutto competenza
scientifica-ambientale invece, il piano elaborato dai manager della
multinazionale Arcelor Mittal non è piaciuto. Lo scorso 16 novembre, era
previsto un altro incontro al Ministero dello Sviluppo Economico in cui la
cordata Am InvestCo Italy avrebbe dovuto presentare il suo piano ambientale agli
enti locali. Incontro a cui con poco tatto istituzionale il sindaco di Taranto,
si è rifiutato di partecipare, pretendendo che venisse aperta una trattativa
diretta, cioè un “tavolo” a cui avrebbero dovuto partecipare solo gli enti
locali toccati direttamente dalla questione dello stabilimento di Taranto. Il
sindaco di Taranto Melucci pretendeva di essere convocato entro il 24 novembre
ed allorquando si è reso conto di essere stato ignorato, e la convocazione non
arrivata, ha annunciato (“pilotato” dietro le quinte da Emiliano) che avrebbe
fatto ricorso al TAR contro l’AIA approvata dal governo il 29 settembre, cioè
l’autorizzazione che consente all’ILVA di Taranto di continuare a produrre alle
attuali condizioni fino al 2023. Michele Emiliano e Melucci hanno annunciato
ufficialmente il 28 novembre di aver presentato il ricorso affidandosi ad un
avvocato-politicante barese Marcello Vernola già coinvolto nella vicenda delle
“consulenze d’oro” del crack Ferrovie Sud Est, in cui la Guardia di Finanza e la
magistratura barese hanno accertato sprechi e consulenze d’oro e soprattutto
“allegre”. Come purtroppo accade in Italia quando c’è di mezzo la magistratura
amministrativa, non è mai chiaro cosa potrebbe succedere in sede di giudizio.
Qualora il TAR dovesse accogliere il ricorso del Comune di Taranto e
della Regione Puglia è possibile che l’AIA venga sospesa in attesa della
decisione finale del Consiglio di Stato al quale inevitabilmente il tal caso il
Governo ricorrerebbe in appello. Ma in questa funesta ipotesi lo stabilimento
dell’ILVA di Taranto verrebbe di fatto costretto a interrompere tutte le
attività, con ingenti danni economici e sopratutto conseguenze sociali ed
occupazionali imprevedibili. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda
molto presente e responsabilmente attivo sulla vicenda, su cui è calato il
silenzio assordante dei partiti a partire dal Pd per finire a Forza Italia, ha
duramente criticato la decisione del governatore Emiliano ed ha paventato
l’ipotesi che il fermo delle attività produttive dell’ILVA di Taranto, potrebbe
indurre la cordata Am InvestCo Italy ad un ritiro dell’offerta di acquisizione.
Voci da tenere in considerazione ricordano che tale ipotesi potrebbe far
rientrare in gioco il gruppo indiano Jindal concorrente nella gara pubblica di
acquisizione dell’ILVA, che aveva persino manifestato (dopo aver perso la gara)
la propria disponibilità ad aumentare la propria offerta iniziale che non era
particolarmente vantaggiosa. Ed in certi affari dietro le quinte può succedere e
“girare” di tutto e di più. Soprattutto in termine di soldi e contributi
politico-elettorali…Il ministro Calendo ha ricordato che sinora “Emiliano ha
fatto ricorso su tutto: dai vaccini al Tap, all’Ilva stessa. Per fortuna li ha
sempre persi. Oggi però la situazione è diversa, perché il rischio è che Arcelor
Mittal ritenga impossibile gestire l’acciaieria più grande dell’Unione Europea
con il sindaco della città e il presidente della regione che vogliono cacciarlo
via”. Come dicevamo poc’anzi i sindacati UILM e FIM-CISL sono schierati con
Calenda e quindi con il Governo, la settimana scorsa hanno organizzato una forte
protesta proprio di fronte alla sede del Consiglio Regionale di Puglia per
protestare e manifestare contro il ricorso di Emiliano e Melucci, che mette a
rischio i posti di lavoro dei 14 mila dipendenti ed i 4mila dell’indotto. Il
ministro Calenda ha fatto sapere di essere pronto a ricominciare le trattative
convocando per il prossimo 20 dicembre un “Tavolo per Taranto” che si terrà a
condizione (giusta secondo noi) che la Regione e il Comune di
Taranto ritireranno il loro ricorso, annunciando che, fino a quando il TAR non
avrà adottato una propria decisione, tutti i colloqui sono sospesi, non volendo
sottostare al vero e proprio “ricatto” dei due politicanti pugliesi. Infatti
definire “politici” Emiliano e Melucci, potrebbe fare giustamente offendere la
lunga tradizione di “veri politici” a cui la Puglia ha dato i Natali, a partire
dai compianti Aldo Moro e Pinuccio Tatarella, arrivando a Claudio Signorile,
Biagio Marzo, ecc…. Ma il problema ambientale di Taranto è in realtà soltanto
l’ultimo dei problemi che si sono presentati nella “questione ILVA”. Un altro
ostacolo è relativo alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione
Europea, in quanto secondo qualcuno con l’acquisizione di ILVA, il Gruppo
Arcelor Mittal (il socio maggioritario e di controllo di Am InvestCo
Italy n.d.r.) potrebbe arrivare ad avere una posizione dominante nella
produzione dell’acciaio in Europa, violando così la normativa anti-trust
dell’Unione. Il procedimento deve terminare entro il prossimo 23 marzo 2018, ma
secondo fonti della Commissione dovrebbe concludersi anche prima. La
multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal ha già annunciato che in caso di
richiesta da parte dell’Antitrust Europea di ridurre la produzione per non
superare le soglie comunitarie, che non ridurrà o modificherà la produzione in
Italia, ma piuttosto dismetterà altre sue attività all’estero. La storia degli
ultimi mesi, conferma che quella dell’ILVA è di fatto una delle questioni
industriali più complesse degli ultimi anni, dove si incrociano e scontrano
esigenze ed interessi (a volte occultati) differenti e spesso in contrasto fra
di loro. La questione delle questioni fondamentali è quella ambientale in quanto
a causa delle numerose violazioni della normativa ambientale, lo stabilimento di
Taranto, ha causato non pochi danni alla popolazione cittadina, portando a
proteste dei cittadini. Ma esiste anche un fondamentale problema
occupazionale: l’ILVA dà lavoro direttamente a Taranto 14 mila dipendenti,
mantenendo di fatto altrettante famiglie, e tramite l’indotto, ad altre 4mila ed
oltre 300 imprese di fornitori ed appaltanti. A Taranto l’ILVA è l’unica reale
attività produttiva industriale ed economica, importantissima e fondamentale per
l’economia locale. Concludendo c’è una questione industriale, la circostanza
che l’acciaio prodotto da ILVA è molto importante per l’economia italiana e,
conseguentemente, se gli stabilimenti dovessero chiudere per la gioia e vanità
di Emiliano e Melucci e di un migliaio di pseudo-ambientalisti della domenica,
diverse aziende italiane sarebbero costrette a rifornirsi all’estero,
soprattutto in Germania, acquistando peraltro acciaio a prezzi maggiorati. Ma
tutto questo Emiliano e Melucci non lo capiscono o non lo sanno. O forse è
proprio quello che vogliono…?
Taranto? “Questa è una città da
commissariare”. Quello che i giornalisti…tarantini non hanno il coraggio di
scrivere, scrive il 17 dicembre 2017 "Il Corriere del
Giorno". Marco Travaglio in un suo intervento al concerto tarantino del 1 maggio
disse che “I giornali a Taranto non scrivono nulla perchè sono comprati dalla
pubblicità”. Una sacrosanta verità. Qualcuno infatti preferisce fare interviste
su commissione in ginocchio o occuparsi di “monnezza”….Permetteteci di
complimentarci con l’amico e collega Enzo Ferrari direttore del
quotidiano Taranto Buona Sera , uno dei pochi giornalisti seri e capaci in un
deserto intellettuale e culturale come quello del giornalismo tarantino, per
l’intervista odierna al collega tarantino Angelo Mellone, che anni fa ha avuto
l’intuizione e la buona idea di trasferirsi anni fa a Roma per fare una carriera
(in RAI) degna di essere chiamata tale . Angelo Mellone nella sua intervista
dice delle verità, esprime dei concetti di cui condividiamo parola per parola, a
partire dalla vertenza Ilva-Taranto, che nel suo complesso, sembrerebbe essere
costata 16 miliardi di euro. “Un danno enorme prodotto dal peggior
meridionalismo e dalla peggiore grettezza culturale che una parte di Taranto ha
sfoggiato in questi anni”. “A quale Taranto si riferisce?” gli chiede Enzo
Ferrari. “A quella lagnosa, vittimista,
rivendicazionista e autolesionista – risponde Mellone – della quale fanno parte
pezzi di giornalismo e ambientalismo che con la loro propaganda continuano a
fare un male devastante a Taranto”. “Ce l’hai con gli ambientalisti”
continua Ferrari. “L’ambiente è un tema troppo serio per relegarlo a gruppi che
hanno necessità di trovare qualcuno a cui aggrappare le loro lagne. Come io non
sono industrialista, loro non sono ambientalisti. Ci sono vie di Roma
– dice Mellone – lo dicono i dati dell’Istituto Superiore della Sanità che hanno
valori di inquinamento superiori a quelli di via Machiavelli, ai Tamburi. Eppure
a Roma nessuno si è mai sognato di far girare manifesti che ritraggono i bambini
con la maschera antigas. In quei manifesti c’è tutta l’impotenza culturale di
questi della paura. Giocare sulla pelle dei bambini è una operazione indecente,
folle, terribile”. “Credi che riusciremo ad uscire da questa vertenza così
lacerante?” “La vertenza si risolverà, – risponde Angelo Mellone – nonostante
la minoranza urlante, la borghesia inutile, l’inesistente classe dirigente della
città. Io mi auguro che alla fine si possa davvero arrivare
all’ambientalizzazione dello stabilimento e alla bonifica del territorio. Ma se
la vertenza si risolverà sarà sempre per un intervento esterno, non per ciò che
la città è in grado di produrre”. “Vuoi dire che Taranto da sola non riuscirà
mai a farcela?” domanda Enzo Ferrari. “Taranto è una città di proprietà dello
Stato. – risponde Mellone – Senza lo Stato resterebbe solo la borghesia inutile
e parassitaria. E lo dico con dolore. Pensiamo che in oltre mezzo secolo di
siderurgia non è mai nata una impresa di trasformazione dell’acciaio. Taranto
andrebbe commissariata, non è in grado di governarsi, è vissuta sempre grazie
all’intervento esterno e quando lo Stato ha cominciato a ritirarsi sono arrivati
i dolori” che rispondendo alla domanda “qualche segnale incoraggiante arriva
dalla valorizzazione di alcuni simboli della nostra cultura, come il Castello
Aragonese e il Museo non credi ?” conclude ricordando qualcosa che ai tarantini
sfugge “Il Castello è stato rilanciato dall’ammiraglio Ricci, che non è di
Taranto, e il museo ha ripreso a brillare con la nuova direttrice, che non è di
Taranto. L’unica realtà tarantina che ha saputo emergere a livello nazionale è
la Ionian Dolphin di Carmelo Fanizza”. Un pò poco per sperare in un risveglio
socio-economico-culturale della città di Taranto. Marco Travaglio in un suo
intervento al concerto tarantino del 1 maggio disse che “I giornali a Taranto
non scrivono nulla perchè sono comprati dalla pubblicità”. Una sacrosanta
verità. Il problema è che ancor prima di comprare i giornali, si sono comprati
con quattro soldi i giornalisti. Quasi tutti. A partire da qualcuno che infatti
è “specializzato” nel pubblicare interviste su commissione, rigorosamente in
ginocchio (come scrisse tempo fa il Nuovo Quotidiano di Puglia), qualcuno che
predilige occuparsi di “monnezza”. La sua specialità…
Angelo Mellone: «Questa è una città da
commissariare». Intervista di domenica 17 dicembre
2017 di Enzo Ferrari, Direttore Responsabile di Taranto Buonasera. Il nuovo
libro natalizio, i druidi e il siderurgico. Il giornalista-scrittore tarantino
Angelo Mellone punge una certa Taranto “assistenzialista”. Ecco l'intervista
realizzata dal Direttore di Taranto Buonasera Enzo Ferrari.
“La stella che vuoi” è il sequel di
“Incantesimo d’amore. A distanza di un anno, sempre a Natale e sempre più
fantasy.
«Sì, questo è
un romanzo pienamente fantasy. L’elemento magico e la lotta tra bene e male sono
preponderanti. I protagonisti sono due bambini che vivono nel mondo degli
adulti: uno dal giorno dei morti del 2016 vede solo ombre, l’altra è l’ultima
discendente delle streghe bianche. È il confronto tra tenebre e luce con un
chiaro richiamo a quel che accade nel Signore degli Anelli».
Solo che non siamo nella Terra di Mezzo
immaginata da Tolkien ma tra la gravina di Massafra, Alberobello, il bosco delle
Pianelle...
«Questo gioco
pagano mi permette di riannodare i fili della tradizione antecedente al
Cristianesimo e di collocarla in queste terre che offrono come scenario la Valle
d’Itria, Grottaglie, Martina Franca. Non ho fatto altro che rielaborare le
nostre tradizioni popolari, il folclore, le superstizioni e ambientarle qui, da
noi. Per scrivere un fantasy non c’è bisogno di andare lontano. In fondo i
Druidi sono arrivati fino al Salento, la Cerva alla quale era intitolata
l’attuale Madonna della Scala di Massafra, è un simbolo solstiziale. Per non
parlare dei simboli sui trulli e della leggenda del mago Greguro e delle
masciare. Intanto “Incantesimo d’amore” diventerà un film. Sarà prodotto dalla
Sun Film e in questi giorni faremo i primi sopralluoghi per scegliere gli
ambienti dove girare».
A proposito di ambienti, in “La stella che
vuoi” ad un certo punto entra in scena anche il siderurgico.
«L’Ilva è un
po’ come le caverne di Mordor. I tre folletti buoni vanno in Acciaieria per
forgiare con l’acciaio la runa della luce e smascherare il maleficio».
E i tre folletti chi sono: Calenda, Mittal e
Melucci?
«No, no. Nessun
riferimento a loro. Ho solo voluto ricreare l’anima antica della nostra terra,
quell’anima pura, spartana, che si batte contro chi crea conflitti e disastri.
Sa che dico? Che la prossima Spartan Race andrebbe disputata proprio al
siderurgico».
E anche questa risposta sembra metaforica...
«Purtroppo in
questi anni si è sviluppato un dibattito lacerante. Si stima che la vertenza
Ilva-Taranto, nel suo complesso, ci sia costata 16 miliardi di euro. Un danno
enorme prodotto dal peggior meridionalismo e dalla peggiore grettezza culturale
che una parte di Taranto ha sfoggiato in questi anni».
A quale Taranto si riferisce?
«A quella
lagnosa, vittimista, rivendicazionista e autolesionista della quale fanno parte
pezzi di giornalismo e ambientalismo che con la loro propaganda continuano a
fare un male devastante a Taranto».
Ce l’hai con gli ambientalisti.
«L’ambiente è
un tema troppo serio per relegarlo a gruppi che hanno necessità di trovare
qualcuno a cui aggrappare le loro lagne. Come io non sono industrialista, loro
non sono ambientalisti. Ci sono vie di Roma - lo dicono i dati dell’Istituto
Superiore della Sanità - che hanno valori di inquinamento superiori a quelli di
via Machiavelli, ai Tam buri. Eppure a Roma nessuno si è mai sognato di far
girare manifesti che ritraggono i bambini con la maschera antigas. In quei
manifesti c’è tutta l’impotenza culturale di questi della paura. Giocare sulla
pelle dei bambini è una operazione indecente, folle, terribile».
Credi che riusciremo ad uscire da questa
vertenza così lacerante?
«La vertenza si
risolverà, nonostante la minoranza urlante, la borghesia inutile, l’inesistente
classe dirigente della città. Io mi auguro che alla fine si possa davvero
arrivare all’ambientalizzazione dello stabilimento e alla bonifica del
territorio. Ma se la vertenza si risolverà sarà sempre per un intervento
esterno, non per ciò che la città è in grado di produrre».
Vuoi dire che Taranto da sola non riuscirà mai
a farcela?
«Taranto è una
città di proprietà dello Stato. Senza lo Stato resterebbe solo la borghesia
inutile e parassitaria. E lo dico con dolore. Pensiamo che in oltre mezzo secolo
di siderurgia non è mai nata una impresa di trasformazione dell’acciaio. Taranto
andrebbe commissariata, non è in grado di governarsi, è vissuta sempre grazie
all’intervento esterno e quando lo Stato ha cominciato a ritirarsi sono arrivati
i dolori».
Però un risveglio esiste e qualche segnale
incoraggiante arriva dalla valorizzazione di alcuni simboli della nostra
cultura, come il Castello Aragonese e il Museo, non credi?
«Il Castello è
stato rilanciato dall’ammiraglio Ricci, che non è di Taranto, e il museo ha
ripreso a brillare con la nuova direttrice, che non è di Taranto. L’unica realtà
tarantina che ha saputo emergere a livello nazionale è la Ionian Dolphin di
Carmelo Fanizza».
Ora però arriveranno tanti soldi che, se spesi
bene, potrebbero dare una luce diversa alla città.
«Mi auguro che
questi fondi vengano gestiti da chi sa gestirli».
E’ costata 16 miliardi all’ Italia la
crisi dell’Ilva, scrive il 7 dicembre 2017 "Il
Corriere del Giorno". Nella stima inedita della SVIMEZ emerge, come il CORRIERE
DEL GIORNO ha più volte scritto e denunciato (unico organo di informazione a
farlo!), un vero e proprio conflitto fra i poteri dello Stato: una magistratura
desiderosa più di visibilità e palcoscenico nazionale che di giustizia e la
politica, con la prima prevalente grazie al potere giudiziario esercitato,
rispetto alla seconda. Per arrivare al ricorso di Emiliano e Melucci contro il
Governo! La crisi dell’Ilva è costata all’economia nazionale italiana per essere
precisi, 15 miliardi e 800 milioni. Tanto. Questo l’impatto sul nostro PIL
(prodotto interno lordo) causato dalla minore produzione dell’impianto di
Taranto secondo i calcoli dello Svimez, che, su richiesta del Sole 24 Ore, ha
inserito nel suo modello econometrico i dati sull’andamento manifatturiero reale
forniti dall’impresa. Il deterioramento dell’ “output” è risultato
significativo. In cinque anni, fra il 2013 e il 2017 sono andati in fumo
quasi 16 miliardi di euro di Pil, cioè l’equivalente di una manovra finanziaria
sui conti pubblici in tempo di recessione. Il primo elemento che colpisce, come
evidenzia lo SVIMEZ è la costanza dell’effetto negativo. Tutto ha origine con
l’arresto di Emilio Riva e dal sequestro degli impianti disposti dalla Procura
di Taranto, avvenuti il 26 luglio 2012, a seguito della quale sono accadute
molte cose. Il 26 novembre 2012 vengono sequestrate 900mila tonnellate di
semilavorati e di prodotti finiti per il valore di un miliardo di euro. Il 24
maggio 2013, vengono “bloccati” ai Rivabeni per 8 miliardi di euro, la cifra da
loro risparmiata – secondo l’opinione ed i calcoli dei custodi giudiziari – per
il mancato ammodernamento degli impianti. Il 4 giugno 2013, il Governo Letta
procede al commissariamento dell’ILVA. Il 5 gennaio 2016, viene reso pubblico il
bando per la vendita. Il 30 novembre 2016, il Governo Renzi raggiunge un accordo
extra-giudiziale con la famiglia Riva per il rientro degli 1,3 miliardi di
euro custoditi fra la Svizzera e il paradiso fiscale delle isole Jersey e
scoperti dalla Guardia di Finanza a seguito di una dichiarazione non veritiera
di “scudo” fiscale introdotto dal ministro Giulio Tremonti durante il Governo
Berlusconi. AmInvestco Italia, la società a maggioranza Arcelor Mittal (85%) ed
a minoranza Gruppo Marcegaglia (15%), si aggiudica l’ILVA il 6 giugno 2017.
Arrivando ai nostri giorni, si consumano gli scontri fra il presidente
della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco del Comune di
Taranto, Rinaldo Melucci, propugnatori di un minaccioso (ed inutile, secondo
noi) ricorso al Tar di Lecce contro il decreto sul piano ambientale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda. Un percorso accidentato in questi cinque anni avente
sullo sfondo, il vano tentativo di trovare una conciliazione fra salute d
occupazione, una piaga che non è stata ancora guarita a Taranto e che soltanto
un cieco o un folle non vedrebbe.
Come il CORRIERE DEL GIORNO ha più volte scritto e
denunciato (unico organo di informazione a farlo!) abbiamo assistito ad un vero
e proprio conflitto fra i poteri dello Stato: una magistratura desiderosa più di
visibilità e palcoscenico nazionale che di giustizia e la politica, con la prima
prevalente grazie al potere giudiziario esercitato, rispetto alla seconda.
Nella stima inedita della Svimez emerge la linearità della perdita di ricchezza
nazionale: 3,22 miliardi di euro di Pil in meno nel 2013, 3,23 miliardi in meno
nel 2014, 3,42 miliardi in meno nel 2015, 2,5 miliardi in meno nel 2016 e 3,47
miliardi in meno nel 2017. Un bel risultato non c’è che dire…per il quale nessun
magistrato, consulente della procura, commissario straordinario pagherà mai un
solo centesimo di euro! La freddezza dei numeri appare evidente, non può
chiaramente tener presente gli sforzi o i ritardi nella annosa risoluzione del
problema ambientale che rimane il “cuore” della questione Ilva, e fa risaltare
quanto l’impatto economico sia profondo per la fisiologia del Paese. Basti
sapere che, a causa gli effetti diretti e indiretti della minore
produzione della acciaieria di Taranto, l’export nazionale è stato
“decapitato” fra il 2013 e il 2017, sulla base calcoli effettuati da Stefano
Prezioso economista della Svimez – di 7,4 miliardi di euro. Un dato che dimostra
quanto l’incapacità dei precedenti proprietari (Gruppo Riva) e della politica,
della magistratura e dei sindacati di raggiungere una mediazione, un accordo e
soprattutto un reale e stabile punto di equilibrio in questa vicenda abbia
danneggiato non poco la natura manifatturiera e orientata all’export di un Paese
delle fabbriche, che ha avuto fin dagli anni Cinquanta una delle sue componenti
principali e più importanti nella siderurgia. Contestualmente i calcoli e le
analisi della Svimez fanno chiarezza su uno dei principali quesiti di una
vicenda che, qualsiasi sia il giudizio o l’opinione su di essa, è senza dubbio
di “interesse nazionale”: il maggiore import estero conseguenziale alla crisi
dell’Ilva. Per dirla in soldi ed essere chiari, i vantaggi acquisiti dai gruppi
stranieri concorrenti all’ ILVA di poter conquistare delle quote di mercato e
nel appropriarsi delle parti più ricche della filiera del valore nelle forniture
di acciaio alla manifattura italiana. Secondo la Svimez, questo altro capitolo
di ricchezza svanita e persa strada facendo costituisce in cinque anni ad un
valore economico pari a 2,9 miliardi di euro. In questa vicenda, applicando un
criterio di valutazione economica, vi è anche un altro aspetto che, è stato
trascurato: il tema degli investimenti fissi lordi nazionali andati perduti in
maniera diretta e indiretta trasformando l’ ILVA in un “gigante” limitato dalla
magistratura, che ha visto scendere la produzione dalle nove milioni di
tonnellate toccate sotto la gestione del Gruppo Riva agli attuali cinque milioni
di tonnellate (quasi il 50% in meno) e con una minore capacità produttiva di
generare ricavi e valore. Va anche detto che l’impianto di Taranto non ha mai
realizzato una eccelsa produzione specializzata ed innovativa. Al contrario, si
è sempre collocata su un segmento medio basso, con la “spremitura” dell’impianto
e con l’“efficienza organizzativa” dei Riva a garantire una buona produttività
(e buoni bilanci). Ma è altresì vero che la scelta obbligata, da parte dei
commissari, di non fare implodere i conti mantenendo a livelli accettabili i
ricavi, ha portato ad una diminuzione del ciclo interno ed a politiche di
acquisti più espansive. A causa della gracilità generale dell’impianto e per
l’irradiamento di questa sua debolezza, ecco che gli investimenti fissi lordi
persi a causa della riduzione della produzione sono stati pari fra il 2013 e il
2017 a 3,7 miliardi di euro.
Per non parlare di un indotto “paralizzato” ed
indebitato a causa dei pagamenti non pagati da parte dell’ ILVA in
amministrazione straordinaria, che diceva ai suoi fornitori “continua a lavorare
a fornirci, altrimenti non lavori più per noi” senza pagare i debiti maturati
che hanno raggiunto i 180 milioni di euro alla data odierna, con le oltre 300
aziende dell’indotto ed in appalto, che rischiano di fallire e non hanno più
credito dalle banche, come ha ricordato ed evidenziato nei giorni scorsi in una
conferenza stampa Vincenzo Cesareo il presidente di Confindustria Taranto . In
realtà, questo problema, è strategicamente maggiore rispetto alla semplice
quantificazione del “danno” per usare un linguaggio tecnico-giuridico, in una
storia piena di troppi magistrati ed altrettanti avvocati. In un Paese come
l’Italia, che come evidenzia lo Svimez ha un problema strutturale con la
dimensione di impresa per via della ritirata dei grandi gruppi privati e
post-pubblici, il danno economico di fatto non è rappresentato soltanto dai 3,7
miliardi di euro di investimenti in meno. Il danno infatti è prevalentemente
costituito anche da quello che non si vede: la diminuzione di quello che gli
economisti chiamano “spillover”, cioè la diffusione informale di innovazione
verso i clienti e i fornitori, che sono per lo più piccoli e medi imprenditori.
Concludendo vi un tema “sociale” che appare complementare alla “questione
ambientale”: i consumi persi dalle famiglie in quanto i redditi di chi è in
Cassa Integrazione sono chiaramente inferiori alla normalità. Consumi andati
persi perché quando lavori in una azienda dell’indotto locale tarantino o in una
società della filiera della fornitura nazionale il tuo posto di lavoro è sempre
costantemente “a rischio”. In questo caso, il calcolo finale elaborato dagli
economisti della Svimez consiste in 2,5 miliardi di euro. Cioè mezzo miliardo di
euro all’anno in meno, dal 2013 ad oggi. Questi sono i “reali” numeri di Taranto
e per l’Italia. Ed i numeri parlano. Molto meglio delle carte giudiziarie e
tantomeno dei ricorsi dei “masanielli” di turno.
La sinistra è morta all’Ilva di Taranto.
Quella dell’impianto siderurgico pugliese è una vicenda enorme, che coinvolge
decine di migliaia di lavoratori e il diritto alla salute di una comunità. In
tutto questo, le due sinistre italiane - né Renzi, né Grasso - hanno una
posizione chiara. Avanti così, verso l'irrilevanza, scrive Francesco Cancellato
il 4 Dicembre 2017 su "L'Inkiesta". Sulla vicenda Ilva sappiamo tante
cose. Sappiamo che è complessa, innanzitutto. Perché se un’azienda decide di
mettere 2,4 miliardi in investimenti industriali e progetti
ambientali nell’acciaieria più grande d’Europa, col corollario di 10mila nuovi
posti di lavoro, è indubbiamente un’ottima notizia. Allo stesso modo, però,
l’allungamento dei tempi del piano di recupero ambientale è una brutta notizia –
certificata dall’Arpa e sottoscritta da un profondo conoscitore della vicenda
Ilva come l’ex ministro dell’ambiente Corrado Clini - soprattutto per gli
abitanti del quartiere Tamburi, a poche centinaia di metri dal campo minerario,
le cui scuole non aprono ogni volta che tira vento, per evitare che i bambini
respirino veleno. Nel frattempo, mentre tutto questo accade, si sente dire che
serve la sinistra. Che serve per combattere le onde nere, i fascismi di ritorno,
i populisti, le destre vere e quelle mascherate. Perfetto: ma come la mettiamo
con l’Ilva? Che opinione avete in proposito? Vanno bene 10mila nuovi posti di
lavoro e 2,4 miliardi di investimenti o ha ragione Emiliano a ricorrere al Tar
contro il decreto ministeriale per difendere, qui e ora, la salute dei
tarantini? Va bene tornare a produrre acciaio, a costo di inquinare – meno ma
comunque un bel po’ – l’aria, oppure è meglio importarlo dalla Cina, dall’India
e da ovunque vi siano governi che non si pongono certe remore? Di fronte a
questa domanda, la sinistra non sa, o comunque non risponde. Non sa Renzi, che
evidentemente ritiene molto più importante – bontà sua – occuparsi di fake news
e bufale online. E se non lo sa il suo segretario, figurarsi se lo sa la base:
così, mentre il sottosegretario Teresa Bellanova sta con il ministro Calenda e
contro Emiliano, i consiglieri regionali pugliesi sono usciti dall’aula o si
sono astenuti quando un loro collega ha promosso un ordine del giorno che
prevedeva, tra le altre cose, il ritiro del ricorso al Tar promosso dalla
Regione contro il decreto del Governo. Di fronte a questa domanda, la sinistra
non sa, e comunque non risponde. Non sa Renzi, che evidentemente ritiene molto
più importante – bontà sua – occuparsi di fake news e bufale online. E anche
dalle parti di “Liberi e Uguali”, nel giorno della fondazione del nuovo soggetto
politico a sinistra del Pd, tutto tace sulla vicenda Ilva.
Nemmeno a sinistra del Pd il quadro è chiaro. Nel
giorno della nascita del nuovo soggetto politico “Liberi e Uguali” tutto tace
sulla vicenda Ilva. Il neo leader Piero Grasso parla di dignità del lavoro, di
diritti e di doveri, di Falcone e Borsellino - e di Renzi, ovviamente - ma non
risulta abbia rilasciato memorabili dichiarazioni programmatiche sul sito
tarantino, così come del resto i suoi compagni di viaggio. La stessa Cgil ha le
idee un po’ confuse, se è vero che Susanna Camusso ha definito il ricorso di
Emiliano «un gioco da bambini», sebbene la Fiom di Maurizio Landini sarà l’unica
sigla sindacale che non parteciperà al presidio sotto la sede della Regione
Puglia per convincere Emiliano e compagni a ritirare il ricorso al Tar. Motivo?
«Non è utile per raggiungere l’obiettivo», disse l’uomo che meno di un mese
fa ha occupato l’Ilva di Genova, perché «lo Stato ci costringe a fare i matti».
Mistero. Di certo c’è che su vicende come questa una linea ce la dovete avere,
care sinistre in cerca d’autore. E se non ce l’avete, se pensate che siano più
importanti le fake news o la distanza dal Pd del destino di 35mila lavoratori
– sommando addetti, indotto e nuove assunzioni previste -, o che un feticcio
giuslavorista come l’articolo 18 sia più meritevole d’attenzione delle politiche
industriali non è che non siete di sinistra. Semplicemente, non siete. E
qualunque colore va bene, alla gente, persino il nero pece, se l’alternativa è
trasparente.
Ilva, duello Calenda-Emiliano. Il
ministro: «Fa ricorsi su tutto e perde. Così fuggono
investitori». Il capo del dicastero dello Sviluppo economico «Serve una legge
conto i populismi locali». E avverte il Governatore: si assumerà la
responsabilità di 20mila posti di lavoro, scrive il 3 Dicembre 2017 "La Gazzetta
del Mezzogiorno". «La prossima legislatura si deve porre il problema di una
clausola di supremazia, una legge per superare i veti degli enti locali di
fronte ad interessi strategici nazionali, come in Germania». A dirlo è il
ministro Sviluppo Carlo Calenda, intervistato dal Corriere della Sera, in
apertura, partendo dal caso Ilva. Torna a scagliarsi ancora contro il
governatore della Puglia: "Emiliano ha fatto ricorso su tutto: dai vaccini al
Tap, all’Ilva stessa. Per fortuna li ha persi. Oggi però il rischio è che Mittal
ritenga impossibile gestire l’acciaieria più grande della Ue con Comune e
Regione che vogliono cacciarlo», «viene da pensare che non abbia consapevolezza
di quello che fa, quello che stiamo vedendo è inaccettabile": «Se l’Ilva chiude
andiamo a comprare l’acciaio in Germania e perdiamo un punto di Pil. Con il Tap
diversifichiamo rispetto al gas russo. Di fronte a tutto questo Emiliano dice
che la questione riguarda solo la Puglia». Il silenzio del Pd le pesa? «Il
silenzio - risponde - non è solo del Pd, ma della classe dirigente italiana.
Anche negli altri partiti non populisti e nella società civile. Ed è
sconcertante». Ieri, il governatore pugliese aveva definito il governo in un
"cul de sac" e che ora deve far vedere le carte in attesa del pronunciamento dei
giudici. Per Emiliano il ricorso serve «a conoscere moltissimi atti che sono
ancora segreti, per esempio il piano industriale che nessuno conosce ancora».
Tesi smentita dal ministro secondo il quale «Il piano industriale ed il piano
ambientale sono stati presentati al Governatore della Puglia ed a quello della
Liguria insieme a molti sindaci, non a quello di Taranto che non si è presentato
all’ultimo minuto pur avendo richiesto l'incontro, da Mittal nell’ambito del
tavolo istituzionale». «Nello stesso tavolo - ha proseguito Calenda - si era
deciso di convocare due incontri separati per Taranto e per Genova per
approfondire le tematiche ambientali e industriali. All’uscita dalla riunione
Emiliano dichiarava alla stampa la sua soddisfazione per la convocazione del
tavolo Taranto salvo qualche giorno dopo presentare ricorso al Tar contro il
Dpcm ambientale. Da quel momento Emiliano ha dichiarato tutto e il contrario di
tutto: che il ricorso era uno come un altro, che in caso di accoglimento della
sospensiva l’Ilva non rischia la chiusura, che il ricorso serve a conoscere
carte segrete quali il piano industriale. Si tratta di affermazioni non
rispondenti al vero». Poi il ministro ribadisce il timore «che l’investitore,
constatata l’ostilità delle Istituzioni locali, scappi, a prescindere dall’esito
del ricorso lasciando sulle spalle del Governo, e non certo di Emiliano, che
sino ad ora nulla di concreto ha fatto a questo proposito, il destino di 20000
persone e i costi delle bonifiche».
MONS. SANTORO: FARE IL BENE DELLA GENTE - Sulla
questione Ilva «non sta a me entrare nella disputa tra Governo ed enti locali ma
desidero ribadire, circa la vertenza che si è aperta in questi giorni nella
città di Taranto, che il mio unico interesse è il bene della gente e la
rinascita del nostro territorio, spesso lasciato nell’incertezza circa il suo
presente ed il futuro». Lo afferma l’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro, nel
suo intervento al meeting «Emigrazione, accoglienza, integrazione,
cittadinanza», che si sta svolgendo nella Basilica San Martino di Martina Franca
e a cui partecipa il ministro dell’Interno Marco Minniti. «Il primo problema -
aggiunge mons. Santoro - è porre fine alla devastazione ambientale e che sia
seriamente preso in considerazione da parte del Governo e del nuovo acquirente
il danno sanitario. In secondo luogo, che sia rispettato e garantito il lavoro
dei dipendenti dell’azienda e delle ditte che lavorano nell’indotto». Inoltre,
l’arcivescovo di Taranto auspica «che, come segno di concreto di una risposta
forte all’impatto inquinante, si dia inizio a partire dai primi di gennaio 2018
alla copertura dei parchi minerali. Gli allarmi Wind days sono indegni di un
paese civile, inaccettabili, non possiamo tollerarli oltre». Che «tutte le parti
in causa - ammonisce il presule - si siedano intorno a un tavolo lasciandosi
alle spalle orgoglio e strategie e lavorino nell’interesse esclusivo della
città, degli operai, dei residenti tutti. Ci sono già stati 12 decreti; non
farebbe male un intervento governativo questa volta condiviso dalla popolazione.
Io - conclude mons Santoro - continuo ad avere fiducia perché le persone di
buona volontà, possano ritrovarsi, unirsi, per essere costruttori di bene e di
bello».
SINDACO MELUCCI: RICORRONO CONFERMA FABBRICA - «Il
ricorso del Comune di Taranto al Tar di Lecce non sospende l’aggiudicazione
dell’Ilva a AM Investco Italy e non c'è rischio alcuno di fermo o chiusura della
fabbrica». Lo scrive il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in una lettera
aperta al ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Dieci punti per
ricordare «quello - sottolinea Melucci - che il ministro non dice». Il ricorso,
secondo il primo cittadino, «non blocca né ritarda la copertura dei parchi
minerali, che in realtà potevano essere coperti già da anni. Chiunque dichiari
il contrario, contribuendo a creare agitazione tra lavoratori e cittadini,
dimostra un grave deficit di competenze». L’unico «vero rischio - sostiene
ancora il sindaco di Taranto - deriva proprio dall’azione del Governo che
consente lo slittamento al 2023 di diversi interventi urgenti e
improcrastinabili per la tutela della salute. Lo dice l’Unione Europea». Al
Comune di Taranto «non è stato notificato - si fa presente - ancora alcun atto
formale a garanzia dell’avvio dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dei
parchi. Non ci si può accontentare di promesse e annunci, sotto la pressione del
ricatto occupazionale». E il ministro Calenda «non vuole - attacca Melucci -
l’istituzione di un tavolo esclusivo per Taranto e non è in grado di rispondere
nel merito alle proposte della città di Taranto: la comunità non cederà al
ricatto (immorale e forse illecito) del ritiro preventivo del ricorso». Il primo
cittadino fa rilevare che "il Comune di Taranto ha fatto precise proposte sulla
rimodulazione di tempi e tecnologie per mettere in sicurezza lo stabilimento: i
ministri Calenda e Galletti non hanno mai preso in considerazione le
osservazioni degli enti locali. Il ministro Calenda, oltre che sulla valutazione
del rischio sanitario, è muto rispetto alla definizione delle pendenze
dell’indotto locale. Evidentemente è più sensibile alle esigenze di lobby e
multinazionali che a quelle delle imprese pugliesi». Per il sindaco «il ministro
Calenda sorvola sul fatto che il Comune di Taranto chiede l’avvio immediato
delle bonifiche e l'aggiornamento dei protocolli di ristoro ambientale» e
«difende i commissari che non hanno costruito alcun utile rapporto con la città;
il Comune di Taranto, per lo stesso motivo, chiede avvicendamento immediato».
Infine, il ministro Calenda «a tutt'oggi - insiste il sindaco - non è in grado
di fornire agli enti locali la documentazione di dettaglio relativa al piano
industriale, fattispecie ampiamente prevista dalla procedura di legge. Il Comune
di Taranto non rinuncia al dialogo costruttivo, per il quale resta disponibilità
piena e immediata. Un dialogo che coinvolga finanche le procedure giudiziali
avviate». Ma «nessuno - conclude Melucci - può pretendere che l'amministrazione
chiuda gli occhi e tradisca i cittadini sulla madre delle questioni, la loro
salute, la loro qualità della vita. Dopo una dozzina di decreti salva Ilva, ora
il Governo fornisca garanzie serie su un decreto salva Taranto e tarantini».
Ecco chi cerca di distruggere l’economia
di Taranto: Emiliano & Melucci, scrive "Il Corriere
del Giorno" il 30 novembre 2017. Ilva: Calenda, stop negoziato attesa Tar “se il
Tar accoglierà la sospensiva richiesta, gli amministratori straordinari dovranno
iniziare lo spegnimento dell’Ilva, poi faremo ricorso al Consiglio di Stato, ma
al Governo non può essere chiesto l’impossibile”. “Ho deciso che congeleremo il
negoziato sull’Ilva aspettando la decisione del Tar di Lecce sull’impugnativa
di Michele Emiliano governatore della Regione Puglia, e del Comune di Taranto”.
Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, durante
l’assemblea della Cgil sull’acciaio. “Sono inutili i tavoli finché non è chiara
la situazione. Se il Tar di Lecce accoglie l’impugnativa, l’amministrazione
straordinaria dovrà procedere allo spegnimento dell’Ilva”. Il giudizio del
ministro Calenda è tranchant: “Dagli Enti locali c’è una gestione schizofrenica.
Ma si sappia, se Regione e Comune usano tutti i mezzi necessari per far saltare
l’Ilva, l’Ilva salta”. “Allora però Emiliano lo dica in modo chiaro, non
attraverso i ricorsi ma assumendosene la responsabilità” Secondo Calenda, quella
del presidente della Regione Puglia è “una battaglia ideologica […] fatta sulle
spalle dei lavoratori e dell’ambiente”. Emiliano – ha aggiunto il ministro –
“sta costruendo una campagna elettorale dicendo cose che non esistono”. E
ancora: “dobbiamo evitare il pericolo più grande che è la fuga dalla realtà e
dalla responsabilità. Dire che l‘Ilva può essere del tutto decarbonizzata è una
fesseria, non dovete dare sponda a chi dice queste cose che non esistono. Non
esistono stabilimenti al mondo. In ballo – avverte Calenda – ci sono 5 miliardi
di euro. Vorrei sapere qual è stato l’ultimo investimento di questa portata al
sud”. Infine il ministro dello Sviluppo economico, ha annunciato che, “se il Tar
accoglierà la sospensiva richiesta, gli amministratori straordinari dovranno
iniziare lo spegnimento dell’Ilva, poi faremo ricorso al Consiglio di Stato, ma
al Governo non può essere chiesto l’impossibile”. Per il segretario confederale
della Cgil Maurizio Landini, quella di Emiliano “è una scelta sbagliata”.
“Questo non è il momento dei tribunali, c’è una trattativa in corso, è il
momento della responsabilità”. “Oggi – ha proseguito Landini – è opportuno far
ripartire gli investimenti e la copertura dei parchi minerari. È importante – ha
proseguito – portare ArcelorMittal a utilizzare tutte le tecnologie migliori e
le soluzioni possibili” per ambientalizzare l’Ilva. “La lotta dei lavoratori –
ha proseguito Landini – ha prodotto l’avvio di una trattativa vera. Sono stati
aperti tavoli istituzionali che adesso devono partire in sede locale. Non è
questo – ha concluso Landini – il momento dei tribunali e dei magistrati”. Anche
per Francesca Re David, segretaria generale della Fiom, il ricorso della Regione
“non è un fatto positivo in una fase così delicata della trattativa”.
Intervistata a margine di un convegno sulla siderurgia in Cgil, la leader
della Fiom ha fatto presente che per gli interventi ambientali dell’Ilva c’è uno
stanziamento di 2,7 miliardi: “Non era mai avvenuto”. “Siamo alle soglie
dell’apertura di tavoli locali e bisogna lavorare insieme per raggiungere il
miglior risultato possibile. Tanto per le questioni industriali quanto per
quelle ambientali ci deve essere l’impegno congiunto di tutti”. Qualcuno adesso
spieghi a Emiliano e Melucci che Roma non è Bari, Bari non è Taranto, e
tantomeno Taranto è Crispiano o una banchina portuale, ambiente dove sicuramente
l’attuale sindaco pro-tempore del capoluogo jonico, si trova sicuramente a suo
più agio… e dove ha dimostrato con i bilanci della sua società di non essere
neanche un valido imprenditore dati i risultati negativi di bilancio sinora
conseguiti della sua società di servizi portuali. E di novelli
“masanielli” Taranto è stanca da molto tempo e non ha certamente più bisogno !
Ed Emiliano, lo Zapata delle Puglie, si
attaccò al Tar, scrive Domenica 03 dicembre 2017 Aldo
Grasso su "La Gazzetta del Mezzogiorno". Cul-de-sac. L’Emiliano Zapata delle
Puglie non recede. Umiliato alle primarie del Pd, cerca sempre una rivincita,
soffia sul fuoco dell’ostilità popolare a infrastrutture e impianti, sacrifica
il senso di responsabilità «in preda a un delirio d’infantilismo» (così si è
espressa una parte del sindacato). I fatti sono noti: il governatore Michele
Emiliano, appoggiato dal sindaco di Taranto, ha fatto ricorso al Tar contro il
nuovo piano ambientale per l’Ilva. Fermare tutto con le carte bollate, con il
fondato rischio che il futuro gestore dell’acciaieria se la svigni, insalutato
ospite! L’ha spiegato molto bene Goffredo Buccini: «La fabbrica uccide coi suoi
fumi ma senza fabbrica si muore di fame». Il Sud non può mandare all’aria cinque
miliardi d’investimenti e 20 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti. Da
quei soldi dipende anche il risanamento del territorio, altrimenti Taranto
resterà sola con i suoi veleni, un dramma ambientale e sanitario che nessuno
vuole sottovalutare e che è di tutti. Come lo è ora, quando il vento spira da
nord-ovest. La politica è confronto continuo, il governatore-magistrato, invece,
ricorre su tutto, oltre ogni buon senso. Come ha dichiarato sabato: «Il governo
è praticamente in un cul-de-sac. E adesso deve attendere il giudizio dei giudici
e soprattutto deve far vedere le carte». Si potrebbe dire che Emiliano è il
diretto irresponsabile delle sue scelte.
Calenda: “Siamo ormai abituati ai ricorsi
di Emiliano su Vaccini, Buona scuola, Tap e anche precedenti su Ilva per fortuna
tutti regolarmente perduti”, scrive il 3 dicembre 2017
"Il Corriere del Giorno". “In questo caso però il rischio è che l’investitore
Arcelor Mittal, constatata l’ostilità delle Istituzioni locali, revochi il
proprio investimento e scappi”. In gioco il destino di oltre 20mila persone e di
una città intera. I retroscena sull’incarico ad un avvocato barese-politico per
il ricorso al Tar. “Rinnovo l’offerta di riaprire immediatamente il tavolo di
Taranto per avviare un dialogo costruttivo ritirando contestualmente il ricorso
contro il Dpcm ambientale”. Il ministro dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda replica al Governatore Michele Emiliano affermando come costui abbia
“dichiarato tutto e il contrario di tutto”. “In questo caso però – conclude il
ministro – il rischio è che l’investitore, constatata l’ostilità delle
Istituzioni locali, scappi a prescindere dall’esito del ricorso lasciando sulle
spalle del Governo, e non certo di Emiliano, il destino di 20.000 persone e i
costi delle bonifiche”. “Il piano industriale ed il piano ambientale dell’Ilva –
spiega Calenda nella nota – sono stati presentati al Governatore della Puglia ed
a quello della Liguria insieme a molti sindaci – ma non a quello di Taranto che
non si è presentato all’ultimo minuto pur avendo richiesto l’incontro – da
Mittal nell’ambito del tavolo istituzionale tenutosi al Ministero dello Sviluppo
Economico lo scorso 16 novembre”. “Nello stesso tavolo – prosegue il ministro
dello Sviluppo Economico – si era deciso di convocare due incontri separati per
Taranto e per Genova per approfondire le tematiche ambientali e industriali.
All’uscita dalla riunione Emiliano dichiarava alla stampa la sua soddisfazione
per la convocazione del tavolo Taranto salvo qualche giorno dopo presentare
ricorso al Tar contro il Dpcm ambientale. Da quel momento Emiliano ha dichiarato
tutto e il contrario di tutto: che il ricorso era uno come un altro, che in caso
di accoglimento della sospensiva l’Ilva non rischia la chiusura, che il ricorso
serve a conoscere carte segrete quali il piano industriale. Si tratta di
affermazioni non rispondenti al vero.” “Oggi però il rischio è che Arcelor
Mittal ritenga impossibile gestire l’acciaieria più grande della Ue con Comune e
Regione che vogliono cacciarlo. Viene da pensare che Emiliano non abbia
consapevolezza di quello che fa, quello che stiamo vedendo è inaccettabile”
aggiungendo “Se l’Ilva chiude andiamo a comprare l’acciaio in Germania
e perdiamo un punto di Pil. Con il Tap diversifichiamo rispetto al gas russo. Di
fronte a tutto questo Emiliano dice che la questione riguarda solo la Puglia”.
Commentando l’equivoco silenzio del Pd sulla vicenda Calenda dice: “Il
silenzio non è solo del Pd, ma della classe dirigente italiana. Anche negli
altri partiti non populisti e nella società civile. Ed è sconcertante”.
Il Pd infatti non può parlare. Emiliano e Melucc isono stati eletti nelle loro
liste… “Siamo ormai abituati ai ricorsi di Emiliano – conclude il
ministro Calenda – su Vaccini, Buona scuola, Tap e anche precedenti su Ilva per
fortuna tutti regolarmente perduti. In questo caso però il rischio è che
l’investitore, constatata l’ostilità delle Istituzioni locali, scappi”. Quello
che sfugge a molti, è che questa è la prima volta che i sindacati in maniera
unitaria sono dalla parte del Governo e dell’industria (Ilva) e contro il
protagonismo dei politicanti di provincia (leggasi Emiliano e Melucci) che si
atteggiano a “masanielli” di turno. Nell’imbarazzante dialogo fra il
governatore Emiliano ed il sindaco Melucci (attraverso i loro
ventriloqui-staffisti) con Calenda, è intervenuto persino il cosiddetto “Museo
spartano di Taranto” che ha ricordato al sindaco di Taranto e al presidente
della Puglia la famosa “pisciata d’orgoglio”: quella del capostipite Filonide
che urinò sull’ambasciatore romano (o ministro?) Lucio Postumio. Ma anche il
Museo Spartano ha qualche lacuna storica e non ricorda come andò a finire la
storia con Roma e quanto costò la “pisciata” alla città (e al suo orgoglio).
Glielo ricordiamo noi: fu assediata, sottomessa, e conquistata. Più o meno
quello che Emiliano da tempo sta cercando di fare. Ma c’è anche un imbarazzante
filo conduttore dell’invasione “barese” nella vicenda ILVA, contestata
dall’ Ordine degli Avvocati di Taranto, e cioè l’incarico affidato dal Comune di
Taranto all’ Avv. Marcello Vernola, ex Presidente della Provincia di Bari con
una giunta di centrodestra, candidatosi anche alla Regione, ed il cui nome
compare nella vicenda degli appalti “facili” delle Ferrovie Sud Est , in cui
l’avv. Vernola risulta aver ricevuto molte delle consulenze d” oro” come ad
esempio gli incarichi legali spezzettati, ben dodici consulenze legali, tutte
con affidamento diretto, e ben sei delle quali arrivate in uno stesso giorno;
incarichi che gli fruttarono quasi 295 mila euro, proprio mentre l’azienda di
trasporti pugliese risultava indebitata per centinaia di milioni di euro.
Incarichi affidati a Vernola dall’ex-amministratore unico, il tarantino Luigi
Fiorillo suo vecchio amico e militante, nel Movimento Giovanile Democristiano (i
giovani della DC – n.d.r.), che è plurindagato.
Calenda “spiazza” Emiliano ed incontra il
sindaco Melucci a Taranto, scrive il 5 dicembre 2017
"Il Corriere del Giorno". Il ministro Calenda ha telefonato questa mattina al
Sindaco di Taranto parlandosi per qualche minuto, ed a un certo punto della
conversazione avrebbe detto a Melucci: “ok, sto venendo da te”. Dopo alcuni
minuti Calenda è arrivato a Palazzo di Città dove ha incontrato il Sindaco di
Taranto. Il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, sta incontrando a
Taranto in queste ore il sindaco Rinaldo Melucci, il quale insieme al
governatore della Puglia Michele Emiliano avevano avviato un braccio di ferro
sulla questione Ilva presentando un ricorso al Tar di Lecce. La visita, a
sorpresa, è stata anticipata dal ministro con una telefonata e l’incontro si sta
svolgendo a Palazzo di Città. Proprio ieri il ministro Calenda aveva
invitato Emiliano a ritirare il ricorso al Tar e ad aprire un tavolo di
confronto. Questa mattina il ministro Calenda ha telefonato al sindaco di
Taranto parlandosi per qualche minuto, ed a un certo punto della conversazione
avrebbe detto a Melucci: “ok, sto venendo da te”. Dopo alcuni minuti Calenda è
arrivato a Palazzo di Città dove ha incontrato il Sindaco di Taranto. Al termine
dell’incontro, è stato diffuso un comunicato stampa concordato con cui è si è
resa nota la convocazione di un Tavolo negoziale dedicato a Taranto con
all’ordine del giorno quanto già richiesto con apposita lettera dal Sindaco al
Ministro prima dell’incontro istituzionale del 16 novembre scorso al Mise. Il
Sindaco di Taranto ed il Ministero dello Sviluppo Economico con un comunicato
congiunto hanno confermato che “al ricevimento della formale convocazione con
l’ordine del giorno condiviso sarà disponibile al ritiro del ricorso al Tar,
previa consultazione sulla questione anche con il Governatore Emiliano”.
L’ordine del giorno dovrebbe comprendere: analisi del piano ambientale del DPCM
e verifica dei possibili miglioramenti; condivisione del cronoprogramma della
copertura anticipata dei parchi primari; gestione e valutazione del danno
sanitario; gestione dell’attività del fondo sociale di Taranto; provvedimenti
per l’indotto; condivisione del piano bonifiche di competenza
dell’amministrazione straordinaria; istituzione di un centro di Ricerca e
Sviluppo sull’acciaio e tecnologie carbon free. “All’ordine del giorno del
Tavolo per Taranto ci sarà anche la valutazione del danno sanitario, oltre
all’analisi del Dpcm, e dei suoi eventuali miglioramenti e il cronoprogramma per
la copertura dei parchi minerali. Sapete che ho dato disposizione
all’amministrazione straordinaria dell’Ilva di partire comunque, prima ancora
che si completi il processo di trasferimento degli asset”, ha dichiarato il
ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda dopo aver incontrato a Taranto
il sindaco Rinaldo Melucci. “Si parlerà – ha specificato – dello sviluppo del
fondo sociale per Taranto, che prevede 30 milioni di euro a sostegno in
particolare dei giovani; del Centro di ricerca che Mittal vuole sviluppare qui,
investendo per farlo diventare centro di eccellenza anche per le tecnologie di
carbon free; del miliardo e 80 milioni di euro di bonifiche che
l’amministrazione straordinaria impiegherà, oltre al miliardo e duecento che
investirà Mittal sulla parte ambientale e dei provvedimenti a favore
dell’indotto“. Parallelamente “può ripartire – ha concluso il ministro – la
vertenza sindacale. Per la convocazione del Tavolo per Taranto sentirò il
sindaco e il governatore e poi indicheremo la data”.
Ilva Taranto: Comune, Regione, Governo…
pace (s)fatta, scrive il 6 dicembre 2017 Michele Tursi
su La Ringhiera. In teoria ora ci sarebbe solo da attendere la data della
ripresa del confronto sull’Ilva che dovrebbe vedere seduti al tavolo del
ministero dello Sviluppo economico anche il Comune di Taranto e la Regione
Puglia. Usiamo il condizionale perchè nero su bianco, al momento, non c’è niente
(a parte la nota congiunta diffusa ieri) e perchè troppo spesso abbiamo
assistito a repentini cambiamenti. Come dicevano i latini “rebus sic stantibus”,
stando così le cose, conoscere la data del nuovo incontro sarebbe la logica
prosecuzione della convulsa giornata vissuta ieri. Ma la politica è fatta di
sfumature. E probabilmente a Michele Emiliano non è molto piaciuto il blitz del
ministro Calenda a Taranto, senza nemmeno una telefonata di cortesia al
presidente della Regione. “Ma non ci formalizziamo sul protocollo – ha detto in
conferenza stampa a Palazzo di città, al fianco del sindaco Rinaldo Melucci –
abbiamo ottenuto un risultato storico”. Nella nota congiunta di Palazzo di
città e del Mise, infatti, vengono accolte tutte le richieste avanzate dal primo
cittadino di Taranto con la lettera del 16 novembre scorso in occasione
dell’incontro istituzionale cui Melucci non partecipò. Il tema che ancora fa
discutere è il ritiro dei ricorsi al Tar, avverso il dpcm del 29 settembre 2017,
avanzati da Comune e Regione. “Il Sindaco ha confermato – si legge nella nota
congiunta – che al ricevimento della formale convocazione con l’ordine del
giorno condiviso sarà disponibile al ritiro del ricorso al Tar, previa
consultazione sulla questione anche con il Governatore Emiliano”. La
consultazione con il governatore c’è stata e sul punto Emiliano ha frenato. “Non
c’è alcun ritiro – ha detto ai giornalisti riuniti nell’aula consiliare – se
nella trattativa verranno affrontati e risolti positivamente gli elementi
costitutivi dei ricorsi, è ovvio che l’azione legale non avrà più motivo di
sussistere e decadrà”.
Dietro le quinte dei “ricatti” alle
istituzioni di Michele Emiliano, politico-magistrato sotto inchiesta del CSM,
scrive Antonello de Gennaro il 6 dicembre 2017 su "Il Corriere del Giorno".
Michele Emiliano è bene ricordarlo ancora una volta, è un magistrato (non in
servizio per fortuna!) sotto inchiesta dalla 1a Commissione disciplinare del
Consiglio Superiore della Magistratura per aver violato la norma che impedisce
ai magistrati di “fare politica”, che è cosa ben diversa dall’ essere un
rappresentante eletto dai cittadini nelle istituzioni. Devo innanzitutto
confessare che sin dal mio primo incontro con Michele Emiliano in una conferenza
stampa a Taranto durante la campagna elettorale per le elezioni regionali, non
ho avuto particolare sintonia e simpatia per l’attuale governatore della Regione
Puglia, ed ancora una volta la mia prima impressione, il mio intuito hanno avuto
ragione. Nella mia lunga vita professionale, sono oltre 30 anni che faccio il
giornalista in lungo e largo per l’Italia non avevo mai incontrato un politico
così ambiguo. Hanno ragione dei politici baresi di lungo corso a definirlo uno
“sfalsino” (cioè una persona a due facce). Michele Emiliano è bene ricordarlo
ancora una volta, è un magistrato(non in servizio per fortuna !) sotto inchiesta
dalla 1a Commissione disciplinare del CSM (il Consiglio Superiore della
Magistratura n. d.a.) per aver violato la norma che impedisce ai magistrati di
“fare politica”, che è cosa ben diversa dal essere un rappresentante eletto dai
cittadini nelle istituzioni, e quindi dovrebbe avere il buon gusto di tacere
prima di “emettere” sentenze e pareri giuridici su questioni di cui dimostra
una palese ed evidente ignoranza. Dopo essere stato fatto fuori dalla politica
cittadina barese con l’avvento del “renziano” Dicaro. Emiliano ha cercato di
ampliare la propria “corrente” sostenendo la sfortuna candidatura a sindaco di
Brindisi di Nando Marino, dove lo stesso Partito Democratico brindisino al
ballottaggio ha preferito votare il candidato (eletto) della lista civica
centrista, pur di non farsi calpestare dall’arroganza barese di Emiliano. Dopo
il fallimento brindisino, Emiliano ha “cavalcato” la candidatura last-minute
di Rinaldo Melucci, un “profano” della politica, con la complicità di
un Pd tarantino frantumato ed incapace di trovare al proprio interno un
candidato alla poltrona di primo cittadino. Qualche “pazzo” aveva offerto la
candidatura a sindaco di Taranto un anno prima delle elezioni al sottoscritto,
ottenendo un garbato netto rifiuto. Dopodichè qualcuno ha provato a convincere
il prefetto Francesco Tagliente (ex questore di Roma e Firenze) che vantava un
solido rapporto di amicizia con Matteo Renzie Luca Lotti, e già indicato come
assessore alla sicurezza nella capitale dall’ on. Roberto
Giacchetti (vicepresidente della Camera) candidato del Pd al Comune di Roma
contro la “grillina” Virginia Raggi. Anche in questo caso è arrivato dal
prefetto Tagliente un garbato rifiuto istituzionale. Alla fine i democratici”
(si fa per dire…) tarantini ci hanno provato anche con il mio amico e
collega Walter Baldacconi direttore dell’emittente televisiva pugliese Studio
100, il quale dopo aver tentennato per qualche secondo, è stato ben consigliato,
ed ha rifiutato anch’egli. Nel frattempo si consumavano le guerriglie interne al
Pd tarantino dove volevano candidarsi in tre : Gianni Azzaro, Piero
Bitetti e Lucio Lonoce, rispettivamente un semplice finanziere in aspettativa,
un ex-macellaio, ed un ex-operaio dell’ ILVA, e quindi per evitare di consegnare
la poltrona di primo cittadino al centrodestra o allo sfumato “pericolo”
grillino, qualcuno ha (mal)pensato di candidare Rinaldo Melucci, noto in città,
negli ultimi anni, solo per essere il presidente dello Ionian Shipping
Consortium un consorzio di operatori portuali, le cui limitate capacità sono
raccontate e testimoniate dai bilanci in perdita della sua società e dei lamenti
e critiche sul suo operato da parte degli stessi soci del consorzio marittimo.
Emiliano ha ben pensato di sottomettere sotto la sua ala “protettiva“ (o
distruttiva ?) il sindaco di Taranto Melucci, usandolo come “cavallo di Troja”,
contro il Governo Renzi, nella spinosa questione dell’ ILVA, ma fonti bene
informate interne al Pd di terra jonica, raccontano dei lamenti di Emiliano con
i referenti tarantini del Pd nei confronti del Sindaco Melucci che, esaltato
dalla sua “staffista-portavoce-tuttofare“, ha letteralmente perso il proprio
controllo ed equilibrio e pensa di poter dettare condizioni a tutti, senza in
realtà contare nulla soprattutto nei reali equilibri e “pesi” della politica che
conta. Il Governatore della Regione Puglia che non ha alcun potere
istituzionale e tantomeno decisionale sulle scelte e posizioni del Comune di
Taranto, appresa la notizia della presenza del ministro dello sviluppo
economico Carlo Calenda a Taranto, non ha gradito il blitz del ministro
definendo l’iniziativa di Calenda una “scorrettezza” istituzionale. Resta da
capire qualcosa: quale sarebbe questa scorrettezza? Un ministro della
repubblica, infatti, è assolutamente libero di incontrare quando e dove vuole un
Sindaco, senza necessariamente dover chiedere il permesso ad Emiliano, che sta
invadendo un pò troppo la politica di Taranto. Non a caso al contrario di
Emiliano i sindacati (Fim Cisl, Fiom, Uil e Cgil) ed altri rappresentanti
istituzionali più seri e capaci del governatore pugliese, come ad esempio il
Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, (centrodestra) hanno espresso
il proprio consenso e soddisfazione per la “buona notizia della riapertura del
dialogo”. Ma il governatore pugliese timoroso di perdere l’amato “palcoscenico”
si è messo subito in auto con il suo fido autista-segretario destinazione
Taranto, dove a sua volta ha incontrato e “sgridato” il sindaco Melucci il quale
ha dimostrato ancora una volta di essere un “burattino” (politicamente parlando
s’intende) nella mani del “burattinaio” barese. Emiliano infatti ha subito
cercato di frenare le aspettative sostenendo in una conferenza stampa congiunta
con Melucci, ritornato all’ordine… che “il ricorso sarà ritirato solo se l’esito
del tavolo sarà positivo”. Affermazione che nella vita (non politica,
evidentemente) costituirebbe un ricatto, un estorsione, aggiungendo “Il ministro
Calenda ha cambiato idea sul coinvolgimento degli enti locali e registriamo una
sopravvenuta saggezza che è un fatto sicuramente positivo ma il ricorso contro
il Dpcm sarà ritirato solo se l’esito del tavolo per Taranto sarà positivo, se
cioè saranno prese in considerazione le nostre richieste, che pure sono state
inserite all’ordine del giorno e questo ci fa ben sperare“. In realtà non è
stato Calenda ad avere cambiato idea, ma bensì sono il sindaco Melucci ed il
governatore Emiliano che hanno accettato di sedersi al tavolo ministeriale, dove
si erano rifiutati di partecipare. La realtà è questa. Speriamo solo che non
facciano ulteriori danni. Anche perchè Emiliano tutte le sue battaglie contro il
Governo dinnanzi al Tar, Consiglio di Stato, Consulta, le ha perse tutte. Tanto
il conto agli avvocati lo pagano i poveri “contribuenti” pugliesi. Che sono le
vere vittime di questo burattinaio della politica levantina.
L’ambiente e Taranto.
Lettera di Claudio Riva, Presidente Riva Forni Elettrici al direttore del
Corriere della Sera, pubblicata il 4 dicembre 2017. "Caro Direttore, l’articolo
“La miopia più forte dell’acciaio” (2 dicembre) merita alcune riflessioni.
Il Gruppo Riva ha investito nell’ Ilva oltre 6 milioni di euro (emerge dai
bilanci) – quasi il triplo di quanto vuole investire il futuro proprietario –
tanto che Taranto è citata più volte come “modello” nella normativa Ue del 2012
(a cui bisognava adeguarsi nei 4 anni successivi). Nel 2013 l’Ilva veniva
commissariata e i 4 anni per gli ulteriori investimenti sono passati: gli
“omessi risanamenti” non possono quindi essere addebitati alla gestione Riva. Se
non fosse stata commissariata, anche i restanti investimenti sarebbero stati
fatti dal Gruppo Riva: cosa ancora oggi non avvenuta. C’è stata invece
l’incredibile distruzione di un patrimonio netto pari a 3 miliardi (a inizio
commissariamento) e la perdita di enormi quote di mercato. La “gestione privata”
è finita in Tribunale, ma è vero che ben prima che il processo iniziasse –
l’Ilva è stata illegittimamente espropriata ai titolari, peraltro senza alcun
indennizzo. Anche questo farà riflettere, come scrive l’articolo all’estero, chi
“all’estero decidesse di investire in Italia”. A oltre 5 anni dal sequestro
degli impianti, il processo vede sgretolarsi importanti capisaldi dell’accusa
e i periti del Tribunale ammettono che la gestione Riva ha rispettato tutti i
limiti previsti dalle normative nazionali ed europee. Al governatore Emiliano è
dunque difficile dar torto: l’Ilva è stata tolta al legittimo proprietario
(italiano) sul presupposto errato che non rispettasse il cronoprogramma degli
investimenti ambientali previsti dall’ ultima Aia: passati cinque anni tale
programma non è stato attuato e viene ora addirittura modificato a favore del
nuovo acquirente indiano. Riguardo alla “corruzione di interi pezzi della
società pugliese”, i verdetti giunti finora dicono l’opposto, essendo stati
assolti con formula piena dal reato di favoreggiamento l’ex-segretario del
vescovo di Taranto don Marco Gerardo e Lorenzo Nicastro, ex assessore
all’ambiente della Regione Puglia. Claudio Riva, Presidente Riva Forni
Elettrici"
Quando la miopia è più forte
dell’acciaio. L’Ilva, mal gestita per decenni,
inquinante e tuttavia strategica per l’industria italiana, è ora al centro di
uno scontro tra governo e Regione Puglia in cui è davvero difficile tenersi
neutrali, scrive Goffredo Buccini l'1 dicembre 2017 su "Il Corriere della Sera".
Il vasto repertorio dell’autolesionismo nazionale si sta arricchendo in queste
ore di un nuovo, sconcertante capitolo sull’Ilva. La grande acciaieria, mal
gestita per decenni, inquinante e tuttavia strategica per l’industria italiana,
è ora al centro di uno scontro tra governo e Regione Puglia in cui è davvero
difficile tenersi neutrali. Vale la pena di riassumere: tutto nasce dal ricorso
del presidente pugliese Michele Emiliano (appoggiato dal sindaco di Taranto)
contro il decreto con cui Roma fissava modi e termini nella produzione e nel
risanamento ambientale della fabbrica in procinto di passare sotto il controllo
della multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal; a fronte di tale ricorso
che, davanti al Tar di Lecce, accusa il governo di procrastinare troppo i tempi
di bonifica ignorando le raccomandazioni degli enti locali e di fatto colloca in
un ennesimo limbo giudiziario il futuro dell’Ilva, il ministro Carlo Calenda ha
preso un’iniziativa non meno clamorosa: bollando gli enti locali di «gestione
schizofrenica», ha congelato il negoziato con Arcelor Mittal (su investimenti e
posti di lavoro) «fino alla decisione del Tar» e ha specificato che, ove
l’impugnativa pugliese fosse accolta, i commissari straordinari, cui tutt’oggi
tocca gestire l’azienda, dovrebbero «procedere allo spegnimento degli impianti».
Certificando, in sostanza, la fine dell’Ilva e, forse, di molto altro. Qui le
letture possibili sono due e in qualche modo si incrociano. La prima riguarda
appunto il futuro dei tarantini, ma anche di un grosso pezzo di Meridione e, in
fondo, della nostra stessa posizione di grande Paese manifatturiero. La seconda,
persino più inquietante, attiene al messaggio che da questa vicenda trasmettiamo
a chiunque, all’estero, decidesse di investire in Italia. In questo senso (ma, a
nostro avviso, solo in questo senso) il ministro per lo Sviluppo Economico ha
torto, perché definisce il caso «senza precedenti»: si tratta invece di un caso
grave ma tipico, purtroppo, in un Paese immobile, ancora malato di veti e
«ricorsismo», che consegna a un localismo bellicoso e velleitario opzioni di
interesse nazionale, in modo che qualsiasi decisione non diventi mai definitiva
e che l’ultima parola spetti sempre, anziché alla politica, a una magistratura
chiamata a compiti palingenetici (sia detto col massimo rispetto: ci sarà sempre
un giudice a Lecce...). Tuttavia la vicenda di Taranto non si può liquidare come
fosse frutto di una qualsiasi sindrome Nimby (non nel mio cortile) che paralizza
un po’ ovunque opere e progetti. È, invece, un dramma collettivo con morti e
malati veri, con acqua piovana rossa di veleni e scuole chiuse nei giorni di
vento, e nasce da errori vecchi di mezzo secolo, da una gestione privata finita
in tribunale, dalla corruzione di interi pezzi di società pugliese, cominciando
da politici, sindacalisti e giornalisti che hanno sempre finto di non vedere
omessi risanamenti e danari distratti. Taranto non è mai riuscita a superare la
dicotomia salute-lavoro: la fabbrica uccide coi suoi fumi ma senza fabbrica si
muore di fame. Dunque? Dunque si doveva voltare pagina. Innanzitutto Taranto non
è solo Taranto, è la ragione per la quale siamo una potenza siderurgica in
Europa: l’acciaieria si dovrà trasformare ma non si può spegnere (quanto alla
riuscita di certe de-industrializzazioni e di certe bonifiche qualcuno vada a
farsi un giretto a Crotone o a Bagnoli). Taranto e i tarantini hanno perciò
ottimi argomenti da far pesare. Quelli di Arcelor Mittal non sono filantropi e
nessuno pretende che lo siano, ma sono leader di settore e sono l’ultima chance:
la produzione verrà tagliata (anche per inquinare meno), l’occupazione lo sarà
di conseguenza, il risanamento ambientale imporrà costi che i franco-indiani
recalcitreranno ad accettare, l’antitrust europeo dovrà dire la sua; e tuttavia
su ciascuna di queste voci e di questi problemi la partita è aperta, il
confronto possibile. O, almeno, lo era, fino al ruggito di Emiliano. Il
presidente della Puglia è uomo di istituzioni. E sta assai stretto nei panni di
politico guevarista dentro cui ha deciso di infilarsi da qualche tempo (più o
meno dall’infelice referendum sulle trivelle). Nemmeno i sindacati hanno capito
la sua mossa, gravata secondo alcuni dal sospetto di una faida interna al Pd;
molti lo invitano a ritirare il ricorso e a sedersi di nuovo al tavolo delle
trattative: un tavolo ancora scosso dal pugno picchiato da Calenda, incredulo
all’idea che il Sud possa mandare all’aria cinque miliardi di investimenti e
ventimila posti di lavoro tra diretti e indiretti (di questo si discuteva). Poco
incline alle diplomazie, il ministro ha in questa storia soprattutto un merito:
la chiarezza. Ha urlato che il re è nudo, che così non si può più andare avanti.
C’è da augurarsi che qualcuno lo senta, prima che l’ultimo treno si sia
allontanato da Taranto, Italia.
Il ministro Calenda: «Ilva, emergenza
nazionale. L’Italia bloccata dai veti incrociati». Il
ministro dello Sviluppo Economico: «La fabbrica rischia di chiudere. C’è un
silenzio assordante della classe dirigente, non soltanto del Pd», scrive Marco
Galluzzo il 2 dicembre 2017 su "Il Corriere della Sera". «Il dato della realtà è
questo: oggi Comune di Taranto e Regione Puglia presentano un ricorso contro un
piano ambientale che prevede 1,2 miliardi di investimenti a carico
dell’investitore, la copertura dei parchi minerari che inizierà a gennaio, e una
produzione limitata a 6 milioni di tonnellate sino a che non si completano tutte
le misure. Un piano approvato da una commissione di esperti indipendenti del
ministero dell’Ambiente, che porta l’Ilva ad essere una della acciaierie più
avanzate al mondo. Se il Tar concederà la sospensiva al piano, come chiesto da
Emiliano, si dovrà iniziare il processo di spegnimento mentre si ricorre al
Consiglio di Stato».
Lei ha parlato di irresponsabilità della classe
dirigente regionale, perché?
«Emiliano ha fatto ricorso su tutto: dai vaccini
al Tap, all’Ilva stessa. Per fortuna li ha sempre persi. Oggi però la situazione
è diversa, perché il rischio è che Mittal ritenga impossibile gestire
l’acciaieria più grande della Ue con il sindaco della città e il presidente
della Regione che vogliono cacciarlo. È stupefacente quello che ha dichiarato
Emiliano, sorprendendosi dello scandalo che ha suscitato, dicendo che è solo uno
dei ricorsi, come tanti altri. Viene da pensare che non abbia consapevolezza di
quello fa e che per lui ricorrere sia normale attività di governo. Per queste
ragioni invece di ignorare i ricorsi e le polemiche che Emiliano cerca con ogni
mezzo ritengo sia importante dire con chiarezza e senza mezzi termini che quello
che stiamo vedendo in Puglia è inaccettabile».
Questo lo deciderà il Tar, o no?
«Certo ma il problema non è solo giuridico. C’è
una Regione che ha due infrastrutture strategiche per l’intero Paese, l’Ilva e
il Tap, contro le quali il Governatore ha mosso una guerra. Dice che vuole Ilva
a gas, cosa che non sta in piedi, perché in nessun paese, neanche quelli che
pieni di gas, c’è un’acciaieria delle dimensioni di Ilva che va a gas. Ma poi
comunque fa ricorsi contro un tubo, quello del Tap, che porta in Europa,
attraverso l’Italia, il gas azero. Ci sono 3 mali che hanno condizionato tutta
la seconda Repubblica: la politica dei ricorsi al Tar; la fuga della realtà,
quando si promettono cose che non si possono fare; l’irresponsabilità nei
confronti delle conseguenze degli atti che si pongono in essere. Lo vedremo
quando poi Emiliano dirà che è responsabilità del governo prendersi cura delle
20 mila persone che perderebbero il lavoro se Ilva chiude».
Perché accosta il Tap all’Ilva?
«Ilva è il caso più eclatante degli ultimi anni,
si tratta di oltre 5 miliardi, il più grande investimento industriale nel
Meridione da decenni. Ma quello del Tap è un caso altrettanto significativo: per
un piccolo tubo di 1,5 metri di diametro, che passa 16 metri sotto la costa e a
cui siamo arrivati dopo la valutazione di 13 percorsi alternativi, siamo in
grande ritardo, rischiamo una figuraccia internazionale. La Regione è persino
arrivata a certificare che gli ulivi sono alberi ad alto fusto per bloccare
l’opera mostrando livelli di creatività mai visti prima».
Perché sono opere strategiche per il Paese?
«Se Ilva chiude andiamo a comprare l’acciaio in
Germania e perdiamo un punto di Pil. Con il Tap diversifichiamo rispetto al gas
russo. Di fronte a tutto questo Emiliano dice che la questione riguarda solo la
Puglia. E il Sindaco minaccia battaglie in quanto discendente degli Spartani. Il
governo intanto ha tenuto in piedi l’Ilva con quasi 500 milioni di euro prestati
all’amministrazione straordinaria. Soldi degli italiani, di tutti i contribuenti
che rientrerebbero se l’acquisto andasse a buon fine».
È una storia già vista con Alitalia.
«Certo, è l’idea che tutto è gratis e dovuto. Il
gas deve essere ad un prezzo basso ma senza gasdotti. Si vogliono posti di
lavoro ma quando ci sono investitori non vanno bene, e quando non ce ne sono è
colpa del Governo. C’è un populismo istituzionale che ormai è quasi un virus. Si
è già visto anche con Alitalia, che probabilmente non otterrà condizioni
migliori al prossimo compratore rispetto a quelle che offriva Ethiad, condizioni
che a loro volta erano peggiori di quelle che garantiva Air France anni fa. Un
processo che è una continua fuga dalla realtà. Se Mittal rinuncia all’acquisto
Emiliano non si farà carico delle bonifiche e dei lavoratori, e sarà il primo a
protestare per il prezzo del gas dopo aver boicottato il Tap. Su Alitalia già si
riparla di nazionalizzare dopo aver speso miliardi di euro dei contribuenti.
Perché alla fine il conto di tutta questa cialtroneria lo pagano sempre i tanti
italiani che lavorano, producono e tengono in piedi il paese».
Pensa anche ai sindacati? La protesta contro
Emiliano sono lacrime di coccodrillo?
«Non si può generalizzare. Per Alitalia sì,
Annamaria Furlan ha definito giustamente quel caso un esempio di populismo
sindacale. Per l’Ilva è diverso i sindacati metalmeccanici hanno ben altro
spessore e consapevolezza del rischio che si corre. Insieme abbiamo vinto una
battaglia giusta con l’investitore perché riconoscesse i livelli salariali
precedenti».
Si può fare politica industriale in questo Paese?
«La si fa. Con Industria 4.0., con il piano Made
in Italy, con la Strategia energetica nazionale. Gli investimenti degli
imprenditori sono cresciuti più del 10% l’export è il doppio di quello francese.
Ma certo senza un sistema amministrativo che funziona e una politica ancorata
alla realtà diventa difficile in particolare occuparsi dei casi più complessi di
quei settori, dall’acciaio ai call center, più colpiti dalla crisi. E in questo
modo aumentano i divari».
Negli stabilimenti Ilva si sono circa 200
ispezioni ambientali l’anno, con 500 risorse che lavorano per gestirle.
«Ecco, l’unico modo per risolvere il problema è
investire il miliardo e duecento milioni del piano ambientale e il miliardo
confiscato ai Riva per le bonifiche».
Il silenzio del Pd le pesa?
«Il silenzio non è solo del Pd, che vede peraltro
Bellanova e De Vincenti insieme a Galletti impegnati tanto quanto me, ma il
silenzio della classe dirigente italiana anche negli altri partiti non populisti
e nella società civile. Ed è sconcertante. Non c’è una strategia di sviluppo
senza una presa di coscienza del fatto che la fuga dalla realtà è la malattia
che nutre il populismo. Noi abbiamo stabilito: dal 2025 niente carbone nelle
centrali elettriche. Bene, tutti d’accordo, oggi tutti vogliono decarbonizzare,
ma se poi provi a fare le necessarie infrastrutture nessuna Regione o comune si
astiene dal fare ricorsi. Così non si va lontano».
Si aspetta una parola da Gentiloni?
«Ogni giorno mi coordino con Gentiloni, il quale
peraltro mi sta supportando molto in Europa che è un altro fronte aperto e
difficile di questa vicenda Ilva».
Ci vogliono norme diverse?
«Fallito purtroppo il referendum, la prossima
legislatura si deve porre il problema di una clausola supremazia in grado di
superare i veti locali di fronte ad interessi strategici nazionali, come in
Germania».
Il Tap rischia di fallire come l’Ilva?
«L’Ilva in realtà è già in amministrazione
straordinaria, e rischia di chiudere. Il Tap lo faremo con enormi difficoltà, e
con l’umiliazione internazionale di essere l’unico Paese che non rispetta i
tempi, mentre tutti gli altri hanno già finito o stanno completando i loro
tratti, dall’Albania alla Grecia alla Turchia».
Oggi Grasso viene incoronato leader Mdp, che ne
pensa?
«Penso che bisogna trovare il modo di fare
un’alleanza ampia nel centrosinistra, ma che parta dai contenuti e che non
sacrifichi la coerenza alle logiche di appartenenza di questa legge elettorale.
Grasso è una persona di grande livello, porterà un contributo, ma ci vogliono
programmi sui punti nodali del Paese. Qui ci occupiamo solo di polemiche sulle
banche e della cronaca del giorno, mentre rischia di chiudere l’Ilva e il
silenzio è assordante. La campagna elettorale è iniziata all’insegna delle
promesse che non si manterranno e si tiene alla larga dalla realtà dove le
soluzioni sono più complesse e le spiegazioni semplicistiche non reggono. Se
questo Paese non fa un bagno di realismo rischiamo lo squagliamento disordinato
della Seconda Repubblica».
Esiste un partito, o metodo, Gentiloni?
«Io credo che Gentiloni ha portato un metodo di
lavoro nuovo nel governo, proseguendo le riforme iniziate da Renzi ma
rassicurando il Paese e rendendo il lavoro più fluido. Credo che sia la strada
giusta, ma senza voler togliere meriti ai risultati del Governo Renzi. Il
paradosso attuale è che i provvedimenti di Renzi sono stati i più riformisti da
molti anni, ma hanno comunicato ad una parte ampia del Paese non un senso di
svolta, ma di insicurezza. Usare il coraggio riformista di Renzi e la forza
tranquilla di Gentiloni secondo me è un mix che porterebbe il Pd lontano».
Ma il programma?
«Appunto manca la costruzione di un programma
solido che porti avanti le riforme, e al momento è un pericolo mortale. La
campagna elettorale oggi si occupa di realtà virtuale innestata in un Truman
show giornaliero incomprensibile per i cittadini e pieno di rancori e sospetti
persino all’interno del Pd. È una situazione che non paga, sicuramente non con
gli elettori di centrosinistra. E non è in linea con quanto fatto dagli ultimi
due governi, che hanno affrontato anche nodi molto complessi e difficili in modo
serio rimettendo in moto il Paese».
ESCLUSIVA. La citazione per danni dei
Riva ai giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, che non la raccontano
tutta…! Scrive Antonello de Gennaro l'1 dicembre 2017
su "Il Corriere del Giorno". L’atto di citazione della famiglia Riva (e società)
contro la Gazzetta del Mezzogiorno, il suo direttore De Tomaso ed il cronista
Mimmo Mazza. Un documento “esclusivo” per capire la verità dietro le quinte del
processo senza interpretazioni pittoresche… o fiancheggiamenti a favore dei
magistrati che hanno imbastito il processo Ambiente Svenduto. Secondo
quanto riportato dall’annuale rapporto di Reporters sans Frontieres, il nostro
Paese ha migliorato e di molto la propria condizione relativa alla libertà di
informazione, balzando dal 77° al 52° posto nella classifica mondiale.
Nonostante questo, l’Italia ancora oggi si colloca agli ultimi posti nell’Unione
Europea. Il primato, invece, continua ad appartenere alla Finlandia, paese in
cui le condizioni di lavoro per i giornalisti sono le migliori al mondo. Sarebbe
davvero interessante, poi, stilare una classifica di quali siano i paesi al
mondo che continuano, forti della convinzione che la libertà di espressione sia
un diritto di tutti, a fare dell’informazione un esercizio di “giornalismo
disinformata”. Proprio così, perché il rischio che all’Italia venga assegnato il
primato della disinformazione non è poi così lontano. Quando nei giorni scorsi
abbiamo ricevuto per posta in una busta l’atto di citazione della famiglia
Riva alla Gazzetta del Mezzogiorno, al suo direttore Giuseppe De Tomaso, ed al
vice-capo servizio della redazione tarantina Cosimo (detto Mimmo) Mazza, ed
effettuato le opportune verifiche a seguito delle quali abbiamo appurato che si
trattava di un documento reale ed integrale, relativo ad una delle varie cause
civili intraprese dai legali della famiglia Riva, abbiamo deciso di pubblicarla
in esclusiva, ritenendo che i lettori abbiano il diritto di conoscere ogni
ragione di parte, soprattutto in una vicenda processuale così complessa come
il processo Ambiente Svenduto, di rilievo nazionale attualmente in corso a
Taranto. Il nostro intento sia ben chiaro non è quello di difendere le tesi
accusatorie dei Riva, nè tantomeno salire sul carro di quei giornalisti e
sindacalisti che si stracciano le vesti atteggiandosi a vittime di una censura
inesistente, ma bensì quello di fare il nostro lavoro di giornalisti ed offrire
ai lettori delle notizie nella loro completezza, e come sempre documentandole
“integralmente”. La causa è relativa ad un articolo pubblicato dalla Gazzetta
del Mezzogiorno lo scorso 17 gennaio 2017nel quale secondo gli avvocati
della famiglia Riva, a cui il codice penale e civile sembrerebbero dare ragione
(dal punto di vista della diffamazione subita dai loro assistiti) in
conseguenza dell’utilizzazione giornalistica manipolata del concetto del
“patteggiamento” al fine di far credere al lettore, facilmente suggestionabile
per il tecnicismo delle questioni, che con tale forma di definizione del
procedimento la società dei Riva ed i componenti della importante famiglia di
industriali lombardi abbia confessato a tutti gli effetti il compimento dei
reati. Cosa che non ha ancora fatto. Secondo il legale dei Riva e delle loro
società il “contenuto diffamatorio” dell’articolo pubblicato e firmato da Mimmo
Mazza coinvolge certamente gli esponenti della famiglia Riva rinviati a giudizio
nonché la Riva Forni Elettrici s.p.a. (parte exd.lgs 231/01) e “coinvolge
altresì il medesimo Claudio Riva in proprio il quale, benché non rinviato a
giudizio, avrebbe secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, ammesso il proprio
coinvolgimento nella vicenda. Peraltro il contenuto diffamatorio a carico del
sig. Claudio Riva attiene alla circostanza che allo stesso viene attribuita la
paternità di una dichiarazione a contenuto potenzialmente calunnioso nei
confronti degli imputati del processo” (Ambiente Svenduto in corso a Taranto –
n.d.a.).
Il cronista Mazza, si legge nell’atto legale dei
Riva, avrebbe utilizzato la capacità di generare confusione della fattispecie,
“attribuendo al legale rappresentante della società che ha avanzato la richiesta
di applicazione di sanzione ex art 63 d.lgs 231/01 una dichiarazione
sostanzialmente coincidente con i capi di imputazione utilizzando l’errato
postulato secondo cui il patteggiamento ( quello previsto dal cit. art. 63
assume la medesima natura dell’ istituto di cui all’ art444 c.p.p. )
equivarrebbe ad un accertamento con sentenza o addirittura aduna
piena confessione di colpevolezza”. Così continua l’atto: ” Nel caso di specie
la fattispecie complessiva costituita dall’ utilizzo distorto dei titoli e
sottotitoli nei quali le dichiarazioni vengono rappresentate fuori dal contesto
dell’ istanza di patteggiamento ex art 63 d.lgs 231/01 e portate all’immediata
attenzione del lettore come una piena confessione di colpevolezza e di
fondatezza totale del teorema accusatorio per evocare una sorta di colpo di
scena processuale, e poi il contenuto dell’· articolo con i capi di imputazione
riportati come dichiarazioni del legale rappresentante di Riva Forni Elettrici
s.p.a., portano a doversi ritenere consumata la fattispecie di cui all’ art 595
comma 3 c.p” (cioè il reato di diffamazione aggravata prevista dal Codice
Penale n.d.a.). Il rispetto del requisito della verità avrebbe quindi imposto al
cronista secondo il legale della famiglia Riva e della loro società “di dare
precisa e completa spiegazione della fattispecie precisando la natura del
procedimento ex art 63 d.lgs 231/01 e ciò proprio al fine di evitare di
ingenerare nella platea dei lettori quella confusione che ha invece voluto
alimentare alterando la verità con l’espressa e colorita attribuzione del
contenuto dei capi di imputazione alle dichiarazioni del legale rappresentante
della Riva Forni Elettrici s.p.a.” invece della ricerca spasmodica
del sensazionalismo fine a stesso che segue logiche poco chiare e sicuramente
strumentali fondate sulla spettacolarizzazione della notizia che punta al gossip
più basso senza in realtà, di fatto, informare il lettore. La comunicazione in
senso generale e con essa l’informazione, giornalistica o televisiva che sia, è
portatrice di un preoccupante potere che apporta una pesante
responsabilità altrettanto grande. Questa responsabilità è nelle mani degli
operatori, siano essi giornalisti, broadcaster o opinion leader, i quali,
allorquando veicolano un messaggio verso un pubblico di fruitori più o meno
vasto, più o meno capace di verificarne la fondatezza, hanno il dovere della
completezza, dell’obiettività e dell’imparzialità. Anche quando il messaggio
stesso è contestualizzato dall’opinione, legittima, di chi comunica. Ed è per
questo che non abbiamo mai voluto fare gli “opinionisti”, preferendo lasciare a
tutti voi lettori le debite considerazioni dopo la lettura dell’atto.
Impantanati nel “giornalismo fai da te”, che fuoriesce nel labirinto delle fake
news da social network, molti sono convinti che, in quanto giornalisti, si possa
esprimere qualunque opinione, credendo di aver acquisito anche il diritto di
raccontare ciò che si voglia, dimenticando troppo spesso che le notizie
dovrebbero essere prima verificate e poi pubblicate. Oggi tutti pensano di
essere giornalisti. Qualcuno serio che si attiene alle regole deontologiche per
fortuna esiste ancora, ma il vero dramma è che giovani blogger, o giornalisti
privi di alcuna esperienza reale, hanno la presunzione di atteggiarsi a
giornalisti “esperti” nei vari settori facendo delle proprie convinzioni dei
dati di fatto, per poi far cadere nella trappola migliaia e migliaia di lettori.
Questo genere di informazione falsata diventa “pura disinformazione” ed è ormai
all’ordine del giorno: dalle fake news alla manipolazione delle notizie, spesso
alcuni mezzi di comunicazione non ci raccontano la verità. E la cosa peggiore è
quando a fare queste campagne di disinformazione sono dei giornalisti.
Assistiamo costantemente ad un uso strumentale del messaggio: ossia si cerca, a
volte, di “colorare” una notizia o di metterla maggiormente in risalto perché
funzionale, rispetto ad altre, a perseguire fini di consenso politico, sociale o
di semplice popolarità di una “casta” o di un gruppo d’influenza o di
potere. In alcuni casi, emerge una certa superficialità di chi fa informazione,
ad esempio nella verifica delle fonti e/o dei fatti, una delle regole più
importanti del giornalismo. Quest’atteggiamento alimenta la totale
disinformazione e la nascita delle cosiddette bufale, che si trovano ad essere
legittimate dall’autorevolezza del mezzo comunicativo (quotidiano, tv o web) che
le veste di veridicità e come tale le diffonde. Si pensi ad esempio a tutte le
notizie gravitate intorno alla vicenda dei migranti negli ultimi tempi. Ogni
giornalista dovrebbe seguire le norme previste dalla Legge e dal codice
deontologico professionale, ma soprattutto scrivere e raccontare la verità per
il dovuto rispetto nei lettori e delle persone di cui si parla e scrive,
altrimenti troveremo sempre più millantatori che si atteggiano a esperti di
tuttologia di cui la rete, la tv, i quotidiani ormai ne sono colmi. Oggi la
disinformazione miete le sue vittime ovunque e spesso ci racconta un mondo
diverso da quello in cui viviamo, per cui diventa complesso e difficile
interagire. Il mondo dell’informazione invece deve garantire trasparenza e
certezza della notizia, evitando così di perdere anche quel poco di credibilità
e di lettori che gli è rimasta. E non sarà sicuramente l’alzata di scudi del
sindacato dei giornalisti a favore di un proprio rappresentante a cambiare il
corso della giustizia. Nei tribunali viene ricordato in ogni aula la regola che
“la legge è uguale per tutti”. E deve continuare ad esserla. Per tutti.
Vincenzo Di Maggio: «L’Ilva di Riva?
Miniera d’oro che scontentava molti». «Con Riva molti
potentati dell’era pubblica rimasero a secco e proprio allora, sarà stato un
caso, si è sviluppata una coscienza ambientalista per problemi che erano noti da
anni», scrive lunedì 04 dicembre 2017 Enzo Ferrari, Direttore Responsabile
Taranto Buona Sera. Vincenzo Di Maggio, il presidente dell’Ordine degli
Avvocati: i suoi rapporti con Riva, la Taranto degli anni ‘70 e il sogno della
serie A. Tutto in una intervista.
Avvocato, lei è stato per circa undici anni il
consulente del Gruppo Riva, per gli aspetti civilistici. Come le fu affidato
l’incarico?
«Mi telefonò lo
Studio Colombo di Milano. Chiesero a me e ad altri avvocati tarantini il
curriculum per valutare a chi rivolgersi qui su Taranto in caso di necessità. Il
giorno dopo mi chiamarono per farmi occupare di una grana che avevano avuto per
gli accessi al porto.
Dopo aver lavorato così a lungo per Riva, che
idea si è fatto di questa famiglia?
«Una famiglia
dedita al lavoro. Con una dimensione aziendale molto semplice. Riva sapeva poco
di evergetismo, di gesti di benevolenza fatti alla comunità. A lui interessava
solo produrre acciaio.
Cosa le ha insegnato quella sua esperienza?
«Ho capito
quello che era lo stabilimento nella gestione pubblica e ho compreso che Taranto
non ha mai avuto una vocazione industriale. Storicamente gli unici veri
imprenditori che abbiamo avuto sono stati i tintori ebrei che avevano gli
opifici nell’attuale Via Roma. Taranto è sempre stata legata alla mammella dello
Stato.
Sta dicendo che l’insediamento dell’Italsider
non è servito a creare una classe imprenditoriale.
«Infatti.
Abbiamo vissuto solo di appalti e subappalti. L’indotto importante era
costituito dalle imprese del nord. E ci siamo accontentati di quanto veniva
offerto attraverso il mondo politico e sindacale.
Dicevamo che Riva era interessato solo alla
produzione.
«Sì. Non a caso
i suoi primi atti furono la cessione del circolo Italsider e il trasferimento
dell’ufficio contratti a Milano.
Cosa ha significato il trasferimento di
quell’ufficio?
«Semplice: si
passò dalla voragine di debiti della gestione pubblica alla trasformazione della
fabbrica in una miniera d’oro. Cambiarono le modalità di gestione e molti dei
potentati dell’era pubblica rimasero a secco e scontenti. Sarà stato un caso, ma
proprio in quel momento si è sviluppata una coscienza ambientalista per problemi
che, come TarantoBuonasera ha già avuto modo di mettere in evidenza nelle scorse
settimane, erano noti da molti anni. E non è che Riva inquinasse più dell’Ilva
pubblica, anzi.
Gli effetti sull’indotto di quel cambio di
marcia quali furono?
«Con la
privatizzazione molte imprese hanno pagato la mancanza di una vera e propria
identità imprenditoriale. Taranto per la prima volta si era imbattuta in un
imprenditore.
Un imprenditore a cui la situazione è però
sfuggita di mano, soprattutto per la questione ambientale.
«Io ho avuto la
famiglia sterminata dai tumori. Mia madre è morta a 46 anni e quindi non posso
distribuire assoluzioni. Ma a mio avviso va condannato l’establishment che ha
governato non il singolo imprenditore che è l’ultimo anello di una catena che
non ha funzionato.
Da “Ambiente svenduto” sono emerse relazioni
piuttosto torbide tra i Riva e alcune personalità del territorio…
«Se fossero
state fatte indagini negli anni dell’Ilva pubblica oggi avremmo potuto scrivere
dei trattati su certi tipi di relazioni…
Oggi siamo di fronte all’ennesimo scontro
istituzionale. Crede che si riuscirà a trovare una soluzione?
«Sinceramente
sono disorientato. Abbiamo voluto dare la colpa di tutti i nostri mali ad una
persona mentre credo che questo sia il momento di cercare soluzioni più che
responsabilità di quanto accaduto.
La riconversione è possibile?
«Sono scettico.
Taranto ha tre risorse: agricoltura, cultura, pesca. Ma possiamo utilizzarle
solo a patto di bonificare l’ambiente che abbiamo svenduto.
E il turismo?
«Nel resto
d’Italia oggi Taranto è conosciuta per le tre “d”: dissesto, disorganizzazione,
diossina. Purtroppo noi stessi stiamo esportando un’immagine devastante della
città. Abbiamo avuto colleghi arrivati a Taranto da tutta Italia per partecipare
a iniziative dell’Ordine degli Avvocati: avevano persino paura di mangiare al
ristorante. Così che turismo vogliamo fare?
Quindi non crede alla riconversione?
«Alla
riconversione deve contribuire in modo determinante lo Stato che ha creato
questa situazione. Il vice sindaco ha parlato di modello Essen: ben venga la
realizzazione di un disegno del genere. È chiaro che lo stabilimento dovrà
essere ridimensionato e gli esuberi ben potrebbero essere ricollocati in nuove
industrie, perché no, tese a risanare l’ambiente, da creare sul territorio.
Passiamo a migliori ricordi: gli anni ‘60 ’70 e
suo padre, Michele Di Maggio, presidente del Taranto.
«Era un’altra
Taranto. Elegante. Era la Milano del Sud. C’era educazione e senso di
appartenenza, orgoglio di essere Tarantini. Oggi la nostra è una città
litigiosa, che si piange addosso: altro che identità spartana! Allora, invece,
c’era speranza nel futuro.
E nel calcio si sperava nella serie A…
«Arrivammo
quinti in serie B con Invernizzi in panchina. Mio padre nutriva l’ambizione
della promozione in serie A. De Palo, presidente del Bari, avrebbe fatto carte
false per Beretti e Paina. Lui disse di no, voleva la massima serie.
Che non arrivò. Anzi, qualche anno dopo suo
padre lasciò…
«Aveva un
caratteraccio e si ritrovò quasi tutta la stampa contro. Poi arrivarono persino
le minacce. Per un anno fui costretto ad essere accompagnato dalla scorta…non
era vita!
Ora lei è presidente dell’Ordine degli
Avvocati. E proprio l’altra settimana è nata la polemica per l’affidamento ad un
avvocato barese dell’incarico per il ricorso del Comune contro l’Aia Ilva. Non
l’avete presa bene.
«A Taranto ci
sono 3.875 avvocati. Non credo che non ve ne fosse uno in grado di fare quel
ricorso. Comunque, subito dopo, ci siamo incontrati con il vicesindaco De
Franchi e gli abbiamo proposto di formulare una nuova short list dove poter
attingere le nostre migliori professionalità a seconda del tipo di causa da
affrontare. Speriamo così di poter costruire migliori relazioni per il futuro ed
offrire un valido contributo alle scelte operative dell’Ente civico.
Ilva, "Ambiente Svenduto": presidente e
giudice Corte d’Assise si astengono. In aula il 20
settembre, scrive il 12 luglio 2017 "Il Corriere di Taranto". Ora ogni spetterà
valutazione al presidente del tribunale Franco Lucafò che dovrà decidere se
rinnovare loro la fiducia o assegnare il procedimento ad un altro collegio.
Sull’istanza di ricusazione dei due giudice si esprimerà comunque la Corte
d’Appello. Ancora un colpo di scena nel processo ‘Ambiente Svenduto’ sul
presunto disastro ambientale prodotto dall’Ilva. Il neopresidente della Corte d’
Assise del processo Stefania D’Errico, e il giudice a latere Fulvia Misserini,
pur avendo respinto nel merito, durante l’udienza odierna, le eccezioni della
difesa degli imputati in merito alla serenità e libertà di giudizio, hanno
dichiarato di astenersi dal portare avanti il dibattimento e quindi di rimettere
ogni valutazione al presidente del tribunale Franco Lucafò. Sarà dunque
quest’ultimo a decidere se rinnovare loro la fiducia o assegnare il procedimento
ad un altro collegio. I difensori di alcuni imputanti, come riportato questa
mattina, hanno presentato anche istanza di ricusazione dei due giudici, sulla
quale comunque si esprimerà la Corte d’Appello. Le ragioni sono sempre le
stesse: le eccezioni legate all’insediamento del giudice Stefania D’Errico al
posto del giudice Michele Petrangelo prima che questi vada in pensione per
raggiunti limiti d’età (il prossimo 2 agosto), il fatto che il giudice sia
residente in uno dei quartieri considerati più inquinati e risulterebbe quindi
potenzialmente parte offesa; inoltre è stata evidenziata la partecipazione del
giudice D’Errico ad una iniziativa ambientalista organizzata da una scuola di
Taranto e l’adesione del marito della giudice ad un gruppo Facebook, risalente
al 2012, chiamato ‘Profumo di Ilva’, di chiara ispirazione e matrice
ambientalista. Al giudice a latere Misserini invece, i difensori hanno chiesto
di astenersi per la sua frequentazione sporadica con un teste del processo
indicato dal pubblico ministero. La presidente D’Errico, al termine di una lunga
camera di consiglio, ha letto due ordinanze separate con cui ha respinto le
eccezioni della difesa, ritenendo che non comportino la necessità
dell’astensione obbligatoria, e sottolineando di essere stata indicata quale
giudice togato aggiunto nel 2016 e che il giudice Petrangelo non avrebbe potuto,
a causa di un impedimento, presiedere l’udienza odierna. In merito al gruppo
Facebook a cui ha aderito il marito e alle altre contestazioni, il giudice ha
invece precisato che si tratta di fatti datati nel tempo e che non ci sono casi
di ‘inimicizie gravi’ con gli imputati. Il processo è stato così aggiornato al
20 settembre prossimo e l’udienza si terrà non più nell’aula di Corte d’Assise
di Taranto ma nell’aula bulker dell’ex Corte d’Appello, al quartiere Paolo VI.
Processo «Ambiente svenduto». Rinnovata
fiducia ai due giudici. «Non c'è alcuna incompatibilità»,
scrive il 21 luglio 2017 “La Gazzetta del Mezzogiorno. Restano al loro posto i
due giudici togati della Corte d’Assise di Taranto impegnati nel processo per il
presunto disastro ambientale causato dall’Ilva. Lo ha deciso il presidente del
Tribunale di Taranto Franco Lucafò che ha depositato oggi il provvedimento con
cui non ravvisa incompatibilità nei confronti del neopresidente della Corte
d’Assise, Stefania D’Errico, e del giudice a latere Fulvia Misserini. Erano
stati alcuni difensori nell’udienza del 12 luglio scorso a mettere in dubbio la
serenità e la libertà di giudizio dei due giudizi che avevano deciso di
astenersi dal portare avanti il dibattimento e di rimettere ogni valutazione
nelle mani del presidente del Tribunale. I difensori, sempre nella scorsa
udienza, avevano presentato anche istanza di ricusazione dei due giudici, sulla
quale si esprimerà la Corte d’Appello, eccependo questioni legate
all’insediamento del giudice Stefania D’Errico al posto del giudice Michele
Petrangelo prima che questi vada in pensione per raggiunti limiti d’età (2
agosto); al fatto che il giudice D’Errico sia residente in uno dei quartieri
considerati più inquinati e risulterebbe, per questo, potenzialmente parte
offesa, e alla partecipazione del giudice D’Errico a una iniziativa
ambientalista organizzata dalla scuola e all’adesione del marito della giudice a
un gruppo Facebook, risalente al 2012, chiamato 'Profumo di Ilvà. Al giudice a
latere Misserini i difensori chiedevano invece di astenersi per la sua
frequentazione sporadica con un teste d’accusa del processo. Il processo è stato
aggiornato al 20 settembre prossimo nell’aula bulker dell’ex Corte d’Appello, al
quartiere Paolo VI.
Ilva: “inammissibile” la ricusazione
giudice, scrive martedì 17 maggio 2016 la Redazione di
"Taranto Buona Sera”. La sezione distaccata di Taranto della Corte d'Appello di
Lecce ha dichiarato inammissibile, per carenza di documentazione, l'istanza di
ricusazione presentata dall'ex assessore provinciale all'Ambiente Michele
Conserva (Pd), uno dei 47 imputati del processo per il presunto disastro
ambientale causato dall'Ilva, nei confronti del presidente della Corte d'Assise,
Michele Petrangelo. L'ordinanza è stata notificata agli avvocati Michele
Rossetti e Laura Palomba, difensori di Conserva, che oggi - secondo quanto
apprende l'Ansa - riproporranno la richiesta di ricusazione presentando la
documentazione mancante in occasione della prima udienza del processo. Prevista
in aula la presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
L'ente è tra le circa mille parti civili del processo. L'ex assessore Conserva è
accusato di concussione tentata e consumata a carico di due dirigenti della
Provincia impegnati con il rilascio di autorizzazioni a favore del gruppo Riva.
I suoi legali motivano la ricusazione con il ruolo di presidente svolto dal
giudice Petrangelo nel collegio del tribunale del Riesame che nel dicembre del
2012 confermò gli arresti domiciliari a carico di Conserva, arrestato dai
finanzieri il 26 novembre dello stesso anno in una inchiesta parallela.
Corrado Clini: "L'Ilva è stata svenduta:
nel 2012 valeva quasi 9 miliardi". L'ex ministro: "La
colpa è di chi voleva la nazionalizzazione", scrive Anna Maria Greco, Giovedì
01/06/2017, su "Il Giornale". Corrado Clini ha gestito da ministro dell'Ambiente
del governo Monti la grande questione dell'Ilva e oggi, che si è arrivati alla
vendita, legge i fatti alla luce della gestione del problema negli ultimi 5
anni.
Professore, due cordate si fronteggiano anche
se quella Arcelor-Mittal sembra favorita rispetto ad AcciaItalia, ma si temono
6mila esuberi, i lavoratori sono in sciopero e il confronto tra governo e
sindacati è durissimo: prevedeva questo epilogo?
«C'era da aspettarselo. È il risultato della
catastrofica perdita di posizione sul mercato di quella che era la più grande
acciaieria d'Europa. Nel 2012, quando feci accettare alla famiglia Riva il piano
di risanamento e ammodernamento degli impianti con un investimento, il valore
dell'asset era attorno a 8-9 miliardi, ora le offerte sono di 1 miliardo e 800
milioni di AcciaItalia e di 2.300 milioni di Arcelor-Mittal. Un quinto del
valore del 2012, la riduzione dell'occupazione è connessa alla progressiva
perdita di quote di mercato con il conseguente calo di produzione. Ovviamente
tutto questo si ripercuote sull'indotto. Se fosse stato attuato il piano, che
doveva essere completato entro il 2015, oggi l'Ilva sarebbe l'acciaieria più
moderna e competitiva d'Europa».
Si paga la scelta del governo Letta di aver
interrotto quel percorso e di aver scelto il commissariamento?
«Non c'è stato il coraggio politico e
istituzionale di proseguire la strada indicata da governo e parlamento nel 2012.
Ha prevalso una campagna mediatica senza precedenti che ha attribuito allo
stabilimento tutti i rischi per la salute generati nella città da molti altri
fattori, sostenuta da provvedimenti giudiziari incomprensibili e da forze (nella
maggioranza di allora e nella Fiom di Landini) che spingevano per la
nazionalizzazione, come negli anni '70, delle Partecipazioni statali. Nessuno ha
voluto prendere in considerazione tranne l'allora vicepresidente della
Commissione Ue Antonio Tajani, il mio allarme sulla connessione tra l'attacco
all'Ilva e l'interesse dei competitor europei e internazionali per la riduzione
della presenza dell'Ilva sul mercato dell'acciaio. I commissari si sono trovati
a gestire il declino dell'acciaieria».
Lei è convinto che si potesse salvare la
posizione sul mercato e l'occupazione senza rischi per la salute dei cittadini?
«Gli interventi urgenti a difesa dell'ambiente e
della salute del piano erano la garanzia per la continuità della produzione e la
salvaguardia dell'occupazione. Invece, questi interventi sono stati rinviati nel
tempo e diluiti nella sostanza, il termine del 2015 è stato prorogato al 2018».
Anche la magistratura...
«Nel 2012 uno dei 3 miliardi che i Riva
destinavano al risanamento era disponibile sotto forma dei prodotti pronti alla
vendita. Ma il gip di Taranto li sequestrò come corpo del reato. Superammo il
blocco con una legge, ma la Consulta riconobbe la legittimità. Eravamo nel 2013
e il governo successivo decise il commissariamento. Tutte le scadenze sono
saltate e ci troviamo a questo punto».
Paradosso Taranto: tra gli aspiranti
sindaco l’Ilva rimane un tabù. Finalmente un articolo
"vero" sulle elezioni amministrative di Taranto. Ed infatti non a caso lo ha
scritto un giornalista del quotidiano LA STAMPA che non vive a Taranto! Mentre i
10 candidati svicolano, tra slogan e proposte irrealizzabili, nel silenzio
complice dei soliti “pennivendoli” da quattro soldi….
Di Paolo Baroni, 1 giugno 2017. L’Ilva è grande
una volta e mezzo la città di Taranto. È naturale che la sovrasti in tutto, che
la fagociti. Il paradosso è che mentre la città rischia di affondare trascinata
dalla crisi del suo siderurgico il tema in città è quasi tabù. Solo l’annuncio
di una nuova ondata di esuberi fuori misura legati all’imminente passaggio di
proprietà, 5-6 mila licenziati di qui al prossimo anno, ha smosso le acque. Si è
fatto sentire il sindaco uscente, Ippazio “Ezio” Stéfano, che ha rivendicato il
coinvolgimento della città nella trattativa per la cessione – un vero paradosso
se si considera che tutti lo indicano come il campione dell’immobilità – e ha
preso posizione qualcuno dei candidati che puntano a subentrargli alla guida di
Palazzo di Città. Da anni e oggi ancora di più, con l’economia in caduta
libera, centinaia di negozi e case sfitte o in vendita a prezzi da saldo e
appena 3 persone su 10 che lavorano (mentre le altre vivono di sussidi pubblici
ed espedienti), l’Ilva a Taranto è «La Questione». Eppure sino a ieri nei comizi
elettorali come nelle interviste tv, pochi ne parlavano esplicitamente. «Molti
si nascondono», spiega il candidato del centrosinistra Rinaldo Melucci. Troppo
facile cavalcare una questione ambientale ma anche troppo rischioso immaginare
di attaccare in qualche modo gli operai che comunque rappresentano pur sempre un
bel pacchetto di voti. Anche il M5S un poco svicola. Il problema ambientale,
complice l’alleanza col movimento “Liberi e pensanti” di derivazione Fiom, è
solo il decimo punto del programma del loro candidato, Francesco Nevoli,
avvocato di professione e figlio dell’assessore al Bilancio che nel 2006 portò
il Comune al dissesto. Che oltre ad evocare l’esigenza di un accordo di
programma per far pesare la città nelle scelte future, e a proporre un
irrealizzabile grande piano di «riconversione economica» del territorio, non va.
Il Pd? Ha sposato la linea Emiliano della de-carbonizzazione, altro progetto
lunare stante l’attuale indisponibilità di gas, ma lo affiancano a proposte più
concrete nel campo del turismo e dell’agroindustria. Il centrodestra? Non
pervenuto. La sua candidata Stefania Baldassari, direttrice in aspettativa del
carcere cittadino, il più delle volte si sottrae al confronto come è capitato
l’altro giorno con Confindustria. Spiega il presidente degli imprenditori
tarantini Vincenzo Cesareo: «Purtroppo c’è molto pressappochismo: c’è tanta
gente che parla per sentito dire e c’è poca conoscenza dei problemi. Anche se
siamo in campagna elettorale questa vicenda non si può liquidare con una battuta
dicendo solo “chiudiamo le fonti inquinanti”, oppure “mettiamo gli operai a fare
le bonifiche”». «Se siamo arrivati a questo punto – denuncia a sua volta il
segretario della Fim Cisl Valerio D’Alò – è soprattutto a causa dell’assenza
della politica locale». A pochi giorni dal voto il quadro politico (e sociale)
di Taranto si presenta frantumato come non mai: 10 aspiranti sindaci, 37 liste,
oltre 1400 candidati. A contendersi il voto di protesta saranno i 5 Stelle e
la Lega d’azione dell’ex sindaco Cito, che da pluri-condannato ricandida il
figlio Mario. Il centrosinistra sulla carta potrebbe contare un ampio consenso
ma si presenta diviso in ben quattro schieramenti. Il candidato di Pd, Psi e
Alternativa popolare è Rinaldo Melucci, giovane presidente di un consorzio
portuale. Emiliano, suo grande sponsor lo ha indicato come futuro «sindaco
sarto», chiamato insomma a «unire e a invertire il processo di confusione e di
scomposizione che si è sviluppato in questi anni». Di certo Melucci non avrà
vita facile perché se la dovrà vedere innanzitutto col presidente uscente del
consiglio comunale, Pietro Bitetti (ex Pd ora Progetto Taranto), appoggiato
dietro le quinte dal vecchio dominus cittadino Claudio Signorile e dal suo
quotidiano Taranto BuonaSera. Quindi col prediletto del sindaco uscente, il
giudice di sorveglianza Massimo Brandimarte (Sviluppo Democrazia Solidarietà),
volto noto di “Forum”, con l’ex procuratore Franco Sebastio (lista
civica MutaVento) e con l’allevatore Vincenzo Fornaro candidato
di Verdi, Civati e De Magistris. Possibile esito del voto dell’11 giugno? I
sondaggi disegnano una gara a quattro, con Nevoli e Cito destinati a rubarsi i
voti a vicenda, ma col candidato del M5S accreditato di un 18-20% davanti
a Baldassari, e a Melucci e Bitetti. Quest’ultima competizione rischia di
favorire per il ballottaggio la candidata del centro-destra che, assieme
a Sebastio e Brandimarte, compone una singolare «filiera della giustizia».
Melucci è convinto che i 5stelle siano sopravvalutati e che alla fine la partita
tra centrosinistra e centrodestra. In realtà tutti dovranno fare i conti con un
terzo incomodo, l’astensionismo, che a Taranto viaggia ben oltre il 40 per
cento.
Elezioni Taranto 2017. La grande
“monnezza”: la stampa. Scrive il 10 aprile 2017
Antonello de Gennaro su "Il Corriere del Giorno". La “Grande Monnezza” è quella
variegata, variopinta, composta da un mix di giornalisti, pennivendoli e
scribacchini, pronti a passare da uno “sponsor” ad un’altra in cambio di soldi o
di qualche promessa. Una “Grande Monnezza” al cui interno sguazzano non pochi
“pennivendoli” (chiamarli giornalisti sarebbe offensivo per quei pochi seri) i
quali fanno questo mestiere calpestando tutte le norme deontologiche, lavorando
sotto mentite spoglie per candidati, politici, aspiranti tali, vendendo il loro
tesserino per qualche centinaia di euro in più. Questo giornale come i nostri
lettori hanno avuto ben modo di verificare è sinora stato silente osservatore su
quanto accade in vista delle prossime elezioni amministrative. Lo abbiamo fatto
perchè al contrario di finti moralisti dell’ultima ora non abbiamo alcun
interesse personale e diretto con alcuna candidatura anche se a questa
competizione (si fa per dire…) elettorale partecipa una mia lontana parente che
porta il mio stesso cognome, e con la quale sono in aperto contrasto ideologico
e caratteriale. Ma di quest’ ultimo particolare a molti non importerà nulla,
mentre qualche frustrato adesso potrà mettersi il cuore in pace.
La “Grande Monnezza” è variegata, variopinta,
composta da un mix di giornalisti, pennivendoli e scribacchini, pronti a passare
da una lista ad un’altra in cambio di soldi o di qualche promessa. Una “Grande
Monnezza” al cui interno sguazzano non pochi “pennivendoli” (chiamarli
giornalisti sarebbe offensivo per quei pochi seri) che fanno questo mestiere
calpestando tutte le norme deontologiche, lavorando sotto mentite spoglie per
candidati, politici, aspiranti tali, vendendo il loro tesserino per qualche
centinaia di euro in più. Nella mia breve permanenza tarantina, durante la quale
la solita mano vigliacca mi ha incendiato la macchina (inutilmente), ho fatto il
mio lavoro: osservato, parlato con candidati, partecipato a conferenze stampa,
ed ho avuto notizia di giornalisti “profughi” di un giornaletto fallito da tre
anni che si propongono a questo o quel candidato per qualche migliaio di euro,
addirittura in accoppiata con il/la rispettiva consorte.
Giornalisti in cassa integrazione (e quindi
retribuiti dallo Stato) come Pierpaolo d’ Auria che manda in giro comunicati
autodefinendosi “addetto stampa del consigliere regionale Liviano”. Giornalisti
che nelle conferenze stampa si stracciano le vesti della professionalità
illudendosi che non sappiamo che quella stessa persona viene indicata da un
parlamentare della provincia come “mio addetto stampa”.
Ho letto la scorsa settimana un editoriale di un
collega, e cioè Enzo Ferrari direttore del quotidiano(Taranto) Buona Sera, il
cui reale editore come a tutti ben noto è la famiglia Signorile (Claudio ex
ministro socialista) lamentarsi del modo di comunicare di una candidata sindaco,
che preferisce comunicare via web (come fanno peraltro una marea di politici a
partire dall’ ex-premier Matteo Renzi, dal leader dl M5S Beppe Grillo e dal
Sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi, tanto per fare qualche nome…) che viene
così testualmente accusata: “scavalco i giornali e faccio da me. Sembrano
affermazioni di un candidato grillino, di quella parte della politica – meglio,
antipolitica – che ha nel suo codice genetico la delegittimazione del ruolo
della stampa e l’uso della pseudo democrazia diretta attraverso la giungla dei
socialnetwork, dove in verità il più delle volte si sviluppano discussioni che
non sono proprio un esempio di civiltà e confronto”. Caro collega Ferrari, la
scelta della Baldassari non è delegittimazione, ma secondo me comunicare
direttamente ai cittadini, agli elettori attraverso i social network soprattutto
in una città come Taranto dove sono molti, troppi, i giornalisti che stanno sul
libro paga di qualcuno che non è il suo lettore o editore, è stato una
legittima scelta che condivido ed apprezzo. Così facendo ha oltrepassato la
solita “mediazione” giornalistica di un tanto al chilo…e costretto i giornali e
siti a dover raccontare il suo pensiero senza travisarlo o interpretarlo
difformemente dalla realtà.
Leggerlo poi su un quotidiano il cui
ex-direttore (Michele Mascellaro) compare ancora oggi nella gerenza come
“redazione di Bari” mentre nello stesso tempo è ufficialmente retribuito ed alle
dipendenze del Gruppo PD al Consiglio Regionale della Puglia onestamente fa solo
ridere, se non piangere per come viene calpestata la nostra deontologia
professionale. Legittimo chiedersi se il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti
di Disciplina in Puglia esiste? “Accogliendo l’invito dell’Associazione della
Stampa di Puglia, i nominativi per l’ufficio stampa sono stati selezionati tra i
giornalisti iscritti all’Ordine”, dichiarava a suo tempo con un comunicato
(privo di firma) il PD pugliese.
Quello stesso Michele Mascellaro che da anni
sfugge alle sue responsabilità (intercettazioni processo Ambiente
Svenduto) grazie al silente menfreghismo dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia e
del sindacato pugliese che lo “protegge”. Ma in cambio di cosa? Il silenzio
forse? E su cosa…?
Vedere apparire un sito online come La Ringhiera
edito non da un editore, da una casa editrice, ma bensì da un’A.P.S. cioè
un’Associazione di Promozione Sociale, che per legge non può avere profitti.
Mentre in realtà vende magliette ed incassa pubblicità attraverso la società
compiacente Capera srl (che li ospita non a caso in ufficio), e che vanta due
direttori (Angelo Di Leoe Michele Tursi) su soli due giornalisti dichiarati che
vi scrivono, i quali peraltro vengono pagati ogni mese da oltre due anni dalla
cassa integrazione, degli articoli inneggianti all’Assostampa pugliese, ed alle
calpestate (da loro stessi) norme deontologiche , fatemelo dire, va venire a dir
poco il voltastomaco. Uno dei due, e cioè Angelo Di Leo come tutti ben sanno a
Taranto, ha lavorato nello “staff” (parola che a qualche sindacalista da
quattro lire non piace molto) di Rosanna Di Bello di Forza Italia quando era
il Sindaco del Comune di Taranto, per poi successivamente armi e bagagli in
occasione delle ultime regionali a Taranto, a fare il capo dello staff
elettorale del consigliere regionale uscente Annarita Lemma, capolista
nel PD, la quale è uscita sonoramente “trombata” cioè non rieletta dai suoi
elettori, e vedere sulla testata dell’ associazione di promozione sociale La
Ringhiera “sparata” (o meglio “spacciata”) come notizia il comunicato
dell’ Assostampa che attacca chi usa “staff di comunicazione” fa sicuramente
sbellicare dalle risate. Parlano proprio loro che non hanno mai fatto nulla per
garantire ai disoccupati pugliesi il diritto al lavoro negli uffici stampa degli
enti pubblici ai sensi della Legge 150.
O vogliamo parlare del cosiddetto
IlGiornalediTaranto, testata online di proprietà di un’associazione no-proft (di
cui ci siamo occupati in passato – leggi QUI) presieduta dall’ex-assessore
regionale Fabrizio Nardoni (ex-Sel-Vendola) diretto dal pubblicista Angelo
Lorusso, marito della giornalista Luisa Campetelli (a sinistra nella foto) alla
guida nel crack giornalistico-editoriale-fallimentare del CdG di Puglia e
Lucania? Lorusso ha un’associazione che effettua corsi di formazione
professionale (con i soldi “pubblici” della Regione Puglia) , ma dopo le due
esperienze fallimentari a capo dello staff elettorale-trombato
di Fabrizio Nardoni, si prodiga da settimane per trovare una nuova collocazione,
offrendosi come “spin-doctor” a chiunque gli capiti a tiro pur di raccattare
qualche migliaio di euro, alternando i suoi rapporti con il Sen. Dario
Stefàno a Tonino Caramia, per finire al consigliere regionale
barese Alfonso Pisicchio.
Dov’era l’Assostampa di Puglia…. allorquando
Michele Tursi ancora in forza, cioè socio-dipendente alla Cooperativa 19
luglio (editore del CdG di Puglia e Lucania successivamente fallito con una
massa fallimentare di oltre 5 milioni di euro) lavorava quotidianamente
alla Camera di Commercio di Taranto, con un contratto di 1.000 euro netti al
mese oltre contributi INPGI , senza che sia stata fatta alcuna selezione e/o
bando pubblico, ed in un aperto contrasto deontologico che questo giornale ha
pubblicamente denunciato e raccontato DOCUMENTALMENTE senza che l’ Ordine dei
Giornalisti di Puglia abbia mosso un solo dito. Ma esiste un Consiglio di
Disciplina in questo Ordine? E’ la domanda che nei prossimi giorni faremo
ufficialmente e legalmente al Presidente del Tribunale di Bari che nomina il
Consiglio su Disciplina su indicazione di una rosa di nomi ricevuta dall’ Ordine
dei Giornalisti. Informando per competenza la Direzione Generale Affari Civili
del Ministero di Giustizia che vigila sugli ordini professionali territoriali.
Possibile che nessuno dei
rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia e del loro “caro” sindacato
si accorga di quanti conflitti d’interesse vi siano nel giornalismo tarantino?
Nessuno alla Gazzetta del Mezzogiorno a Taranto (redazione dove ci sono più
sindacalisti che giornalisti), riceve i comunicati stampa per un candidato
sindaco del centrosinistra inviati e firmati dalla giornalista Maristella
Baggiolini, ex-collaboratrice dell’ex-assessore Fabrizio Nardoni alla Regione
Puglia, che nello stesso tempo è direttore responsabile del giornale
online TVMED, dove all’improvviso è scomparso il suo nome! Tutto normale questo
per la Procura di Taranto che ha indagato tanto sul sottoscritto spendendo
inutilmente tanti soldi del contribuente ??
L’ Ordine dei giornalisti di Puglia e
l’Associazione della Stampa di Puglia (i nuovi Cicì & Cocòdella pseudo
informazione pugliese), denunciano come “il fenomeno costituirebbe sicuramente
una buona notizia, soprattutto in una fase di forte contrazione del mercato del
lavoro giornalistico, se l’incontro fra domanda e offerta di prestazioni
professionali avvenisse nel rispetto della dignità delle persone, prima ancora
che del diritto a un’equa retribuzione sancito dalla Costituzione”. Ma lo sanno
che il più vecchio quotidiano pugliese e cioè la Gazzetta del Mezzogiorno dove
lavora il sindacalista-presidente Bepi Martellotta ed il suo
vice-sindacalista Mimmo Mazza, pagano ai loro collaboratori l’importo di circa 5
euro netti ad articolo? E questo sarebbe l’equo compenso? Probabilmente è più
equo il compenso delle donne delle pulizie che a Taranto percepiscono 8 euro
l’ora!
Come non ridere (o meglio avere pena) delle
dichiarazioni del sindacato pugliese dei giornalisti, di quello che voleva
costituirsi parte civile nei miei confronti per una denuncia strumentale di
“stalking”, frutto della malsana fantasia e farneticazione del suo sodale ed
iscritto Mimmo Mazza presentata nei miei confronti, che è stata annientata
dal Gip di Taranto, dal Tribunale del Riesame e persino dalla Corte di
Cassazione. Scrive l’Assostampa sul suo sito: ““Pervengono al sindacato dei
giornalisti – proseguono – segnalazioni, sulle quali sono in corso verifiche, di
offerte di lavoro a condizioni economiche risibili. Forze politiche e candidati,
che hanno già investito o si preparano a investire decine di migliaia di euro in
campagne pubblicitarie, gadget, cene elettorali e altro, diventano parsimoniosi
quando si tratta di stipulare un contratto con i propri addetti stampa. “Questa
situazione – continua il ridicolo comunicato dell’ASSOSTAMPA di Puglia –
talvolta favorita da comportamenti scorretti di sedicenti giornalisti che si
offrono gratis al politico di turno nella speranza di ricavarne utilità e
gratificazioni future, si va addirittura allargando all’affidamento della
comunicazione a non meglio identificati “staff,” dai quali pervengono comunicati
non firmati in barba alle principali regole della professione. Note, per di più,
ricche di contestazioni nei confronti di quei giornalisti che si sono azzardati
a svolgere regolarmente il loro lavoro esercitando il diritto di cronaca nei
resoconti delle candidature e delle liste” e conclude “è inaccettabile oltre che
offensiva della dignità e del decoro dell’intera categoria. E’ bene ricordare ai
segretari dei partiti politici e ai singoli candidati, qualora lo avessero
dimenticato, che quella giornalistica è un’attività professionale che ha regole,
parametri retributivi e obblighi contributivi anche in Puglia e che non si può
umiliare la dignità degli iscritti all’Albo. Tanto più è illegittimo affidare lo
svolgimento di questa professione a chi la esercita abusivamente, in contrasto
con le prescrizioni che l’attesa riforma dell’editoria ha finalmente sancito”.
E quale sarebbe la Legge che obbliga ad un
candidato di comunicare ed inviare delle proprie dichiarazioni esclusivamente
con un iscritto all’ Ordine? E cosa vieterebbe eventualmente a tutti i laureati
in Scienze della Comunicazione di fare ciò legittimamente? O forse in vista dei
prossimi congressi per il rinnovo delle cariche del Consiglio dell’Ordine dei
Giornalisti di Puglia qualcuno vuole far vedere che si occupa dei colleghi
pugliesi? La Cassazione ha stabilito anni fa che è legittimo criticare (con
continenza) l’operato della magistratura e persino del capo dello Stato,
Quindi cosa e chi vieterebbe a qualcuno di poter esercitare il proprio legittimo
diritto di critica nei confronti di una stampa tarantina nella stragrande
maggioranza dei casi asservita e corrotta? O forse qualcuno a Taranto non si è
accorto di un ente pubblico come la Camera di Commercio di Taranto che da
qualche mesi dichiara come addetto stampa un avvocato-pubblicista, che da
qualche mese firma i suoi comunicati stampa, il quale in realtà si è sempre e
solo occupato di conciliazioni, ed peraltro cugino di un “noto” magistrato
tarantino?
Dov’erano l’Assostampa e l’Ordine dei Giornalisti
di Puglia quando il Comune di Taranto negli ultimi 10 anni ha avuto ed usato
come addetto stampa una gentile “vigilessa” (non iscritta all’ Ordine)?
E dov’erano queste “verginelli” della professione, quando la Provincia di
Taranto a partire dalla Presidenza Gianni Florido ad oggi ha avuto ed utilizzato
a tutt’oggi come addetto stampa una persona che in realtà è una segretaria
dipendente dell’ente provinciale, ed anch’essa non risulta iscritta all’ Ordine
dei Giornalisti? O quando per anni l’ASL Taranto ha avuto un addetto stampa che
non era iscritto all’ Ordine al quale si è iscritto soltanto recentemente dopo
le nostre denunce?
Ma siamo proprio sicuri che a Taranto esiste una
magistratura indipendente che applica a fa rispettare le norme di Legge? I
recenti accadimenti sulle vicende per il processo Ambiente Svenduto dicono
purtroppo il contrario. Secondo fonti abbastanza attendibili sembrerebbe
addirittura che una giornalista-sindacalista tarantina la cui firma appare molto
spesso sull’edizione di Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno svolga incarichi
di comunicazione per il Commissario delle Bonifiche (in rigoroso silenzio ed
anonimato…)! E come mai nessuno si meraviglia e lamenta del fatto che l’Autorità
Portuale di Taranto organizza conferenze stampa, interviste, invii comunicati
stampa senza che risulti assunto un giornalista idoneo a tale compito secondo la
Legge 150? Forse qualcuno non si è tolto del tutto il cappuccio dalla testa
per non riuscire a vedere tutto ciò….
Dov’erano questi “censori” e paladini di una finta
deontologia, degni dei frequentatori di un bar…citato in un’ormai celebre
affermazione del prof. Umberto Eco, allorquando giornalisti e collaboratori
della redazione tarantina della Gazzetta del Mezzogiorno venivano lautamente
ricompensati da un ente pubblico per le loro collaborazioni ad associazioni di
categoria ed enti pubblici?
Appunto cari lettori, questa è la stampa
“monnezza”. Ecco perchè l’informazione a Taranto muore lentamente di giorno in
giorno. E prima del sottoscritto lo ha detto pubblicamente un certo Marco
Travaglio ….in occasione dell’ultimo concerto del 1 maggio. E nessuno ha fiatato
e protestato.
Il giornalista Luigi
Abbate ha perso la causa contro BluStar TV.
Scrive “Il Corriere del Giorno” il 27 giugno 2017. “Le sentenze non si
commentano, si rispettano” dice una vecchia massima. Ma ora chi gli pagherà le
“spese di giustizia compensate”? I partiti che lo corteggiavano mesi fa cosa
diranno adesso? E Travaglio? “Il licenziamento del giornalista Luigi Abbate, è
soltanto l’ultimo atto illegittimo adottato dall’editore dell’emittente
televisiva tarantinaBlustar‘‘. Così tuonava esattamente un anno fa Raffaele
Lorusso presidente dell’Assostampa, il sindacato dei giornalisti pugliesi,
recentemente “promosso” alla guida della FNSI, parlando del giornalista di
Taranto divenuto famoso non per le sue inchieste, ma solo per una domanda
scomoda, e il microfono che gli venne allontanato in una conferenza stampa
da Girolamo Archinà, responsabile delle relazioni istituzionali dell’Ilva,
mentre il giornalista cercava di intervistare lo scomparso presidente Emilio
Riva. Lorusso non contento dichiarò anche: “Già un anno fa, nell’assordante
silenzio delle istituzioni e delle forze politiche di Taranto, Blustar
Tv licenziò quattro giornalisti adducendo quale motivazione il venir meno dei
centomila euro annualmente garantiti dall’Ilva”. Ma nessuno si chiese come mai
le domande “scomode” Luigi Abbate non le faceva quando la sua emittente
televisiva ospitava (come le altre tv locali) la pubblicità dell’Ilva? Dov’era
finita l’indipendenza, la professionalità? Per il Tribunale del Lavoro di
Taranto invece non è andata esattamente come Abbate ed i sindacalisti
raccontavano (e non è la prima volta…!). Il Corriere del Giorno è in grado di
pubblicare la sentenza, facendo parlare i documenti, di cui stranamente
l’Assostampa pugliese ed il suo rappresentante tarantino Mimmo Mazza non
parlano. Nessun comunicato. Nessun commento dell’Assostampa pugliese. I
giornalisti-sindacalisti, è ben noto cercano solo le telecamere per
manifestazioni e convegni dove sentirsi “vivi” e farsi conoscere. Avete mai
visto un “vero” giornalista fare carriera grazie al sindacato? Noi non lo
ricordiamo. Bene che gli vada, i giornalisti-sindacalisti notoriamente vanno a
sedersi sulle poltrone lautamente profumate dell’INPGI (l’ente previdenziale dei
giornalisti) o della CASAGIT (la cassa di assistenza dei giornalisti). E poi
vediamo come succede. Leggete da soli. Ecco la sentenza, che non commentiamo. Ma
ricordiamo a quei politici che si stracciavano le vesti di dosso, che
corteggiavano Abbate, che accusavano l’on. Michele Pelillo di aver contribuito
al licenziamento, che adesso dovrebbero avere il coraggio e la dignità di
chiedere scusa per le accuse infondate, e se accettano un consiglio, tacere.
Farebbero miglior figura! La sentenza parla di licenziamento legittimo per
esubero del personale. Decreto rigetto n. cronol. 20195/2015 24 giugno 2015.
Procedimento n. 448/2015 RG Tribunale di Taranto Giudice del Lavoro.
Ilva Taranto, nel cuore dell'acciaio
italiano. "Vogliamo ripartire senza uccidere più". Il
mega stabilimento si trova di fronte al dilemma tra lavoro e difesa
dell'ambiente, scrive Marco Patucchi il 19 dicembre 2016 su "La Repubblica". La
stella cometa in cima ai cento metri dell'Altoforno 5 è spenta. Il gigante è
fermo da due anni. Dorme. "Mi piange il cuore a vederlo così... meglio andare a
guardare i tre altoforni più piccoli, quelli che sono in funzione". Benedetto
Valli, che lavora qui da quindici anni ed è responsabile di un laminatoio, non
nasconde rabbia e orgoglio mentre indica lo skyline sterminato dello
stabilimento Ilva di Taranto. Quell'orgoglio che da qualche anno bisogna
dissimulare girando in città, fuori dalla fabbrica. Perché oggi lavorare
all'Ilva è come appartenere ad un'altra patria, un'enclave abitata da undicimila
lavoratori. Cinquanta chilometri di strade, duecento di ferrovie e di nastri
trasportatori, un porto, un'intera flotta di navi: quindici chilometri quadrati
di territorio che, un tempo, erano cuore e anima della città. Ora vergogna e
maledizione. "I compagni di scuola ai nostri figli ogni tanto chiedono se è vero
che i loro papà uccidono i bambini...", ci racconta un operaio davanti alla
mensa. E chissà se è solo una battuta amara la sua o se, davvero, si è arrivati
a questo punto. Certo, le colonne di fumo che, improvvise, si impennano
altissime nel cielo qualcosa significheranno. Come le barriere di tela, color
vela antica, che separano lo stabilimento e le sua polveri dal quartiere
Tamburi. Segnano un confine che ormai è frontiera tra due eserciti in guerra. Di
qua le migliaia di caschi gialli, bianchi o blu, di là una città tradita da
quella che per decenni, a partire dagli anni Sessanta dell'Italsider e del
gigantismo delle partecipazioni statali, passando poi attraverso la stagione
privata della famiglia Riva che ha lacerato l'osmosi con il territorio, era
stata la sfida, il sogno di un riscatto sociale ed economico. Ed anche l'anima
dell'intera manifattura italiana, perché non c'è oggetto, utensile, automobile,
macchinario, aeroplano prodotto nel nostro Paese, che non sia nato da qui. Dove
"entra pietra e esce acciaio", come ci dice uno degli addetti della sala di
controllo dell'Altoforno 4. Siderurgia paradigma della grande industria,
dimenticata nell'era del capitalismo immateriale. Ma sempre viva e
insostituibile, pur con le sue emergenze e arretratezze. Statistiche drammatiche
sui tassi di mortalità da inquinamento, inchieste giudiziarie, arresti,
sequestri degli impianti, referendum, lotte politiche e sindacali, esuberi,
morti sul lavoro. Un'intera comunità disgregata. "Negli anni passati gli errori
sono stati fatti, è inutile negarlo. Le norme europee esistevano dal 2005, ma
fino al 2011 si è provveduto poco - prova a spiegare Antonio Bufalini, direttore
operativo dello stabilimento di Taranto e dell'intero gruppo Ilva, oggi in
amministrazione straordinaria - Però finalmente stiamo recuperando sia sul
fronte produttivo che nella riduzione dell'impatto ambientale. Lo dimostrano i
dati e i dissequestri degli impianti decisi dalla magistratura". I manager ti
snocciolano tutti gli interventi di bonifica - dai filtri per l'emissione dei
fumi alla discarica che gli operai hanno soprannominato, fieri, "il Colosseo" -
rivendicando i risultati raggiunti senza interrompere la produzione che oggi
viaggia intorno ai 6 milioni di tonnellate annue. Solo la metà di quanto
sfornava l'Ilva dell'epoca d'oro, comunque un accenno di ripresa. Ecco, la
scommessa che potrà salvare il cuore dell'acciaio italiano è tutta nel
raggiungimento di un equilibrio perfetto tra livelli produttivi, impatto
ambientale e perimetro occupazionale. Un miracolo, forse, considerando che il
grosso delle bonifiche è ancora solo scritto sulla carta dell'Autorizzazione
integrata ambientale: il rifacimento dell'Altoforno 5, la copertura dei parchi
minerari e gli interventi sulle cokerie. Basta aggirarsi tra quei cumuli alti
quindici metri di carbone, minerale di ferro, loppa e agglomerato, un paesaggio
lunare a tinte nere, rosse e grigie, per intuire le dimensioni del progetto di
copertura contro la dispersione delle polveri: un'arcata di almeno ottanta metri
che fino ad oggi non è stata costruita in nessuna acciaieria al mondo (almeno
così assicura il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, che si è preso la
briga di andarle a controllare tutte attraverso Google Maps). La costruzione
toccherà ad una delle due cordate in corsa per rilevare l'Ilva - una guidata
dalla Arvedi e dagli indiani della Jindal (con Cdp e Del Vecchio), l'altra
targata ArcelorMittal e Marcegaglia - Chiunque vinca, avrà a disposizione per le
misure ambientali oltre un miliardo di euro, eredità della gestione Riva
sbloccata dalla magistratura. Chissà se saranno sufficienti. "Ma bisogna fare
presto - dice Giuseppe Romano, segretario della Fiom di Taranto - la carenza di
risorse finanziarie sta ricreando problemi di sicurezza sul lavoro per operai
già esposti al doppio fronte dei rischi ambientali: all'interno quando sono al
lavoro, e all'esterno quando vivono in città. Insomma, il drammatico dilemma tra
morire di fame o di malattia... Perché è evidente che se anche con il nuovo
padrone il livello di produzione sarà l'attuale, allora ci saranno migliaia di
esuberi". La domanda di acciaio italiano dopo un 2015 di crisi, nel 2016 ha
mostrato segnali di timida ripresa sostenuta dagli ordinativi del settore auto
e, naturalmente, questa è una buona notizia soprattutto per l'Ilva. C'è da
combattere la concorrenza dell'acciaio cinese e indiano, però girando nelle
strade infinite dello stabilimento tarantino, tra impianti e automezzi che
ricordano Star Wars (le colate degli altoforni, i "carri siluro" che trasportano
ghisa, le bramme incandescenti, la mastodontica nave Gemma, 300mila tonnellate e
45 uomini d'equipaggio, che ogni due mesi va e viene dal Brasile carica di
minerali, le banchine del porto, i coils argentati in partenza per mezzo mondo)
l'impressione è che il gigante possa ancora farcela. Ma le autobotti che
cospargono continuamente di acqua l'asfalto sconnesso per abbattere le polveri,
così come le decine di cartelli gialli che segnalano le emergenze ambientali,
sono lì a misurare l'enormità di una scommessa esiziale. Un monito a chi pensa
che la questione sanitaria sia soltanto strumentalizzazione politica. "La
siderurgia si può fare senza uccidere la gente", dice ancora Giuseppe Romano. La
grande scommessa, appunto. Sembrano crederci davvero gli operai che davanti al
mare grigio di un pomeriggio invernale, seguono le operazioni di scarico dei
minerali dalla stiva di una nave cinese. Stasera, tornati a casa nel quartiere
Tamburi o nella borgata Paolo VI, si chiederanno per l'ennesima volta se tutto
questo ha ancora un senso, se è ancora giusto.
"Taranto non è più inquinata di Roma", il
ministero della Salute smorza l'allarme sull'Ilva.
Indagine presentata a Roma: i risultati dei test confermano la presenza di
sostanze con potenziale pro-infiammatorio ma non evidenziano una specificità per
la città pugliese dove si registra un picco di tumori, scrive "La Repubblica" il
7 dicembre 2016. L'aria di Taranto è inquinata quanto quella di Roma, sia dal
punto di vista della quantità di polveri sottili che della loro composizione e
dell'effetto sulla salute. Lo afferma uno studio dell'istituto Superiore di
Sanità e dell'Arpa pugliese pubblicato sul sito dell'Istituto. Lo studio è stato
effettuato monitorando la qualità dell'aria in due punti della città, Statte e
via Machiavelli, e confrontando i valori con quelli di una centralina di Roma e
una in una zona rurale. Allo stesso tempo è stato analizzato un gruppo di mamme,
per verificare una eventuale correlazione dell'inquinamento con l'endometriosi,
e uno di bambini alla ricerca di eventuali problemi di sviluppo e neurologici. I
dati del ministero della Salute smorzano l'allarme lanciato dopo il dossier
sull'aumento dei tumori nell'area del siderurgico. Tutti i test, hanno concluso
gli esperti, hanno dato risultati simili tra Taranto e Roma. "Questo è uno
studio importante basato non su indagini statistiche ma su dati sperimentali,
ottenuti su una matrice biologica - afferma Walter Ricciardi, presidente
dell'Iss -, e dimostra che negli ultimi due anni, quelli che abbiamo preso in
considerazione, l'esposizione all'inquinamento non è diversa da quella di una
qualsiasi grande città fortemente urbanizzata". Nello studio di biomonitoraggio
e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto condotto
dall'Istituto superiore della Sanità si rileva che "è comunque opportuno
sottolineare che i risultati ottenuti nel corso di questa indagine, e le
relative implicazioni sui livelli di contaminazione atmosferica nei siti
studiati, sono specificamente riferibili ai periodi in cui sono stati effettuati
i campionamenti, e possono non essere rappresentativi per periodi precedenti, in
cui varie attività antropiche possono avere avuto un impatto diverso".
"Considerando i limiti intriseci dello studio in vitro, la bassa numerosità
campionaria analizzata e il limite temporale dei rilevamenti ambientali, i
risultati dello studio - viene sottolineato - non possono ritenersi conclusivi e
sono solo rappresentativi dei periodi in cui sono stati effettuati i
campionamenti". Con riferimento all'impatto degli inquinanti ambientali sulla
salute riproduttiva femminile, le concentrazioni di PCDD, PCDF (diossine) e PCB
nel siero - è scritto nello studio - "sono in linea con i valori osservati in un
recente studio su gruppi di donne della popolazione generale italiana con
caratteristiche confrontabili a quelle del presente studio".
Ilva, i dati su malattie e
inquinamento «Taranto non supera Roma». Il confronto
fatto tra le aree più esposte all'Ilva di Taranto e altri contesti con aree non
impattate dalle emissioni del siderurgico, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”
il 7 dicembre 2016. «Gli inquinanti genotossici aerodispersi analizzati»
presentano per Taranto «un carico non superiore a quello di Roma, almeno
relativamente alle aree coperte dalle stazioni di campionamento». E’ il punto
fermo dello studio (238 pagine) presentato a Roma dal ministero della Salute e
dall’Istituto superiore di sanità in collaborazione con l’Asl di Taranto, l’Arpa
Puglia, l’Ares Puglia, la Regione Emilia Romagna e l’Azienda provinciale per i
servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Scopo del progetto,
strutturato con quattro obiettivi, la «valutazione dell’esposizione di gruppi di
popolazione residente in aree della città di Taranto prossime allo stabilimento
Ilva a confronto con aree non impattate dalle emissioni dell’Ilva stessa».
Questo per valutare il «possibile impatto sulla salute riproduttiva femminile e
su funzioni cognitive in popolazioni pediatrice in considerazione della
molteplicità di inquinanti rilevati a Taranto». Il campionamento ha riguardato
da un lato 60-80 donne con diagnosi certa di endometriosi e altre 60-80 che si
sono sottoposte a laparoscopia per altri motivi sanitari e 299 bambini, in età
scolare, dai 6 agli 11 anni, «suddivisi equamente fra maschi e femmine e
residenti in aree a distanza incrementale dalla zona di emissione industriale,
con la zona Tamburi, più vicina alle sorgente emissive, Statte-Paolo-VI-Taranto,
e l’area di Talsano più lontana». Fatta poi una comparazione tra Taranto e Roma
attraverso quattro siti di indagine: Roma, viale Regina Elena; Viterbo, area
rurale; Taranto, via Machiavelli nel rione Tamburi a Taranto; Statte. Il comune
di Statte e i Tamburi sono in prossimità dello stabilimento Ilva. Per quanto
riguarda l’esposizione a metalli con proprietà neurotossiche in fluidi e tessuti
di soggetti in età evolutiva (6-11 anni), lo studio dell’Iss di biomonitoraggio
e tossicità degli inquinanti presenti a Taranto "ha permesso di rilevare una
situazione di potenziale presenza di disturbi clinici e preclinici del
neurosviluppo nell’area di Taranto, non riconosciuti e non adeguatamente
sottoposti ad interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi». «Il 15% di
potenziali diagnosi cliniche osservato nel campione esaminato, basato per
definizione su soggetti supposti sani, indica l’opportunità di ulteriori
approfondimenti diagnostici ed epidemiologici. Si tratta comunque - conclude lo
studio - di un risultato in linea con i dati epidemiologici mondiali sulle
patologie del neurosviluppo comprendenti autismo, ADHD, disturbi
dell’apprendimento e del comportamento, che interessano il 10-15% delle nascite.
I disturbi osservati sono maggiormente evidenti nelle aree in prossimità delle
emissioni industriali considerate ed in funzione inversa rispetto alla distanza
dalle sorgenti, calcolata in riferimento ai camini di emissione dell’ILVA, nelle
cui adiacenze insistono anche una raffineria ed un cementificio». «In
collaborazione con la Asl di Taranto si è dimostrato che i metalli pesanti
inducono un ritardo dello sviluppo mentale dei bambini di Taranto e questo è un
fatto gravissimo. E’ una notizia di una gravità senza precedenti. Ovviamente lo
studio registra, anche in corrispondenza con quanto accertato dai magistrati e
dalla Regione Puglia in collaborazione con la Regione Lazio, che quando la
fabbrica abbassa i livelli di produzione, come è stato nel 2015 e nel 2016, i
dati sull'inquinamento sono ovviamente inesistenti o molto bassi». Lo afferma il
presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha partecipato al
convegno dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma su «Studi di biomonitoraggio e
tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto». «Si tratta
dunque di uno studio molto importante e molto interessante - spiega Emiliano -
che conferma tutta la nostra preoccupazione su quello che sta succedendo in
città. Ribadiamo la nostra richiesta che la sanità tarantina venga
particolarmente sostenuta con un intervento speciale di natura economica, ma
anche normativa, che ci consenta di fronteggiare con maggiori disponibilità di
forze una mitragliatrice che spara sulla folla. Ecco, questo è stata l’Ilva in
questi anni». «Siamo particolarmente indignati da quanto è accaduto - ha
continuato Emiliano - perché i 50 milioni destinati al rafforzamento della
sanità tarantina si sarebbero potuti ripristinare nel corso dell’esame al
Senato, così come affermato da Renzi e De Vincenti, se non fosse stata messa la
fiducia poche ore fa e quindi quell'emendamento che avevano promesso non è più
possibile».
Lo sciame populista che pervade Taranto.
Intervista ad Angelo Mellone: scrittore e dirigente
Rai. "I dati elaborati dall'Istituto Superiore della Sanità, assieme ad Arpa
Puglia e Asl, non sono catastrofici. Nel capoluogo jonico non esistono agenti
patogeni e livelli d'inquinamento diversi da quelli riscontrati a Roma. E' ora
di farla finita con gli ambientalqualunquisti e i capipopolo decarbonizzati:
esegeti della demogogia della paura", scrive Vincenzo Carriero l'11 dicembre
2016 su "Cosmopolismedia"
Diretto. Adrenalinico. Circostanziato. Angelo
Mellone ama la sintesi argomentativa e non si ritrae dinanzi ai pensieri
“scomodi”. Più che le mode, è persuaso dal principio di realtà. Dalla ricerca
non adulterata – e stereotipata - della verità. “Cosa dicono gli
ambientalqualunquisti di Taranto dopo il rapporto redatto dall’Istituto
Superiore della Sanità? Non si appaga il proprio ego, non si sceglie di far
carriera aprendo le porte di casa al vento gelido della paura…”.
La vicenda ambientale di Taranto, le sue aporie
socio-produttive, presentano un livello di originalità non derubricabile nelle
categorie, semplicistiche e un po’ farlocche, dei blocchi contrapposti. Le
logiche manichee confliggono con una corretta interpretazione della complessità,
non crede?
“Non vi è dubbio! L’indagine dell’Istituto
Superiore della Sanità, condotta assieme ad Arpa Puglia e Asl di Taranto, offre
però spunti interessanti. Nel capoluogo jonico non esistono agenti patogeni,
livelli d’inquinamento diversi da quelli, per esempio, riscontrati a Roma. Nei
giorni scorsi, poi, l’Università ‘La Sapienza’ ha stilato una classifica sul
numero di patologie tumorali riferibile ai capoluoghi di provincia italiani.
Taranto si piazza in una posizione intermedia e risulta essere messa meglio di
tante altre realtà del Paese. Sulla scorta di questi dati elaborati da
istituzione dalla comprovata professionalità e serietà scientifica, e non da
fantomatiche associazioni localistiche che giocano a fare i medici e gli
epidemiologi della domenica, chiedo agli ultras 2.0, agli agit-prop del
disfattismo piagnone e antisviluppista di ripulire il proprio lessico da termini
come genocidio ed olocausto…”.
L’indagine condotta dall’Istituto Superiore
della Sanità fa riferimento soltanto agli ultimi due anni e, nel biennio
2013-15, la produzione Ilva si è assottigliata parecchio non raggiungendo gli
standard del passato.
“E’ vero, ma siamo comunque in presenza di dati
incoraggianti, che lasciano ben sperare per il futuro. E’ indubbio che la
vecchia Italsider, con gli impianti a pieno regime negli anni ’70 e ’80, abbia
inquinato in maniera oscena questo territorio. Oggi, però, le cose sono
cambiate. Una fabbrica adeguatamente messa a norma, ecocompatibile, può
continuare a produrre. Le lobby degli imprenditori siderurgici del Nord Europa
fanno un gran tifo perché l’Ilva chiuda. Ragionano, seppur mossi da interessi
diversi, come molti esponenti dell’ambientalqualunquismo tarantino”.
Con le sue tesi non teme di passare per un
negazionista?
“I negazionisti negano, per l’appunto, un dato
acclarato; obnubilano la realtà. Io mi limito, invece, a rappresentare i fatti
per quello che sono, senza indulgere nel populismo della paura. C’è la verità,
faticosa da raggiungere, impopolare, molto spesso poco appariscente, e poi ci
sono le campagne elettorali compiute dai non tarantini sulla pelle dei
tarantini. Detesto queste modalità politiciste, sostanzialmente ipocrite nel
ricercare il consenso, così come detesto i capipopolo decarbonizzati in grande
rispolvero negli ultimi tempi”.
Capipopolo decarbonizzati alla Michele
Emiliano?
“Questo lo dice lei (ride, ndr). Vorrei però
tornare sull’ambientalqualunquismo tarantino”.
Prego.
“Si tratta di un mostro con tre teste. La prima di
queste è rappresentata da gran parte del giornalismo locale, dalla ricerca
ossessiva di visibilità di quelli che io chiamo fotocopie di giornalisti.
Barattano la veridicità della notizia con la paura da distillare presso
l’opinione politica per mero calcolo personale. Poi ci sono gli imprenditori
politici del terrore, coloro che pur di conquistare un minimo spazio di consenso
si producono in campagne elettorali estenuanti, infinite, sulla pelle dei
tarantini. Infine c’è lo sciame populista di chi vive perennemente sui social:
un paio di migliaia in tutto. Onniscienti di non si sa che, disfattisti e truci
estensori di un avvenire senza futuro”.
Buona parte della stampa tarantina è la stessa
che prendeva ordini da Archinà su quello che poteva essere scritto e ciò che,
invece, andava debitamente insabbiato. Questa è la città che, con l’Ilva al
massimo della sua influenza politica ed economica, ha registrato un numero di
testate giornalistiche spropositato rispetto alla media giornaliera di lettori.
“E’ vero, tutto ha avuto inizio da lì. Tutto si
tiene assieme con fare compiuto, senza alcuna soluzione di continuità.
D’altronde cosa si vuole pretendere da chi ha campato per anni sui dispacci
passati dalla Procura. Una cosa è fare il giornalista, altro è prendere le mance
da addetto stampa”.
Le bonifiche, converrà, non investono il solo
dato ambientale. Attengono anche ad un dibattito pubblico sfilacciato,
deprimente, sprovvisto di passione e grandi idee-guida.
“Aggiungerei a tutto questo il fatto che Taranto è
una città senza memoria. Smemorata. Va difeso l’onore della nostra storia
industriale, vanno rispettate le tante morti bianche consumatesi in fabbrica.
Com’è possibile che il nostro lungomare non venga dedicato ad un eroe
dell’acciaio? Come si possono riannodare i fili di un’identità smarrita senza
indicare un solo monumento cittadino alle vite andate perdute nel siderurgico?
Di tutto questo gli ambientalqualunquisti non parlano, però…”.
Nell’offerta sanitaria complessivamente
presente nel tarantino, non figurano la Pediatria oncologica e la Chirurgia
toracica. Non si riesce neanche ad acquistare il terzo Acceleratore lineare per
la cura dei tumori solidi. Tutto questo non le sembra quantomeno paradossale?
“Taranto merita una sanità improntata ai livelli
dell’eccellenza. Nei mesi scorsi accettai l’invito di CosmoPolis e firmai una
petizione online perché venisse istituito il reparto di Pediatria oncologica.
Sono assolutamente a favore d’iniziative come questa. Concrete e fattive, mosse
da un autentico amore per questa terra e non da strumentalità politiche o,
peggio, professionali e accompagnate da un carrierismo indecente”.
Il nuovo presidente austriaco è
un’ambientalista. Il partito dei Verdi è forza di tutto rispetto, elettoralmente
considerevole, in Germania e Francia. Perché in Italia una realtà autenticamente
ecologista non riesce ad affermarsi in maniera compiuta?
“L’ambientalismo italiano coltiva nella radice del
suo stesso nome il problema: il suffisso ‘ismo’ agganciato al resto della
parola. Troppo ideologizzato, da sempre una costola del centrosinistra, i
Verdi non sono stati mai in grado di dotarsi di una piattaforma politica
inclusiva e partecipata. Sembrano confinati in una sorta di limbo indefinito,
dove la pratica più ricercata è il solipsismo culturale. Tutto questo
rappresenta un limite per la risoluzione di alcune urgenze di cui soffre il
Paese. Lo dico da ambientalista convinto: la democrazia italiana trarrebbe
vantaggio dalla presenza sulla scena politica di una forza ecologista moderna e
non settaria”.
Ennesima sconfitta della Procura di
Taranto sulla vicenda ILVA. Il magistrato Nicastro assolto definitivamente,
scrive “Il Corriere del Giorno” l’8 settembre 2016. In occasione delle sue
dichiarazioni spontanee dinnanzi al tribunale di Taranto, Nicastro si girò e
rivolgendo l’indice puntato nei confronti del banco dell’accusa rappresentata
dai magistrati della Procura di Taranto disse loro “con voi ci vedremo in
un’altra sede”. Era il 23 luglio del 2015 quando il magistrato Lorenzo
Nicastro ex assessore all’Ambiente della Regione Puglia (Giunta Vendola), non
trattenne le lacrime alla lettura della sentenza di assoluzione. “Ho difficoltà
a tenere disgiunta la vicenda personale che non interessa a nessuno e riguarda
me e la mia famiglia – disse Nicastro – E’ una sentenza di primo grado, ma mi
restituisce una dignità e una serenità che mi è stata tolta per un anno e
mezzo”. Parole sentite, sofferte quelle di Nicastro, quando venne assolto dal
gup di Taranto Vilma Gilli dall’accusa di favoreggiamento nei confronti del
presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, nell’ambito dell’inchiesta sul
disastro ambientale dell’Ilva. In quell’occasione nel giudizio abbreviato, i
pubblici ministeri avevano chiesto ma non ottenuto la sua condanna a 10 anni.
“Ho aspettato – ha spiegato Nicastro – questo dispositivo del giudizio
abbreviato, quattro mesi e più e insieme a me lo hanno aspettato persone che
erano sicuramente innocenti, anche prima di questa sentenza, e sono i miei
familiari e mia madre”. In occasione delle sue dichiarazioni spontanee dinnanzi
al tribunale di Taranto, Nicastro si girò e rivolgendo l’indice puntato nei
confronti del banco dell’accusa rappresentata dai magistrati della Procura di
Taranto disse loro “con voi ci vedremo in un’altra sede”. La giustizia ha fatto
il suo corso e proprio ieri il dr. Nicastro è stato definitivamente ritenuto
innocente anche dalla Suprema Corte di Cassazione, come lo stesso magistrato,
ora in servizio presso la Procura della repubblica di Matera, ha reso noto sulla
sua pagina Facebook: “Oggi è diventata definitiva la mia sentenza di assoluzione
nel processo ILVA. Si è chiusa una piccola storia che piccolissimi uomini
avevano costruito con la medesima approssimazione progettuale con la quale un
circolo dopolavoristico organizza tornei di calcetto. Meglio, di tennis”. Le
accuse “pubbliche” rivolte da Nicastro ai magistrati di Taranto sono a dir poco
pesanti. Così continua nel suo post: “Da oggi i nanetti ammantati di nero e
fregiati di oro e argento, cercheranno un’altra Biancaneve alla quale far
credere di essere giganti. Grazie ai miei avvocati Michele Laforgia e Giovanni
Orfino, lucidi, sereni e strepitosi. Ma grazie ai tantissimi avvocati dai quali
mi sono sentito adottato in questi tre anni. Non li ricordo tutti ma grazie a
tutti, grazie ad Emanuela Sborgia, Beppe Modesti, Francesco Marzullo, Luigi
Covella, Alessandro Amato, Vittorio Triggiani, insomma grazie a tantissimi”.
A Taranto esistono però dei giudici “seri”. Chiaramente i giornalisti che si
vantano di scrivere (o fotocopiare?) di cronaca giudiziaria dei quotidiani
locali di Taranto, sono molto bravi a raccontare dei rinvii a giudizio, o delle
sentenze di condanna che tanto fanno piacere alla Procura della Repubblica. Un
pò più allergici, e quindi lontani dalla verità, quando invece la giustizia
trionfa e gli imputati vengono assolti a darne notizia come in questo caso. Ma
ci pensiamo noi a restituire l’onore e la dignità “pubblica” al dr. Nicastro, a
cui più di qualcuno a Taranto dovrebbe chiedere scusa. Ma per farlo bisogna
avere gli “attributi”. Come abbiamo già scritto in passato, per fortuna anche a
Taranto esistono dei giudici “seri”, come la gip dr.ssa Gilli che assolse il
dr. Nicastro, che non si fanno condizionare dai pubblici ministeri, e le cui
decisioni molto spesso vengono confermate dalla Cassazione. Questa si chiama
“giustizia”. Questo è rispetto per la toga che indossano i giudici. La domanda
che molti si fanno in queste ore è: ma l’altra sede è solo la Cassazione, o come
qualcuno mormora, dinnanzi al Csm? Fonti bene informate sui movimenti negli
uffici giudiziari sostiene che “qualcuno” che aspira a diventare il procuratore
capo di Matera, potrebbe trovare sul suo cammino un altro “impedimento”. Uno dei
tanti. Per averne conferma bastano circa 100 giorni. Che saranno molto lunghi
per “qualcuno”. Alla fine, come si suol dire, è proprio vero: tutte le strade
portano a Roma…
ILVA, PARLA LA VEDOVA DI EMILIO RIVA: MIO
MARITO CONDANNATO SENZA PROCESSO. Giovanna Riva du
Lac si rivolge a Fino a prova contraria il 29 giugno 2016. Dopo aver dato alle
stampe "Emilio Riva, l’ultimo uomo d’acciaio" (Mondadori, pp. 177, 2015), la
vedova ripercorre l’odissea giudiziaria che ha travolto il colosso siderurgico e
la vita dell’uomo al quale è stata legata per oltre quarant’anni. «Credo che non
sia più il momento di tacere. Io ho assistito a una violenza di stato senza
eguali. Mio marito, Emilio Riva, ha subito lo choc di un arresto a 88 anni, è
stato privato dei suoi beni, accusato e mai sentito dai suoi accusatori,
vilipeso da una stampa fanatizzata, descritto come un mostro. E’ morto solo, e
senza giustizia. Perché tutte le misure che hanno travolto la sua vita privata e
pubblica sono state adottate in via "preventiva", senza neppure uno straccio di
condanna di primo grado. Come li chiamate questi se non omicidi legalizzati?
Nulla e nessuno potranno restituirmi mio marito, ma io sento il dovere di
restituire alla memoria collettiva il ricordo autentico di Emilio, un uomo
partito come venditore di rottami di ferro nel dopoguerra e poi diventato il
quarto produttore di acciaio europeo. Lui diffidava dei giornalisti, sua nonna
gli aveva insegnato questo: "stai alla larga da giornalisti, preti e avvocati. I
primi scrivono quello che vogliono, i preti arrivano quando stai per morire e
gli avvocati vogliono solo i tuoi soldi". Seppure a malincuore, io devo parlare,
devo far conoscere la sua storia, quella vera. Nella vicenda Ilva non c’è nulla
di ovvio, solo un mare di violenza che adesso tiene sotto schiaffo il figlio di
Emilio, Fabio Riva, che si è ammalato a seguito di questa vicenda. Spero che non
faranno con lui quello che hanno fatto con mio marito. Spero che gli daranno la
possibilità concreta di difendersi. Spero che lo risparmieranno, se esiste
ancora una parvenza di giustizia in Italia».
Sulla vicenda ripubblichiamo questo pezzo, uscito
all’indomani della morte di Emilio Riva. E’ il ricordo di Stefano Lorenzetto su
una vicenda che al di là dei giudizi di colpevolezza o innocenza mette in
evidenza un fatto inequivocabile: un uomo ha subito una condanna preventiva,
giudiziaria e mediatica, in assenza di un processo.
Così i veleni dei tribunali hanno ucciso Riva di
Stefano Lorenzetto per Il Giornale. Di Emilio Riva, morto nella notte di ieri in
una clinica che da un paio di mesi poteva somministrargli solo cure palliative,
si dirà che era giunta la sua ora: il 22 giugno avrebbe compiuto 88 anni. In
realtà il magnate dell’acciaio era morto il 26 luglio 2012, quando un’ordinanza
del giudice per le indagini preliminari di Taranto lo aveva confinato agli
arresti domiciliari nella sua villa di Malnate (Varese). A parte due ricoveri di
pochi giorni nel centro cardiologico Monzino di Milano, resi urgenti dal cuore
malandato, poté uscirne solo dopo un anno, per scadenza dei termini di custodia
cautelare. Ma non da uomo libero: lo stesso Gip gli impose l’obbligo di dimora.
Il suo male incurabile è stato il sequestro dell’Ilva di Taranto, che Riva aveva
salvato dal fallimento e trasformato nella più importante acciaieria del
continente, sostituendosi allo Stato in seguito alla liquidazione
dell’Italsider. Il tumore osseo che ha consumato l’imprenditore milanese si era
manifestato all’avvio dell’inchiesta per disastro ambientale dalla quale sarebbe
uscito senza condanne epperò cadavere. La caduta delle difese immunitarie
sopravviene quando il dolore diventa troppo pesante per essere sopportato anche
da chi abbia spalle larghe come le sue. Sono gli effetti della privazione di ciò
che per un essere umano conta di più: la libertà personale. Poiché si deve
presumere che nella vicenda giudiziaria di Riva tutto si sia svolto secondo i
crismi di legge, e tenuto conto del fatto che l’ultimo scorcio della sua vita è
stato dominato per intero dai magistrati, si può ben concludere che egli sia
morto per un eccesso di giustizia. Un po’ come accadde ad Alessandro Magno, del
quale fu detto che perì grazie all’aiuto di troppi medici. Il paragone storico
non sembri inappropriato. Al di là dell’infame vulgata che ha tramutato l’ex
rottamaio in un assassino d’inermi cittadini per sete di guadagno, l’ex
«ragiunatt» con laurea ad honorem in ingegneria meccanica era davvero l’ultimo
condottiero della siderurgia italiana. Il più grande: 38 stabilimenti nel mondo,
30.000 dipendenti, 10 miliardi di euro di fatturato. Facendo onore al proprio
carattere, forgiato con lo stesso materiale che gli diede fama, ricchezza e
tormento, ha resistito qualche mese più dei colleghi Luigi Lucchini e Steno
Marcegaglia, usciti di scena tra effluvi d’incenso. L’anno scorso, ormai
prigioniero da dieci mesi in casa propria, Riva si rese conto che niente avrebbe
più potuto riportare in parità la bilancia della giustizia e restituirgli
l’onore perduto. Non i suoi avvocati, pur abilissimi. Non i giornali, abituati a
trattarlo con la simpatia che circondava i monatti di manzoniana memoria. Né
tantomeno, figurarsi, le toghe. Poiché avvertiva che il suo tempo stava per
compiersi, penò a un j’accuse zeppo di fatti e di dati, che potesse riabilitarlo
nella memoria degli eredi. Un libro. Si ricordò allora di un giornalista che lo
aveva intervistato 11 anni prima sul Giornale. Il 21 maggio volle che
incontrassi la moglie, Giuliana Du Lac Capet, nella sua casa milanese di via
Verri. Allenata dal consorte ad andare subito al nocciolo delle questioni, la
signora mi chiese: «È impegnato domenica prossima? La accompagnerei a Malnate da
mio marito, così potrebbe cominciare subito a raccogliere la sua verità. Non c’è
tempo da perdere». Fui costretto a obiettarle che, avvicinando un estraneo senza
l’autorizzazione del magistrato, egli si sarebbe reso responsabile di evasione.
Non solo: io avrei potuto essere inquisito per concorso nel medesimo reato. Si
trattava di un rischio che ero disposto a correre. Ma il suo legale temeva che
Riva finisse ristretto a San Vittore. L’anziano recluso dovette perciò
accantonare il progetto editoriale a lungo accarezzato e che aveva già trovato
un editore. Anche l’ultima possibilità di autodifesa gli veniva negata. Dunque è
così che è morto Riva: senza voce. Sarebbe stato invece interessante, oltreché
giusto, fargli commentare il rapporto di Legambiente, nemica giurata dell’Ilva,
dal quale nel 2012, in piena bufera giudiziaria, risultava che, su 55 capoluoghi
di provincia presi in esame, Taranto figurava al 46˚ posto nella classifica
nazionale dell’inquinamento da polveri sottili, preceduta da Torino, Milano,
Verona, Alessandria, Monza e altre 40 città. Oppure farlo parlare di quel
procuratore capo della Repubblica di Taranto che aveva scritto con largo
anticipo come sarebbe andata a finire questa brutta storia: «Con la vittoria del
bene sul male». Dove il bene erano i giudici e il male Riva. Una sentenza
contenuta nella prefazione di un libro per bambini, nel quale si raccontava che
nella città pugliese, per colpa dell’Ilva, «il cielo era sempre scuro e la gente
si ammalava», ma poi arrivava un dio che tuonava: «Adesso basta!». E giurava:
«Col mio soffio spegnerò le ciminiere, porterò via i fumi e manderò a casa gli
uomini d’acciaio!». Promessa mantenuta: prima a casa e da lì direttamente al
cimitero. A Emilio Riva non hanno portato bene né l’avversione per il comunismo,
che tuttavia non gl’impedì di acquisire e far ripartire due cadenti acciaierie
dell’ex Ddr dove al suo arrivo trovò un presidio di militari dell’Armata rossa,
né il munifico obolo di San Pietro che per anni, in gran segreto, versò
direttamente nelle mani di Papa Wojtyla per consentirgli di pagarsi i suoi
viaggi apostolici nei cinque continenti. Chissà che il custode delle chiavi
decussate non gli abbia adesso dischiuso, dopo tanta prigionia domestica, almeno
le porte di quel paradiso nel quale ha sempre sperato. Un risarcimento postumo
che l’industriale siderurgico non poteva aspettarsi dalla giustizia umana, ma
solo da un santo fresco di canonizzazione.
Tutta la verità e le intercettazioni sui
giornalisti a “libro paga” dell’ILVA. Scrive “Il
Corriere del Giorno” il 4 ottobre 2014. E nel
frattempo da 2 anni l’inchiesta interna all’ Ordine dei Giornalisti di Puglia,
sui giornalisti coinvolti nelle intercettazioni dorme sonni profondi. Sino a
quando? Un folto pubblico di giornalisti, era presente nella biblioteca
civica “Acclavio” a Taranto dove si è svolta due una conferenza sul
tema: “La deontologia dei giornalisti nei massimari della giurisprudenza
dell’Ordine”. Un’ occasione solo per raccogliere ulteriori crediti (in
questo caso 5) per assolvere all’ obbligo formativo richiesto a tutti gli
iscritti all’ Ordine dei Giornalisti di Puglia, o forse per alcuni la
voglia di pulire la propria coscienza? Presenti fra i relatori il vice
presidente del Consiglio di Disciplina Nazionale Elio Donno, il consigliere
dell’Ordine pugliese Piero Ricci e il presidente del Consiglio di Disciplina
pugliese Paolo Aquaro. La presenza del collega Aquaro, che sta seguendo insieme
agli altri componenti del Consiglio di Disciplina un procedimento disciplinare
sui comportamenti vergognosi di alcuni giornalisti tarantini coinvolti a pieno
titolo, e per loro fortuna allo stato attuale senza responsabilità
penale, nell’inchiesta “Ambiente Svenduto” avviata dalla Procura della
Repubblica di Taranto e conclusasi con un recente richiesta di rinvia a giudizio
per 49 imputati e 3 società, . Un’indagine interna, quella dell’Ordine dei
Giornalisti della quale si attendono da oltre due anni gli esiti. Lo scorso 30
novembre del 2012, il Consiglio dell’ Ordine dei Giornalisti di Puglia, si
riunì in seduta straordinaria con all’ordine del giorno l’ esame della
squallida vicenda che coinvolgeva dei giornalisti tarantini, emettendo uno
scarno comunicato di poche righe per dire semplicemente quanto segue: “Il
Consiglio ha deciso di procedere ad approfondimenti ascoltando in fase
preliminare i giornalisti coinvolti che saranno convocati nei prossimi giorni,
perché possano fornire la loro versione dei fatti”. Sono passati due
anni da quel giorno ed un’imbarazzante silenzio è calato su questi
approfondimenti. Pressochè impossibile, ricevere qualssi tipo di aggiornamento,
notizia, neanche la più piccola indiscrezione sullo stato dell’inchiesta interna
all’ Ordine dei Giornalisti pugliese. L’unica certezza è che vi sono
state le audizioni di alcuni giornalisti che negli anni scorsi avevano fatto da
scendiletto ai dirigenti dell’ILVA ed in particolare all’addetto alle
pubbliche relazioni Girolamo Archinà, successivamente licenziato dai Riva. Di
concreto, come immaginabile, nulla. Il silenzio più totale. Alcuni dei
giornalisti coinvolti, paradossalmente ricoprano incarichi direttivi in giornali
e telegiornali tarantini. Resta da capire con quale credibilità per loro e le
varie testate. Durante la solita “lezioncina” sul corretto svolgimento della
professione giornalistica, è arrivata la coraggiosa domanda che ha creato non
poco imbarazzo ai giornalisti presenti: “scusate, a che punto è il
procedimento disciplinare per i giornalisti intercettati nell’inchiesta Ambiente Svenduto?” A
farla coraggiosamente, ma soprattutto giustamente è stato il collega Cataldo
Zappulla, un coraggioso freelance, rivolgendosi a Paolo Aquaro. La
risposta-reazione del giornalista che è presidente del Consiglio di
Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, è stata però succinta,
per non dire fredda: “E’ in corso”. Chiaramente, come prevedibile nessuno
dei presenti si è minimamente soffermato sulla vicenda chiarendo il numero
esatto dei giornalisti coinvolti. Il consigliere dell’ordine dei
giornalisti Paolo Aquaro, avvicinato da una frrelance a fine conferenza, le ha
detto che “non si può sbilanciare ed ha ammesso che l’inchiesta è resa meno
spedita per la mancanza di documentazione. Insomma, mancherebbero gli atti della
Procura, nonostante le richieste avanzat”. Sara vero? Noi ne dubitiamo
fortemente in quanio, il Consiglio dell’ordine ha dei poteri di “persona
giuridica di diritto pubblico (art. 1, ultimo comma, della legge n.
69/1963) ed ente pubblico non economico (art. 1, comma 2, del Dlgs
29/1993, oggi Dlgs n. 165/2001)” Non a caso infatti, l’Ordine dei Giornalisti è
sottoposto alla vigilanza della Direzione Affari Civili del Ministero della
Giustizia (art. 24 della legge 69/1963). “Sono assoggettati al controllo
della Corte dei conti gli ordini e collegi professionali – nella
qualità di enti pubblici non economici nazionali, di cui è menzione
nell’art. 1 comma 2 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 – in quanto ricompresi tra gli
enti di diritto pubblico, a loro volta assumibili tra le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 4 dell’art. 3 l. 14 gennaio 1994 n. 20” (C. Conti,
Sez.contr. enti, 20/07/1995, n.43; – FONTE Riv. Corte Conti, 1995, fasc. 5, 48;
). Ne consegue che l’Ordine dei Giornalisti di Puglia, ha il diritto e
dovere di acquisire gli atti in mano alla Procura della Repubblica di
Taranto, invece di limitare la sua sinora sterile azione alla semplice lettura
di articoli di giornali o di ascoltare altre informazioni raccolte in giro
verbalmente quà e là. L’unico a dire qualcosa di più
ma veramente ben poco, è stato il consigliere dell’Ordine, il
collega Piero Ricci: «Non posso dirvi il numero esatto dei giornalisti
coinvolti. La situazione è abbastanza delicata, ma secondo me il numero è ancora
incompleto perché non abbiamo avuto ancora tutti i nomi e tutte le carte. Finché
non li abbiamo non possiamo fornire un numero definitivo. Sicuramente chiederemo
alla Procura e al presidente del Tribunale di poter accedere a tutto
l’incartamento, perché ciò che abbiamo è insufficiente per aprire altri
procedimenti disciplinari. Sono convinto che bisognerà aprirne altri. Questo,
adesso, possiamo dire all’opinione pubblica. Speriamo di avere la necessaria
collaborazione per delineare un quadro completo della situazione». E dopo
due anni stiamo ancora al “Sicuramente chiederemo alla Procura e al
presidente del Tribunale di poter accedere a tutto l’incartamento” ??? Come
non dare ragione poi a Beppe Grillo ed a quanti propongono la chiusura
dell’Ordine dei Giornalisti !?! Di fatto, Ricci ha avvalorato le voci di
corridoio che circolano da tempo fra i giornalisti di Taranto. Infatti nelle
carte e nel materiale della Procura non figurerebbero solo i nomi già pubblicati
di alcuni giornalisti. La rete dei “pennivendoli” complici di Archinà e
sul libro paga dell’ILVA in realtà è di fatto più estesa ed ancora attiva.
Sarebbe il caso che il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti di
Puglia invece di organizzare corsi e conferenze inutili, che senza i crediti
professionali, andrebbero deserti, si dessero fare e svolgessero il loro dovere
istituzionale ed il loro compito professionale e morale. Le omissioni
nell’applicazioni delle norme di legge, infatti, sono perseguibili penalmente. I
“pennivendoli,”, i giornalisti “marchettari” vanno sanzionati
ed in modo evidente ed esemplare. Lo impone il necessario rispetto nella Legge,
ma sopratutto il dovuto massimo rispetto nei confronti dei dei lettori e
telespettatori che hanno diritto a ricevere un’informazione corretta su quanto è
accaduto ed accade intorno all’ ILVA. «Anche nel mese di
ottobre 2010 – si legge nell’ordinanza del gip Patrizia Todisco – si
registravano eventi di rilievo sul fronte dei rapporti tra Archinà e Assennato,
il direttore generale di Arpa Puglia e su quello dei rapporti che Archinà intratteneva
con la carta stampata e che gli consentivano di manipolare letteralmente la
maggior parte dell’informazione locale che, con sistematicità, risultava
accondiscendente, alle indicazioni e ai suggerimenti di Archinà”.
Nelle pagine del provvedimento del GIP si legge un rapporto diretto e
colluso con i giornalisti di due testate giornalistiche di Taranto. Vengono
riportati i nomi sia di Michele Mascellaro il direttore di Taranto Sera (quotidiano
che ha cessato le pubblicazioni riapparendo successivamente ed ancor oggi in
edicola sotto il nome di Taranto “Buona Sera” ) , che del
giornalista Pierangelo Putzolu che all’epoca dei fatti era caposervizio per la
redazione di Taranto del Nuovo Quotidiano di Puglia attuale il direttore
editoriale a Taranto “Buona Sera” . In particolare fu Putzolu, il 24 agosto del
2010, a consentire la pubblicazione, sul Quotidiano all’interno della
rubrica “Punto di Vista”, un articolo dal titolo “L’allarme berillio e
i fondi pubblici per la bonifica”, firmato da un fantomatico Angelo
Battista, spacciato come “esperto ambientale”, ma che secondo quanto accertato e
scritto dal gip Patrizia Todisco non esisterebbe, ed in realtà sarebbe stata
scritta e firmata con un nome di fantasia da Girolamo Archinà. Di seguito vi
proponiamo i passaggi più interessanti e significativi della “macchina del
fango” giornalistico, messa in piedi dai Riva ed Archinà con il portafoglio
sempre aperto.
Come volevano “bruciare” gli
ambientalisti. Nico Russo, coordinatore
di Taranto Futura,
non piaceva all’ ILVA ed
Archinà.
Era quindi necessario trovare un modo per bruciarlo. Archinà al
telefono con l’avvocato Perli trova
la soluzione ideale: segnalarlo a Michele
Mascellaro. L’uomo, alla guida del quotidiano locale Taranto
Sera (ora Taranto
“Buona Sera”) , è abituato a riportare le notizie con i “toni
che vogliamo noi” diceva la “longa manu” della famiglia Riva.
Archinà (ILVA):
“Avvocato se io per bruciare questo Russo,
se io la facessi chiamare dal direttore
di Taranto Sera, che è poi quello che trascina le notizie per
il giorno dopo”.
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Eh”.
Archinà (ILVA): “Ritiene
opportuno che gli spiega lei, magari senza interviste glielo spiega“.
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Si, ma io non farei interviste eh!”.
Archinà (ILVA):
“Non interviste. No! No! Gli dà notizie…in modo che
lo scrive lui”.
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Come si chiama questo?”.
Archinà (ILVA):
“Michele Mascellaro. La faccio
chiamare io”.
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Ma è…c’è da fidarsi?”.
Archinà (ILVA):
“E’ nostro! E’ nostro! E’ nostro! Si….”
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Mhhhh”.
Archinà (ILVA):
“E’ nostro per intero!”
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Ok”.
Archinà (ILVA):
“E’ quello…è quello che ha fatto scoppiare la
questione Berillio!”
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Ah…Ok. Va bene”.
Archinà (ILVA):
“Le do il suo numero perchè così lui riporta la notizia, così con
il tono che vogliamo noi.…”
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Certo”.
Archinà (ILVA):
“In modo che Russo domani
se vuole tenere la conferenza stampa deve stare attento”.
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Mhhh… va bene”.
Archinà (ILVA):
“Va bene? quindi provvedo”.
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Mi…Mi…Mi interessa molto quell’accesso agli atti”.
Archinà (ILVA):
“Si, si, si certo. Certo va bene.”
Avv.
Perli (legale ILVA) :
“Grazie arrivederci…ci sentiamo buongiorno….”
(Intercettazione
del 21 aprile 2010 – 11:36)
Le intercettazioni tra Mascellaro (direttore
di Taranto Sera) e Girolamo Archinà (pubbliche
relazioni ILVA) svelano
i sistemi usati dalle aziende per gestire i rapporti con la stampa locale:
Archinà (ILVA):
“comunque è andato… mò ti faccio una confidenza, non ti far trapelare
niente quando lo vedi. E’ andato ieri in maniera improvvida e senza avermi
avvisato, Cattaneo (ufficio stampa ILVA
– n.d.r) da Walter Baldacconi (direttore responsabile STUDIO 100 – n.d.r).
Vabbè ma voleva fare i soliti incontri giornalistici. Come li ha fatti con te e
con gli altri, no? In
maniera…alla milanese maniera"!
Mascellaro (Taranto
Sera): "Si".
Archinà (ILVA): “E
si Baldacconi l’ha
portato da Cardamone…”
Mascellaro (Taranto
Sera):
“Ah…quanto gli hanno chiesto?”
Archinà (ILVA):
“Appena è arrivato, dice “sa noi dall’ ENI abbiamo
ricevuto una promessa di un milione di euro, poi Roma l’ha bloccata, per questo
noi li stiamo attaccando”.
Mascellaro (Taranto
Sera): "Ah".
Archinà (ILVA):
“Ehhhh va buò. Dice che ne è tornato scandalizzato".
Mascellaro (Taranto
Sera): "AhAhAhAhAhAh Ah AhAhAh
(risata)".
Archinà (ILVA):
“ Va buò !”
Mascellaro (Taranto
Sera): "Ma
non ti ha detto quanto gli hanno chiesto a lui?"
Archinà (ILVA):
“No vabè ma mica lo fa così lui (Cardamone).
So che sono tre o quattro volte che mi chiama oggi. e non gli rispondo a Cardamone."
Mascellaro (Taranto
Sera): "Ah.
ho capito".
Archinà (ILVA):
“Va buò va! Ci sentiamo domani”.
Mascellaro (Taranto
Sera): “Beato
a chi gli è amico”.
Archinà (ILVA):
“Ciao! Un abbraccio”.
Mascellaro (Taranto
Sera) : “Ciao
Girolamo ciao”.
Il 31 agosto dello stesso anno anche “Taranto
Sera” pubblicava la seguente notizia: “Esclusiva: documento top
secret dell’Arpa smentisce tutto. Un affare di milioni dietro la finta emergenza
berillio”. In un dialogo intercettato Michele Mascellaro,
all’epoca dei fatti direttore di Taranto
Sera, e Girolamo
Archinà si parlavano così al
telefono:
Archinà (ILVA): "Mai
hai visto? Tutti i giornali ti hanno seguito eh!"
Mascellaro (Taranto Sera): "Che
mi tieni a fare a me?"
Archinà (ILVA): "Hai
fatto uno scoop hai fatto…"
Mascellaro (Taranto Sera): "L’ho
scritto anche: “Nostra esclusiva”".
Ma non è finita qui. In un altro passaggio
dell’ordinanza, inoltre, si parlava l’emittente televisiva “Studio 100”
di Taranto citata
da un’annotazione della polizia giudiziaria “Si ritiene che il contratto
pubblicitario rappresenti solo un escamotage per mascherare la dazione di denaro
da parte dell’ILVA al gruppo di Cardamone per
ottenere una linea editoriale favorevole”. Sempre scorrendo gli atti,
secondo la polizia giudiziaria “dalle attività tecniche emerge che l’ILVA ha
commissionato ad un’agenzia pubblicitaria degli spot (al costo di 120.000
euro) che verranno trasmessi dal network facente capo ai Cardamone.
Appare chiaro che il pressing di Gaspare Cardamone abbia
sortito gli effetti desiderati in quanto evidentemente ha ricevuto una
sostanziosa commessa pubblicitaria da parte dell’ ILVA la
quale, a sua volta, come ritorno potrà essere tranquilla che non riceverà
attacchi mediatici ed anzi potrà sfruttare i predetti media a proprio favore
anche mediante una campagna di comunicazione tesa a ridimensionarne la figura
[in senso favorevole ad essa Ilva] agli occhi dell’opinione pubblica, al fine di
non apparire sempre e solo come causa principale dell’inquinamento ma anche come
uno stabilimento proteso all’incremento dello sviluppo eco-sostenibile dei
propri impianti”.
(Intercettazione del 21 aprile 2010 –
11:36)
Una conferenza telefonica tre, da una parte della
cornetta c’è Girolamo Archinà,
dall’altra lo scomparso Emilio Riva, patron dell’ILVA ed Alberto
Cattaneo, dirigente della comunicazione in azienda. Oggetto della
discussione gli spot su una televisione locale.
Emilio
Riva (patron ILVA):
“Archinà!”
Archinà (pubbliche
relazioni ILVA): “Si
dottore l’ho chiamata poco anzi, mi hanno detto che era impegnato”.
Emilio Riva (ILVA):
“Sono qua con Cattaneo ”
(responsabile comunicazione ILVA).
Archinà (ILVA): “Ti
saluto”.
Cattaneo (ILVA):
“Con questi cavolo di spot che vogliamo fare su Studio
100?”
Archinà (ILVA): “Siii”
Cattaneo (ILVA):
“Ma ce li mandano in onda o no?”
Archinà (ILVA): “Ma
allora io, me lo chiesi. Contrattualmente li devono mandare per forza in
onda, io non vedo nessun problema di questo tipo. Era l’unica cosa quando me lo
chiese il ragioniere, era di vedere un pò, se mandare gli spot, poi non
aumentano gli appetiti degli altri esclusi, Questo era l’unico problema. Ma per Studio
100, non è un problema, lo devono
mandare, punto e basta. Perchè è previsto dal contratto”.
Cattaneo (ILVA):
“Girolamo. Ehi, quello che non ho colto da Cardamone è
proprio questa volontà, però se tu ci assicuri noi siamo a posto. Siccome stiamo
spendendo dei soldi per gli spot televisivi. Il nostro problema se spenderli o
no, se questi non li mandano. Capisci?”
Archinà (ILVA): “Il
problema, c’è un contratto firmato per questo, no, c’è un contratto, punto. Per
me il contratto firmato va onorato da entrambe le parti”.
Cattaneo (ILVA):
“Perfetto”.
Archinà (ILVA): “Punto.
E’ un problema che non mi pongo, mi segui?”.
Cattaneo (ILVA):
“Si. Sono felice di quello che mi stai dicendo”.
Archinà (ILVA): “Quando
la settimana scorsa il ragioniere mi fece cenno di questo, io gli dissi, l’unico
momento di riflessione deve essere un momento che, se attraverso questi spot,
gli altri esclusi, Telerama, TBM, At6, cioè
quelle televisioni escluse non…”
Cattaneo (ILVA):
“Eh, ma qualcosa faremo anche con loro eh”.
Archinà (ILVA): “Ecco
quindi ….”
Cattaneo (ILVA): “non
mi preoccuperei di questo”.
Archinà (ILVA): “Infatti,
solo di questo avevo detto. Punto e basta. Perchè gli altri, se vogliono i
soldi, devono darci gli spazi, che invece di fare i redazionali, come mandiamo
noi, cioè, quindi che cacchio vogliono?”
Cattaneo (ILVA): “Si
ma il fatto è che siccome questi spot costano,
poi dobbiamo mandarli in onda eh!”.
Archinà (ILVA): “Si,
dottore lo so…”
Cattaneo (ILVA): “Costano
120.000 euro andiamo a spendere, perchè sono fatti bene, sono fatti con una
logica …”
Archinà (ILVA): “No,
no, dottore, il discorso che dico io, contrattualmente ci spettano degli spazi.
Contrattualmente. Parlo di Studio100.
Per cui su questo, se vogliamo, se vuole, io la prossima settimana oppure anche,
perchè oggi e domani non ci sta lui che stà a Milano, a ritirare un premio, non
so, gliene parlo, gli vado a parlare. Cosa…?”
Rumori di sottofondo (è la voce di Emilio
Riva che parla)
Archinà (ILVA): “Si,
esatto. Glielo vado a dire in maniera spiccicata”.
Cattaneo (ILVA):
“Diciamoglielo, guardi caro signore, che noi stiamo andando, non stiamo facendo
per finta . ILVA sta spendendo dei soldi per fare gli spot, non è uno scherzo!”
Archinà (ILVA): “Lunedì,
vado e glielo dico in maniera spiccicata.
Ripeto l’unico motivo di riflessione dottore che aveva fatto con suo padre era
questo: attenzione siccome in quel budget erano escluse altre televisioni
Telerama, TBM, e
così non svegliamo gli appetiti di questi esclusi. Punto”..
Cattaneo (ILVA): “Va
bene”.
Nell’ordinanza viene alla luce anche quanto non
pochi sospettavano e denunciavano da tempo, rimanendo chissà
perchè inascoltati…. «Il complesso delle attività tecniche svolte fa
emergere uno spaccato nel quale si vede come l’ ILVA utilizzando
lo strumento delle “sponsorizzazioni pubblicitarie”, veicoli
in maniera più o meno “lecita” delle somme agli organi d’informazione, sia
stampa che radio-televisivi, al fine di non essere
continuamente avversata in conseguenza dei numerosi e costanti comunicati stampa
e delle frequenti manifestazioni che le associazioni ambientaliste del
territorio (Altamarea, Peacelink, etc) promuovono contro l’ ILVA considerata
la principale fonte inquinante del territorio».
Ecco cari amici come andavano (e chissà se non
continuano ancora) i rapporti giornalistici a Taranto della stampa corrotta e
collusa con i poteri economici. Se persino il quotidiano LA
REPUBBLICA ha messo
online i file audio delle intercettazioni, cosa aspetta l’Ordine dei
Giornalisti di Puglia a
svegliarsi dal consueto silente torpore? Se poi qualcuno si rivolgesse alla
Direzione Affari Civili del Ministero di giustizia ed alle Procure della
repubblica di Bari e Taranto, allora qualche giornalista potrebbe iniziare a
preoccuparsi anche penalmente. E’ proprio il caso di dire, Taranto inquinata,
grazie anche a (certa) stampa infetta!
“Ambiente svenduto” & giornalismo
corrotto, scrive Antonello De Gennaro il 2 dicembre
2014 su "Il Corriere del Giorno".
"Solo chi non fa nulla non sbaglia mai. Sbaglia soltanto a nascere (1982)" Indro
Montanelli intervistato da Enzo Biagi nel suo programma televisivo “Il Fatto”,
poco prima della sua scomparsa, dipinse in maniera emblematica (alla sua
maniera!) il rapporto tra un giornalista, il suo editore ed il pubblico, e
disse: “Oggi non esiste più un solo giornalista che sappia dialogare con il
suo editore, tutti hanno paura. Ma sono gli editori che dovrebbero temere
i propri giornalisti: dovrebbero temerli perchè essi sono i primi difensori
della trasparenza dei giornali e garanti della lealtà verso il pubblico”. In
questa città sono nato oltre 50 anni fa ed ho avuto la fortuna di avere un padre
come Franco de Gennaro, che insieme ai suoi soci e co-fondatori fondò il
Corriere del Giorno, cioè il quotidiano, che oggi state leggendo nella sua
edizione online. Ho avuto la fortuna di avere oltre a mio padre, dei grandi e
veri “maestri” di giornalismo come Mario Gismondi, Oronzo Valentini, Giorgio
Tosatti, Antonio Ghirelli ecc. Ho avuto la fortuna di riuscire a diventare
giornalista professionista a soli 23 anni (e mio padre era già morto da 3 anni),
record che ancora oggi mi risulta imbattuto. Perchè ve lo racconto? Non certo
per ricevere facile consenso, l’ammirazione o applausi dai lettori che stanno
leggendo quello che scrivo, nè tantomeno per atteggiarmi a “guru” del
giornalismo. Ve lo racconto con grande umiltà, per sfatare delle leggende
metropolitane messe in giro recentemente da giornalisti tarantini (e
della provincia “complessata”) disoccupati, frustrati, incapaci, come le loro
carriere confermano, per mettervi a conoscenza della verità e cioè che in 30
anni (fra un mese) di giornalismo professionistico, non ho mai ricevuto un
qualsiasi tipo di richiamo deontologico dagli Ordini dei Giornalisti a cui sono
stato iscritto (Bari, Milano, Roma). Qualcuno vi dirà: ma quello, de Gennaro è
stato condannato per diffamazione (non giornalistica!) . Come ho già detto in
passato, sono fiero di aver preso una condanna (“processo Svanity Fair“)
peraltro coperta da indulto, e che in appello è stata dimezzata, anche perchè
quelle diffamazioni (di oltre 10 anni fa) successivamente alla luce nelle
inchieste “Vallettopoli” e “Berlusconi Ruby-gate” e “Berlusconi
Ruby-gateBis”, sono diventate a posteriori delle “verità” raccontate dal
sottoscritto in anticipo su tutti, da “solitario” e senza avere a disposizione i
potenti mezzi informatici e di intercettazioni delle forze dell’ordine.
Utilizzati dai pubblici ministeri Woodcock e Boccasini nello loro indagini. In
queste settimane abbiamo pubblicate le intercettazioni che comprovavano le
connivenze fra la delinquenza mafiosa tarantina ed alcuni esponenti della
politica locale e del suo squallido sottobosco. Qualcuno ci ha accusato: “perchè
non parlate anche dei giornalisti corrotti?” Premesso che già lo avevamo
fatto, abbiamo deciso di pubblicare le intercettazioni “INTEGRALI” agli atti
dell’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Taranto, su richiesta
della Procura della repubblica, meglio nota come “inchiesta Ambiente
Svenduto”. I giornalisti coinvolti Pierangelo Putzolu e Walter Baldacconi li
conosco molto bene da anni, ad eccezione di Michele Mascellaro, anche se ora
questi “signori della disinformazione” quando mi incontrano fanno finta
di non vedermi. E fanno bene, perchè sono loro che devono abbassare il capo e
guardare per terra dalla vergogna. Io sto facendo solo e soltanto il mio lavoro:
informare il lettore. Senza “se” e senza “ma”, e soprattutto senza
fare sconti a nessuno. Giornalisti compresi. Partiamo dalle intercettazioni che
riguardano il quotidiano Taranto Sera, successivamente chiuso per
mancanza di lettori… oberato dai debiti e rifondato sotto mentite spoglie,
ribattezzato in (Taranto) Buona Sera con direttore lo stesso
giornalista: Michele Mascellaro. “Ad ogni buon conto, la stampa, in quel caso
il quotidiano “Taranto Sera”, diffondeva la notizia che si era di fronte ad “una
finta emergenza berillio”, insinuando il dubbio che dietro tale emergenza, di
fatto, si celassero ben altri interessi [v. articolo apparso
sul quotidiano “Taranto Sera” del 31.08/01.09.2010, dal titolo: “Un affare di
milioni dietro la fìnta emergenza berillio. NOSTRA ESCLUSIVA. Il documento top
secret dell‘Arpa smentisce tutto”, allegato 57 all’informativa 21.09.2012,
tratto dalla rassegna stampa interna dell’ILVA, decreto 356/10 R.I.T., prog.
2802]. All’indomani della pubblicazione di detto articolo di stampa,
l’ARCHINÀ si intratteneva al telefono con il dott. MASCELLARO, direttore
di “Taranto Sera”, e commentava con soddisfazione l’articolo che questi, su sua
sollecitazione, aveva pubblicato; lo esortava, altresì, a continuare nella
stessa direzione, con un nuovo articolo “pepato” in relazione alla conferenza
stampa che il sindaco STEFÀNO aveva convocato a seguito della diffusione di
dette notizie (conv. dell’01.09.2010, progr. 8013, ore 10.50, allegato 58
all’informativa 21.09.2012).
E gli articoli su
“commissione di Archinà ai giornalisti al suo “servizio” non sono finiti……
Scrive ancora “Il Corriere del Giorno” il 5
dicembre 2014. Eccovi quindi il seguito delle
intercettazioni agli atti dell’inchiesta giudiziaria “Ambiente Svenduto”
che coinvolgono Pierangelo Putzolu ex responsabile della redazione tarantina del
Quotidiano, ed attuale direttore editoriale del quotidiano (Taranto) “Buona
Sera” edito da una cooperativa con sede a Grottaglie (TA), nato sulle ceneri
di “Taranto Sera” la cui società editrice ha cessato la propria attività.
Nelle intercettazioni, Putzolu dimostra di essere asservito agli interessi
di Girolamo Archinà, all’epoca dei fatti responsabile delle relazioni esterne
dell’ILVA (Gruppo RIVA) a Taranto. Come sempre tutto riportato
testualmente ed integralmente. “Proseguono I pubblici ministeri nella
richiesta di misura cautelare (pag 38 e segg.) Sulla scorta di quanto innanzi
evidenziato non possono esservi dubbi sulla metodica utilizzata per raggiungere
gli obiettivi perseguiti dall’ ILVA. E’ evidente che con il ruolo che rivestiva
e con le mansioni che gli erano state demandate, ARCHINA‘ travalicava sovente,
gli argini della liceità, come nel caso che si va a descrivere sempre
finalizzato a screditare sia il direttore dell’ARPA Puglia ASSENNATO sia il
sindaco di Taranto STEFANO visti come i principali nemici dell’ILVA. In tale
opera ARCHINA‘ veniva poi valentemente supportato da due direttori di quotidiani
locali, il dott. Pierangelo PUTZOLU, direttore della sede tarantina del “Nuovo
Quotidiano di Puglia” (Gruppo CALTAGIRONE Editore – n.d.r.) , ed il
dott. Michele Mascellaro, direttore di “Taranto Sera“. ….omissis…… In tale
disegno, ARCHINA‘ veniva supportato dai direttori dei quotidiani locali. Infatti
con l’aiuto del dott. Pierangelo PUTZOLU,
direttore dell’edizione tarantina del “Nuovo Quotidiano di Puglia” pubblicava in
una nota nell’ambito della rubrica “Punto di Vista” del suddetto quotidiano a
firma di un fantomatico BATTISTA Angelo, esperto ambientale, nella quale portata
alla luce la questione, venivano sostanzialmente smentite ARPA Taranto ed ARPA
Puglia. L’articolo di stampa in questione veniva intercettato nella rassegna
stampa dell’ILVA, grazie al monitoraggio della posta elettronica di ARCHINA‘.
Si riporta di seguito, la nota pubblicata il 24.08.2010 sulle pagine del “Nuovo
Quotidiano di Puglia”, edizione di Taranto (allegato 50 all’informativa
21.09.2012).
Taranto, la città degli ambientalisti
(finti) a caccia di protagonismo, scrive
Antonello de Gennaro su “Il Corriere
del Giorno" del 27 dicembre 2015. Come i nostri lettori ben sanno seguendoci
anche sui socialnetwork questo giornale non ha una grande simpatia e soprattutto
nessuna stima per alcuni ambienti finto-ecologisti tarantini dove molti che si
spacciano per “esperti” andrebbero denunciati alla Procura della Repubblica per
procurato allarme. Non li citeremo solo per non dare loro alcuna gratuita
pubblicità ingannevole di cui vivono da alcuni anni, anche perchè come ben noto
a tutti il loro reale scopo è il “protagonismo”, unito ad ambizioni
politico-eletorali, e per qualcuno anche di sopravvivenza. Questa mattina, il
quotidiano La Repubblica, ha pubblicato un articolo sull’inquinamento
nazionale. Scrivendo: “Continua l’allarme smog in tutta Italia, ma la
situazione più critica resta quella di Milano: nel capoluogo lombardo le polveri
sottili sono risultate sopra i limiti anche nel giorno di Natale. La media
giornaliera registrata dall’Arpa Lombardia nella centralina del ‘Verziere’ nel
centro cittadino, il Pm 10 ha segnato valori di 57 microgrammi per metro cubo
contro il limite di 50. Ancora superiore la concentrazione a Città Studi, zona
semi centrale con 67 e 63 a Limito di Pioltello, nell’hinterland. Per quanto
riguarda i comuni della cintura milanese, a far registrare l’inquinamento
maggiore è stata la stazione di Meda (85). La media nell’agglomerato di Milano
si è attestata a 62 microgrammi per metro cubo, di poco superiore a quella di
Bergamo (55) e Brescia (53). Valori oltre i limiti anche a Pavia (59). Resta
quindi confermato nel capoluogo lombardo il blocco del traffico dal 28 al 30
dicembre dalle ore 10 alle 16. A Roma, dopo “approfondita valutazione
tecnico-scientifica dei dati sull’inquinamento”, il Campidoglio ha deciso di
ripristinare le targhe alterne nei giorni 28 e 29 dicembre. Intanto sui social è
divampata la protesta dei cittadini per la chiusura della metropolitana nel
giorno di Natale a partire delle 13. Per oggi l’azienda dei trasporti cittadini
promette mezzi pubblici con orari festi regolari, con solo “qualche lieve
riduzione dei mezzi in circolazione”. Situazione critica anche a Torino, dove
per scongiurare l’ipotesi di un blocco del traffico il comune ha varato il
biglietto unico giornaliero (1.5o euro) per viaggiare sulle linee di trasporto
pubblico urbano e suburbano. L’iniziativa andrà avanti fino al 29 dicembre”.
A Taranto, nonostante l’ILVA, non accade nulla di tutto questo. E badate
bene, non è una nostra opinione. Lo rilevano gli accertamenti
scientifici-sanitari dell’ARPA Puglia, e non quelli dei soliti “noti”
prossimi candidati alle elezioni amministrative del 2017 per il rinnovo del
Consiglio Comunale di Taranto, che ormai vivono mietendo allarme e
preoccupazioni fra gli abitanti del capoluogo jonico, in particolare quelli più
ignoranti ed incompetenti in materia di ambiente e legge. Gente inutile che non
ha mai lavorato un giorno nella sua vita. Chiaramente tutto questo i soliti
“pennivendoli” che scrivono altrove, e non certamente su queste pagine, non ve
lo raccontano. E sapete perchè? Semplice, certi “pennivendoli” prediligono
andare a moderare dibattiti di basso livello organizzati dai “finti”
ambientalisti, farsi dare targhe (dal valore reale “nullo”) e sentirsi
importanti. In realtà, non si accorgono poverini che sono solo inutili. Ecco
cari lettori, i dati “ufficiali” dell’ARPA Puglia. I dati
medico-scientifici che gli altri organi di informazione fanno finta di ignorare,
salvo poi lamentarsi che le redazioni di giornali e televisioni chiudono una
dopo l’altra per mancanza di lettori… !
Giornalismo? No, è solo disinformazione a
ruota libera, continua a scrivere
Antonello de Gennaro su “Il Corriere del Giorno" del 28 dicembre 2015. Ancora
una volta siamo costretti ad occuparci del giornalismo schierato, fazioso,
disinformato molto diffuso a Taranto, spesso al servizio di sindacalisti,
politicanti ed associazioni pseudo-ambientali. Sarà questa la colpa della
chiusura di ben due quotidiani ed una televisione negli ultimi due anni?
Probabilmente si. Cerchiamo di capirci qualcosa. Cercando di fare del
giornalismo chiaro, trasparente, indipendente, e sopratutto documentato, basato
sui fatti, e non sulle opinioni personali qualsiasi esse siano. E’ quello che si
aspettano i lettori quando leggono un giornale, ed è quello che quotidianamente
stiamo cercando di fare. Il giornalista Francesco Casula è un collaboratore
esterno della redazione tarantina del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno,
(retribuito con 5 euro netti ad articolo), che come suo diritto si dichiara
pubblicamente “comunista”, collabora saltuariamente da Taranto con Il
Fatto Quotidiano. Ed è stato proprio sul quotidiano romano diretto da Marco
Travaglio, che nei giorni scorsi il giornalista tarantino ha manifestato la
propria incompetenza in materia di economia e politica industriale.
Casula parlando dell’ILVA di Taranto, ha scritto ieri che “L’AZIENDA
INDIANA ACQUISTA SOLO CON L’IMPUNITÀ TOTALE”, sostenendo in realtà delle
teorie esclusivamente personali e peraltro sulla base di notizie prive di
qualsiasi fondamento ed alcun riscontro (come confermatoci da fonti ministeriali
e dei vertici ILVA), facendosi ridere dietro da una platea molto ampia di
top managers e rappresentanti istituzionali a livello ministeriale e
governativo. Ecco cosa ha scritto il giornalista Francesco Casula su Il Fatto
Quotidiano: “Due condizioni per valutare l’acquisto dell’Ilva di
Taranto. Dettagli non trascurabili che dipingono in modo emblematico la visione
futura dello stabilimento siderurgico ionico. Almeno nelle intenzioni di alcuni
acquirenti. Non acquirenti qualunque, ma quelli teoricamente in pole position
come ArcelorMittal, leader mondiale nella produzione d’acciaio, che insieme a
imprenditori italiani capeggiati dal Gruppo Marcegaglia sarebbero interessati a
sedersi al tavolo per discutere le condizioni di acquisto della fabbrica
dei Riva. In una lettera al governo, infatti, la società indiana ha provato a
mettere le cose in chiaro. Secondo indiscrezioni trapelate dopo il “no” ricevuto
dal Governo nell’ottobre 2014, Mittal è tornata alla carica esattamente 12 mesi
più tardi. Un ritorno reso ancor più legittimo dopo bocciatura dell’Unione
europea che ha bollato come “aiuti di Stato” i prestiti garantiti elargiti
dall’Italia per la sopravvivenza dell’ILVA. Come in una partita di poker, però,
i giocatori indiani hanno provato a rilanciare: per valutare (solo valutare, non
acquistare) il futuro dell’acciaieria ionica, infatti, gli indiani hanno chiesto
che lo stato italiano realizzi due condizioni. La prima inquietante richiesta è
una immunità totale per i nuovi acquirenti e per il management. Non il
“semplice” salvacondotto che il governo italiano ha già garantito agli attuali
amministratori, ma una licenza di impunità. Chi gestisce oggi l’ILVA, infatti,
gode dell’immunità solo in relazione alla realizzazione delle prescrizioni
imposte dal piano ambientale. Mittal, invece, pretende una sorta di
“assicurazione casco” su tutti gli aspetti: una sorta di lasciapassare che
garantirebbe la non punibilità dei nuovi proprietari e dello staff dirigenziale,
ad esempio, anche per responsabilità sulla violazione delle norme di sicurezza”.
Casula straparla quando sostiene di una presunta “bocciatura dell’Unione
europea” che avrebbe a suo dire, e sopratutto dei
suoi amichetti pseudo-ambientalisti “bollato come “aiuti di Stato” i prestiti
garantiti elargiti dall’Italia per la sopravvivenza dell’ILVA”. Peccato per
il lettori del Fatto Quotidiano che tutto
ciò non sia vero, in quanto l’Unione Europa alla data odierna non ha
sanzionato il Governo Italiano, ma ha bensì soltanto effettuato soltanto una
normale apertura della (eventuale) procedura di infrazione che a Bruxelles
aprono a centinaia (!!!) a seguito della valanga di esposti ricevuti dai soliti
“quattro” pseudo-ambientalisti tarantini, ognuno ben noto per la ricerca
spasmodica quotidiana di protagonismo mediatico con velleità elettorali
politiche. Uno stipendio pubblico, si sa, è molto ambito a Taranto….In
realtà come scrive correttamente il collega Claudio Tito del quotidiano La
Repubblica (che almeno sa di cosa scrive) la procedura di infrazione, nella
fattispecie, non è stata ancora completata. Il collega Tito spiega molto bene
che “Sul caso Ilva, infatti, il governo insiste nel richiamare l’attenzione
sulla circostanza che non si tratta di un semplice “salvataggio” ma anche di
un’operazione finalizzata al risanamento ambientale. E secondo l’esecutivo
italiano, proprio la disciplina europea prevede l’intervento pubblico in questi
casi e in modo particolare in riferimento all’intervento siderurgico”.
Aprire una procedura di infrazione, è cosa ben differente. Il
collega Casula dovrebbe avere il buon gusto e la necessaria professionalità di
documentarsi un pò di più e cercare di capire meglio la differenza, magari
facendosela spiegare da un avvocato esperto di diritto internazionale,
specializzazione che in quel di Taranto a dir poco “latita”, e dopodichè forse
avrà la possibilità (e la fondatezza) di poter spiegare la realtà dei fatti, a
quelle decine di lettori che acquistano il Fatto Quotidiano in edicola a
Taranto. Sarebbe interessante conoscere come e da chi Casula abbia appreso e
raccontato virgolettando, cioè attribuendo a terzi delle frasi mai dichiarate
ufficialmente da nessuno (!!!) che la multinazionale franco indiana
Arcelor Mittal, “pretende una sorta di “assicurazione casco” su tutti gli
aspetti”. Un vecchio vizietto giornalistico, che spesso nei Tribunale si
conclude con sentenze per diffamazione per chi si inventa fonti inesistenti. Non
contento, il giornalista-comunista invece di fare informazione per i lettori,
scende nella polemica “politica”, scrivendo: Il governo deve decidere
se proseguire con la trattativa, ma la Puglia dice no. “Il motivo è legato alla
seconda richiesta presentata al governo: il dissequestro dell’area a caldo, cioè
di quei sei reparti bloccati il 26 luglio 2012 dal gip Patrizia Todisco perchè
fonte di emissioni che causavano “malattia e morte nella popolazione”. In
sostanza, come anticipato da Repubblica, gli indiani vorrebbero aumentare il
livello di produzione a 9 milioni di tonnellate all’anno (oggi fermo al limite
di poco più di 8 milioni imposto dall’autorizzazione integrata ambientale), ma
senza passare a nuove forme energetiche, anzi. Mentre l’ipotesi del gas,
auspicata anche dal governatore della Puglia Michele Emiliano prende piede, gli
indiani vorrebbero continuare a produrre acciaio più o meno con la stessa
modalità che ha avvelenato operai e cittadini del quartiere Tamburi, infatti
proprio Emiliano sul Fatto di ieri invocava Eni o Enel come acquirenti ideali
per l’Ilva. Invece, con gli indiani ancora una volta salute e lavoro nel
capoluogo ionico non troverebbero un equilibrio: perché produrre acciaio
partendo da carbone e minerale di ferro stoccate nei parchi minerali (ancora) a
cielo aperto significherebbe lasciare che tonnellate di polveri vengano
trasportate dal vento e finiscano nelle case e nelle vite degli abitanti del
vicino quartiere Tamburi. Ora, naturalmente, la prossima mossa spetta al premier
Matteo Renzi”. Anche in questo caso Casula
continua in un giornalismo “schierato”. Peraltro
disinformato, utilizzando delle dichiarazioni “politiche” e non
tecniche espresse dal governatore Emiliano (che è bene ricordare ai lettori, è
solo un magistrato in aspettativa e non ha mai fatto l’industriale o il
manager!). Come giustamente fa osservare un nostro lettore che di industria ci
capisce qualcosa, “Il Governatore della Puglia scambia un altoforno per un
barbecue e ne chiede l’alimentazione a gas piuttosto che a carbone. Peccato
che siano già alimentati a gas e che il carbonio del carbon coke sia necessario,
in fusione, per produrre l’acciaio che, altrimenti, resterebbe ferro”. Resta
da capire da chi e con quali competenze tecniche specializzate Casula abbia
stabilito e scritto che “produrre acciaio partendo da carbone e minerale di
ferro stoccate nei parchi minerali (ancora) a cielo aperto significherebbe
lasciare che tonnellate di polveri vengano trasportate dal vento e finiscano
nelle case e nelle vite degli abitanti del vicino quartiere Tamburi”.
Casula inoltre non dice come è finito il sequestro giudiziario di
cui parla, operato dal Gip Todisco. Con una prima istanza, in data 4 gennaio
2013, i p.m. tarantini chiedevano disporsi – sulla base dello ius
superveniens rappresentato dall’art. 3 d.l. 207/2012, nel frattempo
convertito in legge – la modifica del provvedimento di sequestro
preventivo delle aree e degli impianti dello stabilimento ILVA (disposto
appunto dal giudice Todisco sin dal 25 luglio 2012 ), restituendo alla proprietà
la facoltà di uso degli impianti e revocando i custodi-amministratori già
nominati dal G.i.p.; in alternativa, chiedevano che fosse sollevata questione di
legittimità costituzionale del decreto legge. Casula non racconta le motivazioni
per cui la Corte costituzionale, lo scorso 9 aprile 2014, ha rigettato il
ricorso del gip di Taranto Patrizia Todisco, e del
Tribunale del Riesame, contro la legge definita “Salva Ilva”.
Secondo la magistratura tarantina il decreto e la legge sarebbero stati
incostituzionali perché, agendo anche in maniera
retroattiva, annullavano di fatto i provvedimenti emessi contro l’acciaieria,
come il sequestro dell’area a caldo o quello dell’acciaio già prodotto e sulle
banchine del porto, in attesa di essere venduto. L’ILVA si era sempre opposta a
questi due decreti di sequestro, presentando ricorsi con la motivazione che la
vendita della merce (un milione e ottocento mila tonnellate rimaste sulle
banchine dal 26 novembre 2012, per un valore commerciale di 1 miliardo di euro)
avrebbero permesso i lavori di bonifica ambientale. Proprio il 3 maggio 2013,
malgrado la Consulta fosse già intervenuta, il Gip Todisco aveva respinto
l’ennesima istanza di restituzione di gran parte della merce, presentata dall’ILVA,
dichiarandola inammissibile perché non erano state ancora depositate le
motivazioni della Corte costituzionale. Qualche giorno prima, infatti, era il 26
aprile 2013 la Procura aveva disposto il dissequestro la restituzione di una
minima parte: l’acquirente delle merci è la compagnia di Stato irachena Oil
Projects Company, e l’ILVA (ancora a gestione “privata”
) aveva annunciato che la data ultima per la spedizione era il successivo 5
maggio 2013; altrimenti l’acciaieria privata avrebbe chiesto un
risarcimento danni allo Stato di 27 milioni di euro. Bene. Adesso leggete cosa
stabilì la Corte Costituzionale sul sequestro
dell’impianto disposto dal Gip Patrizia Todisco. La Consulta ritenne che
bisognava interrompere il clima di “sfiducia preventiva” verso l’ILVA,
perché “l’aggravamento dei reati già commessi o la commissione di nuovi reati
è preventivabile solo a parità delle condizioni di fatto e di diritto
antecedenti all’adozione del provvedimento cautelare. Mutato il quadro normativo (a
seguito dell’introduzione degli interventi di bonifica ambientale come
condizione per la produzione, ndr.) le condizioni di liceità della
produzione sono cambiate e gli eventuali nuovi illeciti penali andranno valutati
alla luce delle condizioni attuali e non di quelle precedenti”. La Consulta,
spiegando le ragioni per le quali respinse la tesi presentata dal GipTodisco e
dal Tribunale del Riesame, aggiunse che “si può rilevare con certezza
che nessuna delle norme censurate (nella legge Salva Ilva, ndr.)
può incidere, direttamente o indirettamente, sull’accertamento della
responsabilità e che spetta naturalmente all’autorità giudiziaria, all’esito di
un giusto processo, l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla
legge”. Non ci sarebbe quindi alcun “Salva-Ilva”, secondo la Consulta
in quanto “le disposizioni non cancellano alcuna fattispecie incriminatrice,
né attenuano le pene, né contengono norme interpretative e/o retroattive in
grado di influire in qualsiasi modo sull’esito del procedimento in corso, come
invece si è verificato nella maggior parte dei casi di cui si sono dovuti
occupare la Corte costituzionale italiana e la Corte di Strasburgo”. Il
novello editorialista dei due ponti…cioè Casula, così conclude il suo articolo:
“Il capo dell’esecutivo non potrà fare altro che scoprire le carte: rimandare al
mittente le proposte e cercare nel frattempo di mantenere le tante promesse
fatte finora a parole oppure svelare il bluff dei proclami degli ultimi
anni e accettare la proposta di Mittal. Perchè al di là di dichiarazioni e
decreti, a Taranto, a distanza di oltre tre anni del sequestro degli impianti
non è cambiato molto. Lo Stato vanta la realizzazione dell’80 percento delle
prescrizioni, ma resta da fare ancora molto: dalla copertura dei parchi minerali
all’individuazione di un nuovo asset aziendale nella speranza che il futuro
degli operai ionici non passi nelle mani di un nuovo padrone interessato
esclusivamente al profitto”. Leggere frasi
dell’articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano,
come ad esempio “il futuro degli operai ionici non passi nelle mani di
un nuovo padrone interessato esclusivamente al profitto” chiarisce senza
alcun dubbio il “credo” politico di Casula. Qualcuno dovrebbe spiegare al
giornalista Casulaed agli ambientalisti “last minute” a lui molto cari,
che un’azienda che produce acciaio non è una congrega di boyscout, o una sezione
del partito comunista, e sopratutto che il fine di qualsiasi attività
imprenditoriale o commerciale che sia, è l’utile, cioè il guadagno. Senza questa
parola magica non si pagano stipendi e fornitori, non si mandano avanti le
aziende. Verrebbe voglia di chiedere a Casula chi dovrebbe individuare “un
nuovo asset aziendale”. Forse qualche suo amico-ambientalista che non
capisce una “mazza” di impresa? O qualche suo collega esperto di questioni
sindacali giornalistiche tarantine puntualmente irrisolte? Di quale “bluff
dei proclami degli ultimi anni” parla il collaboratore tarantino del Fatto (o
stra-fatto?) Quotidiano? La campagna
mediatica giornalistica-ambientalista tarantina accanitasi negli ultimi tre anni
contro il risanamento ambientale e la ristrutturazione industriale dell’ ILVA di
Taranto, sulla quale bene farebbero nel nuovo anno a svolgere qualche
accertamento ed indagare la Guardia di Finanza e la Procura della
Repubblica (quando si risveglierà dal precedente torpore…) su chi finanzia,
come vanno avanti queste pseudo associazioni-ambientali, come vivono e si
mantengono questi pseudo ambientalisti “last minute”. Verrebbero fuori anche
viaggi e biglietti aerei offerti da qualche imprenditore del settore a
giornalisti ed ambientalisti. E state pur certi che se ne vedrebbero e
leggerebbero delle belle. Di “balle” infatti ne abbiamo viste e lette sin troppo
sinora.
LE BUFALE DI PEACELINK. Le “bufale” di
Peacelink sulla trasparenza, su cui molti giornalisti tarantini scivolano…scrive
"Il Corriere del Giorno" l'8 dicembre 2014.
Questa è veramente bella! L’Associazione PeaceLink ha reso noto oggi di essersi
iscritta nel “pubblico” Registro Europeo per la Trasparenza istituito e
gestito dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea per
consentire “una interazione tra le istituzioni europee e le associazioni dei
cittadini, le ONG, le imprese, le associazioni commerciali e di categoria, i
sindacati, i centri di studi” . Per i soliti rappresentanti
dell’associazione invece «È una forma di cittadinanza attiva europea che
vogliamo espandere. Vogliamo, con la nostra iscrizione al Registro
Europeo per la Trasparenza, promuovere la democrazia partecipativa
transnazionale in modo da permettere alle istituzioni stesse di realizzare
politiche adeguate che rispondano alle esigenze dei cittadini europei”. Peccato
però che sull’ Associazione PeaceLink vi sia poca trasparenza. Anzi, nessuna!
Infatti, visitando il loro sito nulla è dato sapere su sia ubicata realmente la
propria sede sociale che nell’atto costitutivo risulta essere collocata presso
l’abitazione di uno dei due soci fondatori (Giovanni Pugliese) e cioè in via
Galuppi 15 a Statte (Taranto). Sul sito dell’associazione peraltro non compare
nessun atto dell’assemblea dei soci che abbia modificato l’atto costitutivo
dove uno dei soci fondatori (Alessandro Marescotti) che la qualifica ed il
titolo di “insegnante di scuola media superiore”, risulta solo portavoce,
mentre oggi lo stesso si auto-qualifica come “Presidente” come potete
verificare di seguito con i vostri occhi. Anche
consultando lo statuto dell’Associazione, si può verificare con i propri
occhi come l’ambiente fosse un interesse molto limitato delle loro attività di
“volontariato”. Ma il comunicato dell’Associazione in questione riserva delle
altre sorprese. Recita (in tutti i sensi…) ” È un grande onore per Peacelink
diventare un’associazione accreditata presso la Commissione Europea e il
Parlamento Europeo. – proseguono - Vogliamo continuare il nostro lavoro
presso le Istituzioni Europee inaugurando anche un’azione di macro-progettazione
europea che possa confluire nella Strategia Europa 2020. Mentre in Italia
vengono fatte leggi per rendere legale ciò che non è legale (incorrendo in
infrazioni europee), e mentre si diffonde un preoccupante intreccio fra mafia e
politica, confermato dalle indagini di Roma, riteniamo che l’Europa sia un
riferimento di legalità imprescindibile per fermare questa riscrittura malata
della legislazione nazionale. Taranto e la nostra nazione – conclude Peacelink -
non possono e non devono sprofondare definitivamente nel malaffare e nella
malapolitica. Vogliamo portare permanentemente il caso Taranto in Europa».
Non sono pochi i giornalisti tarantini che sono caduti nella rete di Peacelink,
Spaziano dalla redazione tarantina del quotidiano regionale (sempre più in
crisi di vendite) La Gazzetta del Mezzogiorno, al quotidiano “Taranto
Oggi” venduto più ai semafori che nelle edicole, passando per
qualche collaboratore dell’edizione barese del quotidiano La Repubblica, che
ha così scritto testualmente “Intanto l’associazione
ambientalista Peacelink Taranto ha ricevuto una lettera dal presidente del
Parlamento Europeo, Martin Schulz, nella quale il presidente si dice
“costantemente informato sulla evoluzione della situazione a
Taranto”, rispondendo ad una missiva di Peacelink del 5 settembre scorso. Lo
rendono noto Alessandro Marescotti, Antonia Battaglia e Luciano Manna per conto
della stessa associazione”. Qualcuno può spiegare a questi giornalisti che
ricevere una lettera formale di risposta ad una propria lettera/istanza/esposto.
Non equivale a ricevere una lettera di Stato o impegnativa da parte dell’Europa?
Resta da capire di quale “onore” trattasi, essendo l’iscrizione al Registro
Europeo per la Trasparenza aperta praticamente a chiunque voglia. E quindi
non si capisce bene di quale “onore” si stia parlando ?!? Che
l’attività “ambientalista” sia di fatto qualcosa di anomalo per
l’associazione lo si deduce da uno stesso articolo del 29 ottobre 2011 presente
sul loro sito (appena tre anni fa) a firma di Marescotti. Ebbene in
quell’articolo che riepilogava i loro 20 anni di attività, è singolare, ed
impossibile non farci caso, non si parla mai di ambiente! Come se
l’Associazione di volontariato Peacelink, (e quindi non di tutela dei
cittadini e/o consumatori) non sapesse nulla dell’inquinamento dell’ ILVA
che non è stato creato o causato certamente negli ultimi mesi. Un “interesse
“ambientalista… dell’ultima ora, che quindi genera di conseguenza non pochi
dubbi sul reale scopo della richiesta costituzione di parte civile presentata
dall’associazione al Gip del Tribunale di Taranto nel processo “Ambiente
Svenduto” attualmente in corso. Ironia della sorte, quell’articolo a firma
Marescotti venne pubblicato nel 2011 proprio dal defunto quotidiano cartaceo “Corriere
del Giorno di Puglia e Lucania” che come è ben noto a tutti i tarantini ed i
nostri lettori, è miseramente fallito in liquidazione coatta con la cessazione
definita delle sue pubblicazioni lo scorso 30 marzo 12014. Parliamo quindi
del clone, cioè della brutta e mal riuscita copia dell’ “originale” Corriere
del Giorno fondato nel 1947 , quello creato dai giornalisti Franco de
Gennaro, Egidio Stagno, Franco Ferraiolo e Giovanni Acquaviva (accanto ai quali
successivamente si affiancarono gli imprenditori Angelo Galantino eNicola
Resta ), e di cui questo quotidiano online che state leggendo è il naturale
“erede” e le legittima prosecuzione della missione di dotare la città di Taranto
di una sua “voce” indipendente. Così come resta da capire come viva (o
sopravviva) quest’ Associazione PeaceLink , chi siano i suoi finanziatori, in
quanto di tutto ciò non vi è traccia, così come non vi è traccia di alcun
bilancio pubblicato sul loro sito. Esiste solo una pagina, con cui
l’Associazione chiede ai propri ignoti sostenitori di contribuire con un
finanziamento. Ma anche in questo caso la “trasparenza” latita in
quanto non vi è neanche un elenco pubblico dei sostenitori. Un comportamento
questo, un pò in antitesi con il vero significato della parola “trasparenza”!
I “volontari” di PeaceLink sono invece molto bravi ad usare i
paroloni ad effetto tipo “Vogliamo continuare il nostro lavoro presso le
Istituzioni Europee inaugurando anche un’azione di macro-progettazione europea
che possa confluire nella Strategia Europa 2020″, pubblicizzando la solita
letterina di cortesia politica ricevuta da un esponente del Parlamento
Europeo dopo appena 3 mesiin risposta alla loro solita “lettera”. Di quale “lavoro”
parlino poi è ignoto saperlo. Probabilmente si riferiscono alla valanga di
esposti, documentazioni, richieste che sono state inviate dappertutto da
PeaceLink (soprattutto ai giornalisti “fiancheggiatori”) e che non hanno mai
sortito alcun concreto effetto ambientalista. E’ anche inutile ricordare i vari
tentativi dei rappresentanti di quest’ Associazione di entrare nelle istituzioni
partecipando a varie campagne elettorali, che si sono sempre rivelate vane:
infatti non hanno mai eletto nessun loro rappresentante. Alle ultime elezioni
amministrative del 2012 per il Comune di Taranto, hanno presentato una
lista denominata “ARIA PULITA PER TARANTO” che ha raccolto appena
l’1,99% dei voti e Marescotti ricevuto appena 507 preferenze. Considerati i
circa 200mila cittadini residenti e votanti a Taranto, un risultato alquanto
eloquente e deludente. Ci sarà un perchè a tutto questo? Secondo noi, una
volta tanto i tarantini non si sono fatti prendere in giro…! “Non potremo mai
dire la verità senza non dover dare un dispiacere a qualcuno”. Questa cari
lettori, amici e nemici, è la regola del “nostro” giornalismo. Che può anche non
piacere a “qualcuno”, ma appunto costituisce solo e soltanto l’opinione di
“qualcuno”, e chiunque esso sia questo “qualcuno”, la sostanza dei fatti non
cambia di una sola virgola! P.S. Abbiamo trovato anche tracce giudiziarie di un
noto esponente di Peacelink (sempre in prima fila accanto
a Marescotti), che vanta alle spalle un’imbarazzante vicenda giudiziaria di
sfratti reiterati, di case occupate abusivamente a Taranto e Roma. Ed ora costui
parla di “legalità”….
Travaglio: “I giornali a Taranto non
scrivono nulla perchè sono comprati dalla pubblicità”.
E’ vero, ma non per tutti…Lettera aperta al direttore
de IL FATTO QUOTIDIANO dopo il suo intervento-show al Concerto del 1 maggio 2015
a Taranto, scrive Antonello de Gennaro su "Il Corriere del Giorno". Caro
Travaglio, come non essere felice nel vedere Il Fatto Quotidiano, quotidiano
libero ed indipendente da te diretto, occuparsi di Taranto? Lo sono anche io, ma
nello stesso tempo, non sono molto soddisfatto della tua “performance” sul palco
del Concerto del 1° maggio di Taranto. Capisco che non è facile leggere il
solito “editoriale”, senza il solito libretto nero che usi in trasmissione
da Michele Santoro, abitudine questa che deve averti indotto a dire delle
inesattezze in mezzo alle tante cose giuste che hai detto e che condivido.
Partiamo da quelle giuste. Hai centrato il
problema dicendo: “A Taranto i giornali non scrivono nulla perchè sono
comprati dalla pubblicità”.. E’ vero e lo provano le numerose
intercettazioni telefoniche contenute all’interno degli atti del processo “Ambiente
Svenduto” e per le quali il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei
Giornalisti di Puglia tergiversa ancora oggi nel fare chiarezza sul
comportamento dei giornalisti locali coinvolti, cercando evidentemente di
avvicinarsi il più possibile alla prescrizione amministrativa dei procedimenti
disciplinari e “salvarli”. Intercettazioni che ti segnalo, solo il quotidiano
che dirigo ha pubblicato “integralmente”. Hai detto qualche inesattezza. Forse
qualcuna di troppo. Innanzitutto il giornalista dell’emittente Blustar TV, che
hai citato e fatto passare come un “eroe-vittima”, in realtà non ha mai fatto
un’inchiesta giornalistica sullo stabilimento siderurgico, bensì ha solo rivolto
una domanda scomoda ad Emilio Riva al termine di un convegno, a confronto della
quale, credimi, le domande fatte ai malcapitati dagli inviati di Striscia la
Notizia e Le Iene nei loro servizi, potrebbero tranquillamente
concorrere ed aspirare a vincere il “Premio Pulitzer“ E poi,
caro Travaglio, quella televisione cioèBlustar TV, che sta per chiudere,
la pubblicità dall’ ILVA la incassava anche lei! Le domande “scomode” di
quel giornalista a Riva sono arrivate solo, guarda caso…quando i rubinetti si
erano chiusi da tempo! Hai paragonato ingiustamente ed erroneamente l’attuale Sindaco
di Taranto Ippazio Stefàno ai suoi predecessori Giancarlo Cito e Rossana Di
Bello, senza sapere che a differenza dei degli altri due, l’attuale primo
cittadino di Taranto, al suo secondo mandato consecutivo, è stato eletto con i
voti di una sua lista civica, senza della quale il centrosinistra non avrebbe
mai governato la città di Taranto, sindaco che gestisce ed amministra la città
in “dissesto economico” finanziario da circa 8 anni, dopo quanto ha ricevuto in
“eredità”…dal precedente sindaco di Forza Italia Di Bello. Hai ha
detto erroneamente che il dissesto di Taranto ammontava a 900mila euro,
dimenticando qualche “zero”…Magari fossero stati solo così pochi! In realtà il
“buco” era di 900 milioni di euro! Se ti avessero informato e documentato
meglio, caro Travaglio, invece di ironizzare sulla
pistola alla cinta del Sindaco, avresti appreso delle pesanti minacce ricevute
dal primo cittadino di Taranto, persino nel suo studio a Palazzo di Città, ad
opera di appartenenti alla criminalità organizzata, la quale grazie a dei
consiglieri comunali collusi silenziosamente si era infiltrata anche all’interno
dell’amministrazione comunale (mi riferisco all’ “operazione Alias”
della DDA di Lecce). Paragonandolo al tuo amico ed ex pm Ingroia che se
ne andava girando in lungo e largo per l’Italia con la “scorta” di Stato, almeno
il sindaco di Taranto non è costato nulla al contribuente, e la sua pistola è
rimasta sempre al suo posto. Caro Travaglio ti anticipo subito un
possibile dubbio. Non sono un elettore, simpatizzante
o apostolo, nè tantomeno amico o parente dell’attuale Sindaco di Taranto, ma
sull’ onestà di Ippazio Stefàno non sono il solo a sostenerla. Ti informo che
oltre al sottoscritto c’è “qualcuno” come il Procuratore capo della repubblica
di Torino, Armando Spataro (tarantino) che dovresti ben conoscere, il quale
essendo persona seria, coerente ed attendibile, sono sicuro sarà pronto a
ripetere quello che disse al sottoscritto: “Sull’onestà di Ippazio Stefàno
sono pronto a mettere la mano sul fuoco”. Non ti ho sentito dire
neanche una sola parola sui tuoi “amici” “grillini”,
che difendi spesso e volentieri in televisione e nei tuoi articoli. Se ti fossi
informato bene, avresti scoperto che i due “cittadini” eletti in Parlamento a
Taranto del M5S, sono stati i primi dopo qualche mese dalla loro elezione
ad abbandonare il movimento di Grillo e Casaleggio. Rinunciare allo stipendio
“pieno” da parlamentare è cosa dura ed ardua. Sopratutto per uno come Alessandro
Furnari (ex disoccupato) ed una come
l’ex-cittadina-pentastellata-deputata Vincenza Labriola la quale, due anni prima
si era candidata alle elezioni comunali per il M5S, ricevendo dal “popolo
grillino” e dai cittadini di Taranto un grande…consenso: la bellezza di 1 voto.
Forse il suo! Per avere traccia della loro attività parlamentare, e conoscere il
loro impegno per Taranto, credo che sia consigliabile alla nostra brava
collega Federica Sciarelli conduttrice di “Chi l’ha visto”. Chissà se ci
riesce …Hai raccontato di intercettazioni, avvenute realmente, fra gli uomini
dell’ILVA e la stessa famiglia Riva, che si intrattenevano telefonicamente con
non pochi politici pugliesi, da destra a sinistra, compreso il neo (ma già ex)
deputato Ludovico Vico. Hai accusato il Pd di averlo fatto rientrare in
Parlamento. Peccato che (purtroppo) gli spettasse di diritto in quanto primo dei
non eletti nel collegio jonico-salentino alle ultime elezioni politiche. O forse
bisognava fare una “legge ad personam” per impedirglielo? Tutta roba
vecchia, riciclata, caro Travaglio, non hai rivelato nulla di nuovo rispetto a
quanto già pubblicato (con audio) dai colleghi del quotidiano La Repubblica,
e che noi umili cronisti di provincia del Corriere del Giorno, abbiamo
approfondito con l’ulteriore pubblicazione integrale online delle
intercettazioni più salienti. Eppure tutto questo, il vostro giovane
collaboratore locale Francesco Casula poteva raccontartelo….ma forse era troppo
impegnato nelle sue conversazioni nell’ufficio dove lavora a Taranto, e cioè un
centro di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia (dove
viene retribuito quindi con soldi pubblici) in cui il giovane collega lavora
insieme alla figlia dell’ex-presidente della Provincia di Taranto Gianni
Florido (PD – area CISL) un politico arrestato a suo tempo
anch’egli per l’inchiesta” Ambiente Svenduto“… Chissà !!! ??? Hai
citato il procuratore capo di Taranto Franco Sebastio ed
i suoi magistrati, come se fossero stato loro gli artefici con una propria
azione “autonoma” a far decollare l’inchiesta giudiziaria sull’ILVA. Ed
anche in questo caso… in realtà non è andata proprio così perchè
l’inchiesta “Ambiente Svenduto” è nata grazie a degli esposti e denunce
di associazioni ambientaliste tarantine, e proprio del sindaco Ippazio Stefàno,
esposti e denunce che non potevano essere dimenticate nei cassetti, come invece
accade tuttora per molti altri casi. Hai dimenticato caro Travaglio di
ricordare che a Taranto un pubblico ministero è stato arrestato e condannato a
15 anni….e ti è sfuggito che un giudice del
Tribunale civile di Taranto è stato arrestato anch’egli mentre intascava una
“mazzetta”. Se vuoi gli atti, te li mando tutti. Completi. Hai
dimenticato anche qualcos’altro.e cioè qualcosa che
non poteva e non doveva sfuggire alla tua nota competenza in materia
giudiziaria. Anche perchè il quotidiano che ora dirigi ne aveva parlato.
La Procura di Taranto aveva realizzato (solo sulla carta) uno dei sequestri più
grossi della storia giudiziaria italiana, nei confronti della
famiglia Riva, sotto indagine per disastro ambientale nell’ambito
dell’inchiesta ILVA. Un decreto di sequestro per equivalente, firmato nel
maggio scorso dal gip Patrizia Todisco su richiesta appunto della procura
tarantina, che imponeva di mettere i sigilli a beni per 8,1 miliardi di
euro senza peraltro mai trovarli ed identificarli! Quindi un sequestro
“fittizio”, rimasto solo sulla carta. E guarda caso, proprio in merito a
questo “strombazzato” grande sequestro…la Corte di Cassazione ha
stabilito che i beni posti sotto sequestro della holding Riva Fire, società
proprietaria di ILVA spa, su richiesta del pool di inquirenti composto
dal procuratore capo Franco Sebastio, dall’aggiunto Pietro Argentino e dai
sostituti Mariano Buccoliero, Giovanna Cannarile e Remo Epifani, non
andavano confiscati motivo per cui ha annullato
senza rinvio il decreto di sequestro, che era
stato confermato nel giugno 2014 anche dal Tribunale del riesame di Taranto. Il
che vuol dire come puoi ben capire da solo, che sui Riva a Palazzo di Giustizia
di Taranto, avevano “toppato” tutti! In ordine: la Procura della repubblica,
l’ufficio del GIP, ed il Tribunale del Riesame. Altro che complimenti…!
Per fortuna ci ha pensato la Procura di Milano (procedendo per
reati di natura fiscale), grazie alla preziosa cooperazione che intercorre sui
reati finanziari fra la Banca d’ Italia, l’Agenzia delle Entrate e
la Guardia di Finanza che hanno scovato un rientro fittizio (cioè mai
effettuato) dall’estero in Italia di capitali della famiglia Riva, operazione
camuffata come “scudata” del valore di 1miliardo e 200 milioni di euro a cui
stanno per aggiungersene altri 3-400 come ha annunciato in audizione al Senato
il procuratore aggiunto milanese Francesco Greco, che sono in pratica i soldi
che la gestione commissariale dell’ ILVA in amministrazione straordinaria ha
richiesto ed ottenuto (ma non ancora sui conti bancari) in utilizzo dal Gip del
tribunale di Milano, previa tutta una serie di garanzie legali a posteriori, in
quanto il contenzioso giudiziario fra Adriano Riva (il fratello e “patron” del
Gruppo, Emilio è deceduto diversi mesi fa) e lo Stato non si ancora concluso,
neanche in primo grado. In compenso, sei stato molto bravo a
spiegare con chiarezza gli effetti reali e vergognosi (mi trovi d’accordo con te
al 100%) dei vari “decreti Salva Ilva”. Permettimi di provocarti: a
quando una bella inchiesta del Fatto Quotidiano su quello che accade
dietro le quinte di Taranto, possibilmente coordinata dall’ottimo Marco
Lillo per evitare cattive figure? Ci farebbe piacere non dover restare i soli
dover scoperchiare i “tombini” di questa città, che per tua conoscenza è
ILVA-dipendente a 360°. Concludendo caro Travaglio, pur riconoscendoti delle
innate capacità giornalistiche e narrative, e stimandoti personalmente, questa
volta te lo confesso mi hai deluso. Hai dimenticato di farti qualche domanda
molto importante come questa: “Come mai al “referendum sull’
inquinamento ambientale” a Taranto hanno aderito e votato solo 20 mila
tarantini” oppure come questa: “Ma gli
altri 180mila tarantini che non sono andati a votare al referendum, dov’erano ?”.
Eppure sarebbe stato facile chiederglielo. Ieri sera li avevi più o meno tutti
di fronte al tuo palco …. Domande serie, caro collega Travaglio, non le
fotocopie di “seconda mano” che ti hanno passato.
La Procura di Taranto, i “portavoce”, i
Carabinieri e l’ILVA, scrive Antonello de Gennaro su
“Il Corriere del Giorno”. In passato ci siamo già occupati di una coppia di
giornalisti e cioè Francesco Casula e Mimmo Mazza che a Taranto tutti chiamano “Cicì”
e “Cocò” per la loro vicinanza. In realtà il giornalista è uno solo, cioè
Mazza, in quanto abbiamo scoperto che il Casula non risulta iscritto all’
Ordine dei Giornalisti di Puglia, e quindi esercitando di fatto illegalmente
(???) la professione giornalistica, che costituisce il suo secondo lavoro, viene
retribuito secondo le nostre fonti presso la Gazzetta del Mezzogiorno a
Bari, per la modica cifra di circa 5 euro ad articolo! I due in realtà, più che
per i lettori, scrivono e vivono per apparire, convinti di essere il Travaglio e
Peter Gomez di Taranto, come ci ha raccontato divertito un nostro caro amico e
noto collega, da sempre molto vicino a Michele Santoro ed a Marco Travaglio.
Mazza si spaccia per “ambientalista” di sinistra, ma invece come racconta
pubblicamente in giro un suo parente, in realtà avrebbe simpatie per la destra.
L’altro, cioè Casula è spudoratamente (e legittimamente) di sinistra come si
evince dalla semplice visualizzazione del suo diario sulla sua pagina Internet.
Teoricamente i due farebbero i cronisti di nera e giudiziaria, ma in realtà
tutti a Palazzo di Giustizia ben sanno che i due vivono di fotocopie ricevute
sottobanco da qualche magistrato desideroso di vedere il proprio nome apparire
sui giornali, o da quegli avvocati i quali pensano che facendo uscire il proprio
nome sulla stampa arrivano i clienti…A memoria d’uomo nessuno
ricorda un’inchiesta giornalistica firmata da uno dei due, ma solo tanti
articoletti-“dettati”, con tanti nomi dei giudici o avvocati e le loro
fotografie in primo piano. Come abbiamo già scritto e rivelato in passato, i due
di giurisprudenza e del codice di procedura penale sanno poco e nulla, come
dimostrano i loro articoli in cui in uno hanno confuso il reato di calunnia
con quello di diffamazione. O forse quell’errore venne fatto volontariamente per
accontentare il socio di una famiglia di gestori di supermercati della provincia
imparentati con Mazza? Incredibilmente, Cocò-Mazza (il più anziano dei due) più
che fare il giornalista passa il suo tempo ad occuparsi di sindacato, lavorando
alla Gazzetta del Mezzogiorno che da oltre un anno gli passa lo
stipendio grazie ai contratti di solidarietà applicati dalla società editrice da
cui dipende, salvo poi auspicare in suo “articoletto” la chiusura dell’ ILVA,
senza chiedersi che fine farebbero i 18mila dipendenti dell’ ILVA
compresi gli appalti, se qualche suo “amichetto/a” della Procura della
Repubblica di Taranto dovesse (ipotesi del 3° tipo, cioè dell’ “irrealtà“)
riuscire a chiudere lo stabilimento siderurgico a colpi di sequestri,
puntualmente annullati, per volere della Cassazione o del Governo.
Il novello “giornalista-ambientalista-sindacalista” Cocò-Mazza, ipotizza (ma in
realtà lo sostiene!) che lo stabilimento siderurgico sia pericoloso per chi vi
lavora, e che tutti gli altri impianti dell’area a caldo siano nocivi per operai
e cittadini. Non contento, dall’alto della sua superbia, che in realtà è
inconsistente, scrive e pone delle domande “alle quali non si risponde né per
decreto, né per ordinanza, ma mettendo a disposizione, ora e subito, tutti i
soldi necessari a salvare quella che anche nei fatti deve essere ritenuta una
azienda strategica. Altrimenti è meglio spegnere tutto, senza bisogno di
ricorrere ai codici”. Quello che Mazza non capisce è che in questo momento
il Governo Renzi sta facendo tutto il possibile per salvare l’azienda,
risanarla ambientalmente e venderla nel giro di 2-3 anni al migliore offerente
sul mercato internazionale. Operazione questa, seguita dal consulente economico
di Palazzo Chigi, Andrea Guerra, che di management ed industria ci capisce
leggermente molto di più del Mazza, il quale in vita sua ha gestito solo e
soltanto, e forse…, lo stipendio che porta a casa! Qualcuno dovrebbe spiegare a
Cocò (o a Cicì?) che ad agosto l’ILVA in amministrazione
straordinaria, riaccenderà l’altoforno AFO 1 ristrutturato e risanato con
i soldi del Governo, in attesa che arrivino i soldi sequestrati e confiscati ai
Riva dalla Procura della Repubblica di Milano, e non dalla Procura di Taranto,
che come confermano i fatti, in realtà non è stata mai capace di sottrarre un
solo euro al Gruppo Riva. Nel gennaio 2014, infatti gli “ermellini” ,
cioè i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nelle nove pagine
delle motivazioni sulla decisione presa di annullare senza rinvio l’estensione
del maxi sequestro da 8,1 miliardi di euro firmato due anni fa (17 luglio 2013)
dal gip tarantino Patrizia Todisco, hanno sostenuto e “cassato” che non
è possibile, “sulla base di una relazione di controllo o di collegamento
societario solo genericamente prospettato, e nell’assenza di un preciso
coinvolgimento delle società partecipate nella consumazione dei
reati-presupposto, o, quanto meno, nelle condotte che hanno determinato
l’acquisizione di un illecito profitto, ricavare l’esistenza di alcun nesso
logico-giuridico tra quest’ultimo ed il conseguimento di eventuali illeciti
benefici da parte delle controllate”. Il provvedimento con cui il gip di
Taranto, Patrizia Todisco, aveva sequestrato, nell’ambito dell’inchiesta
sull’inquinamento dell’ Ilva, a partire da maggio 2013 e messo sotto
sequestro 8,1 miliardi di euro, in beni e conti (ma solo sulla carta!) del
gruppo Riva partendo da Riva Fire ed estendendosi alle società
collegate tra cui Riva Energia, Riva Acciaio e Muzzana Trasporti
secondo la Cassazione presenta “aspetti di abnormità strutturale che
lo pongono fuori dall’ordinamento con l’esigenza della sua conseguente
rimozione”. La Suprema Corte mise in luce a suo tempo, come il provvedimento
del gip Patrizia Todisco sia stato emesso senza la necessaria richiesta del pm,
ma esclusivamente sulla base della relazione formulata dal custode
giudiziario Mario Tagarelli. “Spetta, dunque, al pubblico ministero –
scriveva non caso la Cassazione nell’ordinanza – il potere esclusivo
di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure”
aggiungendo che nel fatto in questione “è pacifico che il provvedimento
impugnato è stato emesso dal gip non in relazione ad una richiesta cautelare
proveniente dal pm, ma ad una richiesta di precisazione della portata
applicativa di un precedente provvedimento” presentata dal custode
giudiziario. Quindi, il provvedimento della Todisco, firmato dietro richiesta
del custode giudiziario, ha “autorizzato, in difetto, di una correlativa
richiesta da parte del pubblico ministero, una estensione del sequestra
preventivo in relazione ad oggetti (azioni, quote sociali, cespiti aziendali,
ecc.) e a destinatari (le società ricorrenti, neanche sottoposte ad indagine
riguardo ai fatti di reato oggetto di contestazione) del tutto diversi rispetto
a quelli indicati nell’originario decreto”. Secondo la Cassazione, il
provvedimento a carico delle società Riva Acciaio e Riva Energia “non
espone le ragioni giustificative delle precisazioni fornite alle richieste in
tal senso avanzate dal custode richieste il cui contenuto” venne
completamente condiviso dal gip Todisco, senza che la stessa legittimasse i
motivi dell’estensione del sequestro. Per i giudici della Suprema Corte “Non
vengono illustrate, infatti, le ragioni per cui i beni costituenti oggetto del
sequestro debbano considerarsi profitto del reato, e dunque aggredibili con una
misura cautelare reale”. Ma tutto questo, Cicì e Cocò lo hanno dimenticato.
I magistrati di Taranto, no. Ed ecco spiegata la guerra allo “Stato”-gestore
dell’ ILVA in amministrazione straordinaria ! Quello che non si spiega,
che è incredibile è come sia possibile che il Comando Provinciale dei
Carabinieri di Taranto alle 22 di sera, si metta a distribuire via mail un
comunicato stampa scritto su carta bianca, privo di firma, in nome e per conto
della Procura della Repubblica di Taranto. Credetemi, cari lettori, in 30 anni
di giornalismo professionistico svolto in tutt’ Italia, non avevo mai visto
nulla di simile! Ma per l’“amico” Sebastio (procuratore capo di Taranto n.d.a.)
il colonnello Sirimarco (comandante provinciale CC Taranto) fa questo ed altro…
Peccato o per fortuna, a secondo dei punti di vista, soltanto sino al 1
settembre!
La Procura di Taranto non si rassegna.
Dopo il Governo…ora è il “turno” degli operai ILVA,
scrive “Il Corriere del Giorno”. La Prefettura in serata del 17 luglio 2015 di
fatto “censura” l’operato della Procura e degli incolpevoli Carabinieri che
hanno solo eseguito un ordine della Magistratura tarantina, che secondo noi
farebbe bene a rasserenarsi. Sedici dipendenti dell’ILVA e tre della
ditta d’appalto Semat in servizio al primo turno sono stati identificati
e denunciati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto per
violazione di sigilli a conclusione dei controlli effettuati oggi dai militari
nell’ara dell’Afo2 l’altoforno sottoposto a sequestro senza facoltà d’uso
dalla Procura, ma il cui utilizzo è di fatto legittimato ad operare grazie a un
decreto del Governo. A disporre il “blitz” odierno dei Carabinieri di
Taranto, disposto dal pm Antonella De Luca e dal procuratore
aggiunto Pietro Argentino, ma stranamente non sono stati contatti i competenti
Carabinieri del NOE (distaccato a Lecce) che sinora hanno sempre
operato all’interno ed esterno dello stabilimento siderurgico, per loro
competenze in materia ambientale. Soltanto alle 22:00 di venerdì 17 sera i Carabinieri di
Taranto hanno diffuso via mail alla stampa un comunicato redatto su carta
bianca, anonima, privo di firma, contenenti queste testuali parole: “Con
riferimento ad alcune attività ispettive svolte in data odierna, su delega di
questa Procura della Repubblica, dagli organi di Polizia Giudiziaria all’interno
dello Stabilimento ILVA, si precisa che sono stati effettuati solo accertamenti
di carattere assolutamente preliminare in vista di eventuali successive attività
di indagine. Tanto è stato precisato nel corso di un incontro tenuto nel
pomeriggio in Prefettura, cui sono intervenuti anche i Sindacati, dal comandante
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Taranto”. Che però… stranamente non
usa la carta intestata, nè firma il comunicato. Incredibile, ma vero, di fatto a
Taranto ormai l’ILVA, i sindacati, i lavoratori, e le aziende forti anche
del pieno sostegno del Governo, sono compatti ed uniti nell’intento di comune di
non fermare la produzione e rischiare di spegnere lo Stabilimento. Ma “qualcuno”
evidentemente alla Procura della Repubblica di Taranto, sembra non
darsi pace. Sarà voglia di protagonismo? O qualcuno forse si sente già in
campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative per diventare
Sindaco…? O invece qualcun’altro ambisce alla poltrona di procuratore capo a
seguito dell’imminente pensionamento dell’attuale capo della procura Franco
Sebastio? Scegliete voi la risposta. Credeteci, difficilmente sbaglierete…
Renzi riapre l'Ilva, i Pm mandano i
carabinieri, scrive “Magazine Donna”. Neppure il
decreto del governo scritto in fretta e furia lo scorso 4 luglio 2015 per
evitare il blocco degli altoforni dell’Ilva (il n° 2) e dei cantieri Fincantieri
di Monfalcone sembra smuovere i magistrati pugliesi dalla convinzione che
qualcosa di losco si stia facendo nell’acciaieria più grande d’Europa. Tanto che
in mattinata del 16 luglio i carabinieri del Comando provinciale di Taranto
hanno notificato a 19 operai del primo turno dell’Afo 2 Ilva (16 dell’Ilva e 3
della ditta d’appalto Semat) una denuncia a piede libero «per violazione dei
sigilli giudiziari». Lo scorso 29 giugno i magistrati tarantini avevano posto
sotto sequestro l’impianto numero 2 (sono in tutto 5 i forni ma ben 3 sono
fermi), dopo che l’8 giugno un getto di ghisa fusa aveva colpito e ustionato un
addetto (Alessandro Morricella). L’operaio dell’Ilva era morto quattro giorni
dopo a seguito delle ustioni riportate sul 90% del corpo. E i magistrati avevano
quindi chiesto il sequestro dell’impianto perché «non è sicuro e mette a rischio
la vita degli operai». Poi il governo aveva emanato il decreto salva Ilva (e
salva Fincantieri, incappata anch’essa in un sequestro nei giorni successivi),
evitando il blocco dell’attività a Taranto come a Monfalcone. Ma il decreto del
4 luglio stando ai magistrati tarantini – sarebbe zeppo di errori. Violerebbe
ben 6 articoli della Costituzione e da qui il ricorso alla Corte Costituzionale.
La Procura – su mandato del pubblico ministero Antonella De Luca – è tornata
all’attacco, visto che nei giorni scorsi il gip Martino Rosati aveva sospeso il
giudizio sulla richiesta di dissequestro avanzata dall’azienda e inviato gli
atti alla Corte Costituzionale. Il gip infatti afferma che il decreto 92 (il
salva Ilva del 4 luglio) è in contrasto con diversi articoli della Costituzione
e consente all’Ilva, solo perché azienda di «interesse strategico nazionale», di
proseguire la sua attività industriale, e quindi «anche di proseguire il reato
che le viene contestato». L’Ilva aveva chiesto alla Procura la «facoltà d’uso» e
il rinvio di dieci giorni dello stop dell’impianto (previsto per il 6 luglio),
garantendo di aver «già attuato le prescrizioni di sicurezza ordinate dallo
Spesal dell’Asl» ed essersi impegnata a presentare un ulteriore piano
migliorativo. Il decreto del governo – nella sostanza – è un’opera
(evidentemente mal scritta) di acrobazia normativa. Infatti non annulla il
sequestro ma stabilisce «che l’Ilva può comunque continuare la sua attività».
Un’attività consentita nei 12 mesi successivi al sequestro ed entro 30 giorni
dal sequestro l’Ilva deve presentare un piano con ulteriori misure di sicurezza
da presentare all’autorità giudiziaria e sottoporre alla vigilanza di Vigili del
Fuoco, Inal ed Asl. Il decreto, ora all’esame del Parlamento, ha consentito
all’Ilva di non spegnere, a Fincantieri di non chiudere i cancelli. Ora però il
provvedimento dei magistrati tarantini rischia di creare un baratro tra
magistrati e governo.
Nel braccio di ferro tra governo e
magistrati sul caso Ilva, a rimetterci questa volta sono gli operai,
scrive "Il Corriere della Sera”. Sedici dipendenti
diretti dell’Ilva e tre della ditta d’appalto Semat, in servizio nel primo
turno, questa mattina sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della
Polizia giudiziaria per violazione di sigilli, essendo stati trovati al lavoro
nell’area dell’Altoforno 2, sottoposto a sequestro senza facoltà d’uso dalla
Procura. Ma l’impianto, dove l’8 giugno scorso rimase gravemente ferito il
35enne operaio Alessandro Morricella, morto quattro giorni dopo per le ustioni
riportate sul 90 per cento del corpo, è ancora in marcia grazie a un decreto del
governo, l’ottavo che riguarda il Siderurgico per sospendere gli effetti degli
interventi dei magistrati nell’ambito dell’inchiesta per disastro ambientale.
Proprio lunedì prossimo 20 luglio è prevista la conclusione dell’udienza
preliminare con la decisione del gup Vilma Gilli sui rinvii a giudizio e i riti
abbreviati. Sono 52 gli imputati (49 persone fisiche e tre società) tra gli ex
vertici dell’azienda, dirigenti, funzionari ministeriali e di enti, politici e
imprenditori. Il blitz dei carabinieri, su delega della magistratura, agita
dunque la vigilia del processo denominato «Ambiente svenduto». Non sono ancora
chiare le motivazioni che hanno spinto i militari a procedere alla contestazione
della violazione di sigilli. Nei giorni scorsi il gip Martino Rosati ha
sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al decreto
governativo che ha congelato il sequestro dell’Afo 2, rinviando gli atti alla
Consulta. Contestualmente è stata respinta la facoltà d’uso dell’impianto, ma il
giudizio dovrebbe essere comunque sospeso fino alla pronuncia della Corte
costituzionale. Dopo i controlli e le denunce dei carabinieri, i sindacati hanno
subito incontrato l’azienda per chiedere informazioni su quanto accaduto,
sostenendo come nella vicenda «i lavoratori siano privi di qualsiasi
responsabilità diretta e per quanto tali, non debbano essere coinvolti da
provvedimento alcuno anche e soprattutto in termini di sicurezza e salvaguardia
impiantistica». Il primo a dare notizia del blitz dei carabinieri è stato, con
un messaggio su Twitter, il segretario nazionale della Fim, Marco Bentivogli,
sottolineando che «la sicurezza dei lavoratori è sempre più a rischio in Ilva di
Taranto. Nei diversi contenziosi — ha ammonito — vogliamo garanzie, altrimenti
la fermiamo noi la fabbrica». La posizione dei sindacati è contenuta anche in un
verbale di incontro inviato al prefetto di Taranto, Umberto Guidato. «Non è
possibile stare in questa situazione — spiega lo stesso Bentivogli — e non è
possibile stare in una situazione di massima confusione e incertezza. Su mandato
della Procura, oggi i carabinieri sono andati all’Ilva, hanno identificato tutti
i lavoratori presenti sull’impianto e contestato loro il mancato rispetto
dell’ordine della Procura, ovvero il sequestro dell’altoforno 2 senza facoltà
d’uso. Ma non spetta ai lavoratori garantire l’attuazione delle prescrizioni o
degli ordini dell’autorità giudiziaria. Non è possibile, anzi è allucinante che
i lavoratori siano identificati come responsabili. È l’Ilva che deve farlo e
allora o l’Ilva ci dice che gli impianti sono sicuri, oppure — conclude
Bentivogli — siamo noi a fermare il siderurgico. In questo caos gestionale non
si può più stare». Dopo l’irruzione dei carabinieri non si è fatta attendere la
reazione dell’azienda. In una nota l’Ilva ha ribadito «di aver operato nel pieno
rispetto della legalità in ottemperanza alle previsioni del decreto legge 92/15.
I dipendenti identificati hanno eseguito le previsioni di un decreto Legge
normato su presupposti di urgenza. Al momento resta garantita la continuità
produttiva». Allo stesso tempo, l’Ilva annuncia che «garantirà la tutela legale
dei propri dipendenti fornendo loro la più ampia assistenza». «Dopo il nostro
incontro di oggi a seguito dell’arrivo dei Carabinieri all’altoforno 2 dell’Ilva
— ha spiegato al proposito il segretario della Uilm di Taranto, Antonio Talò, in
una pausa dell’incontro con l’Ilva — l’azienda sta per andare dal prefetto di
Taranto per farsi autorizzare al funzionamento degli impianti e garantire la
sicurezza dei lavoratori». «Vogliamo che i lavoratori siano garantiti sia per la
sicurezza ed anche sotto il profilo giuridico. I lavoratori non possono essere
destinatari di avvisi di garanzia perché, secondo la Procura, hanno disatteso un
ordine dell’autorità giudiziaria. L’azienda deve assolutamente chiarire come
stanno le cose. Se queste garanzie non ci saranno date, allora saremo noi a dire
ai lavoratori di non andare più sugli impianti e la fabbrica, a quel punto, si
fermerà». Alla luce di quanto accaduto nello stabilimento i sindacati sono stati
convocati al tavolo che si è tenuto alla prefettura di Taranto da cui sarebbero
arrivate rassicurazioni come evidenziato da un comunicato di Fim, Fiom e Uilm:
«Il prefetto ha formulato rassicurazioni circa l’estraneità dei lavoratori ai
fatti contestati e che simili azioni non avranno a ripetersi. Ampie
rassicurazioni sono state fornite in merito all’accesso su Afo 2 di tutti i
lavoratori interessati alle pertinenti lavorazioni».
Ilva, torna la
paura. La Procura di Taranto: "Fra quattro giorni spegnete l'altoforno 2".
Slitta a giovedì la decisione del gup sul processo
'Ambiente svenduto'. Assennato (Arpa): "Non ho mai tradito i pugliesi". E gli
avvocati di Vendola chiedono di derubricare l'ipotesi di reato per l'ex
governatore, scrive Giuliano Foschini su “La Repubblica” del 21 luglio 2015.
In quell’enorme gioco dell’oca che sembra Taranto – tiri un dado e ritorni
sempre al punto di partenza – la Procura ha notificato un nuovo provvedimento di
spegnimento dell’Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico, l’unico al momento
ancora in funzione. In sostanza significa far chiudere l’impianto. Questa volta,
come si legge nelle due pagine consegnate all’Ilva dal custode giudiziario
dell’impianto, l’ingegner Barbara Valenzano, c’è però una data: “Entro il 24
luglio dovremo essere informati del cronoprogramma per lo spegnimento
dell’impianto”. Siamo allo scontro totale, l’ennesimo tra procura e Governo. Che
può essere così sintetizzato: dopo la morte dell’operaio Alessandro Morricella,
la procura di Taranto sequestra l’Altoforno 2 perché
considerato troppo pericoloso per i lavoratori. Qualche giorno dopo il gip
Martino Rosati ne conferma il sequestro. Il Governo, davanti alla prospettiva di
una chiusura della fabbrica, firma un decreto legge straordinario (l’ottavo
nel giro di due anni “ad Ilvam”) che dispone il dissequestro dell’impianto e
consente la ripresa dell’attività. L’Ilva riapre lo stabilimento e chiede il
dissequestro al gip Martino Rosati sulla base della nuova legge. Ma Rosati
solleva la questione di costituzionalità sulla nuova norma. Nel frattempo l’Ilva
continua il lavoro, tra le polemiche dell’Anm (che considera illegittimo il
provvedimento legge) e la spinta del ministro Guidi che considera irresponsabile
la posizione dei magistrati. Vengono mandati i carabinieri in azienda per
identificare gli operai che lavoravano, il Prefetto assicura che non accadrà mai
più, il presidente della Regione, Michele Emiliano, dice per la prima volta che
“l’apertura dell’Ilva non è un dogma”.
Poi, il nuovo colpo di scena. “Il custode – si legge nel provvedimento – chiede
alla società di voler procedere, nell’immediato, all’attuazione del programma di
interventi per lo spegnimento in sicurezza dell’Altoforno 2, così come previsto
dal decreto di sequestro preventivo. Contestualmente il custode chiede di essere
informato, entro la data del 24 luglio, in merito alla realizzazione delle opere
da realizzarsi per procedere alle attività di spegnimento”. E l’Ilva? Per il
momento domani i lavoratori lavoreranno come al solito. “Si prende atto
dell’accesso effettuato in data odierna dal custode – mette a verbale il legale
dell’Ilva, Angelo Loreto – Attesa la procedura seguita dall’Autorità
giudiziaria, e in vigenza del decreto legge che legittima l’esercizio di
attività di impresa negli stabilimenti strategici di interesse nazionale come il
sito Ilva, ci si riserva ogni valutazione e iniziativa volta a chiarire il
perimetro e i contenuti dell’eventuale provvedimento giudiziario di esecuzione
che giustificherebbe l’iniziativa odierna”. Tradotto: per il momento rimane
com’è, ma presto chiederemo l’intervento di un nuovo giudice. Tutto si muove,
dunque, ma tutto rimane fermo, quindi. Un po’ com’è accaduto nei 40 gradi e più
della palestra dei Vigili del fuoco dove si svolge l’udienza preliminare del
maxi processo "Ambiente svenduto". Il gup Wilma Gilli avrebbe dovuto esprimersi
ma le lunghissime controrepliche dei difensori degli imputati l’hanno spinta a
rimandare tutto a giovedì quando però, per alcune situazioni, potrebbe anche
chiedere un supplemento di indagini. Tra gli altri, hanno voluto parlare
personalmente il direttore generale dell’Arpa, Giorgio Assennato, e l’ex
assessore all’Ambiente, Lorenzo Nicastro, che visibilmente emozionato, ha
chiesto che gli venga restituita la “dignità da magistrato”. "Mi si accusa di
aver venduto la salute dei cittadini di Taranto", passando "da eroe a traditore.
Io nego che ci sia stato qualsiasi tipo di arrendevolezza nei confronti
dell'Ilva", ha sostenuto Assennato.
Secondo quanto è stato possibile ricostruire da
Siderweb, sulla base di alcuni documenti allegati agli atti, prenderebbe sempre
più corpo l’ipotesi che l’incidente dello scorso 8 giugno in cui perse la vita
l’operaio 35enne Alessandro Morricella, sia dovuto più all’applicazione di una
pratica scorretta piuttosto che ad un problema strutturale dell’impianto.
Ipotesi, questa, che però non convincerebbe il Gip ed il suo staff. Secondo
quanto ricostruito, infatti, a fungere come innesco della deflagrazione che ha
investito il lavoratore sarebbe stato il distacco dal foro di colata di parte
del materiale protettivo a base di resina che ne circonda il bordo, che, al
contatto con la ghisa incandescente, si sarebbe incendiato, dando origine della
fiammata fatale. All’origine del distacco di refrattario, però, ci potrebbe
essere il tentativo sconsigliato dalle pratiche aziendali di allargare
manualmente il foro di colata per implementarne la portata, intaccando
probabilmente il materiale protettivo. Un’ ipotesi contestata in parte sia
dall’ingegner Barbara Valenzano, custode giudiziario dell’impianto, sia dal Gip
Martino Rosati i quali ritengono insufficienti i provvedimenti in materia di
sicurezza proposti da Ilva fatti da barriere in acciaio rivestite da
refrattario, videosorveglianza sul rispetto delle procedure, rilevazione
automatizzata delle temperature e, soprattutto, tramite la formazione e il
rispetto delle corrette procedure.
Ilva ha presentato uno studio del possibile danno che potrebbe derivare dal
completo spegnimento degli impianti o dal funzionamento solo con Afo 4.
Un’ipotesi che incrementerebbe in maniera massiccia le emissioni inquinanti per
la mancata ottimizzazione nella combustione delle materie prime e, se vi fosse
uno spegnimento completo, la necessità di investire tra i 200 e i 260 milioni di
euro per il rifacimento delle cockerie che, in caso di fermata, vedrebbero
irrimediabilmente compromessi i propri refrattari il cui rifacimento
comporterebbe lo stop completo dell’azienda per almeno 24 mesi.
"Se venisse spento
anche uno solo dei due altoforni in attività a Taranto, non solo sarebbe
antieconomico tenere aperto l’impianto ma anche organizzativamente non si
riuscirebbe più ad alimentare il flusso della produzione". Il ministro dello
Sviluppo economico Federica Guidi, in un’intervista al Corriere della Sera,
torna così sul caso Ilva, invitando la magistratura a valutare il peso delle
scelte sull'azienda siderurgica: "alla magistratura chiediamo di fare il proprio
lavoro avendo chiaro l’impatto delle decisioni che prende. E nel caso
Fincantieri avrei preferito che si fossero tenuti presenti i danni che si
potevano procurare con la sola chiusura del cantiere, solo a causa
dell’interpretazione di una normativa europea non perfettamente recepita nel
nostro ordinamento". "Finora – continua il ministro – non è stato notificato
alcun provvedimento che metta in discussione l’operatività degli altoforni. Sono
dunque ottimista e ricordo che è in corso un’operazione di risanamento
ambientale che ha richiesto ingenti finanziamenti e la chiusura temporanea di
due altoforni". "Spegnere altri altoforni vorrebbe dire rinunciare a uno dei
siti siderurgici più efficienti d’Europa e togliere lavoro a 14-15 mila persone
nel Sud d’Italia. Non c' è nessun motivo, visto che il risanamento è in corso,
così come c' è il massimo impegno per impedire incidenti sul lavoro, perchè
anche un solo ferito è troppo".
Caro procuratore Sebastio le scrivo….di
Antonello de Gennaro direttore de "Il Corriere del Giorno". Egregio Procuratore
della Repubblica di Taranto, per mia fortuna non ho frequentazioni con i suoi
uffici, ed anche se la conosco da circa 30 anni, non ho mai avuto occasione di
frequentarla come invece fanno assiduamente alcuni giornalisti di Taranto, i
quali vengono definiti dagli avvocati del Foro “i ventriloqui della Procura
tarantina”. E sono lieto quindi di essere ampiamente equidistante nel
rispetto dei reciproci ruoli e funzioni che ricopriamo. Le scrivo quindi
questa lettera “aperta” con riferimento alle sue parole da lei pubblicamente
espresse venerdì scorso nel cortile della caserma “De Carolis” sede del
Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, in occasione della
ricorrenza annuale della Festa dell’Arma dei Carabinieri. Istituzione da
me notoriamente amata e rispettata e con la quale a livello centrale presso il
Comando Generale da oltre 30 anni intrattengo rapporti idilliaci di
collaborazione ed amicizia, senza aver bisogno di indossare il “Cappellone”
dell’ Arma, o di ricevere la tessera “onoraria” dell’ Associazione
Carabinieri in congedo da lei ricevuti su iniziativa personale del suo “caro
amico” Col. Daniele Sirimarco, attuale comandante provinciale a Taranto per i
prossimi due mesi e mezzo, in quanto a settembre come ben noto a tutti ormai
lascerà l’incarico per avvenuta compiuta decorrenza del periodo di
comando previsto normalmente di prassi. Ero presente anche io venerdì scorso in
caserma ad ascoltarla, ed a scanso di equivoci, ho registrato tutta la
manifestazione, compreso quindi il suo intervento, dove lei ha parlato della
stampa, di “alcuni” che poi in realtà è uno solo: il sottoscritto. Quindi
avrebbe avuto maggior stile invece di applicare il plurale “maiestatis”,
di coniugare meglio la lingua italiana e parlare al singolare. Ho avuto qualche
dubbio, ed ho quindi fatto passare qualche giorno proprio per fare le opportune
verifiche, ed essere certo, come lo sono, che sono stato solo io a scrivere e
parlare di lei. Lei ha detto (testualmente) che ha conosciuto “nei 40 anni di
servizio,tanti comandanti, tanti ufficiali, tanti Carabinieri ed ho sempre nei
loro confronti un rapporto di simpatia ed affetto“. Ed in questo mi ha
battuto di qualche anno…, avendo avuto dal 1983 ad oggi anche il sottoscritto
uno splendido rapporto con semplici e eccezionali carabinieri, sottufficiali,
ufficiali, comandanti, colonnelli, generali, comandi provinciali, di brigata,
legione, e comandanti generali dell’ Arma, nelle mie frequentazioni
istituzionali allorquando lavoravo (notoriamente) nello staff del Presidente
del Consiglio, poi due ministri Guardasigilli, un Ministro delle Partecipazioni
Statali, un ministro al Commercio con l’ Estero, ed un
sottosegretario al Ministero dell’ Interno con delega alla Polizia di
Stato, ecc. in qualità di “portavoce”, cioè di giornalista-ufficio stampa.
Ho avuto anche io come lei, tante frequentazioni di “militari”, anche
superiori al ruolo e funzioni di un Comandante provinciale dell’Arma. Molti dei Carabinieri che
ho conosciuto e frequentato, creando anche rapporti di amicizia, hanno fatto una
brillante carriera istituzionale nell’Arma e nei “Servizi”. Ma io non ho mai “creato
una coppia”, e non ho mai visto una rapporto così stretto fra un Procuratore
Capo ed un ufficiale dei Carabinieri, come lei ha detto riferendosi al
suo rapporto molto “stretto” che intrattiene con il colonnello Sirimarco.
Scelte e stili di vita differenti. In mio articolo dal titolo “Svanito il
porto delle nebbie della Procura di Roma, a Taranto la “Procura della diossina”.
Su cui bisogna fare chiarezza” dello
scorso 2 aprile ricordavo quante cose “strane” ed illegali accadono a Taranto e
provincia sotto gli occhi “distratti” della Procura di Taranto da lei guidata,
che molto spesso non ha fatto rispettare ed applicato le Leggi ed i decreti
legislativi vigenti, dimenticando anche le norme emanate dal CSM, il Consiglio
Superiore della Magistratura, e la cui lettura sarebbe necessaria… a qualche
suo collega della procura tarantina. Ebbene sappia che pubblicamente ed alla
presenza di terzi non pochi rappresentanti delle istituzioni locali, della
politica, numerosi avvocati tarantini, persino più di qualche “servitore dello
Stato” fra cui appartenenti alle Forze dell’Ordine mi hanno fatto i complimenti
per aver avuto il coraggio (io direi, in realtà, il dovere) di scrivere quello
che ho scritto nel mio precedente editoriale a lei sicuramente noto. Nel
frattempo ho scoperto anche che alcuni investigatori tarantini nel corso delle
loro indagini spesso e volentieri identificano l’associazione mafiosa
preferendo trasmettere gli atti alla Procura della Direzione Distrettuale
Antimafia di Lecce. Sarebbe interessante chiedere a loro il perchè…Non è un
offesa annunciare l’imminente pensionamento di un magistrato. Succede a tutti.
E’ successo all’(ex) presidente del Tribunale di Taranto dr. Antonio Morelli, e
succederà anche a lei. Nessuno le ha augurato la pensione, anche se in realtà è
un augurio vero. “Andare in pensione” significa porre fine alla propria
attività lavorativa e finalmente ad una certa età, riposarsi. Lei nel suo
discorso di saluto e ringraziamento per il “cappellone” ha detto che “Ho
sempre avuto con i Carabinieri un rapporto di simpatia e di affetto. Qualcuno ha
notato questa vicinanza, ne ha anche scritto. In effetti è così. Un
Magistrato che sente amico i rappresentanti delle forze dell’ordine per quanto
riguarda il rapporto di servizio, io penso che costituisca un fatto positivo, io
dico un privilegio. Qualcuno dice “quando se ne và?” Si è scritto “se ne va a
fine giugno”, qualcun’altro “se ne va a fine anno”. Ma al di là di quelle che
possono essere le partenze, gli arrivi, i ricambi, rimane sempre questo
rapporto”. Ebbene caro Procuratore Sebastio, mi spiace confutarla e
contestare alcune sue affermazioni come quella “qualcuno ha fatto già i nomi
dei miei eventuali sostituti” sarebbe stato più corretto fare nomi e
cognomi, in maniera tale che ognuno nel suo ruolo e compito si assuma le sue
responsabilità. Noi giornalisti siamo costretti per Legge a farlo, i magistrati
hanno sempre detto e fatto quello che volevano, anche se adesso finalmente
grazie alla riforma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2015, n. 52, vi
è la nuova Legge 27 febbraio 2015, n. 18 sulla disciplina della responsabilità
civile dei magistrati. La “festa” è finita. Nessun cittadino italiano è un “unto
dal Signore”, e come è giusto che sia, chi sbaglia, ed a qualsiasi titolo e
ruolo, deve risponderne! Ebbene non esiste nè “qualcuno”, nè “qualcun
altro”, ma solo un solo giornalista e cioè il sottoscritto che ha avuto il
coraggio di scrivere quello che non solo pensa, ma quello che ha scoperto
“documentalmente”, e che metterà a disposizione dell’Autorità competente
preposta, che non è sicuramente la Procura della Repubblica di Taranto.
Concludendo, le ricordo anche una “stranezza” o meglio una “leggerezza”. Quella
di andare a trovare in redazione “per solidarietà” l’anno scorso un
gruppo di giornalisti soci di una Cooperativa editrice fallita (come lei sa, la
liquidazione coatta è una procedura del diritto fallimentare) mettendo in dubbio
la dovuta equidistanza della Procura della Repubblica nei confronti di qualcuno
che potrebbe rischiare la denuncia penale e bancarotta fraudolenta, se il
curatore attenendosi ai suoi doveri d’ufficio, e soprattutto se la Guardia di
Finanza che come ha sempre fatto nella stragrande maggioranza dei casi ,
dovessero fare qualche ulteriore controllo e ravvedere delle responsabilità
penali…Infine le confesso che mi piacerebbe video-intervistarla e farle tante
domande. Anche scomode. Ma ho forti dubbi che lei accetterà. In ogni caso
l’invito è pubblico, aspetto una sua risposta. Cordialmente.
FOTOVOLTAICO VS FOSSILE: QUALE ENERGIA PER IL
FUTURO?
Fotovoltaico, è davvero più sostenibile
del gas? La richiesta di
energia elettrica aumenta sempre di più nel mondo. Ogni paese si trova ad
affrontare un quesito: costerà di più generare corrente con centrali a gas o con
centrali solari fotovoltaiche? Report ha cercato di fare un raffronto tra le due
tecnologie, analizzando tutti i costi sia dal punto economico che quello di
ricaduta ambientale, dalla sabbia alla cella, dal giacimento alla centrale, fino
allo smaltimento e trattamento per il riutilizzo.
L’anticipazione dell’inchiesta di Report in onda domenica alle 21.45 su Rai3 -
di Roberto Pozzan /Corriere TV. La conferenza sul clima di Parigi vuole arrivare
a un risultato semplice, cioè diminuire le emissioni di gas serra. Il problema è
che l’obiettivo deve essere raggiunto in un mondo in cui cresce esponenzialmente
il consumo di energia, e in cui chi tradizionalmente ne ha il monopolio fa di
tutto per non perdere quote di mercato. La “guerra” tra fossili e rinnovabili è
una realtà, ambigua nel suo manifestarsi con istanze di ordine estetico,
burocratico ma anche scientifico. I detrattori delle rinnovabili da sempre
sostengono che per costruire centrali solari fotovoltaiche, e quindi per
costruire i pannelli, sia necessario un consumo di energia fossile tale da
renderle antieconomiche e addirittura più impattanti di quelle tradizionali.
Questo punto di vista che aveva un fondamento fino a qualche decennio fa ha
ancora senso? L’inchiesta di Report paragona la generazione elettrica da gas con
quella da fotovoltaico, per arrivare a conclusioni che fanno ben sperare per il
futuro del clima. La realtà tecnologica e scientifica risulta evidente e sta
dunque alla politica decidere i tempi della transizione.
PUNTATA DEL 13/12/2015: A TUTTO SOLE? Di
Roberto Pozzan. La
richiesta di energia elettrica aumenta sempre di più nel mondo. Ogni paese si
trova ad affrontare un quesito: costerà di più generare corrente con centrali a
gas o con centrali solari fotovoltaiche? Report ha cercato di fare un raffronto
tra le due tecnologie, analizzando tutti i costi sia dal punto economico che
quello di ricaduta ambientale, dalla sabbia alla cella, dal giacimento alla
centrale, fino allo smaltimento e trattamento per il riutilizzo.
“A TUTTO SOLE?” Di Roberto Pozzan.
MILENA GABANELLI IN STUDIO Guardiamo al futuro, a
Parigi per 10 giorni i grandi della terra hanno discusso su come ridurre il
drammatico riscaldamento globale, dovuto all’inquinamento causa il consumo di
combustibile fossile, l’alternativa elettricità prodotta da fonte rinnovabile,
ora per esempio noi siamo così sicuri che un pannello fotovoltaico impatta di
meno, solo perché è una lastra su un tetto.
STEFANO PEDONE - ENERGEKO Questa city car percorre
circa 130 chilometri con una carica.
ROBERTO POZZAN In quanto tempo si ricarica?
STEFANO PEDONE - ENERGEKO Si ricarica in 5 ore,
cinque ore e mezzo al massimo.
ROBERTO POZZAN Posso caricarla a casa?
STEFANO PEDONE - ENERGEKO La possiamo caricare
ovunque.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO È facile! Come caricare
un telefonino.
ROBERTO POZZAN Quanti kw/h ci vogliono per
caricare completamente le batterie?
STEFANO PEDONE - ENERGEKO Ci vogliono circa, per
una city car come questa, 10 kw/h.
ROBERTO POZZAN E quindi quanto mi costa?
STEFANO PEDONE - ENERGEKO Costa tra un euro e
cinquanta e 2 euro. Questo è quanto. Andiamo a spendere per avere i nostri
130-140 chilometri.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Se pagassimo sotto
forma di benzina, dovremmo spendere almeno 14 euro.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Nel dipartimento di
scienza e meccanica della Brooks University di Oxford si fa ricerca per la
Formula Uno, ma anche su tanti altri aspetti legati alla transizione energetica.
ROBERTO POZZAN L’energia del futuro quale sarà?
MARCO RAUGEI - OXFORD BROOKS UNIVERSITY È
l’elettricità. Perché l’elettricità è un vettore energetico molto versatile, ci
si può fare di tutto, è molto pulita al momento in cui la si usa e si presta
agli usi più disparati.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Questa elettricità
bisognerà produrla. Capire quale fonte tra gas e fotovoltaico avrà un minore
impatto economico e ambientale è il tema. I ricercatori usano un parametro che
si chiama “Eroi”.
NICOLA ARMAROLI - CNR Che rappresenta il rapporto
tra l’energia che io effettivamente ottengo netta dalla mia sorgente rispetto a
quella che ho speso per ottenerla. Più questo rapporto è alto, più questa fonte
energetica ha valore.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO In questo calcolo è
cruciale considerare il tempo di vita di un pannello. Se producesse per un solo
giorno, sarebbe solo un danno ambientale. Per questo all’Enea testano la durata
e la resa dei pannelli commerciali. ROBERTO POZZAN L’efficienza massima a cui si
arriva adesso, qual è?
FRANCESCO DE LIA - ENEA Il modo più efficiente
presente sul mercato è una efficienza circa del 22%, 21-22%.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Se moltiplichiamo la
produzione elettrica per gli anni di vita del pannello, sapremmo quanto c’ha
reso rispetto a quanto si è inquinato per costruirlo.
MARIO TUCCI - ENEA Questa, ad esempio, è una cella
fotovoltaica in silicio monocristallino ad efficienza del 20%. ROBERTO POZZAN
Mammamia. E questa nasce da questo...?
MARIO TUCCI - ENEA Esattamente, nasce da questo
materiale, che è appunto un buffer di silicio, che parte da un oggetto del
genere che poi viene affettato e appunto per realizzare degli oggetti
estremamente sottili. Ed è chiaro poi che il costo definisce anche la
tecnologia. Se io ho molti soldi a disposizione, riesco ad arrivare anche a
efficienze del 25%.
ROBERTO POZZAN Cioè, in Italia, il costo di un
megawattora prodotto con il gas o prodotto con il fotovoltaico, sono
comparabili?
GIAMPIERO CELATA - DIRETTORE TECNOLOGIE
ENERGETICHE ENEA Il costo del fotovoltaico oramai possiamo dire che siamo
sull’ordine dello 15 centesimi, 0,15 euro per kilowattora.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Con il gas invece, oggi
c’è chi riesce a produrre anche a 6 centesimi di euro a kilowattora. Ma
rivoluzionando il sistema produttivo, anche il prezzo del fotovoltaico si può
abbassare di molto. Lo ha già fatto questa ditta italiana.
FRANCO TRAVERSO - MEGACELL Questo è il pannello
solare fotovoltaico finito, bifacciale, quindi costituito da due lastre di vetro
e dalla cella interna che è bifacciale. Questa ne fa sul fronte 280 e poi sul
retro ne fa altri 70. Quindi produce molta più energia, okay, con lo stesso
materiale, con gli stessi componenti. Viene a costare oggi sui 35 euro a
megawattora e arriverà nel giro di pochi anni, quindi al 2018, sotto i 20, 25
euro a megawattora.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Che rapportato al
kilowattora, vuol dire 2 centesimi e mezzo.
FRANCO TRAVERSO - MEGACELL Con questa tecnologia
stiamo montando, ad esempio in Cile, la prima centrale al mondo bifacciale, da
2,5 megawatt, la più grande in assoluto. È una svolta epocale.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Dal punto di vista
ambientale, anche il fotovoltaico ha il suo impatto. Produrre pannelli a sua
volta richiede molta energia. Cominciamo con la materia prima. Il silicio.
L’impatto è basso perché dopo l’ossigeno, è l’elemento più abbondante sulla
crosta terrestre. È l’elemento base della sabbia, che per diventare silicio
commerciale dovrà essere scaldato in una fornace tra elettrodi di carbonio. Il
processo richiede temperature superiori ai 1900 gradi e quindi inquina. Si
ottengono blocchi che poi dovranno essere purificati per diventare celle
fotovoltaiche. Poi, sono necessari altri passaggi chimico-fisici che hanno
bisogno di altra energia. Alla fine si otterrà il cosiddetto lingotto, che va
affettato e squadrato.
FRANCO TRAVERSO - MEGACELL A questo punto la fetta
di silicio è pronta per essere processata e la facciamo diventare cella
fotovoltaica.
ROBERTO POZZAN Quante celle producete qui?
FRANCO TRAVERSO - MEGACELL Noi produciamo 1,5
milioni di fette di silicio al mese. Dal punto di vista tecnologico, siamo i
primi al mondo a fare questa produzione di serie perché dalla stessa fetta di
silicio che io le ho mostrato, lei riesce a ottenere il 25% o più di energia
solo per il fatto sul retro di questa fetta di silicio si genereranno cariche
elettriche come sul fronte.
ROBERTO POZZAN Il costo di un pannello dell’80,
’81...
FRANCO TRAVERSO - MEGACELL Faccia conto rispetto
ad adesso almeno sette volte tanto.
ROBERTO POZZAN E quanto produceva?
FRANCO TRAVERSO - MEGACELL Direi meno della metà.
Il fotovoltaico oggi non lo ferma più nessuno, a prescindere dal prezzo del
petrolio.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Ma l’energia necessaria
a costruire questi pannelli in media in quanto tempo verrà restituita dagli
stessi pannelli?
MARCO RAUGEI - OXFORD BROOKS UNIVERSITY L’energia
necessaria consumata dai processi di produzione viene restituita nell’arco di un
paio di anni. I successivi venti o trenta anni di produzione di energia
elettrica sono diciamo un rendimento netto positivo.
ROBERTO POZZAN Da un punto di vista ambientale...
MARCO RAUGEI - OXFORD BROOKS UNIVERSITY Nel caso
di un impianto fotovoltaico le emissioni di Co2 sono almeno un ordine di
grandezza ovvero sia almeno dieci volte più basse rispetto a quelle di un
impianto a gas naturale, ad esempio.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Teniamo presente che
molte strutture del gas, già le abbiamo costruite, con i danni ambientali
connessi. E sarebbe uno spreco non sfruttarle. Vediamo ora il famoso “Eroi”,
cioè il rapporto tra energia prodotta rispetto a quello che ho speso per
ottenerla, per i nuovi giacimenti, che oramai vengono trovati solo nelle
profondità marine. Sono necessari immagini satellitari, che diano le coordinate
a navi che poi effettueranno una lunga serie di test geologici e riscontri
sismici, fatti con i tristemente noti “airgun”. Servono apparecchiature,
macchinari, navi, costruite e fatte lavorare ovviamente consumando energia, per
produrre la quale verrà immessa in atmosfera anidride carbonica oltre ai gravi
squilibri ambientali causati dagli stessi test. Il danno alla vita marina dei
riscontri sismici può essere molto alto, come dimostrano, secondo alcuni
biologi, gli spiaggiamenti dei capodogli sulle spiagge del Gargano. Accertata la
presenza degli idrocarburi si passa alle trivellazioni. Raggiunto il giacimento,
si dovrà costruire una piattaforma per estrarlo e questo metano dovrà subire
processi di deumidificazione e desolforazione senza contare il fatto che essendo
un gas serra almeno 21 volte più potente della anidride carbonica ed essendo
provato che statisticamente nell’atmosfera finirà tra il 2% e il 7% della
produzione, il contributo al riscaldamento globale sarà drammatico! Poi ci sarà
bisogno di stoccaggio e costruzione di metanodotti con centrali di compressione
che lo spingano verso i luoghi di consumo attraverso percorsi che possono essere
lunghi migliaia di chilometri.
NICOLA BATTILANA - DIRETTORE TECNICO SNAM RETE GAS
I principali gasdotti di rete nazionale, poi tutti i gasdotti della rete
regionale, e sommati arrivano a superare abbondantemente i 32mila chilometri.
ROBERTO POZZAN Quanto costa un chilometro di
metanodotto?
NICOLA BATTILANA - DIRETTORE TECNICO SNAM RETE GAS
I costi variano da, non so, 300mila euro per i diametri più piccoli a chilometro
fino a quasi 3 milioni per quelli che sono i diametri più grandi, quindi abbiamo
una variabilità molto elevata.
ROBERTO POZZAN C’è un’idea di quanto incida questo
sul prezzo del gas?
NICOLA BATTILANA - DIRETTORE TECNICO SNAM RETE GAS
Trasporto più stoccaggio circa il 5% e lì dentro c’è tutto.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Solo un 5%, che però
anno dopo anno peserà sull’intero ciclo di vita del metanodotto.
MARCO RAUGEI - OXFORD BROOKS UNIVERSITY Se noi
volgiamo elettricità come dicevamo prima, l’unico metodo possibile è bruciare
questo gas in una caldaia, sostanzialmente; due terzi dell’energia compresa in
questo combustibile fossile, come il gas naturale all’inizio, viene dispersa
nell’ambiente come calore e solo un terzo viene alla fine recuperato come
energia elettrica che poi viene immessa in rete e utilizzata.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO C’è da dire che le
centrali a ciclo combinato sono le meno impattanti perché l’elettricità viene
prodotta da turbine che girano bruciando il gas come nei jet degli aerei e
producono enormi quantità di vapore, che mette in moto un’altra turbina che a
sua volta genera elettricità, arrivando a efficienze che superano il 50%.
L’impatto ambientale è basso anche perché il consumo d’acqua è minimo.
MASSIMILIANO TORO - DIRETTORE CENTRALE SORGENIA
Con l’acqua piovana c’andiamo avanti quasi tutto l’anno e io una volta che ho
visto questa centrale mi chiedo perché non impongano a tutti di fare una cosa
del genere che è un vantaggio ambientale, ma un vantaggio anche economico.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Perché l’acqua che
raffredda le turbine a gas e alimenta quella a vapore, non viene sprecata, ma
riutilizzata.
MASSIMILIANO TORO - DIRETTORE CENTRALE SORGENIA
Questa tubazione che parte con un diametro di 8 metri e si sviluppa per più di
100 metri raccogliamo nuovamente l’acqua e l’acqua viene con delle pompe
rilanciata nei generatori di vapore. ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO A Enea ci hanno
detto che in media megawattora fotovoltaico oggi costa 150 euro, ma con i
pannelli di ultima generazione si può scendere anche a 40 euro.
ROBERTO POZZAN E quanto costa un megawattora
prodotto da voi?
MASSIMILIANO TORO - DIRETTORE CENTRALE SORGENIA In
questo momento il prezzo del gas è più basso chiaramente il costo di produzione
è più contenuto diciamo all’incirca sui 60 euro megawattora.
ROBERTO POZZAN 60 euro megawattora.
MASSIMILIANO TORO - DIRETTORE CENTRALE SORGENIA
55/60 euro megawattora, però è volatile in funzione del prezzo del gas. ROBERTO
POZZAN Cioè se il prezzo del gas raddoppiasse quanto aumenterebbe?
MASSIMILIANO TORO - DIRETTORE CENTRALE SORGENIA
Quasi del doppio.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Gli 800 Megawatt di
potenza di questa centrale corrispondono teoricamente a più di 5 chilometri
quadrati di pannelli fotovoltaici. Un’estensione difficile da reperire in
Italia. C’è da aggiungere che con il sistema elettrico attuale, sostituire
centrali come questa con il fotovoltaico, porterebbe a squilibri per ora non
gestibili dalla rete. Si potrebbe causare un blackout.
MARCO RAUGEI - OXFORD BROOKS UNIVERSITY
Specialmente, non so ad esempio d’inverno la sera quando gli utenti accendono
tutti i loro elettrodomestici in casa, le luci ecc. Nel caso delle centrali
convenzionali posso, entro certi limiti, mandare la centrale a pieno regime. Nel
caso delle fonti rinnovabili questo non è direttamente possibile.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO Quindi ad oggi, il
prezzo del megawattora fra rinnovabili e gas è simile. Ma questo prezzo spesso
non comprende le emissioni di Co2 che per il gas sono quasi 10 volte superiori a
quelle del fotovoltaico a parità di energia prodotta. Né i danni causati
dall’uso di una fonte inquinante. Spese sanitarie per malattie, spese causate da
disastri climatici e, addirittura, spese per mantenere l’apparato militare
impiegato a difesa dei siti e dei percorsi sensibili dell’energia. I Marò
prigionieri in India, per esempio, stavano lì per proteggere le rotte del
petrolio. Ma il costo della vicenda lo paga lo stato italiano e non le grandi
compagnie petrolifere. Se fossero loro a pagare probabilmente riverserebbero i
costi nel prezzo del combustibile. Magari fino a renderlo anti economico. E poi,
finito il ciclo di produzione, quanto impatta riciclare i manufatti del gas
rispetto ai pannelli?
NICOLA ARMAROLI - CNR Per quanto riguarda i gas,
tipicamente i gasdotti di solito, quando non si utilizzano più vengono lasciati
lì, d’altra parte si tratta di manufatti in acciaio che insomma si sbriciolano.
ROBERTO POZZAN Quanto costa riciclare un pannello?
GIUSEPPE ZILIANI - SEA ECOSERVIZI Tra gli 80 ai
120 euro a tonnellata. Consideriamo che una tonnellata stanno tra i 50 e i 55
pannelli.
ROBERTO POZZAN E quanta energia consumate in
questo processo?
GIUSEPPE ZILIANI - SEA ECOSERVIZI Circa 1,1
kilowatt per ogni pannello.
ROBERTO POZZAN FUORI CAMPO La cornice d’alluminio
e le connessioni in rame si recuperano facilmente. Il vetro viene levigato e
recuperato. Quello che resta, passando in un mulino torna a essere silicio,
polimeri plastici e metalli pronti a essere venduti come materie prime.
ROBERTO POZZAN Ma secondo lei c’è il rischio che
questi pannelli finiscano in discarica?
GIUSEPPE ZILIANI - SEA ECOSERVIZI A mio modo di
vedere, è difficile perché i materiali di cui sono composti sono tutti materiali
che hanno un consistente valore.
MILENA GABANELLI IN STUDIO Allora un altro paio di
cifre così ci forniscono il quadro completo. Secondo gli studi
internazionalmente riconosciuti nel 2013 i combustibili fossili hanno goduto di
stanziamento pubblico per 550 miliardi di dollari, contro i 128 stanziati per le
rinnovabili. Non è una differenza da poco, poi non decolla uno si chiede.
Guardiamo invece l’occupazione: allora per il settore del gas ogni gigawattora
di gas produce 0.2 posti di lavoro, mentre da rinnovabili ed efficienza
energetica 1 posto di lavoro per gigawattora, cioè cinque volte tanto. E’ chiaro
a tutti che la direzione sarà quella lì, quella della conversione
all’elettricità fonte rinnovabile però per la transizione ci vuole l’intervento
politico, cioè servono prestiti agevolati e poi regole chiare e credibili che
durino nel tempo perché se cambiano ogni volta che c’è un rimpasto, ogni volta
che cambia un ministro nessuno investe più.
In questa inchiesta, però, non si dice che con il
fotovoltaico l’impatto ambientale dal punto di vista estetico deturpa l’ambiente
con una distesa di specchi. Oltretutto, quella distesa di silicio distrugge la
silvicoltura e l’agricoltura.
LA BUFALA DELL’INQUINAMENTO.
Smascherate le balle dei verdi Lo smog ha
smesso di crescere. I dati smentiscono gli allarmisti:
da 3 anni il livello di gas serra nell’atmosfera è stabile. Non esiste alcun
rischio imminente legato all’inquinamento, scrive il 7 luglio 2017 Francesco
Rigatelli su "Libero Quotidiano". Tra gli ospiti più autorevoli del convegno
"L’agenda per il clima e l’energia negli scenari globali in cambiamento",
organizzato ieri all’Università degli Studi di Milano da Francesco Rutelli in
qualità di presidente del Centro per un futuro sostenibile, reminescenza del suo
impegno verde, c’è il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia,
l’organismo con sede a Parigi che cerca di armonizzare le politiche sul tema dei
vari Paesi. Quando Fatih Birol prende la parola smentisce una serie di luoghi
comuni con tabelle alla mano. Una è quella che riproduciamo qui a fianco,
secondo cui negli ultimi tre anni le emissioni globali di anidride carbonica si
sarebbero stabilizzate. Un’altra è che «contrariamente a quanto generalmente si
pensi, gli Stati Uniti e la Cina sono i Paesi che negli ultimi anni hanno più
diminuito l’inquinamento». Nessun rischio imminente, dunque, anche se «bisogna
continuare la riduzione della Co2, tra i gas serra responsabili del
surriscaldamento climatico, e qualsiasi altra ricetta rispetto alla diminuzione
di 2 gradi della temperatura globale è pericolosa», chiarisce Birol. Già, ma
come? «Le auto elettriche sono specchietti per le allodole, il vero problema
sono i riscaldamenti delle case, le industrie e i camion che trasportano merci».
Dunque, via libera alle classiche auto. Accanto alla crescita d’importanza del
gas naturale rispetto al petrolio vanno incoraggiate poi le energie rinnovabili,
«ma bisogna migliorarne l’immagazzinamento e la rete per trasmetterle,
altrimenti se ne rischia la dissipazione». Tra i tanti interventi autorevoli,
Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri, porta il caso della sua azienda
che ha firmato con General Electric un accordo per rispettare le nuove pratiche
ambientali. L’ex ambasciatore e ora pure presidente dell’Ispi esprime anche
preoccupazione per il disimpegno di Trump dagli accordi di Parigi sul clima,
dimostrandosi al contempo fiducioso che la Storia faccia lo stesso il suo corso.
Li Ruiyu, ambasciatore cinese a Roma, in dialogo con Simona Bonafè, parlamentare
europea del Pd specializzata sul tema, spiega in proposito la posizione della
Repubblica Popolare: «Viviamo un rapporto diplomatico con gli Stati Uniti che
tende a complicarsi, ma l’atteggiamento della Cina vuole essere pragmatico senza
interesse per i cambiamenti di linea degli altri Paesi. Così continuiamo a
onorare gli accordi di Parigi, ricordiamo che gli Stati Uniti hanno contribuito
per il 29% all’inquinamento attuale e la Cina per l’8%, ma stiamo attenti a non
compiere in futuro gli errori fatti dall’Occidente». E se il politologo Alberto
Martinelli contestualizza il tema nel multipolarismo, soprattutto nella
confusione globale, e nel tempo dei «nazionalpopulismi», Antonio Navarra,
presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici esprime «la
necessità di dati credibili per costruire scenari attendibili. Servono
investimenti responsabili in tal senso». Proprio l’Università degli Studi di
Milano ha appena lanciato un nuovo dipartimento interdisciplinare, caso unico in
Italia, per studiare il tema. Contrariamente a quanto generalmente si pensi, gli
Stati Uniti e la Cina sono i Paesi che negli ultimi anni hanno più diminuito le
emissioni di anidride carbonica.
Filippo Facci, tanto allarme per l'inquinamento
che però è calato, scrive il 22 Ottobre 2017 su "Libero Quotidiano". La polizia
brancola nello smog: siamo già alla "nube tossica", come scriveva ieri LaPresse
(tra altri) e come se fossimo a una post-Chernobil, o più banalmente a Pechino.
Ma non si tratta, ora, di scrivere il solito articolo genere "e che sarà mai"
solo perché pure quest' anno è arrivato ottobre con la nebbia e lo smog, si
tratta solo, ogni tanto, di guardare anche a un bicchiere che è mezzo vuoto:
della nebbia e dello smog che non ci sono più. Negli ultimi anni, infatti, sono
calati incredibilmente: un buon motivo per abbassare la guardia? Ma neanche per
idea: un motivo, però, per non incedere in sparate e allarmismi da morte
imminente o da sterile caccia al colpevole. In questi giorni siamo tutti a
strascico della "foto choc dallo spazio" pubblicata dall' astronauta Paolo
Nespoli, dove si vede la Pianura Padana coperta da una coltre bianca che tutti
hanno titolato come smog ("dal Piemonte al Friuli") anche se poi, nei resoconti
più onesti, scopri essere nebbia con una percentuale di smog che resta
un'incognita. Ma se queste sono cazzatelle, gli allarmi da film horror lanciati
dalla giunta grillina di Torino («non aprite porte e finestre») hanno
frastornato molti cittadini e sancito che tra i comuni italiani regna l'anarchia
più assoluta, tanto che persino un torinese come Sergio Chiamparino, ieri, l'ha
presa sul ridere: «Io apro le finestre, vado in bici e vado a correre». Ma il
ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, sempre ieri, già rideva meno: «Nel
protocollo scientifico che abbiamo sottoscritto col Piemonte, la misura di
chiudere porte e finestre non esiste». Che cosa esiste, dunque? I dati.
Tanti dati. Nella storica Lombardia, per esempio,
siamo passati dai 300 ug/m3 di pm 10 degli anni Settanta ai meno di 100 attuali
(dati Arpa, unico ente titolato alle rilevazioni) e in sostanza, a Milano come a
Torino, cinquant' anni fa l'inquinamento dell'aria era tre o quattro volte
maggiore di oggi, tempo in cui lo smog è comunque migliorato soprattutto perché
è progressivamente sparita l'anidride solforosa, quella che dava una tonalità
rosacea all' aria e che provocava le piogge acide. Un' auto euro5, oggi, emette
venti volte meno inquinanti di una vecchia euro0. I riscaldamenti a carbone sono
scomparsi, quelli a gasolio sono stati perlopiù sostituiti dal metano (o gpl) e
le fabbriche si sono spostate fuori dalle città o, purtroppo, all' estero.
Infatti il vero problema dello smog di una volta, oggi, ce l'hanno i cinesi, che
non vanno neanche più in bicicletta. Per il resto - e sono cose risapute, o
meglio che dovrebbero esserlo - a produrre polveri sottili non c' è solo il
traffico o il riscaldamento, ma i cantieri edili, cose come il sale
antighiaccio, moltissimo l'agricoltura (le arature, i fertilizzanti azotati, i
letami, i liquami) e persino i mezzi elettrici, che producono pm10 per il
rotolamento delle gomme o delle ruote d' acciaio sulle rotaie. E c' è
soprattutto la natura, visto che certe zone di pianura - come la Padana, ma
anche la Valdarno fiorentina - hanno la particolarità di concentrare e non
lasciar dissipare gli inquinanti. Pioggia e vento, come scriveva l'esperto
Jacopo Giliberto sul Sole24 Ore, sono toccasana che la Pianura Padana non ha.
Però, ecco, la Pianura Padana ha il vento di scirocco che porta le sabbie
sahariane: quando arriva quello, i livelli delle polveri salgono da paura. Ecco
perché, mentre a Torino gli inesperti grillini fanno chiudere porte e finestre
(forse per la micro-criminalità imperante) gli amministratori più collaudati,
ormai, si sono arresi anche all' inutilità dei blocchi del traffico, che,
soprattutto in un giorno o due, non influenzano in alcun modo i livelli delle
polveri. Insomma, moltissimo è stato fatto, moltissimo si potrebbe fare e
moltissimo si deve fare: anche senza gli assurdi limiti imposti dalla Comunità
Europea che continua a distribuire sanzioni a tutti. L' Italia ha comunque
emissioni inferiori a molti altri paesi: la concentrazione di polveri è sì
aumentata dal 2005 al 2009, ma poi ha ripreso costantemente a calare nonostante
il grosso delle emissioni venga dal riscaldamento: quello che molti, al Nord,
non hanno ancora acceso. Il traffico, in rapporto, inquina molto meno: ma l'uso
dell'auto è in calo, e i ridicoli limiti di velocità chiesti per motivi (anche)
ambientali farebbero solo inquinare di più; le rilevazioni hanno evidenziato che
un limite di 30 all' ora in città - chiesto per esempio da molti ciclisti -
farebbe aumentare le emissioni perché costringerebbe a usare marce più basse e a
consumare più carburante. Il successo del bike sharing (quello serio, non quello
gratuito) e dei mezzi pubblici efficienti, tra altre cose, è ciò che a Milano ha
scoraggiato l'uso dell'auto. Ogni giorno, nella "capitale morale", la sola Linea
2 della metropolitana trasporta circa 550mila persone, quando l'intero Molise ha
314mila abitanti. E Milano, di linee, ne ha quattro. Filippo Facci
La bufala del grande inquinamento.
Negli ultimi 14 anni l'aria a Milano è stata molto
meno pulita di oggi. Il blocco è servito solo a peggiorarla, scrive Chiara
Campo Sabato 02/01/2016 su “Il Giornale”. Contrordine, l'aria di Milano non è
più da bollino rosso. Dopo una settimana di allarmi e polemiche, nell'ultimo
giorno del 2015 i livelli delle polveri sottili sono tornati tra i 32 e 36
microgrammi al metro cubo (la soglia di allarme è fissata a 50). Il Comune ha
provveduto a diramare una nota per sostenere che «anche i tre giorni di blocco
del traffico» hanno contribuito al risultato: «Per la prima volta dopo 35 giorni
il Pm10 è sceso sotto i limiti di legge». Un tentativo maldestro di giustificare
lo stop ai motori: dopo il primo giorno l'aria in città era persino peggiorata,
un flop. E il bollettino sulla qualità dell'aria di Arpa Lombardia certifica che
nella città governata dalla giunta ambientalista di Giuliano Pisapia il Pm10 nel
2015 è stato «fuorilegge» per 101 giorni, quasi uno su tre. E tre volte tanto
quei 35 giorni che la normativa europea fissa come tetto massimo degli
sforamenti in un anno intero. Il 2014 (particolarmente piovoso) le polveri sono
state off limits per 68 giorni, l'anno prima 81. Ma andando indietro nel tempo,
quello che oggi i Verdi definiscono «un annus horribilis» è stato persino tra i
migliori dal 2002 ad oggi. I giorni da bollino rosso, a parte l'eccezione del
2010 (con 84) sono stati sempre stati più numerosi. Tredici anni fa si arrivò al
picco di 163, nel 2004 scesero a 134 poi di nuovo su a 148 nel 2006 e due anni
dopo già a 110. A conferma, come ha ribadito più volte nelle ultime settimane il
presidente della Regione Lombardia, che «i provvedimenti estemporanei non
servono nulla», siano blocchi auto, domeniche a piedi o targhe alterne. Il
termometro dello smog dal 2002 ad oggi dimostra che le «performance» sono legate
alla situazione meteo e alle condizioni geografiche e climatiche sfavorevoli in
cui si trova la Pianura Padana. Servono piuttosto dei provvedimenti strutturali,
come il rinnovo dei mezzi pubblici più inquinanti. «Tutto quello che potevo fare
come sindaco l'ho fatto - ha sostenuto ieri Pisapia -, e ben prima che
intervenisse il governo» con il piano antismog presentato dal ministro
dell'Ambiente Gian Luca Galletti prima di capodanno a governatori e sindaci
dell'Anci. In quattro anni è mezzo, è invece la lettura dell'ex vicesindaco di
Milano Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d'Italia, «la giunta Pisapia
non ha adottato alcun provvedimento veramente efficace. Area C (il ticket
d'ingresso da 5 euro per entrare in centro con l'auto) serve solo a fare cassa».
Paradossalmente, le polveri sottili registrate dalle centraline dell'Arpa
collocate in Area C hanno sempre valori superiori rispetto alle altre zone della
città. E «il calo delle polveri di queste ore è dovuto solo al cambio del meteo,
non certo di un blocco del traffico che ha causato solo danni e disagi a
cittadini e commercianti».
Blocco auto dannoso «Prima dello stop
l'aria era più pulita». I
dati dell'agenzia per l'ambiente Maroni attacca: «Misura inutile» Il Comune:
«Aspettiamo domani», scrive Maria sorbi Mercoledì 30/12/2015 su “Il Giornale”.
Mettiamola così: i pranzi no stop di Natale e Santo Stefano hanno avuto più
effetti sullo smog del blocco del traffico. La pigrizia post panettone ha
fermato più auto. Dal 25 al 27 dicembre si sono registrate meno polveri sottili
rispetto a lunedì, primo giorno delle limitazioni anti polveri sottili. A
confermare i dati sono i tecnici dell'Arpa: «Il blocco del traffico non è stato
sufficiente - spiega Silvia Bellinzona, direttore del settore monitoraggi
ambientali - I dati migliori sono stati registrati nei giorni precedenti. Tra
l'altro nel primo giorno di blocco abbiamo registrato un andamento delle polveri
differente nei vari Comuni. E non sempre i livelli migliori sono stati misurati
nelle città che hanno effettuato il blocco auto». Milano compresa. Ma il sindaco
Giuliano Pisapia non perde la speranza e cerca di mettere una pezza
sull'evidente fallimento del provvedimento. «Valutazioni più puntuali andranno
ovviamente fatte a conclusione delle tre giornate di limitazione del traffico
stabilite dall'ordinanza - si legge in una nota del Comune, diffusa per prendere
tempo - La misura è stata già utile a contenere i livelli di inquinanti
nell'aria in una fase di alta pressione». «Milano senz'auto, ma le polveri
aumentano» twitta il presidente lombardo Roberto Maroni dopo aver letto i dati
delle centraline anti smog: «È la conferma che i blocchi estemporanei non
servono». Lo stesso commento arriva da più parti politiche. Il coordinatore
regionale di Forza Italia Mariastella Gelmini rileva: «Il blocco non è servito a
nulla. Anche Renzi è costretto ad ammettere che non sono le automobili il nemico
da combattere». «Le politiche di riduzione dell'inquinamento - commenta Nicolò
Mardegan, lista civica Noixmilano - sono da costruire con cura, prevenendo
situazioni di emergenza». Non risparmia parole forti contro il sindaco il leader
leghista Matteo Salvini: «La trovata di quell'ignorante di Pisapia è servita
solo a rovinare la giornata a migliaia di persone che lavorano. Perché il Pm10 a
Milano, dopo una giornata senza circolazione delle auto, è persino aumentato al
contrario di quanto accaduto a Monza che non ha adottato misure del genere e
dove comunque il Pm10 è diminuito». A fargli eco sono gli esponenti leghisti in
Regione Lombardia: «Per combattere l'emergenza occorrono interventi strutturali
- spiega il capogruppo Massimiliano Romeo - non certamente quelli messi in campo
dalla sinistra, che sulla questione sta facendo solo un'operazione di propaganda
mediatica». Oggi la Regione Lombardia, durante l'incontro a Roma con il ministro
all'Ambiente Gianluca Galletti, chiederà contributi di 2 miliardi di euro in
cinque anni per attuare politiche ambientali più incisive: a cominciare da
un'azione comune a tutte le Regioni della pianura padana.
Ecco la verità sullo smog,
scrive Nicola Porro su "Il Giornale" del 29 dicembre 2015. La
mini polemica tra il sindaco Pisapia e Beppe Grillo su smog e alberi tagliati a
Milano, conforta la tesi dello storico Robert Conquest: «Tutti sono di destra
nelle cose di cui si intendono». Pisapia sembra un pericoloso conservatore
quando ricorda al leader dei Cinque stelle che sì, a Milano, sono stati tagliati
circa cinquecento alberi, ma per far posto ad una verde metropolitana. Entrambi,
vittime dell’integralismo ambientale, sbagliano però il bersaglio. Non è certo
che questo inquinamento sia così mortale come lo dipingono (tra poco lo vedremo)
ma è sicuro che nulla ha a che vedere con il mito della deforestazione. In
Italia si realizza, i sorrisi si evitino please, un censimento pubblico degli
alberi. Ebbene non è mai esistita una stagione (in migliaia di anni dicono gli
esperti) con un maggior numero di foreste. Vi sembra grossa? Anche a chi scrive,
ma è così: abbiamo 210 alberi pro capite. Negli ultimi dieci anni, mentre ci
raccontavano del consumo del suolo e piripi piripa, in Italia abbiamo piantumato
quasi fossimo dei maniaci di Hay Day. Ecco i numeri totali: nel 2005 avevamo
10,4 milioni ettari di bosco (circa un terzo della nostra superficie); dieci
anni dopo l’estensione è salita ad 11 milioni. Il che vuol dire 600mila ettari
di boschi in più. Nella sola Lombardia si sono sviluppati 26mila ettari di
boschi e foreste aggiuntivi. Tra un po’ gli alberi diventeranno come i cinghiali
in Maremma: un discreto fastidio per gli abitanti del luogo. La relazione tra
deforestazione ed inquinamento non funziona più. Anzi, a voler essere polemici
essa si sarebbe invertita: più alberi uguale più inquinamento. Tocca inventarne
un’altra. E la tendenza riguarda l’intero continente. L’Europa (la fonte questa
volta è Forest.org) dal 1990 al 2015 ha piantumato come una pazza. La superficie
boschiva è cresciuta di 17,5 milioni di ettari, per intendersi è come dire che
in Europa nell’ultimo quarto di secolo è nato un bosco grande come tutto il
Friuli Venezia Giulia ogni anno. Piogge acide (ve le ricordate?) permettendo.
Come la mettiamo allora con i 68mila morti in più dell’Italia che si
registreranno nel 2015? E di cui i politici illuminati si fanno un gran cruccio.
Per Grillo rischiano di essere legati proprio all’inquinamento. Anche l’Oms
parla di record di «morti premature», causa smog. Partiamo da una piccola
considerazione: quella dei morti è l’unica statistica che si riesce a fare con
precisione prima della fine del periodo di osservazione. Ma prendiamoli pure per
buoni. Nel 2015 ci potrebbero essere più morti (lo ricordava anche Silvio
Garattini) grazie alla chimica. Ma non quella inquinante: quella buona. Grazie
alla quale siamo tra le popolazioni più longeve del mondo. Si arriva ad un punto
in cui però tocca morire: non più a 70 anni, ma in media per le donne in Italia
a 84 anni. Questa media si è spostata in avanti e ciò corrisponde ad un effetto
statistico semplice: bassa mortalità ieri, recupero oggi. Garattini addirittura
ci ricorda come la folle campagna antivaccini (tra cui quelli influenzali
soprattutto per i più anziani) stia determinando una piccola, ma pericolosa,
epidemia nelle fasce di popolazione più a rischio. Riguardo all’Oms e ai suoi
morti non bisogna aggiungere molto a quanto scritto da Umberto Veronesi: «Morti
premature è un termine ambiguo su cui sono scettici molti scienziati. Tumori al
polmone e malattie cardiovascolari riconducibili in qualche modo all’aria che
respiriamo sono in diminuzione». Avanti con la prossima frottola ambientalista.
Ps. Per favore considerate la vostra responsabilità ambientale prima di non
stampare questo articolo. Se potete, stampatelo su un bel foglio di carta A4,
alimenterete così l’industria cartaia, di cui l’Italia era un’eccellenza,
contribuirete a generare posti di lavoro e al taglio degli alberi in eccesso.
Clima, Zichichi su Parigi: “previsioni
inattendibili a 15 giorni, figuriamoci a 10 anni. Le
vere emergenze sono altre”. Clima, anche Antonino Zichichi tra gli scettici sui
cambiamenti climatici: in un’intervista al Giornale un punto di vista molto
interessante, scrive il
5 dicembre 2015 12:51 Peppe
Caridi su "Meteo web".
Antonio Zichichi,
Presidente della World federation of scientist (federazione degli scienziati
mondiali), parla della Conferenza sul Clima in atto a Parigi e lo fa ai
microfoni di Nicola
Porro che intitola l’intervista su “Il
Giornale” in edicola oggi “La
bufala ambientale”. Le parole dello scienziato affermato in tutto il
mondo sono molto forti ed evidenziano tutte le contraddizioni del mondo
scientifico e politico sul clima e sui cambiamenti climatici.
“Per descrivere
in modo matematicamente rigoroso l’evoluzione del clima – spiega
Zichichi – sono
necessarie tre equazioni differenziali non lineari fortemente accoppiate.
Differenziali vuol dire che è necessario descrivere l’evoluzione istante per
istante nello spazio e nel tempo (nel dove e nel quando). Non lineari vuol dire
che l’evoluzione dipende anche da se stessa. Esempio: il mio futuro dipende
anche da me stesso. Fortemente accoppiate vuol dire che l’evoluzione descritta
da ciascuna equazione ha enormi effetti anche sulle altre. Questo sistema di tre
equazioni non ha soluzione analitica; il che vuol dire nessuno riuscirà mai a
scrivere l’equazione dell’evoluzione del clima. L’unica strada è costruire
modelli ad hoc. Un modello matematico non è la verità scientifica, ma
l’equivalente del dire che “E’ così perchè l’ho detto io”; non a parole, ma
scrivendo formule che obbediscono a ciò che io penso sia la soluzione”.
Rispondendo alle domande del noto giornalista e conduttore TV, Zichichi
chiarisce: “Le
sto dicendo che le previsioni hanno senso solo a breve termine. Quelle sul tempo
di domattina hanno margini di errori bassissimi, quelle tra 15 giorni sono
inattendibili. Si figuri una previsione sul clima a 10 anni. Quello che funziona
bene è il cosiddetto now casting; lo abbiamo scoperto noi con un progetto pilota
della Wfs in Cina studiando il fiume Giallo che causava migliaia di morti per le
previsioni alungo termine che davano troppo spesso falsi allarmismi. La gente
ignorava gli allarmi restando a casa. Fino a quando noi abbiamo introdotto le
previsioni a breve termine: “now casting”. Ecco perchè il presidente Den Ziao
Ping mi ricevette a Pechino come fossi un capo di Stato e mi disse che avrebbe
sostenuto l’istituzione di un laboratorio mondiale per la scienza senza segreti
e senza frontiere come facciamo al Cern e a Erice nel Centro di Cultura
Scientifica che porta il nome dei pupillo di Fermi, Ettore Majorana. Io mi
limito a dire che ci sono 72 emergenze planetarie che a differenza di quelle
climatiche sono verificabili, certe, scientificamente provabili. Una di queste
ad esempio, e sbugiarda l’oggi, è l’acqua. Servirebbero molte risorse per
renderla disponibile e pulita per milioni di persone come ha ricordato Papa
Francesco”. In conclusione, Zichichi afferma:
“Si facciano leggi
che puniscano severamente l’inquinamento senza confondere i veleni con le
problematiche climatologiche, come sono CO2 ed effetto serra. Bisogna
demonizzare i veleni che vengono impunemente versati nell’atmosfera. L’anidride
carbonica (CO2) è cibo per le piante. Se nell’atmosfera non ci fosse stata CO2
non sarebbe nata la vita vegetale. E siccome la vita animale viene dopo quella
vegetale, noi non saremmo qui. L’effetto serra non è un nostro nemico. Se non ci
fosse l’effetto serra la temperatura di questo satellite del sole sarebbe 18°C
sottozero. L’effetto serra ci regala 33°C“.
Il guru Zichichi smonta le eco-balle:
clima e smog, cosa sta succedendo, scrive il 29
dicembre 2015 “Libero Quotidiano”. "Proibiamo di immettere veleni nell'aria con
leggi draconiane" ma ricordiamoci che "l'effetto serra è un altro paio di
maniche, e noi umani c'entriamo poco. Sfido i climatologi a dimostrarmi che tra
cento anni la Terrà sarà surriscaldata. La storia del climate change è
un'opinione, un modello matematico che pretende di dimostrare l'indimostrabile".
Antonio Zichichi, 85 anni, in una intervista a Il Mattino avverte: "Noi
studiosi possiamo dire a stento che tempo farà tra quindici giorni, figuriamoci
tra cento anni". E poi si chiede Zichichi: "In nome di quale ragione si pretende
di descrivere i futuri scenari della Terra e le terapie per salvarla, se ancora
i meccanismi che sorreggono il motore climatico sono inconoscibili?
Divinazioni". Lo scienziato spiega che "per dire che tempo farà tra molti anni,
dovremmo potere descrivere l'evoluzione del tempo istante per istante sia nello
spazio che nel tempo. Ma questa evoluzione si nutre anche di cambiamenti
prodotti dall'evoluzione stessa. È un sistema a tre equazioni che non ha
soluzione analitica". Quindi perché molti scienziati concordano sul
riscaldamento globale? "Perché hanno costruito modelli matematici buoni alla
bisogna. Ricorrono a troppi parametri liberi, arbitrari. Alterano i calcoli con
delle supposizioni per fare in modo che i risultati diano loro ragione. Ma il
metodo scientifico è un'altra cosa". E "occorre distinguere nettamente
tra cambio climatico e inquinamento. L'inquinamento esiste, è dannoso, e chiama
in causa l'operato dell'uomo. Ma attribuire alla responsabilità umana il
surriscaldamento globale è un'enormità senza alcun fondamento: puro inquinamento
culturale. L'azione dell'uomo incide sul clima per non più del dieci per cento.
Al novanta per cento, il cambiamento climatico è governato da fenomeni naturali
dei quali a oggi gli scienziati, come dicevo, non conoscono e non possono
conoscere le possibili evoluzioni future. Ma io sono ottimista".
RISCALDAMENTO GLOBALE PER MANO DELL’UOMO? LA
PIU’ GRANDE MENZOGNA.
Mi sono chiesto quali interessi ci fossero, oltre
l’evidente fanatismo ideologico, dietro questa (per molti) potente menzogna.
Oggi iniziamo a dare qualche piccola risposta.
Speculazioni
sul clima, ora anche le assicurazioni ci marciano.
Per ora sono state le compagnie americane ad aver preso al balzo il martellante
allarmismo nei confronti degli eventi atmosferici. Il clima cambia? Ebbene anche
le polizze aumentano, scrive Luca Angelini il
28 Dicembre 2009.L'equazione
clima più caldo, uragani più violenti non fa una grinza, almeno per le compagnie
assicurative americane. Ma c'è da giurarci che anche quelle nostrane tra non
molto, vista anche la recente ricorrenza di nubifragi, troveranno il modo per
ritoccare al rialzo le polizze riguardanti le calamità naturali (spesso in
verità escluse dagli indennizzi). Tutto è partito dalla messa a punto di un
particolare modello matematico che elabora dati e variabili riferite anche ai
cambiamenti climatici e che stila previsioni a medio termine della possibile
incidenza degli eventi catastrofici quali uragani, inondazioni o tornado. Il
modello ha individuato le aree più a rischio e stilato una lista delle località
nere, per la maggior parte situate lungo la costa orientale degli Stati Uniti.
In queste zone i premi assicurativi relativi a beni mobili e immobili sono
dunque più che raddoppiati. Naturalmente le compagnie assicurative hanno colto
la palla al balzo e in molti casi sono stati messi in atto veri e propri abusi
ai danni di famiglie che, già subissate dal grave problema del caro-mutui, non è
più in grado di sostenere le cifre richieste. Morale, i settori indicati quali
zone a rischio, si stanno velocemente spopolando. Caso eclatante riportato sul
Wall Street Journal quello di una infermiera di Cape Cod, località sita nel
Massachusset e classificata zona ad alto rischio. Nonostante dal lontano 1991
non si siano più verificati uragani, le polizze hanno subìto un'impennata
insostenibile costringendo la malcapitata a vendere forzatamente la propria
casa. Sul suo triste esempio anche numerosi abitanti della zona sono stati
costretti a porre in atto l'estremo rimedio. Una frenata al grande sistema
arriva proprio da colei che ha messo a punto tale modello, ossia tale Karen
Clark. L'economista americana afferma che gli esiti dei modelli vanno utilizzati
solo quando offrono risposte certe e inequivocabili e non qualora si basino solo
su dati aleatori o statistici, ivi compreso il dubbio impatto dei cambiamenti
climatici, tutt'altro che verificato, provato e dimostrato.
Allarmisti o negazionisti, questo è il
dilemma, scrive Anna Benedetti su “La Repubblica" il
27 gennaio 2010. Dal libro di Stefano Caserini A qualcuno piace caldo. Errori e
leggende sul clima che cambia, che, come quello di Visconti, offre una
necessaria e razionale discussione su quello che realmente sta accadendo sul
nostro pianeta, e sulle sue cause ho scelto le seguenti righe. Pag. 11 - pag.
279 «Questo libro non è un trattato sulla climatologia del pianeta, scritto per
spiegare lo stato della conoscenza scientifica sui cambiamenti climatici o sulle
azioni intraprese a livello internazionale per contrastarli. Non vuole esserlo.
Non è neppure un libro sulle azioni piccole e grandi da intraprendere per dare
il proprio contributo quotidiano per limitare le emissioni di gas climalteranti.
Il libro vuole provare a spiegare il problema dei cambiamenti climatici a
partire da chi sostiene che il problema non ci sia, cercando di capire se le
affermazioni a volte clamorose dei negazionisti climatici reggono il confronto
con l'approfondimento scientifico. (...) Come hanno trattato il tema dei
cambiamenti climatici i mezzi di comunicazione italiani? Sono stati allarmisti?
Sono stati negazionisti? A guardare i titoli dei giornali e delle trasmissioni
televisive negli ultimi anni si direbbe entrambe le cose. Da una parte i
sensazionalismi per gli sconvolgimenti del clima, da fare sembrare imminente la
fine del mondo. Dall' altra i titoli sulla bufala dell'effetto serra, sulla
favola della terra più calda, e così via».
Siracusa, 22 aprile
2009. (Adnkronos) - "Non voglio entrare nella polemica, ma tra il negazionismo e
le posizioni allarmistiche di chi dice che tra dieci anni il Polo Nord si
scioglierà, ci sono posizioni più equilibrate. Ecco perchè il ruolo
dell'informazione nella lotta ai cambiamenti climatici è strategico". Lo ha
detto il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, nel corso della
conferenza stampa al termine dell'incontro con le Ong prima dell'apertura del G8
di Siracusa.
Clima, Margherita Hack: allarmismo
eccessivo, scrive il
22
agosto 2009 Peppe Caridi su "L'Ansa".
Sui cambiamenti climatici, Margherita Hack è convinta che “ci sia un allarmismo
eccessivo”. Parlando alla platea di Cortina incontra, l’astrofisica ha
sottolineato che “è certo, però, che è per via dei gas serra che la temperatura
aumenta. Un po’ come quello che succede in una macchina lasciata al sole”. Sui
provvedimenti da prendere per frenare il surriscaldamento del pianeta, Hack ha
sostenuto l’incremento dell’uso delle energie alternative: “ora che si aggiunge
il contributo di Cina e India, noi non possiamo pretendere di essere gli unici a
vivere bene e lasciar gli altri a morir di fame – ha rilevato -. Bisogna usare
di più solare ed eolico, e iniziare a pensare che il nucleare oggi è molto più
sicuro”. “Rimane da risolvere il problema delle scorie – ha concluso – ma si
stanno facendo passi avanti”.
Che tempo farà. Falsi allarmismi e
menzogne sul clima il libro di Cascioli Riccardo; Gaspari
Antonio anno 2008.
Mentre da più parti si levano prepotenti le voci dei nuovi "profeti di sventura"
della climatologia, una breve storia di tale disciplina - recente e passata -
mette in luce le mille domande sul clima che ancora attendono risposta. Secondo
gli autori, le pretese di verità accampate dai movimenti ambientalisti, che nel
nome della salvezza del pianeta prefigurano scenari apocalittici, altro non sono
che tecniche di marketing per favorire gli interessi speculativi di grandi
gruppi economici. Le testimonianze, i documenti e gli studi statistici qui
raccolti mostrano che le previsioni di surriscaldamento della terra sono
inattendibili. Fondate sulle manipolazioni dei pochi dati scientifici certi,
queste false teorie fanno del mutamento del clima un "mito" creato a tavolino,
con l'unico scopo di spargere timori infondati e di sostenere, di riflesso, il
business dell'energia rinnovabile. Un'inchiesta approfondita che racconta i
casi, sfata i pregiudizi e denuncia i falsi allarmismi.
Clima e
allarmismi: a qualcuno piace caldo.
Dati preoccupanti e minacce di catastrofismi. Cosa si
nasconde dietro il nuovo rapporto sulla Co2, pubblicato a pochi giorni da un
nuovo summit sul clima? Ne parliamo con il meteorologo Guido Guidi. Intervista
di Maria Acqua Simi su “Il Giornale del Popolo” del 16.09.2014.
La scorsa settimana, un rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale
(OMM) ha lanciato un nuovo allarme: i gas a effetto serra avrebbero raggiunto
concentrazioni record nel 2013, con conseguenze importanti sull’atmosfera e gli
oceani. Come commentare questi dati? Lo abbiamo chiesto a Guido
Guidi, meteorologo e blogger (climatemonitor.it). «Cominciamo
con l’osservare una cosa semplice: il report è stato pubblicato a pochi giorni
dall’inizio dell’ennesima riunione dei Paesi che fanno parte dell’IPCC (il panel
intergovernativo dell’ONU sui cambiamenti climatici), che si troveranno da
settimana prossima a New York per cercare di trovare un accordo sulla riduzione
delle emissioni. Essendo l’OMM una delle braccia dell’IPCC, esso ha tutto
l’interesse a far alzare il livello di attenzione su questi argomenti in
prossimità di questo incontro. Incontro che, tra l’altro, non nasce sotto buoni
auspici, perché sembra che alcuni leader delle Nazioni più importanti non
saranno presenti e manderanno invece degli sherpa».
Il
rapporto dell’OMM sulla concentrazione di Co2 è però piuttosto allarmante:
sarebbe la prima volta in assoluto, infatti, che si assiste a un aumento così
forte nell’arco di un anno.
«A
dire il vero questo report non dice nulla di nuovo. È palese che la
concentrazione di anidride carbonica continua ad aumentare malgrado tutto.
Malgrado gli sforzi più o meno proattivi di alcune Nazioni per ridurre le
emissioni; malgrado siano stati presi accordi (che molti Stati non hanno
mai implementato); malgrado il fatto che la crisi finanziaria prima e economica
poi è stata l’unica ragione vera per cui tra il 2008 e il 2009 si è visto un
rallentamento delle emissioni. Altri rallentamenti dovuti a sforzi di
de-carbonizzazione non se ne sono visti. E dunque la concentrazione continua ad
aumentare con un rateo costante. Leggendo il report, sono però rimasto perplesso
dal fatto che si sia data molta enfasi all’alto livello di concentrazione (che è
certo importante) tacendo però completamente un altro dato decisamente
importante: da oltre 15 anni – e nonostante le emissioni di Co2 continuino ad
aumentare – la temperatura media superficiale del pianeta non cresce più. Ormai
siamo a un rateo assente. E questo è ormai evidente a tutti e provato da
numerose ricerche recenti. Un’ampia fetta del mondo della ricerca si sta
interrogando sul perché di questo fatto, ma ovviamente nel report dell’OMM non
se ne trova traccia. La Co2 aumenta, la temperatura no. Siamo di fronte a una
variabile naturale? Presumibile. È qualche cosa che indica che il sistema
ambientale è meno sensibile all’aumento della Co2 di quanto si immaginasse? È
un’ipotesi. Il calore piuttosto che essere disperso nell’atmosfera viene
assorbito dagli Oceani? Altra ipotesi. Sono tutte domande a cui al momento non
siamo in grado di rispondere. E di questa incertezza dovremmo tener conto».
Quindi la
temperatura non sta più aumentando? Ma non doveva essere questa la madre di
tutte le tragedie prospettate nell’arco degli ultimi anni?
«Intendiamoci:
è fuor di dubbio che nelle ultime tre decadi del secolo scorso la temperatura
media del pianeta è aumentata. Ed è aumentata un bel po’. Oggi però non è più
così. E allora ci si deve chiedere il perché. La comunità scientifica deve
indagare nuovi elementi nel sistema. I modelli di simulazione che abbiamo
adottato finora – modelli che ipotizzavano diversi livelli di aumento della Co2
– proiettavano aumenti della temperatura. Ma la realtà li ha sconfessati: in
barba alle simulazioni, negli ultimi 15 anni l’aumento non c’è stato. Questo
significa che nel sistema ci deve essere qualcosa che ci sfugge, di non banale,
per cui il sistema ambientale non risponde come noi ci aspettavamo».
In pratica,
abbiamo sbagliato i calcoli...
«Esatto.
E questo perché c’è ancora tantissimo da scoprire. Qual è la fonte unica e
primaria di energia di tutto il sistema? Una sola: il sole. E noi delle
dinamiche solari sappiamo pochissimo. Certo è, però, che c’è una componente
importante della comunità scientifica che pensa – sulla base delle simulazioni –
che la continua emissione di Co2 in atmosfera possa portare il sistema ad agire
in modo diverso da come ha sempre agito. Ma è davvero così? Oggi si parla di
cambiamenti climatici ma il clima è sempre cambiato. Il punto è se l’evoluzione
futura del clima possa dipendere da cause diverse da quelle che hanno sempre
generato cambiamenti climatici».
Quindi in poche
parole, i dati del report sono giusti, gli allarmismi invece no.
«Quel
report non fa una piega: le emissioni e la concentrazione aumentano. Ma
emissioni e concentrazione sono legati da dinamiche molto complesse che noi
ancora non conosciamo bene. Costruire scenari, quindi, è un compito non solo
difficile ma forse anche sbagliato. In tutto ciò, la posizione delle istituzioni
sovranazionali che si occupano di queste cose è chiara: il clima sta cambiando
per effetto delle attività umane, tra queste le emissioni e quindi bisogna
ridurle. Viene sostenuta una posizione acquisita. Ma questo non significa che
sia scientificamente provata. E c’è anche un’altra cosa da tenere in
considerazione: tutto il movimento – anche scientifico – ha beneficiato in modo
enorme di tutta l’attenzione che si sta dando a questa problematica. E per
attenzione si intende fondi per la ricerca, posizioni, rendite di posizione. A
pensar male si fa peccato.»
Cambiamento climatico, in Italia è già
realtà. Il riscaldamento della Terra non è
un’opinione: è un fatto accertato. Le cui conseguenze sono sotto i nostri occhi,
anche nel nostro Paese. Da nord a sud, siamo andati a vedere che cosa sta
succedendo. Mentre a Parigi si è aperto il summit COP21 sul futuro del pianeta,
scrive Fabrizio Gatti il 30
novembre 2015 su “L’Espresso”. C'era una volta l'autunno. Sulle Alpi i
ghiacciai erano
bianchi di freddo. La nebbia nascondeva alla vista i fiumi e le prime brinate
indurivano la pianura. C’era una volta, sì. Un mondo al passato. Perché anche il
2015 conferma che
quell’autunno non esiste più. I ghiacciai sono colate nere a
rischio d’estinzione. La campagna è un prato verde colorato di fiori appena
sbocciati. Germogliano i noccioli a un mese da Natale. E in cima al Muro
di Sormano, la faticosa salita del Giro d’Italia che fu, il sole
riscalda i visitatori con una temperatura da maniche corte: 22 gradi a oltre
millecento metri di quota, ma è il 18 novembre. Perfino Gastone,
focoso maschio di anatra muschiata, non sembra badare più al calendario. La
stagione dell’accoppiamento è finita da mesi. Lui e la femmina immobilizzata
sotto il suo becco, però, se la spassano con vigore sull’aia della Cascina
Sguazzarina, deliziosa fattoria che ospita scolaresche e
famiglie a Castel
Goffredo, in provincia di Mantova. Se potesse parlare alla XXI
Conferenza sul cambiamento climatico, convocata dalle Nazioni
unite domenica
29 novembre a Parigi
per obbligare gli Stati a provvedimenti concreti, il baldanzoso papero direbbe
sicuramente che per lui il riscaldamento globale va bene così com’è. Eppure se
ci fermiamo a guardarlo da vicino, in Italia il paesaggio è già inesorabilmente
cambiato. Solo trent’anni fa, il bisnonno di Gastone avrebbe
aspettato aprile. Allora non si andava in “calore”
con l’inverno alle porte. Era una contraddizione: sia per le regole di madre
natura sia per i centigradi del termometro. Eccoci in viaggio nelle follie di
questo ennesimo
autunno in corsa per essere tra i più caldi della storia. Più
del record 2014, secondo un andamento che dal 1992 registra temperature annuali
sempre al di sopra della media del trentennio 1961-1990, scelto come periodo di
riferimento.
Floriano Lenatti, 55
anni, è tra le guide alpine più famose in
Valmalenco, in Lombardia. Per diciannove anni ha gestito il
rifugio “Marco
e Rosa” a 3.609 metri nel massiccio del Bernina. E si ricorda
bene quando il caldo ha cominciato a inseguire la neve sui monti: «Nel 1987, gli
stessi giorni di luglio durante l’alluvione in Valtellina, abbiamo visto per la
prima volta piovere a 3.600 metri. Prima dell’87, quando cambiava il tempo
d’estate, non era mai piovuto sul rifugio “Marco e Rosa”. Magari tempestava e
poi subito cadeva la neve. Da allora lo zero termico va sempre più in alto,
sopra i quattromila. E piove. Quest’anno è piovuto parecchio. È stata un’estate
molto calda anche in quota, come quella record del 2003».
L’alluvione in
Valtellina e in Valmalenco del 1987 è il primo di una serie di eventi estremi
che in Italia annunciano il nuovo corso climatico: lo zero
termico per giorni a
più di quattromila metri, piogge torrenziali dai ghiacciai giù fino in valle, 53
morti, migliaia di sfollati. Da allora i ghiacciai non sono più guariti. Dopo un
decennio di progressiva espansione, riprende proprio in quell’anno la loro
rapida ritirata. Anche lo Scerscen inferiore
ai piedi del Bernina, dove trent’anni fa si ritrovavano le squadre di sci ad
allenarsi in agosto, ha lasciato spazio a sentieri di pietre e roccia. Non lo si
vede da quaggiù, nel ripido fondovalle. Lo nasconde una parete oltre i tremila
metri completamente senza neve. Saliamo la mattina presto con il fotografo
Simone Donati. La meta è un altro ghiacciaio: il Ventina,
sul versante opposto, ai piedi del monte Disgrazia. I ghiacciai sono il
termometro che dimostra il riscaldamento climatico. Fabrizio Gatti è salito in
quota sui ghiacciai della Brenva e del Miage sul Monte Bianco e sul ghiacciaio
Ventina in Lombardia. In questo video racconta la letterale evaporazione di
queste importanti riserve d'acqua, ma anche la riconquista della vegetazione e
la presenza di insetti e farfalle a novembre inoltrato là dove un tempo cadeva
la neve. La sua espansione massima l’ha raggiunta diciottomila anni fa. Di quel
periodo glaciale, il Ventina e gli altri ghiacciai del
Disgrazia hanno
lasciato un souvenir a pochi chilometri da Monza, il Sasso
di Guidino, gigantesco masso erratico che si può ancora ammirare
a Besana
Brianza. Nel frattempo, il ghiaccio si è ritirato di oltre
centotrenta chilometri. Oggi si arriva comodi in auto a Chiareggio,
l’ultimo paese della Valmalenco, dove da autunno a primavera il sole resta basso
dietro le montagne. Nonostante l’ombra permanente, l’ora del mattino e i 1.600
metri di quota, il 16 novembre la giornata comincia con 6 gradi. Non c’è un solo
cristallo di brina sull’erba. L’acqua scorre abbondante nei torrenti. Il Ventina
ci attende a due ore e mezzo di cammino. Ma il cartello è forse precedente al
2014, perché dopo la netta ritirata degli ultimi due anni, serve un’altra
mezz’ora tra i massi instabili della morena per mettere i piedi sul ghiaccio. Il riscaldamento
globale e la sua
recente accelerazione li si potrebbero misurare in
passi. Dal 1910 fino al 1941 sarebbe bastata poco più di un’ora
per toccare il ghiacciaio. E chi si è arrampicato fin qui nel 1980 ricorda che
trentacinque anni fa ci volevano due ore a piedi, non di più. Una parete
bianca e azzurra, spezzata dai seracchi, si affacciava su questa
splendida valle che il “Servizio glaciologico lombardo” ha trasformato, con
segnali e cartelli, in museo
a cielo aperto. Adesso dall’Alpe Ventina, a circa 1.500 metri,
la fronte avanzata del ghiacciaio non si vede più. Si è ritirata dietro un
avvallamento. Tra l’erba secca del pianoro spuntano invece le
primule. Una rana va a ripararsi sotto un sasso. Controluce
sull’acqua del ruscello volano sciami di moscerini, mosche e piccole farfalle.
Potrebbe essere primavera.
Non c’è in giro nessuno
nel raggio di chilometri. E quassù. a quota 2.500, il Ventina è
evaporato. Si è sgonfiato e in trentacinque anni è arretrato di centinaia di
metri. Ma più che l’arretramento, colpiscono la perdita di volume su tutta la
sua lunghezza e il colore
nero della superficie, sotto il millimetrico strato di neve.
All’inizio del pomeriggio, nonostante il sole non abbia mai illuminato il
versante precario del sentiero, la temperatura è di
molto sopra lo zero. Il termometro appoggiato su un sasso
oscilla tra gli 8 e i 9 gradi e dalla pancia sotto il ghiaccio risale il
fragore dell’acqua
che, pur con l’inverno meteorologico alle porte, continua a scorrere abbondante.
Al tramonto torniamo ai 13 gradi del fondovalle. Ora Floriano
Lenatti gestisce
d’estate il rifugio “Gerli
Porro” ai piedi del ghiacciaio e di questo lento addio è un
silenzioso testimone: «Dai rilievi del Servizio glaciologico lombardo,
nell’ultimo anno il
Ventina si è ritirato di altri 55 metri e abbassato di 5. Un record senza
precedenti. Il fatto che ora il ghiacciaio sia nero, significa che è andata via
tutta la copertura nevosa. E ogni metro di ghiaccio richiede almeno dieci metri
di neve fresca per riformarsi». Lasciamo la Valmalenco e il Monte
Bianco ci accoglie
con i 16 gradi di una mattina piena di sole a Courmayeur,
1.224 metri, martedì 17 novembre. Stessa temperatura alla base del
ghiacciaio della Brenva. È l’immensa colata candida immortalata
in tutte le fotografie della
vetta più alta. Anche se candida non è più. Sotto i 3.800 il ghiaccio senza neve
è grigio. Più giù, è completamente nero. I ghiacciai adesso sono due. Dieci anni
fa il ripido collegamento con il bacino di alimentazione si è interrotto. E la
lingua a fondovalle ai piedi del santuario
di Notre-Dame de Guérison è
diventata un ghiacciaio fossile. Se le temperature non caleranno, nel giro di
qualche decennio scomparirà. Intanto arretra estate dopo estate. Così come si
sgonfia, anno dopo anno, il Miage,
il più grande ghiacciaio nero del Bianco e di tutte le Alpi. Dal bordo della
morena, che segna il suo spessore massimo, il salto verticale ormai è di una
trentina di metri. Ma il ghiaccio non si vede. Guardando su, fino in quota, è
sepolto da metri di pietre e massi. L’acqua di fusione se ne va verso
l’Adriatico. Le rocce restano. Arretra lo zero termico, avanza la vegetazione.
Anche ai bordi dei ghiacciai i larici,
un tempo umili piante alte non più di quaranta centimetri, diventano alberi. È
la riscossa del bosco. Come a Pian del Tivano, provincia di Como, mille metri di
quota oltre l’arrampicata ciclistica del Muro di Sormano, dove da diversi giorni
a metà novembre il
termometro supera i 20 gradi. Noccioli e betulle hanno occupato
le piste da sci. Gli impianti
di risalita fermi da
venticinque anni sono reperti archeologici del clima che fu. Tra le capre di un
recinto accanto alla biglietteria dello skilift, una gallina ha appena concluso
la cova e ora porta a spasso una manciata di pulcini.
Diego Monti, 48
anni, proprietario della baita “La
Colma”, si ricorda quando ogni pomeriggio almeno quindici
pullman salivano dalla Brianza per portare i bambini alla scuola di sci. «Nel
febbraio 2014», racconta, «in una notte ha messo giù 70 centimetri di neve. Poi
ha cominciato a piovere e in quattro giorni s’è sciolta tutta. La neve a volte
arriva ancora. Quello che manca è il freddo per conservarla». Sotto la stazione
di Brignole a Genova uno sbarramento di cemento armato impedisce il deflusso
delle piene del torrente Bisagno. Ancora oggi, a distanza di un anno dall'ultimo
disastro nulla è cambiato. In questo video Fabrizio Gatti scende con una
telecamera dove il corso d'acqua è stato coperto, proprio sotto la città. E
racconta come, nonostante la pulizia del letto, lo sbarramento del Bisagno
costituisca tuttora un grave pericolo per Genova. Ma con il riscaldamento
climatico e la cementificazione degli argini, aumentano le alluvioni anche lungo
i fiumi della pianura Padana. Mentre, durante la forte burrasca del 21 novembre
2015 in Toscana, il mare supera le scogliere e invade le strade. Un prato ancora
pieno di fiori fuori stagione e oltre il piccolo ponte sul canale, ecco la Cascina
Sguazzarina nella
campagna di Castel
Goffredo. Come tutte le fattorie della pianura Padana, anche
questa ha la sua popolazione di mosche e zanzare. Il
gelo serviva da regolatore. Più faceva freddo d’inverno, meno
larve e parassiti si risvegliavano in primavera. Ora che la temperatura media è
aumentata, gli insetti e non solo il papero Gastone si sentono più
arzilli. «Quando avevo dieci anni», ricorda Giacomo
Pedretti, 44 anni, agricoltore, «pattinavamo sui canali
ghiacciati. Oggi è raro vedere gli alberi bianchi di brina». L’agricoltura
deve per forza adattarsi: «In questa zona si arava in autunno,
poi pioveva e si lasciava che il gelo rompesse le zolle», spiega Pedretti
davanti alla sua fattoria didattica: «Adesso si ara dieci giorni prima della
semina, perché se lo facciamo in autunno le zolle si riempiono d’acqua e, senza
gelo, restano inzuppate fino in primavera. Questa è un’area ricca d’acqua. Ma in
quarant’anni la campagna non si era mai allagata. Negli ultimi tre anni, è
successo due volte». Nel bosco accanto al recinto degli animali, gli alberi si
avvicinano all’inverno con nuovi germogli e foglie ancora verdi. Stesso
paesaggio alla riserva
Wwf “Le Bine”, sul fiume Oglio al confine tra le province di
Cremona e Mantova. Il caldo ha portato qui una libellula che
prima abitava soltanto nel Sud Italia e in Africa. E l’argine, tra il fiume e la
palude, profuma di artemisia appena
cresciuta. Anche se oggi, 19 novembre, gli steli dovrebbero essere già secchi da
un pezzo.
Francesco Cecere, 48
anni, responsabile della riserva, mostra i fiori appena spuntati sui rami di
nocciolo. «Uno studio su venticinque anni di temperatura alle Bine», spiega,
«dimostra un aumento della media delle massime nei mesi caldi. È cambiata anche
la distribuzione delle piogge,
ora più concentrata in alcuni periodi. E anche le alluvioni,
che fino a vent’anni fa avevano un periodo di ritorno di circa dieci anni: oggi
si ripetono con frequenza di due o tre anni intervallate da secche più lunghe.
Ma non è detto che le alluvioni dipendano solo dal clima. Spesso si dà colpa al
riscaldamento, per far passare gli errori dell’uomo». È probabilmente il caso di Genova,
dove con i 18 gradi del 20 novembre è ancora primavera. Le ruspe lavorano da
mesi alla pulizia del torrente Bisagno dopo la serie di tragiche piene. La
principale causa che blocca l’acqua però è sempre lì: la ridotta altezza
disponibile dove il corso è stato interrato, proprio sotto viale Brigate
partigiane, dalla stazione di Brignole alla Foce. Non sembra esistano
alternative: o si riapre il torrente o ci si prepara a futuri disastri. A fine
settimana, scende da Nord la prima vera perturbazione. Nel porto di Livorno i
pescatori rinforzano gli ormeggi. Sabato 21 novembre, temperatura dell’aria e
dell’acqua sono uguali: 18 gradi. Ma le raffiche di vento toccano i cento
all’ora. «Sì, sono irriconoscibili anche le stagioni
del mare», ammette Michele
Vitiello, 40 anni, comandante del peschereccio “Anastasia”: «Il
Tirreno è ancora caldo. Orate e calamari che in autunno si avvicinavano alla
costa, restano più a lungo in profondità. È cambiata anche la rapidità con cui
arriva il brutto tempo. Ora bastano poche ore e ti trovi con una
burrasca addosso».
L’ultima tappa riporta a Milano.
Piove sull’Autostrada del Sole. Dopo Piacenza l’orizzonte buio è rischiarato dai
fulmini di un temporale. Mancano poche ore a domenica 22 novembre e sembra una
notte di fine
luglio.
I mutamenti climatici cambiano il mondo:
L'Italia sarà tropicale. Le coltivazioni tradizionali
sostituite da frutta esotica. Mentre gli ulivi arrivano fino alla Valtellina. E
le zanzare portano malattie africane. Ecco come l’aumento delle temperature sta
già modificando flora e fauna del nostro Paese, scrivono Sandro Iannacone e
Simone Velesini il 30 novembre 2015
su “L’Espresso”. Banane di Sicilia, olio extravergine delle Alpi, pomodori
padani. Ma anche febbri tropicali, litorali scomparsi, stambecchi senza cibo.
I mutamenti climatici stanno cambiando i connotati dell’Italia e del mondo.
E minacciano di farlo ancora più significativamente nei decenni a venire: alla
vigilia della ventunesima Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni
Unite, da cui dovrebbe arrivare la firma del primo accordo
universale e vincolante sul clima, è ormai chiaro che il nostro paese è un hot
spot del cambiamento climatico, un luogo nel quale già oggi si registrano
pesanti influenze dell’aumento delle temperature su agricoltura, alimentazione,
salute, turismo. Ecco quello che sta già accadendo. Gli effetti dei
cambiamenti climatici sono particolarmente evidenti in Italia, perché il bacino
del Mediterraneo è una delle zone in cui il riscaldamento globale ha iniziato a
mostrarsi precocemente. A partire dall’800, la temperatura nel nostro paese è
salita in media di un decimo di grado ogni 10 anni, e negli ultimi decenni il
fenomeno si è velocizzato: l’Italia,
oggi, è di un grado più calda rispetto agli anni Sessanta. Nel
2014 si è segnato il record di sempre (1,45 gradi in più rispetto alla media) e
il 2015 sembra destinato a confermare il trend: il luglio appena trascorso è
stato infatti il più torrido della storia, con 3,6 gradi oltre la media di
questo decennio. Quando l’aumento di temperatura sarà stabilmente oltre
i due gradi in più rispetto
all’era pre-industriale, ammonisce l’Intergovernmental Panel on Climate Change
(Ipcc) delle Nazioni Unite, i cambiamenti climatici
potrebbero diventare
irreversibili.
Dengue e febbre
del West Nile sono
malattie comuni nelle zone tropicali, ma probabilmente dovremo farci l’abitudine
anche dalle nostre parti. Trasmesse da zanzare e altri insetti che prosperano
grazie al caldo, queste nuove patologie si stanno infatti radicando anche nel
nostro paese. Nel 2008 erano 12 i casi di dengue registrati in Italia, ma sono
aumentati velocemente passando a 51 nel 2010 e a 74 nel 2012. Simile la
situazione anche per la malattia neuroinvasiva da West Nile, originaria
dell’Africa Orientale: 8 casi nel 2008, saliti a 44 nel 2013. Anche le allergie si
fanno sempre più comuni a causa del global
warming, che ha allungato la stagione di fioritura di molte
piante, come la parietaria o
il
cipresso, aumentando da 10 a 100 volte la concentrazione dei
pollini nell’aria. «Il risultato», spiega Vincenzo
Patella, direttore della Task Force sui cambiamenti climatici
della Società italiana di allergologia, asma ed immunologia clinica, «è che
negli ultimi dieci anni il numero di allergici è raddoppiato: oggi sono il 20
per cento della popolazione italiana, e si prevede che diventino il 60 per cento
nel 2050». Anche l’asma è
sempre più frequente: i casi sono aumentati del 60 per cento rispetto agli anni
Ottanta, e le morti raddoppiate. Non è una critica alla politica nazionale, ma
una constatazione agricola. L’aumento delle temperature ha permesso infatti di
avviare la coltivazione
di frutti tropicali, un tempo assenti in Italia, e la Sicilia si
è rivelata particolarmente adatta per le banane, tanto che a Palermo ha oggi
sede il più grande produttore del paese. Ma non solo. Come spiega Stefano
Masini, responsabile dell’Area Ambiente di Coldiretti, è l’intero
paesaggio agricolo del
nostro paese ad essere mutato radicalmente. La coltura dellavite si
è spostata sempre più a nord: nei comuni di Morgez e La Salle, in Valle d’Aosta,
a circa 1.200 metri di quota, oggi si producono ad esempio i vini più alti
d’Europa. L’ulivo,
dal canto suo, ha raggiunto la Valtellina, mentre
pomodori da conserva e grano,
che prima si fermavano più o meno in Toscana, oggi sono coltivati con successo
in tutta la pianura Padana. Oltre a mutare la geografia delle colture, i
cambiamenti climatici stanno portando nei nostri campi
batteri e insetti
tropicali infestanti,
che trovano le temperature perfette per proliferare: come il punteruolo
rosso, un parassita delle palme di origine africana, e la
drosofila del ciliegio, originaria del continente americano. O
ancora la temuta Xilella fastidiosa,
che ha devastato gli ulivi del Salento anche grazie alle temperature
estremamente miti dello scorso inverno. «Nei prossimi decenni, l’impatto
sull’agricoltura italiana rischia di essere pesantissimo», spiega
Domenico Pignore dell’Istituto
di genetica vegetale del Cnr di Bari. Un buon esempio, aggiunge l’esperto, è il
grano, pianta simbolo della cultura italiana. «Le coltivazioni oggi si stanno
spostando progressivamente verso il nord, ma se non interverremo, nei
prossimi 50 anni il frumento rischia di sparire dalla
nostra penisola, con danni incalcolabili da un punto di vista culturale ed
economico». Abita i boschi e le pianure in quota delle Alpi, e per proteggersi
fa affidamento sulla sua pelliccia:
bianca in inverno, per
mimetizzarsi con la
neve, e bruno rossastra in estate, come le rocce e le piante tra cui si muove.
Con le stagioni ormai impazzite, l’ermellino si
trova però ad indossare sempre più spesso la pelliccia sbagliata quando si
sciolgono le nevi, in primavera, divenendo facile
bersaglio dei suoi
predatori. Un altro caso emblematico è quello dello stambecco:
le piante di cui si nutre germogliano anticipatamente, e sono povere di sostanze
nutritive fondamentali. La conseguenza è un forte
aumento della mortalità durante
lo svezzamento, passata dal 50 per cento degli anni Ottanta a più del 75 per
cento dei giorni nostri. Sono alcuni degli esempi contenuti nell’ultimo report
del Wwf, che evidenzia gli effetti nocivi dei cambiamenti
climatici sulla fauna italiana. Tra questi, i più evidenti sono la
diffusione di specie non autoctone, solitamente di origine
tropicale, come i pappagalli ormai
di casa nelle città del Centro-Sud, o le meduse che
sempre più spesso invadono le acque e le spiagge italiane. Come nel 2013, quando
un enorme banco di Pelagia
noctiluca, piccola medusa di colore violetto estremamente
urticante, ha letteralmente invaso le spiagge dell’Isola
d’Elba, mettendo in fuga i bagnanti e provocando diversi
ricoveri a causa delle sue punture. Riscaldamento globale vuol dire (anche) addio
ghiacciai. Un fenomeno cui l’Italia non è immune, come spiega Claudio
Smiraglia, professore di geografia fisica e geomorfologia
all’Università degli Studi di Milano e coautore del “Nuovo
catasto dei ghiacciai italiani”, il documento che raccoglie e
cataloga le informazioni relative ai sistemi glaciali del nostro paese: «Siamo
di fronte a un collasso: per tutti i ghiacciai dell’arco alpino, così come per i
due piccoli ghiacciai del Gran Sasso, si è registrato un regresso
del 30-33 per cento rispetto agli anni Sessanta». Poco più di
mezzo secolo fa, i ghiacciai delle Alpi si estendevano su 370 chilometri
quadrati, una superficie pari a quella del lago di Garda; a oggi se ne sono persi
oltre 160 chilometri quadrati, più o meno quanto il lago di
Como. «L’acqua dei ghiacciai», continua Smiraglia, «è passata dallo stato solido
allo stato liquido e poi non è stata sostituita, perché
le nevicate sono diventate sempre più rare». Un fenomeno che sta
modificando notevolmente la
biodiversità dell’orizzonte
alpino: la vegetazione - soprattutto aghifoglie e larici - sale sempre più di
quota, colonizzando gli spazi una volta occupati dai ghiacci e alterando gli
equilibri naturali dell’ecosistema. Invertire
la tendenza sembra molto difficile, se non impossibile: «Anche
se riuscissimo a stabilizzare le emissioni di gas serra», ammonisce Smiraglia,
«ci vorranno decenni prima che l’atmosfera reagisca di conseguenza. Nel
frattempo, probabilmente, la maggior parte dei ghiacciai italiani sarà
scomparsa: non resteranno che pochi lembi di ghiaccio, parzialmente coperti da
detriti, alle quote più alte».
Venezia, Versilia,
le saline
di Trapani, il cagliaritano:
sono solo alcune delle 33 zone che corrono il rischio di essere
allagate entro il 2100, a causa dell’innalzamento del livello
del Mediterraneo. A raccontarlo è uno studio di Fabrizio
Antonioli, del Centro Ricerche Casaccia dell’Enea, e le
previsioni dell’Ipcc, secondo cui le acque italiane si solleveranno di 50
centimetri nei
prossimi cento anni per effetto dei soli cambiamenti climatici. A questi andrà
sommato l’abbassamento
della superficie terrestre, per un aumento netto di quasi un
metro. Tutto perché, a causa delle temperature sempre più calde, le calotte
polari si sciolgono e riversano in mare aperto enormi masse d’acqua allo stato
liquido, che innalzano il livello degli oceani e mettono a repentaglio intere
zone costiere. Negli ultimi
cento anni, per effetto dei soli cambiamenti climatici (cioè al
netto di altri fattori, come il movimento della crosta terrestre), il livello
del mare è salito, nel mondo, di
quasi venti centimetri. Se dalle nostre parti le cose vanno
leggermente meglio (l’innalzamento registrato nel Mediterraneo è di tredici
centimetri e mezzo) è solo grazie all’“effetto
diga” esercitato dallo stretto di Gibilterra, ma c’è poco da
stare sereni: «I cambiamenti climatici stanno influenzando pesantemente il
Mediterraneo», racconta
Sandro Carniel, dell’Istituto di Scienze Marine del Cnr di
Venezia, «in termini di temperatura, salinità, circolazione e livello del mare».
Come evidenziato nell’ultimo documento messo a punto dal Ministero
dell’Ambiente, per esempio, nel periodo 1904-2006 la temperatura superficiale
dell’acqua è aumentata di 0,85 gradi nel Mediterraneo occidentale, di 0,92 nello
Ionio e di ben 1,45 nell’Adriatico. L’aumento del livello delle acque
nell’intero bacino del Mediterraneo, invece, è stato stimato essere di 2,1
millimetri l’anno nel periodo 1992-2005, sebbene con qualche variabilità locale.
Clima, a cosa serve la conferenza di
Parigi. L'incontro Cop21, che riunisce i
rappresentanti di oltre 150 Paesi, deve porre le basi per un accordo sulla
riduzione delle emissioni da gas serra. E dopo anni di flop potrebbero esserci
reali passi avanti. Ma non è detto saranno sufficienti, scrive Marco Magrini il
30 novembre 2015 su “L’Espresso”. Ottantadue presidenti, sei vicepresidenti,
quarantasette primi ministri, due cancellieri, cinque re, tre principi, un emiro
e un segretario di Stato che parlano al microfono, uno dopo l’altro. I massimi
rappresentanti di oltre 150 Paesi del mondo, da Barack Obama a Xi Jingpin, da
Vladimir Putin a Recep Erdogan, da Matteo Renzi al cardinale Pietro Parolin,
aprono oggi a Parigi la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, battezzata
Cop21. Un fiume di parole che dovrebbe preludere all’accordo internazionale su
una monumentale ricoversione energetica, necessaria a ridurre la collettiva
dipendenza dai combustibili fossili che riscaldano l’atmosfera. Ecco le
trattative che vanno a cominciare, in cinque punti.
1. La
posta in gioco. La
scienza assicura che non bisogna permettere alla temperatura media terrestre di
salire oltre i due gradi centigradi (è già cresciuta di un grado da metà
Ottocento a oggi), pena drammatiche conseguenze climatiche: dal livello dei mari
che sale inesorabilmente, agli oceani che si acidificano; dal Medioriente che
diventa invivibile, al permafrost siberiano che si scioglie. Sono almeno dieci
anni che questo consesso cerca di raggiungere un accordo capace di superare il
Protocollo di Kyoto, che aveva il difetto di coinvolgere solo i Paesi
industrializzati (peraltro senza gli Stati Uniti, che non l’hanno mai
ratificato). Finora però, a cominciare dal celebre flop del vertice di
Copenhagen, nel 2009, la diplomazia climatica internazionale ha inanellato un
fallimento dopo l’altro. Stavolta ci sono le premesse per un cambio di passo.
Tensione in place de la République, dove gruppi di estrema sinistra hanno
cercato di organizzare un corteo in vista della conferenza sul clima, Cop21. La
polizia ha sparato alcuni lacrimogeni. Le manifestazioni erano state vietate a
causa dello stato di emergenza.
2.
Ognuno per sé. Per
cominciare, la vecchia idea di un impegno uguale per tutti, è stata abbandonata.
Siamo entrati nell’era degli Indc (acronimo che sta per Intended
nationally determined contributions) dove ogni nazione è libera di
stabilire i suoi obiettivi di tagli alle emissioni di gas-serra. La Cina ad
esempio, promette di ridurre del 65 per cento l’intensità delle sue emissioni di
anidride carbonica (ovvero a parità di Pil), entro il 2030. Gli Stati Uniti
invece, puntano a un taglio tout-court del
28 per cento entro il 2025. L’Europa, che è da sempre la prima della classe, ha
già deliberato da anni – e per legge – un taglio del 20 per cento entro il ben
più vicino 2020, con l’opzione di arrivare al 30 per cento se altri faranno
altrettanto. All’Unfccc, la convenzione delle Nazioni Unite che organizza questi
negoziati, partecipano 194 Paesi del Mondo. Di questi, solo 181 hanno consegnato
le loro lettere di impegno, talvolta piuttosto vaghe, come nel caso dell’Arabia
Saudita che non è ovviamente troppo incline all’idea di veder scendere i consumi
globali di petrolio, di gran lunga la sua prima risorsa economica. Tuttavia,
siccome in questo ambito multilaterale si vota non a maggioranza, ma
all’unanimità, questi obiettivi più flessibili, fissati a livello nazionale,
paiono davvero propedeutici alla firma del trattato.
3. Guai
a chiamarlo "trattato". Quella
parola però, non va proprio pronunciata. Se, come sembra, si arriverà a
un’intesa finale, verrà chiamata Accordo di Parigi o qualcosa del genere. Ma
Trattato di Parigi proprio no: basterebbe quello a richiedere la ratifica del
Congresso americano che, per via dell’intransigente posizione repubblicana, non
passerebbe mai. Piaccia o no, un solo partito politico di una sola nazione, è in
grado di compromettere l’intero, faticoso processo internazionale.
L’amministrazione Bush, notoriamente legata alle lobby petrolifere, lo aveva
sempre ostacolato. L’amministrazione Obama, che descrive i cambiamenti climatici
come un rischio di portata epocale per il mondo del futuro, è più che
favorevole: ma a patto di non richiedere un’approvazione parlamentare, che
sarebbe impossibile. Non a caso, due settimane fa il segretario di Stato John
Kerry ha dichiarato che «l’accordo di Parigi non sarà legalmente vincolante». A
caldo, l’Unione Europea ha risposto picche. Ma poi il ministro francese Laurent
Fabius (che stamani sarà eletto presidente della Cop21) ha cambiato idea: «non
si chiamerà trattato e non conterrà impegni vincolanti». Migliaia di persone in
piazza a Parigi per formare una catena umana lunga (secondo gli organizzatori)
quasi 3 chilometri in occasione della conferenza sul clima Cop21. Da Place de la
Republique a Place de la Nacion i partecipanti hanno esposto cartelli di
esortazione, nei confronti dei politici di tutto il mondo presenti al vertice,
per trovare le giuste misure per contenere l'aumento delle temperature globali e
sostenere i paesi più poveri.
4.
Venti favorevoli e contrari. In
compenso, il momento è magico. Non soltanto c’è un democratico alla Casa Bianca.
Il caso vuole che, in due Paesi industrializzati come il Canada e l’Australia,
due primi ministri pro-ambiente abbiano appena preso il posto di due
conservatori apertamente schierati contro i negoziati climatici. Poi, tutt’altro
che irrilevante, c’è il mondo delle imprese multinazionali. Le quali, oggi più
che mai, non chiedono di inquinare impunemente, ma di conoscere le regole del
gioco il prima possibile, in modo da poter investire di conseguenza, in
un’ottica di lungo periodo. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un
impegno sincero: un po’ perché è quel che chiedono i consumatori, un po’ perché
molte di loro hanno già visto che l’efficienza energetica fa bene al mondo, ma
anche al bilancio di fine esercizio. Ma allora, chi è rimasto a remare contro?
Beh, l’ambigua posizione dell’Arabia Saudita è ovviamente ricalcata da altri
Paesi petroliferi, come il Venezuela. Ma le grandi corporation del petrolio,
soprattutto quelle americane, sono forse le più irriducibili. Spicca il ruolo
dei petrolieri Charles e David Koch che, secondo il Washington Post, alle ultime
elezioni americane hanno coordinato una rete di fondi e associazioni
conservatrici, contribuendo al Partito Repubblicano con
407 milioni di dollari. Non è difficile capire perché i senatori di quello
stesso partito sono così avversi alla questione climatica.
5.
L’ultima spiaggia? Sono
almeno quattro anni, che l’appuntamento di Parigi viene descritto come l’ultima
ancora di salvezza. Le organizzazioni non governative, presenti in forze alla
Cop21, ricordano che, facendo i calcoli sulla base degli impegni annunciati dai
singoli Paesi, negli anni a venire la temperatura aumenterà comunque di 2,7
gradi centigradi, ovvero ben sopra la soglia del pericolo. Greenpeace, Wwf,
Oxfam e gli altri, chiedono di non superare gli 1,5. Tuttavia, come ha detto due
giorni fa Cristiana Figueres, segretario dell’Unfccc, «l’importante è costruire
una fiducia reciproca, applaudire ogni passo avanti e poi aggiungere un’altra
pietra miliare». In altre parole, l’importante è cominciare. A parte le poche
teste coronate per diritto ereditario, i primi ministri e i capi di Stato che
parlano oggi a Parigi, andranno e verranno nella parentesi di un mandato
elettorale o due. Gli incerti destini della nostra comune atmosfera invece,
hanno bisogno di cure e attenzioni molto, molto più lungimiranti.
Il 2015 sembra già destinato a essere
l’anno più caldo della storia. E se si vogliono
evitare conseguenza catastrofiche su sicurezza alimentare, riserve d’acqua,
stabilità economica e pace internazionale bisogna fare di più e in fretta,
scrive Marco Magrini l'1 dicembre 2015 su “L’Espresso”. Tre giorni fa, proprio
alla vigilia del vertice climatico attualmente in corso a Parigi,
l’Organizzazione meteorologica mondiale, uno dei bracci scientifici delle
Nazioni Unite, ha comunicato al mondo due brutte notizie. La prima: a un mese
dalla sua conclusione, il 2015 sembra già destinato a essere l’anno
più caldo della storia, nonché il quinto anno più caldo
consecutivo. La seconda: proprio quest’anno, l’aumento della temperatura media
planetaria valicherà la soglia di un grado centigrado, rispetto all’era
pre-industriale. Un grado di differenza, sembra poca – o pochissima – cosa. Ma
non per chi conosce la distinzione fra la meteorologia (lo studio giornaliero
delle condizioni atmosferiche in particolari aree geografiche) e la climatologia
(lo studio nel lungo periodo e su scala planetaria). Se in meteorologia,
come sappiamo dalla nostra esperienza quotidiana, un grado di differenza in più
o in meno è del tutto risibile, nella climatologia si
tratta di un valore macroscopico. Ecco perché quella che arriva dalle Nazioni
Unite è una pessima notizia. Qui a Parigi, nel centro congressi di Le Bourget
trasformato in un fortino protetto dalle forze dell’ordine, i diplomatici di 195
Paesi del mondo sono appena all’inizio del tour-de-force negoziale che dovrebbe
portarli a sottoscrivere il tanto atteso Accordo di Parigi, o chissà come verrà
chiamato. Tutto ruota intorno alle 183 concessioni volontarie fatte da
altrettanti Paesi (inclusa l’Europa a nome dell’Italia e dagli altri 27 Stati
dell’Unione), che sono state riaffermate ieri dai rispettivi leader o teste
coronate. «È un buon inizio», ha commentato il segretario generale delle Nazioni
Unite, Ban-ki
Moon. «Però, se vogliamo limitare l’aumento della temperatura
globale entro i due gradi, dobbiamo andare molto più avanti e molto più
rapidamente. La scienza è chiara: anche un aumento di 2 gradi, avrà serie
conseguenze sulla sicurezza alimentare e le riserve d’acqua, sulla stabilità
economica e la pace internazionale». Nei solenni discorsi davanti ai
rappresentanti della diplomazia climatica di tutto il mondo, i leader della
Terra hanno fatto più di una volta esplicito riferimento all’obiettivo
dei due gradi, che ormai ha assunto il ruolo di punto fermo
della politica internazionale. Ne ha parlato il presidente russo
Vladimir Putin (non
esattamente un paladino del climate change). O il presidente dell’Ungheria, János
Áder, che si è lanciato in un appassionato, ipotetico discorso
al nipote che deve ancora nascere, il cui futuro è appeso a un tenue filo di
speranza: che quel grande consesso di presidenti e primi ministri apparso ieri
davanti ai microfoni del mondo, faccia per davvero quello che dice. Tutto è
cominciato in sordina con la Rivoluzione industriale, che ha alimentato il
crescendo rossiniano dell’economia planetaria con il carbone, il petrolio e il
gas naturale. Una volta bruciati, rilasciano carbonio che si lega con l’ossigeno
dell’atmosfera sotto forma di anidride carbonica. La quale – lo sappiamo
dall’Ottocento – trattiene la radiazione infrarossa della Terra e la riscalda. E
qui compare un altro numero, anche stavolta apparentemente risibile e
insignificante: nell’èra pre-industriale, la concentrazione di CO2 era
di 280 parti per milione. Oggi, abbiamo superato la soglia dei 400. Cosa possono
fare solo 400 molecole di anidride carbonica in mezzo a un altro milione di
molecole? Anche in questo caso, molto. Già superare la soglia di 450,
garantirebbe il temuto avvicinamento ai famosi due gradi. Ieri, i numerosi
rappresentanti degli Stati-isola del mondo, minacciati dall’innalzamento dei
mari, hanno chiesto a gran voce ai Paesi industrializzati di non superare il
tetto del grado e mezzo. Un tetto che, anche qualora gli impegni solenni
annunciati ieri dai leader del mondo venissero rispettati, è destinato ad essere
sfondato. E non di poco: i calcoli dicono +2,7 gradi. Quel che sembra chiaro
però, è che la corsa verso un mondo a basso impatto di carbonio è ufficialmente
cominciata. La banca Barclays stima che, solo per mantenere quelle promesse
ci sarà bisogno di 21.500 miliardi di dollari di investimenti in energie
alternative e in efficienza energetica, da qui al 2040. E questa
cifra, una volta tanto, non appare per nulla insignificante.
I No Global e la demenza col nemico,
scrive il 29 novembre 2015 Francesco Maria Del Vigo su "Il Giornale". Più volte,
in questo blog, ho manifestato il mio sdegno nei confronti dei vari “No
qualcosa”. Non perché non ci si possa ribellare e non si possa manifestare il
proprio dissenso – chi dice Signornò mi sta sempre antropologicamente simpatico
– ma per il modo cretino con cui lo fanno. Sfasciare una città, in branco,
peraltro senza ottenerne nessun vantaggio, non è un gesto politico. È un gesto
psichiatrico. Da manicomio. Chiamare “no global” questi cretini è un torto nei
confronti di tutti quelli che hanno criticato più volte le storture della
globalizzazione. Questi sono solo dei disadattati. Dei frustrati che scaricano
la loro rabbia – tutti insieme, protetti dall’anonimato della massa –
distruggendo città, spaccando vetrine (di commercianti con la cartella di
Equitalia da pagare), malmenando poliziotti e magari distruggendo l’automobile
che un povero cristo qualunque sta cercando di pagarsi a rate. Li abbiamo visti
in azione tante volte: dal G8 di Genova all’inaugurazione di Expo di pochi mesi
fa a Milano. C’è sempre qualcuno che li giustifica: sono giovani, incompresi,
figli delle periferie e delle emarginazioni (anche se spesso sono figli della
alta borghesia con le terga ben riparate), non trovano lavoro, è una generazione
difficile, è colpa del sistema e della società. Non c’è una giustificazione: un
cretino che devasta una città è solo un cretino che devasta una città. Un
delinquente. E come tale deve essere arrestato. Non si capisce perché se uno
evade il fisco è un reietto schifoso che deve marcire in galera, e se uno prende
a sassate un poliziotto o devasta un negozio è un neo rivoluzionario che
combatte per il sol dell’avvenire. Perché c’è sempre, nemmeno troppo
velatamente, una certa complicità nei loro confronti: da parte della politica,
della società civile (ogni volta che scrivo questo termine devo prendere un
antiemetico) e di una parte degli intellettuali. Spesso sono vecchi male
invecchiati, che rivedono in ogni forma di casino i fasti di una gioventù così
rivoluzionaria da averli portati direttamente dalle piazze e dai cortei nei
palazzi del potere e nei salotti buoni. Ora il circo dei disadattati si è
spostato a Parigi per la Conferenza sul Clima. Dove un gruppo di sedicenti anti
capitalisti ha fatto casino a Place de la Republique, lanciando contro le forze
dell’ordine tutto quello che trovava sul suo cammino. Compresi gli oggetti in
ricordo delle vittime della strage jihadiste del 13 novembre scorso. Fa
piuttosto schifo, è evidente. Questi disgraziati che giocano a fare alla guerra,
sono penosi in tempi di pace. Ma in tempi di guerra sono anche criminali. Perché
prima o poi finiranno – magari involontariamente, magari no – per aiutare le
frange terroristiche che stanno cercando di gettare l’Europa nel caos. In tempo
di guerra – e questo, a suo modo, è un tempo di guerra parcellizzata, rarefatta,
rateizzata – li avrebbero condannati per intelligenza col nemico. Visti i
soggetti propongo un reato più blando: la demenza col nemico. Ma guai a
sottovalutarli.
La lobby del petrolio e la conferenza di
Parigi. Ora promette di contribuire alla causa
ambientale, ma per anni ha finanziato opinionisti e politici per dire che
l'effetto serra era un'invenzione, scrive l'1 dicembre 2015 su Panorama Michele
Zurleni. La notizia è gustosa: dieci tra le maggiori compagnie petrolifere del
mondo hanno annunciato che intendono fare la loro parte affinché venga raggiunto
un accordo sulla riduzione del riscaldamento globale alla
Conferenza di Parigi. Visto da una certa prospettiva,
questo sembra l'annuncio di un piromane che passa dall'altra parte della
barricata e si arruola nei pompieri. Però è così: La Oil
and Gas Climate Initiative, il gruppo che include la BP, Shell, Saudi
Aramco, la Total e diverse altre importanti società (il
20% della produzione mondiale di petrolio e gas), prima
dell'inizio della conferenza ha diffuso una dichiarazione in cui afferma che
l'obiettivo è quello di tutti gli altri: due gradi centigradi in meno di
riscaldamento globale. "Spesso si ha l'impressione che i combustibili fossili
siano i cattivi ragazzi in questa storia, ma i cattivi ragazzi - ha detto il
numero uno della Total Patrick Pouyanne - qualche volta sono parte della
soluzione del problema". Se l'impegno sarà effettivo e non si rivelerà solo
un'abile manovra di pubbliche relazioni, lo diranno i lavori della conferenza e
il prossimo futuro. Queste compagnie petrolifere hanno passato gli ultimi anni a
sabotare tutti gli sforzi per ridurre l'emissione di gas serra e ora si
presentano a Parigi con la vesti dell'agnello. Negli ultimi anni, la lobby del
petrolio ha speso decine e decine di milioni di dollari per negare l'esistenza
dei cambiamenti climatici. Sono stati finanziati "scienziati" per dimostrare che
non c'è alcun nesso tra l'emissione di gas e il surriscaldamento del pianeta;
sono stati dati migliaia e e migliaia di dollari a opinionisti per scrivere che
il surriscaldamento globale era una favola degli ambientalisti; negli Usa (per
esempio) sono stati foraggiati
decine di politici per
bloccare ogni legge che prevedesse dei limiti alla diffusione dei gas serra. Lo
hanno fatto le compagnie che ora fanno parte del "gruppo di Parigi" - come la Bp
(indicata da un''organizzazione indipendente, la britannica Influence
Map, come la più
strenua oppositrice a qualsiasi normativa ambientale a livello europeo) - e lo
hanno fatto, a maggior ragione, le società petrolifere che non hanno aderito
all'iniziativa parigina. Tra quest'ultime ci sono le americane Exxon e
la Chevron. Negli Usa, la lobby del petrolio è molto potente. Lo è sempre stata.
E, da anni, lavora per far passare un principio a livello di pubblica opinione:
l'effetto serra è una barzelletta. Nello
scorso luglio, il quotidiano britannico The Guardian pubblicava un articolo che
riguardava proprio la ExxonMobil. La compagnia, nonostante molti dei suoi azionisti
avessero chiesto otto anni prima di smetterla di finanziare politici e
opinionisti per negare i cambiamenti climatici, aveva continuato a farlo. A
diversi membri del Congresso (per
lo più repubblicani) erano arrivati un totale di 3 milioni e mezzo di dollari,
mentre altri 30 milioni di dollari erano stati dati a ricercatori e attivisti di
gruppi anti o pseudo ambientalisti per diffondere falsità sul riscaldamento
globale. Negli Stati Uniti, i Re del "negazionismo" ambientale sono i fratelli
Koch, tra i più importanti industriali americani, vicini al Tea
Party e finanziatori di tutte le campagne e le lobby conservatrici (in primis,
quella delle armi). Greenpeace ha
rivelato che i Koch hanno speso una cifra che si aggira attorno agli 80 milioni
di dollari in una quindicina di anni
per foraggiare i gruppi che negano l'esistenza dell'effetto serra. La lobby del
petrolio continuerà a lavorare a Washington. L'attivismo di Barack
Obama sul fronte
ambientale è visto come un vero pericolo. Non è un caso che il Congresso (a
maggioranza repubblicano) abbia fatto le barricate contro le leggi proposte
dalla Casa Bianca in questo campo. E c'è già chi dice che Capitol Hill potrebbe
rigettare l'accordo che uscirà dalla Conferenza di Parigi. Quella sarebbe la più
grande vittoria dei "negazionisti per interesse (economico)" dei cambiamenti
climatici.
La più grande menzogna dei nostri tempi
ansiosi. L'aumento delle temperature indotto dall'uomo
è un falso: non c'è nesso con le emissioni di Co2, scrive Franco
Battaglia Martedì 01/12/2015 su “Il Giornale”. Quella del riscaldamento globale
indotto dalle attività umane è la più grande menzogna del secolo scorso.
Ripetuta tante di quelle volte che alla fine i più si sono convinti che è vera.
Perfino Papa Bergoglio, che con la Sua ultima Enciclica ha dato prova di essere
stato insidiato dal Diavolo. Non sarebbe la prima volta: chi sennò insidiò
Urbano VIII quando costrinse Galileo a sottoscrivere l'atto di abiura? Bergoglio
oggi come Urbano allora si appella al consenso scientifico. Il fatto è che mai
ci si può appellare al consenso scientifico per sostenere l'attendibilità di
qualsivoglia affermazione. Anzi, a dire il vero, è contro il consenso che la
scienza fa progressi. Quel che conta sono i fatti. L'acqua è H2O non perché v'è
un consenso scientifico, ma perché non v'è alcun fatto che contraddice la
formula H2O. Il consenso scientifico ai tempi di Galileo era che la Terra fosse
ferma al centro dell'universo e quello ai tempi di Einstein era che l'etere
esiste. Come oggi si dice ma non è vero il consenso scientifico è che il caldo
di cui gode il pianeta è conseguenza delle attività umane. Il fatto è che il
pianeta vive da milioni d'anni in una sorta di perenne stato glaciale,
interrotto, ogni centomila anni, da diecimila anni di, detta in gergo, optimum
climatico. Orbene, questa nostra umanità sta vivendo nell'ultimo di questi
favorevoli periodi. Ed è da ventimila anni, cioè da quando il pianeta cominciò a
uscire dall'ultima era glaciale, che i livelli dei mari si sono elevati: di
oltre cento metri rispetto ad allora. Né l'attuale optimum climatico ha
raggiunto ancora i massimi di temperatura che si raggiunsero, in assenza di
attività umane, negli optimum climatici precedenti. Una volta usciti da un'era
glaciale, il clima del pianeta non resta immobile in un ideale plateau termico.
Per esempio, durante l'ultimo optimum climatico, vi sono stati periodi caldi
(olocenico, romano e medievale), intervallati da cosiddette piccole ere
glaciali, l'ultima delle quali durò qualche secolo ed ebbe il suo minimo 400
anni fa, quando il clima riprese a riscaldarsi, e sta continuando a farlo fino
ad oggi. Ma 400 anni fa, quando cominciò il processo, le attività umane erano
assenti, e tali rimasero per almeno 3 secoli. Viviamo in un secolo di monotòno
crescente riscaldamento, corrispondente all'inconfutabile monotòna, crescente
immissione di gasserra? La risposta è no. Nel periodo 1945-1970, in pieno boom
di emissioni, il clima visse un periodo d'arresto, ed è da almeno 14 anni che
sta accadendo la stessa cosa: a dispetto di una crescita senza sosta delle
emissioni di CO2, la temperatura media del pianeta è al momento stabilizzata ai
livelli di 14 anni fa. Abbiamo così fatti a sufficienza per smentire ciò che
viene spacciato come consenso scientifico. Nella Sua Enciclica il Papa ha
proposto che i Paesi ricchi del mondo costruiscano in quelli poveri gli impianti
cosiddetti alternativi di produzione energetica. Non si rende conto, Sua
Santità, che questo significa, di fatto, negare ai poveri l'unico bene materiale
l'energia abbondante e a buon mercato che solleverebbe la misera condizione in
cui essi vivono. Quegli impianti «alternativi», infatti, non funzionano (è un
fatto tecnico). Ci s'immagini, per un attimo, che con un miracolo spariscano in
un istante tutti gli impianti nucleari, a carbone e a gas dell'Europa e, sempre
con lo stesso miracolo, fossero sostituiti da impianti eolici e fotovoltaici di
pari potenza a quelli spariti. Si fermerebbero, sì, i climatizzatori contro cui
Bergoglio ha sollevato l'indice (che pur tanto sollievo portano alle sofferenze
dal caldo e dall'umidità), ma si spegnerebbero anche gli impianti degli
ospedali, le fabbriche e tutte le luci. Per farla breve: si smetterebbe di
essere Paesi ricchi. Proporre che i Paesi poveri usino solo quegli impianti per
il proprio fabbisogno energetico, significa negare loro l'energia, cioè
significa condannarli alla povertà. Proporre, poi, che siano i Paesi ricchi a
sostenere l'enorme, quanto inutile, sacrificio economico, significa impoverire
le popolazioni di questi Paesi a vantaggio di quella ristretta minoranza che,
unica, si avvantaggerebbe del miserabile affare. La ristretta minoranza che ha
assunto le forme del diavolo che, temo, s'è insinuato nei cuori dei consiglieri
del Santissimo Padre.
E poi se si muore di smog, tassiamo le
bici? Scrive il 30 novembre 2015 Antonio Ruzzo su "Il
Giornale". Dovrebbe essere finito il tempo delle chiacchiere. Dovrebbe essere
finito il tempo dei compromessi, delle decisioni compiacenti che chi amministra
spesso prende per non scontentare chi l’ha votato o chi potrebbe votarlo.
L’inquinamento atmosferico soprattutto per chi vive nelle città del nord è un
problema serio che deve essere affrontato anche con scelte impopolari. C’è un
interesse di salute da tutelare e va fatto. Quindi vanno fermate le auto che
inquinano, vanno fermati camion e furgoni che hanno motori di trent’anni fa,
vanno messi a norma bruciatori e caldaie ma con controlli seri sui fumi, vanno
fatte scelte alternative sul trasporto che non può essere solo su gomma. E
altro ancora si potrebbe fare. Perché tutto ciò va fatto subito? Perché L’Italia
è il Paese dell’Unione europea che segna il record del numero di morti prematuri
rispetto alla normale aspettativa di vita per l’inquinamento dell’aria. La stima
arriva dal rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (Aea): il Belpease nel
2012 ha registrato 84.400 decessi di questo tipo, su un totale di 491mila a
livello Ue. Tre i ‘killer’ sotto accusa per questo triste primato. Le micro
polveri sottili (Pm2.5), il biossido di azoto (NO2) e l’ozono, quello nei bassi
strati dell’atmosfera (O3), a cui lo studio attribuisce rispettivamente 59.500,
21.600 e 3.300 morti premature in Italia. Il bilancio più grave se lo
aggiudicano le micropolveri sottili, che provocano 403mila vittime nell’Ue a 28
e 432mila nel complesso dei 40 Paesi europei considerati dallo studio, L’impatto
stimato dell’esposizione al biossido di azoto e all’ozono invece è di circa
72mila e 16mila vittime precoci nei 28 Paesi Ue e di 75mila e 17mila per 40
Paesi europei. L’area più colpita in Italia dal problema delle micro polveri si
conferma quella della Pianura Padana, con Brescia, Monza, Milano, ma anche
Torino, che oltrepassano il limite fissato a livello Ue di una concentrazione
media annua di 25 microgrammi per metro cubo d’aria. Ora di certo ci sarà chi
avrà modo e maniera di interpretare anche questi dati. Di infarcirli di se, di
ma, di fare come si dice sempre dei “distinguo”. Ci sarà chi parlerà di
terrorismo ambientale e di inutili allarmismi. Può darsi. Certo e che più che
tanti incontri, tavole, conferenze mondiali e globali sul clima forse basterebbe
il coraggio di fare scelte più semplici e concrete già domattina. Poi però leggi
che c’è qualcuno in Parlamento che per far quadrare i conti sta prendendo in
considerazione l’ipotesi di targare e bollare anche le bici e allora ti cadono
le braccia. E pensi che forse questo è un mondo che gira al contrario.
Gli
allarmismi interessati sul clima, scrive Riccardo
Cascioli l'1-04-2014. E’ proprio vero che gli eventi estremi sono in aumento, ma
non sono quelli climatici. Si tratta invece dei rapporti catastrofisti dell’IPCC
(il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici) che si stanno
moltiplicando, preceduti da sapienti indiscrezioni che cominciano a spargere
terrore nei giorni precedenti il rilascio ufficiale, per poi alimentare il
dibattito nelle settimane seguenti. Ieri c’è stata appunto in Giappone la
pubblicazione della “Sintesi per i politici” del Rapporto del Gruppo di lavoro
2. Una volta il Rapporto, pubblicato all’incirca ogni 6 anni, veniva presentato
tutto insieme, sempre preceduto di qualche mese dalla sua Sintesi per i
politici. Evidentemente sembrava troppo poco, così adesso l’annuncio di
catastrofi climatiche prossime venture arriva a rate, Gruppo di lavoro per
Gruppo di lavoro (ce ne sono 3). E siccome, allarme dopo allarme, cresce
l’assuefazione, ogni annuncio deve necessariamente essere più catastrofico del
precedente per attirare l’attenzione. Così quello presentato ieri, già da giorni
veniva annunciato come il più terribile documento scientifico mai presentato
finora, con la "quasi certezza" del solito campionario di eventi: inondazioni,
uragani, siccità, ondate di calore, fame, povertà, migrazioni. Il tutto perché
la temperatura potrebbe aumentare di 4 gradi centigradi nei prossimi 70-80 anni.
Potrebbe, ma già vent’anni fa si prevedeva un aumento esponenziale della
temperatura globale che invece non c’è stato. Anzi, è dal 1998 che la
temperatura non cresce, e diversi scienziati hanno cominciato a parlare di un
prossimo raffreddamento delle temperature. La verità è che nessuno è in grado di
sapere cosa accadrà non solo tra 10, 50, 100 anni, ma neanche la prossima
settimana. Troppo poco si sa sul clima e come gli innumerevoli fattori che
contribuiscono a determinarlo interagiscono fra loro. Così si spaccia per
scienza quella che semplicemente è una grande truffa politico-economica ai danni
della collettività, che si avvale anche del contributo di uomini di scienza
(qualcuno in buona fede, tanti altri no) per legittimare politiche ambientali ed
energetiche che vanno a vantaggio di pochi gruppi o paesi. Pensiamo solo al
fatto che tutti i media accreditano l’IPCC come il massimo organismo scientifico
in fatto di clima. Così tutti immaginano che lì siedano tutti i più importanti e
titolati climatologi del mondo. Niente affatto, e non c’è neanche da indagare
troppo. Basta rileggere il nome dell’organismo: si chiama Panel
Intergovernativo, vale a dire è un organismo politico che risponde direttamente
ai governi. I governi scelgono gli scienziati che vi partecipano e i governi
controllano ciò che uscirà dal Rapporto. Uno scienziato al soldo del governo –
dal quale dipendono i finanziamenti per il suo istituto di ricerca - e il cui
futuro dipende anche dalla forza dell’allarme che lancerà, potrà mai essere
davvero distaccato e valutare oggettivamente i dati a sua disposizione? Certo,
ci sono anche quegli scienziati che, arruolatisi in buona fede, poi ritirano la
propria firma una volta visto l’andazzo. E’ successo anche stavolta con uno dei
70 esperti chiamati a redigere la Sintesi per i politici. L’economista olandese
Richard Tol, che si occupa degli effetti dei cambiamenti climatici, si è
ritirato nei giorni scorsi perché non condivideva l’allarmismo estremo di cui si
è voluto permeare questo rapporto. Ma questa è solo la punta dell’iceberg. Il
presidente dell’IPCC, l’indiano Rajiendra Pachauri, in carica dal 2002, non solo
non è uno scienziato del clima (è ex ingegnere ferroviario) ma ha anche un
evidente conflitto di interessi visto che è allo stesso tempo il fondatore di un
centro studi indiano (TERI) che si occupa di ricerche sul clima ed è coinvolto
in numerosi progetti economici ed energetici i cui finanziamenti dipendono dagli
allarmi lanciati dall’IPCC. E malgrado lo scandalo sia scoppiato alcuni anni fa,
Pachauri è rimasto ben saldo in sella. Ma il suo non è l’unico caso di conflitto
di interessi. Pensiamo al rapporto pubblicato ieri: bisogna sapere che il
Rapporto completo del Gruppo di Lavoro 2 è composto di 30 capitoli a cui hanno
collaborato centinaia di esperti, ma per ogni capitolo c’è un responsabile. Tra
tutte vengono poi scelte una settantina di persone per redigere la Sintesi. Ci
si aspetterebbe la scelta di persone al di sopra di ogni sospetto, capaci di
sintetizzare in modo onesto e obiettivo i diversi contributi. Ebbene, tra i
redattori della Sintesi presentata ieri ci sono ben noti attivisti ecologisti,
fanatici delle politiche climatiche. Uno di questi è l’astrofisico Michael
Oppenheimer, da vent’anni rappresentante dell’Environment Defense Fund (EDF),
una delle più ricche organizzazioni ecologiste americane; un altro è
l’australiano Ove Hoegh-Guldberg, biologo marino, che da vent’anni confeziona
studi per Greenpeace e WWF. Ancora, troviamo il medico neozelandese Alistair
Woodward, autore di diversi lavori per la promozione di “terapie verdi” e
impegni ecologisti. Peraltro tutti e tre dal 2010 sono stati nominati
responsabili di singoli capitoli: Oppenheimer il 19 (sui rischi emergenti e le
vulnerabilità), Hoegh-Guldberg il 30 (sugli Oceani) e Woodward l’11 (sulla
salute umana). Quanto possano essere affidabili personaggi che grazie agli
allarmi sul clima vedono piovere centinaia di milioni di dollari sulle loro
organizzazioni, è facile immaginarlo. Ciò ovviamente non significa che non ci
siano o non ci saranno catastrofi naturali, ma ci sono sempre state. L’unica
cosa certa è che seguire questi individui non potrà che portare conseguenze
peggiori, perché ci spingono a buttare un’enormità di soldi su progetti inutili
(se non per loro) togliendo risorse preziose per rendere meno vulnerabili le
popolazioni più esposte agli eventi atmosferici estremi.
Cambiamenti
climatici, fa più danni l’allarmismo della Co2.
L’“ambientalista scettico” Bjorn
Lomborg spiega perché, dati alla mano, è più utile aiutare il Terzo Mondo a
uscire dalla povertà che buttare montagne di denaro in inutili campagne “green”,
scrive “Tempi” il 4 febbraio 2015. Con la consueta sana dose di
pensiero anti-ideologico, l’“ambientalista
scettico” Bjorn Lomborg è tornato a sottolineare dalle colonne del Wall
Street Journal quale sia secondo lui “la cosa allarmante
dell’allarmismo climatico”. La tendenza a bombardare il pubblico con titoloni
catastrofici e appelli disperati spesso impedisce al mondo di prendere atto di
dati che in molti casi smentiscono quegli stessi allarmi, e dunque di studiare
soluzioni fondate sulla ragione anziché sul panico.
Per esempio, ricorda Lomborg cominciando a elencare i fatti inattesi
registrati dagli osservatori scientifici, «è indubbio che le emissioni di
anidride carbonica sono in crescita, e più rapidamente di quanto abbia predetto
la maggior parte degli scienziati. Ma molti allarmisti climatici sembrano
credere che i cambiamenti climatici siano peggiori delle attese. Ignorando però
che molti dati in realtà sono incoraggianti. Lo studio
più recente dell’Ipcc (il Gruppo intergovernativo di esperti sul
cambiamento climatico, organismo Onu premiato con il Nobel per la pace nel 2007
insieme ad Al Gore, ndr) ha riscontrato che nei precedenti 15 anni le
temperature erano aumentate di 0,09 gradi Fahrenheit. La media di tutti i
modelli prevedeva 0,8 gradi. Stiamo dunque assistendo a un aumento di
temperatura inferiore del 90 per cento alle attese». Concentrare l’attenzione
solo sui casi peggiori, insiste Lomborg, non contribuisce all’individuazione di
solide politiche ambientali. Un altro esempio? Le calotte polari. «Sì, il
ghiaccio artico si scioglie più rapidamente rispetto alle attese dei modelli. Ma
i modelli hanno predetto che anche il ghiaccio antartico si sarebbe ristretto, e
invece si sta espandendo». Non basta? Prendiamo la siccità: si continua a
ripetere che in futuro la mancanza di acqua sarà una piaga sempre più frequente.
Eppure, spiega il direttore del Copenaghen Consensus Center, «uno studio pubblicato
a marzo dalla rivista Nature mostra
che in realtà la superficie del pianeta colpita da siccità è diminuita dal
1982». E non è finita. Continua Lomborg: «A dicembre, alla conferenza Onu sul
clima organizzata a Lima, in Perù, è stato detto ai partecipanti che i loro
paesi dovranno tagliare le emissioni di anidride carbonica per evitare in futuro
danni causati da tempeste come il tifone Hagupit, che ha colpito le Filippine
proprio nei giorni della conferenza, uccidendo almeno 21 persone e
costringendone oltre un milione a lasciare le proprie case. Eppure, secondo uno
studio pubblicato nel 2012 dall’American
Meteorological Society’s Journal of Climate, i tifoni che colpiscono
l’area delle Filippine per la verità sono in calo dal 1950». Insomma, ribadisce
l’“ambientalista scettico”, sentiamo ripetere in continuazione che «le cose sono
peggiori che mai, ma i fatti non dicono questo». E forse pensando proprio a un
caso come quello delle Filippine, Lomborg suggerisce a esperti e comunicatori di
riconoscere una volta per tutte che «non si tratta tanto di tagliare le
emissioni di anidride carbonica, quanto di tirare fuori le persone dalla
povertà». Non è un caso se nel mondo il tasso di morti causate da disastri
naturali è crollato del 97 per cento dall’inizio del secolo scorso a oggi: il
calo impressionante, spiega Lomborg, «è dovuto soprattutto allo sviluppo
economico che aiuta le nazioni a resistere alle catastrofi». Del resto è ovvio
che un uragano in Florida non uccide quanto un uragano nel Sudest asiatico. Più
che spendere montagne di soldi per produrre risultati trascurabili con le
energie rinnovabili, perciò, il mondo farebbe meglio a promuovere con più
convinzione lo sviluppo dei paesi poveri.
Energie rinnovabili, ora ci pensano
Zuckerberg e Gates. I membri della nuova associazione,
composta solo di imprenditori privati, mette assieme 388 miliardi di dollari in
patrimoni personali. Obiettivo: accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche.
Niente beneficenza: agirà come un venture capital, scrive Paolo Fiore l'1
dicembre 2015 su “L’Espresso”.
Verdi. Anzi, verdoni. Alcuni degli uomini più ricchi (e potenti) del pianeta si
sono uniti nella Breakthrough Energy Coalition. Una coalizione che ha
l'obiettivo di accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili. Segni
particolari: è composta solo da imprenditori privati ma ha la potenza di fuoco
di uno Stato di medie dimensioni. I membri del gruppo sono appena 28. Ma mettono
assieme patrimoni personali per 388 miliardi di dollari. Tra di loro c'è l'uomo
più ricco del mondo (Bill
Gates), il più facoltoso dell'India sulla carta (Mukesh Ambani)
e nella realtà (Ratan Tata). E ancora: il più ricco d'Africa (Aliko Dangote) e
il secondo paperone cinese (Jack Ma). E poi, solo per citare i più noti, Jeff
Bezos (boss di
Amazon), Mark
Zuckerberg (ceo di
Facebook) e George Soros. Per capire qual è l'impatto che questo gruppo potrebbe
avere a livello mondiale, bastano alcuni dati. La
loro fortuna personale supera del 30 per cento gli investimenti mondiali in
energie rinnovabili del 2014, pari a
270 miliardi. Se Gates decidesse di investire in eolico e solare tutto il suo
patrimonio (circa 79 miliardi di dollari), supererebbe la spesa compiuta nel
settore da tutti i Paesi fuori dal
G-20 tra il 2009 e il 2013. Mr Microsoft e soci non si priveranno in un sol
colpo del loro tesoro. Ma basterebbe mettere sul piatto il 2% dei loro patrimoni
per coprire la somma spesa in ricerca e sviluppo nel 2014 da istituzioni
pubbliche (5,5 miliardi) e imprese (6,6 miliardi) di tutto il mondo. E questo
solo per fermarsi alle tasche personali. Perché la forza di questi imprenditori
deriva anche dai fatturati delle loro aziende. Il giro d'affari di Microsoft
supera il prodotto interno lordo della Slovacchia. La Reliance Industries
Limited, maggiore impresa privata indiana, guidata da Mukesh Ambani, ha un
fatturato paragonabile al Pil dell’Azerbaigian. Amazon vende prodotto pari al
prodotto interno lordo dell'Oman e Ratan Tata della Bielorussia. La Hp guidata
da Meg Whitman (altro membro del club) fattura più della Bulgaria. Mettendo
insieme i fatturati delle imprese coinvolte, si toccano i 458 miliardi di
dollari. Più o meno il Pil dell'Argentina. E questo senza contare gli asset di
venture capital ed hedge fund entrati nel gruppo. Confronti come questi sono
poco più di un gioco: una multinazionale non è una nazione. Ma le cifre la
dicono lunga sul potere che si accentra nella Breakthrough Energy Coalition.
Definirla un gruppo nato intorno ai big della tecnologia sarebbe limitante. È
vero, ci sono i fondatori di Alibaba, Microsoft, Amazon, Facebook e LinkedIn. Ma
la coalizione è molto di più: è una lobby (termine che negli Stati Uniti non è
una parolaccia) potente come e più di uno Stato. Una elite cha avrà portafoglio
ampio e grande potere contrattuale. I volti del tech sono forse i più noti, ma
ci sono anche magnati dei media come Richard Branson di Virgin e conglomerate
industriali dei Paesi in via di sviluppo (Dangote group, Reliance Industries,
Tata). La schiera più nutrita, semmai, è un'altra: quella degli uomini d'affari
che hanno fatto miliardi con venture capital ed hedge fund: Ray Dalio di
Bridgewater Associates, John Doerr di Kleiner Perkins Caufield & Byers, Vinod
Khosla di Khosla Ventures, Neil Shen di Sequoia Ventures, Nat Simons e Laura
Baxter-Simons di Prelude Ventures, Chris Hohn di The Children's Investment Fund.
E poi non poteva mancare sua maestà George Soros. La composizione del gruppo
suggerisce che la Breakthrough Energy
Coalition non è una fondazione che fa
beneficenza. È una società che investe. Lo si legge chiaramente nel suo
manifesto. “Ci focalizzeremo su imprese a livello early stage” (cioè ai primi
passi) che abbiano “il potenziale per ridurre le emissioni e cambiare il mondo
dell'energia”. Gates e compagni funzioneranno come un venture capital sui
generis: si porrà nel vuoto creato tra ricerca pubblica e investimenti
privati. “Gli investimenti governativi – si legge sul sito web del gruppo -
hanno nutrito la creatività privata e portato a enormi successi nel campo
spaziale, medico e tecnologico. La politica dovrebbe fare lo stesso nel campo
dell'energia”. Tuttavia, “i fondi che oggi il governo destina alle rinnovabili e
le ricerche pubbliche non sono sufficienti”. Dall'altra parte, “gli investimenti
early stage nel settore hanno un rischio troppo elevato per essere appetibili
agli occhi dei business angel e dei venture capital tradizionali”. La
Breakthrough Energy Coalition si piazza qui: tra debolezza pubblica e un mercato
privato che deve sempre mantenere un equilibrio tra rischi e benefici. Serve
“una partnership” tra pubblico e privato che sostenga “i progetti governativi” e
convinca gli investitori privati “a supportare le idee innovative”. “Non
possiamo aspettare che il sistema cambi”. Non c'è tempo. E adesso ci sono 388
miliardi di motivi per farsi convincere.
Clima, basta con gli allarmismi, servono
realismo e responsabilità, scrive
Luca Mercalli il 28 luglio 2015 su “La
Stampa”. La climatologia è ormai materia popolare, le previsioni del tempo hanno
surclassato l’oroscopo. Questo caldo è e sarà la nuova normalità, poi si scopre
che decenni fa abbiamo avuto lo stesso fenomeno. Sono contraddizioni che tengono
legata la gente alla climatologia, un po’ di allarmismo al momento giusto con
successiva rassicurazione. Ma più che sapere se domani pioverà o ci sarà sole, è
bene comprendere che lo studio del clima diventerà sempre più importante.
Prevedere quello che accadrà è difficile, ma è materia affascinante che col
tempo riuscirà ad anticipare l’intensità dei fenomeni con precisione temporale e
geografica portando grandi benefici economici e salvando vite umane. Tutte le
principali accademie scientifiche del mondo sono concordi nell’affermare che il
riscaldamento globale sarà la maggior minaccia che l’Umanità dovrà affrontare
nel vicino futuro. Quindi il problema è proprio l’informazione confusa e
contraddittoria. Più che di allarmismi e rassicurazioni, abbiamo bisogno di
chiarezza, realismo e responsabilità. I progressi scientifici hanno migliorato
l’affidabilità dei modelli matematici accoppiati oceano-atmosfera che simulano
il clima come il Coupled Model Intercomparison Project promosso fin dal 1995 dal
World Climate Research Programme. Come giustamente osserva anche Lei, stanno
nascendo – accanto ai tradizionali servizi meteorologici - i servizi climatici
in grado di fornire ai politici e ai cittadini gli scenari climatici a cui
stiamo andando incontro. In Italia il Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti
Climatici ha messo a disposizione la piattaforma geografica Lancelot dove
consultare cosa succederà al clima della propria regione. Ma dopo che su queste
mappe colorate si è presa visione dell’inferno che ci aspetta, tocca muoversi e
prendere provvedimenti efficaci. Invece pensiamo che sia tutto un banale
videogioco. Attenti, c’è una sola partita da giocare. Caro Mercalli, se in un
gruppo si pronunciasse la classica frase “Non ci sono più le mezze stagioni”,
sicuramente si intavolerebbe una discussione sulle mutazioni climatiche. A tal
proposito è curioso leggere Leopardi: “Egli è pur vero che l’ordine antico delle
stagioni par che vada pervertendosi. Qui in Italia è voce e querela comune, che
i mezzi tempi non vi son più; e in questo smarrimento di confini, non vi è
dubbio che il freddo acquista terreno. Io ho udito dire a mio padre, che in sua
gioventù, a Roma, la mattina di Pasqua di resurrezione, ognuno si rivestiva da
state. Adesso chi non ha bisogno dì impegnar la camiciola, vi so dire che si
guarda molto bene di non alleggerirsi della minima cosa di quelle ch’ei portava
nel cuor dell’inverno”. È un passo sia dello Zibaldone [4241-4242] sia dei
Pensieri [XXXIX], datato 1827, ma dove in realtà il Leopardi riferisce parole -
risalenti al 1683 - di Lorenzo Magalotti, segretario dell’Accademia del Cimento,
l’associazione scientifica fiorentina prima in Europa a utilizzare il metodo
sperimentale galileiano. E non si tratta di idee campate in aria: il Magalotti
visse nel pieno della Piccola Età Glaciale, e dunque l’osservazione che “il
freddo acquista terreno” era sostanzialmente corretta. Oggi fa assai più caldo,
quindi “non ci sono più le stesse stagioni”. I passi letterari sono utili per
ricostruire la storia del clima prima delle osservazioni strumentali, ma devono
sempre essere messi in relazione con dati oggettivi ottenuti da archivi
“naturali”, come l’analisi di pollini fossili nelle torbiere, anelli di
accrescimento degli alberi, morfologia delle morene glaciali, rapporti isotopici
dell’ossigeno o di altri elementi contenuti nel ghiaccio polare o nei depositi
minerali delle grotte. Mettendo insieme tutte queste informazioni la
paleoclimatologia ha ricostruito migliaia di anni di evoluzione climatica
terrestre.
Luca Mercalli, climatologo e docente di sostenibilità e
comunicazione ambientale, presiede la Società meteorologica italiana e dirige la
rivista «Nimbus», occupandosi di divulgazione per «La Stampa» e «RAI3», dove
conduce «ScalaMercalli». Tra i suoi libri: «Che tempo che farà» (Rizzoli) e
«Prepariamoci» (Chiarelettere).
Troppo allarmismo sul clima, parola di
James Lovelock, scrive Enzo Pennetta il 25 Aprile
2012. Lo scienziato inglese James Lovelock balzò alla ribalta nel 1979 per aver
formulato l’ipotesi “Gaia” con la quale sosteneva che la Terra fosse un unico
organismo. Ambientalista della prima ora e sostenitore del Riscaldamento
climatico causato dalla CO2, adesso afferma di essere stato troppo allarmista.
Non solo il “Guru” dell’ambientalismo ha affermato di essere stato troppo
allarmista, ma ha affermato che anche altri notissimi personaggi impegnati in
prima linea contro l’AGW (Anthropic
Global Warming) lo sono stati, a partire dall’ex vice Presidente USA Al
Gore, il cui stesso premio Nobel sarebbe dunque da mettere in
discussione, almeno questo è quanto riportato sul sito World
News:
James Lovelock, lo scienziato anticonformista che è diventato
un guru del movimento ambientalista con la sua teoria “Gaia” della Terra come un
unico organismo, ha ammesso di essere stato “allarmista” sul cambiamento
climatico e afferma che anche altri commentatori ambientali, come Al Gore, lo
sono stati altrettanto.
Il fatto risale a più di un mese fa, ma ad esso non è stato dato molto risalto,
i più maliziosi potranno pensare che la notizia poteva non piacere a diversi
organi di informazione e
a tutti coloro che intorno alla teoria dell’AGW hanno, in un modo o nell’altro,
costruito un business. Il motivo di questa presa di posizione è spiegato dal
novantaduenne scienziato con la constatazione che non è stata rispettata la
prevista correlazione tra due grandezze, nel caso in questione l’incremento di
CO2 che dovrebbe precedere il conseguente incremento della temperatura:
“Il mondo non si è riscaldato molto dall’inizio del nuovo millennio. Dodici anni
sono un tempo ragionevole … (la temperatura) è rimasta pressoché costante,
mentre avrebbe dovuto essere in aumento – l’anidride carbonica è in aumento, non
c’è dubbio su questo “, ha aggiunto. La situazione di cui
parla Lovelock è quella mostrata su questo grafico pubblicato il 12 aprile su Climate
Monitor:
Quello che alcuni fautori nostrani dell’AGW sembrano non voler vedere è infatti
che la crescita della curva della CO2, linea azzurra, subisce un’impennata senza
che la temperatura faccia altrettanto, e che quindi non è la stasi delle
temperature degli ultimi anni a invalidare la teoria della causa antropica, ma
la sua mancata correlazione con l’aumento della CO2, proprio come mostrato nella
figura. Se infatti le cose fossero andate come previsto dai fautori dell’AGW
adesso staremmo fronteggiando eventi naturali ben più vistosi, come quelli che
lo stesso Lovelock prevedeva:
…prima che questo secolo finisca miliardi di noi moriranno e le poche coppie
riproduttive di persone che sopravvivono saranno nell’Artico dove il
clima rimarrà tollerabile.
Come è facile constatare, all’anziano scienziato è bastato fare una elementare
considerazione per giungere alla conclusione che si è fatto dell’allarmismo: le
previsioni non sono state rispettate, e quindi non è la CO2 a causare il
riscaldamento della Terra. Ma questa sua presa di posizione certamente non
piacerà a molti, e così il novantaduenne “Guru”, rischia di essere trasformato
rapidamente da “Vecchio saggio” a “Vecchio rimbambito”… così va il mondo.
LE PALE EOLICHE. IL
PROGRESSO IDEOLOGICO E LA DISTRUZIONE DI UNA CIVILTA’. L’ISIS COME LA SINISTRA.
Alla ricerca
dell'Appia perduta: in Basilicata tra pale eoliche e nuovi Don Chisciotte.
Li chiamano "Erection Manager" perché sanno erigere questi falli ad altezze
paurose, scrive Paolo Rumiz su “La Repubblica”.
Don Chisciotte era niente. La Mancha nemmeno. La lotta vera con i mulini a vento
la fai in Basilicata, Italia, tra l'Ofanto e Melfi. Comincia con una strada
misteriosamente chiusa al traffico; la Statale 303, di nuovo lei, ma ancora più
sfasciata, e degradata a Provinciale. Non ci passa più nessuno, come se il
tratturo antico se la fosse rimangiata. E noi la risaliamo in un silenzio
ingannatore, tra finocchietto e ginestre, attirati dalla Medusa. Nessuno di noi
sa che questa sarà la tappa più dura del viaggio. Il grano è pettinato al
contrario, perché dopo Borea è arrivato lo Scirocco con tafani nervosi. Ed è un
corpo a corpo, contro la salita, contro il vento, persino contro le pecore, che
scendono a slavina verso il fiume.
"Di dove siete?",
chiede il giovane pastore che le segue stravaccato in macchina. Non ha mai visto
nessuno passare a piedi di là. Gli italiani non camminano nella pancia del loro
Paese. "Siamo del Nord".
La sorpresa si tramuta
in sbalordimento. "E dove andate? ".
"A Brindisi".
Ride, si sbraccia per
salutarci e passa oltre, strombazzando dietro al gregge lanciato verso
l'abbeverata in una scia di caccole. Ma già dal fiume sale un'autocisterna piena
d'acqua, con un altro giovanotto al volante. Musica rock dal cruscotto, cicca
accesa e portiera aperta per ventilare le ascelle. Anche lui non ha mai visto
nessuno a piedi da queste parti.
"Ditemi un po', ma che
fate? Passeggiate? Con sti zainetti 'ncoppa?".
"Andiamo da Roma a
Brindisi ".
"A piedi?".
Noi in coro:
"Certamente".
E lui: "Ma chi vi
paga?".
Noi: "Storia lunga. Ma
lei piuttosto, che fa?".
"Bagno la strada per i
mezzi pesanti che arrivano. Tra poco cominciano a lavorare quelli delle pale".
Alziamo gli occhi
verso la collina. La traccia dell'Appia, già divorata dai campi di grano e dagli
orti, muore contro un gigantesco parco eolico. Sopra di noi quattro colonne
mozze di torri in costruzione, targate Alfa Wind, immense già prima di essere
finite. Roba di ottanta metri, senza contare le pale. Ed è solo l'inizio. Le
alture e i boschi dove Federico II di Svevia andava a caccia sono talmente
scorticati dall'industria del vento che anche il gomitolo della nostra strada ci
sfugge di mano. ... Goethe, Viaggio in Italia, 1786: i Romani "lavoravano per
l'eternità. Avevano calcolato tutto, tranne la follia dei devastatori, a cui
nulla poteva resistere". Ed ecco i primi mostri, peseranno come 5- 6 carri
armati ciascuno. Lenti, inesorabili, indifferenti alla nostra presenza, passano
sull'ex 303 dissestandola definitivamente. Azienda "Ruotolo", "Fratelli Runco"
da Cosenza. Giganteschi anche gli autisti. Sembrano i padroni. E invece no, i
capi sono altri: mercenari alieni dalle mani di pianisti, giovani tecnici
stranieri che lasciano la fatica agli italiani. Passano ragazzi spagnoli, col
sorriso vagamente canzonatorio, abbronzati, in T shirt nere, su furgoni bianchi
o land-rover. Il nome della ditta, "Moncobra", sembra rubato a un film di
Tarantino. Poi gli irlandesi. Li chiamano "Erection manager", altro nome
dell'altro mondo, perché sanno erigere questi falli ad altezze paurose. Poco
oltre, un podere, con un contadino che suda attorno ai pomodori. Gli chiedo cosa
pensa dei giganti intorno a lui, ma non risponde. Come se il mondo non lo
riguardasse. Ma che fai, vorrei dirgli, non vedi che sei rimasti solo, che i
vincenti sono loro? Non capisci che qui nessun politico verrà mai, e tantomeno a
piedi, a vedere cosa sta succedendo quassù? Guarda cosa è accaduto a San Giorgio
la Molara, sopra Benevento, diventata inaccessibile perché l'eolico gli ha
devastato le strade. E guarda qui a due passi, in contrada San Nicola. Hanno
espropriato terreni agricoli per fare una enorme centrale elettrica collegata
alle pale, e l'hanno dichiarata "temporanea". Ma qui nulla è temporaneo. Qui si
svende l'Italia. E ognuno sa che è "per sempre". Ancora torri immense. Di una è
stato appena scavato il basamento, grande come mezzo stadio di calcio. Oltre,
bulldozer sventrano altri campi da grano, e lo sterro lascia ai lati montagne di
detriti che saranno spianati chissà quando. La morte della strada è certificata
dai ruderi di una cantoniera: "Anas" c'era scritto, ma è rimasta solo la lettera
"A", e tu ti chiedi perché in Italia non esiste il reato di incuria e abbandono
del pubblico bene. Attorno, la dolcezza dei declivi, anziché consolarti, ti ara
l'anima e ti fa schiumare di rabbia. Capisci di essere un vano ficcanaso, un
moscerino impotente; se ne accorge anche l'ultimo degli operai. "Che fate?" ci
chiedono da un cantiere. "Un film", rispondiamo. "E come si chiama?". "Appia
antica". E loro giù a ridere. Dalla cima del colle, chiamato Torre della
Cisterna, appare la Puglia sterminata a desertica. L'unica terra, forse, che le
pale eoliche non riescono a schiacciare, ma paradossalmente sembrano mettere a
misura. Sotto di noi, una superstrada e una ferrovia, con una traccia plausibile
dell'Appia che passa sotto i piloni di entrambe. Ma è subito Far West, il corpo
a corpo col filo spinato, poi con una recinzione abusiva, infine con un canneto,
dal quale usciamo quasi nuotando, tenuti su dal fogliame, senza toccare il
terreno, pieni di sete e graffiati da capo a piedi. Ma Riccardo, la nostra
guida, ritrova il gomitolo e apre la strada, tranquillo. Sulla mappa Igm c'è
scritto "strada provinciale di Leonessa", ma la strada è solo uno sterrato senza
anima viva. Tracce di basolato sotto un dito di polvere. E noi avanti, tra i
campi, fino a una valletta incantata piena di ginestre. Profumo da sballo. In
cima, un ripetitore. E la vista magnifica sul castello di Melfi.
Le pale eoliche sono l'Isis, la
Basilicata la nostra Palmira.
In nome di un finto progresso il paesaggio di un'intera regione è
stato sfregiato da impianti mostruosi. Regalando solo povertà, scrive Vittorio
Sgarbi su “Il Giornale”. Altroché elicotteri che spargono petali! Nulla può dare
più dolore, a chi ama Roma e la sua storia, della distruzione, sul nostro corpo,
sulla nostra memoria, sulla nostra anima, del tempio di Baal Shamin. E il fumo
che si alza dalle rovine, un fungo che richiama i più tragici simboli della
guerra, fino all'assurda violenza della bomba atomica, in un richiamo doloroso
tanto più dove non c'è nessun nemico, ma solo pietre di un mondo perduto, è
un'immagine intollerabile che mai vorrei vedere. E, dietro quel fumo, le teste
decapitate dei martiri. Gli attentati criminali a Ninive, a Nimrud, a Hatra, in
un crescendo di violenza e di terrore, sono macabri annunci che minacciano di
non avere fine. Qualcuno può consolarsi pensando che in Italia non potrebbe
accadere. E invece accade, in un silenzio ancora più tombale dell'indifferenza
per i morti e le rovine di Palmira, di chi si indigna per il carro funebre di
Totò. L'Isis è a casa nostra e, per di più, con la presa in giro della tutela
dei beni culturali, del territorio, del paesaggio, dell'ambiente. Ecco, negli
anni Settanta l'ideologia pseudo marxista aveva innalzato la bandiera dell'ambientalismo,
trasformando anche parole e concetti; e contrabbandando il paesaggio in
territorio e le belle arti in beni culturali. Sono stato io, al ministero, a
ripristinare la terminologia «belle arti» e «paesaggio». Ma era ormai troppo
tardi. Orrori non a Palmira ma nel centro storico di Roma venivano imposti da
sindaci e ministri, dopo preventiva distruzione del passato: penso alla teca di
Richard Meier, all'Ara Pacis; penso allo sconvolgimento di Piazza San Cosimato;
penso alla cancellazione di Bernini da Piazza Montecitorio. Tutto questo è
accaduto con il consenso delle autorità. Fino allo sconvolgente allestimento su
un trampolino da piscina del Marco Aurelio, sottratto alla piazza del
Campidoglio. Ovunque sono cresciuti orrori: a Firenze il Palazzo di Giustizia, a
Venezia il cubo di Santa Chiara. Oggi, mentre i colleghi dell'Isis distruggono
indisturbati, indisturbati lavorano i costruttori di casa nostra. Ma non bastava
sconvolgere il volto del territorio con edifici innominabili. Occorreva proprio
intervenire capillarmente sul paesaggio. Ed ecco allora che, prima il Molise e
la Puglia, e ora la Basilicata, sono state cancellate; nella prospettiva di
Matera capitale europea della cultura, la strada per raggiungere quella città è
stata puntellata di pale eoliche, con una accelerazione tipica di chi teme di
perdere il vantaggio che norme della incivile Europa hanno concesso a
speculatori e facilitatori. Superata Benevento, martoriata da rotatorie decorate
con immagini di Padre Pio lanciato verso il cielo, si iniziano a vedere
centinaia e centinaia di croci, in disordine, rarefatte o affollate. Sono pale
che non girano, ferme, piantate su tutti i colli a perdita d'occhio. Da
Grottaminarda a Flumeri, a Frigento, a Gesualdo, a Buonabitacolo, ad Accadia, a
Sant'Agata, a Lacedonia, a Candela, a Palazzo San Gervasio, a Spinazzola, a
Genzano di Lucania, ad Ascoli Satriano, a Canosa, a Troia, a Foggia. Via via,
come alberi di una foresta meccanica, con l'ironia di chiamarne la insensata
proliferazione senza ordine né logica, che non sia la cupidigia, di permesso in
permesso, di amministrazioni comunali, regionali, intrinsecamente mafiose, in
una stabile trattativa con uno Stato criminale, parchi eolici. Ed è inutile
richiamare quello Stato e quell'Antimafia, che si agitano per la colonna sonora
del Padrino o per un comico manifesto, al rispetto dell'art. 9 della
Costituzione, scritto per garantire un mondo perduto, all'opposto di quello che
vediamo. E quando vandali su vandali bruciano i boschi, eccoli non trovare più
alberi, ma incendiare pale, il cui fusto è nero. E nero resterà fino a quando
una mano pietosa tenterà di svellere quei giganteschi chiodi che hanno
crocifisso i colli, stuprandoli e riempiendoli di cemento armato fino al
midollo. Intorno la vegetazione è scomparsa, gli uccelli volano altrove, ma i
nostri occhi contemplano l'orrore dove fino a qualche anno fa c'era la curva di
dolci colline. E qualcuno avrà detto: «Ma non sono luoghi importanti, non ci
sono monumenti significativi» (e non è vero). Una ragione in più per lasciare
integro un paesaggio e conservargli la bellezza del suo essere remoto, lontano,
una meraviglia da scoprire. Nessun paesaggio è meno importante di un altro, in
Italia. E sembra assai singolare che le stesse autorità che hanno assistito
imprudenti e complici, magari magnificando l'energia pulita, a danno di una
purissima bellezza, siano oggi, con le stesse espressioni, a celebrare la
romantica difesa di paesi abbandonati, di borghi dimenticati, in alcune giornate
disperatamente dedicate alla memoria di un uomo giusto che oggi sarebbe
furibondo e che non aveva previsto, tra i vari aspetti positivi un riscatto del
meridione e della Basilicata attraverso la cultura. Mi riferisco a Carlo Levi e
al Festival della Luna e i Calanchi ad Aliano, dove Levi fu al confino.
L'organizzatore Franco Arminio pensa agli antichi forni, alle tradizioni, ai
canti, alla lingua, in un riscatto di ciò che il progresso ha cancellato nel
disprezzo per la povertà. Ed è bellissimo sulla carta. Ma le colline sono
perdute. Arminio coltiva la «paesologia». Ed è forse troppo tardi. Così come
Carmen Pellegrino inventaria paesi abbandonati (e forse per questo salvati),
autodeterminandosi come «abbandonologa». Ma niente è meno abbandonato di ciò che
vive dentro noi, e che i barbari minacciano e distruggono, come l'Isis ha fatto
con il tempio di Baal Shamin. E mentre noi ci difendiamo in trincea, ad Aliano,
ovunque sono disseminate mine e lanciate bombe, esattamente come a Palmira con
le mostruose pale eoliche e gli immondi pannelli fotovoltaici. Vorremmo
cominciare veramente una lotta contro la mafia e il potere che la sostiene
invece che declinarla in prediche, appelli, e luoghi comuni. Qui, i luoghi e la
bellezza comune, risparmiati per secoli, si sono sottratti. Un paesaggio perduto
è come un tempio distrutto. E non ho mai visto difendere questi paesaggi
sfregiati quelle autorità sconcertate contro i simboli, e pronte a dichiarare e
a scrivere la loro indignazione per i carri funebri trainati dai cavalli
convocati dalla mafia. I simboli di mafia, cari Saviano, don Ciotti, Boldrini,
Alfano, sono queste violentissime ferite al paesaggio (non petali di rose) che
voi vi ostinate a non vedere, e che rappresentano la più terribile testimonianza
del patto Stato-mafia degli ultimi 10 anni. Franco Arminio si rifugia nel paese
di Carlo Levi, e le massime autorità dello Stato applaudono. Sordi, ciechi,
muti.
E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.
Perché leggere Antonio Giangrande?
Ognuno di noi è segnato nella sua esistenza da un
evento importante. Chi ha visto il film si chiede: perché la scena finale de
“L’attimo fuggente”, ogni volta, provoca commozione? Il professor John Keating (Robin
Williams), cacciato dalla scuola, lascia l’aula per l’ultima volta. I suoi
ragazzi, riabilitati da lui dalla corruzione culturale del sistema, non ci
stanno, gli rendono omaggio. Uno dopo l’altro, salgono in piedi sul banco ed
esclamano: «Capitano, mio capitano!». Perché quella scena è così potente ed
incisiva? Quella scena ci colpisce perché tutti sentiamo d’aver bisogno di
qualcuno che ci insegni a guardare la realtà senza filtri. Desideriamo, magari
senza rendercene conto, una guida che indichi la strada: per di là. Senza
spingerci: basta l’impulso e l’incoraggiamento. Il pensiero va a quella poesia
che il vate americano Walt Whitman scrisse dopo l'assassinio del presidente
Abramo Lincoln, e a lui dedicata. Gli stessi versi possiamo dedicare a tutti
coloro che, da diversi nell'omologazione, la loro vita l’hanno dedicata per
traghettare i loro simili verso un mondo migliore di quello rispetto al loro
vivere contemporaneo. Il Merito: Valore disconosciuto ed osteggiato in vita,
onorato ed osannato in morte.
Robin Williams è il professor Keating nel film
L'attimo fuggente (1989)
Oh! Capitano, mio Capitano, il tremendo viaggio
è compiuto,
La nostra nave ha resistito ogni tempesta:
abbiamo conseguito il premio desiderato.
Il porto è prossimo; odo le campane, il popolo
tutto esulta.
Mentre gli occhi seguono la salda carena,
la nave austera e ardita.
Ma o cuore, cuore, cuore,
O stillanti gocce rosse
Dove sul ponte giace il mio Capitano.
Caduto freddo e morto.
O Capitano, mio Capitano, levati e ascolta le
campane.
Levati, per te la bandiera sventola, squilla
per te la tromba;
Per te mazzi e corone e nastri; per te le
sponde si affollano;
Te acclamano le folle ondeggianti, volgendo i
Walt Whitman (1819-1892) cupidi volti.
Qui Capitano, caro padre,
Questo mio braccio sotto la tua testa;
È un sogno che qui sopra il ponte
Tu giaccia freddo e morto.
Il mio Capitano tace: le sue labbra sono
pallide e serrate;
Il mio padre non sente il mio braccio,
Non ha polso, né volontà;
La nave è ancorata sicura e ferma ed il ciclo
del viaggio è compiuto.
Dal tremendo viaggio la nave vincitrice arriva
col compito esaurito,
Esultino le sponde e suonino le campane!
Ma io con passo dolorante
Passeggio sul ponte, ove giace il mio Capitano
caduto freddo e morto.
Antonio Giangrande. Un capitano necessario. Perché
in Italia non si conosce la verità. Gli italiani si scannano per la politica,
per il calcio, ma non sprecano un minuto per conoscere la verità. Interi
reportage che raccontano l’Italia di oggi “salendo sulla cattedra” come avrebbe
detto il professore Keating dell’attimo fuggente e come ha cercato di fare lo
scrittore avetranese Antonio Giangrande.
Chi sa: scrive, fa, insegna.
Chi non sa: parla e decide.
Chissà perché la tv ed i giornali gossippari e
colpevolisti si tengono lontani da Antonio Giangrande. Da quale pulpito vien la
predica, dott. Antonio Giangrande?
Noi siamo quel che facciamo: quello che diciamo
agli altri è tacciato di mitomania o pazzia. Quello che di noi gli altri dicono
sono parole al vento, perche son denigratorie. Colpire la libertà o l’altrui
reputazione inficia gli affetti e fa morir l’anima.
La calunnia è un venticello
un’auretta assai gentile
che insensibile sottile
leggermente dolcemente
incomincia a sussurrar.
Piano piano terra terra
sotto voce sibillando
va scorrendo, va ronzando,
nelle orecchie della gente
s’introduce destramente,
e le teste ed i cervelli
fa stordire e fa gonfiar.
Dalla bocca fuori uscendo
lo schiamazzo va crescendo:
prende forza a poco a poco,
scorre già di loco in loco,
sembra il tuono, la tempesta
che nel sen della foresta,
va fischiando, brontolando,
e ti fa d’orror gelar.
Alla fin trabocca, e scoppia,
si propaga si raddoppia
e produce un’esplosione
come un colpo di cannone,
un tremuoto, un temporale,
un tumulto generale
che fa l’aria rimbombar.
E il meschino calunniato
avvilito, calpestato
sotto il pubblico flagello
per gran sorte va a crepar.
E’ senza dubbio una delle arie più famose (Atto I)
dell’opera lirica Il Barbiere di Siviglia del 1816 di Gioacchino
Rossini (musica) e di Cesare Sterbini (testo e libretto). E’ l’episodio in cui
Don Basilio, losco maestro di musica di Rosina (protagonista femminile
dell’opera e innamorata del Conte d’Almaviva), suggerisce a Don Bartolo (tutore
innamorato della stessa Rosina) di screditare e di calunniare il Conte,
infamandolo agli occhi dell’opinione pubblica. Il brano “La calunnia è un
venticello…” è assolutamente attuale ed evidenzia molto bene ciò che avviene (si
spera solo a volte) nella quotidianità di tutti noi: politica, lavoro, rapporti
sociali, etc.
Alla fine di noi rimane il nostro operato, checché
gli altri ne dicano. E quello bisogna giudicare. Nasco da una famiglia umile e
povera. Una di quelle famiglie dove la sfortuna è di casa. Non puoi permetterti
di studiare, né avere amici che contano. Per questo il povero è destinato a fare
il manovale o il contadino. Mi sono ribellato e contro la sorte ho voluto
studiare, per salire nel mondo non mio. Per 17 anni ho cercato di abilitarmi
nell’avvocatura. Non mi hanno voluto. Il mondo di sotto mi tiene per i piedi; il
mondo di sopra mi calca la testa. In un esame truccato come truccati sono tutti
i concorsi pubblici in Italia: ti abilitano se non rompi le palle. Tutti uguali
nella mediocrità. Dal 1998 ho partecipato all’esame forense annuale. Sempre
bocciato. Ho rinunciato a proseguire nel 2014 con la commissione presieduta
dall’avv. Francesco De Jaco. L’avvocato di Cosima Serrano condannata con la
figlia Sabrina Misseri per il delitto di Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana.
Tutte mie compaesane. La Commissione d’esame di avvocato di Lecce 2014. La più
serena che io abbia trovato in tutti questi anni. Ho chiesto invano a De Jaco di
tutelare me, dagli abusi in quell’esame, come tutti quelli come me che non hanno
voce. Se per lui Cosima è innocente contro il sentire comune, indotti a pensarla
così dai media e dai magistrati, perché non vale per me la verità che sia
vittima di un sistema che mi vuol punire per essermi ribellato? Si nega
l’evidenza. 1, 2, 3 anni, passi. 17 anni son troppi anche per il più deficiente
dei candidati. Ma gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Compiti non
corretti, ma ritenuti tali in tempi insufficienti e senza motivazione e con
quote prestabilite di abilitati. Così per me, così per tutti. Gli avvocati
abilitati negano l’evidenza. Logico: chi passa, non controlla. Ma 17 anni son
troppi per credere alla casualità di essere uno sfigato, specialmente perché i
nemici son noti, specie se sono nelle commissioni d’esame. In carcere o
disoccupato. Tu puoi gridare a squarciagola le ingiustizie, ma nessuno ti
ascolta, in un mondo di sordi. Nessuno ti crede. Fino a che non capiti a loro. E
in questa Italia capita, eccome se capita! La tua verità contro la verità del
potere. Un esempio da raccontare. Ai figli non bisogna chiedere cosa vogliono
fare da grandi. Bisogna dir loro la verità. Chiedergli cosa vorrebbero che gli
permettessero di fare da grandi. Sono nato in quelle famiglie che, se ti capita
di incappare nelle maglie della giustizia, la galera te la fai, anche da
innocente. A me non è successo di andare in galera, pur con reiterati tentativi
vani da parte della magistratura di Taranto, ma sin dal caso Tortora ho capito
che in questa Italia in fatto di giustizia qualcosa non va. Pensavo di essere di
sinistra, perché la sinistra è garantismo, ma non mi ritrovo in un’area dove si
tollerano gli abusi dei magistrati per garantirsi potere ed impunità. E di tutto
questo bisogna tacere. A Taranto, tra i tanti processi farsa per tacitarmi sulle
malefatte dei magistrati, uno si è chiuso, con sentenza del Tribunale n.
147/2014, con l’assoluzione perché il fatto non sussiste e per non doversi
procedere. Bene: per lo stesso fatto si è riaperto un nuovo procedimento ed è
stato emesso un decreto penale di condanna con decreto del Gip. n. 1090/2014:
ossia una condanna senza processo. Tentativo stoppato dall’opposizione.
Zittirmi sia mai. Pur isolato e perseguitato. Gli
italiani son questi. Ognuno dia la sua definizione. Certo è che gli italiani non
mi leggono, mi leggono i forestieri. Mi leggeranno i posteri. Tutto regolare: lo
ha detto la tv, lo dicono i giudici. Per me, invece, è tutto un trucco. In un
mondo di ladri nessuno vien da Marte. Tutti uguali: giudicanti e giudicati.
E’ da decenni che studio il sistema Italia, a carattere locale come a livello
nazionale. Da queste indagini ne sono scaturiti decine di saggi, raccolti in una
collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo", letti in tutto il
mondo, ma che mi sono valsi l’ostruzionismo dei media nazionali. Pennivendoli
venduti ai magistrati, all’economia ed alla politica, ma che non impediscono il
fatto che di me si parli su 200.000 siti web, come accertato dai motori di
ricerca. Book ed E-Book che si possono trovare su Amazon.it, Lulu.com.
CreateSpace.com e Google Libri, oltre che in forma di lettura gratuita e free
vision video su
www.controtuttelemafie.it, mentre la promozione
del territorio è su
www.telewebitalia.eu.
Ha la preparazione professionale per poter dire la
sua in questioni di giustizia?
Non sono un giornalista, ma a quanto pare sono
l’unico a raccontare tutti i fatti. Non sono un avvocato ma mi diletto ad
evidenziare le manchevolezze di un sistema giudiziario a se stante. La mia
emigrazione in piena adolescenza in Germania a 16 anni per lavorare; la mia
laurea quadriennale in Giurisprudenza presa in soli due anni all’Università
Statale di Milano, lavorando di notte e con moglie e due figli da mantenere,
dopo aver conseguito il diploma da ragioniere in un solo anno da privatista
presso un Istituto tecnico Statale e non privato, per non sminuirne
l’importanza, portando tutti i 5 anni di corso; tutto ciò mi ha reso immune da
ogni condizionamento culturale od ambientale. I miei 6 anni di esercizio del
patrocinio legale mi hanno fatto conoscere le macagne di un sistema che non è
riuscito a corrompermi. Per questo dal 1998 al 2014 non mi hanno abilitato alla
professione di avvocato in un esame di Stato, che come tutti i concorsi pubblici
ho provato, con le mie ricerche ed i miei libri, essere tutti truccati. Non mi
abilitano. Perché non sono uguale agli altri, non perché son meno capace. Non mi
abilitano perché vedo, sento e parlo. Ecco perché posso parlare di cose
giuridiche in modo di assoluta libertà, senza condizionamento corporativistico,
anche a certezza di ritorsione. E’ tutta questione di coscienza.
E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.
A’ Cuscienza di Antonio de Curtis-Totò
La coscienza
Volevo sapere che cos'è questa coscienza
che spesso ho sentito nominare.
Voglio esserne a conoscenza,
spiegatemi, che cosa significa.
Ho chiesto ad un professore dell'università
il quale mi ha detto: Figlio mio, questa parola si
usava, si,
ma tanto tempo fa.
Ora la coscienza si è disintegrata,
pochi sono rimasti quelli, che a questa parola
erano attaccati,
vivendo con onore e dignità.
Adesso c'è l'assegno a vuoto, il peculato, la
cambiale, queste cose qua.
Ladri, ce ne sono molti di tutti i tipi, il
piccolo, il grande,
il gigante, quelli che sanno rubare.
Chi li denuncia a questi ?!? Chi si immischia in
questa faccenda ?!?
Sono pezzi grossi, chi te lo fa fare.
L'olio lo fanno con il sapone di piazza, il burro
fa rimettere,
la pasta, il pane, la carne, cose da pazzi, Si è
aumentata la mortalità.
Le medicine poi, hanno ubriacato anche quelle,
se solo compri uno sciroppo, sei fortunato se
continui a vivere.
E che vi posso dire di certe famiglie, che la
pelle fanno accapponare,
mariti, mamme, sorelle, figlie fatemi stare zitto,
non fatemi parlare.
Perciò questo maestro di scuola mi ha detto,
questa conoscenza (della coscienza)
perchè la vuoi fare, nessuno la usa più questa
parola,
adesso arrivi tu e la vuoi ripristinare.
Insomma tu vuoi andare contro corrente, ma questa
pensata chi te l'ha fatta fare,
la gente di adesso solo così è contenta, senza
coscienza,
vuole stentare a vivere. (Vol tirà a campà)
L’ITALIA, IL PAESE DEI NO. LA SINDROME DI
NIMBY.
Vengo anch'io. No, tu no (1967 - Fo, Jannacci)
Inserita nell'album omonimo (che contiene una
schidionata di brani indimenticabili: si va da "Giovanni, telegrafista" a
"Pedro, Pedreiro", da "Ho visto un re" a "Hai pensato mai", quest'ultima
versione in lingua della stupenda "Gastu mai pensà" di Lino Toffolo), "Vengo
anch'io. No, tu no" (1967) porta Enzo Jannacci in cima alle classifiche di
vendite, con esiti commerciali mai più ripetuti nel corso della sua lunga
carriera. Assai accattivante nell'arrangiamento, attraversato da elementi
circensi, la canzone divenne una sorta di inno di tutti gli esclusi d'Italia dai
grandi rivolgimenti in atto - siamo, ricordiamolo, nel '68 - perchè snobbati
dall'intellighenzia dell'epoca. Grazie a versi beffardi e surreali, scritti da
Jannacci in sostituzione di quelli originariamente vergati perlopiù da Dario Fo
e maggiormente ancorati al reale, il brano s'imprime nella memoria collettiva,
diviene una sorta di tormentone nazionale, contribuisce in larga misura a far
conoscere ad un pubblico più vasto la figura di un artista inclassificabile
quanto geniale.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale
Vengo anch'io? No tu no
Per vedere come stanno le bestie feroci
e gridare "Aiuto aiuto e` scappato il leone"
e vedere di nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
Si potrebbe andare tutti quanti ora che è
primavera
Vengo anch'io? No tu no
Con la bella sottobraccio a parlare d'amore
e scoprire che va sempre a finire che piove
e vedere di nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore
Vengo anch'io? No tu no
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano
un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore
e vedere di nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale
Vengo anch'io? No tu no
per vedere se la gente poi piange davvero
e scoprire che è per tutti una cosa normale
e vedere di nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
No, no e 354 volte no. La sindrome Nimby
(Not in my back yard, "non nel mio cortile") va ben oltre il significato
originario. Non solo contestazioni di comitati che non
vogliono nei dintorni di casa infrastrutture o insediamenti industriali: 354,
appunto, bloccati solo nel 2012 (fonte Nimby Forum). Ormai siamo in piena
emergenza Nimto – Not in my term of office, "non nel mio mandato" – e
cioè quel fenomeno che svela l’inazione dei decisori pubblici. Nel Paese dei
mille feudi è facile rinviare decisioni e scansare responsabilità. La protesta
è un’arte, e gli italiani ne sono indiscussi maestri. Ecco quindi pareri "non
vincolanti" di regioni, province e comuni diventare veri e propri niet, scrive
Alessandro Beulcke su “Panorama”. Ministeri e governo, in un devastante regime
di subalternità perenne, piegano il capo ai masanielli locali. Tempi
decisionali lunghi, scelte rimandate e burocrazie infinite. Risultato: le
multinazionali si tengono alla larga, le grandi imprese italiane ci pensano due
volte prima di aprire uno stabilimento. Ammonterebbe così a 40 miliardi di euro
il "costo del non fare" secondo le stime di Agici-Bocconi. E di questi tempi,
non permettere l’iniezione di capitali e lavoro nel Paese è una vera follia.
NO TAV, NO dal Molin, NO al nucleare, NO
all’ingresso dei privati nella gestione dell’acqua: negli ultimi tempi l’Italia
è diventata una Repubblica fondata sul NO? A quanto
pare la paura del cambiamento attanaglia una certa parte dell’opinione pubblica,
che costituisce al contempo bacino elettorale nonché cassa di risonanza
mediatica per politici o aspiranti tali (ogni riferimento è puramente
casuale). Ciò che colpisce è la pervicacia con la quale, di volta in volta, una
parte o l’altra del nostro Paese si barrica dietro steccati culturali,
rifiutando tutto ciò che al di fuori dei nostri confini è prassi comune. Le
battaglie tra forze dell’ordine e manifestanti NO TAV non si sono verificate né
in Francia né nel resto d’Europa, nonostante il progetto preveda
l’attraversamento del continente da Lisbona fino a Kiev: è possibile che solo in
Val di Susa si pensi che i benefici dell’alta velocità non siano tali da
compensare l’inevitabile impatto ambientale ed i costi da sostenere? E’
plausibile che sia una convinzione tutta italica quella che vede i treni ad alta
velocità dedicati al traffico commerciale non rappresentare il futuro ma, anzi,
che questi siano andando incontro a un rapido processo di obsolescenza? Certo,
dire sempre NO e lasciare tutto immutato rappresenta una garanzia di
sicurezza,soprattutto per chi continua a beneficiare di rendite di posizione
politica, ma l’Italia ha bisogno di cambiamenti decisi per diventare finalmente
protagonista dell’Europa del futuro. NO?
Il Paese dei "No" a prescindere. Quando
rispettare le regole è (quasi) inutile. In Italia non
basta rispettare le regole per riuscire ad investire nelle grandi
infrastrutture. Perché le regole non sono una garanzia in un Paese dove ogni
decisione è messa in discussione dai mal di pancia fragili e umorali della
piazza. E di chi la strumentalizza, scrive l’imprenditore Massimiliano Boi. Il
fenomeno, ben noto, si chiama “Nimby”, iniziali dell’inglese Not In My
Backyard (non nel mio cortile), ossia la protesta contro opere di interesse
pubblico che si teme possano avere effetti negativi sul territorio in cui
vengono costruite. I veti locali e l’immobilismo decisionale ostacolano progetti
strategici e sono il primo nemico per lo sviluppo dell’Italia. Le contestazioni
promosse dai cittadini sono “cavalcate” (con perfetta par condicio) dalle
opposizioni e dagli stessi amministratori locali, impegnati a contenere ogni
eventuale perdita di consenso e ad allontanare nel tempo qualsiasi decisione
degna di tale nome. Dimenticandosi che prendere le decisioni è il motivo per il
quale, in definitiva, sono stati eletti. L’Osservatorio del Nimby
Forum (nimbyforum.it) ha verificato che dopo i movimenti dei cittadini (40,7%) i
maggiori contestatori sono gli amministratori pubblici in carica (31,4%) che
sopravanzano di oltre 15 punti i rappresentanti delle opposizioni. Il sito
nimbyforum.it, progetto di ricerca sul fenomeno delle contestazioni territoriali
ambientali gestito dall'associazione no profit Aris, rileva alla settima
edizione del progetto che in Italia ci sono 331 le infrastrutture e impianti
oggetto di contestazioni (e quindi bloccati). La fotografia che emerge è quella
di un paese vecchio, conservatore, refrattario ad ogni cambiamento. Che non
attrae investimenti perché è ideologicamente contrario al rischio d’impresa. Il
risultato, sotto gli occhi di tutti, è la tendenza allo stallo. Quella che i
sociologi definiscono “la tirannia dello status quo”, cioè dello stato di
fatto, quasi sempre insoddisfacente e non preferito da nessuno. A forza di "no"
a prescindere, veti politici e pesanti overdosi di burocrazia siamo riusciti
(senza grandi sforzi) a far scappare anche le imprese straniere. La statistica è
piuttosto deprimente: gli investimenti internazionali nella penisola valgono 337
miliardi, la metà di quelli fatti in Spagna e solo l’1,4% del pil, un terzo in
meno di Francia e Germania. Un caso per tutti, raccontato da Ernesto Galli Della
Loggia. L’ex magistrato Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, città assurta
come zimbello mondiale della mala gestione dei rifiuti, si è insediato come
politico “nuovo”, “diverso”, “portatore della rivoluzione”. Poi, dicendo “no” ai
termovalorizzatori per puntare solo sulla raccolta differenziata, al molo 44
Area Est del porto partenopeo, ha benedetto l’imbarco di 3 mila tonn di
immondizia cittadina sulla nave olandese “Nordstern” che, al prezzo di 112 euro
per tonn, porterà i rifiuti napoletani nel termovalorizzatore di Rotterdam. Dove
saranno bruciati e trasformati in energia termica ed elettrica, a vantaggio
delle sagge collettività locali che il termovalorizzatore hanno voluto. Ma senza
andare lontano De Magistris avrebbe potuto pensare al termovalorizzatore di
Brescia, dove pare che gli abitanti non abbiano l’anello al naso. Scrive Galli
Della Loggia: “Troppo spesso questo è anche il modo in cui, da tempo, una
certa ideologia verde cavalca demagogicamente paure e utopie, senza
offrire alcuna alternativa reale, ma facendosi bella nel proporre soluzioni che
non sono tali”.
«C’è un disegno, che lacera, scoraggia e divide e
quindi è demoniaco, al quale non dobbiamo cedere nonostante esempi e condotte
disoneste, che approfittano del denaro, del potere, della fiducia della gente,
perfino della debolezza e delle paure. E’ quello di dipingere il nostro Paese
come una palude fangosa dove tutto è insidia, sospetto, raggiro e corruzione. -
Aprendo i lavori del parlamentino dei vescovi italiani del 27-30 gennaio 2014 ,
il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, rassicura sulla tenuta morale del
paese e chiede a tutti – di reagire ad una visione esasperata e interessata che
vorrebbe accrescere lo smarrimento generale e spingerci a non fidarci più di
nessuno. L’Italia non è così - afferma il cardinale - nulla – scandisce – deve
rubarci la speranza nelle nostre forze se le mettiamo insieme con sincerità.
Come Pastori – rileva il porporato – non possiamo esimerci dal dire una parola
sul contesto sociale che viviamo, consapevoli di dover dare voce a tanti che non
hanno voce e volto, ma che sono il tessuto connettivo del Paese con il loro
lavoro, la dedizione, l’onestà.»
IL SUD TARTASSATO.
Sud tartassato: il Meridione paga più di tutti,
scrive Lanfranco Caminiti su “Il Garantista”. Dice la Svimez che se muori e vuoi
un funerale come i cristiani, è meglio che schiatti a Milano, che a Napoli ti
trattano maluccio. E non ti dico a Bari o a Palermo, una schifezza. A Milano si
spende 1.444,23 euro per defunto, a Napoli 988 euro, a Bari 892 euro e 19
centesimi, a Palermo 334 euro. A Palermo, cinque volte meno che a Milano. Il
principe Antonio De Curtis, in arte Totò, si rivolterà nella tomba, che a quanto
pare non c’è nessuna livella, dopo morti. E checcazzo, e neppure lì terroni e
polentoni siamo uguali. E basterebbe solo questo – il culto dei morti dovrebbe
antropologicamente “appartenere” alle società meridionali, era il Sud la terra
delle prefiche, era il Sud la terra delle donne in nero, era il Sud la terra dei
medaglioni con la fotina dell’estinto che pendono sul petto delle vedove – per
dire come questa Italia sia cambiata e rovesciata sottosopra. Si paga al Sud di
più per tutto, per l’acqua, la monnezza, l’asilo, gli anziani, la luce nelle
strade, i trasporti, insomma per i Lep, come dicono quelli che studiano queste
cose: livelli essenziali delle prestazioni. Essenziali lo sono, al Sud, ma
quanto a prestazioni, zero carbonella. Eppure, Pantalone paga. Paga soprattutto
la classe media meridionale che si era convinta che la civilizzazione passasse
per gli standard nazionali. Paghiamo il mito della modernizzazione. Paghiamo
l’epica della statalizzazione. Paghiamo la retorica della “cosa pubblica”.
Paghiamo l’idea che dobbiamo fare bella figura, ora che i parenti ricchi, quelli
del Nord, vengono in visita e ci dobbiamo comportare come loro: non facciamoci
sempre riconoscere. Paghiamo le tasse, che per questo loro sono avanti e noi
restiamo indietro. Lo Stato siamo noi. Parla per te, dico io. Dove vivo io, un
piccolo paese del Sud, pago più tasse d’acqua di quante ne pagassi prima in una
grande città, e più tasse di spazzatura, e non vi dico com’è ridotto il cimitero
che mi viene pena solo a pensarci. Sono stati i commissari prefettizi – che
avevano sciolto il Comune – a “perequare” i prelievi fiscali. Poi sono andati
via, ma le tasse sono rimaste. Altissime, cose mai viste. In compenso però, la
spazzatura si accumula in piccole montagne. A volte le smantellano, poi si
ricomincia. Non sai mai quando, magari qualcuno dei laureati che stanno a
girarsi i pollici al baretto della piazza potrebbe studiarla, la sinusoide della
raccolta rifiuti. Invece, i bollettini arrivano in linea retta. Con la scadenza
scritta bella grossa. L’unica cosa che è diminuita in questi anni al Sud è il
senso di appartenenza a una qualche comunità più grande del nostro orto privato.
La pervasività dello Stato – e quale maggiore pervasività della sua capacità di
prelievo fiscale – è cresciuta esponenzialmente quanto l’assoluta
privatizzazione di ogni spirito meridionale. Tanto più Stato ha prodotto solo
tanta più cosa privata. E non dico solo verso la comunità nazionale, la Patria o
come diavolo vogliate chiamarla. No, proprio verso la comunità territoriale. Chi
può manda i figli lontano, perché restino lontano. Chi può compra una casa
lontano sperando di andarci il prima possibile a passare gli anni della
vecchiaia. Chi può fa le vacanze lontano, a Pasqua e a Natale, il più esotiche
possibile. Chi non può, emigra. Di nuovo, come sempre. Il Sud è diventato terra
di transito per i suoi stessi abitanti. Come migranti clandestini, non vediamo
l’ora di andarcene. il Sud dismette se stesso, avendo perso ogni identità
storica non si riconosce in quello che ha adesso intorno, che pure ha accettato,
voluto, votato.
C’era una volta l’assistenzialismo.
Rovesciati come un calzino ci siamo ritrovati contro un federalismo
secessionista della Lega Nord che per più di vent’anni ci ha sbomballato le
palle rubandoci l’unica cosa in cui eravamo maestri, il vittimismo. Siamo stati
vittimisti per più di un secolo, dall’unità d’Italia in poi, e a un certo punto
ci siamo fatti rubare la scena da quelli del Nord – e i trasferimenti di
risorse, e le pensioni, e l’assistenzialismo e la pressione fiscale e le camorre
degli appalti pubblici – e l’unica difesa che abbiamo frapposto è stata lo
Stato. Siamo paradossalmente diventati i grandi difensori dell’unità nazionale
contro il leghismo. Noi, i meridionali, quelli che il federalismo e il
secessionismo l’avevano inventato e provato. Noi, che dello Stato ce ne siamo
sempre bellamente strafottuti. Li abbiamo votati. Partiti nazionali, destra e
sinistra, sindaci cacicchi e governatori, li abbiamo votati. Ci garantivano le
“risorse pubbliche”. Dicevano. Ci promettevano il rinascimento, il risorgimento,
la resistenza. Intanto però pagate. Come quelli del Nord. Facciamogli vedere.
Anzi, di più. La crisi economica del 2007 ha solo aggravato una situazione già
deteriorata. E ormai alla deriva. È stata la classe media meridionale
“democratica” l’artefice di questo disastro, con la sua ideologia statalista.
Spesso, loro che possono, ora che le tasse sono diventate insopportabili, ora
che il Sud è sfregiato, senza più coscienza di sé, ora se ne vanno. O mandano i
loro figli lontano. Chi non può, emigra. Di nuovo, come sempre.
Non solo i cittadini italiano sono tartassati, ma
sono anche soggetti a dei disservizi estenuanti.
ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO
PARLARE CLAUDIO BISIO.
In molti mi hanno scritto chiedendomi il testo del
mio monologo effettuato durante il Festival di Sanremo 2013 il 16 Febbraio
scorso. Beh, eccolo. Inoltre alcuni di voi, sull'onda del contenuto di quel
monologo hanno creato una pagina facebook "Quelli che domenica voteranno con un
salmone". Come vedete, l'ho fatto anch'io...
Sono un italiano. Che emozione... E che paura
essere su questo palcoscenico... Per me è la prima volta. Bello però. Si sta
bene… Il problema ora è che cosa dire. Su questo palco è stato fatto e detto
davvero di tutto. E il contrario di tutto. Gorbaciov ha parlato di perestroika,
di libertà, di democrazia… Cutugno ha rimpianto l’Unione Sovietica. Gorbaciov ha
parlato di pace… e Cutugno ha cantato con l’Armata Rossa… Belen ha fatto vedere
la sua farfallina (io potrei farvi vedere il mio biscione, ma non mi sembra
un’ottima idea… è un tatuaggio che ho sulla caviglia, dopo tanti anni a Mediaset
è il minimo…) Ma soprattutto Benigni, vi ricordate quando è entrato con un
cavallo bianco imbracciando il tricolore? Ecco, la rovina per me è stato proprio
Benigni. Lo dico con una sana invidia. Benigni ha alzato troppo il livello. La
Costituzione, l'Inno di Mameli, la Divina Commedia... Mettetevi nei panni di uno
come me. Che è cresciuto leggendo Topolino... Però, se ci pensate bene, anche
Topolino, a modo suo, è un classico. Con la sua complessità, il suo spessore
psicologico, le sue contraddizioni… Prendete Nonna Papera, che animale è? ...
chi ha detto una nonna? Non fate gli spiritosi anche voi, è una papera. Ma è una
papera che dà da mangiare alle galline. Tiene le mucche nella stalla... Mentre
invece Clarabella, che anche lei è una mucca, non sta nella stalla, sta in una
casa con il divano e le tendine. E soprattutto sta con Orazio, che è un cavallo.
Poi si lamentano che non hanno figli... Avete presente Orazio, che fa il bipede,
l’antropomorfo, però ha il giogo, il morso, il paraocchi. Il paraocchi va bene
perché Clarabella è un cesso, ma il morso?!? Ah, forse quando di notte arriva
Clarabella con i tacchi a spillo, la guêpiere, la frusta: "Fai il Cavallo! Fai
il cavallo!" nelle loro notti sadomaso… una delle cinquanta sfumature di biada.
E Qui Quo Qua. Che parlano in coro. Si dividono una frase in tre, tipo: "ehi
ragazzi attenti che arriva Paperino/ e/ ci porta tutti a Disneyland", oppure:
"ehi ragazzi cosa ne direste di andare tutti/ a/ pescare del pesce che ce lo
mangiamo fritto che ci piace tanto..." ecco, già da queste frasi, pur banali se
volete, si può evincere come a Quo toccassero sempre le preposizioni semplici,
le congiunzioni, a volte solo la virgola: "ehi ragazzi attenti che andando in
mezzo al bosco/, / rischiamo di trovare le vipere col veleno che ci fanno del
male" inoltre Quo ha sempre avuto un problema di ubicazione, di orientamento...
non ha mai saputo dove fosse. Tu chiedi a Qui: "dove sei?" "sono qui!" ...
Chiedi a Qua "dove sei?", e lui: "sono qua!" tu prova a chiederlo a Quo. Cosa ti
dice? "sono Quo?" Cosa vuol dire? Insomma Quo è sempre stato il più sfigato dei
tre, il più insulso: non riusciva né a iniziare né a finire una frase, non era
né qui, né qua... Mario Monti. Mari o Monti? Città o campagna? Carne o Pesce? Lo
so. So che siamo in piena par condicio e non si può parlare di politica. Ma
sento alcuni di voi delusi dirsi: ma come, fra sette giorni ci sono le elezioni.
E questo qui ci parla di mucche e galline... Altri che invece penseranno: basta
politica! Io non voglio nascondermi dietro a un dito, anche perché non ne ho
nessuno abbastanza grosso… decidete voi, volendo posso andare avanti per altri
venti minuti a parlare di fumetti, oppure posso dirvi cosa penso io della
situazione politica… Ve lo dico? Io penso che finché ci sono LORO, non
riusciremo mai a cambiare questo paese. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Non
mantengono le promesse. Sono incompetenti, bugiardi, inaffidabili. Credono di
avere tutti diritti e nessun dovere. Danno sempre la colpa agli altri… A CASA!
Tutti a casa!!! (A parte che quando dici tutti a casa devi stare attento,
specificare: a casa di chi? No perché non vorrei che venissero tutti a casa mia)
Vedo facce spaventate... soprattutto nelle prime file... Lo so, non devo parlare
dei politici, ho firmato fior di contratti, ci sono le penali... Ma chi ha detto
che parlo dei politici? Cosa ve l'ha fatto pensare? Ah, quando ho detto
incompetenti, bugiardi, inaffidabili? Ma siete davvero maliziosi... No, non
parlavo dei politici. Anche perché, scusate, i politici sono in tutto poche
centinaia di persone... cosa volete che cambi, anche se davvero se ne tornassero
tutti a casa (casa loro, ribadisco)? Poco. No, quando dicevo che devono andare
tutti a casa, io non stavo parlando degli eletti. Io stavo parlando degli
elettori... stavo parlando di NOI. Degli italiani. Perché, a fare bene i conti,
la storia ci inchioda: siamo noi i mandanti. Siamo noi che li abbiamo votati. E
se li guardate bene, i politici, ma proprio bene bene bene... è davvero
impressionante come ci assomigliano: I politici italiani… sono Italiani!
Precisi, sputati. Magari, ecco, con qualche accentuazione caricaturale. Come le
maschere della commedia dell'arte, che sono un po' esagerate, rispetto al
modello originale. Ma che ricalcano perfettamente il popolo che rappresentano.
C'è l'imbroglione affarista, tradito dalla sua ingordigia “Aò, e nnamose a
magnà!... A robbin, ‘ndo stai?”; C'è il servitore di due padroni: "orbo da
n'orecia, sordo de n'ocio"… qualche volta anche di tre. Certi cambiano casacca
con la velocità dei razzi… C'è il riccone arrogante...”Guadagno spendo pago
pretendo” C'è la pulzella che cerca di maritarsi a tutti i costi con il riccone,
convinta di avere avuto un'idea originale e che ci rimane male quando scopre che
sono almeno un centinaio le ragazze che hanno avuto la sua stessa identica
idea... C'è il professore dell'università che sa tutto lui e lo spiega agli
altri col suo latino/inglese perfetto: "tananai mingheina buscaret!" Cos’ha
detto? “Choosy firewall spending review” Ah, ecco, ora finalmente ho capito… C'è
quello iracondo, manesco, pronto a menar le mani ad ogni dibattito... “culattoni
raccomandati” Insomma, c'è tutto il campionario di quello che NOI siamo, a
partire dai nostri difetti, tipo l'INCOERENZA. Come quelli che vanno al family
day... ma ci vanno con le loro due famiglie... per forza poi che c'è un sacco di
gente.... E se solo li guardi un po' esterrefatto, ti dicono: "Perché mi guardi
così? Io sono cattolico, ma a modo mio”. A modo tuo? Guarda, forse non te
l'hanno spiegato, ma non si può essere cattolico a modo proprio... Se sei
cattolico non basta che Gesù ti sia simpatico, capisci? Non è un tuo amico,
Gesù. Se sei cattolico devi credere che Gesù sia il figlio di Dio incarnato
nella vergine Maria. Se sei cattolico devi andare in chiesa tutte le domeniche,
confessare tutti i tuoi peccati, fare la penitenza. Devi fare anche le novene,
digiunare al venerdì... ti abbuono giusto il cilicio e le ginocchia sui ceci.
Divorziare: VIETATISSIMO! Hai sposato un farabutto, o una stronza? Capita.
Pazienza. Peggio per te. Se divorzi sono casini… E il discorso sulla coerenza
non vale solo per i cattolici... Sei fascista? Devi invadere l’Abissinia!
Condire tutto con l'olio di ricino, girare con il fez in testa, non devi mai
passare da via Matteotti, anche solo per pudore! Devi dire che Mussolini, a
parte le leggi razziali, ha fatto anche delle cose buone! Sei comunista? Prima
di tutto devi mangiare i bambini, altro che slow food. Poi devi andare a Berlino
a tirare su di nuovo il Muro, mattone su mattone! Uguale a prima! Devi guardare
solo film della Corea… del nord ovviamente. Devi vestirti con la casacca grigia,
tutti uguali come Mao! …mica puoi essere comunista e poi andare a comprarti la
felpa da Abercrumbie Sei moderato? Devi esserlo fino in fondo! Né grasso né
magro, né alto né basso, né buono né cattivo... Né…Da quando ti alzi la mattina
a quando vai a letto la sera devi essere una mediocrissima, inutilissima,
noiosissima via di mezzo! Questo per quanto riguarda la coerenza. Ma vogliamo
parlare dell'ONESTÀ? Ho visto negozianti che si lamentano del governo ladro e
non rilasciano mai lo scontrino, Ho visto fabbriche di scontrini fiscali non
fare gli scontrini dicendo che hanno finito la carta, Ho visto ciechi che
accompagnano al lavoro la moglie in macchina, Ho visto sordi che protestano coi
vicini per la musica troppo alta, Ho visto persone che si lamentano
dell’immigrazione e affittano in nero ai gialli… e a volte anche in giallo ai
neri!, Ho visto quelli che danno la colpa allo stato. Sempre: se cade un
meteorite, se perdono al superenalotto, se la moglie li tradisce, se un piccione
gli caga in testa, se scivolano in casa dopo aver messo la cera: cosa fa lo
stato? Eh? Cosa fa?... Cosa c’entra lo stato. Metti meno cera, idiota! Lo sapete
che nell'inchiesta sulla 'ndrangheta in Lombardia è venuto fuori che c'erano
elettori, centinaia di elettori, che vendevano il proprio voto per cinquanta
euro? Vendere il voto, in democrazia, è come vendere l'anima. E l'anima si vende
a prezzo carissimo, avete presente Faust? Va beh che era tedesco, e i tedeschi
la mettono giù sempre durissima, ma lui l'anima l'ha venduta in cambio
dell'IMMORTALITA'! Capito? Non cinquanta euro. Se il diavolo gli offriva
cinquanta euro, Faust gli cagava in testa. La verità è che ci sono troppi
impresentabili, tra gli elettori. Mica poche decine, come tra i candidati… è
vero, sembrano molti di più, ma perché sono sempre in televisione a sparar
cazzate, la televisione per loro è come il bar per noi... "Ragazzi, offro un
altro giro di spritz" "E io offro un milione di posti di lavoro" e giù a ridere.
"E io rimborso l'imu!” “e io abolisco l'ici!" “Guarda che non c'è più da un
pezzo l'ici" "Allora abolisco l'iva... E anche l'Emy, Evy e Ely!" "E chi sono?
"Le nipotine di Paperina! "Ma va là, beviti un altro grappino e tasi mona!..."
Vedi, saranno anche impresentabili ma per lo meno li conosci, nome e cognome, e
puoi anche prenderli in giro. Invece gli elettori sono protetti dall’anonimato…
alle urne vanno milioni di elettori impresentabili, e nessuno sa chi sono!
Sapete quale potrebbe essere l’unica soluzione possibile? Sostituire
l'elettorato italiano. Al completo. Pensate, per esempio, se incaricassimo di
votare al nostro posto l'elettorato danese, o quello norvegese. Lo prendiamo a
noleggio. Meglio, lo ospitiamo alla pari... Au pair. Carlo, ma chi è quel
signore biondo che dorme a casa tua da due giorni? “Oh, è il mio elettore
norvegese alla pari, domenica vota e poi riparte subito... C'è anche la
moglie”... E per chi votano, scusa? "Mi ha detto che è indeciso tra Aspelünd
Gründblomma e Pysslygar". Ma quelli sono i nomi dell'Ikea!, che tra l’altro è
svedese… "Ma no, si assomigliano… però ora che mi ci fai pensare, effettivamente
ho visto nel suo depliant elettorale che i simboli dei loro partiti sono un
armadio, una lampada, un comodino. Mah. E tu poi, in cambio cosa fai, vai a
votare per le loro elezioni? In Norvegia? "Ah, questo non lo so. Non so se mi
vogliono. Mi hanno detto che prima devo fare un corso. Imparare a non
parcheggiare in doppia fila. A non telefonare parlando ad alta voce in treno. A
pagare le tasse fino all'ultimo centesimo. Poi, forse, mi fanno votare." Si, va
beh, qualche difficoltà logistica la vedo: organizzare tutti quei pullman,
trovare da dormire per tutti... Ma pensate che liberazione, la sera dei
risultati, scoprire che il nostro nuovo premier è un signore o una signora
dall'aria normalissima, che dice cose normalissime, e che va in televisione al
massimo un paio di volte all'anno.
(Lancio di batteria e poi, sull’aria de
“L’italiano”)
Lasciatemi votare
con un salmone in mano
vi salverò il paese
io sono un norvegese…
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
Economia Sommersa: Il Nord onesto e
diligente evade più del Sud, scrive Emanuela
Mastrocinque su “Vesuviolive”. Sono queste le notizie che non dovrebbero mai
sfuggire all’attenzione di un buon cittadino del Sud. Per anni ci hanno
raccontato una storia che, a furia di leggerla e studiarla, è finita con il
diventare la nostra storia, l’unica che abbiamo conosciuto. Storia di miseria e
povertà superata dai meridionali grazie all’illegalità o all’emigrazione, le
due uniche alternative rimaste a “quel popolo di straccioni” (come ci definì
quella “simpatica” giornalista in un articolo pubblicato su “Il Tempo” qualche
anno fa) . Eppure negli ultimi anni il revisionismo del risorgimento ci sta
aiutando a comprendere quanto lo stereotipo e il pregiudizio sia stato utile e
funzionale ai vincitori di quella sanguinosa guerra da cui è nata l‘Italia.
Serviva (e serve tutt‘ora) spaccare l’Italia. Da che mondo e mondo le società
hanno avuto bisogno di creare l’antagonista da assurgere a cattivo esempio, così
noi siamo diventati fratellastri, figli di un sentimento settentrionale razzista
e intollerante. Basta però avere l’occhio un po’ più attento per scoprire che
spesso la verità, non è come ce la raccontano. Se vi chiedessimo adesso, ad
esempio, in quale zona d’Italia si concentra il tasso più alto di evasione
fiscale, voi che rispondereste? Il Sud ovviamente. E invece non è così. Dopo
aver letto un post pubblicato sulla pagina Briganti in cui veniva
riassunta perfettamente l’entità del “sommerso economico in Italia derivante
sia da attività legali che presentano profili di irregolarità, come ad esempio
l’evasione fiscale, che dal riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività
illecite e mafiose” abbiamo scoperto che in Italia la maggior parte degli
evasori non è al Sud. Secondo i numeri pubblicati (visibili nell‘immagine
sotto), al Nord il grado di evasione si attesta al 14, 5%, al centro al 17,4%
mentre al Sud solo al 7,9%. I dati emersi dal Rapporto Finale del Gruppo
sulla Riforma Fiscale, sono stati diffusi anche dalla Banca d’Italia. Nel
lavoro di Ardizzi, Petraglia, Piacenza e Turati “L’economia
sommersa fra evasione e crimine: una rivisitazione del Currency Demand Approach
con una applicazione al contesto italiano” si legge “dalle stime a
livello territoriale si nota una netta differenza tra il centro-nord e il sud,
sia per quanto attiene al sommerso di natura fiscale che quello di natura
criminale. Per quanto riguarda infine l’evidenza disaggregata per aree
territoriali, è emerso che le province del Centro-Nord, in media, esibiscono
un’incidenza maggiore sia del sommerso da evasione sia di quello associato ad
attività illegali rispetto alle province del Sud, un risultato che pare
contraddire l’opinione diffusa secondo cui il Mezzogiorno sarebbe il principale
responsabile della formazione della nostra shadow economy. Viene meno, di
conseguenza, la rappresentazione del Sud Italia come territorio dove si
concentrerebbe il maggiore tasso di economia sommersa". E ora, come la
mettiamo?
Si evade il fisco più al Nord che al Sud. E’ uno
dei dati che emerge dal rapporto sulla lotta all’evasione redatto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Secondo Padoan, la somma totale delle principali
imposte evase (Iva, Ires, Irpef e Irap) ammonta a 91 miliardi. Il 52% di questa
cifra si attesta dunque nel Settentrione, contro i 24 miliardi del centro (26%
del totale) e i 19,8 miliardi del Meridione (22%). Il dato è influenzato dal
maggior reddito nazionale del Nord. Soprattutto, scrivono i tecnici del Tesoro,
la rabbrividire la percentuale di verifiche sulle imprese che trova irregolarità
fiscali: è 98,1% tra le grandi, al 98,5% sulle medie e al 96,9% sulle Pmi. Il
record tocca agli enti non commerciali, il 99,2% non è in regola. 100% di
`positività´ i controlli sugli atti soggetti a registrazione. Ad ogni modo,
l’evasione effettiva ‘pizzicata’ dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, ha
rilevato il Mef, ammonta a 24,5 miliardi. La maggiore imposta accertata è così
salita dell’87% in sette anni, rispetto ai 13,1 miliardi del 2006. Un numero in
calo rispetto agli anni 2009-2012 e soprattutto rispetto al picco di 30,4
miliardi del 2011.
Ma quale Sud, è il Nord che ha la palma
dell’evasione, scrive Vittorio Daniele su “Il
Garantista”. Al Sud si evade di più che al Nord. Questo è quanto comunemente si
pensa. Non è così, invece, secondo i dati della Guardia di Finanza, analizzati
da Paolo di Caro e Giuseppe Nicotra, dell’Università di Catania, in uno studio
di cui si è occupata anche la stampa (Corriere Economia, del 13 ottobre). I
risultati degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza mostrano come,
nelle regioni meridionali, la quota di reddito evaso, rispetto a quello
dichiarato, sia inferiore che al Nord. E ciò nonostante il numero di
contribuenti meridionali controllati sia stato, in proporzione, maggiore. Alcuni
esempi. In Lombardia, su oltre 7 milioni di contribuenti sono state effettuate
14.313 verifiche che hanno consentito di accertare un reddito evaso pari al 10%
di quello dichiarato. In Calabria, 4.480 controlli, su circa 1.245.000
contribuenti, hanno consentito di scoprire un reddito evaso pari al 3,5% di
quello dichiarato. Si badi bene, in percentuale, le verifiche in Calabria sono
state quasi il doppio di quelle della Lombardia. E ancora, in Veneto il reddito
evaso è stato del 5,3%, in Campania del 4,4% in Puglia, del 3,7% in Sicilia del
2,9%. Tassi di evasione più alti di quelle delle regioni meridionali si
riscontrano anche in Emilia e Toscana. Alcune considerazioni. La prima riguarda
il fatto che nelle regioni del Nord, dove più alta è la quota di evasione, e
dove maggiore è il numero di contribuenti e imprese, si siano fatti, in
proporzione, assai meno accertamenti che nel meridione. Poiché, in Italia, le
tasse le paga chi è controllato, mentre chi non lo è, se può, tende a schivarle,
sarebbe necessario intensificare i controlli là dove la probabilità di evadere è
maggiore. E questa probabilità, secondo i dati della Guardia di Finanza, è
maggiore nelle regioni più ricche. La seconda considerazione è che il luogo
comune di un’Italia divisa in due, con un Nord virtuoso e un Sud di evasori, non
corrisponde al vero. L’Italia è un paese unito dall’evasione fiscale. Il fatto
che in alcune regioni del Nord si sia evaso di più che al Sud non ha nulla a che
vedere né con l’etica, né con l’antropologia. Dipende, più realisticamente, da
ragioni economiche. L’evasione difficilmente può riguardare i salari, più
facilmente i profitti e i redditi d’impresa. E dove è più sviluppata l’attività
d’impresa? Come scrivevano gli economisti Franca Moro e Federico Pica, in un
saggio pubblicato qualche anno fa della Svimez: «Al Sud ci sono tanti evasori
per piccoli importi. Al Nord c’è un’evasione più organizzata e per somme
gigantesche». Quando si parla del Sud, pregiudizi e stereotipi abbondano. Si
pensa, così, che la propensione a evadere, a violare le norme, se non a
delinquere, sia, per così dire, un tratto antropologico caratteristico dei
meridionali. Ma quando si guardano i dati, e si osserva la realtà senza la lente
deformante del pregiudizio, luoghi comuni e stereotipi quasi mai reggono. Di
fronte agli stereotipi e alle accuse – e quella di essere evasori non è certo la
più infamante – che da decenni, ogni giorno e da più parti, si rovesciano contro
i meridionali, non sarebbe certo troppo se si cominciasse a pretendere una
rappresentazione veritiera della realtà. Insieme a pretendere, naturalmente, e
in maniera assai più forte di quanto non si sia fatto finora, che chi, al Sud,
ha responsabilità e compiti di governo, faccia davvero, e fino in fondo, il
proprio dovere.
Quante bugie ci hanno raccontato sul
Mezzogiorno! Scrive Pino Aprile su “Il Garantista”.
L’Italia è il paese più ingiusto e disuguale dell’Occidente, insieme a Stati
Uniti e Gran Bretagna: ha una delle maggiori e più durature differenze del
pianeta (per strade, treni, scuole, investimenti, reddito…) fra due aree dello
stesso paese: il Nord e il Sud; tutela chi ha già un lavoro o una pensione, non
i disoccupati e i giovani; offre un reddito a chi ha già un lavoro e lo perde,
non anche a chi non riesce a trovarlo; è fra i primi al mondo, per la maggiore
distanza fra lo stipendio più alto e il più basso (alla Fiat si arriva a più di
400 volte); ha i manager di stato più pagati della Terra, i vecchi più garantiti
e i giovani più precari; e se giovani e donne, pagate ancora meno. È in corso un
colossale rastrellamento di risorse da parte di chi ha più, ai danni di chi ha
meno: «una redistribuzione dal basso verso l’alto». È uscito in questi giorni
nelle librerie il nuovo libro di Pino Aprile («Terroni ’ndernescional», edizioni
PIEMME, pagine 251, euro 16,50). Pubblichiamo un brano, per gentile concessione
dell’autore. Quante volte avete letto che la prova dell’ estremo ritardo
dell’Italia meridionale rispetto al Nord era l’alta percentuale di analfabeti?
L’idea che questo possa dare ad altri un diritto di conquista e annessione può
suonare irritante. Ma una qualche giustificazione, nella storia, si può trovare,
perché i popoli con l’alfabeto hanno sottomesso quelli senza; e í popoli che
oltre all’alfabeto avevano anche ”il libro” (la Bibbia, il Vangelo, il Corano,
Il Capitale, il Ko Gi Ki…) hanno quasi sempre dominato quelli con alfabeto ma
senza libro. Se questo va preso alla… lettera, la regione italiana che chiunque
avrebbe potuto legittimamente invadere era la Sardegna, dove l’analfabetismo era
il più alto nell’Italia di allora: 89,7 per cento (91,2 secondo altre fonti);
quasi inalterato dal giorno della Grande Fusione con gli stati sabaudi: 93,7. Ma
la Sardegna era governata da Torino, non da Napoli. Le cose migliorarono un po’,
40 anni dopo l’Unità, a prezzi pesanti, perché si voleva alfabetizzare, ma a
spese dei Comuni. Come dire: noi vi diamo l’istruzione obbligatoria, però ve la
pagate da soli (più o meno come adesso…). Ci furono Comuni che dovettero
rinunciare a tutto, strade, assistenza, per investire solo nella nascita della
scuola elementare: sino all’87 per cento del bilancio, come a Ossi (un secolo
dopo l’Unità, il Diario di una maestrina, citato in Sardegna , dell’Einaudi,
riferisce di «un evento inimmaginabile »: la prima doccia delle scolare, grazie
al dono di dieci saponette da parte della Croce Rossa svizzera). Mentre dal
Mezzogiorno non emigrava nessuno, prima dell’Unità; ed era tanto primitivo il
Sud, che partoriva ed esportava in tutto il mondo facoltà universitarie tuttora
studiatissime: dalla moderna storiografia all’economia politica, e vulcanologia,
sismologia, archeologia… Produzione sorprendente per una popolazione quasi
totalmente analfabeta, no? Che strano. Solo alcune osservazioni su quel
discutibile censimento del 1861 che avrebbe certificato al Sud indici così alti
di analfabetismo: «Nessuno ha mai analizzato la parzialità (i dati sono
quelli relativi solo ad alcune regioni) e la reale attendibilità di quel
censimento realizzato in pieno caos amministrativo, nel passaggio da un regno
all’altro e in piena guerra civile appena scoppiata in tutto il Sud: poco
credibile, nel complesso, l’idea che qualche impiegato potesse andare in giro
per tutto il Sud bussando alle porte per chiedere se gli abitanti sapevano
leggere e scrivere» rileva il professor Gennaro De Crescenzo in Il Sud:
dalla Borbonia Felix al carcere di Penestrelle. Come facevano a spuntare oltre
10.000 studenti universitari contro i poco più di 5.000 del resto d’Italia, da
un tale oceano di ignoranza? Né si può dire che fossero tutti benestanti, dal
momento che nel Regno delle Due Sicílie i meritevoli non abbienti potevano
studiare grazie a sussidi che furono immediatamente aboliti dai piemontesi, al
loro arrivo. Sull’argomento potrebbero gettare più veritiera luce nuove
ricerche: «Documenti al centro di studi ancora in corso presso gli archivi
locali del Sud dimostrano che nelle Due Sicilie c’erano almeno una scuola
pubblica maschile e una scuola pubblica femminile per ogni Comune oltre a una
quantità enorme di scuole private» si legge ancora nel libro di De
Crescenzo, che ha studiato storia risorgimentale con Alfonso Scirocco ed è
specializzato in archivistica. «Oltre 5.000, infatti, le ”scuole” su un totale
di 1.845 Comuni e con picchi spesso elevati e significativi: 51 i Comuni in
Terra di Bari, 351 le scuole nel complesso; 174 i Comuni di Terra di lavoro, 664
le scuole; 113 i Comuni di Principato Ultra, 325 le scuole; 102 i Comuni di
Calabria Citra, 250 le scuole…». Si vuol discutere della qualità di queste
scuole? Certo, di queste e di quella di tutte le altre; ma «come si
conciliano questi dati con quei dati così alti dell’analfabetismo? ». E
mentiva il conte e ufficiale piemontese Alessandro Bianco di Saint-Jorioz, che
scese a Sud pieno di pregiudizi, e non li nascondeva, e poi scrisse quel che vi
aveva trovato davvero e lo scempio che ne fu fatto (guadagnandosi l’ostracismo
sabaudo): per esempio, che «la pubblica istruzione era sino al 1859 gratuita;
cattedre letterarie e scientifiche in tutte le città principali di ogni
provincia»? Di sicuro, appena giunti a Napoli, i Savoia chiusero decine di
istituti superiori, riferisce Carlo Alianello in La conquista del Sud. E le
leggi del nuovo stato unitario, dal 1876, per combattere l’analfabetismo e
finanziare scuole, furono concepite in modo da favorire il Nord ed escludere o
quasi il Sud. I soliti trucchetti: per esempio, si privilegiavano i Comuni con
meno di mille abitanti. Un aiuto ai più poveri, no? No. A quest’imbroglio si è
ricorsi anche ai nostri tempi, per le norme sul federalismo fiscale regionale.
Basti un dato: i Comuni con meno di 500 abitanti sono 600 in Piemonte e 6 in
Puglia. Capito mi hai? «Mi ero sempre chiesto come mai il mio trisavolo fosse
laureato,» racconta Raffaele Vescera, fertile scrittore di Foggia «il mio
bisnonno diplomato e mio nonno, nato dopo l’Unità, analfabeta». Nessun Sud,
invece, nel 1860, era più Sud dell’isola governata da Torino; e rimase tale
molto a lungo. Nel Regno delle Due Sicilie la ”liberazione” (così la racconta,
da un secolo e mezzo, una storia ufficiale sempre più in difficoltà) portò
all’impoverimento dello stato preunitario che, secondo studi recenti
dell’Università di Bruxelles (in linea con quelli di Banca d’Italia, Consiglio
nazionale delle ricerche e Banca mondiale), era ”la Germania” del tempo, dal
punto di vista economico. La conquista del Sud salvò il Piemonte dalla
bancarotta: lo scrisse il braccio destro di Cavour. Ma la cosa è stata ed è
presentata (con crescente imbarazzo, ormai) come una modernizzazione necessaria,
fraterna, pur se a mano armata. Insomma, ho dovuto farti un po’ di male, ma per
il tuo bene, non sei contento? Per questo serve un continuo confronto fra i dati
”belli” del Nord e quelli ”brutti” del Sud. Senza farsi scrupolo di ricorrere a
dei mezzucci per abbellire gli uni e imbruttire gli altri. E la Sardegna, a
questo punto, diventa un problema: rovina la media. Così, quando si fa il
paragone fra le percentuali di analfabeti del Regno di Sardegna e quelle del
Regno delle Due Sicilie, si prende solo il dato del Piemonte e lo si oppone a
quello del Sud: 54,2 a 87,1. In tabella, poi, leggi, ma a parte: Sardegna, 89,7
per cento. E perché quell’89,7 non viene sommato al 54,2 del Piemonte, il che
porterebbe la percentuale del Regno sardo al 59,3? (Dati dell’Istituto di
Statistica, Istat, citati in 150 anni di statistiche italiane: Nord e Sud
1861-2011, della SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno). E si
badi che mentre il dato sulla Sardegna è sicuramente vero (non avendo interesse
il Piemonte a peggiorarlo), non altrettanto si può dire di quello dell’ex Regno
delle Due Sicilie, non solo per le difficoltà che una guerra in corso poneva, ma
perché tutto quel che ci è stato detto di quell’invasione è falsificato: i
Mille? Sì, con l’aggiunta di decine di migliaia di soldati piemontesi
ufficialmente ”disertori”, rientrati nei propri schieramenti a missione
compiuta. I plebisciti per l’annessione? Una pagliacciata che già gli
osservatori stranieri del tempo denunciarono come tale. La partecipazione armata
dell’entusiasta popolo meridionale? E allora che ci faceva con garibaldini e
piemontesi la legione straniera 11 domenica 4 gennaio 2015 ungherese? E chi la
pagava? Devo a un valente archivista, Lorenzo Terzi, la cortesia di poter
anticipare una sua recentissima scoperta sul censimento del 1861, circa gli
analfabeti: i documenti originali sono spariti. Ne ha avuto conferma ufficiale.
Che fine hanno fatto? E quindi, di cosa parliamo? Di citazioni parziali,
replicate. Se è stato fatto con la stessa onestà dei plebisciti e della storia
risorgimentale così come ce l’hanno spacciata, be’…Nei dibattiti sul tema, chi
usa tali dati come prova dell’arretratezza del Sud, dinanzi alla contestazione
sull’attendibilità di quelle percentuali, cita gli altri, meno discutibili, del
censimento del 1871, quando non c’era più la guerra, eccetera. Già e manco gli
originali del censimento del ’71 ci sono più. Spariti pure quelli! Incredibile
come riesca a essere selettiva la distrazione! E a questo punto è legittimo
chiedersi: perché il meglio e il peggio del Regno dí Sardegna vengono separati e
non si offre una media unica, come per gli altri stati preunitari? Con i numeri,
tutto sembra così obiettivo: sono numeri, non opinioni. Eppure, a guardarli
meglio, svelano non solo opinioni, ma pregiudizi e persino razzismo. Di fatto,
accadono due cose, nel modo di presentarli: 1) i dati ”belli” del Nord restano
del Nord; quelli ”brutti”, se del Nord, diventano del Sud. Il Regno sardo era
Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e Sardegna. Ma la Sardegna nelle statistiche
viene staccata, messa a parte. Giorgio Bocca, «razzista e antimeridionale »,
parole sue, a riprova dell’arretratezza del Sud, citava il 90 per cento di
analfabeti dell’isola, paragonandolo al 54 del Piemonte. Ma nemmeno essere di
Cuneo e antimerìdionale autorizza a spostare pezzi di storia e di geografia: la
Sardegna era Regno sabaudo, i responsabili del suo disastro culturale stavano a
Torino, non a Napoli;
2) l’esclusione mostra, ce ne fosse ancora
bisogno, che i Savoia non considerarono mai l’isola alla pari con il resto del
loro paese, ma una colonia da cui attingere e a cui non dare; una terra altra
(«Gli stati» riassume il professor Pasquale Amato, in Il Risorgimento oltre i
miti e i revisionismi «erano proprietà delle famiglie regnanti e potevano
essere venduti, scambiati, regalati secondo valutazioni autonome di proprietari».
Come fecero i Savoia con la Sicilia, la stessa Savoia, Nizza… Il principio fu
riconfermato con la Restaurazione dell’Ancièn Regime, nel 1815, in Europa, per
volontà del cancelliere austriaco Klemens von Metternich). E appena fu
possibile, con l’Unità, la Sardegna venne allontanata quale corpo estraneo, come
non avesse mai fatto parte del Regno sabaudo. Lo dico in altro modo: quando
un’azienda è da chiudere, ma si vuol cercare di salvare il salvabile (con
Alitalia, per dire, l’han fatto due volte), la si divide in due società; in una,
la ”Bad Company”, si mettono tutti i debiti, il personale in esubero, le
macchine rotte… Nell’altra, tutto il buono, che può ancora fruttare o rendere
appetibile l’impresa a nuovi investitori: la si chiama ”New Company”.
L’Italia è stata fatta così: al Sud invaso e
saccheggiato hanno sottratto fabbriche, oro, banche, poi gli hanno aggiunto la
Sardegna, già ”meridionalizzata”. Nelle statistiche ufficiali, sin dal 1861, i
dati della Sardegna li trovate disgiunti da quelli del Piemonte e accorpati a
quelli della Sicilia, alla voce ”isole”, o sommati a quelli delle regioni del
Sud, alla voce ”Mezzogiorno” (la Bad Company; mentre la New Company la trovate
alla voce ”Centro-Nord”). Poi si chiama qualcuno a spiegare che la Bad Company è
”rimasta indietro”, per colpa sua (e di chi se no?). Ripeto: la psicologia
spiega che la colpa non può essere distrutta, solo spostata. Quindi, il percorso
segue leggi di potenza: dal più forte al più debole; dall’oppressore alla
vittima. Chi ha generato il male lo allontana da sé e lo identifica con chi lo
ha subito; rimproverandogli di esistere. È quel che si è fatto pure con la
Germania Est e si vuol fare con il Mediterraneo.
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO UCCIDE, MA SI MUORE
ANCHE DI RUMORE…
Inquinamento atmosferico e acustico,
scrive Tina Ohliger sul sito del Parlamento Europeo. L'inquinamento atmosferico
reca danno alla nostra salute e all'ambiente. Benché le sue fonti siano
numerose, esso è causato principalmente dal settore industriale, dei trasporti,
della produzione energetica e da quello agricolo. Una nuova strategia dell'UE in
materia di qualità dell'aria mira a garantire il pieno rispetto della normativa
in vigore sulla qualità dell'aria entro il 2020 e stabilisce nuovi obiettivi a
lungo termine per il 2030. Inoltre, l'aumento del traffico e delle attività
industriali è una causa frequente di inquinamento acustico, che può anche avere
un effetto negativo sulla salute umana. La direttiva sul rumore ambientale
contribuisce a determinare i livelli di rumore all'interno dell'UE e ad adottare
le misure necessarie per far sì che siano accettabili. Una normativa distinta
disciplina le emissioni acustiche derivanti da fonti specifiche.
Base giuridica.
Articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Contesto generale.
L'inquinamento atmosferico è nocivo per la nostra salute e
l'ambiente in cui viviamo. Esso può provocare non solo malattie cardiovascolari
e respiratorie, ma anche il cancro, e costituisce la principale causa di morte
prematura nell'UE legata all'ambiente. Alcune sostanze, come arsenico, cadmio,
nichel e idrocarburi policiclici aromatici, sono agenti cancerogeni genotossici
per l'uomo e non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste
sostanze non comportano un rischio. L'inquinamento atmosferico ha inoltre
effetti negativi sulla qualità dell'acqua e del suolo, oltre a danneggiare gli
ecosistemi per mezzo dell'eutrofizzazione (eccessivo inquinamento da azoto) e
delle piogge acide. Da questo fenomeno sono pertanto interessati il settore
agricolo, le foreste, i materiali e gli edifici. Benché le fonti di tale
tipologia di inquinamento siano diverse, esso è causato principalmente dal
settore industriale, dei trasporti, della produzione energetica e da quello
agricolo. Sebbene negli ultimi decenni l'inquinamento atmosferico in Europa sia
diminuito in termini generali, l'obiettivo dell'Unione nel lungo termine, vale a
dire «livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi
significativi per la salute umana e per l'ambiente», è tuttora a rischio.
Soprattutto nelle aree urbane («punti caldi»), dove vive la maggior parte degli
europei, le norme di qualità dell'aria vengono spesso violate, il che può
provocare gravi problemi per la salute. Gli agenti inquinanti più problematici
nella fase attuale sono le polveri sottili e l'ozono (troposferico) a livello
del suolo. I livelli di inquinamento acustico sono in crescita nelle aree
urbane, principalmente a causa dell'aumento del traffico e delle attività
industriali e ricreative. Secondo le stime, quasi il 20% della popolazione
dell'Unione europea è vittima di livelli di inquinamento acustico considerati
inaccettabili. Tale forma di inquinamento può incidere sulla qualità della vita
e può portare a livelli significativi di stress, disturbi del sonno e a
ripercussioni negative per la salute, come problemi cardiovascolari. Il rumore
ha inoltre un impatto sulla fauna selvatica.
Risultati nell'ambito della lotta
all'inquinamento atmosferico. In Europa, la qualità
dell'aria è migliorata considerevolmente da quando l'UE ha iniziato, negli anni
'70 del secolo scorso, a contrastare tale problematica. Da allora, sostanze
quali anidride solforosa (SO2), monossido di carbonio (CO), benzene
(C6H6) e piombo (Pb) sono diminuite in maniera notevole.
L'UE dispone di tre diversi meccanismi giuridici per affrontare l'inquinamento
atmosferico: la definizione di norme generali di qualità dell'aria per quanto
concerne la concentrazione degli inquinanti atmosferici nell'ambiente; la
definizione di limiti (nazionali) per le emissioni complessive di agenti
inquinanti; l'elaborazione di una normativa specifica in base alla fonte,
controllando, per esempio, le emissioni industriali o stabilendo norme in
materia di emissioni dei veicoli, efficienza energetica o qualità dei
carburanti. Integrano la normativa summenzionata strategie e misure volte a
promuovere la tutela dell'ambiente e la relativa integrazione nel settore dei
trasporti e in quello energetico.
A. Qualità dell'aria ambiente.
Sulla base degli obiettivi della strategia tematica sull'inquinamento
atmosferico del 2005, (vale a dire ridurre la concentrazione di particelle
sottili, PM2.5, del 75% e quella di ozono troposferico, O3, del 60%, nonché
ridurre del 55%, sempre entro il 2020 rispetto ai livelli del 2000,
l'acidificazione e l'eutrofizzazione, che rappresentano una minaccia per
l'ambiente), è stata adottata, nel giugno 2008, una revisione della direttiva
relativa alla qualità dell'aria ambiente, la quale incorpora gran parte della
legislazione in materia. Soltanto la quarta «direttiva derivata» (2004/107/CE)
dalla precedente direttiva quadro sulla qualità dell'aria è attualmente ancora
in vigore. Essa fissa valori obiettivo (meno rigidi di quelli limite) per
arsenico, cadmio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici. La direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente si prefigge di ridurre
l'inquinamento atmosferico a livelli tali che limitino al minimo gli effetti
nocivi per la salute umana o per l'ambiente. A tale fine essa istituisce misure
volte a definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente (ossia
limiti che non devono essere superati in alcun luogo dell'UE) in relazione ai
principali inquinanti atmosferici (anidride solforosa, biossido di azoto, ossidi
di azoto, materiale particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio e
ozono). Gli Stati membri sono tenuti a definire zone e agglomerati per valutare
e gestire la qualità dell'aria ambiente, monitorare le tendenze a lungo termine
e garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a
disposizione del pubblico. Le misure sono inoltre intese a mantenere la qualità
dell'aria ambiente, laddove sia buona, mentre, laddove si superino i valori
limite, è necessario adottare dei provvedimenti. La direttiva introduce per la
prima volta un obiettivo di qualità dell'aria ambiente per il PM 2.5. La
direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici stabilisce limiti nazionali di emissione per quattro
inquinanti atmosferici (SO22, NOx, COV e ammoniaca (NH3)), i principali
responsabili dell'acidificazione, dell'ozono a livello del suolo e
dell'eutrofizzazione del suolo, nell'ottica di ridurne gli effetti nocivi,
fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020. A norma della
direttiva in parola, gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente
informazioni concernenti le emissioni e le proiezioni per tutti gli inquinanti
in questione e a elaborare programmi per la progressiva riduzione delle
emissioni nazionali degli inquinanti al fine di conformarsi ai singoli limiti
nazionali di emissione. Gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi ai limiti
stabiliti entro il 2010; tuttavia, almeno un limite non è stato rispettato da
diversi Stati, talvolta nell'arco di numerosi anni. Gli obiettivi a lungo
termine della direttiva consistono nel non superamento dei carichi e dei livelli
critici nonché nell'efficace tutela dei cittadini dai rischi accertati
dell'inquinamento atmosferico per la salute. Nell'ambito del nuovo pacchetto
«aria pulita» viene proposta una revisione. Alla fine del 2013, la Commissione
ha proposto un nuovo pacchetto di provvedimenti per un'aria pulita, che presenta
due obiettivi principali, vale a dire il rispetto della normativa vigente fino
al 2020 e la riduzione degli impatti a lungo termine dell'inquinamento
atmosferico. Il pacchetto comprende un nuovo programma «Aria pulita per
l'Europa» che descrive la problematica nonché le misure strategiche necessarie
per conseguire i nuovi obiettivi intermedi volti a ridurre l'impatto sulla
salute e sull'ambiente fino al 2030. Esso propone la revisione della direttiva
NEC, con l'aggiornamento dei limiti nazionali per il 2020 e il 2030
relativamente ai quattro inquinanti attualmente disciplinati, come pure ad altri
due, ovvero le particelle sottili e il metano (CH4). Il pacchetto comprende
inoltre una proposta di nuova direttiva relativa alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di
combustione medi (in aggiunta ai grandi impianti di combustione che sono già
disciplinati) e una proposta di ratifica della versione modificata del
protocollo di Göteborg alla Convenzione della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico a grande distanza per
diminuire l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono a livello del suolo.
B. Trasporti su strada.
Numerose direttive sono state adottate per limitare l'inquinamento causato dal
settore dei trasporti, fissando norme di emissione per diverse categorie di
veicoli, come ad esempio automobili, veicoli commerciali leggeri, autocarri,
autobus e motocicli, nonché disciplinando la qualità del carburante e il
relativo tenore di zolfo e piombo. La norma di emissione attualmente in vigore
per le autovetture e i furgoni leggeri è Euro V. Essa fissa limiti di emissione
per una serie di inquinanti atmosferici, in particolare gli ossidi di azoto
(NOx) e il particolato (PM). Gli Stati membri sono tenuti a negare
l'omologazione, l'immatricolazione, la vendita e l'introduzione di veicoli (e
dei relativi dispositivi di controllo dell'inquinamento di ricambio) che non
rispettano i limiti in questione. Euro VI, che dovrebbe entrare in vigore nel
settembre 2014 e applicarsi all'omologazione di tutti i nuovi modelli di
autoveicoli e, l'anno successivo, all'immatricolazione e alla vendita di tutte
le nuove auto e i nuovi furgoni leggeri, stabilisce limiti di emissione ancora
più bassi, soprattutto per quanto concerne le emissioni di NOx (per i veicoli
commerciali leggeri e le automobili per esigenze particolari tutti i termini
sono prorogati di un anno). In detta norma è compresa una clausola di revisione
per il ciclo di guida e la procedura di prova al fine di garantire che le prove
vengano effettuate in condizioni di guida reali. Il regolamento (CE) n. 715/2007
fissa inoltre norme sulla conformità in servizio, la durata dei dispositivi di
controllo dell'inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (OBD), la
misurazione del consumo di carburante e disciplina l'accessibilità delle
informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo per gli operatori
indipendenti. Lo stesso vale per il regolamento (CE) n.595/2009, che fissa
valori limite di emissione per i veicoli pesanti (autobus e camion). La norma
d'emissione attualmente in vigore è Euro VI. Al fine di ridurre ulteriormente
l'inquinamento provocato dalle emissioni degli autoveicoli, l'UE ha introdotto
un divieto di commercializzazione della benzina contenente piombo, nonché
l'obbligo di rendere disponibili carburanti senza zolfo all'interno dell'Unione.
La direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso
consumo energetico nel trasporto su strada impone alle amministrazioni
aggiudicatrici di tener conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale
nell'arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2
e di talune sostanze inquinanti, al momento dell'acquisto di veicoli adibiti al
trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli
puliti e a basso consumo energetico.
C. Altre emissioni provenienti dal
settore dei trasporti. Ulteriori norme di emissione
sono state fissate per le macchine mobili non stradali, ad esempio scavatrici,
bulldozer e motoseghe, per i trattori agricoli e forestali o per le imbarcazioni
da diporto. La direttiva 1999/32/CE disciplina le emissioni di zolfo derivanti
dai trasporti marittimi attraverso la definizione di un tenore massimo di zolfo
consentito nei combustibili utilizzati nel trasporto marittimo. È stata poi
modificata dalla direttiva 2005/33/CE, che ha designato il Mar Baltico, il
Canale della Manica e il Mare del Nord come «zone di controllo delle emissioni
di zolfo» (SECA), in cui è consentito un tenore di zolfo pari all'1,5 % in
massa. La stessa norma si applica alle navi passeggeri in servizio regolare
fuori delle SECA. Un'ulteriore direttiva di modifica (direttiva 2012/33/UE)
allinea gli standard dell'Unione alle disposizioni dell'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) e della Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), oltre a introdurre una norma
relativa al tenore dello 0,5% del combustibile entro il 2020, indipendentemente
da un eventuale rinvio da parte dell'IMO. Nell'allegato VI della Convenzione,
sono fissati limiti di emissione per l'anidride solforosa (SOx), gli ossidi di
azoto (NOx), le sostanze che riducono lo strato di ozono (O3) e i composti
organici volatili (COV) provenienti dalle navi cisterna.
D. Emissioni causate dall'industria.
La nuova direttiva sulle emissioni industriali (IED, direttiva 2010/75/UE)
disciplina le attività industriali altamente inquinanti, attività che
rappresentano una quota rilevante dell'inquinamento in Europa. Adottata nel
novembre del 2010, essa consolida e fonde tutte le direttive del caso (in
materia di incenerimento dei rifiuti, COV, grandi impianti di combustione,
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ecc.) in un coerente
strumento legislativo che si prefigge di agevolarne l'attuazione e di ridurre al
minimo l'inquinamento derivante da varie fonti industriali. La direttiva
stabilisce gli obblighi che tutti gli impianti industriali devono rispettare,
contiene un elenco di misure per la prevenzione dell'inquinamento delle acque,
dell'aria e del suolo e funge da base per il rilascio di licenze o
autorizzazioni agli impianti industriali. Applicando un approccio integrato,
essa tiene conto delle prestazioni ambientali complessive di un impianto, tra
cui l'utilizzo di materie prime o l'efficienza energetica. Il concetto di
«migliori tecniche disponibili» (BAT) svolge un ruolo centrale e lo stesso vale
per la flessibilità, le ispezioni ambientali e la partecipazione del pubblico.
Risultati nell'ambito della lotta
all'inquinamento acustico.
Rumore ambientale:
la direttiva quadro relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale (direttiva 2002/49/CE) mira a ridurre l'esposizione a questo tipo di
rumore armonizzando i descrittori acustici e i metodi di valutazione,
raccogliendo informazioni sull'esposizione al rumore sotto forma di «mappe
acustiche» e rendendo tali informazioni disponibili al pubblico. Sulla base di
quanto precede, agli Stati membri è imposto di definire piani di azione per
affrontare i problemi relativi all'inquinamento acustico. Occorre procedere a un
riesame delle mappe acustiche e dei piani d'azione almeno ogni cinque anni.
Traffico stradale:
le direttive 70/157/CEE e 97/24/CE (che saranno sostituite nel 2016 con nuove
regolamentazioni) stabiliscono i limiti relativi ai livelli ammissibili del
rumore emesso dai veicoli a motore, dai ciclomotori e dai motocicli. Nell'aprile
del 2014 si è adottata una nuova regolamentazione sul livello sonoro dei veicoli
a motore che introduce un nuovo metodo di prova per la misurazione delle
emissioni sonore, diminuisce i valori limite di rumore attualmente in vigore e
racchiude disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore in sede di procedura di
omologazione. Essa si applicherà a partire dall'aprile del 2016. A integrazione
di ciò, la direttiva 2001/43/CE sancisce la verifica e l'imposizione di limiti
sul livello di rumore causato dal rotolamento dei pneumatici e la sua graduale
riduzione.
Traffico aereo:
nel 1992 è stata limitata l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione
in linea con le norme stabilite dall'Organizzazione internazionale
dell'aviazione civile (ICAO). Ciò ha comportato di fatto il divieto dagli
aeroporti europei dei velivoli più rumorosi (direttiva 92/14/CEE, abrogata dalla
direttiva 2006/93/CE). La direttiva 2002/30/CE (attualmente in fase di
revisione) stabilisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, sulla
base «dell'approccio equilibrato» raccomandato dall'ICAO (rendere gli aerei meno
rumorosi attraverso la definizione di norme relative alla rumorosità; gestire in
maniera sostenibile il territorio circostante gli aeroporti; adeguare le
procedure operative al fine di ridurre l'impatto acustico a terra e, se del
caso, introdurre limitazioni operative).
Traffico ferroviario:
nel contesto della direttiva relativa all'interoperabilità ferroviaria, una
specifica tecnica di interoperabilità (STI) fissa i livelli massimi di rumore
prodotto dai nuovi veicoli ferroviari (convenzionali). Nel 2013 la Commissione
ha avviato una consultazione pubblica su «un'effettiva diminuzione del rumore
prodotto dai carri merci in seno all'Unione europea» in vista di eventuali
misure di follow-up.
Altre fonti di rumore:
i grandi impianti industriali e agricoli, contemplati dalla direttiva sulle
emissioni industriali, possono ottenere autorizzazioni in funzione
dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) come riferimento.
Esiste inoltre una regolamentazione relativa all'inquinamento acustico prodotto
dai cantieri edili (per esempio da scavatrici, pale caricatrici, macchine per
movimento terra e gru a torre), dalle imbarcazioni da diporto o dalle
attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
Ruolo del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo ha svolto un ruolo decisivo nell'elaborazione di una
politica ambientale progressiva di lotta contro l'inquinamento atmosferico e
acustico. Prendendo atto del fatto che ogni anno 50 000 persone muoiono
prematuramente a causa dell'inquinamento atmosferico provocato dalle navi, i
deputati al Parlamento europeo hanno votato in favore di una drastica
diminuzione del nocivo tenore di zolfo dei carburanti marittimi. Ai sensi delle
nuove norme adottate nel 2012 dal Parlamento, il limite generale di zolfo per i
carburanti nei mari europei verrebbe ridotto dal 3,5% allo 0,5% entro il 2020. I
deputati si sono battuti con successo contro i tentativi di prorogare tale
termine di cinque anni. Su richiesta del PE, la legislazione adottata chiede
inoltre alla Commissione di valutare la possibilità di estendere i più rigorosi
limiti SECA a tutte le acque territoriali dell'Unione. Quanto all'inquinamento
acustico, il Parlamento ha ripetutamente sottolineato la necessità di abbassare
ulteriormente i valori soglia e di introdurre procedure di rilevamento
ottimizzate in relazione al rumore ambientale. Esso ha caldeggiato la
definizione di valori a livello di UE per l'inquinamento acustico nelle aree in
prossimità degli aeroporti (tra cui anche l'eventuale divieto di volo in orario
notturno), nonché l'estensione delle misure per la riduzione dell'inquinamento
acustico agli aerei subsonici militari. Il Parlamento ha altresì approvato
l'introduzione graduale di nuovi limiti acustici per le automobili al fine di
ridurre il limite dagli attuali 74 decibel (db) a 68 db. I deputati hanno
inoltre condotto una campagna di successo per introdurre etichette che informino
i consumatori sui livelli acustici, analogamente a quanto avvenuto per i regimi
esistenti in materia di rendimento del carburante, la rumorosità dei pneumatici
e le emissioni di CO2.
Rumori quotidiani? Ecco quelli che fanno
male alla salute. Dal
rumore della pioggia, al talk show a voce alta, al rumore del traffico fino
all'aspirapolvere in casa: ecco i danni alla salute dei rumori quotidiani più
banali, scrive “Stai Bene”.
Il clacson delle auto, la sirena dell’ambulanza, il cane che abbaia, ma anche le
chiacchiere dei colleghi. Il rumore è, di fatto, una presenza costante nelle
nostre giornate con cui bisogna imparare a convivere; tuttavia è importante
sapere che i rumori possono avere effetti enormi non solo sulla qualità delle
nostre giornate, ma anche sulla salute. Il 61% degli europei che vivono in aree
metropolitane soffre per l’inquinamento acustico e l´invasione di decibel
(l’unità di misura con cui viene misurata l’intensità del suono) nelle loro case
e il 32% si sente molto o estremamente infastidito. Gli effetti dei rumori sulla
salute si verificano però in maniera “silenziosa”. Come? Con problemi di vista,
difficoltà di respirazione e sonno disturbato. Non solo. Secondo un rapporto
dell´Organizzazione mondiale della sanità,
migliaia di persone nel mondo si ammalano o muoiono di attacchi cardiaci
provocati proprio dalla prolungata esposizione al rumore metropolitano. L’Oms
con il progetto “Noise Environmental Burden on Diseas”, iniziato nel 2003,
rivela che, oltre alla relazione tra il rumore metropolitano e le malattie
cardiache, il 2% dei cittadini europei soffre di seri disturbi del sonno
a causa del caos e il 15% di grave irritabilità. L'Unione europea ha emanato una
direttiva che obbliga le città con più di 250 mila abitanti a produrre mappe
digitali del rumore, che indichino le zone urbane dove il traffico è maggiore.
Traffico, aspirapolvere, tv: i decibel nocivi.
Ciascuno di noi ha un personale definizione di rumore. Da un punto di vista più
scientifico, sono due gli elementi che concorrono a rendere un rumore pericoloso
per la salute: l’intensità (che viene misurata in decibel) e la durata. Vediamo
quali sono i danni che i rumori possono provocare alle persone:
fino a 40 dB l’organismo non ne risente;
da 40 a 60 dB si possono aver le prime reazioni di
fastidio;
tra 60 e 80 dB, aumenta la sensazione di stress e
malessere, con segni fisici come tachicardia e colite;
tra 80 e 120, possono comparire nausea, capogiri
ed emicrania;
tra 120 e 180, ci sono danni all’udito e dolore.
Secondo le linee guida dell'Organizzazione
mondiale della sanità, il rumore durante la notte non dovrebbe superare i 50
decibel per evitare problemi cardiovascolari; per non soffrire di disturbi del
sonno dovrebbe essere sotto i 42 decibel; per non sentirsi irritati o tesi sotto
i 35 decibel (il suono di un sussurro).
Facciamo qualche esempio:
Il battito di ali di una farfalla: 5 dB.
Una conversazione con tono di voce normale: 30 dB.
Il rumore della pioggia: 50 dB.
Una conversazione animata (oppure tv o radio a
volume alto): 60 dB.
L’aspirapolvere: 85 dB.
Il rumore che si rileva in una strada mediamente
trafficata: 90 dB.
Se combinate questa casistica rumorosa con la
scala del fastidio di rumore pubblicata più in alto, scoprite per esempio che
quando piove, il rumore della pioggia è già causa di irritabilità, un tal show
in cui i presenti litigano danno stress, tachicardia e colite, il rumore del
traffico quando siete fuori casa, o della banale aspirapolvere quando siete a
casa portano nausea, capogiri ed emicrania.
Come difendersi dal rumore al lavoro e in casa. Se
difendersi totalmente dal rumore è impossibile, si può cercare almeno di
limitare i danni da inquinamento acustico. Ecco come.
Al lavoro – I macchinari e le attrezzature
presenti nell’ambiente di lavoro non dovrebbero produrre un rumore superiore a
85 decibel. La soluzione ottimale consisterebbe nell’avere macchinari poco
rumorosi o altrimenti schermarli. Quando però questo non è possibile, deve
essere ridotto il tempo di esposizione al rumore e vanno indossate apposite
protezioni: tappi e cuffie fonoassorbenti. Coloro che, per motivi di lavoro,
sono esposti a un ambiente rumoroso dovrebbero sottoporsi con regolarità a un
esame audiometrico.
In casa – Se nell’ambiente di lavoro non possiamo
agire personalmente sulla riduzione del rumore, dobbiamo cercar di farlo almeno
tra le pareti domestiche, agendo sulle fonti che producono rumore. Anzitutto
dobbiamo cercare di abbassare il volume di radio, televisione, hi-fi. Quindi
dovremmo tenere chiusa la porta della stanza in cui funzionano lavastoviglie o
lavatrice. Un altro modo per diminuire il rumore consiste nel fare ricorso a
pannelli fonoassorbenti. Si possono utilizzare pareti doppie, separate tra loro
da un’intercapedine riempita di lana di vetro, oppure ricorrere alle finestre
con doppi vetri.
Inquinamento acustico, l'Italia è troppo
rumorosa. Nel 2012 il 42,6% delle sorgenti di rumore
oggetto di controllo ha superato almento una volta il limite normativo, scrive
“La Repubblica”. Chi abita nei pressi di Malpensa o Ciampino, lo sa bene.
L'Italia è un paese rumoroso, dove l'inquinamento acustico rappresenta ormai uno
dei maggiori problemi ambientali. Lo rileva l'Annuario dei dati ambientali
dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
secondo il quale il 42,6% delle sorgenti di rumore oggetto di controllo, nel
2012, ha presentato almeno un superamento dei limiti normativi. I controlli,
rileva lo studio, sono stati più diffusi per quanto riguarda le attività di
servizio e commerciali (il 57,7%) seguite dalle attività produttive (31,5%). Una
delle possibili risposte a questo problema sempre più sentito è la
classificazione acustica, che deve essere approvata dai comuni: ma al 31
dicembre 2012 esisteva solo nel 51% dei centri abitati italiani. Le regioni con
la percentuale di comuni zonizzati più elevata rimangono Marche e Toscana (97%),
Valle d'Aosta (sale al 96%), Liguria (84%), Lombardia (sale all'83%), mentre
quelle che registrano percentuali inferiori al 10% sono Abruzzo (7%), Sardegna
(3%) e Sicilia (1%). La percentuale di popolazione residente in comuni che hanno
approvato la classificazione acustica è pari al 56,5%, con forte disomogeneità
sul territorio nazionale. Il rumore rappresenta il fattore di disturbo più
segnalato dalla popolazione che risiede nelle vicinanze degli aeroporti, spesso
localizzati in prossimità delle aree urbane. In particolare l'aeroporto "G. B.
Pastine" di Ciampino, compreso nel territorio di Roma, Ciampino e Marino,
secondo aeroporto del Lazio per movimentazione aerea. Dal 2008, anche a seguito
del significativo incremento del numero di voli dovuto allo sviluppo delle
compagnie "low cost", l'Arpa Lazio ha installato una propria rete di stazioni di
misura. Il monitoraggio acustico effettuato nel 2012 ha consentito di
riscontrare livelli annuali di Lva (Livello di Valutazione del rumore
Aeroportuale) superiori ai limiti in due postazioni di misura e livelli medi di
LAeq (Livello equivalente) superiori ai limiti in altre due postazioni, in
particolare presso due edifici scolastici sono stati riscontrati livelli
superiori a 10 dB(A) del limite diurno relativo alla Classe I (50 dB(A)).
All'inquinamento acustico si aggiunge poi l'inquinamento elettromagnetico: in
Italia, nel 2012, erano presenti 6.094 impianti Srb (Stazioni radio base) e
11.382 impianti Rtv (Radiotelevisivi). Tra il 2011 e il 2012 si è registrato un
aumento degli impianti Srb e della relativa potenza complessiva, pari
rispettivamente al 10% e al 42%. I casi di superamento dei limiti di legge
riguardo gli impianti Radiotelevisivi (pari a 608) sono circa 7 volte superiori
a quelli relativi agli impianti Srb (Stazione Radio Base), pari a 88.
Il rumore che avvelena l'Italia,
scrive “La Repubblica”. Diecimila vittime l'anno in Europa a cui vanno aggiunti
casi crescenti di malattie cardiache, insonnia e problemi cognitivi per i
bambini. Meno conosciuto di quello atmosferico, l'inquinamento acustico ci costa
ogni anno un pesante tributo in termine di salute. Le leggi per tenere i decibel
sotto controllo ci sarebbero, ma sono ampiamente disattese. Come dimostrano i
casi dei quartieri attraversati dalle autostrade, di quelli a ridosso degli
aeroporti e il nostro viaggio nel centro di Roma muniti di un fonometro.
Ogni anno 10mila vittime in Europa,
scrive Antonio Cianciullo. A Torino è finita in tribunale la battaglia tra i
cittadini di piazza Vittorio e della Gran Madre e 11 gestori di locali notturni
dei Murazzi accusati di disturbo della quiete pubblica e apertura abusiva. A
Roma in buona parte del centro è ormai guerra permanente tra la specie invasiva
dei pub e quella in ritirata degli artigiani, con la responsabile del Comitato
Vivere Trastevere, Dina Nascetti, che denuncia 80 decibel in piena notte, un
frastuono vietato anche attorno alle fabbriche. Il conflitto - reso cronico
dall'assalto dilagante delle birrerie con sbornia inclusa nei tour organizzati -
è destinato a riaccendersi in molte città con l'avvicinarsi dell'estate e delle
multe europee per il mancato rispetto delle direttive sull'inquinamento
acustico. "La procedura contro l'Italia per il rumore è stata aperta
formalmente: in assenza di correzione di rotta le sanzioni arriveranno nel giro
di un anno", ricorda Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente.
"Purtroppo questo è un problema troppo spesso trascurato. Le norme ci sono, e
anche molto precise, ma i risultati pratici sono vicini allo zero". E in futuro
andrà anche peggio perché i limiti sono destinati a diventare più severi. Nel
febbraio 2013 il Parlamento europeo ha approvato un progetto di legge per
abbassare il tetto di decibel per le automobili da 74 a 68 decibel e per i mezzi
pesanti da 81 a 79 decibel. Le indagini sulle conseguenze dell'overdose di
decibel danno infatti risultati sempre più inquietanti. Secondo l'ultimo
rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, Noise in Europe 2014, quasi il 20%
della popolazione dell'Unione europea (oltre 125 milioni di persone) è
sottoposto a livelli di inquinamento sonoro inaccettabili. Questa esposizione -
calcola lo studio - contribuisce ogni anno nella Ue alla morte di 10mila
persone, a oltre 900mila casi di ipertensione e a 43mila ricoveri ospedalieri
per ictus e malattie coronariche. I danni si manifestano anche nel disturbo del
sonno di 8 milioni di persone. "Dobbiamo proteggere soprattutto gli ambienti più
a rischio e i momenti della giornata più esposti: il livello raccomandato
dall'Organizzazione mondiale per la salute è di 30 decibel nella stanza da letto
durante la notte e 35 decibel nelle classi scolastiche", ricorda Roberto
Bertollini, direttore di ricerca dell'ufficio europeo dell'Oms. "La mancanza di
un sonno adeguato può determinare infatti pressione alta e malattie
cardiovascolari. Si calcola che nell'Unione europea a causa dell'eccesso di
rumore si perdano 61mila anni di buona qualità della vita per malattie
ischemiche del cuore, 45mila anni per disturbi cognitivi nei bambini, 903mila
anni per disturbi del sonno. Sommando anche gli altri effetti si arriva a un
totale di 1,6 milioni di anni di vita di buona qualità persi". "Per ogni decibel
oltre i limiti raccomandati dall'Oms (55 diurni e 45 notturni) aumentano del 5%
gli interventi di pronto soccorso per problemi cardiaci", aggiunge l'avvocato
Lluis Gallardo. "Per fortuna in Spagna la magistratura comincia a muoversi: i
casi più eclatanti sono stati quelli del ristorante El Portet, con la condanna a
4 anni di detenzione, del bar Macumba, anche in questo caso 4 anni, e del pub
Donegal, che finora ha avuto la pena maggiore: 5 anni e 6 mesi di carcere".
Anche in Italia sono arrivate le prime sentenze in materia. Nel 2011, ad
esempio, la Cassazione ha convalidato un risarcimento di 5 mila euro per i
disturbi provocati da un disco-pub di Soleto, in provincia di Lecce. Decisioni
collegate a verdetti sempre più netti da parte della comunità scientifica:
secondo una ricerca condotta dall'équipe di Megan Ruiter, dell'università
dell'Alabama di Birmingham, la possibilità di ictus aumenta di 4 volte nelle
persone che dormono meno di 6 ore per notte, rispetto a chi ne dorme 7-8. A
questi rischi ha cercato di far fronte la direttiva europea del giugno 2002. La
norma prevede la creazione di mappe acustiche delle città e piani di
risanamento. Principi recepiti dalla legge quadro italiana che sancisce
l'obbligo per i Comuni con più di 50mila abitanti di presentare una relazione
biennale sullo stato acustico del proprio territorio. Ma solo 15 dei 147 Comuni
che superano i 50mila abitanti hanno rispettato la legge. E ovviamente, come per
i rifiuti, è scattata (aprile 2013) la procedura di infrazione per violazione
delle direttive europee: i dati sulla mappature del territorio sono considerati
incompleti, i piani di azione inadeguati, la comunicazione ai cittadini
insufficiente. Eppure la comunicazione sarebbe semplice: forse proprio questo è
il problema visto che la legge resta quasi ovunque lettera morta. Nelle aree
particolarmente protette (come ospedali e scuole) il valore da non superare è 45
decibel di giorno e 35 di notte. Nelle aree prevalentemente residenziali si
arriva a 50 decibel di giorno e 40 di notte. Nelle aree a intensa attività umana
si sale a 65 decibel di giorno e 55 di notte. In quelle esclusivamente
industriali sono ammessi 65 decibel sia di giorno che di notte.
Inquinamento acustico, a Roma livelli
sforati ovunque. "Calcolando che la scala di
misurazione è logaritmica, cioè che il valore raddoppia ogni 3 decibel, emerge
la distanza abissale che separa gli 80 decibel di Trastevere dall'obbligo di
mantenere nelle aree a intensa attività umana il limite notturno a 55 decibel:
vuol dire che la pressione acustica è 256 volte più alta del lecito", aggiunge
Zampetti, che ha coordinato un'indagine sul campo, con i fonometri, di
Legambiente. Per comprendere il senso di questi numeri si può pensare che in una
stanza da letto se ci sono 65 decibel ci si sveglia, ma già a partire da 40 - 45
decibel si cominciano a registrare effetti di disturbo che alterano la fase Rem
del sonno e portano ad alzarsi la mattina dopo con un senso di spossatezza.
Sembra piuttosto chiaro. Ma ai Comuni la norma che difende il nostro sistema
nervoso dall'assalto dei picchi di rumore non piace. "A fine 2013 il piano era
stato approvato solo in 13 città", si legge in uno studio appena reso pubblico
da Legambiente. "Sebbene Ispra specifichi come l'indagine abbia evidenziato la
necessità del piano di risanamento in 25 dei 73 capoluoghi di provincia
analizzati". Sempre dal rapporto dell'Ispra è emerso che nel 2013 nei Comuni
capoluogo ci sono stati 1.474 controlli sul rumore, 9 volte su 10 per
segnalazione dei cittadini. In quasi la metà di questi interventi si è accertato
almeno un superamento dei limiti previsti dalla legge. Chi è il maggior
colpevole di questo fracasso? La prima fonte di inquinamento acustico è il
traffico (l'Italia si attesta al secondo posto a livello europeo per tasso di
motorizzazione, con oltre 62 autovetture ogni 100 abitanti, valore che supera
del 30% il dato medio europeo). Ma il maggior numero di lamentele è causato da
attività commerciali (come discoteche e pubblici esercizi, 71% sui controlli
totali) e produttive (industriali, artigianali e agricole, 11%), seguite da
cantieri e manifestazioni (8%). Segno della necessità di un intervento su più
fronti.
Genova pioniera nella battaglia per il
silenzio, scrive Giulia Destefanis. La storia della
Genova che batte i pugni, lotta, incrocia le braccia e fa piccole grandi
rivoluzioni, passa anche di qui. Dal tratto Genova-Savona dell'autostrada A10,
una ferita di rumore che taglia in due la città di Ponente, in mezzo alle case
dei quartieri di Prà e Palmaro, "con un impatto sul tessuto urbano che non ha
eguali in altre parti del mondo", dice il presidente del Municipio cittadino di
Ponente Mauro Avvenente. Perché qui, negli anni '70, il raddoppio delle
carreggiate si è mangiato metri di vivibilità anche in altezza, con la
costruzione di una carreggiata sopra l'altra ed auto e tir che sfrecciano a 3
metri dalle finestre del terzo piano dei palazzi. "In quei tratti il rumore
passava l'immaginazione, non riuscivi a parlare sul balcone, impossibile tenere
le finestre aperte d'estate... E allora all'inizio degli anni '90 sono iniziate
le proteste", racconta lo storico condottiero dei comitati dei residenti,
Arcadio Nacini. Dopo 20 anni di lotte, occupazioni "di caselli e sedi
istituzionali", e l'innovativo "Progetto pilota Genova", con la prima
commissione sull'inquinamento acustico autostradale creata al ministero
dell'Ambiente e sforzi di cui hanno beneficiato poi città di tutta Italia, "a
partire dall'obbligo per Società Autostrade di destinare il 7% dei ricavi dalle
nuove costruzione alla riduzione dell'impatto acustico", oggi la battaglia di
Genova contro il fracasso è vinta a metà. Si sono ottenute, sì, le tante
barriere fonoassorbenti lungo la A10 (e la A7, altra grana che taglia la città
verso nord, verso Milano) costruite negli anni 2000, che hanno "schermato"
qualcosa come 130mila abitanti. Due le soluzioni: i pannelli verticali ai lati
delle carreggiate, e quelli coprenti, sorta di gallerie "traforate" di materiale
fonoassorbente, che hanno ridotto il rumore ma scatenato altre polemiche. Questa
volta sull'impatto ambientale e visivo delle barriere: "Causano una quasi totale
occlusione della vista, con danni sulla qualità della vita e sul valore della
abitazioni vicine", denunciava ancora poco tempo fa in consiglio comunale Paolo
Putti, capogruppo grillino. Eppure, benché a suo tempp molti cittadini avessero
chiesto i nuovi "tunnel" trasparenti, fu la Soprintendenza stessa a volerli
grigi, giudicandoli meno impattanti. Il dibattito continua, "ma intanto in quei
tratti il rumore è notevolmente ridotto, i vecchi che ricordano i tempi senza
barriere dicono di essere rinati", continua Nacini, che grazie alle sue
battaglie ambientaliste era stato eletto consigliere comunale e lo è stato sino
al 2012, tra le fila di Se. "E non si dimentichi - aggiunge ancora - che è stata
una rivoluzione: l'istituzione della prima commissione al ministero fu una
vittoria, e il caso-Genova ha fatto scuola in Italia. Certo, non è ancora stata
vinta la battaglia più importante". Ecco perché il successo, si diceva, è a
metà: perché nel tratto più delicato, proprio dove l'autostrada sfiora il terzo
piano dei palazzi, si pensò a un complesso progetto per riportare le carreggiate
una di fianco all'altra. "E firmammo pure l'accordo con Regione e Autostrade -
ricorda sempre Nacini - Ma poi fummo traditi". Dopo un decennio di dibattiti, il
progetto infatti è tramontato un anno fa perché troppo costoso. "Ora le
Autostrade hanno promesso tunnel di pannelli come quelli già presenti in altri
tratti - spiega il presidente del Municipio di zona Mauro Avvenente - Speriamo
che a breve partano i lavori. Ma ne abbiamo chiesti altri, perché le criticità a
Genova non sono finite". E non danneggiano solo i residenti, ma anche i turisti:
"Ad esempio in un luogo di pace e natura molto frequentato, la storica Villa
Pallavicini, si continua a sentire il rumore dei tir, ed è inaccettabile.
Basterebbe il proseguimento di un metro delle barriere già presenti:
inspiegabile che non sia ancora stato realizzato".
A Prato il quartiere attraversato dalla
A11, scrive Gerardo
Adinolfi. Sulla terrazza della casa della signora Laura Nocentini di
Cafaggio, frazione di Prato, in Toscana, sembra di essere in una piazzola di
sosta dell'autostrada A11. Si fa fatica anche a parlare. Ogni mattina lei si
sveglia, apre la finestra e dalla camera da letto può godersi il panorama
trafficato dell'arteria che collega Firenze al litorale tirrenico: una scia di
tir e macchine senza interruzione. Per sentire i rumori dei motori che
sfrecciano a 130 chilometri orari tra i caselli di Prato Est e Prato Ovest,
invece, non c'è bisogno neanche di aprire le persiane."Sembra sempre che ci sia
un terremoto - dice Laura mimando i boati - di notte se soffri di insonnia sei
cullato dai tir". Nel 1997 sul cavalcavia dell'A11 un camion sbandò scavalcando
il guard rail e finì prima nella scarpata e poi sul terrazzo distruggendolo. Ora
è inutilizzato. Troppa la paura di un nuovo incidente. Ma soprattutto è troppo
il rumore che proviene dall'autostrada, a neanche 2 metri e mezzo di distanza.
Laura e gli altri residenti della zona aspettano da 14 anni che siano costruite
le barriere antirumore.
Niente barriere antirumore, l'incubo
della frazione sulla A11. Cafaggio è una storia tutta
italiana fatta di intese, proteste, protocolli, procedure burocratiche, ricorsi,
sospensive e rimpalli. Cafaggio è una frazione divisa in due dall'autostrada. Un
quartiere di 2.500 residenti, di cui 500 abitano nelle case e nei palazzi che
costeggiano il cavalcavia di via Roma. Molte delle abitazioni sono state
costruite negli anni '50, prima che la Firenze-Mare passasse di lì. "Troppo
inquinamento acustico", ripetono i residenti e fanno vedere una mappa dell'Arpat
che include l'area nella zona rossa. La zona rossa indica il massimo livello di
rumore rilevato in città. Il paradosso vuole che confinante con l'autostrada, a
soli 20 metri, ci sia anche un palazzo di 5 piani che ospita alcuni uffici
dell'Asl di Prato. Prima che la tempesta di vento del 5 marzo scorso li portasse
via, su tutti i balconi di via Roma, via Davanzati, via Jacopo da Lentini
c'erano lenzuoli bianchi e la scritta: "In mezzo ad un'autostrada". Che è anche
il nome del Comitato dei residenti pronto, dopo anni di battaglie inascoltate, a
presentare un esposto in procura contro Autostrade per l'Italia per chiedere,
passando alle vie giuridiche, la costruzione delle barriere antirumore. Un
piano, nel 2001, era anche partito con un accordo tra il Comune di Prato e
Autostrade che prevedeva 3 chilometri di barriere. "Ad oggi ne sono state
installate per appena 200 metri", dice Tommaso Chiti, portavoce del Comitato.
Tutto si è bloccato nel 2004, dopo un nuovo accordo tra Autostrade e Ministero
che legava la costruzione delle barriere a quella della terza corsia nel tratto
Firenze-Pistoia. Un progetto da 390 milioni di euro per 3 anni di lavoro che la
Regione Toscana ha confermato nella variante al piano di indirizzo territoriale
del 2013. Dieci anni di lavori fermi, senza nessuna prospettiva prossima di
ripresa e in attesa che si concluda l'iter. Ma a che punto è? Per la terza
corsia, di competenza statale, manca ancora un progetto esecutivo, come si
rileva da un documento della Regione Toscana. E nello Sblocca Italia non sono
previsti finanziamenti. Quasi quattro anni fa, nel 2011, Autostrade per l'Italia
ha presentato alla Regione tutta la documentazione necessaria per ottenere il
parere favorevole richiesto dal ministero dell'Ambiente, ottenendolo, ma il 28
maggio 2014 si è di nuovo bloccato tutto perché Autostrade ha presentato ricorso
contro le prescrizioni e chiesto la sospensione del decreto. Si arriva così ad
oggi con la Toscana decisa a non cambiare la sua delibera e lo Stato che ha
avviato un'istruttoria sul caso. Tempi ancora lunghi, quindi. A pagare, nel
frattempo, sono gli abitanti. "Abbiamo contestato ad Autostrade l'utilizzo della
sospensiva rilasciata ormai 10 anni fa - spiega l'assessore comunale
all'ambiente Filippo Alessi - dopo tutto questo tempo non è più applicabile". Il
Comune di Prato vuole accelerare ed è anche disposto a cofinanziare
l'intervento, come già fatto nel 2001. "Se può essere un incentivo, noi ci
siamo", dice Alessi. La progettazione delle barriere, però, dovrebbe seguire lo
stesso iter burocratico già in corso per la terza corsia e quindi potrebbe avere
tempi anche più lunghi. "Sembra che sia un'opera non importante - dice
l'assessore - e questo prender tempo non fa renderci nervosi".
I dannati di Orio al Serio tra charter e
voli cargo, scrive Edoardo Bianchi. "Per la
disperazione, una sera mi misi a contarli; poi persi il conto e provai a
prendere sonno". Sorride, il sindaco di Orio al Serio, Alessandro Colletta. Ma è
un sorriso quasi amaro. Non è facile vivere, mangiare, dormire sotto un
frastuono di turbine che sembra non smettere mai. Non è il solo. Anche i suoi
concittadini e altri sindaci di altri comuni limitrofi soffrono le stesse
insonnie e inseguono gli stessi incubi. "Basta affacciarsi alla finestra",
aggiunge Claudio Pedrini, commerciante del comune di Cassinone, "per capire il
livello di rumore che ha raggiunto la nostra città". Apre le imposte e si
prepara ad alzare la voce. Il rombo dell'ennesimo aereo in fase di atterraggio
suggerisce qualche minuto di silenzio. Pedrini con il dito indica il cielo.
Poi riprende: "Come vede, la situazione è sempre più complicata. E' quasi
impossibile vivere in questi quartieri. Ma l'emergenza non riguarda solo noi, di
Cassinone. Coinvolge tutti i 17 comuni del Bergamasco travolti da questo vero
inquinamento acustico".
Inquinamento acustico, tra i dannati di
Orio al Serio. La storia è nota. L'aeroporto
Caravaggio, così intitolato dal 2011, ha avuto uno sviluppo imponente dal
2000. Da piccolo scalo regionale usato più che altro dai jet executive e altri
voli charter, ha finito per assumere dimensioni e un'intensità di traffico che
il progetto iniziale non aveva considerato e previsto. Oggi accoglie tutto il
flusso alternativo a Linate e Malpensa, soprattutto quello low cost. Il numero
di passeggeri è aumentato in modo esponenziale, come quello del numero di
velivoli che decollano e atterrano. I limiti acustici decisi dalle diverse
amministrazioni responsabili sono stati superati. Ma gli interessi commerciali,
economici, e anche politici, che ruotano attorno allo scalo bergamasco finiscono
per frenare decisioni che in molti, associazioni e comitati locali su tutti,
ritengono ormai ineludibili. "L'inquinamento acustico - commenta il primo
cittadino di Orio Al Serio - è figlio di una scelta imposta per altre ragioni.
La pianificazione urbanistica non è più compatibile con l'attuale traffico
aereo". Alessandro Colletta conosce a fondo la realtà della provincia. "I Comuni
di Grassobbio e Seriate", ricorda, "prestano solo una parte del proprio
territorio ad uno dei limiti aeroportuali; non sono investiti del tutto dal
frastuono provocato dai jet. Diverso il discorso per quelli di Cassinone, di
Colognola e dello stesso Orio al Serio: sorgono esattamente ad est e ovest del
campo d'aviazione. Il primo è allineato alla rotta di atterraggio, gli altri due
a quella di decollo. E' chiaro che si tratta di realtà diverse. Ma siamo tutti
noi a pagare le conseguenze dello sviluppo dello scalo". Dal 2003, l'aeroporto è
divenuto infatti il centro nevralgico dei voli charter da e per il Nord Italia e
in poco più di dieci anni ha fatto registrare un aumento impressionante di
passeggeri trasportati: da due milioni del 2002, agli oltre otto milioni del
2013. Oltre al traffico civile, a Orio al Serio si sono concentrati anche tutti
i voli cargo. Sono questi il vero incubo dei cittadini. Operano in orari
notturni, fuori da quelli già occupati dai voli commerciali e sono dei veri
giganti dei cieli, spinti da enormi turbine che squarciano con frastuoni
infernali le notti silenziose. I dati qui sopra riportati sono eloquenti.
Testimoniano da soli lo sviluppo del traffico negli anni e soprattutto il flusso
di passeggeri e di merci. Il ministero dell'Ambiente è stato ovviamente
coinvolto. Ma prima di intervenire, nel 2014 ha dato incarico all'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) della Regione Lombardia di
verificare l'impatto acustico ambientale generato dal campo di volo sulla zona
circostante. Silvana Patrizia Angius, una fisica esperta di problemi acustici, è
la responsabile dell'Unità organizzativa agenti fisici e radioprotezione
dell'Agenzia. A lei è stata affidato il monitoraggio degli squilibri acustici
attorno all'aeroporto di Orio al Serio. A suo parere i valori sono
effettivamente superiori ai limiti imposti dalla Regione Lombardia. "Ma la
responsabilità", sostiene, "ricade solo in parte sullo scalo. Il vero
inquinamento è dovuto al traffico stradale e ferroviario della zona. Anche
questi sono aumentati. E' chiaro che le soglie vengono regolarmente superate. Il
problema, quindi, è dovuto a diversi fattori. Ed è su tutti questi che
bisognerebbe intervenire".
Salta il divieto di voli notturni, a Orio
al Serio salute a rischio. Ma come si è giunti a
queste conclusioni? E' la stessa Angius a spiegarlo: "Abbiamo svolto - ricorda -
un'analisi incrociata tra il periodo di maggior traffico aereo e quello di fermo
dello scalo per esigenze di manutenzione. I dati sono stati catturati ed
elaborati da delle centraline in dotazione alla società che gestisce
l'aeroporto". Per fare il confronto si è proceduto a due diverse valutazioni. Il
primo è chiamato LVa: registra i 'picchi acustici' al passaggio degli aerei. Il
secondo è detto Leq: memorizza il valore acustico ambientale, ossia tutti i
rumori indipendenti dall'aeroporto e provocati da altre sorgenti presenti nella
zona. "Ebbene - sottolinea la dirigente dell'Arpa - nel 2014 l'attività
aeroportuale sembra non aver inciso da sola sull'inquinamento acustico; esso
appare generato anche dal traffico autostradale e ferroviario. Quello che viene
registrato attraverso le centraline, sono i picchi di LVa al momento del decollo
e atterraggio degli aerei che, sommati, determinano l'incisività d'inquinamento
acustico dovuto ai voli". Ma i risultati sono contestati da tutti i comitati
cittadini sorti nei Comuni, come l'associazione "Colognola per il suo futuro".
Spiega Gabriella Pesce, rappresentante dell'organizzazione: "Basta confrontarle
con la perizia fonica effettuata dalla Bionoise di Stezzano per conto
dell'Amministrazione comunale e i valori appaiono subito diversi e maggiori".
Secondo quest'altra analisi, alcune centraline posizionate in zone differenti
rispetto a quelle di proprietà Sacbo avrebbero registrato livelli decibel
superiori. "La perizia basa i suoi risultati su misure logaritmiche. Ogni tre
Db, il rumore viene amplificato e percepito in maniera raddoppiata dalle
persone. Il risultato, quello che arriva alle nostre orecchie, è micidiale". Il
fatto che la stessa società che gestisce lo scalo di Orio al Serio registri i
dati e di fatto si autocertifichi suscita grandi perplessità. Il presidente
dell'Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni e Trasporti, Dario Balotta, lo dice
chiaramente: "La cosa migliore, quella più equilibrata, sarebbe di affidare ad
una struttura esterna la valutazione e l'analisi dei dati. Lo abbiamo chiesto
più volte. Ma sembra che sia impossibile". Il dibattito continua da anni. Con
polemiche e precisazioni. La responsabile dell'Arpa difende la scelta. E
precisa: "I dati sono grezzi. Ci vengono forniti e li facciamo elaborare. Il
rischio di analisi viziate è escluso". Replica di Ballotta: "E' una questione di
costi. Ma basterebbe reintrodurre la tassa sul rumore e le analisi sarebbero
finanziate". La tassa in effetti esisteva, fino a qualche anno fa. Poi, complice
la crisi e il calo degli incassi degli aeroporti, la Regione Lombardia ha
pensato di abolirla. Un rimpallo di posizioni e punti di vista che scatena un
coro di lamentele da parte di chi il rumore lo subisce. L'avvocato Valentina
Carminati, assessore all'Ambiente del Comune di Bagnatica, sintetizza così: "I
cittadini vorrebbero che i voli cargo, quelli più inquinanti da un punto di
vista acustico, fossero deviati verso l'aeroporto Montichiari di Brescia. Ma non
è facile. Bisognerebbe mettere d'accordo la Save ( gestore dell'aeroporto di
Venezia) e la Sacbo, per la spartizione degli introiti generati dagli stessi
voli". Antonella Litta, responsabile nazionale dell'Isde (Associazione medici
per l'ambiente), ritiene invece che il problema comunque non si risolverebbe.
"Smistare i voli in altri aeroporti - osserva - finirebbe solo per distribuire i
tassi di inquinamento. Il livello generale resterebbe uguale. Ma coinvolgendo
fette più larghe della popolazione". Nel vasto elenco dei disagi dovuti
all'aeroporto di Orio, c'è poi come detto quello dei voli notturni e quello
della zonizzazione acustica: un limite territoriale approvato dalla Commissione
aeroportuale per la prima volta nel 2010, ma poi revocato nel 2013 dal Tar di
Brescia dopo un ricorso proposto dai Comitati locali. Così si è giunti ad una
situazione di stallo creata da veti incrociati. Da una parte, il disagio di voli
in piena notte non autorizzati e contro la normativa che ne vietava il traffico
(modificata e approvata dal Tar del Lazio nell'ottobre del 2014). Dall'altra, il
rifiuto da parte della direzione aeroportuale di avviare dei lavori di
insonorizzazione e delocalizzazione, successivi all'annullamento della
zonizzazione acustica che specificava le zone urbanistiche, e il rispetto dei
livelli acustici stabiliti. Insomma, il classico paradosso all'italiana.
CHI INQUINA, NON PAGA.
Responsabilità ambientale.
L’Unione europea (UE) stabilisce una quadro comune di responsabilità al fine di
prevenire e riparare i danni causati agli animali, alle piante, agli habitat
naturali e alle risorse idriche, nonché i danni arrecati ai suoli. Il regime di
responsabilità si applica, da un lato, ad alcune attività professionali
esplicitamente elencate e, d'altro lato, alle altre attività professionali
quando l'operatore ha commesso un errore o una negligenza. Spetta comunque alle
autorità pubbliche accertarsi che gli operatori responsabili adottino o
finanzino le misure necessarie in materia di prevenzione e riparazione.
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale. La direttiva istituisce un quadro di responsabilità ambientale
basato sul principio “chi inquina paga” per prevenire e riparare i danni
ambientali.
Ai sensi della direttiva, i danni ambientali sono
definiti nel modo seguente:
i danni, diretti o indiretti, arrecati
all'ambiente acquatico coperti dalla legislazione comunitaria in materia di
gestione delle acque;
i danni, diretti o indiretti, arrecati alle specie
e agli habitat naturali protetti a livello comunitario dalla direttiva "Uccelli
selvatici" e dalla direttiva "Habitat";
la contaminazione, diretta o indiretta, dei
terreni che crea un rischio significativo per la salute umana.
Il principio di responsabilità si applica ai danni
ambientali e alle minacce imminenti di danni qualora risultino da attività
professionali, laddove sia possibile stabilire un rapporto di causalità tra il
danno e l'attività in questione. La direttiva distingue due situazioni
complementari cui si applica un regime di responsabilità diverso: da una parte,
le attività professionali elencate nella direttiva stessa, e dall'altra parte,
altre attività professionali.
Il primo regime si applica alle attività
professionali pericolose o potenzialmente pericolose elencate nell'allegato III
della direttiva. Si tratta essenzialmente di attività agricole o industriali
soggette ad un'autorizzazione ai sensi della direttiva sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento, di attività che comportano lo scarico di
metalli pesanti nell'acqua o nell'aria, di impianti che producono sostanze
chimiche pericolose, di attività di gestione dei rifiuti (in particolare gli
scarichi e gli impianti di incenerimento) nonché di attività concernenti gli
organismi geneticamente modificati e i microrganismi geneticamente modificati.
Secondo questo regime, l'operatore può essere considerato responsabile anche se
non ha commesso errori.
Il secondo regime di responsabilità si applica a
tutte le attività professionali diverse da quelle elencate all'allegato III
della direttiva, ma solo quando un danno o una minaccia imminente di danno viene
causato alle specie e agli habitat naturali protetti dalla legislazione
comunitaria. In tal caso, la responsabilità dell'operatore sarà messa in causa
solo se questo ha commesso un errore o una negligenza.
La direttiva prevede una serie di casi di
esclusione della responsabilità ambientale. Il regime di responsabilità non si
applica, ad esempio, in caso di danno o minaccia imminente di danno derivante da
un conflitto armato, una catastrofe naturale o un'attività prevista dal trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, da un'attività di
difesa nazionale o di sicurezza internazionale, nonché un'attività che rientra
in alcune convenzioni internazionali elencate all'allegato IV. Quando emerge una
minaccia imminente di danno ambientale, l'autorità competente designata da
ciascuno Stato membro può:
imporre all'operatore (inquinatore potenziale) di
adottare le misure preventive idonee;
adottarle essa stessa recuperando successivamente
le spese relative a queste misure.
Quando si verifica un danno, l'autorità competente
può:
imporre all'operatore interessato di adottare le
misure di riparazione idonee (determinate sulla base delle regole e dei principi
enunciati all'allegato II della direttiva); o adottare misure preventive essa
stessa recuperando successivamente le spese relative a queste misure. In caso di
più danni verificatisi, l'autorità competente può decidere l'ordine di priorità
per il loro risarcimento.
La riparazione dei danni ambientali assume diverse
forme secondo il tipo di danno:
per i danni che interessano i suoli, la direttiva
impone che i suoli in questione siano decontaminati fino ad eliminare qualsiasi
rischio significativo di causare effetti nocivi sulla salute umana;
per i danni che interessano l'acqua o le specie e
gli habitat naturali protetti, la direttiva mira a ripristinare le condizioni
originarie dell’ambiente precedenti al danno. A tal fine, le risorse naturali
danneggiate o i servizi danneggiati dovrebbero essere ripristinati o sostituiti
da elementi naturali identici, simili o equivalenti, o nel luogo dell'incidente
o, se necessario, in un sito alternativo. Maggiori dettagli sul metodo da
adottare per la riparazione del danno ambientale sono riportati nell'allegato II
della direttiva.
Nel caso in cui l'autorità competente stessa abbia
attuato misure di prevenzione o riparazione, tale autorità copre i costi
sostenuti dall'operatore responsabile del danno o della minaccia imminente di
danno. Lo stesso principio si applica in relazione alle valutazioni ambientali
per determinare l'entità dei danni e alle misure da adottare per risolvere il
problema. L'autorità competente è legittimata ad avviare i procedimenti per il
recupero entro cinque anni dalla data di completamento delle misure di
prevenzione o riparazione oppure dalla data in cui l'operatore responsabile o il
terzo, sono stati identificati, a seconda di quale data sia posteriore. Qualora
più operatori siano solidalmente responsabili del danno, essi devono sostenere i
costi di riparazione o solidalmente o su base proporzionale. La direttiva non
obbliga gli operatori a fornire una garanzia finanziaria, come un'assicurazione,
per coprire la loro potenziale insolvenza. Tuttavia, gli Stati membri sono
tenuti a incoraggiare gli operatori a utilizzare tali meccanismi. Le persone
fisiche o giuridiche che potrebbero essere colpite dal danno ambientale, nonché
le organizzazioni il cui scopo è la protezione dell'ambiente possono, a
determinate condizioni, chiedere alle autorità competenti di intervenire
rispetto ad un danno. Le persone e le organizzazioni che hanno presentato una
richiesta di azione possono avviare un ricorso presso un tribunale o una
organizzazione specifica al fine di valutare la legittimità delle decisioni,
azioni o omissioni dell'autorità competente. Quando un danno o la minaccia di un
danno può avere conseguenze che colpiscono più di uno Stato membro, tali Stati
collaborano negli sforzi per prevenire o riparare.
Verdi, dossier sull'Italia: dall'Ilva
all'Eternit, chi inquina non paga. Gli ambientalisti
hanno esaminato gli ultimi dieci anni di maxi-inquinamenti provati. E hanno
calcolato che tra il 2004 e il 2013 le aziende italiane non hanno risarcito
danni per 220 miliardi di euro,, scrive Corrado Zunino su “La Repubblica”. Dice,
un nuovo dossier dei Verdi, che in Italia chi inquina non paga. Ilva di Taranto,
Caffaro di Brescia, Eternit di Casale Monferrato, il petrolchimico di Agusta in
Sicilia, l'ex Stoppani di Cogoleto sulla costa ovest genovese. Fabbriche in
funzione e fabbriche dismesse hanno inquinato - e lo ha certificato una
procura o un'istituzione di Stato - e non hanno mai versato un euro per
risarcire i danni al territorio e ai suoi abitanti. Il danno ambientale
comprende il ricovero in ospedale dei cittadini ammalati a causa
dell'inquinamento, i costi ambientali e quelli delle bonifiche. Già. In Europa
"chi inquina paga" è un dogma garantito dalla direttiva europea 35 del 2004, in
Italia no. Angelo Bonelli, portavoce degli ambientalisti, a inizio 2015 ha preso
in esame gli ultimi dieci anni di maxi-inquinamenti provati e ha calcolato che
tra il 2004 e il 2013 le aziende italiane non hanno pagato danni per 220
miliardi di euro. Alla prescrizione penale - spesso sopravvenuta, come hanno
illustrato gli ultimi processi per l'amianto dell'Eternit o per la discarica di
Bussi nel Pescarese - è seguita la prescrizione economica. In molti casi,
l'Ilva di Taranto per esempio, le aziende sotto accusa continuano a produrre e a
bruciare, a sversare. Nello stesso periodo considerato - 2004-2013 - i
tribunali italiani hanno preso atto di un milione e 552 mila prescrizioni. Di
queste, ottantamila riguardano reati ambientali. Ci sono 7.300 chilometri
quadrati da bonificare nel paese, che sono pur sempre il 2,4 per cento della sua
superficie. Trecento comuni interessati per sette milioni di persone coinvolte.
I siti inquinati di interesse regionale sono oltre 33 mila, trentanove quelli di
interesse nazionale. I costi di bonifica per ettaro stanno tra i 450 mila e il
milione di euro, ma i soldi (pubblici e privati) per avviare le pulizie delle
terre e delle acque sono dati con il contagocce. Dal 2002 al 2013 sono stati
spesi quattro miliardi di euro: 2,3 di Stato e 1,8 delle aziende. Il danno
ambientale nel Sin di Taranto (i dintorni dell'Ilva, sito di importanza
nazionale da bonificare) è stimato dai custodi giudiziari della Procura della
Repubblica in 8,5 miliardi. Per la discarica abruzzese di Bussi il ministero
dell'Ambiente ha valutato altri 8,5 miliardi. Per la centrale Enel di Polesine
Camerini a Porto Tolle, provincia di Rovigo, l'Ispra, che è il controllore
pubblico dell'ambiente, ha calcolato il danno ambientale in 2,7 miliardi con una
relazione scientifica depositata nel procedimento penale che ha portato nel 2011
alla condanna dell'ex amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni. Nel
petrolchimico di Priolo-Melilli-Augusta, provincia di Siracusa, solo per
disinquinare l'area servirebbero 10 miliardi a cui vanno aggiunti i danni
sanitari e ambientali arrivando a quota 12 miliardi. A Brescia la Caffaro,
produttrice di policlorobifenili (Pcb), ha inquinato per cinquant'anni e fino al
1983: il danno stimato dall'Ispra è di 1,5 miliardi. Il fiume Toce ha portato il
Ddt della Syndial (Eni) nel Lago Maggiore e il Tribunale di Torino nel luglio
2008 ha sentenziato la condanna dell'azienda indicando il danno per il periodo
che va dal 1990 al 1996 in 1,9 miliardi. Per i composti di cromo della Stoppani
dell'area Cogoleto, che ha cessato l'attività nel 2003, a fronte di 1,3 miliardi
da risarcire, la pubblica struttura commissariale ha sostenuto interventi per
400 milioni di euro. I privati, zero. L'Istituto superiore di sanità ha stimato
in diecimila i casi di mortalità in eccesso in 44 siti di interesse nazionale
(oggi sono, appunto, solo 39). "Incrementi significativi dell'incidenza di
tumori maligni a carico di numerose sedi sono stati messi in evidenza dalla
ricerca", si legge. Uno studio dedicato al sito di Augusta-Priolo e di Gela
sostiene che la bonifica dell'area salverebbe 47 persone l'anno e farebbe
risparmiare 10 miliardi di euro in trent'anni. La dotazione del ministero
dell'Ambiente per le bonifiche - ultimo dato conosciuto quello del 2013 - è
di un milione di euro. Un milione. Le uniche risorse davvero disponibili
arrivano dalle transazioni con i privati, che fin qui hanno dato 540 milioni.
L'Eni ha in corso una maxi-trattativa con il ministero dell'Ambiente per
chiudere nove contenziosi aperti per la bonifica di nove siti industriali.
Angelo Bonelli, il coordinatore dei Verdi che ha curato il dossier, dice: "Chi
ha inquinato e attentato alla salute dei cittadini in Italia non ha mai pagato.
Le conseguenze economiche di questo danno ambientale sono state elevate negli
indotti dell'agricoltura, della pesca, nel turismo e nel commercio. Elevate e
poco studiate". I Verdi chiedono l'introduzione del sequestro dei patrimoni per
chi ha inquinato, "bisogna seguire la procedura utilizzata per i sequestri per
mafia".
LA NATURA NON E' AMBIENTALISTA.
La natura? Non è ambientalista.
La natura è una grande macchina che produce vita e morte. Dall'infinitamente
piccolo (i batteri) all'infinitamente grande (le galassie), si nasce e si muore
ed è solo una questione di tempo. Se usiamo con disinvoltura l'aggettivo
«naturale», in realtà su questa macchina abbiamo ancora molto da imparare e da
capire. A cominciare dal fatto che la natura non è buona né giusta né bella.
Questi sono giudizi e proiezioni umani. La natura di noi non si cura. E quando
la si usa per giustificare comportamenti, opinioni, valori si producono errori e
talvolta tragedie. Combinando attualità e filosofia, il libro affronta con stile
caustico e dissacrante tutti i temi più controversi - dal nostro rapporto con le
tecnologie ai paradossi del cibo a Km zero e delle terapie naturali, fino alla
nascita dell'«ambientalista collettivo» e alle applicazioni scellerate del
principio di precauzione - in un capovolgimento di prospettiva che ci induce a
riflettere su quello che intendiamo per natura.
Ogm, inquinamento, km zero: un pamphlet di Testa
ribalta i luoghi comuni dell'ecologismo. Che sono pericolosi, scrive Matteo
Sacchi su “Il Giornale”. Naturale. Secondo natura. Naturalmente. Paroline che
usiamo di continuo e che hanno, sempre più, assunto il valore di sinonimi di:
buono, bello, giusto, equilibrato. Un po' perché in un mondo dove la tecnologia
va veloce è «naturale» avere la tentazione di essere passatisti. Un po' perché
la natura, spesso compendiata dalla formula bio, è di moda e, come cantava
Gaber, «Quando è moda è moda!». Ma davvero questa equivalenza tra natura e tutto
ciò che è positivo ha un senso? Ed è un'equivalenza così automatica? Ci riflette
sopra Chicco Testa in Contro (la) natura (Marsilio, pagg. 130 euro 10, scritto
con Patrizia Feletig). E il responso è già tutto nel sottotitolo: Perché la
natura non è buona né giusta né bella . Testa, che è stato anche presidente di
Legambiente, non può facilmente essere tacciato di poca sensibilità ecologica.
Però al giochino di santificazione di quella che già per Leopardi era una
matrigna di cattivo carattere non ci sta. E in un pamphlet, molto agile, elenca
una serie di fatti e di capisaldi logici difficili da smentire. Faranno però
venire l'orticaria a chi sogna ritorni a un'età dell'oro de-tecnologizzata,
figlia del mito del buon selvaggio. Il primo dato che rileva è che «usiamo
l'aggettivo "naturale" per rafforzare opinioni e concetti che sono solamente
nostri». Giusto per fare un esempio, chi elogia il ritorno al mondo agricolo di
una volta, di quel mondo agricolo "vende" un'idea quanto mai edulcorata, a metà
tra l'Arcadia virgiliana e le réclame del Mulino Bianco. Ma è natura? Così
Testa: «Ciò che noi amiamo della vita in natura è in realtà un paesaggio che
abbiamo forgiato secondo le nostre esigenze e che è cominciato a diventare bello
e piacevole negli ultimi decenni». Insomma niente che abbia a che fare con il
mondo selvaggio. Solo qualche anno fa la vita delle campagne era «grama, molto
grama». Adesso però la campagna è carina, «oggi è possibile vivere a Bolgheri
con gli stessi comfort di chi vive a Manhattan... grazie alla tecnologia».
Quella che ci piace è una finta natura, comoda e umanizzata. Non mancano nemmeno
pagine dedicate ai cosiddetti rimedi naturali, a partire da un capitoletto
intitolato «Cialtroterapia». Elencano con dovizia di particolari medicinali
fitoterapici che possono allegramente mandare al creatore, gli effetti
devastanti del curarsi con terapie non testate clinicamente. E spiegano bene
come quello della cura alternativa sia diventato un enorme business che spesso,
come nel caso dell'omeopatia, si basa su un principio di diluizione tale che
assumere il farmaco «è un po' come versare una tazzina di caffè in una piscina
olimpionica, bere un sorso di quell'acqua e pretendere di aver assunto della
caffeina». Sotto sotto c'è un'idea molto sbagliata della natura perché invece la
natura funziona con le regole della chimica. Insomma c'è molto più buon senso
"naturale" in un laboratorio che in chi rifiuta le vaccinazioni. Con lo stesso
piglio viene poi spiegato come le città siano energeticamente più efficienti e
meno inquinanti della campagna, come la sopravvivenza delle balene debba molto
all'utilizzo industriale del petrolio, et similia. Tutti fatti che non
piaceranno a chi ha trasformato l'ambientalismo in catastrofismo. Come
Greenpeace che Testa definisce (sempre con apposito capitoletto) il «Politburo
dell'ambiente». Ma ciò di cui abbiamo parlato sin qui è solo il livello più
semplice, anche se forse più divertente, del puntuto saggio. Sotto traccia c'è
un ragionamento, più profondo, su come la deificazione della natura e
l'ignoranza delle più elementari basi scientifiche e storiche crei un miscuglio
pericoloso. Sulla scorta di una lunga tradizione di pensatori, che si potrebbe
far partire da John Stuart Mill, l'autore ragiona sul fatto che «La natura è
un'imponente macchina che produce vita e morte... Da questa macchina abbiamo
molto da imparare e molto da capire. Ma non è giusta, né buona né bella. Come
nessuna macchina può esserlo in sé. La natura non si cura di noi esseri umani.
Va avanti e basta. Quando a essa si ricorre invece per giustificare
comportamenti, giudizi e valori, si producono errori e talvolta tragedie». Ma
dicendo queste cose Testa rischia di essere fuori moda.
La natura non ha bisogno di
fondamentalisti, scrive Massimo Micucci su “The
Frontpage”. “Contro la Natura. Perchè la Natura non è nè buona, nè giusta, nè
bella”. Un libro, scritto da Chicco Testa con Patrizia Feletig, che si legge nel
corso di una mattinata con soddisfazione, che deve essere costato tempo, ma non
troppa fatica: perchè sono idee che gli autori sostengono ovunque, assieme ad
una limitata e crescente pattuglia di ambientalisti scettici. “Contro (la)
Natura”, nel provocare scandalo e scomuniche, è come inchiodare le tesi di
Lutero sulla porta della cattedrale di Wittemberg, contro la chiesa egemone ed
indiscussa della natura. Scrivere che la natura può e deve essere modificata,
affinchè la specie umana possa viverci meglio, è peggio di una eresia. Pur
essendo la realtà e pur corrispondendo ad un istinto naturale, quello di
allontanare la morte e migliorare la propria vita. Il comandamenti, la virtù
teologali, i peccati ed i riti della religione naturalista, ambientalista,
integrista, anti-sviluppista ed anti-scientifica vengono passati in rassegna e
sottoposti ad una critica puntuale ed argomentata, con ironia e con dovizia di
esempi clamorosi ed evidenti. Il cuore della “verità naturalista assoluta” è
che la natura è bella, buona, giusta, quanto potente (questo è vero) e
salvifica. Sarebbe l’uomo con il suo sviluppo, prevalentemente capitalista, ad
ostacolarla e ad imbrattarla, condannando tutti alla morte del pianeta tra
catastrofi ad intensità crescente ed atroci tormenti. Quelli della decrescita
felice, del KM-0, del principio di precauzione, i No-Triv, No-Tav, No-Gas,
No-Oil, No-Coke, se ne fregano se negli ultimi decenni grazie al progresso umano
e tecnologico sul presunto ordine naturale delle cose, le condizioni degli
umani sono migliorate, le malattie “naturali” combattute attraverso le ultime
scoperte scientifiche, o se si sono ridotti i morti per denutrizione e su come
le tecnologie – comprese quelle più discusse – hanno migliorato la vita
sopratutto dei poveri grazie all’industrializzazione e all’urbanizzazione. Il
problema, di tutti e non solo degli ambientalisti riformisti come Chicco Testa o
Patrick Moore, è che questa religione ha imposto la sua cornice intellettuale e
comunicativa a tutti (soprattutto a sinistra) ed ovunque (in modo particolare a
chi se la passa meglio). Motivo per cui, ci ritroviamo davanti ad una Vandana
Shiva che paragona gli scienziati favorevoli agli ogm a stupratori seriali. Per
non parlare di Green Peace, associazione senza alcuna trasparenza democratica,
in cui il Politburo sta facendo di tutto, in nome della ideologia anti-ogm, per
fermare il Golden Rice che consentirebbe di debellare la mancanza di vitamina B
in grandi aree in via di sviluppo e di salvare milioni di bimbi dalla cecità.
Insomma “natura e “ naturale” sono parole da maneggiare con cura, perchè un
tempo anche partorire con dolore e schiavizzare i neri era considerato da
qualcuno come naturale e ancora oggi altri cercano di imporre come naturale ed
unica la forma di famiglia che sta nelle scritture. Se ci sono voluti secoli per
evitare che la popolazione europea venisse decimata regolarmente dalle
epidemie, se altrettanto c’è voluto per ridurre il numero di persone che
vivevano sotto il limite della sopravvivenza, per allungare l’età media e
ridurre la mortalità infantile, vale la pena tenere la natura con tutto il
rispetto alla distanza giusta. Distanza di cui ci rallegriamo solo quando la
civiltà e la tecnica ci tiene al riparo da accidenti o catastrofi, appunto,
naturali. Una rassegna di esempi e ragionamenti che a tratti fa sorridere per
le clamorose incongruenze dei fondamentalisti, a volte invece deprime, ma ci
aiuta a pensare e a sviluppare un punto di vista critico rispetto al pensiero
pesante e spesso retrogrado di chi considera la natura un eden da riconquistare.
Quanto valgono gli operai Ilva, si chiede Nicola
Porro su “Il Giornale”. L’Italia è ancora il secondo produttore europeo di
acciaio, dopo la Germania. Con il 15 per cento del totale, produciamo più
billette e prodotti piani di francesi (che hanno il nucleare e un prezzo
dell’energia ridicolo), spagnoli e inglesi. È un mestiere che prima i bresciani
con i forni elettrici e poi i Riva con gli altiforni sanno fare. Il caso degli
acciai speciali di Terni (due forni elettrici) che i tedeschi della Thyssen
vogliono mollare, parte da lontano, ma riguarda, in sostanza, cinquecento operai
(con tutto il rispetto per ognuno di loro). Pensate cosa avverrebbe se dovesse
saltare l’Ilva di Taranto (portandosi dunque appresso gli stabilimenti di Genova
e Novi): 16mila dipendenti a spasso. Altro che quattro feriti in piazza davanti
all’ambasciata tedesca. Sia nel primo caso, sia nel secondo ci sono precise
responsabilità. E non riguardano i proprietari di questi impianti, non sono
affare dei padroni (che possono aver commesso degli sbagli), ma di quello che i
professoroni chiamano «sistema Paese» e che poi non si capisce mai cosa sia. Ve
lo spieghiamo noi. Sistema Paese (che non funziona) è quel Paese in cui
l’amministratore delegato della Thyssen viene condannato a 16 anni per omicidio
volontario e dopo sette anni non conosce ancora il prezzo finale della sua pena.
In uno dei suoi impianti, la linea numero 5, sono tragicamente morti sette
operai. E uno di loro si è salvato per miracolo. Negligenza della Thyssen. Il
processo, dopo vari gradi, è ancora in corso. In primo grado un tribunale
italiano ha condannato il massimo responsabile di quell’industria come se avesse
volontariamente ucciso i suoi sette operai. Qualunque impresa, anche micro, ha
centinaia di controlli, ma evidentemente non lo stabilimento Thyssen di Torino,
dove è avvenuto il fattaccio. Quando poi la tragedia avviene, si condanna con il
manganello il boss tedesco dell’impresa. E si rettifica in appello. Non
stupiamoci quindi se i vertici tedeschi dichiarano, più o meno: in Italia non si
può investire. Indovina, indovinello: se la Thyssen deve chiudere uno dei suoi
stabilimenti europei, quale Paese sceglie? Nessuno dice di lasciare impunite le
malefatte delle multinazionali, ma converrebbe avere un po’ di certezza del
diritto e non sparare sentenze clamorose e di piazza. L’Ilva di Taranto è un
altro tragico caso di scuola. Un malinteso senso di giustizia (che vale solo in
un senso, quello dell’accusa) sta distruggendo un patrimonio del Paese. Gli
altiforni di Taranto sono stati espropriati alla famiglia Riva sulla base di
accuse durissime (disastro ambientale) che sono tutte ancora da dimostrare. La
prima udienza è arrivata un mesetto fa, dopo più di due anni di caos
giudiziario. Il patron della famiglia è morto, l’azienda è stata commissariata
e, secondo un bel reportage di Paolo Bricco, dagli arresti a oggi i vari
commissari hanno bruciato 2,5 miliardi di patrimonio netto. Hanno messo in
ginocchio l’acciaio italiano. Con un accanimento da Far West , dove però i
soprusi arrivano dagli sceriffi. L’Eurostat, non Babbo Natale, ha calcolato che
i tedeschi dal 2003 al 2010 hanno fatto investimenti ambientali nelle loro
industrie siderurgiche per circa 450 milioni. L’Italia per circa un miliardo, e
dunque la quota Ilva di Taranto (che rappresenta il 55% della nostra industria)
ha investito nei sette anni della gestione Riva più di quanto abbiano fatto
tutte le industrie tedesche. La questione sociale dell’Ilva è lì lì per
scoppiare. Su questa Zuppa lo scriviamo da più di un anno. Intanto il tempo
passa e l’azienda va a catafascio. Le imprese non si gestiscono con i commissari
(grazie al cielo Bondi ha lasciato il passo al più serio Gnudi). L’Ilva è
sull’orlo del collasso finanziario e quando domani vedremo i suoi operai in
piazza non potremo girarci dall’altra parte: dovremo dire loro con chi
prendersela. E non sono i Riva. Il governo ha deciso di mettere in campo la
Cassa depositi e prestiti, si tratta di una nazionalizzazione bella e buona. È
pur sempre meglio dell’offerta degli indiani: spregiudicati nel comprare a
debito e a prezzi da saldo e poi nel fare lo spezzatino. Ma l’aver sventato un
rischio (quello indiano, appunto) e aver individuato una possibile via d’uscita
(la Cdp con Arvedi, che di acciaio se ne intende) non toglie che il legittimo
proprietario esista e si chiama Riva. Tanto per intenderci, i suoi affari, fuori
dal perimetro dell’Ilva e dunque delle inchieste tarantine, vanno a gonfie vele.
I suoi Forni Elettrici (non ha diversificato in pizzi e merletti) fatturano
circa 4 miliardi di euro, fanno utili e non hanno indebitamento rilevante. Sono
degli imprenditori modello? Non lo sappiamo. Ma non c’è alcuna sentenza, nemmeno
di primo grado, che dica il contrario. E la loro gestione economica dell’Ilva di
Taranto, e ora della Forni Elettrici, dimostra come siano tra i pochi in Europa
a saper fare questo mestiere. E noi li abbiamo sputtanati e buttati a mare. Ne
pagheremo le conseguenze. E sarà inutile piangerci sopra. Era già tutto
previsto…Ps. Rincresce vedere come il mondo industriale sia stato assente dalla
difesa di questa famiglia, e dunque di questa industria strategica per il Paese.
E solo ora stia dando qualche cenno di vita. A parte la solitaria battaglia del
numero uno di Federacciai (Antonio Gozzi si è battuto come un leone per fare
emergere le ragioni dell’impresa) e dell’attuale numero uno di Assolombarda
(Gianfelice Rocca), il resto del mondo confindustriale si è girato dall’altra
parte. Si è vergognato dei Riva. In fondo, pensavano, potevano essere un po’ più
puliti. O un po’ più confindustriali.
LA BEFFA DEI SOLDI NON SPESI PER I DEPURATORI.
Inquinamento delle acque, i dati allarmanti di
Goletta Verde. I campioni prelevati e analizzati dall'associazione ambientalista
sono a dir poco preoccupanti senza eccezioni, dalla Liguria alla Sicilia.
Principali imputati i depuratori assenti o non idonei e comportamenti criminali
come lo sversamento di rifiuti industriali, scrive Carmine Gazzanni su
“L’Espresso”. A leggere il rapporto sulla
qualità delle acque di balneazione stilato, come ogni anno, dal ministero della
Salute, non ci sarebbe di che preoccuparsi. Si evidenzia, addirittura, un
aumento delle acque di qualità eccellenti in Italia, con una percentuale pari
all’87,2% sul totale delle acque di balneazione italiane, rispetto all’85,1%
dell’anno precedente. Insomma, come si legge nel rapporto, “l’Italia è uno dei
paesi europei con un più elevato livello di tutela sanitaria in questo settore”.
Un risultato di tutto rispetto se consideriamo che il nostro è il Paese europeo
con il maggior numero di acque di balneazione tra marine (4.880) e interne
(629), per un totale di 5.511 siti. Un quarto del totale di quelle europee.
Peccato, però, che i dati pubblicati dal ministero, pur essendo lodevoli, non
sembrino poi così attendibili. Non fosse altro per un motivo: il rapporto,
pubblicato a stagione estiva ormai nel vivo, descrive una realtà riferita alle
analisi condotte nel 2013. E, com’è facilmente immaginabile quando si parla di
inquinamento delle acque, nel giro di un anno può cambiare davvero tutto.
Perlomeno questo viene da pensare confrontando il quadro che emerge dalla
relazione ministeriale con quanto sta venendo alla luce dalle analisi condotte
in questi giorni da Legambiente nell’ambito della campagna “Goletta Verde”.
Certo, qui parliamo di esami condotti su un campionamento di siti. Eppure le
analisi dovrebbero mettere tutti in allerta. Per questioni ambientali. Ma anche
per ragioni economiche. Cominciamo dai dati. Come spiega la portavoce di Goletta
Verde, Serena Carpentieri, i prelievi e le analisi vengono eseguiti dal
laboratorio mobile di Legambiente. I parametri indagati sono microbiologici
(enterococchi intestinali, escherichia coli) e vengono determinati come
“inquinati” i risultati che superano i valori limite previsti dalla normativa
sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo
del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli che superano più del doppio
tali valori. “Quando quei batteri si trovano nell’acqua – precisa Carpentieri –
significa che c’è un inquinamento di tipo biologico causato da insufficiente
depurazione”. L’obiettivo, d’altronde, è proprio questo, andare a scovare
situazioni critiche: “Difficilmente andiamo a campionare tratti di mare che non
sono interessati da scarichi, foci di fiumi e quant’altro. Su segnalazione dei
cittadini e con l’aiuto dei nostri circoli locali andiamo a campionare siti che
sono interessati da canali e fiumi”. Ebbene, da Nord a Sud Legambiente presenta
e illustra una realtà impressionante. Il viaggio di Goletta Verde è partito
dalla Liguria dove, sui 23 campionamenti effettuati lungo i 345 chilometri di
costa, nel 40% dei casi sono stati rinvenuti valori di inquinanti ben oltre i
limiti consentiti. Dei sei prelievi in provincia di Genova, tre sono risultati
“fortemente inquinanti”, così come anche a Imperia e a La Spezia. Tutta colpa,
dicono da Legambiente, di “acque avvelenate da scarichi non depurati
adeguatamente che evidentemente provengono anche dalle aree interne e attraverso
i fiumi si immettono a mare”. E la situazione non si presenta poi tanto diversa
scendendo giù lungo la costa tirrenica. Anzi, se si vuole peggiora. E così,
nonostante in Toscana si riscontrino dati tutto sommato positivi con “solo” sei
casi che hanno fatto registrare valori oltre il consentito su un totale di 18
prelievi effettuati, bisogna anche qui entrare nel merito. Facendo un raffronto
con il Portale delle Acque del Ministero della Salute, infatti, scopriamo che
due dei sei punti inquinati (Foce torrente Carrione a Grosseto, Marina e Moletto
del Pesce di Marciana Marina, in provincia di Livorno) non sono per nulla
campionati dalle autorità competenti; le restanti quattro invece risultano
balneabili. Addirittura, denuncia l’associazione, due punti dell’isola d’Elba
risultati inquinati, nel portale istituzionale godono di un profilo
“eccellente”. C’è qualcosa che non torna. Ma anche questo, purtroppo, non deve
sorprendere. Come ci spiega Serena Carpentieri, infatti, “molti tratti di mare
interessati da Goletta Verde non ricadono in acque di balneazione per il
ministero e quindi sono stati propri esclusi dai campionamenti. In pratica,
viene dato per scontato che sono tratti inquinati e tali devono rimanere dato
che non vengono monitorati”. Siamo al paradosso. Dati davvero preoccupanti
arrivano anche dal Lazio dove, su un totale di 24 campionamenti, ben 18 (il 75%)
presentano una incredibile concentrazione di inquinamento microbiologico. Basti
questo: in 13 casi il giudizio è addirittura “fortemente inquinato”. Bollino
rosso soprattutto per quanto riguarda la provincia di Roma: in quasi la totalità
dei prelievi (in 12 casi su 13) sono stati registrati livelli ben al di sopra
del consentito. Non solo. Secondo quanto denunciato dal COOU (Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati) che sta conducendo le analisi con Legambiente, una
vera e propria piaga per il Lazio è costituita dallo sversamento di oli usati. I
dati registrati nell’ultimo rapporto (relativo al 2013) sono impressionanti:
solo in questa regione sono stati raccolti 10.252 tonnellate di olio usato, di
cui 6.548 nella provincia di Roma. Al peggio, però, non c'è fine. E allora, per
raschiare davvero il fondo del barile, bisogna aspettare di leggere i dati
relativi a Campania, Calabria e Sicilia. Dei 31 punti monitorati in Campania,
ben 21 sono risultati inquinati e, di questi, 10 campionamenti riguardano la
sola provincia di Napoli. Numeri, d’altronde, che non sorprendono: anche le
ultime stime ufficiali (relative al 2012) dell’Arpac parlano di una regione con
una quota di depuratori non conformi superiore al 50%. E, come nel Lazio, anche
in Campania la responsabilità sarebbe imputabile agli oli usati non eliminati in
modo corretto. Secondo la denuncia di Antonio Mastrostefano, direttore della
Comunicazione del COOU, “se eliminato in modo scorretto questo rifiuto
pericoloso può danneggiare l’ambiente in modo gravissimo: 4 chili di olio usato,
il cambio di un’auto, se versati in mare inquinano una superficie grande come
sei piscine olimpiche”. Basti pensare che lo scorso anno sono stati quasi 14mila
le tonnellate di olio usato recuperato dal COOU. Di questi quasi 9mila nella
provincia napoletana. E allora non sarebbe affatto un caso che, dopo ben due
condanne dell’Unione Europea per il mancato trattamento delle acque reflue, sia
arrivata, proprio all’inizio della stagione estiva, l’apertura di una terza
procedura d’infrazione e che questa coinvolga ben 115 comuni campani (su un
totale di poco meno di 900), classificando la Campania tra le regioni peggiori
d’Italia. Numeri, questi, che fanno eco a quelli pugliesi: su un totale di 187
depuratori, 12 impianti continuano a scaricare nel sottosuolo nonostante questa
sia una pratica vietata dalla legge (non a caso due sono stati da poco
dismessi), 39 depuratori (dati Arpa Puglia 2013) non sarebbero affatto a norma,
33 sarebbero sotto sequestro per procedimenti penali e 37 sarebbero coinvolti
dalla procedura UE. Una realtà incredibile che, dallo screening effettuato,
evidenzia pesanti anomalie soprattutto nel tarantino e nel brindisino: i dati di
Goletta Verde parlano di 5 punti “fortemente inquinati” su 10 campionamenti
effettuati nelle due province. Ci sono regioni, poi, dove i problemi depurativi
vanno avanti da anni. È il caso della Sicilia. Dalle analisi di Goletta Verde
emerge che oltre il 60% dei punti monitorati lungo le coste non supera l’esame:
su 26 prelievi totali, 16 casi hanno restituito un giudizio negativo. C’è da
sorprendersi? Probabilmente no, dato che si registrava una situazione
profondamente critica già nel 2008 quando l’Istat realizzò il suo ultimo
rapporto sui livelli di depurazione e la Sicilia si classificava come peggiore
regione italiana, registrando solo un 47% di adeguata copertura. Non sorprende,
pertanto, che nella nuova procedura d’infrazione siano addirittura 175 i comuni
siciliani attenzionati. Si dirà: ma negli anni non è stato fatto niente? Come
vedremo, no. Nonostante i lauti stanziamenti messi a disposizione. È inizio
luglio quando la procura di Vibo Valentia, guidata da Mario Spagnuolo, denuncia
trenta sindaci tutti del vibonese per scarico abusivo, al termine di un’indagine
a tappeto condotta dalla Capitaneria di Porto di Vibo Marina che ha messo sotto
osservazione gli impianti di depurazione del territorio provinciale. Dai
controlli, infatti, sarebbe emersa una situazione disastrosa: secondo quanto
denunciato dalle autorità, il servizio di depurazione nel vibonese coprirebbe
solo il 40% della popolazione, i reflui del 60% degli abitanti scorrerebbe a
mare o in fossi e torrenti, su 50 comuni della provincia di Vibo ben 17 non
sarebbero dotati di impianti e gran parte dei tronchi fognari scaricherebbero le
proprie acque, senza alcun tipo di trattamento, nei corsi d'acqua che arrivano a
mare. Insomma, un disastro. Così come lo è stata un’altra vicenda, anche questa
denunciata dalla procura di Vibo, sull’indotto dell’Alaco, il lago artificiale
che, tra la provincia vibonese e quella catanzarese, rifornisce d’acqua circa
400 mila abitanti: tra tecnici, funzionari regionali e amministratori locali
(tra cui anche i due sindaci dei capoluoghi) sono 36 le persone coinvolte nei
confronti dei quali si contesta, tra le altre cose, anche l’avvelenamento
colposo delle acque. Una realtà incredibile, dunque, quella calabrese. E i dati
di Legambiente non fanno che confermarlo: addirittura nell’80% dei casi
campionati (19 su 24) sono state registrate cariche batteriche almeno due volte
più alte di quelle consentite dalla legge, con un giudizio di “fortemente
inquinato”. E non è solo Legambiente a denunciare questa situazione, visto che
nella nuova procedura di infrazione europea sul trattamento dei reflui urbani
sono 129 i comuni calabresi in cui vengono segnalate “anomalie” sulla
depurazione. Oltre al danno ambientale, quello economico. Tra sentenze UE e
finanziamenti mai utilizzati. Il quadro che emerge, dunque, è spaventoso. E non
solo per questioni ambientali, ma anche per ragioni economiche. La direttiva
europea sulle acque reflue è del 21 maggio 1991: sono dunque quasi 25 anni che
l’Italia resta inadempiente e colleziona sanzioni comunitarie, nonostante la
direttiva sia stata recepita nel ‘99. E così, a conferma del grave deficit del
sistema depurativo, è arrivata solo pochi mesi fa la terza procedura
d’infrazione, relativa a 41 agglomerati urbani per un totale di circa 900 comuni
sparsi in ben 12 regioni italiane. Gravissime le conclusioni a cui giunge la
Commissione e riportate nella comunicazione del 31 marzo: “la Commissione
ritiene che l’Italia sia venuta meno agli obblighi incombenti (...) della
Direttiva 91/271/CEE in un numero consistente di agglomerati, alcuni dei quali
molto grandi (Roma, Firenze, Napoli, Bari, Pisa, ecc.) e alcuni dei quali
scaricano in aree sensibili”. E ancora: “l’Italia è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti della Direttiva in cinquantacinque aree sensibili”. Conclusioni
che ribadiscono quanto già detto nelle due sentenze di condanna già inflitte:
una, arrivata a luglio 2012 (e aperta nel 2004), riguardante oltre 100
agglomerati; la seconda (aperta nel 2009) la cui sentenza è arrivata il 10
aprile 2014 e riguardante decine di agglomerati, dalla Sicilia alla Lombardia,
con più di 10mila abitanti equivalenti che scaricano in aree sensibili. “Ben
presto – dice Carpentieri – arriveranno anche delle multe in seguito alle
condanne. Bisognerà vedere se negli agglomerati sia stata messa in atto una
programmazione tale da poter evitare sanzioni pecuniarie”. Sanzioni che
potrebbero essere decisamente pesanti. Secondo una ricognizione della
Confservizi Piemonte si parlerebbe di una condanna che andrebbe da un minimo di
11.904 euro a un massimo di 714.240 euro per ogni giorno di ritardo
nell’adeguamento a decorrere dalla pronuncia della sentenza, che si
aggiungerebbero a una somma forfetaria che per l’Italia corrisponde ad un minimo
di 8 milioni 863 mila euro. Ancora più drastico è stato il gruppo Hera (società
che gestisce il servizio idrico in Emilia Romagna) che addirittura ha parlato di
sanzioni che in totale potrebbero arrivare a 700 milioni di euro. Bisognerebbe
correre ai ripari, dunque. E il prima possibile. Peccato, però che poco si stia
facendo. Nonostante – paradosso dei paradossi – i finanziamenti ci siano.
Clamorosi i casi, tra gli altri, di Sicilia e Calabria. Secondo quanto
denunciato dalla deputata M5S Dalila Nesci in un’interrogazione depositata in
questi giorni, dal 2000 al 2012 la regione calabrese ha beneficiato tra fondi
CIPE, europei e ministeriali di 717 milioni di euro proprio per completare,
adeguare e ripristinare il sistema fognario. A vedere i risultati, però,
sembrerebbe proprio che poco sia stato fatto, tanto che la parlamentare ha
chiesto conto di tali finanziamenti e dei progetti portati a termine. Situazione
analoga anche in Sicilia. Secondo la denuncia di Legambiente il miliardo e 161
milioni di euro messi a disposizione per la regione dal Fondo di Sviluppo e
Coesione per realizzare fogne e depuratori rischia ora di tornare a Bruxelles.
Il motivo è tragicomico: quasi nessuno ha utilizzato questi fondi. “Finora –
denuncia ancora Carpentieri - le risorse utilizzate ammontano ad appena 65
milioni”. Il resto è rimasto incredibilmente in cassa. Vedremo cosa succederà
d’ora in avanti considerando che con la legge di stabilità 2014 è stato
istituito un fondo apposito finalizzato a potenziare la rete depurativa per i
reflui urbani. La dotazione complessiva per il prossimo triennio è di 90 milioni
di euro (10 per quest’anno, 30 per il 2015 e 50 per il 2016). Difficile, davanti
ad un quadro così desolante, rintracciare singole responsabilità. Certamente gli
enti locali hanno la loro bella fetta di colpa dato che “sono i primi chiamati
in causa soprattutto in riferimento alle progettualità da avviare. È una materia
che tocca tanti enti che dovrebbero riunirsi attorno ad un tavolo per
pianificare il lavoro. Questa dinamica però – continua la portavoce di
Legambiente – spesso fallisce e il risultato è che ogni estate ci troviamo a
dover commentare dati di questo genere e ad assistere a sequestri di depuratori
e a malfunzionamenti di vario genere. Ci sono situazioni che vanno avanti da
decenni e non si vede all’orizzonte una soluzione”. Alla negligenza e incuria
delle singole amministrazioni locali, si affiancano anche responsabilità
ministeriali. Quello che verrebbe da pensare, infatti, è che mancano i dovuti
controlli. E, quando ci sono, arrivano in spaventoso ritardo. Non solo infatti
il rapporto presentato pochi giorni fa dal ministero della Salute si riferisce,
come detto, ad analisi del 2013. C’è anche dell’altro. Il 9 luglio scorso,
infatti, si è riunita la “Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico
e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche” messa in piedi direttamente
della Presidenza del Consiglio dei ministri e in cui ritroviamo tecnici
ministeriali, della protezione civile e delle varie amministrazioni locali.
Ebbene, in quella data si è deciso di avviare – finalmente – la programmazione
di interventi in materia di depurazione e trattamento delle acque reflue. Bene.
Ma da quando? Da settembre 2014. Insomma, a stagione estiva e turistica
conclusa. D’altronde è tempo di vacanze. Meglio farsi un bagno in mare.
Inquinato.
La beffa dei soldi non spesi per i
depuratori, due miliardi inutilizzati. Quattro
italiani su dieci scaricano nei fiumi e in mare. In arrivo una maximulta da
Bruxelles. Maglia nera al Friuli Venezia Giulia, scrive Gian Antonio Stella su
“Il Corriere della Sera”. Zero carbonella: ecco i soldi spesi dalla Sicilia di
quel miliardo e 96 milioni di euro che aveva ricevuto per depurare le acque. Un
danno e una beffa: sta per arrivare, da Bruxelles, una sanzione pesante. Che non
colpirà solo l’isola. È l’Italia tutta, infatti, a essere lontana dagli standard
dei Paesi di punta: il 36% dei cittadini scarica direttamente nei fiumi e in
mare. Una vergogna. Che ci può costare quasi un miliardo di maximulta. Soldi
buttati per «sciatterie, inefficienze, mancati controlli...». La tabella di
confronto col resto d’Europa fa arrossire: dietro di noi, che arranchiamo con
solo 64 cittadini su cento dotati d’un sistema fognario, ci sono l’Estonia, il
Portogallo, la Slovenia... Ma siamo staccati di 9 punti dal Belgio, 17 dalla
Repubblica Ceca, 20 dalla Francia, 22 dalla Spagna, 33 dalla Finlandia, 34 dalla
Lituania e dalla Gran Bretagna, 36 dall’Austria, dalla Germania o dall’Olanda.
Certo, i dati della «Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e lo
sviluppo delle infrastrutture idriche», voluta da Renzi per accorpare il tema
delle acque e unificare ad esempio sei banche dati diverse «dove non c’era un
numero che tornasse», dicono che è il Mezzogiorno l’area più critica: la metà
dei cittadini scarica senza filtri. A dispetto di certi stereotipi
anti-meridionalisti, però, spiega Erasmo D’Angelis, che guida la Struttura, la
regione più esposta alla stangata europea per l’assenza di depurazioni è il
Friuli Venezia Giulia. Dove la multa in arrivo da Bruxelles il 1° gennaio 2016,
secondo le previsioni calcolate dalla Struttura di missione dovrebbe essere di
66 milioni di euro pari a 53,6 euro pro capite. Il doppio della multa alla
Calabria, quasi il quintuplo rispetto alla Liguria, sette volte la media
nazionale (8,1 euro), il decuplo della Puglia. Seconda, per sanzione pro capite,
è un’altra regione settentrionale, la Val d’Aosta: 39 euro pro capite. Terza la
Sicilia, che pagherà complessivamente la somma più alta: 185 milioni. Ma è tutta
la penisola, accusa D’Angelis, ad essere in ritardo: «Perfino in Lombardia
(dico: in Lombardia!) i fiumi e i laghi sono per il 40% gravemente inquinati».
Totale della maximulta in arrivo per i depuratori, secondo la Struttura: 482
milioni di euro. Più altrettanti o poco meno per l’inquinamento di corsi
d’acqua, laghi, lagune... Sono strettamente collegati il rischio idrogeologico,
lo sviluppo delle infrastrutture idriche e l’adeguamento del sistema della
depurazione delle acque e della bonifica delle discariche. Senza equilibrio,
addio. Come ricorda una relazione della «Struttura» alla Camera, il nostro è uno
dei Paesi più franosi del mondo: «486.000 delle 700.000 frane in tutta l’Ue sono
in 5.708 Comuni italiani, 2.940 a livello di attenzione molto elevato». E questo
«si intreccia con una impressionante carenza pianificatoria di superficie, la
quasi scomparsa delle manutenzioni, abuso del suolo e fiumi incanalati in piste
da bob o intubati sotto le città pronti ad esplodere al primo nubifragio come il
Seveso». E si intreccia ancora «con un generale fatalismo e la scarsa percezione
della dimensione dei rischi e di conoscenza dei fenomeni». Va da sé che la
potenza distruttiva della natura (Dante stesso pare accennare alle «bombe
d’acqua» ma ce n’erano molte meno di oggi) «viene moltiplicata dai nostri errori
fatali, primo fra tutti la caparbietà con la quale il territorio più fragile» e
più abitato (189 abitanti per chilometro quadrato contro i 114 della Francia e
gli 89 della Spagna) «è stato spremuto» senza tener conto della «regola base
della prevenzione strutturale». Un esempio? Su 16.700 chilometri di binari
ferroviari 6.700 sono esposti a rischio: «Non occorrono esperti
amministrativisti o contabili ma di psichiatria». Basta, sostiene il documento,
«non è più accettabile vedere l’Italia che crolla, frana e si allaga così
facilmente e non poter far nulla o poco perché pur in presenza di risorse
bisogna aspettare firme, timbri e pareri per tempi indefiniti. E assistere a
Conferenze di servizi dove i poteri di veto di ogni partecipante sono simili a
quelli del Consiglio di Sicurezza Onu, facendo passare 3-6 anni dalla
progettazione all’inizio di lavori anche banali». Matteo Renzi assicura di voler
accantonare «un miliardo l’anno del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
2014-20 per il finanziamento di interventi infrastrutturali di messa in
sicurezza di territori e in particolare a difesa delle aree metropolitane». Ma
poi, sarà possibile spendere quei soldi o resteranno appesi al soffitto come
caciocavalli? La domanda non è retorica: negli ultimi 16 anni, accusa il
documento consegnato a Montecitorio, non sono stati usati un sacco di quattrini
destinati alla messa in sicurezza idrogeologica e alla depurazione delle acque,
che come abbiamo visto nel caso del Seveso o del Sarno sono strettamente legate.
Colpa di «procedure burocratiche abnormi», di ricorsi infiniti dopo ogni appalto
(perfino i lavori sul Bisagno, protagonista di disastrose inondazioni a Genova,
sono bloccati...), di veti incrociati, di «ritardi ed eccessiva complessità
delle procedure di valutazione di impatto ambientale». Totale dei soldi non
spesi, in tre blocchi principali di finanziamenti: due miliardi e 273 milioni.
Tutti denari già disponibili, cash, per i quali non sono mai stati aperti i
cantieri. E qui sono sotto accusa soprattutto tre regioni meridionali. «Sicilia,
Calabria e Campania hanno in comune l’impressionante incapacità di spesa e
l’inefficienza della Pubblica amministrazione a partire dai livelli regionali»,
scrive D’Angelis in una lettera al presidente del Consiglio. Un esempio? I soldi
stanziati con gli accordi di programma 2009/10. In Calabria, su 185 interventi
programmati, solo cinque cantieri aperti e manco uno chiuso nonostante il
territorio sia così fragile da aver vissuto dal 2010 a oggi «454 nuove
emergenze». In Campania su 97 programmati solo quattro cantieri aperti e solo
due chiusi. In Sicilia 194 programmati, 43 cantieri già chiusi e 71 aperti ma la
Regione, che avrebbe dovuto sborsare 172 milioni accanto a quelli statali, ha
scucito solo «lo 0,1%». Quanto al Report delle opere idriche, «la Delibera Cipe
60/2012 impegnava 1,6 miliardi per le Regioni del Sud per un totale di 183
interventi (depuratori, collettori, reti fognarie). Ad oggi nessuna opera è
conclusa». Nessuna. Maglia nera, come dicevamo, la Sicilia che grazie anche a
Stefania Prestigiacomo era stata benedetta da una pioggia di quattrini: «Su 96
opere programmate per 1.096 miliardi appena 5 opere al preliminare e zero fondi
impegnati». Ulteriore conferma di una certezza: non è (solo) una questione di
soldi...
AREA MARINA PROTETTA. A MANDURIA QUALCOSA NON
VA……
A Manduria qualcosa non va. Non voglio pensare che
tutti i cittadini del paese messapico siano in sintonia con i loro
amministratori. Al contrario, la cosa sarebbe grave e da far pensare.
Gli amministratori manduriani, che si presume
rappresentino tutta la cittadinanza di Manduria, sembra che adottino
provvedimenti amministrativi paradossali e poco condivisibili dal resto del
mondo.
Gli amministratori manduriani e quelli savesi, pur
avendo un vasto territorio idoneo alla bisogna, furbescamente, prima hanno
deciso di disfarsi delle loro feci, scaricandoli sul territorio di Avetrana, con
la realizzazione del depuratore consortile a fianco dell’Urmo, frazione
turistica di Avetrana ad 1 km dal mare, giusto per rovinare lo sviluppo
turistico di Avetrana, poi, non contenti decidono di sversare il liquame nel
mare prospiciente, di competenza manduriana.
Questo con la colpevole, se non dolosa, complicità
dei rappresentanti locali e regionali di tutti gli schieramenti politici: da
Calò, Massaro fino a Massafra; da Fitto a Vendola.
Non è che per anni Manduria abbia fatto qualcosa
per quel suo territorio di costa. Abusivismo, abbandono e degrado. Quello che fa
Maruggio con Campomarino, o Porto Cesareo per sé e con Torre Lapillo per
valorizzare la costa e creare sviluppo e lavoro, (giusto per citare i loro
vicini più prossimi), per i manduriani è una missione impossibile.
Cosa si può pensare di una amministrazione che ti
vieta addirittura il parcheggio per le auto dei bagnanti pendolari che
dall’entroterra si versano sulla costa. Giusto per respingerli come se fossero
migranti venuti dall’Africa. E poi per difendere cosa? Se non una costa
abbandonata e desolata.
Per i manduriani considerare il Salento come la
nuova El Dorado del turismo al pari del resto della Puglia o della Versilia o
del litorale marchigiano romagnolo è una utopia scolastica. Purtroppo i limiti
culturali ed imprenditoriali son quelli. Chissà se gli amministratori manduriani
hanno mai visitato quei luoghi, giusto per imparare qualcosa dai loro colleghi.
Oggi che si vedono stretti in un cul de sac dalle
proteste di tutte le popolazioni spalleggiate dalle loro amministrazioni
comunali dei paesi limitrofi per la questione depuratore consortile, il
Consiglio Comunale di Manduria ha approvato all’unanimità l’avvio dell’iter per
l’istituzione di un’area marina protetta a tutela degli ecosistemi marini e
costieri del tratto di mare che ricade nella giurisdizione della città
messapica. I diciotto chilometri della costa di Manduria si allungano in
direzione sud-ovest da Torre Borraco a Torre Columena dove arrivano le ultime
propaggini delle Murge Tarantine, passando per San Pietro in Bevagna. Quasi a
tempo di record, quindi, la proposta avanzata dal circolo di Manduria di
Legambiente è stata recepita dall’intero consesso elettivo. Legambiente ha
prodotto tutta la documentazione necessaria, oltre alle cartine dell’area
interessata. Il Consiglio Comunale, pertanto, non si è lasciato sfuggire
l’occasione di avviare l’iter per dotarsi di uno strumento per loro prezioso.
Ergo: sotto l’egida degli ambientalisti hanno
approvato l’adozione di un progetto di desertificazione. Le mire degli
ambientalisti manduriani è come quello degli ambientalisti tarantini: anziché
incrementare aziende sanificate tendono a desertificare il territorio dal
tessuto produttivo.
L’adozione della proposta assomiglia alla
barzelletta di quel marito tradito che per punire la moglie si taglia il…….
In un periodo di recessione, intervenendo sullo
sviluppo, impedendone la crescita è un paradosso.
Per chi vuol sapere cosa sia una Area Marina
Protetta, basta leggere Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'area naturale marina protetta, definita per
comodità, anche a livello internazionale, generalmente e più brevemente solo
come area marina protetta o AMP, è una zona di mare circoscritta, in genere di
particolare pregio ambientale e paesaggistico, all'interno della quale è in
vigore una normativa limitativa e protettiva dell'habitat, delle specie e dei
luoghi, e relativa alla regolamentazione e gestione delle attività consentite.
Rientrano nell'ambito delle aree naturali protette e spesso sono anche
definite riserve; in alcune di esse viene consentita anche la pesca commerciale
tradizionale, presumibilmente non distruttiva.
In Italia dopo un lunghissimo iter di studio e
fattibilità, contrastato soprattutto da pescatori, persone e politici con
interessi particolari soprattutto speculativi all'interno delle aree dove ne era
prevista l'istituzione, un estenuante e acceso dibattito politico nonché un
profondo ritardo nei confronti di tutti gli stati occidentali, è stata
finalmente attuata una legge quadro ed infine nel giro di diversi anni sono
state infine istituite nel tempo tutte le aree marine ora in esercizio.
Le motivazioni di base erano e sono la necessità
di preservare l'ambiente ed in particolare la flora, la fauna e la geologia
delle aree prese in esame, di rendere impossibile o limitare, se non per motivi
di effettiva necessità istituzionali, la costruzione di nuovi edifici e di non
effettuare attività turistiche, commerciali ed industriali che potessero in
qualche modo snaturare e danneggiare e fasce costiere di tali località, anche se
in effetti le tardive istituzioni hanno consentito negli anni passati di
costruire alberghi e insediamenti abitativi completamente inadeguati e fuori
dalle logiche ambientalistiche all'interno delle aree costiere di pregio. Le AMP
sono in pratica delle zone dove è praticamente molto difficile se non
impossibile costruire lungo i litorali nuovi edifici, nel caso possono e devono
essere restaurati e resi fruibili per le normali attività degli enti e
associazioni preposti alla tutela, valorizzazione e promozione di tali aree.
Una delle peculiarità delle regole dell’AMP è
quella di limitare le attività di pesca e prelievo con delle regolamentazioni
specifiche, ma anche quella di promuovere ed effettuare dei programmi di studio,
ricerca e ripopolamento abbinati a dei programmi didattici ed educativi che
permettano la maggiore conoscenza e sensibilità nei confronti della natura.
In Italia le aree sono suddivise in 3 zone
denominate zona "A", zona "B" e zona "C" Le zone "A" sono delle aree delimitate
dove non è possibile svolgere alcuna attività, quindi neanche il transito e la
balneazione, che non sia di carattere scientifico e di controllo, mentre le zone
"B" e "C" sono fruibili ma con relativi limiti alla pesca e agli attrezzi
utilizzabili ed alla velocità di transito, in genere sotto i 6 nodi vicino alle
coste. La pesca sportiva con canne e lenze è generalmente consentita con
autorizzazioni contingentate mentre la pesca subacquea sportiva è completamente
vietata, ed è consentita solo la pesca subacquea professionale limitatamente
alla raccolta del riccio di mare Paracentrotus lividus che hanno raggiunto la
taglia commerciale e solo in apnea, con ulteriore limitazione delle quantità
prelevabili.
In poche parole Area Marina Protetta significa
area marina e costiera non più fruibile da alcuno, residente o turista.
Bene, ma come si concilia da desertificazione e
quindi l’inibizione di qualsivoglia opera urbanistica igienico sanitaria con la
sanificazione di tutta un’area aggredita dall’edilizia abusiva con migliaia di
case che scaricano i liquami domestici nella falda acquifera?
C’è da chiedersi: a Manduria come si scelgono i
rappresentanti politici? Per la loro capacità o solo per la loro ambizione e
capacità di proporsi per apparire?
DEPURATORI. COME CI PRENDONO PER IL CULO.
Dal 23 luglio 2014 una piattaforma attrezzata per
le trivellazioni marine ha effettuato dei carotaggi (trivellazioni per prelevare
campioni da esaminare), nei fondali in zona Specchiarica, marina di Manduria,
scrive “La voce di Manduria”. La società che se ne occupa è la Ce.Sub. di San
Giorgio, incaricata dalla ditta Putignano, l’impresa aggiudicataria dei lavori
di realizzazione del depuratore con scarico a mare. I lavori già autorizzati
dalla Capitaneria di porto prevedono «l’esecuzione di un’indagine stratigrafica
dei fondali marini tramite attività di carotaggio continuo e l’esecuzione di
video riprese subacquee lungo l’asse di varo della condotta negli specchi acque
meglio di seguito individuati, propedeutici alla costruzione di una condotta
sottomarina asservita all’impianto di depurazione e collettori di scarico a
servizio degli abitanti di Sava e Manduria». Di tali lavori di carotaggio sono
stati già informati sia la Regione Puglia che il Comune di Manduria. A
quest’ultimo la comunicazione è pervenuta proprio mercoledì 23. Sicuramente
prima al presidente Nichi Vendola e al suo assessore ai Lavori Pubblici,
Giovanni Giannini che proprio lunedì (due giorni prima che al comune di Manduria
arrivasse il fax dell’Aqp), ha incontrato i sindaci di Manduria, Sava, Avetrana
e Maruggio ai quali – invitati a Bari proprio per discutere la questione
depuratore -, non è stata data comunicazione di un iter oramai più che avviato.
Alla vigilia dell’importante incontro sulle sorti del depuratore consortile tra
gli assessori regionali Giannini e Nardoni, rispettivamente ai lavori pubblici e
all’agricoltura, e i sindaci di Sava, Manduria e Avetrana, il primo cittadino di
Sava, Dario Iaia, che ha chiesto e ottenuto l’incontro, prende posizione e
lancia la proposta che «potrebbe mettere d’accordo tutti». «E’ necessario – dice
– che vi sia un ulteriore sforzo da parte degli organi regionali per finanziare
e rendere concreto un maggiore affinamento delle acque reflue ed il riuso in
agricoltura, con lo sversamento dei reflui nelle cave di Avetrana o nei terreni
messi a disposizione dal comune di Manduria, prevedendo la condotta sottomarina
solo per i casi di emergenza». Consapevole delle resistenze che opporranno alla
sua proposta «gli oltranzisti dell’ambiente i quali si opporranno sempre e
comunque a qualunque soluzione», il sindaco Iaia presenta per la prima volta una
proposta alternativa al vecchio progetto dell’acquedotto pugliese che, allo
stato dei fatti, prevede un depuratore sulla costa manduriana con lo sversamento
nel mare di Specchiarica attraverso una condotta sottomarina, dei reflui non
affinati. La proposta del sindaco di Sava è sostanzialmente identica a quella
che il sindaco di Manduria ha ribadito nel corso di una riunione avuta venerdì
mattina nel suo studio con i rappresentanti dei comitati ambientalisti di
Manduria e Avetrana. Il sindaco savese ha le idee chiare in proposito. «Ho
chiesto ai miei colleghi sindaci ed agli assessori Nardoni e Giannini di
insediare un tavolo politico – afferma Iaia – per confrontarci, ancora, su quale
possa essere la soluzione più condivisa per risolvere questa annosa questione.
Come abbiamo avuto modo di chiarire anche in altre occasioni – continua il primo
cittadino di Sava – questo non può più essere il tempo dell’attesa, ma deve
essere quello della decisione e della responsabilità che deve essere assunta da
chi ha ruoli politico amministrativi. Il mio comune con 17 mila abitanti –
sottolinea Iaia – non può più attendere la realizzazione di quest’opera perché
le condizioni igienico sanitarie sono al limite, a meno che – avverte – non si
voglia che si ritorni a parlare di colera anche da noi. Queste considerazioni,
avverte il sindaco Iaia, valgono anche per Manduria, per Avetrana e per le
marine, «ancora oggi – ricorda – prive completamente o in gran parte di sistema
fognario». Rivolgendosi agli ambientalisti soprattutto avetranesi, il sindaco di
Sava conclude così il suo intervento: «dovrebbero ammettere – dice – che oggi
tutti noi stiamo inquinando la falda acquifera e quindi il mare; anche se non lo
vediamo lo sappiamo ed è sufficiente guardare i dati dell’Arpa sul decadimento
della qualità delle acque nei mesi estivi, causato dagli scarichi in falda».
Alla luce di questo nuovo intervento di Sava le posizioni delle parti si possono
così delineare. Le istituzioni di Manduria e Sava, mantenendo ferma la necessità
di un nuovo depuratore, spingono per l’ambientalizzazione dell’opera: sì al
depuratore; sì all’affinamento dei reflui da utilizzare per uso irriguo; sì alla
condotta sottomarina a Specchiarica ma solo per il troppo pieno quando cioè le
falde o le cave non riusciranno a smaltire la quantità dei reflui prodotta in
eccesso. Le istituzioni di Avetrana e gli ambientalisti più convinti (questi
ultimi quasi tutti avetranesi), dicono no al depuratore sulla costa, no alla
condotta sottomarina e sì alle alternative delle cave o trincee drenanti.
Insieme alla comunicazione di inizio lavori di carotaggio, l’Acquedotto pugliese
ha fatto sapere come si muoverà sino al completamento dell’opera (depuratore
tabella 2 con condotta sottomarina di un chilometro) che dovrebbe entrare in
esercizio il 15 marzo del 2017 mentre i lavori, sempre secondo il cronoprogramma
della società che lo gestirà (l’Aqp stessa), termineranno il 15 luglio del 2016.
L’apertura vera e propria del cantiere invece, è stata fissata per il prossimo
15 settembre 2014.
Questo non basta. In piena estate e in periodo di
fulcro turistico si impedisce la balneazione. Secondo quanto previsto
dall’ordinanza della Capitaneria di Porto che autorizza l’impresa «Ce. Sub»,
incaricata di effettuare i sondaggi e le videoriprese dei fondali dove sarà
ancorata la condotta del depuratore, tutta la zona interessata deve essere
interdetta alla balneazione, navigazione e pesca. Questo sino alla fine delle
operazioni prevista per il 10 agosto. Sino a quella data, quindi, una vasta zona
di mare (una lingua larga 400 metri e lunga un chilometro in direzione di
Specchiarica) è off-limits. «Negli specchi d’acqua sopra indicati – si legge
infatti nell’ordinanza della capitaneria – durante le attività specificate sono
vietate la navigazione di qualsiasi unità navale, la pesca e qualsiasi altra
attività legata all’uso del mare».
Non hanno perso tempo e sono passati ai fatti gli
avetranesi che per protesta hanno bloccato la litoranea. Sin dalle prime ore del
pomeriggio gli attivisti dei comitati avetranesi e semplici residenti della zona
di Specchiarica si sono raccolti sul tratto di spiaggia dove, al largo, erano in
corso i lavori di trivellazione e carotaggio. Ne è nata una manifestazione
spontanea cresciuta a dismisura. Il gruppetto di protestanti si è trasformato in
folla rumorosa e arrabbiata composta anche da ambientalisti manduriani. I
manifestanti tra cui alcuni amministratori di Avetrana, hanno detto che non si
muoveranno da lì sino a quando non si fermeranno i lavori. Disagi intanto sono
stati creati alla circolazione per l’interruzione della litoranea all’altezza
del Bar D’Alì nella Marina di Specchiarica. Tra le proposte di lotta avanzate,
oltre al sit in permanente, la raccolta firme e l’occupazione pacifica con
imbarcazioni civili del tratto di mare interessato ai saggi della ditta di San
Giorgio. Durante i comizi improvvisati non sono mancate accuse di lassismo al
popolo e alle istituzioni di Manduria. Assenti gli amministratori messapici.
Già tutte anime candide. E vi si elencano.
Gli Amministratori di Manduria e Sava vogliono
sversare la loro “merda” nel territorio di avetrana: «E’ necessario – dice – che
vi sia un ulteriore sforzo da parte degli organi regionali per finanziare e
rendere concreto un maggiore affinamento delle acque reflue ed il riuso in
agricoltura, con lo sversamento dei reflui nelle cave di Avetrana o nei terreni
messi a disposizione dal comune di Manduria, prevedendo la condotta sottomarina
solo per i casi di emergenza» Dice il Sindaco di Sava Daio Iaia. La proposta del
sindaco di Sava è sostanzialmente identica a quella che il sindaco di Manduria
Roberto Massafra ha ribadito nel corso di una riunione avuta nel suo studio con
i rappresentanti dei comitati ambientalisti di Manduria e Avetrana.
I manduriani, si sa, sono inconcludenti dal punto
di vista amministrativo; litigiosi e polemici dal punto di vista politico; sono
molto volpini, così come i savesi, se devono fottere i vicini stupidi, come sono
quelli di Avetrana. Il progetto sul depuratore e sullo scarico a mare fu avviato
da Antonio Calò e proseguito da Francesco Saverio Massaro, Paolo, Tommasino
Roberto Massafra.
I governatori e le giunte regionali hanno
autorizzato i depuratori e gli scarichi a mare, (quindi non solo quello
consortile di Manduria-Sava posto a confine al territorio di Avetrana e sulla
costa). I vari governatori sono stati Raffaele Fitto del centro destra e Nicola
Vendola del centro sinistra. Entrambi gli schieramenti hanno preso per il culo
le cittadinanze locali, preferendo fare gli interessi dell’Acquedotto pugliese,
loro ente foriero di interessi anche elettorali.
Le popolazioni in rivolta, in particolare quelle
di Avetrana, sono sobillate e fomentate da quei militanti politici che ad
Avetrana hanno raccolto, prima e dopo l’adozione del progetto, i voti per
Antonio Calò alle elezioni provinciali e per tutti i manduriani che volevano i
voti di Avetrana. Il sindaco Luigi Conte, prima, e il sindaco Mario De Marco,
dopo, nulla hanno fatto per fermare un obbrobrio al suo nascere. Conte ha
pensato bene, invece, con i soldi pubblici, di avviare una causa contro Fitto
per la riforma sanitaria. In più, quelli del centro destra e del centro
sinistra, continuavano e continuano ed essere portatori di voti per Raffaele
Fitto e per Nicola Vendola, o chi per loro futuri sostituti, e per gli
schieramenti che li sostengono.
Certo, però, è che la ritorsione non si è fatta
attendere.
Gestiva un chiosco-bar in muratura con tanto di
tettoria ricoperta in legno per la sistemazione di tavolini e sedie per gli
avventori direttamente realizzato sulla spiaggia libera, in un tratto di
pubblico demanio marittimo del litorale del comune di Manduria, per la
precisione in località Specchiarica, per una superficie totale abusivamente
occupata di circa 200 mq., all’interno della quale i militari accertatori
appartenenti al Nucleo Difesa mare della Guardia Costiera di Taranto hanno
rinvenuto anche un ripostiglio in legno, una vasca di stoccaggio e persino una
fossa imhoff, il tutto in difetto di alcun titolo concessorio che legittimasse
l’occupazione di pubblico demanio oltre che di alcuna concessione edilizia
rilasciata dal Comune competente, scrive “La Voce di Manduria” in questo
lunghissimo periodo senza soluzione di continuità sintattica. All’atto del
controllo, condotto in prima mattinata del 24 luglio 2014 , il chiosco, ubicato
in un tratto di litoranea altamente frequentato da turisti e bagnanti, iniziava
ad affollarsi per il sopraggiungere di clienti, che sorpresi del fatto che
l’intera struttura fosse completamente abusiva, hanno assistito agli
accertamenti condotti dal personale militare procedente. Di tutta l’operazione è
stata prontamente informata la Procura della Repubblica di Taranto che ha
disposto l’immediato sequestro penale di tutte le opere abusive realizzate. Il
titolare del chiosco-bar è stato quindi denunciato dai militari procedenti per
la abusiva occupazione ai sensi dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione.
“Ecco un esempio come in Italia funzionano i
controlli. Quel kiosco si trova là da minimo 40 anni, prima era invisibile o
altro!!!”, commenta Maria.
“Ma dai un ristoro come ce ne sono a centinaia.
Proprio un comune pochissimo virtuoso come quello di Manduria che fa le pulci ad
un poveraccio che tira a campare. Ma mi faccia il piacere se volete controllare
andate a vedere quello che non viene fatto per gli abitanti di tutta la Marina
di Manduria.Mancanza di acqua potabile e fognatura per cominciare. Ma proprio
per cominciare……”, scrive invece Rossiandrea900.
L’acquedotto Pugliese, invece, fa gli affari suoi.
Non riusa i reflui della depurazione per l’agricoltura perché troppo oneroso.
Come se l’acqua resa non se la facesse pagare.
La stampa, poi, più che altro è manduriana o
tarantina. Sai quanto se ne fottono di quei quattro indigeni avetranesi?
Basta guardare cosa succede a chi sputa nel piatto
in cui si mangia.
E’ stato licenziato Luigi Abbate, il giornalista
di Taranto divenuto famoso per le sue domande scomode e il microfono che gli fu
strappato dalle mani durante una conferenza stampa da Girolamo Archinà, il
responsabile delle relazioni istituzionali dell’Ilva, arrestato nell’ambito
dell’inchiesta della magistratura tarantina "Ambiente Svenduto". Lo scrive in
una nota il presidente di Assostampa Puglia, Raffaele Lorusso. Già un anno fa,
nell'assordante silenzio delle istituzioni e delle forze politiche di Taranto,
Blustar Tv - scrive Lorusso - licenziò quattro giornalisti adducendo quale
motivazione il venir meno dei centomila euro annualmente garantiti dall'Ilva.
DEPURATORI DELLE ACQUE E POLEMICHE STRUMENTALI.
UN PROBLEMA NAZIONALE, NON LOCALE.
Come si butta via l’acqua. Lo spreco di una
risorsa naturale essenziale per la vita e lo sviluppo economico.
Diritto alla salute o idolatria naturista?
Politica malsana o interessi economici? Disatteso fabbisogno di acqua o
inquinamento delle acque superficiali? Tutto questo parlame coinvolge tutti i
cittadini, mentre la magistratura sta a guardare…..
«Per secoli si sono sversate in falda sotterranea
o nei canali di scolo le acque reflue di origine urbana, quando esse non erano
riutilizzate. La natura auto depurava l’insano liquido. Poi con
l’industrializzazione sono nati i problemi di inquinamento delle risorse
idriche. E sono nati i depuratori ed il business del trattamento delle acque
reflue. Oggi è una vergogna solo starne a parlare. Scegliere tra il riuso e lo
spreco o l’inquinamento? Solo i mentecatti possono decidere di buttare a mare o
in falda una risorsa naturale limitata! Solo i criminali scelgono di inquinare
l’ambiente e impedire lo sviluppo economico!»
Questo denuncia il dr Antonio Giangrande,
presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie” ed autore del libro
“Ambientopoli” pubblicato su Amazon.
Si definisce trattamento delle acque reflue (o
depurazione delle acque reflue) il processo di rimozione dei contaminanti da
un'acqua reflua di origine urbana o industriale, ovvero di un effluente che è
stato contaminato da inquinanti organici e/o inorganici. Le acque reflue non
possono essere reimmesse nell'ambiente tal quali poiché i recapiti finali come
il terreno, il mare, i fiumi ed i laghi non sono in grado di ricevere una
quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità autodepurativa.
Il trattamento di depurazione dei liquami urbani consiste in una successione di
più fasi (o processi) durante i quali, dall'acqua reflua vengono rimosse le
sostanze indesiderate, che vengono concentrate sotto forma di fanghi, dando
luogo ad un effluente finale di qualità tale da risultare compatibile con la
capacità autodepurativa del corpo ricettore (terreno, lago, fiume o mare
mediante condotta sottomarina o in battigia) prescelto per lo sversamento, senza
che questo ne possa subire danni (ad esempio dal punto di vista dell'ecosistema
ad esso afferente). . Il ciclo depurativo è costituito da una combinazione di
più processi di natura chimica, fisica e biologica. I fanghi provenienti dal
ciclo di depurazione sono spesso contaminati con sostanze tossiche e pertanto
devono subire anch'essi una serie di trattamenti necessari a renderli idonei
allo smaltimento ad esempio in discariche speciali o al riutilizzo in
agricoltura tal quale o previo compostaggio.
Il problema che ci si pone è: la depurazione è
effettivamente eseguita? Le acque reflue depurate dove possono essere reimmesse?
In grandi vasche o bacini per il riuso in agricoltura od industria, o smaltite
inutilizzate in mare o nei fiumi o direttamente in falda? Quale è la valenza
economica per tale decisione? Quale conseguenza ci può essere se la depurazione
è dichiarata tale, ma non è invece effettuata?
L'acqua di riuso, costa di più dell'acqua
primaria, sotterranea o superficiale, per questo è conveniente smaltire ed
inquinare il mare o la falda con le acque che i gestori dicono essere depurate.
Affermazioni infondate? No! Peggiora lo stato di salute del nostro mare.
Imputato numero uno è la «mala depurazione»: 130 i campioni risultati inquinati
dalla presenza di scarichi fognari non depurati - uno ogni 57 km di costa - sul
totale delle 263 analisi microbiologiche effettuate dal laboratorio mobile di
Goletta Verde, storica campagna di Legambiente, in quest'estate. Un dato in
aumento rispetto all’anno precedente,quando era risultato inquinato 1 punto ogni
62km.
Su queste basi ultimamente è salita alla ribalta
la presa di posizione con relative proteste di alcune località costiere. La
popolazione non vuole lo scarico a mare. Ma come sempre nessuno li ascolta.
Ogni estate la bellezza incontaminata del nostro
mare è messa a rischio dalla pessima gestione di depuratori e scarichi a mare da
parte di istituzioni e amministrazioni pubbliche. Ed il turismo ne paga le
conseguenze. E’ da qualche anno ormai che l’inizio della bella stagione ci pone
l’inquietante dubbio di quale sarà il tratto di costa a chiazze marroni che
dovremo evitare e, quel che è peggio, leggiamo distrattamente delle proteste del
comitato di turno, quasi la cosa non riguardasse tutti noi. La situazione è
molto delicata e non mette a rischio solo ambiente e salute, ma anche la
possibilità di fare del nostro mare il principale volano di sviluppo del
territorio. Le maggiori criticità riguardano i comuni di Manduria, Lizzano,
Pulsano e il capoluogo Taranto ed è perciò facile capire come la situazione vada
letta nel suo insieme, poiché finisce per riguardare tutta la litoranea
orientale.
Oggi in Puglia il servizio di depurazione copre il
77% del fabbisogno totale, secondo i dati forniti dal Servizio di tutela delle
acque della Regione e contenuti nel Piano di tutela delle acque. Numeri che
evidenziano come poco meno di un milione di cittadini pugliesi scarica i propri
reflui senza che questi vengano depurati. Sono 187 i depuratori che coprono il
servizio su tutto il territorio regionale, ma su cui insistono ancora problemi
di funzionamento, criticità e situazioni irrisolte che in alcuni casi rendono
inefficace la depurazione dei reflui. Innanzitutto c’è la questione dei 13
impianti che scaricano in falda, con grave rischio di inquinamento delle acque
sotterranee. Poi ci sono i depuratori che presentano problemi nel funzionamento
e i cui scarichi risultano non conformi, come certificano i dati Arpa relativi
al 2012. La causa di queste anomalie deriva dal cattivo funzionamento degli
impianti, causato in alcuni casi anche all’ingresso nei depuratori di reflui
particolari (scarti dell’industria casearia o olearia, industriali o un apporto
eccessivo di acque di pioggia spesso legate alla incapacità dei tessuti urbani
di drenare l’acqua). Un problema che riguarda il 39% degli impianti a livello
regionale secondo i dati a disposizione dell’Acquedotto pugliese, ma che in
alcune province arriva ad oltre l’80%, come nel caso dei depuratori della BAT.
La Puglia, inoltre, come si evince dal dossier Mare Monstrum di Legambiente, è
la quarta regione a livello nazionale per numero di illeciti legati
all’inquinamento del mare riscontrati, con 261 infrazioni, pari al 10,1% sul
totale, 328 fra le persone denunciate e arrestate e 156 sequestri.
Le norme violate sono quelle previste dal Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e comunque il
reato contestato è il getto pericoloso di cose. Ma non tutte le procure della
Repubblica si muovono all’unisono.
Avetrana, Pulsano, Lizzano, Nardò, ecc. Il
problema, però, come si evince, non è solo pugliese. Il riuso delle acque
nessuno lo vuole. Eppure il fabbisogno di acqua cresce. Recentemente, con la
crescita della sensibilità ambientale in tutto il pianeta, il tema
del riutilizzo delle acque si sta diffondendo sempre più: anche l’Unione Europea
si è spesso occupata di riutilizzo delle acque reflue, ma solo recentemente
questo tema è entrato nel Piano di Azione volto ad individuare criteri e
priorità per il finanziamento di nuovi progetti nel campo della gestione
delle risorse idriche. Il riutilizzo in agricoltura delle acque usate è una
pratica diffusa in molti paesi e sempre più spesso raccomandata dagli organismi
internazionali che promuovono lo sviluppo sostenibile; tra i paesi che hanno la
maggior esperienza nel settore è bene ricordare gli Stati Uniti e lo Stato
di Israele.
La vicepresidente e assessore all'Assetto del
Territorio della Regione Puglia, Angela Barbanente, ha diffuso questa nota sulla
questione della depurazione in Puglia. «La mia opinione è che “la politica si
manterrà chiacchierona, rincorrendo ora l’uno ora l’altro contestatore” sino a
quando, in questo come in altri campi, mancherà di una visione chiara,
condivisa, realizzabile. La visione che occorre perseguire, questa sì senza
tentennamenti se si hanno a cuore la salvaguardia e il risanamento
dell’ambiente, e quindi la salute dei cittadini, dovrebbe innanzitutto prevedere
il massimo possibile riutilizzo delle acque depurate in agricoltura o per usi
civili. Non è ammissibile, infatti, che nella Puglia sitibonda si butti in mare
l’acqua depurata mentre nei paesi nordeuropei ricchi di acque superficiali si
adottano ordinariamente reti duali per evitare di sprecare la risorsa! Inoltre,
ove possibile e specialmente nelle aree turistiche, si dovrebbe fare ricorso a
tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione.»
Non ha tutti i torti e sentiamo di sposare le sue
parole. Nell'ultimo decennio sono state registrate annate particolarmente
siccitose con una ridotta disponibilità di risorse idriche tradizionali. Le
cause sono dovute in parte ai mutamenti meteo climatici ma anche al crescente
peso demografico e turistico, ai maggiori fabbisogni connessi allo sviluppo
economico industriale, agricolo (anche se in questi ultimi anni pare affermarsi
un'inversione di tendenza complice la crisi economica) e civile. Ciò implica la
necessità di avviare cambiamenti radicali nei comportamenti e nelle abitudini di
cittadini e aziende finalizzati al risparmio idrico, di reperire nuove fonti di
approvvigionamento e al contempo di incentivare in tutte le forme possibili il
riuso delle acque depurate. Il riutilizzo delle acque reflue costituisce una
fonte di approvvigionamento idrico alternativo ai prelievi da falda, e
rappresenta una buona pratica di gestione sostenibile delle acque che consente
di fronteggiare lo stato di crisi quali-quantitativa in cui versa la risorsa
idrica. Infatti attraverso il riutilizzo si limita il prelievo delle acque
sotterranee e superficiali e si riduce la riduzione dell'impatto degli scarichi
sui corpi idrici recettori.
Questa lotta di civiltà ci deve coinvolgere tutti,
senza tentennamenti ed ipocrisie, fino all’estremo gesto di non votare più i
nostri partiti di riferimento con gli amministratori regionali che decidono
contro gli interessi della collettività.
E passiamo oltre al fatto che i sindaci ci
obbligano a contrarre in termini perentori il servizio di smaltimento delle
acque con i gestori locali, che sono anche i gestori dei depuratori. I sindaci
si mettono a posto per eventuali screzi legali. I cittadini pagano un oneroso
tributo in termini di spese di allaccio e di smaltimento per un servizio che non
si sa se e quando si attiverà. Un altro balzello che si dovrebbe invece chiamare
“Pizzo”.
CONTRO IL DEPURATORE CONSORTILE SAVA-MANDURIA
AD AVETRANA E SCARICO A MARE. LOTTA UNITARIA O FUMO NEGLI OCCHI?
Sentiamo la voce del dissenso dell’Associazione
Contro Tutte le Mafie e dell’Associazione Pro Specchiarica entrambe di Avetrana.
La prima a carattere nazionale e la seconda prettamente di interesse
territoriale. Il perché di un rifiuto a partecipare alla lotta con gli altri,
spiegato dal Dr Antonio Giangrande, componente del direttivo di entrambe le
associazioni avetranesi. «L’aspetto da affrontare, più che legale (danno
emergente e lucro cessante per il territorio turistico di Avetrana) è
prettamente politico. La gente di Avetrana non si è mobilitata in massa e non vi
è mobilitazione generale, come qualcuno vuole far credere, perché è stufa di
farsi prendere in giro e conosce bene storia e personaggi della vicenda. Hanno
messo su una farsa poco credibile, facendo credere che vi sia unità di intenti.»
Esordisce così, senza giri di parole il dr Antonio Giangrande. «Partiamo dalla
storia del progetto. La spiega bene il consigliere comunale Arcangelo Durante di
Manduria: “Che la realizzazione a Manduria di un nuovo depuratore delle acque
reflue fosse assolutamente necessario, era già scontato; che la scelta del nuovo
depuratore non sia stata fatta dall’ex sindaco Francesco Massaro, ma da Antonio
Calò, sindaco prima di lui, ha poca importanza. Quello che invece sembra molto
grave, è che il sindaco Massaro, in modo unilaterale, nel verbale del 12
dicembre 2005 in allegato alla determina della Regione Puglia di concessione
della Via (Valutazione d’Impatto Ambientale), senza informare e coinvolgere il
consiglio comunale sul problema, ha indicato il mare di Specchiarica quale
recapito finale del depuratore consortile”. Bene. Da quanto risulta entrambi gli
schieramenti sono coinvolti nell’infausta decisione. Inoltre questa decisione è
mirata a salvaguardare il territorio savese-manduriano ed a danneggiare
Avetrana, in quanto la localizzazione del depuratore è posta sul litorale di
Specchiarica, territorio di Manduria (a poche centinaia di metri dalla zona
residenziale Urmo Belsito, agro di Avetrana)». Continua Giangrande, noto autore
di saggi con il suffisso opoli (per denotare una disfunzione) letti in tutto il
mondo. «L’unitarietà della lotta poi è tutta da verificare. Vi sono due
schieramenti: quello di Manduria e quello di Avetrana. Quello di Manduria è
composto da un coordinamento istituito solo a fine maggio 2014 su iniziativa dei
Verdi e del movimento “Giovani per Manduria” con il comitato “No Scarico a mare”
di Manduria. Questo neo coordinamento, precedentemente in antitesi, tollera il
sito dell’impianto, purchè con sistema di filtrazione in tabella IV, ma non lo
scarico in mare; quello di Avetrana si oppone sia alla condotta sottomarina che
alla localizzazione del depuratore sul litorale di Specchiarica. Il comitato di
Avetrana (trattasi di anonimo comitato ed è tutto dire, ma con un solo e
conosciuto uomo al comando, Pino Scarciglia) ha trovato una parvenza d’intesa
fra tutti i partiti, i sindacati e le associazioni interpellate, per la prima
volta sabato 17 maggio 2014, e si schierano compatti (dicono loro), superando
ogni tipo di divisione ideologica e ogni steccato, che sinora avevano reso poco
incisiva la mobilitazione. In mattinata del 17 maggio, il Consiglio Comunale di
Avetrana si è riunito per approvare, all’unanimità, la piattaforma di
rivendicazioni già individuata nella riunione fra il comitato ristretto e i
rappresentanti delle parti sociali. In serata, invece, maggioranza e minoranza
sono saliti insieme sul palco di piazza Giovanni XXIII per rivolgere un appello
alla comunità composta per lo più da forestieri. Si legge nel verbale
dell’ultima riunione del Movimento. “E’ abbastanza chiaro, inoltre, che le
Amministrazioni Comunali di Manduria, che si sono succedute nel tempo da 15 anni
a questa parte, non hanno avuto nè la volontà nè la capacità di modificare o di
bloccare questo obbrobrio, trincerandosi dietro a problematiche e a questioni
tecniche/burocratiche, a parer loro, insormontabili”. Il gruppo di lavoro
unitario avetranese è composto da consiglieri di maggioranza e minoranza (Cosimo
Derinaldis, Antonio Baldari, Pietro Giangrande, Antonio Lanzo, Emanuele Micelli
e Rosaria Petracca). “Vorrei innanzitutto far notare come, finalmente, si stia
superando ogni tipo di steccato politico o ideologico – afferma l’assessore
all’Agricoltura e al Marketing Territoriale, Enzo Tarantino. Steccato veramente
superato? A questo punto reputo poco credibile una lotta portata avanti da chi,
di qualunque schieramento, continui a fare propaganda politica contrapposta per
portare voti a chi è ed è stato responsabile di questo obbrobrio ai danni dei
cittadini e ai danni di un territorio incontaminato. Quindi faccio mia la
domanda proposta da Arcangelo durante “Bisogna dire però, che il presidente
Vendola è in misura maggiore responsabile della questione, poichè di recente ha
firmato il decreto di esproprio, nonostante che, prima il consiglio comunale
dell’ex amministrazione Massaro e dopo quello dell’amministrazione Tommasino, si
siano pronunciate all’unanimità contrarie allo scarico a mare. Presidente
Vendola, ci può spiegare come mai, quando si tratta di opere che riguardano
altri territori, vedi la Tav di Val di Susa, reclama con forza l’ascolto e il
rispetto dei cittadini presenti sul territorio; mentre invece, quando si tratta
di realizzare opere che interessano il nostro territorio, (dove lei ha il
potere) non rivendica e utilizza lo stesso criterio, come l’ultimo provvedimento
da lei adottato in qualità di Commissario Straordinario sul Depuratore?”»
AMIANTO. IL KILLER CONOSCIUTO.
Amianto. In greco amiantos. Significa immacolato,
ma anche incorruttibile. Il termine asbesto equivale ad amianto ed in greco
significa perpetuo, inestinguibile. L'amianto è un minerale naturale a struttura
microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei
silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Si ottiene
a seguito di un'attività estrattiva, e il suo nome deriva dalla parola Asbesto
che tradotto significa "Che non si spegne mai". La sua composizione chimica è
variabile ed è costituita appunto da fasci di fibre molto fini, tanto che in un
centimetro lineare si possono allineare fianco a fianco 335.000 fibrille di
amianto paragonato alla quantità di 250 capelli per il solito spazio di un
centimetro, fa capire quanto siano sottili. Per la normativa italiana sotto il
nome di amianto sono compresi 6 composti distinti in due grandi gruppi: anfiboli
e serpentino, l'amianto serpentino è composto principalmente da amianto
cosiddetto bianco chiamato anche crisotilo, dall'aspetto sfrangiato. L'altro
chiamato anfibolo è composto da crocidolite (amianto blu), amosite, e tremolite,
l'amosite e pochi altri. Fra le sue caratteristiche più interessanti, l'amianto
ha una buona resistenza termica elevata, all'azione di agenti chimici e
biologici, alla trazione, all'usura. É stato così largamente usato per le sue
eccezionali proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento termico ed
elettrico, per la facilità di lavorazione (struttura fibrosa), di resistenza
agli acidi ed alla trazione, è facilmente mescolabile ad altre sostanze
(cemento), dotato di capacità fonoassorbenti e per ultimo ma non trascurabile
l'aspetto che aveva un basso costo. Queste ed altre proprietà, legate ad un
basso costo di produzione, hanno fatto dell'amianto un materiale estremamente
versatile, utilizzato per la fabbricazione di oltre 3000 prodotti. Considerate
queste caratteristiche, ha trovato largo utilizzo nei campi dell'Edilizia,
dell'Industria e dei Trasporti, sotto forma di innumerevoli manufatti . Era
presente nelle frizioni e nei freni degli autoveicoli e dei treni (adesso non
più), come materiale isolante, materiali fonoassorbenti, coperture di edifici
industriali (Eternit), tubazioni, serbatoi, cassoni e guarnizioni. Inoltre
l'amianto è stato utilizzato in maniera insolita per produrre imballaggi, carta
e cartoni, pavimentazioni (linoleum) tessuti ignifughi per l'arredamento di
teatri e cinema e addirittura nell'abbigliamento. Nel nostro paese il crisolito
ha rappresentato il 75% dell'uso totale di amianto ed il 75% di tutto l'amianto
usato è stato impiegato nel settore edilizio e delle costruzioni. In Italia
l'attività estrattiva era svolta presso la miniera di Balangero (Piemonte)
adesso chiusa per procedere alla bonifica dell'area. Nel nostro paese il boom è
avvenuto negli anni che vanno dal 1960 al 1990 in corrispondenza appunto del
boom economico, e già nel 1983 in accordo con una direttiva CEE, è vietata anche
in Italia l'applicazione dell'amianto spruzzato in edilizia, ma solo nel 1992
viene vietata la produzione e il commercio di manufatti contenente amianto con
la cessazione di tutte le attività di estrazione, importazione, ed utilizzo. Le
malattie da amianto possono manifestarsi dopo molti anni, a volte persino dopo
40 anni dalla prima esposizione. La pericolosità dell'amianto consiste, infatti,
nella capacità che il materiale ha di rilasciare fibre potenzialmente inalabili
dall'uomo, fibre che hanno la caratteristica di dividersi in senso longitudinale
anzichè trasversale come le altre tipologie di fibre. I materiali più pericolosi
sono ovviamente quelli contenenti amianto friabile, il cemento-amianto (o
Eternit) ha una pericolosità molto inferiore dato che le fibre al suo interno
sono presenti in misura dal 10% al 15%, rispetto ai materiali friabili che
possono arrivare anche al 100% di presenza di fibre. La sua pericolosità è
comunque legata allo stato di conservazione. Non sempre l'amianto, però, è
pericoloso; lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente
circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica,
da stress termico, dilatamento di acqua piovana. Per questa ragione il
cosiddetto amianto friabile che cioè si può ridurre in polvere con la semplice
azione manuale è considerato più pericoloso dell'amianto compatto che per sua
natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.
Malati per colpa dell’amianto. Il picco deve
ancora arrivare. Un nemico che colpisce dopo molto tempo, anche dopo quaranta
anni dall’esposizione. L’amianto è stato dichiarato cancerogeno già negli anni
Sessanta, scrive Maria Giovanna Faiella “Il Corriere
della Sera”. È un nemico subdolo, che colpisce a distanza di anni e continua a
fare vittime anche oggi. Anzi: secondo studi scientifici ed epidemiologici il
picco di malattie provocate dall’esposizione all’amianto si raggiungerà nei
prossimi 15 anni. Da qui il monito a non abbassare la guardia venuto dagli
esperti nel corso di una conferenza internazionale, svoltasi di recente a Roma
su iniziativa dell’Osservatorio nazionale amianto, l’associazione onlus che
raggruppa lavoratori ex esposti, familiari delle vittime, medici, ricercatori,
avvocati, ingegneri. «Secondo le nostre stime - afferma l’avvocato Ezio Bonanni,
presidente dell’Osservatorio - i mesoteliomi con esito infausto sono circa 1.500
l’anno, i tumori polmonari almeno tremila e, se si aggiungono le altre patologie
asbesto-correlate, siamo ben oltre i 5mila morti per amianto ogni anno». Sebbene
l’uso di questo minerale, dichiarato cancerogeno dalla comunità scientifica
internazionale già negli anni Sessanta, sia stato vietato nel nostro Paese ormai
ventidue anni fa da una legge dello Stato (n. 257 del 1992), la sua pericolosa
eredità rimane tuttora, soprattutto a causa del lungo periodo di latenza delle
malattie asbesto-correlate, in particolare del mesotelioma (leggi la scheda
della malattia), uno dei tumori più aggressivi: passano perfino 40-45 anni tra
l’inizio dell’esposizione all’amianto e il momento in cui si manifesta la
malattia. Quelle fibre inalate tanti anni fa ora fanno ammalare soprattutto i
lavoratori esposti; risale agli anni Ottanta, prima della sua messa al bando, il
periodo di massima produzione di questo materiale molto utilizzato perché
economico, versatile e resistente anche al fuoco; veniva impiegato non solo
nelle fabbriche di cemento-amianto, nei cantieri navali e in diversi siti
industriali, ma anche per costruire case, scuole, ospedali. «In diversi casi, in
barba alla legge, si è continuato a usare l’amianto fino al 2004 attraverso
deroghe tecniche - denuncia Paolo Pitotto, medico del lavoro e consulente della
Procura della Repubblica di Milano -. E l’esposizione continua oggi, anche
perché uno dei principali problemi da risolvere è la dismissione dei materiali
con amianto». Il loro deterioramento, anche semplicemente dovuto alla vetustà,
può essere causa di rilascio di fibre e può quindi nuocere alla salute. «La
mancata rimozione dell’amianto espone al pericolo le persone sia in ambito
lavorativo sia negli ambienti di vita - sottolinea Pitotto - e continueranno ad
aumentare le malattie asbesto-correlate». Le fibre di amianto inalate possono
causare placche pleuriche e ispessimenti della pleura o malattie più gravi,
anche se meno diffuse, come: asbestosi; mesotelioma pleurico, pericardico,
peritoneale, della tunica vaginale o del testicolo; carcinoma polmonare. In
quest’ultimo caso, spiega Luciano Mutti, direttore del laboratorio di oncologia
clinica all’Asl 11 di Vercelli: «Il rischio è maggiore se le fibre di amianto
interagiscono con un altro agente cancerogeno, il fumo di sigaretta. Secondo
studi, inoltre, l’amianto fa aumentare il rischio di tumori gastrici, delle
ovaie, di laringe e faringe». Secondo i dati aggiornati al 2008 del Registro
nazionale dei mesoteliomi, che attua una sorveglianza epidemiologica su tutta la
popolazione, i più a rischio rimangono i lavoratori, ma circa l’8-10% dei
pazienti si è ammalato per motivi ambientali, vivendo vicino a siti contenenti
amianto, o in quanto familiari dei lavoratori esposti, per esempio a causa di
residui su indumenti.
Tra i luoghi da bonificare anche 2.500 edifici
scolastici. La prevenzione primaria può ridurre il numero di nuovi malati e
salvare molte vite. «Il rimedio più efficace contro gli effetti nocivi
dell’amianto è evitare ogni forma di esposizione» afferma Giancarlo Ugazio,
esperto in patologie da esposizione occupazionale ed extra lavorativa ad asbesto
e presidente del Gruppo di ricerca per la prevenzione della patologia
ambientale. Già, l’esposizione. La mappatura della presenza di amianto sul
territorio nazionale, ancora in corso da parte di Inail, Ministero dell’Ambiente
e Regioni, ha registrato al 2013 circa 34 mila siti contaminati. Secondo il
Cnr-Consiglio nazionale delle ricerche, con gli attuali ritmi di bonifica
serviranno ancora 85 anni per completare la dismissione degli oltre 32 milioni
di tonnellate di amianto presenti in Italia. «Siamo ancora in fase di mappatura,
nel frattempo altri cittadini potrebbero ammalarsi - chiosa l’avvocato Ezio
Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto - . Occorre procedere
subito con la messa in sicurezza dei siti e degli edifici, a partire da quelli
scolastici: stimiamo che circa 2.500 scuole siano a rischio di amianto. Oltre
alla loro ristrutturazione, come ha annunciato di recente il Governo, va
disposta la bonifica, perché eseguire i lavori senza tener conto della possibile
presenza del minerale significa correre il rischio che si sbricioli, liberando
fibre nell’aria poi inalate da studenti e personale scolastico». Un’altra
emergenza riguarda la sorveglianza sanitaria di lavoratori e cittadini già
esposti a fibre di amianto e che rischiano di ammalarsi. «Visto il lungo periodo
di latenza tra esposizione e insorgenza delle malattie asbesto-correlate diventa
ancora più importante il monitoraggio preventivo degli ex esposti - sottolinea
Paolo Pitotto, medico del lavoro e consulente della Procura della Repubblica di
Milano - . Le Regioni avrebbero dovuto istituire con proprie norme i registri
degli ex esposti all’amianto, ma funzionano davvero solo in Lombardia, Veneto,
Friuli, Toscana: qui vengono eseguiti controlli periodici gratuiti. In Friuli è
garantito anche il supporto psicologico». L’anno scorso il Governo Monti ha
approvato il Piano nazionale amianto che, però, non è mai entrato in vigore
perché non ha ottenuto il via libera della Conferenza Stato-Regioni, soprattutto
per la carenza di copertura finanziaria. «Quel Piano è inadeguato e va rivisto -
commenta il presidente dell’Osservatorio nazionale amianto -. Innanzitutto,
minimizza i numeri dell’epidemia in corso, poiché fa riferimento a una stima di
circa mille decessi l’anno per il mesotelioma pleurico ma sorvola su tutti gli
altri mesoteliomi, sul tumore al polmone e sulla stessa asbestosi. L’elenco
delle patologie che l’Inail indennizza come asbesto-correlate, presumendone
l’origine professionale, va aggiornato con tutte le altre patologie». «Poi, -
continua Bonanni - occorre puntare sulla prevenzione primaria con la bonifica di
tutti i siti contaminati. Per esempio, il rinnovo degli impianti potrebbe
avvenire predisponendo un piano industriale che utilizzi i fondi strutturali
europei e la leva fiscale per consentire la detrazione delle spese». Ma, una
volta individuato, come viene smaltito l’amianto e dove va a finire? «La maggior
parte va in Germania dove viene reso inerte e riutilizzato, mentre quel che
resta in Italia va nelle discariche autorizzate o in posti non proprio
limpidissimi, come la Terra dei fuochi - afferma il presidente dell’Osservatorio
amianto -. C’è poi il problema dell’amianto friabile: le cave abbandonate, per
esempio, non sono adatte a contenerlo. Piuttosto che continuare a portarlo
all’estero con enormi costi di trasporto e bonifica, perché non costruire anche
da noi impianti di inertizzazione? Oltre a tutelare la nostra salute e
l’ambiente, creerebbero nuovi posti di lavoro».
Amianto, la strage dimenticata. Quindici operai
morti, almeno 150 malati e un intero quartiere a rischio avvelenamento. È il
tragico bilancio portato alla luce dall'inchiesta sull'Isochimica, l'azienda di
Avellino dove negli anni '80 i lavoratori erano assunti per rimuovere a mani
nude la fibra killer dai treni. Perché oltre allo scandalo Eternit in Italia ci
sono ancora centinaia di siti da bonificare e migliaia di persone che rischiano
di essere contaminate, scrivono Antonio Cianciullo e Pierluigi Melillo su “La
Repubblica”. La fabbrica della morte è chiusa da quasi trent'anni, ma continua
ad uccidere. Il killer fantasma è nell'aria, ogni giorno gli abitanti di borgo
Ferrovia, quartiere popolare di Avellino, respirano i veleni che arrivano da
quel mostro chiamato "Isochimica", l'opificio dove negli anni '80 venivano
scoibentate le carrozze ferroviarie, quasi tremila in sei anni. Si lavorava a
mani nude, senza mascherine, inconsapevoli dei pericoli. Almeno 20mila
tonnellate di amianto sarebbero state sotterrate nel piazzale della fabbrica,
altre scorie sono state chiuse in cubi di cemento oppure sistemate in sacchi
neri e sversate nelle acque del fiume Sabato o addirittura nel mare della
costiera amalfitana. L'hanno rivelato gli ex operai ai magistrati. "Ma mentre
tutto ciò accadeva dov'erano i cittadini?", si chiede il procuratore della
Repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo, che paragona l'Isochimica all'Eternit
di Casale Monferrato, all'Ilva di Taranto a alla Thyssen Krupp. "Dovremo andare
via da qui", dice Gabriella Testa, alla guida del comitato di mamme di borgo
Ferrovia che si battono per la bonifica del sito. L'Arpac, l'agenzia regionale
per l'ambiente della Campania, ha accertato che ci sono 27 fibre di amianto per
litro d'aria nella zona, stando alle raccomandazioni dell'Oms non ce ne dovrebbe
essere nemmeno una. Il biologo Carlo Caramelli, garante del Tribunale per i
diritti del malato, ha chiesto al prefetto di far evacuare il rione. "Perché
Renzi non viene a visitare la scuola elementare che è a cento metri dalla
fabbrica?", ha chiesto polemicamente Carlo Sibilia, l'avellinese arrivato in
Parlamento con il Movimento 5 Stelle. C'è già stato lo screening sui bambini
della scuola, il pediatra dell'Asl di Avellino, Felice Nunziata, che ha guidato
l'equipe per le analisi, ha ammesso: "Qui non farei vivere mio figlio, la
bonifica è urgente". Ma è ancora tutto fermo: il Comune non ha i soldi, la
Regione prende tempo. Eppure il procuratore Cantelmo, dopo aver messo sotto
inchiesta il titolare dell'Isochimica, Elio Graziano, imprenditore protagonista
negli anni '80 dello scandalo "lenzuola d'oro", l'ex giunta comunale e perfino
il curatore fallimentare, ha cercato di imprimere un'accelerazione nominando
custodi giudiziari dell'impianto il sindaco, Paolo Foti, e il governatore
regionale, Stefano Caldoro. Dopo anni di omissioni e indifferenza almeno
qualcosa si muove. Ma la svolta non c'è stata. Resta il conto dei morti, una
lunga scia di lutti e dolore: l'amianto ha già ucciso 15 ex operai ed un
lavoratore che con l'Isochimica non c'entrava nulla. Si chiamava Vittorio
Esposito, lucidava i pavimenti della stazione ferroviaria dove si scoibentavano
le carrozze ferroviarie direttamente sui binari evitando di portarle in
fabbrica. Anche sua moglie, la vedova Rosetta Capobianco che lavava le tute del
marito impregnate di amianto, si è ammalata ai polmoni, ma continua a battersi
per il risanamento del quartiere. E ora da qualche mese la Procura indaga su
altri 23 decessi, nuovi casi sospetti tra ex operai, familiari e cittadini di
cui sono state sequestrate cartelle cliniche e certificati di morte. Si fanno i
conti. All'Isochimica lavoravano 333 operai, almeno 150 sono già risultati
ammalati. "Ormai ci sentiamo dei morti che camminano", confessa Carlo Sessa, uno
degli ex operai che ha visto morire i compagni di lavoro: da tempo chiede
inutilmente aiuto a tutti i partiti per la battaglia del prepensionamento degli
ex dipendenti della fabbrica dei veleni. Ma la politica è rimasta ancora
indifferente. E il futuro fa paura. Mario Polverino, direttore del polo
pneumologico dell'ospedale "Scarlato" di Scafati, ha scoperto che gli 80 operai
dell'Isochimica provenienti dal Salernitano sono stati tutti contaminati dalle
fibre killer. "Il picco delle malattie derivanti dall'amianto si avrà intorno al
2020, quindi tutti gli ex operai e i cittadini sono a rischio", conferma
Polverino che ha paragonato l'Isochimica alla miniera di crocidolite, l'amianto
blu, di Wittenoom Gorge nel Western Australia dove a distanza di 45 anni
dall'esposizione, le persone che abitavano nei dintorni della cava continuavano
ad ammalarsi e a morire fino a far diventare il villaggio una città fantasma.
Ma Borgo Ferrovia ora vuole vivere. Anche se la lotta contro i veleni non è
ancora finita. C'è un'altra morte sospetta legata alla fabbrica dei veleni su
cui indaga la Procura di Avellino. Lui si chiamava Vito Cotrufo: fu ucciso nel
1987 da un tumore ai polmoni, l'Isochimica era ancora in piena attività. Sarebbe
stata chiusa solo due anni dopo dal pretore di Firenze, Beniamino Deidda che
indagava sui morti delle grandi officine toscane dove le carrozze ferroviarie
tornavano dalla fabbrica irpina, ripulite male dall'amianto. Nelle carte della
Procura di Avellino ci sono poi i nomi dei decessi più recenti: Umberto De
Fabrizio, Vittorio Matarazzo, Luigi Maiello, Alberto Olivieri e altri dodici ex
lavoratori Isochimica, stroncati da malattie all'apparato respiratorio causate
dall'amianto. Parallela a queste si è consumata poi la tragedia di Pasquale
Soricelli, che nel 2011 dopo aver scoperto di essere affetto da una grave
malattia per le fibre killer si tolse la vita. Una targa da qualche anno ricorda
il sacrificio di questi lavoratori davanti alla fabbrica. Chissà se oggi il
titolare dell'Isochimica, l'ormai 82enne Elio Graziano, che sconta da condannato
ai domiciliari le sue pene nell'abitazione di contrada Scrofeta alla periferia
di Avellino, pensa mai al disastro che ha lasciato alle sue spalle. "Ho sempre
solo fatto del bene", ripete ancora oggi al suo avvocato, il penalista Alberico
Villani. Tornerà un uomo libero solo il 19 ottobre del 2017, quando finirà il
conto delle sentenze che l'hanno colpito per corruzione e omicidio colposo. Ma
con lui la giustizia non ha ancora chiuso i conti. Lo chiamavano "Papà Elio"
perché lui, da presidente dell'Avellino ai tempi della serie A, elargiva con
grande generosità, come un buon padre di famiglia, banconote da centomila lire a
tifosi e operai che lo acclamavano. Era un imprenditore rampante Graziano, che
dopo l'Isochimica aprì un altro stabilimento industriale a Fisciano (Salerno)
per la produzione del detersivo "Dyal", marchio che sponsorizzava le magliette
dell'Avellino. Anche nel piazzale di quella fabbrica sarebbe stato smaltito
l'amianto. Il patron arrivava allo stadio "Partenio" in elicottero prima delle
partite e prometteva premi favolosi ai calciatori. Da presidente portò
l'Avellino guidato in panchina da Luis Vinicio a sfiorare la qualificazione
all'allora Coppa Uefa, lanciando campioni che avrebbero fatto le fortune della
Juventus come Tacconi, Favero e Vignola. L'anno dopo, nel campionato '87-'88, ci
fu però la retrocessione in B e l'esplosione dello scandalo delle "lenzuola
d'oro", storia di mazzette pagate da Graziano ai vertici delle Ferrovie per le
forniture di biancheria sui treni notturni. Vicenda che costò la poltrona
all'allora presidente delle Fs Ludovico Ligato. Per l'industriale iniziò così la
parabola discendente che non è ancora finita. Perché c'è anche lui tra i 24
iscritti nel registro degli indagati nell'inchiesta della Procura sulla morte di
quanti sono stati uccisi dall'amianto dell'Isochimica.
Polvere killer ovunque ma lo smaltimento è fermo,
scrive Antonio Cianciullo. Molto amianto e poche discariche attrezzate.
Una previsione di 2mila morti all'anno e 22 anni di ritardo sulle misure di
sicurezza. Mentre dal punto di vista giudiziario il quadro delle responsabilità
è emerso con chiarezza nel primo grado di giudizio che ha visto i proprietari
della Eternit condannati a 16 anni di reclusione per disastro doloso permanente,
il panorama dell'esposizione alla fibra killer resta sconfortante. Ci sono più
di 34mila siti da bonificare e oltre 32 milioni di tonnellate di amianto sparse
in giro. Non è solo un problema che si declina al passato. Il rischio continua.
Anzi si allarga visto che c'è una crescita dei casi di esposizione non
professionale: tra le vittime aumentano le persone entrate casualmente in
contatto con l'amianto (più di 50mila edifici contengono asbesto). Mettendo
assieme i luoghi più esposti al pericolo si arriverebbe a 75mila ettari,
l'equivalente della provincia di Lodi. Questa superficie - formata dalle zone
inserite nel programma nazionale di bonifica del ministero dell'Ambiente -
comprende Casale Monferrato e i 47 Comuni vicini costruiti usando amianto;
Bagnoli e la contrada Targia a Siracusa, con le fabbriche di cemento amianto;
Comuni come Broni (Pavia) con i siti produttivi dismessi che lavoravano la fibra
killer; le miniere di Balangero (Torino), ed Emarese (Aosta) da dove veniva
estratto il minerale; gli edifici che hanno utilizzato asbesto. Ma i dati sono
parziali e sotto stimati perché la legge del 1992, che in Italia ha vietato
l'estrazione, l'importazione e l'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che
lo contengono, obbligava le Regioni ad adottare entro 180 giorni dalla sua
entrata in vigore un programma dettagliato per il censimento, la bonifica e lo
smaltimento dei materiali contaminati dalla fibra killer. La disposizione però è
rimasta quasi ovunque lettera morta. In molte aree del paese i dati mancano.
"Ancora oggi le Regioni si trovano in forte ritardo negli interventi per ridurre
il rischio sanitario da amianto ", si legge nel rapporto firmato da Legambiente.
"Un ritardo che in alcuni casi riguarda addirittura l'approvazione del Piano. Ad
oggi solo due Regioni hanno previsto una data in cui arriveranno a completare la
bonifica e la rimozione dei materiali contenti amianto: la Lombardia (entro il
2016) e la Sardegna (entro il 2023)". Ecco l'elenco delle aree critiche
contenuto nel dossier: 23.816 edifici pubblici (di cui oltre 12 mila in
Piemonte) e 24.299 edifici privati (il 99% in Lombardia); 100 milioni di metri
quadrati in strutture di cemento amianto (l'81% in Lombardia); 650 mila metri
cubi di amianto censiti in Basilicata, Abruzzo e Liguria; in tre regioni
(Toscana, Emilia Romagna e Piemonte) la contaminazione da amianto riguarda anche
le aree di cava. "Tra il verdetto scientifico di estrema pericolosità e la
reazione è passato un tempo troppo lungo", commenta Stefano Ciafani,
responsabile scientifico di Legambiente. "Perciò oggi milioni di italiani,
probabilmente un terzo della popolazione, si trovano esposti a un rischio che
poteva essere evitato con un intervento tempestivo. Ora bisogna andare veloci:
creare un Fondo nazionale per le bonifiche dei siti 'senza più padrone', sul
modello del Superfund statunitense; completare le analisi epidemiologiche nelle
aree a maggior rischio; organizzare discariche sicure per i materiali ricavati
dalle bonifiche, mentre oggi esportiamo il 75% dei rifiuti contenenti amianto e
questo incide molto sui costi".
LADROCINIO AL MINISTERO DELL’AMBIENTE?
Ex
ministro Clini indagato anche a Roma: associazione a delinquere per corruzione,
scrive “La Repubblica”. L'inchiesta
coinvolge anche la moglie Martina Hauser ed altre 4-5 persone e verte su
presunte provviste realizzate tramite progetti per centinaia di milioni
realizzati in Cina e Montenegro. Ora è ai domiciliari per il procedimento aperto
dalla procura di Ferrara: un mln sottratto da fondi governo. E' accusato di far
parte di una associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. L'ex
ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, dal 26 maggio 2014 ai domiciliari con
l'accusa di peculato su richiesta della procura di Ferrara, è investito da una
nuova bufera giudiziaria a Roma sulla gestione ministeriale di una gran massa di
milioni utilizzati per finanziare progetti all'estero. La vicenda verte su
presunte provviste realizzate tramite progetti per centinaia di milioni
realizzati in Cina e Montenegro. Oltre all'ex ministro, nel registro degli
indagati sono state iscritte altre 4-5 persone tra cui la moglie di Clini,
Martina Hauser, assessore comunale a Cosenza. E il movimento "Rivolta ideale",
fondato dall'avvocato Michele Arnoni, ex segretario provinciale di Cosenza de La
Destra, ha chiesto le dimissioni della Hauser che ha le deleghe per la
Sostenibilità ambientale e le Energie rinnovabili, insieme alla Programmazione e
l'ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche. Due inchieste incrociate.
Quella del pm Alberto Galanti marcia infatti parallelamente a quella della
procura di Ferrara. La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici di Clini e
trovato documenti utili a Roma. Cina e Montenegro sono al centro di progetti,
rispettivamente per 200 milioni e 14 milioni di euro approvati nell'arco di più
di un decennio e riguardano prevalentemente la riqualificazione ambientale di
alcune aree. Il sospetto degli inquirenti è che dietro il finanziamento di
questi progetti, ottenuti da imprese italiane, ci sia stato un giro di mazzette.
Martina Hauser, la
moglie dell'ex Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, è assessore comunale a
Cosenza. Le sue deleghe sono la Sostenibilità ambientale e le Energie
rinnovabili, insieme alla Programmazione e l'ottimizzazione dell'uso delle
risorse idriche. Dopo che si è diffusa la notizia che Martina Hauser è indagata,
il movimento "Rivolta ideale", fondato dall'avvocato Michele Arnoni, ex
segretario provinciale di Cosenza de La Destra, ne ha chiesto le dimissioni. "Le
dimissioni, a nostro avviso - afferma il movimento in un comunicato -
rappresentano un atto dovuto per stile, dignità ed etica politica" ma anche "per
consentire all'assessore Hauser, già sempre assente dal territorio sin dal suo
insediamento e fortemente voluta dal sindaco, Mario Occhiuto, di difendersi con
maggiore serenità dalle pesanti accuse". A chiedere che si dimetta è anche l'ex
sindaco di Cosenza, Pietro Mancini, figlio dell'ex segretario nazionale del Psi,
Giacomo. "Gli indagati, fino a sentenza definitiva - sostiene Pietro Mancini -
non vanno considerati colpevoli. Tuttavia, donna Martina, se non l'ha già fatto,
rassegni al più presto le dimissioni e rinunci alla poltrona".
Nell'inchiesta di Ferrara c'è
anche il caso della distrazione di 54 milioni destinati dal ministero al
progetto "New Eden", che serviva "alla protezione e preservazione dell'ambiente
e delle risorse idriche, da realizzarsi in Iraq". L'ex ministro dell'Ambiente
Corrado Clini aveva un conto cifrato in Svizzera, denominato 'Pesce', nel quale
sarebbero confluiti i fondi sottratti al finanziamento del governo italiano per
il progetto di risanamento delle acque in Iran. Lo scrive il Gip di Ferrara
nell'ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto i domiciliari per l'ex
ministro. L'intervento prevedeva anche una sorta di bonifica del bacino del
Tigri e dell'Eufrate, nel sud iracheno. Oltre a Clini, un ordine di custodia
cautelare ai domiciliari è stato firmato dal gip anche anche a carico di Augusto
Calore Pretner, imprenditore e ingegnere del padovano, socio dello studio che ha
curato il progetto. Oggi al tribunale di Ferrara Pretner però non ha sostenuto
l'interrogatorio avvalendosi della facoltà di non rispondere. Nei confronti
dell'ex ministro dell'Ambiente la procura di Ferrara aveva chiesto la custodia
cautelare in carcere ma il Gip Piera Tassoni ha respinto la richiesta dei pm.
"Nonostante la gravità delle condotte delittuose - si legge nell'ordinanza del
giudice - si ritiene che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente
salvaguardate per entrambi gli indagati con l'adozione degli arresti
domiciliari". L'ex ministro Corrado Clini sarà interrogato domani mattina a
palazzo di Giustizia a Ferrara: da quanto si apprende il gip Piera Tassoni, come
accaduto oggi per l'altro arrestato, l'ingegnere padovano Augusto Pretner, ha
deciso di ascoltare direttamente l'ex ministro evitando una rogatoria con Roma
dove Clini si trova agli arresti domiciliari nella propria abitazione, per
l'accusa di peculato. Clini arriverà a Ferrara, dunque, in modo autonomo con il
suo avvocato Paolo Dell'anno che aveva già dichiarato l'estraneità alle accuse.
L'ex ministro dell'Ambiente Corrado Clini avrebbe intascato oltre un milione di
euro facente parte del finanziamento che il governo italiano aveva concesso per
il progetto New Eden in Iraq. Lo scrive il Gip di Ferrara Piera Tassoni
nell'ordinanza di custodia cautelare sottolineando che il denaro, attraverso
l'emissione di false fatture, sarebbe finiti su un conto corrente aperto a
Lugano mediante otto bonifici per complessivi 1.020.000. "E' stato messo in atto
un complesso e sofisticato meccanismo, preordinato all'appropriazione di denaro
pubblico, conseguendo ingenti profitti", scrive il Gip. "Il pericolo di
reiterazione del reato - aggiunge - s'individua nella già reiterata condotta
criminosa protrattasi nel tempo e 'naturalmente' tesa alla ripetizione".
Nell'ordinanza il giudice ricostruisce il percorso fatto dal denaro. Le somme
distratte attraverso un sistema di fatture false, scrive, "una volta pervenute
sul conto intestato a Coolshade Enterprise di Augusto Pretner erano con un primo
passaggio versate con bonifico, per il solo transito di denaro, al conto
corrente relazione bancaria Limecross Limited Tortola facente capo da un
intermediario svizzero e con un secondo passaggio, nella stessa data del
ricevimento, trasferite con bonifico, per pari importo ed in dipendenza del
codice, su altri conti correnti, identificati con tre codici: 'Schiavo', 'Sole'
e 'Pesce'. Sole si identifica in Augusto Pretner. Pesce si identifica in Corrado
Clini. Il terzo è di persona deceduta". Sul conto 'Pesce', secondo l'accusa,
finiscono otto bonifici per un totale di 1.020.000 tra il 14 ottobre 2008 e il
22 giugno 2011. Quel conto, si legge nell'ordinanza, "è stato aperto il 13
giugno 2005. Trattasi di relazione cifrata il cui titolare è Corrado Clini".
Quattro passaggi esteri e poi i soldi arrivavano a
destinazione: conto corrente 0247678051 aperto presso la filiale di Lugano
dell’Ubs, intestato a Corrado Clini, scrive Fiorenza Sarzanini su “Il Corriere
della Sera”. Nome in codice, «Pesce». Celandosi dietro lo pseudonimo l’ex
ministro dell’Ambiente pensava forse di farla franca. Invece sono state proprio
le autorità elvetiche a denunciare l’irregolarità di quegli otto bonifici per un
totale di un milione e 20mila euro ordinati tra il 2008 e il 2011 contestando il
reato di riciclaggio. E alla fine le verifiche effettuate dalla Guardia di
Finanza hanno convinto il giudice di Ferrara a far scattare l’arresto. Anche
perché il denaro proveniente dai fondi pubblici stanziati per l’Iraq potrebbe
essere soltanto una parte dei finanziamenti che Clini ha «stornato» per sé
nell’ambito di numerosi progetti internazionali gestiti nel suo incarico di
direttore generale. La procura di Roma sta indagando su flussi finanziari che
superano i 215 milioni di euro e ipotizza il reato di associazione a delinquere
finalizzata alla corruzione anche nei confronti della moglie Martina Hauser,
assessore comunale a Cosenza e - dice l’accusa - destinataria di alcuni
contratti di consulenza proprio grazie al marito. Il «paravento» individuato dai
finanzieri di Ferrara guidati dal colonnello Sergio Lancerin era il progetto
«New Eden» affidato alla «Nature Iraq» per lo sfruttamento di Tigri e Eufrate.
Investimento del governo italiano: 54 milioni di euro. Una segnalazione arrivata
lo scorso anno dalla polizia tributaria olandese accusa la società «Gbc, Global
Business & Comunications» di aver emesso false fatture in favore della Ong. Le
verifiche effettuate dal Nucleo Tributario confermano il sospetto e forniscono
altri dettagli. Scrive il giudice nell’ordinanza di cattura contro Clini e il
suo «socio», anche lui ai domiciliari, Augusto Calore Pretner: «Le somme erogate
dal governo italiano confluivano nei conti correnti intestati a “Nature Iraq” e
“Iraq Foundation”. Dagli stessi conti erano tratti i bonifici con cui queste
società pagavano le fatture emesse nei loro confronti dalla “Gbc” per un totale
di 3milioni e 424mila euro». In realtà l’azienda non ha svolto alcuna attività,
quei documenti contabili sarebbero «pezze d’appoggio» per creare le provviste da
destinare a Clini e ai suoi presunti sodali. Il provvedimento giudiziario
ricostruisce i successivi passaggi del denaro: «La società olandese “Orient
Invest” emette fatture per un totale di 3 milioni e 251mila euro che la “Gbc”
paga su un conto corrente aperto a Dubai tenendosi una percentuale del 5 per
cento. A sua volta la “Orient Invest” trattiene una percentuale del 2 per cento
e bonifica 3 milioni e 172mila euro su un conto aperto presso la Ubs di Lugano e
intestato alla società di dominio caraibico “Coolshade Enterprise”». È la tappa
cruciale perché quest’ultima azienda fa capo a Pretner e serve allo smistamento
delle somme che puntualmente avviene, sia pur con un frazionamento per sfuggire
ai controlli. L’espediente evidentemente non basta. Dopo un ulteriore passaggio
sul deposito messo a disposizione da un mediatore svizzero, i soldi arrivano su
tre conti che hanno un’intestazione in codice: «Sole» è Pretner e prende 2
milioni e 30mila euro; «Schiavo» è Luciano Mascellani, un signore poi morto al
quale risultano bonificati 120mila euro; «Pesce» è Clini che riceve un milione e
20mila. Ben più alte le somme che Clini avrebbe ricevuto grazie ai progetti di
cooperazione internazionale avviati in Cina e Montenegro per la riqualificazione
ambientale di vaste aree. Gli inquirenti sospettano che lo stesso «sistema»
usato per l’affare iracheno sia stato adottato per gli altri Stati. E calcolando
che la percentuale presa attraverso «New Eden» supera il 5%, l’ammontare totale
delle mazzette potrebbe superare i 10 milioni di euro. Denaro che Clini avrebbe
spartito con la moglie e altri «soci» disponibili a mettere a disposizione
società per l’emissione di false fatture. Il 12 ottobre 2013, quando i
magistrati di Ferrara lo hanno convocato per contestargli le irregolarità
relative ai rapporti del ministero con «Nature Iraq», Clini ha dichiarato:
«Prendo atto dei documenti che mi vengono mostrati, ma non so nulla. In ragione
del mio incarico (direttore generale ndr) prenderò i necessari provvedimenti a
tutela dello Stato italiano». In realtà i soldi erano già al sicuro sui suoi
conti correnti italiani. Il conto svizzero è stato infatti «svuotato il 4 agosto
2011 trasferendosi i soldi su un altro conto attraverso 18 bonifici intestati
alla società Freelance riferibile a soggetti intermediari finanziari dediti al
trasporto di valuta contante». Sono i cosiddetti «spalloni» che l’ex ministro ha
evidentemente deciso di utilizzare anche per sfuggire al fisco.
L’amico “Corrado” era Clini?
Si chiede Sabrina Giannini su “Il Corriere della Sera”. Allora ministro
dell’Ambiente, Clini rifiutò con sdegno di essere “quel Corrado, un nostro uomo”
evocato da un manager dell’Ilva nel corso di una presunta intercettazione
telefonica che sarebbe stata registrata dalla Guardia di Finanza per conto dei
magistrati tarantini. Non si è ancora capito che fine abbia fatto la
registrazione integrale di quella intercettazione, forse e come spesso accade
quando il re perde la corona, affiorerà all’improvviso aggiungendo (o forse
togliendo) un tassello del puzzle ancora incompleto che ha portato a uno dei
disastri ambientali più gravi degli ultimi anni e che ha visto contrapporsi il
Gip Todisco ai decreti salva-Ilva, incluso quello firmato nel 2012 dal ministro
del governo Monti, Corrado Clini appunto. Monti lo scelse come tecnico, di certo
poco esperto di ambiente avendo una laurea in medicina. Eppure le sue perle di
saggezza sembravano derivare da profonda conoscenza del fenomeno, come quando
dichiarò che il problema ambientale nasceva dall’imbecillità urbanistica di chi
aveva costruito il quartiere Tamburi a ridosso dell’acciaieria. Avesse letto su
Wikipedia la storia in breve di Taranto avrebbe appreso che quel quartiere c’era
già al tempo dei Romani (quelli con le bighe e non quelli delle auto blu usate
anche dai Dg ministeriali come lui), quindi qualche secolo prima che in preda
all’ansia di prestazione meridionalista (e relativa questua di voti) i
democristiani costruissero un gigante d’argilla, costato alla collettività 32
miliardi di euro in sedici anni solo per ripianare i debiti e, soprattutto, un
imprecisato tributo di vite umane. Clini, da due giorni agli arresti
domiciliari per la presunta accusa di avere sottratto milioni di euro dalle
casse pubbliche, avrà tempo per colmare le sue lacune in storia e comprendere
anche quale altra perla ci ha donato quando aveva proposto come soluzione per
Taranto lo spostamento del quartiere sfortunato. Una sorta di deportazione di
massa che avrebbe risolto il problema. Che ovviamente non era l’acciaieria e la
gestione criminale dei dirigenti dell’Italsider prima e dei Riva poi,
consapevoli che ogni centesimo risparmiato per il risanamento degli impianti
avrebbe minato la salute degli operai e dei cittadini (almeno otto miliardi di
euro risparmiati dai Riva secondo gli esperti del Gip Todisco, due dei quali
trafugati nei paradisi fiscali secondo i magistrati milanesi: si veda a
proposito l’inchiesta su Report “Patto d’acciaio”.) Ma se un dirigente di
carriera come Clini guadagna trecentomila euro l’anno una ragione ci sarà. Il
Wikileaks - Italian reaction to President Bush's new climate change initiative
“servitore dello Stato” Corrado sarebbe stato «un architetto chiave del ponte
tra gli Stati Uniti e l’Europa in materia di cambiamenti climatici negli anni
del governo Berlusconi (2001-2006)», come scrive l’ambasciatore Ronald Spogli
nelle sue comunicazioni riservate con il Dipartimento di Stato, pubblicate da
WikiLeaks. “Il nostro migliore amico al ministero dell’Ambiente” sarebbe stato
proprio Corrado Clini percepito dagli americani come un aiuto in un momento
critico per Bush, isolato per avere scelto di non aderire al Protocollo di Kyoto
con lo scopo di non penalizzare le industrie inquinanti. Da dirigente
“esperto” in questioni climatiche Clini nell’ottobre del 2012 entra nella
squadra di Monti e firma il primo decreto salva-Ilva con il quale si mettono
alla porta i custodi nominati dal tribunale restituendo così la gestione dello
stabilimento ai Riva e al loro presidente Bruno Ferrante, il quale, forte dello
scudo del decreto, ha continuato a produrre acciaio in deroga a numerose norme
ambientali senza attivare il risanamento come avrebbe dovuto. Mentre i Riva
spostavano i loro soldi in passaggi societari inestricabili in Lussemburgo,
l’Ilva di Monti-Clini-Ferrante “tutelava” i polmoni dei cittadini del quartiere
Tamburi (in attesa della deportazione) recintando lo stabilimento con le reti
usate per la raccolte delle olive varietà leccino che, secondo l’”esperto”
Clini, avrebbero potuto trattenere le polveri inquinanti che si sollevano
insieme ai minerali. A corredo della farsa furono acquistati otto cannoni
nebulizzatori che per mesi non hanno funzionato (per fortuna, perché avrebbero
fatto più danni che altro). L’effetto di quel decreto fu devastante e ancora
oggi Taranto ne paga le conseguenze. Il commissario Bondi voluto da Letta non ha
trovato i soldi per risanare né per riqualificare l’acciaio sempre meno
appetibile perché l’azienda è poco affidabile per la qualità della materia
prima. Il mercato non perdona. La Corte Costituzionale aveva restituito
all’azienda la facoltà d’uso a patto che risanasse e così non è stato. La
Procura, incredibilmente, non ha più agito contro i trasgressori e il recente
decreto del governo Renzi ha ormai azzerato quell’obbligo. Il piano ambientale è
stato rivisto da Bondi, sono stati tolti i vincoli, annullate le prescrizioni e
rinviati sine die i termini per eseguire gli interventi. Oggi non resta
che quel monumento alla finzione che si è voluto erigere a disprezzo
dell’intelligenza umana: le reti per le olive che non proteggono i polmoni dei
bambini dei Tamburi. Il diritto alla salute di quei bambini, di tutti gli
abitanti dei Tamburi, è annientato dalle leggi “speciali” redatte dagli
“esperti” dei ministeri e da Bondi, un chimico risanatore di finanze che ha
clamorosamente fallito perfino nella sua pratica: quella di chiedere soldi alle
banche. I veri esperti che avrebbero tutelato e pianificato un risanamento
graduale e, parallelamente, garantito la produzione a rigor di legge, potevano
essere i tre custodi giudiziari nominati dal giudice Patrizia Todisco. Oltre a
stimare gli interventi necessari per eliminare le “emissioni inquinanti”
definendone i costi in 8 miliardi di euro, avevano anche definito un piano di
recupero preciso e dettagliato. Centinaia di pagine, sintesi delle centinaia di
ore passate a studiare camini, impianti, filtri, emissioni e quindi soluzioni.
Tutto già fatto, bastava applicarlo. Ma Antonio Gozzi, presidente di
Federacciai, in un’intervista definisce i tre custodi nominati dal Gip Todisco
“tre ragazzi che accusano Riva di aver sottratto 8 miliardi di profitti
all’ambiente, giudizio però bocciato dalla Cassazione.” I “tre ragazzi” sono gli
ingegneri industriali tecnici dell’Arpa coordinati da Barbara Valenzano,
dirigente con specializzazione in impianti chimici di processo, massimo titolo
conseguibile quale qualificazione professionale, che nel frattempo si sarebbe
rivolta a un avvocato per querelare Gozzi. Il quale forse non sa che la
Cassazione ha annullato il provvedimento del Gip con motivazioni legate alla
procedura di sequestro e non per le modalità con cui è stato redatto il Piano di
interventi necessari per risanare l’Ilva, tanto che lo stesso Bondi l’avrebbe
ricalcato, fatta eccezione per la copertura dei parchi minerari. Peccato che i
soldi dei Riva siano blindati sotto sequestro a Milano e non utilizzabili per lo
scopo del risanamento, a meno che non siano loro ad autorizzarlo. Ovviamente se
avessero avuto lo spessore degli industriali illuminati non avrebbero
trasformato l’Ilva in uno degli esempi di inciviltà industriale di cui possiamo
solo vergognarci. Anche a causa delle protezioni istituzionali e degli aiuti dei
governi. Ministri salva-Ilva inclusi. Tra questi anche Clini. L’esperto Clini.
Verso il quale Gozzi non ha mai proferito cattive parole. Sarà perché Clini è
amico di tutti?
LA GRANDE BUFALA: LA GREEN ECONOMY.
La più grande bufala della storia: la
green economy, scrive Gianni Petrosillo. La nostra
avrebbe dovuto essere l’era dell’energia pulita, il secolo lindo e
trasparente delle fonti rinnovabili “non convenzionali”. Da quando poi il
profeta nero dell’ecologia verbale, simbolicamente perfetto ed eticamente
furbetto, al pari dei suoi scaltri predecessori, è salito sul pero della prima
potenza mondiale non si è parlato d’altro perché egli stesso non aveva
nient’altro di coinvolgente da dire. Il signor Presidente aveva ricevuto il
mandato preciso di accendere le coscienze per spegnere i cervelli, di infiammare
i cuori per bruciare i concorrenti, di innalzare gli spiriti per seppellire le
nazioni. Questo ha fatto con premura prima che il tanto annunciato futuro
radioso dell’umanità sostenibile ed ecocompatibile si sciogliesse al sole e si
volatilizzasse nell’aria. Le bugie hanno le gambe corte ma il passo spedito,
quel che basta per seminare i potenziali competitori creduloni che restano
indietro quanto più avanzati e moderni si sentono. Sole, vento, combustibili
vegetali e non inquinanti in generale avrebbero dovuto prendere il posto delle
fonti classiche, dal carbone, al petrolio, al gas, nel giro di qualche anno. Ed,
invece, siamo ancora al punto di partenza con la differenza che rispetto al
passato abbiamo accumulato montagne di balle sesquipedali e di menzogne
monumentali, piuttosto difficili da smaltire. Il conformismo propagandistico
ecologistico ha alimentato l’illusione energetica “non convenzionale” per
recondite ragioni geopolitiche, accollando spese pazze alle collettività più
incaute ed ingenue. I buoni di cuore e gli ultrasensibili ai destini del globo,
nonché al fato delle generazioni a venire (machissenefrega), alle quali avremmo
l’obbligo di riconsegnare il pianeta perché ne siamo meri usufruttuari per
volere della sorte, di dio o di chissà cos’altro (salvo soprese spaziali che
potrebbero cancellarlo all’istante senza tener conto delle nostre speranze) se
la sono bevuta tutta d’un fiato. L’unica cosa che è aumentata a dismisura è la
produzione di scorie intellettuali che hanno avvelenato il buon senso e le
faticose risultanze della scienza in questo campo. I padroni del mondo adesso
se la ridono impunemente essendo stati più pragmatici e meno accecati dalle
fandonie del Global Warming o da quelle sui limiti della crescita. Essi sanno
come fornire le dosi giornaliere di “soma” social-ambientale a chi gli
scodinzola intorno, evitando di contaminarsi e di rincitrullirsi a loro volta.
Così, all’abbisogna, con estrema lucidità, impartiscono il contrordine senza
stuzzicare i popoli che dormono da quando sono nati. Non che non ci abbiano
rimesso pure loro qualcosa ma il gioco valeva la candela e, comunque, gli altri
avrebbero perso tutto, compresa la faccia. Obama ha incominciato decantando i
colossali investimenti in imprese innovative del settore delle rinnovabili.
Solyndra e A123 Systems, i casi più eclatanti. Entrambe miseramente fallite con
sperperi di denaro pubblico e posti di lavoro. Tuttavia, dietro le quinte, gli
Usa lavoravano ad altro senza andare tanto per il sottile e mettendo da parte le
chiacchiere verdi. Scommettevano sul gas di scisto e ancora sul petrolio (alla
faccia delle teorie sul picco e sul suo esaurimento imminente) perché, ai
livelli tecnologici dati, non c’è finora nulla di superiore, di conveniente e di
performativo (escludendo il nucleare). Oggi, grazie alla tecnica del fracking
che consiste nella frantumazione delle rocce per estrarne il gas (shale gas)
Washington ha raggiunto la quasi autonomia energetica. Sapete come hanno
chiamato gli americani questo sistema di sfruttamento delle risorse naturali che
presenta controindicazioni ambientali elevatissime? La rivoluzione tranquilla.
E meno male…Ma questo è il minimo della presa per i fondelli. Sabato 1° febbraio
il Washington Post, in un articolo a firma di Juliet Eilperin e Steven Mufson,
ha scritto del maxi-oleodotto progettato tra Canada e Stati Uniti che a pieno
regime sarà in grado di trasportare di 830.000 barili di greggio al giorno. La
pipeline attraverserà tutto il Midwest, da Nord a Sud, fino al Texas, un
percorso lunghissimo e costoso (oltreché ad alto impatto ambientale) che,
tuttavia, si completerà lo stesso, nonostante gli ecologisti siano già sul piede
di guerra, perché si tratta di acciuffare il primato mondiale sul petrolio (del
Nord America su paesi come l’Arabia). Gli interessi nazionali e strategici del
Paese vengono anteposti, com’è giusto che sia, alle favole belle e impossibili.
La testa prima del cuore ed il fegato di rischiare prima di tutto il resto. E
in Italia, invece, che facciamo? Continuiamo a strapagare sulla bolletta
energetica ogni “inutilità alternativa” per fare contenti i parassiti del verde
e a costituire comitati di opposizione, altrettanto alternativi, ma soltanto al
raziocinio, per bloccare qualsiasi sviluppo. A che serve il progresso vero
quando si hanno a disposizione pozzi inesauribili di progressismo finto? Vivremo
di quelli, cioè decresceremo felici e impotenti.
Energia, la bufala della green economy,
scrive Fabio Balocco su “Il Fatto Quotidiano”. Alcuni, non pochi, che
masochisticamente leggono ciò che scrivo, sono convinti sviluppisti. Per loro il
massacro che l’uomo sta perpetuando alla Terra è necessario appunto come lo
sviluppo. Le morti per inquinamento, i disastri ambientali, puri incidenti di
percorso oppure effetti collaterali indesiderati ma ahimè necessari. Sono questi
che pronunciano la solita trita e ritrita frase “questi ambientalisti che
dicono no a tutto” ed in particolare, in campo energetico (l’energia =
motore dello sviluppo), “si oppongono al nucleare, al carbone, al petrolio, e
persino al solare, all’eolico, ed all’idroelettrico”. Non rispondo per decenza a
chi continua a volere il nucleare, visto che già i disastri parlano da soli,
visto che le scorie nessuno giustamente le vuole, così come nessuno vuole le
miniere estrattive. Non rispondo neppure a coloro che sono favorevoli
all’utilizzo di carbone e petrolio nella produzione di energia visti anche i
recenti sviluppi riguardanti la salute delle persone che hanno la sfortuna di
vivere nei siti intorno alle centrali. Andiamo invece a quella che viene
definita la “green economy”, che spesso ha più l’apparenza di una operazione di
greenwashing che di una reale produzione compatibile con l’ambiente.
Solare. Va
benissimo il solare sparso sul territorio, ma non su terreni coltivabili. Che
tipo di “economia verde” è un’energia che il verde commestibile lo fa sparire? A
Torino c’è ad esempio una realizzazione virtuosa: pannelli solari piazzati sopra
una discarica chiusa. E perché non agire sulla leva delle imposte per convincere
chi ha o realizza capannoni industriali a rendersi autonomi energeticamente? I
capannoni continuano ad essere realizzati in prefabbricati e sono
energeticamente ignobili: caldi d’estate e freddi d’inverno.
Eolico. Gli
incentivi fanno sì che buona parte dei parchi eolici fino ad oggi realizzati non
siano economicamente vantaggiosi, in quanto realizzati in zone scarsamente
ventilate. Ma non solo: pale eoliche realizzate sui crinali ed alte da 60 a 100
metri possono forse considerarsi compatibili con la tutela del paesaggio
predicata dall’art. 9 della Costituzione? Esiste il minieolico ed il
microeolico, perché se si vuole incentivare non si incentivano soprattutto
queste forme di produzione, anziché quelle ad alto investimento, che, tra
l’altro, esperienza dimostra che possono attirare capitali di dubbia origine?
Idroelettrico.
Realizzato soprattutto in montagna, l’idroelettrico “ha già dato”. Eppure, anche
qui, si continuano a presentare nuove domande di concessione per il cosiddetto
“piccolo idroelettrico”, e cioè sotto i 3 megawatt di potenza. Eppure più del
90% dei corsi d’acqua alpini non versa in condizioni di naturalità. Ha senso
continuare a sfruttare la risorsa a danno dei pochi ecosistemi ancora integri?
Biomasse. Le
centrali a biomassa oggi vanno di moda. Ma se ha un senso una centrale che
sfrutti gli scarti di lavorazione agricola, o le cippature delle alberate,
nessun senso ha invece realizzare una centrale che brucia legna proveniente
dall’estero, con relativi costi di trasporto, oppure una centrale che brucia
legna proveniente dal taglio di un bosco secolare.
Una parola sugli inceneritori.
Siamo l’unico paese che ha dato incentivi agli inceneritori (chiamandoli
vezzosamente “termovalorizzatori”) assimilandoli alle fonti rinnovabili. Non è
il caso di spendere molte parole. Una raccolta differenziata virtuosa come
dovrebbe essere in ogni comune (ce ne sono che raggiungono percentuali del 90%)
non darebbe nessuna linfa vitale agli inceneritori. Non si avrebbe il problema
delle scorie, e non si avrebbero le ricadute negative sulla salute dei
cittadini.
Gli sviluppisti troveranno in queste poche righe
ulteriori elementi di accusa. “eh, sì, e allora come ci possiamo sviluppare?”.
Il punto è proprio qui. Non dobbiamo ingrassare, dobbiamo dimagrire. Non è
semplice, ma è necessario.
La green economy e la sua mistificazione,
scrivono Franco Fondriest e Luca Lombroso su “Il fatto Quotidiano”. La
“green economy” va molto di moda in alcuni ambienti politici, in particolare di
centro sinistra. Ma è veramente questa la via giusta per ridare fiato al
pianeta? Ora tutto è green:
- i detersivi sono green, basta aggiungere qualche
componente naturale;
- gli alberghi sono green, basta lavare meno
spesso gli asciugamani;
- i centri commerciali sono green, basta collocare
un pannello solare;
- le banche sono green, basta fare un po’ di home
banking.
Basta una ritoccatina e tutto diventa green.
Perfino le supercar sportive e la formula uno con la scusa del motore ibrido,
perfino la guerra, con i cacciabombardieri a biocarburanti che ammazzano e
distruggono tutto, ma non l’ambiente (!!!!!!!). Il riciclaggio dei rifiuti ne è
un esempio ancor più chiaro; una filiera industriale basata sul riciclo di
materiali, poniamo plastica, implica che si continui a utilizzare plastica e a
buttarne via, per poi riciclarla, all’infinito. E’ certamente meritevole
riciclare rifiuti, ma ciò implica la necessità, nei processi produttivi,
di uso di energia e di acqua. Ma a volte la convenienza “energetica”
(tecnicamente ‘Eroei’, Energia ritornata rispetto l’energia investita) è
risicata, e il processo si sostiene, a fatica, grazie a pubblici contributi,
vedi il caso del vetro; basta guardare a fianco dell’Autosole fra Modena e
Bologna per trovarne vere e proprie montagne abbandonate, fra le giuste proteste
dei comitati e le vaghe promesse, non mantenute, dei politici. Altre volte,
aziende “ecologiche” che riciclano materiale si incendiano, e allora ci
accorgiamo di quanto poco ecologico è stoccare plastica, pneumatici, o
quant’altro. La vera via per risolvere il problema dei rifiuti insomma non è il
riciclaggio, ma la loro drastica riduzione alla fonte e ciò vale per quelli
urbani e ancor più per quelli di cui pochi parlano, detti “speciali”, ovvero i
rifiuti industriali prodotti alla fonte della filiera. In poche parole, la via
proposta per uscire dalla crisi economica da alcuni politici ed ambientalisti
sarebbe la “crescita verde”, ovvero se non si riesce più a vendere un oggetto,
o a costruire una grande opera, si rimedia facendolo ecosostenibile. Questa via
è solo poco meglio, o forse meno peggio, del consumismo tradizionale e ha dei
grossi limiti e problemi, economici etici e ambientali. Spesso sconfina nel
greenwashing, che è ancora più dannoso per l’ambiente perché induce il
consumatore, in buona fede, a comprare prodotti inutili solo perché “ecologici”
o giustifica la costruzione di grandi opere solo piantando qualche albero e
facendo una barriera antirumore, magari coperta di pannelli solari male esposti
al sole. Altra cosa invece è parlare di “futuro sostenibile” e non di “sviluppo
sostenibile”, infatti con sviluppo spesso si sottintende la crescita che,
piaccia o no, verde o sporca che sia, è limitata da ragioni fisiche e di
disponibilità di risorse e probabilmente è anche definitivamente terminata,
almeno nel nostro paese e in altri. Riprendiamo l’esempio dei centri commerciali
fuori dalle città; portano traffico, inducono al consumo, consumano quantità
ingenti di energia per illuminazione, riscaldamento, raffrescamento e
refrigerazione dei cibi; la vera alternativa sostenibile sono i centri di
vicinato, i mercati a (vero) km 0, quelli biologici o di gruppi di acquisto
solidale. Quindi, se a qualcuno piace green perché è funzionale ad un sistema
basato sulla crescita, nel quale fare e disfare è funzionale, lo dica
chiaramente, ma non lo si spacci per sviluppo sostenibile!
CHI HA PAURA DELLE
NUOVE TECNOLOGIE: HYST ED OGM?
Antonio Giangrande:
“Fame nel mondo: disinformazione e scienza”.
«Siamo un paese di
truffatori, o, magari, qualcuno ha interesse a farci passare come tali». Così
afferma il dr Antonio Giangrande, noto saggista di fama mondiale e presidente
dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal
Ministero dell’Interno. Associazione fuori dal coro e fuori dai circuiti
foraggiati dai finanziamenti pubblici.
«Ogni qualvolta c’è una
nuova tecnologia o una nuova terapia, che non sia abilitata e di proprietà
intellettuale delle grandi lobbies, ecco lì che interviene la magistratura a
stoppare il tutto. Dei metodi Di Bella e Stamina sono argomenti che ho trattato
nei miei libri nel tema della sanità. In questa sede voglio parlare delle
tecnologie HYST e degli OGM, trattati nei miei libri nel tema delle frodi agro
alimentari.»
“L’Italia sfamerà il
Mondo grazie alla tecnica BioHyst. Gli scienziati italiani hanno scoperto un
nuovo metodo per ricavare farine proteiche dai sottoprodotti dell’industria
molitoria attraverso un processo di frammentazione degli scarti- scrive Anna
Germoni su “Panorama” – Nel mondo, 800 milioni di persone soffrono
di fame. In Italia da alcuni anni c’è una tecnologia, denominata Hyst, in grado
di valorizzare a fini alimentari i residui di attività agricole. A sperimentarlo
un’associazione onlus, Scienza per Amore, che conta 200 soci, ha la titolarità
del brevetto e un progetto internazionale, Bits of Future: food for all. Con
questa tecnologia si ricavano farine proteiche dai sottoprodotti dell’industria
molitoria, attraverso un processo di frammentazione degli scarti. Il ministero
della Salute, il 19 dicembre del 2012 ha dato «parere positivo alla produzione e
commercializzazione di integratore alimentare di vitamina B1, manganese e
fosforo prodotto con il sistema Hyst»; anche quello delle Politiche agricole il
18 dicembre del 2012 si è espresso favorevolmente «per la produzione e
commercializzazione di frumento prodotto da crusca». Sei paesi africani: Burkina
Faso, Camerun, Congo, Ruanda, Senegal, Somalia e Burundi, interessati a questa
tecnologia, hanno ottenuto l’ok dalla World Bank di Washington e della Banca
Africana di Sviluppo di Tunisi per installarla. L’impianto è stato sperimentato
da universitari e persone altamente qualificate che ne hanno attestato
l’efficacia Fra le certificazioni, quelle delle università de La Sapienza di
Roma, di Milano, la Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, l’Asl di Pavia,
Confindustria energia. Il macchinario, su cui girano miliardi di euro, viene
inghiottito da due filoni giudiziari. Da una parte i ministeri della Salute
e delle Politiche agricole, esprimono pareri favorevoli sulla validità e
potenzialità di tale impianto e della tecnologia che usa, dall’altra la polizia
municipale boccia l’utilità e l’adeguatezza del metodo Hyst. I soci della onlus
hanno chiesto il dissequestro alla Procura di Roma e che sia disposto incidente
probatorio al fine di testare l’efficacia di impianto e tecnologia alla presenza
di consulenti nominati dal giudice. Tali istanze sono state per ora rigettate,
impedendo agli indagati di smontare in concreto le accuse di vigili urbani e PM
di Roma. Chi ha titolo per valutare l’efficacia di una tecnologia, i dicasteri
competenti o la polizia municipale? I soci di una onlus che si autofinanzia
possono truffare se stessi? Chi ha interesse a bloccare questo impianto?” Si
chiede ancora Anna Germoni su “Panorama”.
“Tecnologia
Hyst: truffa o rivoluzione umanitaria? – Si chiede Patrizia Notarnicola su
“L’Indro”. – La tecnologia Hyst (Hypercritical Separation Technology) è un
sistema, inventato e perfezionato negli ultimi 40 anni dall’ingegnere Umberto
Manola, per trasformare scarti dell’industria alimentare (cruscame) e biomasse
agricole (ad esempio paglia e legno) in componenti per l’alimentazione umana,
per la zootecnica e per la produzione di biocarburanti. In poche parole, dagli
scarti si otterrebbero soprattutto farine alimentari a basso costo e senza alcun
impatto ambientale, con un grandissimo vantaggio per i Paesi più poveri.”
“Una setta? Forse solo
degli illusi che voglio fare arte e mettere a disposizione dei governi nuovi
strumenti tecnologici per sopperire alla carenza alimentare dei paesi più
poveri? Sta di fatto che l’associazione Scienza per l’Amore ha visto
sequestrati preventivamente entrambi i siti web dove promuovevano le loro
attività e progetti. Il Tribunale di Roma, con la Procura della Repubblica –
Direzione distrettuale antimafia, ha dato mandato alla Polizia locale di Roma
Capitale, con il suo Gruppo di elite sulla Sicurezza Sociale Urbana,
all’oscuramento in base al Proc. Pen. N. 13650/11 R.G.I.P. e il Proc. Pen. N.
25093/10 R.G.N.R., probabilmente perché sospettati di essere dei truffatori con
il voler contribuire alla crescita e al benessere dell’Africa, mettendo in grado
gli stessi africani di sfruttare al meglio le risorse locali, dove sono
endemiche le carenza alimentari ed energetiche – scrive Nero Penna – Il Progetto
Bits of Future: Food For All può lasciare alcuni per lo meno perplessi
sulla possibilità che un macchinario trasformi degli scarti in cibo, ma
sequestrare la loro vetrina senza specificarne le motivazioni. Bisogna diffidare
dei soci e simpatizzanti dell’associazione, e perché? Magari sono contagiosi ed
è consigliabile non stringere loro la mano. Sul sito veniva sbandierata
l’adesione di una serie di stati africani (Repubblica del Senegal, Governo di
Transizione della Repubblica Somala, Repubblica del Burkina Faso, Repubblica del
Camerun, Repubblica del Ruanda, Repubblica del Burundi, Repubblica del Congo
Brazzaville) al Progetto con lettere di ministri e rappresentanze diplomatiche.
Forse sono solo il frutto di millantato credito o come è spesso accade
un’occasione per dei governanti di fare un po’ di business?”
CHI HA PAURA DELL’OGM?
“«Ogm? L’unica cosa di
cui dovete aver paura è il terrorismo pseudo-scientifico che uccide il biotech»,
– scrive Emmanuele Michela su “Tempi” – Pierdomenico Perata, rettore della
Sant’Anna di Pisa, smonta tutte le leggende sugli organismi “giornalisticamente
modificati”. Ma ammette: «Purtroppo in questo campo chi fa disinformazione è più
abile di chi informa». Nel clima di sospetto che verte attorno ai cibi
transgenici la stampa ha giocato un ruolo chiave, e a Tempi Perata cerca
di fare luce sui tanti limiti e pericoli addebitati a questo genere di colture.
«Ai giornalisti piace inventare titoli a effetto. E così nascono anche leggende
che non esistono, come la “fragola-pesce”, o la storia che i semi Ogm sarebbero
sterili. Eppure, tra ricercatori, scienziati e biotecnologi il fronte sembra
compatto nel guardare con favore agli Ogm.»”
“Fino ad oggi un solo
coltivatore, a Vivaro in Friuli, aveva seminato mais ogm – su un piccolo
appezzamento di poco più di mezzo ettaro – fra proteste, denunce e mobilitazioni
di ambientalisti e soprattutto di contadini – scrive Jenner Meletti su “La
Repubblica” – Adesso invece una “Petizione pro mais transgenico Mon 810″ viene
firmata da oltre 600 imprenditori agricoli del mantovano (associati alla
Confagricoltura) e inviata alla Regione Lombardia.”
“Stessa biodiversità
campi ogm e non. Lo indica il primo studio sulle coltivazioni in Africa – scrive
“L’Ansa” – Il primo studio sui campi di mais geneticamente modificato (gm) in
Africa indica che la biodiversità degli insetti è uguale a quella presente nelle
colture tradizionali, sia per la varietà delle specie che per il numero di
individui. Condotto in Sudafrica e pubblicato sulla rivista Environmental
Entomology, il risultato si deve al gruppo di ricerca coordinato da Johnnie van
den Berg, della North-West University. I dati confermano quelli raccolti finora
dalle ricerche condotte in Cina, Spagna, e Stati Uniti su campi di riso, cotone
e mais gm. La biodiversità di un ecosistema agricolo, scrivono gli autori dello
studio, è importante non solo per il suo valore intrinseco, ma perché influenza
le funzioni ecologiche vitali per la produzione vegetale nei sistemi agricoli
sostenibili e nell’ambiente circostante. Una delle preoccupazioni più comuni in
merito alle colture geneticamente modificate è il potenziale impatto negativo
che potrebbero avere sulla diversità e l’abbondanza degli organismi che
ospitano, e successivamente sulle funzioni degli ecosistemi. Pertanto,
proseguono gli autori, è essenziale valutare il potenziale rischio ambientale di
queste colture e il loro effetto sulle specie. Tuttavia la valutazione
dell’impatto del granturco ogm sull’ecosistema è stata finora ostacolata dalla
mancanza di liste di controllo delle specie presenti nelle coltivazioni di mais.
Il primo obiettivo dello studio è stato quindi compilare una lista degli insetti
che popolano queste colture per confrontare la diversità e l’abbondanza nelle
coltivazioni ogm. In due anni in entrambi i campi considerati nella ricerca sono
stati censiti 8.771 insetti di 288 specie, fra decompositori, erbivori,
predatori, e parassiti. I dati indicano che, per quanto riguarda i campi di mais
in Sudafrica, ”la diversità di insetti nei sistemi agricoli ogm – sottolinea van
den Berg – è elevata come nei sistemi di agricoltura tradizionali”.”
“La comunicazione della
scienza nell’era dei social: emozionare o informare? – Si chiede Moreno
Colaiacovo su “I Mille” – Organismi geneticamente modificati, metodo Stamina,
sperimentazione animale: il dibattito pubblico su temi scientifici è più acceso
che mai. Incalzata dai media e dai gruppi di pressione, la politica si è trovata
ad affrontare – spesso con scarsi risultati – problemi complessi, in cui
l’aspetto scientifico e quello sociale si sono mescolati a tal punto da
risultare molte volte indistinguibili. E se alla classe politica possiamo
rimproverare di non aver affrontato razionalmente questi problemi, concedendo
troppo alla demagogia, d’altra parte non si può dire che la popolazione avesse
gli strumenti per valutare lucidamente le questioni che di volta in volta
venivano sollevate: raramente i media hanno scelto di spiegare, quasi sempre
hanno preferito scandalizzare, commuovere o spaventare. Impostare un dibattito
sui binari dell’emotività è il modo più semplice per muovere le coscienze,
soprattutto in un Paese come il nostro, dove la cultura scientifica è da sempre
trattata con supponenza e sospetto. Parte di questa strategia ha a che fare con
l’uso delle immagini. Puoi fare un discorso perfettamente logico e convincente,
puoi presentare numeri e tabelle, ma il castello della razionalità crolla
miseramente se dall’altra parte c’è un’immagine vincente. Con le immagini è
tutto più facile: basta una foto per far scattare a piacimento sentimenti come
la rabbia, l’indignazione, la paura, la pietà. E i tre temi menzionati
all’inizio di questo articolo, in effetti, hanno tutti un denominatore comune:
in tutti questi casi l’opinione pubblica è stata condizionata e plasmata anche
grazie all’uso di immagini forti. Immagini che passano in TV e sui giornali, ma
che diventano virali soprattutto sui social network, Facebook in particolare.
Nel caso degli OGM si è voluto spaventare. Basta cercare “OGM” su Google per
rendersene conto: le immagini neutrali o favorevoli agli organismi geneticamente
modificati sono una minima parte rispetto ai mostruosi fotomontaggi che hanno
accompagnato questa tecnologia fin dalla sua nascita. Pensiamo alla
fragola-pesce, una creatura mitologica che è ormai entrata a far parte
dell’immaginario collettivo. Una vera e propria leggenda metropolitana che si è
rivelata essere lo strumento perfetto per allontanare l’interlocutore dal
sentiero della razionalità e spingerlo verso le pulsioni più istintive, che ci
portano a fuggire da tutto ciò che è nuovo e sconosciuto, invitandoci ad
approdare al porto sicuro della tradizione e dei bei tempi andati.
Ovviamente non è mai esistita nessuna fragola-pesce, ma l’immagine era così
evocativa da resistere ancora oggi, a distanza di anni dalla sua comparsa sui
media. Cosa dire invece del metodo Stamina? Il caso è diventato di pubblico
dominio grazie alle Iene, il cui messaggio è passato in gran parte attraverso la
strumentalizzazione di immagini di bambini malati e sofferenti. Gli scienziati,
dal canto loro, hanno dovuto subire l’accusa infamante di essere persone
insensibili, fredde macchine razionali impossibili da scalfire persino con la
più straziante delle tragedie umane. Eppure è esclusivamente con la razionalità
e la lucidità che si può fare scienza, e trasformare le nuove conoscenze in
soluzioni terapeutiche concrete ed efficaci. Ma quando dall’altra parte c’è il
dolore di un bambino sbattuto in prima pagina (o in prima serata), qualunque
considerazione ancorché giusta svanisce istantaneamente. Infine, la questione
più scottante e attuale, quella relativa alla sperimentazione animale. Anche
qui, la battaglia tra le due fazioni (perché di guerra si tratta, in molti casi)
si è combattuta a suon di immagini. I movimenti animalisti hanno fatto
abbondante uso di fotografie terribili, con animali costretti a subire tremende
torture, ma non hanno disdegnato nemmeno sapienti fotomontaggi volti a
screditare quei ricercatori che avevano difeso pubblicamente l’utilità della
vivisezione (come viene impropriamente chiamata). Poco importa se le immagini
cruente di animali straziati non corrispondano alla realtà, almeno non qui in
Europa, e ancor meno importa il fatto che circa il 92% degli scienziati ritenga
che purtroppo non si possa fare a meno della sperimentazione animale. L’impatto
emotivo di quelle foto e di quei camici insanguinati è semplicemente devastante.
Le immagini sono uno strumento potentissimo all’interno di una discussione,
specie se gli interlocutori non sono molto informati sul tema. Spesso
raggiungono l’obiettivo, muovendo le masse verso una posizione piuttosto che
un’altra. E ad avvantaggiarsene sono stati anche coloro che stanno dalla parte
della scienza, come dimostra la recente vicenda di Caterina Simonsen, suo
malgrado divenuta nel giro di poche settimane una celebrità della rete. Il
coinvolgimento emotivo è un’arma micidiale, che può essere usato sia dagli
oppositori della scienza, sia da quelli che dovrebbero esserne i paladini. Ma è
davvero la strategia migliore? Dal punto di vista etico, sfruttare immagini di
persone sofferenti per portare avanti una causa non sembra certo il massimo
della correttezza. Tuttavia, non è a questo che mi riferisco, quanto piuttosto
all’efficacia di questo approccio nel lungo periodo. Le immagini scioccanti sono
perfette per orientare l’opinione pubblica in merito al singolo episodio (i
movimenti animalisti hanno obiettivamente accusato il colpo dopo la vicenda di
Caterina), ma hanno il difetto di mancare il bersaglio grosso, quello che un
amante della scienza dovrebbe considerare come l’obiettivo prioritario:
insegnare a valutare un problema in modo razionale, informandosi e pesando pro e
contro. In teoria, viviamo in una democrazia moderna, relativamente colta e
istruita. Dovremmo quindi smetterla di trattare le persone come un gregge da
guidare da una valle all’altra ogni volta che si presenta un nuovo argomento di
discussione. Oggi è la sperimentazione animale, domani potrebbe essere
qualcos’altro. La verità è che esiste soltanto una bussola che permette di
trovare sempre, in ogni circostanza, la via giusta: è la bussola del pensiero
critico, della logica e della corretta informazione. Educare le persone a usarla
le renderà cittadini liberi, e realmente consapevoli delle proprie opinioni.
Fare informazione corretta paga. Prendiamo ad esempio il recentissimo sondaggio
IPSOS sulla sperimentazione animale: la percentuale di favorevoli saliva dal 49%
al 57% se agli intervistati venivano fornite informazioni di base
sull’argomento. In modo analogo, all’ultimo Festival della Letteratura di
Mantova, il ricercatore Dario Bressanini e la giornalista Beatrice Mautino erano
riusciti a vincere un confronto Oxford-style sul tema degli OGM, convincendo
molti scettici a passare dalla loro parte. Comunicare la scienza in modo pacato,
chiaro e oggettivo rimane ancora la strategia vincente. Anche nell’era di
Twitter e Facebook.”
CHI HA PAURA DELLE
NUOVE TECNOLOGIE: HYST ED OGM?
CHI HA PAURA DELLA
TECNOLOGIA HYST PER SFAMARE IL MONDO?
Quando la
carestia sarà un ricordo,
scrive Nero Penna. Una setta? Forse solo degli illusi che voglio fare arte e
mettere a disposizione dei governi nuovi strumenti tecnologici per sopperire
alla carenza alimentare dei paesi più poveri? Sta di fatto che l’associazione
Scienza per l’Amore ha visto sequestrati preventivamente entrambi i siti web
dove promuovevano le loro attività e progetti. Il Tribunale di Roma, con la
Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia, ha dato mandato
alla Polizia locale di Roma Capitale, con il suo Gruppo di elite sulla Sicurezza
Sociale Urbana, all’oscuramento in base al Proc. Pen. N. 13650/11 R.G.I.P. e il
Proc. Pen. N. 25093/10 R.G.N.R., probabilmente perché sospettati d essere dei
truffatori con il voler contribuire alla crescita e al benessere dell’Africa,
mettendo in grado gli stessi africani di sfruttare al meglio le risorse locali,
dove sono endemiche le carenza alimentari ed energetiche. Lo strumento per
realizzare questi obiettivi è la tecnologia Hyst, che consente di impiegare a
fini alimentari ed energetici qualsiasi scarto proveniente dalle lavorazioni
agricole. Si produrranno così farine per alimentazione umana, zootecnica ed
energia pulita. L’Hyst è un sistema innovativo che anticipa quello che, nelle
pubblicazioni scientifiche del settore, si auspica di realizzare fra 10-20 anni.
Una tecnologia che trasforma gli scarti di cereali e frutta in prodotto
alimentare appare molto simile al sottoporsi a una cura staminale con cellule
trattate in ambiente difficilmente ritenuto sterile. Il Progetto Bits of
Future: Food For All lascia per lo meno perplessi sulla possibilità che un
macchinario trasformi degli scarti in cibo, ma sequestrare la loro vetrina senza
specificarne le motivazioni. Bisogna diffidare dei soci e simpatizzanti
dell’associazione, e perché? Magari sono contagiosi ed è consigliabile non
stringere loro la mano. Sul sito veniva sbandierata l’adesione di una serie di
stati africani (Repubblica del Senegal, Governo di Transizione della Repubblica
Somala, Repubblica del Burkina Faso, Repubblica del Camerun, Repubblica del
Ruanda, Repubblica del Burundi, Repubblica del Congo Brazzaville) al Progetto
con lettere di ministri e rappresentanze diplomatiche. Forse sono solo il frutto
di millantato credito o come è spesso accade un’occasione per dei governanti di
fare un po’ di business? L’Ifad (Fondo Internazionale per la Sviluppo Agricolo)
interpellato sull’essere a conoscenza del progetto Bits of Future: Food for
All ha risposto chiarendo le competenze dell’organizzazione impegnata nello
sviluppo agricolo e ha tenuto a chiarire che la Fao (Food and Agriculture
Organization of the United Nations: Employment) potrebbe rispondere. Mentre alle
richieste inviate alla Fao di essere a conoscenza del progetto e confermare un
loro interesse non è a tutt’oggi giunto alcun commento. Come non ha fatto
seguito alcuna risposta con il Wfp (Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni
Unite).
L'Italia
sfamerà il Mondo grazie alla tecnica BioHyst.
Gli scienziati italiani hanno scoperto un nuovo metodo per ricavare farine
proteiche dai sottoprodotti dell’industria molitoria attraverso un processo di
frammentazione degli scarti, scrive Anna Germoni su
“Panorama”.
Nel mondo, 800 milioni di persone soffrono di fame. In Italia da alcuni anni c’è
una tecnologia, denominata Hyst, in grado di valorizzare a fini alimentari i
residui di attività agricole. A sperimentarlo un’associazione onlus, Scienza per
Amore, che conta 200 soci, ha la titolarità del brevetto e un progetto
internazionale, Bits of Future: food for all. Con questa tecnologia si ricavano
farine proteiche dai sottoprodotti dell’industria molitoria, attraverso un
processo di frammentazione degli scarti. L’ingegnere Pier Paolo Dell’Omo,
presidente della onlus, nonché ricercatore del dipartimento di ingegneria
astronautica, elettrica ed energetica de La Sapienza di Roma dice: «Con un
chilo di pula prodotta dalle riserie, che costa 15 centesimi di euro, si
producono 40 dosi di integratori, prodotti ideali per ovviare ai deficit
proteici sulla malnutrizione». Il ministero della Salute, il 19 dicembre del
2012 ha dato «parere positivo alla produzione e commercializzazione di
integratore alimentare di vitamina B1, manganese e fosforo prodotto con il
sistema Hyst»; anche quello delle Politiche agricole il 18 dicembre del 2012 si
è espresso favorevolmente «per la produzione e commercializzazione di frumento
prodotto da crusca». Sei paesi africani: Burkina Faso, Camerun, Congo, Ruanda,
Senegal, Somalia e Burundi, interessati a questa tecnologia, hanno ottenuto l’ok
dalla World Bank di Washington e della Banca Africana di Sviluppo di Tunisi per
installarla. L’impianto è stato sperimentato da universitari e persone altamente
qualificate che ne hanno attestato l’efficacia Fra le certificazioni, quelle
delle università de La Sapienza di Roma, di Milano, la Cattolica del Sacro Cuore
di Piacenza, l’Asl di Pavia, Confindustria energia. Il dottor Vito Pignatelli,
responsabile del coordinamento tecnologie biomasse e bioenergie per le fonti
rinnovali dell’Enea, interpellato da Panorama sull’efficacia dell’impianto
risponde: «Da quel che ho avuto modo di vedere, e dai documenti che riportano i
risultati delle prove effettuate presso laboratori universitari, la tecnologia
in esame presenta indubbiamente interessanti potenzialità. Migliora la qualità
nutrizionale delle farine ottenute dalla macinazione dei cereali. Poi è chiaro
che, utilizzando la capacità degli impianti, si può pensare ad un uso degli
stessi per ottenere un’elevata produzione di biogas anche da biomasse ricche di
zuccheri non fermentiscibili, come sono appunto le paglie, o, in prospettiva,
per la produzione di etanolo di seconda generazione. E con ulteriori prove
sperimentali, sarà certamente in grado di dimostrare tutte le sue potenzialità,
anche nel campo della bioenergia». Panorama ha consultato un altro
parere, quello dell’ingegnere Franco Del Manso, responsabile dei rapporti
internazionali ambientali e tecnici dell’Unione petrolifera, che riferisce: «Nel
campo dei biocarburanti abbiamo individuato nella tecnologia BioHyst una delle
possibili risposte all’esigenza di trasformare residui delle lavorazioni
agricole in biometano per l’impiego nel settore dei trasporti. Sulla base dei
risultati preliminari che ci sono stati forniti dai tecnici che hanno sviluppato
la tecnologia, l'Unione Petrolifera e le società ad essa associate, sono molto
interessate alla verifica di tali risultati con sperimentazioni ad hoc da
effettuarsi con prove su strada. Il biometano prodotto con questa tecnologia è
configurabile come biocarburante di seconda generazione, cui viene riconosciuto
un valore energetico doppio e dunque faciliterebbe il raggiungimento degli
obblighi di miscelazione dei biocarburanti». Ma l’impianto è fermo, posto sotto
sequestro dalla Procura di Roma dal marzo 2011 per indagini della polizia
municipale capitolina, nei confronti sia di alcuni soci finanziatori della onlus
con l’ipotesi di reato di associazione a delinquere e truffa nei confronti degli
altri associati, sia dell’ideatore di tale progetto di cooperazione, sotto
processo a Tivoli per presunti abusi sessuali su due minori e per aver
“inventato” il metodo Hyst al fine di spillare soldi agli associati. Il
macchinario, su cui girano miliardi di euro, viene inghiottito da due filoni
giudiziari. Da una parte i ministeri della Salute e delle Politiche
agricole, esprimono pareri favorevoli sulla validità e potenzialità di tale
impianto e della tecnologia che usa, dall’altra la polizia municipale boccia
l’utilità e l’adeguatezza del metodo Hyst. I soci della onlus hanno chiesto il
dissequestro alla Procura di Roma e che sia disposto incidente probatorio al
fine di testare l’efficacia di impianto e tecnologia alla presenza di consulenti
nominati dal giudice. Tali istanze sono state per ora rigettate, impedendo agli
indagati di smontare in concreto le accuse di vigili urbani e PM di Roma. Chi ha
titolo per valutare l’efficacia di una tecnologia, i dicasteri competenti o la
polizia municipale? I soci di una onlus che si autofinanzia possono truffare se
stessi? Chi ha interesse a bloccare questo impianto?
Tecnologia Hyst: truffa
o rivoluzione umanitaria? Si chiede Patrizia Notarnicola su “L’Indro”.
Intervista con Daniele Lattanzi, responsabile Business Development Manager di
BioHyst. La tecnologia Hyst (Hypercritical Separation Technology) è un sistema,
inventato e perfezionato negli ultimi 40 anni dall'ingegnere Umberto Manola, per
trasformare scarti dell'industria alimentare (cruscame) e biomasse agricole (ad
esempio paglia e legno) in componenti per l'alimentazione umana, per la
zootecnica e per la produzione di biocarburanti. In poche parole, dagli scarti
si otterrebbero soprattutto farine alimentari a basso costo e senza alcun
impatto ambientale, con un grandissimo vantaggio per i Paesi più poveri. A
questo risultato rivoluzionario si arriva, secondo il suo inventore, con l'uso
di una sola macchina, capace di separare i componenti della materia prima e di
provocare l’urto, ad alta velocità e con forti correnti d’aria, delle particelle
di biomassa. In questo modo amido e proteine, importantissimi per
l’alimentazione umana, vengono isolati dalla parte fibrosa, che invece non è
digeribile dall’uomo. Della validità scientifica di questa ricerca, che è
finanziata dall’associazione 'Scienza per Amore',ci occuperemo in una seconda
puntata della nostra inchiesta. Ci interessa intanto capire perché sul
Presidente di questa associazione, Danilo Speranza, siano cadute come un
macigno pesantissime accuse nell’ambito di due procedimenti penali diversi:
truffa da un lato, abusi sessuali su due minori dall’altro. Per cercare di
saperne di più, abbiamo intervistato Daniele Lattanzi, membro di Scienza per
amore e responsabile Business Development Manager di BioHyst.
A che punto è la
ricerca per l’applicazione della tecnologia Hyst?
«Al momento abbiamo
operato su due installazioni pilota per testarla insieme al suo inventore,
l’ing. Manola. Tuttavia i due impianti in questione (ndr. San Giuseppe di
Comacchio e a Chignolo Po, in provincia di Pavia) sono sotto sequestro
dell’autorità giudiziaria per ragioni probatorie.»
Perché nel 2011 è
scattato il sequestro?
«Per valutarne il
funzionamento e i risultati. Contro Danilo Speranza è stato avviato un
procedimento penale per truffa. È stato accusato di millantare la validità della
tecnologia per estorcere denaro agli altri associati di “Scienza per amore”. Chi
ha sollevato le accuse, pur non avendo prove scientifiche, sostiene che gli
impianti producevano sostanze velenose. Siamo ancora in fase di indagini
preliminari. Una prima perizia tecnica, disposta dal pm, ha dato riscontro alle
valutazioni precedentemente condotte dall’Università di Milano a nostro
vantaggio.»
Prima ancora, nel
2010, Speranza, ex maestro di yoga, è stato arrestato a Roma per abusi sessuali
su minori. Oggi è agli arresti domiciliari. Ma chi è Danilo Speranza e che
relazione ha con la tecnologia Hyst?
«Danilo Speranza si
occupa da anni di progetti filantropici. Circa 20 anni fa ha incontrato l’ing.
Manola e ha inizialmente finanziato da solo il progetto, come persona fisica.
Poi ha proposto all’associazione di dare un secondo finanziamento ma in maniera
molto libera. In questo modo si voleva dare una prospettiva diversa alla
tecnologia. Questo accadeva agli inizi degli anni ’90. L’associazione si
chiamava ancora R.e. Maya.»
Perché
l’associazione R.e. Maya, accusata di essere una setta, ha cambiato nome in
“Scienza per amore” dopo l’arresto?
«L’associazione ha
voluto prendere le distanze dalle accuse degli ex associati di R.e. Maya. Il
boom mediatico aveva imposto un rifacimento della comunicazione del progetto
Hyst. In questo modo abbiamo voluto tutelare sia la tecnologia sia coloro che
l’hanno finanziata e portata avanti.»
Quanti sono oggi
gli associati di “Scienza per amore”?
«Circa 200, tutti su
Roma».
Nessuno tra voi ha
voluto prendere le distanze da Speranza?
«Le accuse che hanno
colpito Speranza riguardavano fatti di cui gli associati non potevano avere
notizia o riscontro oggettivo. Il percorso seguito per la tecnologia Hyst è
sempre stato alla luce del giorno e a conoscenza di tutti.»
Dalle nostre
indagini (ndr. riscontri della Polizia Giudiziaria di Roma) risulta che alcuni
ex associati si sono sentiti raggirati e plagiati dallo Speranza. Non temete che
entrambi i procedimenti penali in corso compromettano l’attendibilità del vostro
progetto?
«Credo che questo sia
l’ obiettivo di chi ha fatto la denuncia: screditare il promotore e gettare
fango sull’associazione chiamandola “setta”, in modo da adombrare il progetto.
Ma contro la tecnologia Hyst non è stato portato uno straccio di prova
scientifica. La tecnologia è stata invece valutata positivamente dall’università
di Milano, dall’università La Sapienza di Roma, dall’Enea. Abbiamo avuto
riscontro dal ministero della Salute e dal ministero delle politiche agricole.»
Che rapporti ci sono
tra la vostra associazione e l’inventore Manola in questo momento?
«Manola ci ha ceduto i
diritti sulla sua invenzione. Con lui in questo momento abbiamo rapporti
marginali.»
Avete contatti con
i Governi africani in cui vorreste esportare la vostra tecnologia?
«Abbiamo esposto il
progetto al vicepresidente della banca Africana di Sviluppo , il professor
Mthuli Ncube, e su sua iniziativa, lo abbiamo presentato a Tunisi a tutto il suo
staff. Abbiamo riscontri da parte di moltissimi governi africani, come Congo
Brazzaville, Burundi, Senegal, Somalia, Rwanda e Camerun. Il nostro è un
progetto commerciale attraverso il quale intendiamo reperire risorse per un
progetto di cooperazione internazionale. Il nostro fine è dare a questo Paesi
gli strumenti sia per lavorare sia per produrre da soli quanto necessario per
una esistenza dignitosa.»
CHI HA PAURA
DELL’OGM?
Ruminano
tranquille, nella grande stalla, le 140 vacche dell'azienda Lasagna. La campagna
mantovana è la più grande "fabbrica" italiana di formaggi e di carne.
Cinquecentomila vacche da latte, 1,3 milioni di maiali, 150.000 bovini da carne.
Tutti animali nutriti soprattutto a mais e soia. Ed è proprio in questa enorme
fabbrica (dove vengono lavorati parmigiano e grana padano, cosce per il
prosciutto di Parma e per il San Daniele, bistecche e braciole per macellerie e
supermercati) che si spacca la linea Maginot dei contadini italiani, fino ad
oggi uniti e compatti contro gli ogm, organismi geneticamente modificati, scrive
Jenner Meletti su “La Repubblica”.
Fino ad oggi un solo coltivatore, a Vivaro in Friuli, aveva seminato mais ogm -
su un piccolo appezzamento di poco più di mezzo ettaro - fra proteste, denunce e
mobilitazioni di ambientalisti e soprattutto di contadini. Adesso invece una
"Petizione pro mais transgenico Mon 810" viene firmata da oltre 600 imprenditori
agricoli del mantovano (associati alla Confagricoltura) e inviata alla Regione
Lombardia. "Noi non vogliamo fare la guerra a nessuno" racconta il presidente
Lasagna. "Vogliamo una discussione laica, senza ideologie. Vogliamo una ricerca
scientifica - fatta dalle università, non dalla Monsanto - che dia risposte
precise. Gli ogm sono già nel nostro Paese. Il 90% della soia mangiata dai
nostri animali è geneticamente modificata, come il 40% del mais.
Stessa
biodiversità campi ogm e non.
Lo indica il primo studio sulle coltivazioni in Africa, scrive “L’Ansa”. Il
primo studio sui campi di mais geneticamente modificato (gm) in Africa indica
che la biodiversità degli insetti è uguale a quella presente nelle colture
tradizionali, sia per la varietà delle specie che per il numero di individui.
Condotto in Sudafrica e pubblicato sulla rivista Environmental Entomology, il
risultato si deve al gruppo di ricerca coordinato da Johnnie van den Berg, della
North-West University. I dati confermano quelli raccolti finora dalle ricerche
condotte in Cina, Spagna, e Stati Uniti su campi di riso, cotone e mais gm. La
biodiversità di un ecosistema agricolo, scrivono gli autori dello studio, è
importante non solo per il suo valore intrinseco, ma perché influenza le
funzioni ecologiche vitali per la produzione vegetale nei sistemi agricoli
sostenibili e nell'ambiente circostante. Una delle preoccupazioni più comuni in
merito alle colture geneticamente modificate è il potenziale impatto negativo
che potrebbero avere sulla diversità e l'abbondanza degli organismi che
ospitano, e successivamente sulle funzioni degli ecosistemi. Pertanto,
proseguono gli autori, è essenziale valutare il potenziale rischio ambientale di
queste colture e il loro effetto sulle specie. Tuttavia la valutazione
dell'impatto del granturco ogm sull'ecosistema è stata finora ostacolata dalla
mancanza di liste di controllo delle specie presenti nelle coltivazioni di mais.
Il primo obiettivo dello studio è stato quindi compilare una lista degli insetti
che popolano queste colture per confrontare la diversità e l'abbondanza nelle
coltivazioni ogm. In due anni in entrambi i campi considerati nella ricerca sono
stati censiti 8.771 insetti di 288 specie, fra decompositori, erbivori,
predatori, e parassiti. I dati indicano che, per quanto riguarda i campi di mais
in Sudafrica, ''la diversità di insetti nei sistemi agricoli ogm - sottolinea
van den Berg - è elevata come nei sistemi di agricoltura tradizionali''.
«Ogm? L’unica cosa di cui dovete aver
paura è il terrorismo pseudo-scientifico che uccide il biotech»,
scrive Emmanuele Michela su “Tempi”. Pierdomenico Perata, rettore della
Sant’Anna di Pisa, smonta tutte le leggende sugli organismi “giornalisticamente
modificati”. Ma ammette: «Purtroppo in questo campo chi fa disinformazione è più
abile di chi informa». Si potrebbe parlare di Ogm partendo da Eric-Gilles
Séralini, il ricercatore francese che nel novembre 2012 aveva dimostrato che un
certo mais transgenico induceva tumori, salvo poi
essere scaricato dalla Food and Chemical Toxicology, rivista che a inizio
dicembre ha ritirato lo studio in oggetto per evidenti lacune metodologiche.
Oppure, si potrebbe ricordare la posizione statuaria dell’Italia di fronte alle
biotecnologie, che sul nostro territorio non possono essere usate per coltivare.
O ancora, si potrebbe guardare all’Expo 2015, evento che verterà attorno alla
nutrizione del mondo, tema che però gli ambientalisti vorrebbero ridurre solo al
biologico e alle pratiche agricole minimaliste, escludendo gli sviluppi più
freschi del settore agroalimentare. Tutte tematiche che lasciano intendere
quanto sia urgente un dibattito non ideologizzato sull’argomento: «Ma purtroppo
chi fa disinformazione in questo campo è più abile di chi invece fa
informazione». C’è fastidio e rassegnazione nelle parole di Pierdomenico Perata,
docente ordinario di Fisiologia vegetale e ricercatore nel settore delle
biotecnologie, e dalla scorsa primavera rettore della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa (ha preso il posto di Maria Chiara Carrozza, diventata ministro
dell’Istruzione). Sorride al ricordo di quel soprannome con cui la scienza
motteggia l’atteggiamento molto scoopistico con cui i media guardano agli Ogm:
organismi giornalisticamente modificati. Nel clima di sospetto che verte attorno
ai cibi transgenici la stampa ha giocato un ruolo chiave, e a
Tempi Perata cerca di fare luce sui tanti
limiti e pericoli addebitati a questo genere di colture.
«Ai giornalisti piace inventare titoli a effetto.
E così nascono anche leggende che non esistono, come la “fragola-pesce”, o la
storia che i semi Ogm sarebbero sterili».
Eppure, tra
ricercatori, scienziati e biotecnologi il fronte sembra compatto nel guardare
con favore agli Ogm.»
«Tutte
le accademie scientifiche nazionali hanno preso posizione: non esiste un
problema Ogm a livello scientifico. Ormai non sono considerati una minaccia per
la salute delle persone o dell’ambiente, su questo proprio non c’è più
dibattito. Può starci invece la considerazione che a ciò debba fare seguito una
liberalizzazione del commercio di questi prodotti, ma non si capisce perché la
politica deve offrire pseudo-ragioni scientifiche per supportare la propria
obiezione agli Ogm, e non possa usare invece argomentazioni politiche. È
scorretto trasmettere un’immagine di pericolo all’opinione pubblica per
giustificare queste scelte politiche. Forse a livello economico non conviene
aprire agli Ogm, o forse sì, però sta qui il punto del dibattito.»
A fine novembre sul
Corriere della Sera gli accademici dei Lincei lanciavano l’allarme: il no
italiano agli Ogm mette in pericolo l’economia italiana.
«Sì,
e il primo danno è per gli agricoltori: molti, specie nel nord Italia, dicono
che coltivare Ogm sarebbe un grande vantaggio per loro. D’altronde, c’è un
motivo per cui alcuni organismi geneticamente modificati, penso al mais Bt o
alla soia, hanno avuto un enorme successo a livello planetario. Non vengono
attaccati dagli insetti, consentono pratiche agricole più agevoli. Impedire ai
nostri agricoltori di sfruttare queste tecnologie significa metterli in una
posizione di inferiorità competitiva rispetto a quelli degli altri paesi. Il
fatto che la soia è comunque necessaria per l’alimentazione del bestiame,
innesta un corto circuito: in Italia non coltiviamo quella transgenica, ma alla
fine la importiamo per darla ai nostri maiali.
È abbastanza stupido. Preoccupanti sono poi le previsioni sul lungo periodo.»
In che senso?
«La
ricerca biotech in Italia è ormai inesistente, non è più finanziata. Il nostro
paese ha ancora delle competenze residuali rimaste dall’ultimo decennio, ma
nell’arco di 10-20 anni perderemo tutto e saremo totalmente inermi di fronte
alle nuove tecnologie transgeniche portate avanti da altre nazioni. Non solo non
saremo più in grado di proporle noi italiani, ma non saremo neanche in grado di
valutare quelle che ci verranno proposte. Non si vuole comprendere che il
progresso di questo settore è talmente veloce che nell’arco di uno o due decenni
avremo tecnologie di modifica delle piante totalmente diverse da quelle odierne:
il nostro paese non avrà altra scelta se non adottarle. Da acquirente però, non
da venditore.»
Parliamo dello
studio di Séralini ritirato dalla rivista Food and Chemical Toxicology.
Come spiega questo stop?
«La
storia della pubblicazione di Séralini è un pasticcio combinato in prevalenza
dalla rivista. È abbastanza inusuale che un articolo venga ritirato su basi che
avrebbero giustificato una non accettazione dello stesso all’origine. Spesso è
stato criticato proprio sul piano metodologico, la retraction di oggi sembra un
goffo tentativo per rimediare all’errore precedente. Vorrei poi ricordare una
cosa: ciò che scrive un ricercatore su una rivista scientifica non rappresenta
la verità, ma rappresenta un punto di vista basato più o meno su risultati
scientifici. Ciò che conta è l’opinione che la comunità scientifica ha di quei
risultati, e la verifica degli stessi col tempo. Un lavoro come quello di
Séralini ha richiesto anni, per cui servirà tempo perché ricercatori
indipendenti lo verifichino. Rimandando quindi il giudizio su questo studio, ciò
che risulta bizzarro è che un singolo lavoro è riuscito a determinare posizioni
politiche sugli Ogm. A differenza di altri temi come il cambiamento climatico,
sulle colture transgeniche la politica decide in base all’opinione del 5 per
cento dei ricercatori, ignorando i migliaia di articoli che invece mostrano
quanto innocue siano queste coltivazioni.»
Per quanto riguarda
l’Expo, come giudica questa paura nei confronti degli organismi geneticamente
modificati? Teme che questo possa ritardare gli investimenti di espositori
stranieri?
«Non
lo so, non sono convinto che l’Expo avrebbe avuto dalle multinazionali del
transgenico delle iniezioni di liquidità così consistenti. Si può credere a un
contrasto dell’Europa (non solo dell’Italia) agli Ogm anche a causa dell’origine
di queste tecnologie, prevalentemente americane. Come se ci fosse un
protezionismo, magari anche giustificato: siccome gli Ogm sono nelle mani delle
multinazionali americane, perché dovremmo dargli spazio? È anche vero, però, che
l’Europa fin qui ha giocato malissimo: vi sono realtà importanti dell’industria
tedesca, come la Basf che ha spostato all’estero tutta la sua ricerca biotech.
Quindi il nostro continente perde tanto in ricerca quanto in aziende, e da
questo punto di vista l’Expo può essere un’occasione per dibattere di colture
transgeniche. Purtroppo non so se verrà fatto. Temo invece che ci sarà offerta
una visione più bucolica dell’agricoltura, non industriale. Un’agricoltura che
esiste solo nella testa degli italiani, quella secondo cui nel secolo scorso si
coltivava meglio di oggi, cosa ovviamente non vera.»
Ma un evento
simile dedicato al cibo può permettersi di chiudere totalmente gli occhi davanti
a queste innovazioni?
«Il mio timore è che l’Expo diventi
un’occasione persa per affrontare uno dei temi principali della nutrizione,
ossia la mancanza di cibo in una quota considerevole del mondo. Nei prossimi
cinquant’anni la popolazione aumenterà, e con essa la carenza alimentare, specie
nei paesi dove già non si è in grado di sfamare la gente. Senza un dibattito su
ciò, l’Expo rischia di diventare una vetrina delle eccellenze agroalimentari
solo dei paesi ricchi. Non so se sarà così, se lo fosse sarebbe un grave errore.»
Ma siamo sicuri che
lo sviluppo degli Ogm possa davvero ridurre i problemi di nutrizione nel mondo?
In fondo, la fame è dovuta alla povertà, non alla carenza di risorse alimentari.
«Nei
paesi poveri la fame dipende dal fatto che la produzione agricola non è in grado
di soddisfare la richiesta interna, figuriamoci se sono in grado di acquistarne
altrove. Ma se la produttività agricola degli stati sviluppati è già al massimo,
in quelli poveri c’è una potenzialità enorme, ed è qui che serve l’utilizzo di
tutte le tecnologie. Gli Ogm sono incidentalmente la meno costosa: è più facile
ed economico sviluppare una pianta resistente agli insetti piuttosto che
comprare e distribuire l’antiparassitario. Per quest’ultimo servono trattori,
macchinari e competenza, per gli Ogm basta sapere piantare. Il loro alto costo è
legato alle procedure di registrazione: è la burocrazia a renderli onerosi. E
bisogna aggiungere che la questione delle sementi è un falso problema: i semi
sterili non esistono. Al massimo possiamo dire che qualunque mais coltivato in
Italia è ibrido: dai suoi semi si ottiene la segregazione dei diversi caratteri
presenti nella pianta, e in questo modo ciò che nascerà sorà diverso da ciò che
abbiamo seminato in origine. Ma questo accade con tutti i moderni ibridi, non
solo con gli Ogm.»
In questo modo,
però, se vuole ottenere piante commerciabili, l’agricoltore è obbligato a
rivolgersi all’azienda da cui ha acquistato le sementi: è la tanto contestata
brevettatura dei semi.
«Ma
l’agricoltore è già vincolato alle aziende. I coltivatori della Pianura Padana
comprano i semi dalle multinazionali americane e se vogliono una determinata
produttività devono rimanere legati a quell’azienda. Se volessero utilizzare i
semi prodotti dalla pianta non ci sarebbero problemi per le multinazionali. E
per gli agricoltori? Semplicemente raccoglierebbero prodotti diversi, proprio
per la segregazione dei caratteri.»
Un altro punto
contestato è che queste colture porterebbero alla perdita progressiva delle
tipicità di casa nostra.
«Sfido
chiunque a dire che soia e mais sono prodotti tipici italiani. Sono specie che
vengono da altri continenti (America e Asia), non vedo in che modo il mais Ogm
può colpire la tipicità italiana. Se andiamo invece su altre colture bisogna
fare un discorso a sé. Il pomodoro San Marzano, ad esempio, non lo coltiva più
nessuno perché è terribilmente suscettibile ai virus. È stato soppiantato da
altre varietà non transgeniche, prodotte da multinazionali non italiane.
Attualmente il pomodoro da industria, il perino, non è più San Marzano. Non c’è
bisogno di evocare gli Ogm per ipotizzare una perdita di agrobiodiversità, che
invece è insita nel concetto di agricoltura: da sempre varietà meno produttive
sono sostituite con varietà più produttive.»
È possibile che gli
Ogm vengano incontro a queste varietà italiane, come accaduto con la papaya
delle Hawaii, salvata proprio con colture transgeniche?
«Potrebbero
sicuramente. Ad esempio, alcuni centri di ricerca della zona di Napoli avevano
proprio pensato a un pomodoro San Marzano resistente ai virus, che quindi
potesse essere coltivato senza problemi. Ma in Italia non si possono coltivare
gli Ogm, e quindi lo studio non ha avuto futuro.»
Perché la scienza fa
così fatica a comunicare con l’opinione pubblica italiana?
«Perché
il ricercatore, purtroppo, tende ad adottare nella comunicazione lo stesso
rigore metodologico che segue nel fare ricerca. E quindi di fronte alla domanda:
«Gli Ogm fanno bene o fanno male?», l’attivista risponde: «Fanno male», lo
scienziato inizia a fare dei distinguo, e a quel punto la comunicazione è già
persa. E così il timore arriva alla gente, dove c’è un’innegabile paura di quel
che si mangia: probabilmente l’uomo è arrivato fino a oggi perché ha sempre
avuto paura di cibarsi di ciò che non conosceva. E mentre siamo pronti a
comprare un nuovo modello di cellulare perché su queste tecnologie non abbiamo
alcuna diffidenza, nei confronti del cibo abbiamo invece migliaia di anni di
evoluzione che ci hanno educato a diffidare dei prodotti che non conosciamo.»
E gli agricoltori?
Come guardano agli Ogm? Da una parte la Coldiretti è sempre rigida nel suo no,
dall’altra ci sono coltivatori come Silvano Dalla Libera e gli altri di
Futuragra, apertissimi alle innovazioni…
«Bisognerebbe
chiedere a questi agricoltori cosa coltivano. Se seminano mais è probabile che
siano a favore degli Ogm, se coltivano pomodori non gli costa nulla essere
contro, dato che non ci sono pomodori geneticamente modificati in commercio.
Probabilmente sta anche qui l’origine della posizione della Coldiretti: i loro
agricoltori sono coltivatori di mais o no? Oggi in Italia la questione Ogm
riguarda mais e soia, nient’altro. Mi chiedo quante di queste posizioni
riflettono gli interessi dei propri associati.»
La comunicazione della scienza nell’era
dei social: emozionare o informare? Si chiede Moreno
Colaiacovo su “I Mille”. Organismi geneticamente modificati, metodo Stamina,
sperimentazione animale: il dibattito pubblico su temi scientifici è più acceso
che mai. Incalzata dai media e dai gruppi di pressione, la politica si è trovata
ad affrontare – spesso con scarsi risultati – problemi complessi, in cui
l’aspetto scientifico e quello sociale si sono mescolati a tal punto da
risultare molte volte indistinguibili. E se alla classe politica possiamo
rimproverare di non aver affrontato razionalmente questi problemi, concedendo
troppo alla demagogia, d’altra parte non si può dire che la popolazione avesse
gli strumenti per valutare lucidamente le questioni che di volta in volta
venivano sollevate: raramente i media hanno scelto di spiegare, quasi sempre
hanno preferito scandalizzare, commuovere o spaventare. Impostare un dibattito
sui binari dell’emotività è il modo più semplice per muovere le coscienze,
soprattutto in un Paese come il nostro, dove la cultura scientifica è da sempre
trattata con supponenza e sospetto. Parte di questa strategia ha a che fare con
l’uso delle immagini. Puoi fare un discorso perfettamente logico e convincente,
puoi presentare numeri e tabelle, ma il castello della razionalità crolla
miseramente se dall’altra parte c’è un’immagine vincente. Con le immagini è
tutto più facile: basta una foto per far scattare a piacimento sentimenti come
la rabbia, l’indignazione, la paura, la pietà. E i tre temi menzionati
all’inizio di questo articolo, in effetti, hanno tutti un denominatore comune:
in tutti questi casi l’opinione pubblica è stata condizionata e plasmata anche
grazie all’uso di immagini forti. Immagini che passano in TV e sui giornali, ma
che diventano virali soprattutto sui social network, Facebook in particolare.
Nel caso degli OGM si è voluto spaventare. Basta cercare “OGM” su Google per
rendersene conto: le immagini neutrali o favorevoli agli organismi geneticamente
modificati sono una minima parte rispetto ai mostruosi fotomontaggi che hanno
accompagnato questa tecnologia fin dalla sua nascita. Pensiamo alla
fragola-pesce, una creatura mitologica che è ormai entrata a far parte
dell’immaginario collettivo. Una vera e propria leggenda metropolitana che si è
rivelata essere lo strumento perfetto per allontanare l’interlocutore dal
sentiero della razionalità e spingerlo verso le pulsioni più istintive, che ci
portano a fuggire da tutto ciò che è nuovo e sconosciuto, invitandoci ad
approdare al porto sicuro della tradizione e dei bei tempi andati.
Ovviamente non è mai esistita nessuna fragola-pesce, ma l’immagine era così
evocativa da resistere ancora oggi, a distanza di anni dalla sua comparsa sui
media. Cosa dire invece del metodo Stamina? Il caso è diventato di pubblico
dominio grazie alle Iene, il cui messaggio è passato in gran parte attraverso la
strumentalizzazione di immagini di bambini malati e sofferenti. Gli scienziati,
dal canto loro, hanno dovuto subire l’accusa infamante di essere persone
insensibili, fredde macchine razionali impossibili da scalfire persino con la
più straziante delle tragedie umane. Eppure è esclusivamente con la razionalità
e la lucidità che si può fare scienza, e trasformare le nuove conoscenze in
soluzioni terapeutiche concrete ed efficaci. Ma quando dall’altra parte c’è il
dolore di un bambino sbattuto in prima pagina (o in prima serata), qualunque
considerazione ancorché giusta svanisce istantaneamente. Infine, la questione
più scottante e attuale, quella relativa alla sperimentazione animale. Anche
qui, la battaglia tra le due fazioni (perché di guerra si tratta, in molti casi)
si è combattuta a suon di immagini. I movimenti animalisti hanno fatto
abbondante uso di fotografie terribili, con animali costretti a subire tremende
torture, ma non hanno disdegnato nemmeno sapienti fotomontaggi volti a
screditare quei ricercatori che avevano difeso pubblicamente l’utilità della
vivisezione (come viene impropriamente chiamata). Poco importa se le immagini
cruente di animali straziati non corrispondano alla realtà, almeno non qui in
Europa, e ancor meno importa il fatto che circa il 92% degli scienziati ritenga
che purtroppo non si possa fare a meno della sperimentazione animale. L’impatto
emotivo di quelle foto e di quei camici insanguinati è semplicemente devastante.
Le immagini sono uno strumento potentissimo all’interno di una discussione,
specie se gli interlocutori non sono molto informati sul tema. Spesso
raggiungono l’obiettivo, muovendo le masse verso una posizione piuttosto che
un’altra. E ad avvantaggiarsene sono stati anche coloro che stanno dalla parte
della scienza, come dimostra la recente vicenda di Caterina Simonsen, suo
malgrado divenuta nel giro di poche settimane una celebrità della rete. Il
coinvolgimento emotivo è un’arma micidiale, che può essere usato sia dagli
oppositori della scienza, sia da quelli che dovrebbero esserne i paladini. Ma è
davvero la strategia migliore? Dal punto di vista etico, sfruttare immagini di
persone sofferenti per portare avanti una causa non sembra certo il massimo
della correttezza. Tuttavia, non è a questo che mi riferisco, quanto piuttosto
all’efficacia di questo approccio nel lungo periodo. Le immagini scioccanti sono
perfette per orientare l’opinione pubblica in merito al singolo episodio (i
movimenti animalisti hanno obiettivamente accusato il colpo dopo la vicenda di
Caterina), ma hanno il difetto di mancare il bersaglio grosso, quello che un
amante della scienza dovrebbe considerare come l’obiettivo prioritario:
insegnare a valutare un problema in modo razionale, informandosi e pesando pro e
contro. In teoria, viviamo in una democrazia moderna, relativamente colta e
istruita. Dovremmo quindi smetterla di trattare le persone come un gregge da
guidare da una valle all’altra ogni volta che si presenta un nuovo argomento di
discussione. Oggi è la sperimentazione animale, domani potrebbe essere
qualcos’altro. La verità è che esiste soltanto una bussola che permette di
trovare sempre, in ogni circostanza, la via giusta: è la bussola del pensiero
critico, della logica e della corretta informazione. Educare le persone a usarla
le renderà cittadini liberi, e realmente consapevoli delle proprie opinioni.
Fare informazione corretta paga. Prendiamo ad esempio il recentissimo sondaggio
IPSOS sulla sperimentazione animale: la percentuale di favorevoli saliva dal 49%
al 57% se agli intervistati venivano fornite informazioni di base
sull’argomento. In modo analogo, all’ultimo Festival della Letteratura di
Mantova, il ricercatore Dario Bressanini e la giornalista Beatrice Mautino erano
riusciti a vincere un confronto Oxford-style sul tema degli OGM, convincendo
molti scettici a passare dalla loro parte. Comunicare la scienza in modo pacato,
chiaro e oggettivo rimane ancora la strategia vincente. Anche nell’era di
Twitter e Facebook.
ILARIA ALPI, NATALE
DE GRAZIA E LE NAVI DEI VELENI.
Aspettando il 20 Marzo 2013, Rai Tre presenta
Toxic Somalia. Il punto sul caso Ilaria Alpi di Mariangela Gritta Grainer.
Alpi-Hrovatin, il caso, Associazione Ilaria Alpi. Il 20 marzo 2013
saranno passati 19 anni dalla tragica esecuzione di Mogadiscio in cui Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin sono stati uccisi con un solo colpo ciascuno sparato alla
nuca. Sappiamo che si è trattato di un’esecuzione. Un’esecuzione su
commissione. Ilaria è stata uccisa perché era brava, il suo modo di fare
giornalismo di cercare sempre la verità e di comunicarla ha fatto paura e fa
ancora paura. Per questo la verità sulla sua uccisione ancora non si conosce per
intero. Sappiamo che è stata uccisa, insieme a Miran, perché aveva rintracciato,
nel suo lavoro d’inchiesta, un gigantesco traffico internazionale di rifiuti
tossici e di armi che aveva nella Somalia (martoriata da un sanguinario
dittatore come Siad Barre prima e dalla guerra civile poi) un crocevia
importante per traffici illeciti di ogni tipo che solamente organizzazioni
criminali, mafia, ’ndrangheta e camorra possono gestire (come indagini di
procure, dichiarazioni di pentiti e collaboratori di giustizia hanno fatto
emergere anche di recente). Lunedì 4 marzo alle ore 23.05 Rai Tre presenta un
reportage – Premio Speciale alla 18^ edizione del Premio Ilaria Alpi – scritto e
diretto da Paul Moreira, firma di prestigio del giornalismo d’inchiesta in
Europa: una iniziativa forte in apertura di un mese di marzo ricco di
incontri per non dimenticare Ilaria e Miran, il loro lavoro, le loro vite e
soprattutto per dare impulso alla ricerca delle prove e dei responsabili
(esecutori e mandanti) di questa esecuzione. In “Toxic Somalia” Moreira
documenta gli effetti sulla popolazione dei rifiuti tossici scaricati
dall’occidente in terra somala, seguendo la strada aperta da Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin e ricostruendo i rapporti segreti tra il mondo degli affari e quello
della criminalità. L’inchiesta valorizza il lavoro intrapreso dalla giovane
inviata del TG3 e dal suo operatore mostrando con efficacia come ne abbia
segnato la tragica fine perché gli affari sporchi, l’illegalità potesse e possa
continuare. In programma diversi incontri che ci aiuteranno a rimettere sotto i
riflettori il duplice delitto di Mogadiscio nel contesto delle stragi di mafia,
di tangentopoli, la fine della prima Repubblica. Due i fatti che l’anno appena
trascorso ci ha consegnato.. Il processo che vedeva imputato per il reato di
calunnia Ahmed Ali Rage detto Jelle (testimone d’accusa chiave nei confronti di
Hashi Omar Hassan in carcere da oltre dieci anni dopo la condanna definitiva a
26 anni) si è chiuso con una assoluzione le cui motivazioni sono incredibili
(“…appare evidente l’impossibilità di pervenire ad un giudizio di
colpevolezza…”). Assoluzione in contumacia avendo di fatto accertato che la
testimonianza potrebbe essere falsa mentre un cittadino somalo è in carcere
forse innocente e di certo due cittadini italiani, Ilaria e Miran, sono stati
assassinati quasi vent’anni fa e ancora non hanno avuto giustizia. La relazione
conclusiva della commissione bicamerale d’inchiesta sulle ecomafie sostiene che
il capitano Nicola De Grazia è stato avvelenato (riesumata la salma, “la
consulenza del professor Arcudi arriva ad una conclusione inequivoca: …..la
morte è la conseguenza di una “causa tossica”). Il capitano Natale De Grazia
(morto in circostanze misteriose il 13 dicembre 1995 mentre si recava a La
Spezia per indagini importanti) è stata figura chiave del pool investigativo
coordinato dal procuratore di Reggio Calabria Francesco Neri che indagava sulle
“navi dei veleni”. Fu De Grazia a trovare il certificato di morte e/o l’annuncio
“di morte avvenuta di Ilaria” nelle perquisizioni effettuate a casa di Giorgio
Comerio, noto trafficante di armi, e coinvolto secondo gli investigatori nel
piano per smaltire illecitamente rifiuti tossico nocivi che prevedeva la messa
in custodia di rifiuti radioattivi delle centrali nucleari in appositi
contenitori e il loro ammaramento. “La morte del capitano De Grazia si
inscrive tra i misteri irrisolti del nostro Paese”, con queste parole si
conclude la relazione della commissione. In contrasto e dunque ancora più
incomprensibile la decisione assunta dal Procuratore della Repubblica di Nocera
Inferiore di chiedere l’archiviazione dell’inchiesta sul caso della morte del
capitano Natale De Grazia. Due fatti che confermano quanto è avvenuto in questi
anni dolenti: depistaggi occultamenti, carte false, testimoni e/o persone
informate dei fatti che hanno mentito …: il tutto spesso confezionato
direttamente e/o con la complicità di parti e strutture dello Stato. “Menti
raffinatissime” sono state e sono in azione fin dai primi giorni dopo
l’uccisione premeditata: l’omissione di soccorso, la sparizione dei blok notes e
di alcune cassette video, la non effettuazione dell’autopsia, la violazione dei
sigilli dei bagagli, la costruzione “persistente” della tesi della casualità
(tentativo di sequestro finito male, il proiettile vagante …)…….Il corso della
giustizia è stato compromesso, gli assassini e chi li copre hanno potuto contare
sul fatto che le tracce si possono dissolvere, che alcuni reperti sono scomparsi
o non sono più utilizzabili, che molti testimoni sono morti in circostanze
misteriose, che anche pezzi di Stato hanno lavorato all’accreditamento ufficiale
di una falsa versione manipolando fatti reali. Nonostante infiniti tentativi che
avrebbero voluto chiudere questo caso da anni l’impegno incessante di Giorgio e
Luciana Alpi lo hanno tenuto aperto e grazie a loro all’associazione Ilaria Alpi
al premio e alle moltissime scuole, istituzioni, migliaia di cittadine e
cittadini che sono impegnati il caso è ancora apertissimo. Siamo ancora qui non
ci arrendiamo vogliamo e avremo verità, tutta la verità e giustizia. Può essere
una buona medicina anche per questa nuova fase politica che di certo esige aria
pulita ripartire dal “senso della verità” e della giustizia. Mariangela
Gritta Grainer,Presidente Associazione Ilaria Alpi.
SIAMO ALLE SOLITE:
VOGLIONO INSABBIARE TUTTO. IL CAPITANO DE GRAZIA E' MORTO INUTILMENTE?
Perché non è
arrivato vivo alla Spezia? Il dossier: "La
Spezia crocevia dei veleni", scrive “Città Della Spezia”.
Legambiente si prepara per l'udienza
sull'archiviazione dell'inchiesta sulle navi dei veleni.
Poco più di un mese per riuscire a mettere insieme una quantità
di notizie di rilievo tale da convincere il gip del Tribunale della Spezia a
rifiutare la richiesta di archiviazione dell'indagine sulle navi dei veleni
avanzata dalla procura. E' la missione che sta compiendo Legambiente, tanto a
livello nazionale, quanto localmente, con l'appoggio legale dell'avvocato
Valentina Antonini. "La procura spezzina - ha spiegato Paolo Varrella - ha
avanzato la richiesta per indizi insufficienti, ma riteniamo di poter
contribuire nel fornire dati da 'sgranare' e poter così far procedere le
indagini. Se ci fosse stata maggiore attenzione sulle problematiche che
riguardano casi come Pitelli o le navi dei veleni, probabilmente non avremmo
dovuto stendere un dossier e intervenire in soccorso della magistratura. Invece
non abbiamo a disposizione nessuna indagine epidemiologica seria, che avrebbe
potuto fornire dati incontrovertibili, e la politica si disinteressa
completamente di queste vicende". A ribadire come il problema sia prima di tutto
una questione politica è stato Marco Grondacci, esperto di diritto ambientale,
che ha contribuito alla stesura del dossier e che continuerà a guardare da
vicino le questioni che riguardano le navi dei veleni, una vicenda resa ben nota
anche per l'assassinio rimasto senza colpevoli di Natale Di Grazia, il capitano
della Capitaneria di porto che si stava recando proprio alla Spezia per indagare
sui traffici illeciti di rifiuti pericolosi e sugli affondamenti delle navi
cariche di veleni. Non a caso il dossier è stato intitolato 'La Spezia, crocevia
dei veleni - Vent'anni di misteri, di colpevoli silenzi e di nessuna verità'.
"Viviamo in un regime di opacità amministrativa, senza alcuna attenzione per la
prevenzione, da parte di quasi nessuno degli enti che dovrebbero occuparsene.
Invece - ha detto Grondacci - non è mai stata fatta una mappatura seria della
situazione ambientale e degli effetti che questa ha sulle persone". Matteo
Bellegoni, segretario provinciale Fiom Cgil, ha parlato della necessità di
avviare una 'bonifica culturale', mentre Daniela Patrucco, intervenuta a nome
del comitato 'Spezia via dal carbone', ha definito la città della Spezia come
una "nave scuola nel campo del lasciar andare le cose in un certo modo, per la
prassi di piegare le normativa a ragioni differenti. Finché poi non interviene
la magistratura. C'è un filo rosso di omertà che lega le vicende degli ultimi 20
anni, con il disinteresse a intervenire che è di fatto una sorta di
favoreggiamento delle attività criminali". "Un filo rosso - ha aggiunto Enrico
Adami, per l'associazione Murati vivi di Marola - che si estende anche sul Campo
in ferro e sullo stoccaggio dell'amianto rimosso dalle navi militari, che a
quanto ci risulta è avvenuto senza rispettare le normative. E le istituzioni,
che ben sanno come stanno le cose, non fanno niente". Il vice presidente di
Legambiente, Stefano Ciafani, venuto alla Spezia per appoggiare l'iniziativa
della sezione locale presieduta da Stefano Sarti, ha ricordato come
l'associazione sia impegnata anche sul fronte di Pitelli, con il ricorso al Tar
che chiede che ritorni ad essere un sito di bonifica di interesse nazionale.
"Non ci possiamo rassegnare al fatto che Pitelli e le navi dei veleni finiscano
come tanti altri casi in Italia, dove la presenza di figure 'grige', che
lavorano per rendere tutto estremamente complicato, hanno impedito che si
arrivasse a punire i colpevoli, anche se le verità storiche sono ben note".
"Bisogna evitare la parcellizzazione delle tematiche - ha concluso l'avvocato
Antonini - lavorare affinché i collegamenti tra i diversi casi vengano alla
luce".
Navi dei veleni, De Grazia avvelenato
durante il viaggio per La Spezia, scrive ancora scrive
“Città Della Spezia”.
La commissione parlamentare ha stabilito
che il capitano, che indagava su un enorme traffico di rifiuti tossici, sia
morto per 'causa tossica'. Un piccolo squarcio nel
velo del mistero che avvolge insieme le morti del capitano Natale De Grazia,
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, con la città della Spezia e un traffico
internazionale di rifiuti tossici. Quindici anni dopo la notte in cui il
capitano De Grazia morì inspiegabilmente sul sedile dell'auto che lo stava
portando da Reggio Calabria alla volta del golfo spezzino, il presidente della
commissione parlamentare d'inchiesta Gaetano Pecorella ha anticipato le
conclusioni alle quali sono giunti deputati e senatori, affiancati da
specialisti di prim'ordine: De Grazia, che stava indagando su 180 inabissamenti
dolosi, non è morto per cause naturali, ma per una 'causa tossica'. In pratica:
è stato avvelenato. E a suffragio di questa ipotesi (sostenuta da tempo dai
familiari) ci sono alcuni avvenimenti rimarcati dallo stesso Pecorella. "Tutti
gli elementi di sospetto - ha dichiarato il presidente della commissione
parlamentare - hanno acquisito una luce particolare ed inquietante. Mettendo
insieme più elementi erano venuti alla luce una serie di fatti che inducevano a
sospettare della morte del capitano". La prima è che De Grazia svolgeva indagini
di grande importanza sul traffico di rifiuti radioattivi e pericolosi e che
c'erano interessi significativi, anche di Stati esteri. Il secondo punto è che
c'era stato "un tentativo di spostare De Grazia ad altri uffici; tentativo poi
bloccato dagli stessi magistrati". Ancora: parte del "materiale di indagine su
De Grazia, contenuto nei fascicoli processuali, è stato sottratto". E inoltre,
"si sono perse le tracce del certificato di morte di Ilaria Alpi che De Grazia
aveva trovato" nel corso di una perquisizione. Infine, tra gli elementi di
sospetto, secondo Pecorella c'è il fatto che "poco prima della morte di De
Grazia si sciolse il gruppo investigativo che aveva in carico inchieste di
grande importanza". Se tre indizi fanno una prova, ce n'era abbastanza per
pensare che un 41enne, sottoposto a visite mediche periodiche dalla Marina
militare, giunto all'acme di una attività di indagine pericolosa e che
pestava i piedi di molti potentati, potesse non essere morto per un arresto
cardiaco. Eppure la prima autopsia svolta stabilì proprio questo. Purtroppo,
trascorsi tanti anni, per il professore Giovanni Arcudi, perito interpellato
dalla commissione, non è stato possibile stabilire possa essere stata la causa
tossica. E nemmeno se questa effettivamente ci sia stata. La conclusione è stata
ottenuta per esclusione della possibilità che la morte sia stata naturale. Il
decesso dovuto ad una tossina, secondo il perito, "appare analiticamente
motivata, e scientificamente inattaccabile. Ciò che risulta è che il capitano De
Grazia ha ingerito gli stessi cibi di chi lo accompagnava nel viaggio, salvo un
dolce: queste almeno sono state le dichiarazioni dei testimoni (i due
carabinieri che erano in viaggio con De Grazia). Se così è, appare difficile
ricondurre la tossicità ad una causa naturale, anche se non lo si può escludere
in forma assoluta". Il presidente Pecorella, ha concluso dicendo che "non è
compito della commissione pronunciare sentenze, né sciogliere nodi di competenza
dell'autorità giudiziaria, ma non si può non segnalare che la morte del capitano
De Grazia si inscrive tra i misteri irrisolti del nostro Paese". E i nuovi
risultati impongono di valutare la situazione in una chiave nuova e non poco
allarmante.
Il capitano De Grazia avvelenato mentre
indagava sulla nave del Kgb, scrive Giuseppe
Baldessarro su “La Repubblica”. Le conclusioni della commissione parlamentare
sui rifiuti tossici: Non si crede alla incidente e ci sono gli elementi per
riaprire il caso dell'ufficiale morto come torna a chiedere anche Legambiente.
Nuovi informazioni sullo strano caso della nave Latvia. La morte del capitano
Natale De Grazia non ha mai convinto nessuno. Oggi però ci sono anche gli
elementi concreti per chiedere la riapertura del caso. Legambiente, che per
prima lanciò l'allarme sulle navi dei veleni all'inizio degli anni 90 ha
organizzato a Reggio Calabria un incontro a cui prende parte anche Alessandro
Bratti, componente Pd della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Un dibattito per dire che il "Caso De
Grazia", non è chiuso. Una richiesta sostenuta dalle conclusioni cui è giunta la
stessa Commissione, per la quale l'ufficiale che indagava sui traffici illegali
di scorie non morì "di morte naturale", come stabilito da due perizie mediche
fatte immediatamente dopo il decesso, ma che si trattò di una morte dovuta ad
una sorta di intossicamento. Veleno insomma. De Grazia era sulle tracce delle
navi dei veleni che venivano utilizzate per inabissare sostanze tossiche. Ed era
arrivato a scoprire storie pericolose. Il mistero dei cargo affondati nel
Mediterraneo poteva essere risolto. Natale De Grazia la notte in cui morì si
stava recando a La Spezia, porto nel quale doveva fare una serie di
approfondimenti, incontrando anche alcune fonti "riservate". A La Spezia,
sapeva, essere in porto anche una strana imbarcazione la Latvia, una motonave
dell'ex Unione Sovietica, che era stata dei servizi segreti russi. Scrive la
Commissione: "Dell'esistenza di questa nave si dà conto per la prima volta
nell'annotazione di polizia giudiziaria redatta dal Corpo forestale dello Stato
di Brescia in data 26 ottobre 1995, nella quale si evidenzia che la nave,
venduta ad un prezzo superiore al valore reale, avrebbe potuto essere destinata
al trasporto di rifiuti nucleari e/o tossico-nocivi". E ancora: "Nell'area
portuale di La Spezia è presente la motonave Latvia. adibita al trasporto
passeggeri, ex-sovietica, giunta nei cantieri Oram prima della caduta del blocco
orientale. Nave ritenuta come appartenente ai servizi segreti sovietici (Kgb)
(...). Attualmente è ormeggiata alla diga di La Spezia, è stata messa in vendita
(forse dal tribunale) ed acquistata da una società Liberiana con sede in
Monrovia, tramite un ufficio legale di La Spezia. Da fonte attendibile risulta
che il prezzo pagato è superiore di quello del valore reale, e questo fa
supporre che potrebbe essere utilizzata come "bagnarola" per traffici illegali
di varia natura, in particolare di rifiuti nucleari e o tossico-nocivi (...)".
La misteriosa Latvia viene menzionata in un'altra annotazione di polizia
giudiziaria che porta la data 10 novembre 1995. Nell'informativa "il brigadiere
Gianni De Podestà comunicò alle procure di Reggio Calabria e di Napoli che fonte
confidenziale attendibile aveva di recente riferito in merito al coinvolgimento
di famiglie camorristiche e logge massoniche deviate nei traffici di rifiuti
radioattivi e tossico nocivi interessanti la zona di La Spezia e l'hinterland
napoletano. Si dava atto che la Latvia, così come già era stato fatto per la
Rigel e la Jolly Rosso, avrebbe dovuto essere preparata per salpare nell'arco di
4 giorni con un carico non ben definito (rifiuti tossico-nocivi e/o radioattivi)
per poi seguire la rotta La Spezia-Napoli (per un ulteriore carico, come
accertato per la Rosso) - Stretto di Messina-Malta - ritorno sulle coste joniche
(per affondamento)". Fantasie di un informatore pazzo? No, secondo gli
investigatori è molto attendibile. La fonte denominata "Pinocchio", ritenuto
uomo in odore di servizi segreti italiani, indica fatti precisi. Rimane anonima
per ragioni di sicurezza personale, familiare e per la polizia giudiziaria che
lavora all'indagine. Sembrerebbe quasi un infiltrato. Di fronte a
un'informazione dettagliata di questo tipo, il pm reggino Francesco Neri e il
pool di cui De Grazia faceva parte, iniziò ad indagare anche sulla Latvia.
Spiega la Commissione: "Si trattava, infatti, di una nave che era possibile
monitorare per così dire 'in diretta' e che consentiva, quindi, di superare i
vuoti conoscitivi attinenti alle altre navi delle quali si erano perse le
tracce". Appare, quindi, del tutto credibile la circostanza emersa nell'ambito
dell'inchiesta svolta dalla Commissione, secondo la quale il capitano De Grazia
si sarebbe dovuto recare a La Spezia anche per effettuare indagini con
riferimento alla predetta nave e per avere un contatto diretto con la fonte
confidenziale che aveva già riferito informazioni in merito alla Latvia. Tale
circostanza, invero, non risulta da alcun documento, ma è stata rappresentata
alla Commissione da un soggetto il cui nome è rimasto segretato". Il 13 dicembre
a La Spezia sarebbe arrivato De Grazia. Non fece in tempo, morì misteriosamente
nel viaggio di andata. Una morte resa ancora più sospetta da un fatto: "data 15
dicembre 1995, due giorni dopo il decesso del capitano De Grazia, l'ispettore
Tassi trasmise un fax alla procura circondariale di Reggio Calabria nel quale
testualmente riferiva che "In data odierna è stata accertata la partenza della
Motonave Latvia, avvenuta all'incirca verso la terza decina del Novembre per
raggiungere il porto di Ariga (Turchia)". La Commissione trae le conclusioni:
"Non può non sottolinearsi la peculiarità della vicenda, tenuto conto dei
seguenti dati: nel pieno di indagini concernenti l'utilizzo di navi per lo
smaltimento illecito di rifiuti tossici, vi era la possibilità di monitorare una
nave, la Latvia, rispetto alla quale vi erano concreti indizi in merito al suo
utilizzo per le predette finalità illecite; ebbene, nonostante la preziosissima
fonte di informazioni, rappresentata dalla motonave in questione, non solo non
risultano effettuate verifiche approfondite da parte degli ufficiali di polizia
giudiziaria della zona, ma neppure risultano essere stati mai sentiti gli
occupanti della nave; paradossale è poi che non sia stato predisposto un
servizio di osservazione in merito agli spostamenti della nave".
Dalle carte spuntano il nome di Gelli e i
magistrati spiati dai servizi segreti, continua
Giuseppe Baldessarro. La commissione ha anche desecretato delle informazioni
arrivate dal Copasir da cui emergono cinquecento milioni di spese sostenute
dagli 007. Per fare cosa? "Un giorno mi presento al Sismi e sequestro un
documento, con tanto di provvedimento del magistrato. Ho trovato grande
collaborazione nel generale Sturchio, il capo di gabinetto. Mi chiese se volessi
il tale documento e me lo dettero tranquillamente. (...) Chiedevamo se avevano
qualcosa su Giorgio Comerio. Il primo documento che emerse mostrava che Giorgio
Comerio era colui il quale aveva ospitato in un appartamento, non so se di sua
proprietà, a Montecarlo l'evaso Licio Gelli". A raccontarlo davanto ai deputati
della Commissione d'inchiesta sui rifiuti è Nicolò Moschitta, maresciallo dei
Carabinieri e componente di punta del pool di investigatori che con De Grazia,
si occupava delle navi dei veleni. "In modo particolare, (nel documento) si
trattava della fuga di Licio Gelli da Lugano fino al suo rifugio segreto nel
principato di Monaco. Ci risulta che la casa in cui era ospitato Licio Gelli era
di Giorgio Comerio. In seguito, i servizi segreti sono entrati ufficialmente con
noi nell'indagine perché esaminavano la documentazione, d'accordo con la
magistratura. In effetti, è stata una collaborazione corretta, leale e senza
problemi". La collaborazione tra procura e Sismi proseguì anche dopo che il
fascicolo fu trasmesso alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.
La conferma è nel provvedimento con il quale il sostituto procuratore Alberto
Cisterna, divenuto poi titolare dell'indagine, autorizzò la polizia giudiziaria
"ad avvalersi dell'ausilio informativo del Sismi per il tramite di persone
nominativamente indicate appartenenti all'ottava divisione". Se quello descritto
"fu il rapporto 'formale' tra procura e servizi segreti, in merito alle indagini
sulle "navi a perdere", Secondo la Commissione, si tratterebbe di "un ulteriore
profilo di intervento dei servizi segreti nella materia riguardante il traffico
dei rifiuti radioattivi e tossico nocivi e il traffico di armi". "In
particolare il documento proveniente dal Copasir, riguarda una comunicazione del
Sismi al Cesis in merito alle spese sostenute nell'anno 1994 per i servizi di
intelligence connessi al problema del traffico illecito di rifiuti radioattivi e
di armi, indicati nella misura di 500 milioni di lire. Si tratta di un documento
desecretato dalla Commissione particolarmente interessata a comprendere in che
modo fossero stati utilizzati i 500 milioni di lire nelle operazioni di
intelligence relative al traffico di rifiuti e di armi. Per farne cosa? "Non è
stato però possibile, nonostante le numerose audizioni effettuate sul punto,
sapere in che modo sia stata spesa la somma di cui sopra, per lo svolgimento di
quali attività e, ancor prima, per quali ragioni i servizi, all'epoca, fossero
interessati al tema dei rifiuti radioattivi". Che i servizi fossero stati
coinvolti ufficialmente nell'inchiesta delle navi è un fatto accertato. Ora però
la commissione si pone anche qualche altra domanda, visto che gli stessi servizi
controllavano i movimenti del pool di magistrati e investigatori che lavoravano
al caso. E infatti: "È stato, inoltre, prospettato alla Commissione, ma non è
stato acquisito alcun riscontro al riguardo, un ulteriore ipotetico
interessamento dei servizi all'indagine svolta da Neri attraverso il controllo
delle attività poste in essere dalla procura e dagli ufficiali di polizia
giudiziaria". Le indicazioni in questo senso le fornisce il Colonello della
Forestale Rino Martini (anch'esso coinvolto nelle indagini) alla Commissione
quando dice: "In quel periodo, si verificarono due episodi, uno dei quali
ricordato dal procuratore Pace. Per una settimana siamo stati filmati da un
camper parcheggiato di fronte alla caserma in cui operavo. Una sera in cui erano
stati invitati anche altri magistrati, avevamo deciso di recarci in una bettola
sul Maddalena, che non è frequentata da nessuno durante la cena perché è aperta
solo di giorno, e dieci minuti dopo il nostro arrivo attraverso una strada nel
bosco è arrivata un'altra autovettura e si sono presentati a cena due ragazzi di
trentanni, che hanno lasciato la macchina nel parcheggio. Siamo usciti per primi
e, attraverso due sottufficiali dei Carabinieri di Reggio Calabria presenti,
dalla targa dell'autovettura siamo risaliti al proprietario: il Sisde di Milano.
(...) Certamente, c'era un controllo telefonico e attività ambientali di
verifica su come ci muovevamo".
'Rigel', è al largo di Capo Spartivento
la nave perduta carica di veleni, continua “La
Repubblica”. Il cargo, che batteva bandiera maltese, venne fatto affondare il 21
settembre 1987. Prima di morire, il comandante De Grazia aveva trovato
abbondanti prove sul fatto che il naufragio era servito per nascondere in fondo
al mare un inconfessabile carico di scorie nucleari. Truffe, corruzione, cemento
e polvere di marmo per nascondere l'evidenza. Motonave Rigel, battente bandiera
maltese, stazza 3852 tonnellate. Affondata 20 miglia a largo di Capo Spartivento
alla latitudine di 37 gradi e 58' nord e longitudine di 16 gradi e 49' est,
almeno ufficialmente. È una carretta del mare, molto voluminosa certo, ma pur
sempre una carretta. È colata a picco, con il suo carico "generico", il 21
settembre del 1987. E' una nave dei veleni, o meglio è l'unica delle navi
cercate dal capitano Natale De Grazia su cui affiorano indizi precisi, sostenuti
da un'inchiesta precedente. Dell'affondamento della Rigel, infatti, si viene a
sapere per un dettaglio particolare. L'armatore greco Papanicolau chiede ai
Lloyd's il risarcimento dei danni. La nave era assicurata e, dopo il naufragio,
il proprietario vuole passare all'incasso. Scrive a Londra, senza prevedere che
le assicurazioni, prima di pagare, avrebbero condotto le loro indagini,
acquisendo elementi quantomeno singolari. E scoprendo che l'affondamento era una
truffa. Che era stato provocato per mettere le mani su qualche miliardo della
compagnia. Circostanza costata ai protagonisti della vicenda una condanna penale
definitiva. La storia della Rigel è emblematica. È la copia conforme di altre
vicende e, forse, è anche rappresentativa dell'intera storia del traffico dei
veleni. C'è del marcio. È chiaro. Basta leggere le carte dell'inchiesta della
procura della Repubblica di La Spezia. Dell'affondamento non c'è traccia nei
registri delle Autorità marittime locali e nazionali. Non una parola. Da nessuna
parte. Se non ci fosse stata la denuncia di Papanicolau, di questa nave,
affondata durante il suo viaggio da Marina di Carrara a Limassol (Cipro), non
sarebbe rimasta neanche l'ombra. L'equipaggio quel 21 settembre non lancia
neppure l'SOS. Non chiede aiuto alle Capitanerie di Porto calabresi o siciliane,
che in poche ore avrebbero potuto essere sul posto. Niente di tutto questo.
Comandante e marinai vengono salvati "per caso" dalla Krpan, una nave jugoslava
che non li sbarca in uno dei tanti approdi italiani che ha sulla rotta. Se ne va
invece in giro per il Mediterraneo per un po' e poi scarica tutti a Tunisi.
Strano. E non è il solo elemento anomalo. Il processo per truffa stabilisce che
c'è qualcosa che non va anche sul carico denunciato. Secondo i registri, nella
stiva della Rigel c'erano "macchine riutilizzate" e "polvere di marmo". In
realtà quel carico non era stato mai controllato dalla dogana, i funzionari
dell'ufficio si erano fatti corrompere per 900 mila lire a container. Alcuni dei
soggetti coinvolti nell'inchiesta di La Spezia, pur ammettendo di non sapere
cosa in realtà trasportasse la nave, ammisero che il carico non era quello
dichiarato e che era stata commessa una truffa ai danni dell'assicurazione. C'è
di certo che almeno 60 container erano stati riempiti di blocchi di cemento,
"appositamente realizzati nell'arco di tre mesi". Perché? Qualcuno potrebbe
rilevare che i blocchi servissero per far affondare prima la nave. Sbagliato. O
quantomeno illogico. Il cargo era pieno di mille e 700 tonnellate di polvere di
marmo, oltre alle presunte "macchine". Sufficienti a far inabissare qualsiasi
nave. E, se proprio ci fosse stato un problema, perché non usare altra polvere
di marmo? È più pesante del cemento e persino meno costosa. Invece no. Invece si
decide per i blocchi. La spiegazione del magistrato Francesco Neri nelle carte
dell'indagine che si stava svolgendo a Reggio Calabria è netta: "Appare
ipotizzabile che la presenza a bordo dei blocchi fosse utile alla
cementificazione di rifiuti radioattivi". Non è finita. Ci sono tre persone,
lavoratori del porto coinvolti nelle indagini, che parlano con il pm. Sono Paolo
Lantean, Nedo Picchi e Riccardo Baronti, e confermano che "i container, una
volta caricati dei blocchi di cemento, di notte, erano stati tenuti d'occhio da
alcuni sconosciuti". Personaggi strani, che avevano montato la guardia ai
contenitori d'acciaio e che ci avevano girato attorno per diverse ore. Cosa
sorvegliavano? C'è poi dell'altro. La Rigel è già pronta a salpare il 2
settembre. Ma non si muove da Marina di Carrara. La ragione è semplice:
Papanicolau vuole i soldi che gli spettano dai caricatori. Un miliardo e mezzo,
come stabilito tramite l'avvocato genovese Teresa Gatto. Si legge nella sentenza
che lo condanna per la truffa: "Una parte doveva essere versata entro due giorni
dalla partenza della Rigel da Marina di Massa e l'altra metà prima del
naufragio". Si è accertato che ci furono dei ritardi nei pagamenti e che la
Rigel dopo la partenza si fermò per qualche tempo a Palermo, poi gironzolò
davanti a Capo Spartivento per almeno una settimana prima di essere affondata.
Aspettava, insomma, il segnale dell'avvenuto incasso. E, infatti, i soldi
arrivano estere su estero la sera del 18 settembre. E la nave cola a picco il
21. "Lost the ship". La storia riaffiora quando il comandante Natale De
Grazia, durante una perquisizione nel maggio del '95, trova un'agenda che viene
poi sequestrata. Alla pagina del 14 settembre c'è un appunto in inglese: "Se noi
non abbiamo il denaro disponibile prima del 19 settembre non possiamo comprare
la nave per la produzione al pubblico". E, sul foglio dell'agenda relativo al 21
settembre, la frase "Lost the ship". Che tradotto significa "Perduta la nave".
Coincidenze? I riferimenti alla Rigel sembrano chiari. L'agenda era in un
cassetto dell'ufficio di Giorgio Comerio, il faccendiere implicato in mille
traffici di rifiuti ed in altrettanti di armi. Uno che è pappa e ciccia con i
servizi segreti di mezzo mondo. Prima di partire per il suo ultimo viaggi De
Grazia aveva telefonato all'allora procuratore di Matera Nicola Maria Pace che
conduceva indagini parallele a quelle di Reggio Calabria sul traffico di rifiuti
radioattivi: "Procuratore quando torno deve venire a Reggio Calabria. La porto
nel punto preciso in cui è affondata la Rigel". Non è mai più tornato.
Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.
RELAZIONE SULLA MORTE DEL CAPITANO DI
FREGATA NATALE DE GRAZIA. Segue
il testo della ”Relazione sulla morte del capitano di fregata Natale De Grazia”
così come è stata pubblicata sul sito del relatore on. Alessandro Bratti.
(Relatori: On. Gaetano PECORELLA e On. Alessandro
BRATTI)
Approvata dalla Commissione nella seduta del 5 febbraio 2013- Comunicata alle
Presidenze l’11 febbraio 2013 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6
febbraio 2009, n. 6.
RELAZIONE SULLA MORTE DEL CAPITANO DI
FREGATA NATALE DE GRAZIA
PREMESSA
Il capitano Natale De Grazia. Il dodici dicembre
1995 è stato l’ultimo giorno di vita del capitano Natale De Grazia. Alle prime
ore del 13 dicembre 1995, qualche giorno prima del suo trentanovesimo
compleanno, il capitano De Grazia è deceduto per cause che a molti apparvero
quanto meno sospette e che ancora oggi, a distanza di anni, continuano ad essere
considerate tali. Il capitano di fregata Natale De Grazia era un ufficiale della
Marina militare, in servizio presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria.
Al momento della sua morte era applicato alla sezione di polizia giudiziaria
presso la procura circondariale di Reggio Calabria e faceva parte di un pool
investigativo, coordinato dal sostituto procuratore Francesco Neri, costituito
per effettuare le indagini avviate a seguito di un esposto presentato da
Legambiente, concernente presunti interramenti di rifiuti tossici in Aspromonte.
Nel corso dell’inchiesta si aprirono subito scenari inquietanti legati al
fenomeno delle “navi a perdere”, indicandosi con tale espressione le navi
affondate dolosamente con carichi di rifiuti radioattivi o comunque tossici,
smaltiti illegalmente nelle profondità marine. Secondo un dossier di Legambiente
trasmesso alla Commissione gli affondamenti sospetti di navi, tra il 1979 ed il
2000, sarebbero stati 88 (doc. 117/30). Del gruppo investigativo facevano parte,
oltre al capitano De Grazia, il maresciallo capo Scimone Domenico, appartenente
alla sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri presso la procura di Reggio
Calabria, il maresciallo Moschitta e il carabiniere Rosario Francaviglia, questi
ultimi due appartenenti al nucleo operativo del reparto operativo CC di Reggio
Calabria. In un momento successivo parteciparono attivamente alle indagini anche
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo forestale dello Stato di
Brescia e di La Spezia. Nelle indagini il capitano De Grazia profuse una
dedizione ed un impegno fuori dal comune, tali da farlo considerare, anche dai
sui stessi colleghi, il “motore” dell’inchiesta. Non a caso, dopo la sua morte,
le attività investigative (giunte a risultati importanti e, da un certo punto di
vista, ad una vera e propria fase di svolta) subirono un rallentamento
significativo: alcune delle attività che il capitano stava personalmente
compiendo non furono proseguite e si disperse, in parte, quel bagaglio di
conoscenze e di professionalità che il capitano aveva acquisito nel corso
dell’inchiesta e aveva messo a servizio dei magistrati e dei colleghi. Per dare
un’idea di quanto fosse considerato fondamentale l’apporto professionale del
capitano De Grazia, basti leggere le note che il procuratore capo della procura
circondariale di Reggio Calabria, dottor Scuderi, inviò al comandante della
Capitaneria di porto e al procuratore generale presso la Corte d’appello di
Reggio Calabria: la prima, del 13 novembre 1995, finalizzata a far dispensare il
capitano dalle ordinarie attività svolte presso la Capitaneria di porto onde
consentirgli di dedicarsi all’indagine della procura; la seconda, di
ringraziamento, del 27 novembre 1995 (doc. 681/7). Entrambe si riportano
integralmente.
Nota del 13 novembre 1995: “Oggetto: Proc. penale
n. 2114/94 R.G.N.R. – Indagini relative ad un traffico di rifuti tossici e/o
radioattivi. Com’è noto alla S.V., anche per aver partecipato ad una delle
riunioni promosse dal procuratore generale per il coordinamento tra le varie
procure interessate, da parte di quest’ufficio sono in corso le indagini di cui
in oggetto, le quali hanno già conseguito i primi risultati anche grazie al
prezioso contributo, in termini di professionalità, intuito investigativo e
spirito di sacrificio, del C.C. Natale De Grazia, in servizio presso codesto
Comando. Da circa tre mesi, però, detto ufficiale si trova nell’impossibilità di
svolgere tale attività in quanto impegnato, come dalla S.V. personalmente
significatomi in via informale, nell’espletamento dei suoi compiti di Istituto.
La conseguenza immediata di ciò, purtroppo, è stata una situazione di stallo
dell’attività investigativa, che ha gravemente risentito, per la sua specificità
(pare che i rifiuti vengano smaltiti col sistema delle “navi a perdere”), del
venir meno delle conoscenze tecniche del succitato ufficiale (oltre che della
sua elevata professionalità). In considerazione di quanto sopra, vorrà esaminare
la possibilità di disporre che il capitano De Grazia sia temporaneamente, e per
due mesi almeno, dispensato dai compiti attinenti a codesto ufficio, onde
consentirgli di riprendere a collaborare con lo scrivente nello svolgimento
delle delicate e complesse indagini di cui sopra”.
Nota del 27 novembre 1995: “La presente per darLe
atto della grande sensibilità dimostrata in relazione ai problemi che ebbi a
prospettarle con la mia del 13 u. s. ringraziarla vivamente della sollecitudine
con cui ha consentito al capitano De Grazia di continuare a collaborare con
quest’ ufficio nelle indagini di cui in oggetto”. Rientrato a tempo pieno nel
gruppo investigativo, il capitano De Grazia si dedicò nuovamente alle indagini
con la consueta determinazione. Nel tardo pomeriggio del 12 dicembre 1995 partì,
unitamente al maresciallo Moschitta e al Carabiniere Francaviglia, con
autovettura di servizio, alla volta di La Spezia per dare esecuzione alle
deleghe di indagine, firmate dal procuratore Scuderi e dal sostituto Neri,
finalizzate ad acquisire maggiori elementi di conoscenza in merito
all’affondamento di alcune navi. Durante il viaggio, sul tratto autostradale di
Salerno, alle prime ore del 13 dicembre 1995, il capitano venne colto da malore
e, quindi, trasportato dall’ambulanza, nel frattempo intervenuta, presso il
pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore, ove però giunse cadavere.
Con nota del 22 dicembre 1995 il capitano Antonino
Greco, comandante del nucleo operativo del reparto operativo CC di Reggio
Calabria, rimise al procuratore Scuderi le sei deleghe di indagine datate 11
dicembre 1995 “non potute evadere a causa del decesso del capitano di corvetta
De Grazia Natale” (doc. 321/2). Il Comitato civico “Natale De Grazia” ha
trasmesso alla Commissione una serie di documenti dai quali si rileva che nel
giugno 2004 l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferì al
capitano De Grazia la Medaglia d’oro alla Memoria con le seguenti motivazioni:
“Il capitano di Fregata (CP) Spe r.n. Natale DE GRAZIA ha saputo coniugare la
professionalità, l’esperienza e la competenza marinaresca con l’acume
investigativo e le conoscenze giuridiche dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria,
contribuendo all’acquisizione di elementi e riscontri probatori di elevato
valore investigativo e scientifico per conto della procura di Reggio Calabria.
La sua opera di Ufficiale di Marina è stata contraddistinta da un altissimo
senso del dovere che lo ha portato, a prezzo di un costante sacrificio personale
e nonostante pressioni ed atteggiamenti ostili, a svolgere complesse
investigazioni che, nel tempo, hanno avuto rilevanza a dimensione nazionale nel
settore dei traffici clandestini ed illeciti operati da navi mercantili. Il
comandante De Grazia è deceduto in data 13.12.1995 a Nocera Inferiore per
“Arresto cardio-circolatorio”, mentre si trasferiva da Reggio Calabria a La
Spezia, nell’ambito delle citate indagini di “Polizia Giudiziaria”. Figura di
spicco per le preclare qualità professionali, intellettuali e morali, ha
contribuito con la sua opera ad accrescere e rafforzare il prestigio della
Marina militare Italiana” (doc. 191/2).
L’APPROFONDIMENTO SULLA MORTE DEL CAPITANO DE
GRAZIA
L’approfondimento sulle cause del decesso del
capitano De Grazia si inserisce nel contesto dei più ampi accertamenti chela
Commissione ha effettuato sul fenomeno delle “navi a perdere”. Si tratta di un
tema tornato di attualità a seguito del rinvenimento nell’anno 2009, sui fondali
antistanti la costa di Cetraro, del relitto di una nave, inizialmente (ed
erroneamente) ritenuta essere la Cunsky ossia una delle navi che l’ex
collaboratore di giustizia Francesco Fonti aveva indicato essere state affondate
dolosamente insieme al loro carico di rifiuti altamente tossici. In relazione a
questa vicenda, la procura di Paola ha aperto un procedimento penale, poi
proseguito dalla procura di Catanzaro e conclusosi con un provvedimento di
archiviazione. Nell’ambito di questa più ampia inchiesta, invero, sono emerse
talune peculiarità relative alle circostanze che hanno accompagnato il decesso
del capitano ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti sia perché le
indagini effettuate all’epoca furono carenti sotto molteplici aspetti, lasciando
insoluti interrogativi in ordine alle cause del decesso sia perché tale tragico
evento si inserisce in un contesto investigativo del tutto particolare in
ragione degli interessi in gioco e dei personaggi coinvolti (dalle indagini
sulle navi a perdere condotte dalle procure di Reggio Calabria e Matera
emersero, infatti, per la prima volta indizi di un disegno criminoso di respiro
sovranazionale, nel quale apparivano coinvolti diversi Stati, riguardante il
presunto inabissamento in mare di rifiuti tossici). La Commissione, oltre ad
aver acquisito copia degli atti del procedimento aperto presso la procura della
Repubblica di Nocera Inferiore relativo al decesso del capitano nonché degli
atti riguardanti le indagini alle quali lo stesso capitano De Grazia aveva preso
parte, ha svolto direttamente una serie di attività mirate a far luce sugli
aspetti poco chiari della vicenda. In primo luogo, si è cercato di comprendere
come mai, dopo la morte del capitano, il gruppo investigativo si fosse
progressivamente sfaldato, come se, ad un certo momento, tutti coloro che ne
avevano preso parte non fossero più interessati a proseguire, nonostante si
trattasse di un’indagine particolarmente rilevante sia per l’oggetto trattato
(smaltimento illecito di rifiuti radioattivi) sia per le dimensioni
sovranazionali del traffico illecito sia, ancora, per la collaborazione prestata
non solo da diverse forze di polizia operanti sul territorio nazionale, ma anche
dai servizi segreti, in particolare dal Sismi. Contestualmente, si è cercato di
comprendere se effettivamente, all’epoca, vi fosse un clima di intimidazione che
gli stessi inquirenti hanno dichiarato di aver percepito durante lo svolgimento
del loro lavoro. Ancora, sono stati oggetto di approfondimento da parte della
Commissione alcuni aspetti emergenti proprio dall’indagine avviata dalla
magistratura in ordine al decesso del capitano e conclusasi con provvedimento di
archiviazione.
L’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
Gli approfondimenti della Commissione sono stati
effettuati attraverso: - l’acquisizione dei documenti afferenti le indagini
dell’autorità giudiziaria (tra i più rilevanti si segnalano gli atti delle
indagini svolte dalle procure circondariali di Reggio Calabria e di Matera in
merito allo smaltimento di rifiuti radioattivi; gli atti dei procedimenti
relativi al decesso del capitano De Grazia; gli atti dei procedimenti iscritti
dalla procura presso il tribunale di Reggio Calabria e dalla procura presso il
tribunale di Paola);
- l’acquisizione di documenti utilizzati da
precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta (Commissione di inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Commissioni parlamentari di inchiesta sul
ciclo dei rifiuti presediute dall’On. Russo e dall’On. Scalia);
- audizione dei persone in grado di riferire
elementi utili ai fini dell’inchiesta.
E’ stato, inoltre, conferito un incarico di consulenza tecnica al prof. dottor
Giovanni Arcudi (direttore dell’Istituto di medicina legale nella facoltà medica
dell’Università di Roma “Tor Vergata” nonchè consulente della Commissione) al
fine di operare una rivalutazione delle attività medico legali svolte dai
consulenti nominati dal pubblico ministero e dalle parti civili nell’ambito del
procedimento aperto presso la procura della Repubblica di Nocera Inferiore,
volto ad accertare le cause del decesso del capitano De Grazia.
Tra gli auditi si segnalano:
- i magistrati Francesco Neri, Nicola Maria Pace,
Francesco Greco, Giancarlo Russo, Felicia Genovese, Francesco Basentini, Alberto
Cisterna;
- Postorino Francesco, cognato del capitano di
fregata Natale De Grazia;
- il maresciallo Niccolò Moschitta, già
appartenente al nucleo oeprativo dei Carabinieri di Reggio Calabria;
- il maresciallo Domenico Scimone, già
appartenente al nucleo oeprativo dei Carabinieri di Reggio Calabria;
- il carabiniere Rosario Francaviglia,
appartenente al nucleo oeprativo dei Carabinieri di Reggio Calabria;
- il carabiniere Angelantonio Caiazza;
- il carabiniere Sandro Totaro;
- l’ex colonnello del Corpo forestale dello Stato
di Brescia, Rino Martini;
- il brigadiere del Corpo dello Stato Gianni De
Podestà;
- il vice ispettore del Corpo forestale dello
Stato dello stato Claudio Tassi;
- Francesco Fonti, ex collaboratore di giustizia;
- il medico legale, dottoressa Del Vecchio;
- il medico legale, dottor Asmundo;
- il comandante in seconda, ufficiale presso la
Capitaneria di porto di Vibo Valentia, Giuseppe Bellantone;
- rappresentanti della società di navigazione
Ignazio Messina.
La relazione è strutturata in due parti: La prima
dedicata all’indagine avviata dalla procura circondariale di Reggio Calabria,
nella quale ebbe un ruolo determinante il capitano De Grazia. Ed infatti, non è
possibile trattare adeguatamente il tema del decesso del capitano, senza avere
prima analizzato nel dettaglio l’indagine nella quale lo stesso era impegnato;
in questa parte si è affrontato anche il tema relativo allo sfaldamento del
gruppo investigativo nel quale operava il capitano De Grazia. La seconda parte è
dedicata alle cause della morte del capitano e all’inchiesta aperta sul punto
dalla magistratura. Sono poi riportati gli accertamenti e le attività che la
Commissione ha ritenuto di svolgere al fine di approfondire tutti gli aspetti
ritenuti poco chiari. Infine, vi sono le conclusioni, nelle quali la Commissione
– pur nella consapevolezza della difficoltà di scrivere una parola definitiva
sulla vicenda in questione, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dagli
accadimenti – riesamina criticamente tutti gli elementi acquisiti.
PARTE PRIMA – LE INDAGINI GIUDIZIARIE
1 – L’INDAGINE AVVIATA DALLA PROCURA CIRCONDARIALE
DI REGGIO CALABRIA
1.1 – La denuncia di Legambiente del 2 marzo 1994
e l’apertura del procedimento. La Commissione ha accertato che il primo
procedimento penale aperto in relazione alla vicenda delle “navi a perdere” fu
quello recante il n. 2114/94 mod. 21 R.G.N.R., iscritto presso la procura
circondariale di Reggio Calabria, assegnato al sostituto procuratore della
Repubblica, dottor Francesco Neri. Il procedimento venne aperto inizialmente a
carico di ignoti a seguito di un esposto di Legambiente del 2 marzo 1994 nel
quale si denunciava l’esistenza, in Aspromonte, di discariche abusive contenenti
materiale tossico-nocivo e/o radioattivo, trasportato con navi presso porti
della Calabria e, successivamente, in montagna con automezzi pesanti. Nella
denuncia si evidenziava come il territorio calabrese si prestasse
particolarmente alla realizzazione di discariche abusive sia perché i porti
erano scarsamente controllati, sia perché l’Aspromonte, con le sue caverne
naturali, appariva il luogo ideale in cui nascondere questo tipo di materiale.
Vennero, pertanto, disposti dal pubblico ministero accertamenti tecnici – per il
tramite dell’istituto geografico militare – finalizzati a verificare se il
territorio calabrese fosse effettivamente adatto per un simile illecito
smaltimento di rifiuti. La risposta fu affermativa in quanto realmente
l’Aspromonte, per la sua geomorfologia, accessibilità e vicinanza a porti
incontrollati si prestava ad essere utilizzato per occultare rifiuti pericolosi.
Contestualmente, vennero delegate indagini ai ROS, alla Guardia di finanza e
alla squadra mobile di Reggio Calabria, finalizzate ad accertare quali veicoli
pesanti avessero potuto trasportare rifiuti in Aspromonte. Occorre subito
evidenziare che – in poco meno di un anno – le indagini ebbero sviluppi
inimmaginabili, tanto che nel giugno 1995 il sostituto procuratore Francesco
Neri sentì l’esigenza di trasmettere al procuratore capo una relazione nella
quale evidenziava le tappe investigative ed i sorprendenti scenari che si erano
aperti, per i quali riteneva necessario procedere con rogatorie internazionali,
collaborazioni con altre procure, non solo calabresi, e scambio di informazioni
con i servizi segreti (cfr. doc. 362/3 allegato).
1.2 – Approfondimenti relativi alla nave Korabi e
costituzione del primo gruppo investigativo. Il tema investigativo ben preso si
ampliò. Ed infatti, contemporaneamente allo svolgimento degli accertamenti sulle
caratteristiche del territorio calabrese, giunse alla procura di Reggio Calabria
la notizia che la nave Koraby, battente bandiera albanese e salpata dal porto di
Durazzo con destinazione Palermo, era stata perquisita nella rada antistante
“Pentimele” perché sospettata di trasportare materiale radioattivo (scorie di
rame di altoforno). La nave, giunta a Palermo, era stata respinta per
radioattività del carico. Tuttavia, al successivo controllo presso il porto di
Reggio Calabria, ove si era ormeggiata, detta radioattività non era stata
riscontrata. La nave aveva, perciò, ripreso la sua navigazione con destinazione
Durazzo. Questo dato è stato rappresentato dal dottor Neri come particolarmente
inquietante perché poteva far presumere che la nave si fosse disfatta del carico
radioattivo nel percorso tra Palermo e Reggio Calabria.
Nel corso dei controlli effettuati presso il porto di Reggio Calabria dalla
Guardia di finanza venne trovato a bordo della nave un motore fuoribordo, del
quale il comandante non seppe fornire alcuna giustificazione. I successivi
controlli effettuati consentirono di accertarne la provenienza furtiva. Venne
disposto, dunque, il fermo di polizia giudiziaria del comandante per
ricettazione ed il sequestro della nave, nel frattempo ormeggiata presso il
porto di Pescara. Gli accertamenti disposti successivamente sulla radioattività
della motonave Koraby ebbero esito negativo e la nave venne, pertanto,
dissequestrata. Fu disposta, in seguito, consulenza collegiale per accertare se
le “presunte” scorie di rame contenessero “plutonio” o altre sostanze
radioattive o fungessero da “scudo” ad altra fonte radioattiva di cui il
comandante si era potuto disfare nel tragitto tra Palermo e Reggio Calabria.
Invero, lo stesso, nel corso dell’interrogatorio reso innanzi all’autorità
giudiziaria di Pescara, aveva dichiarato che il carico ritirato a Durazzo era
stato scaricato a Rieka (Fiume) Slovenia per essere poi caricato su vagoni
ferroviari con destinazione ignota (cfr. doc. 362/3 allegato). Si iniziò,
dunque, a profilare l’ipotesi che rifiuti tossici potessero essere smaltiti
illecitamente in mare.
La denuncia di Legambiente fu trasmessa anche alle procure di Locri, Palmi, Vibo
Valentia e Crotone. Fu disposta una consulenza collegiale da parte di tutte le
procure interessate al fine di ottenere una mappa aggiornata di tutti i
possibili siti (discariche, cave, ecc.) di stoccaggio abusivo di rifiuti
radioattivi e tossico/nocivi. Sempre nello stesso periodo venne acquisita dalla
procura della Repubblica di Savona (pubblico ministero dottor Landolfi)
documentazione circa il ritrovamento di 6.000 fusti contenenti materiale tossico
in una cava di Borghetto Santo Spirito, gestita da personaggi legati alle cosche
calabresi. L’ipotesi, poi approfondita dalla procura di Locri, competente per
territorio, era che il materiale tossico potesse essere destinato al sud, nei
territori gestiti dalle cosche predette. Anche dalle procure di Vibo Valentia,
Crotone e Palmi pervennero notizie in merito a presunti interramenti di rifiuti
tossici. Quello sopra descritto è lo scenario nel quale si sviluppò l’indagine
condotta dal dottor Francesco Neri. Proprio per la complessità delle situazioni
emerse venne creato un apposito gruppo investigativo costituito dal maresciallo
capo Scimone Domenico, appartenente alla sezione di polizia giudiziaria dei
Carabinieri presso la procura di Reggio Calabria, dal capitano di fregata De
Grazia Natale, dal maresciallo M. Moschitta e dal carabiniere Rosario
Francaviglia, questi ultimi due appartenenti al nucleo operativo del reparto
operativo CC di Reggio Calabria. Tale gruppo ebbe modo di interfacciarsi sia con
la procura di Matera (che indagava sul centro ricerche Trisaia Enea di
Rotondella) sia con il Corpo forestale dello Stato di Brescia (che aveva da
tempo avviato indagini mirate su Giorgio Comerio, presunto trafficante di
rifiuti tossici e, più in generale, mirate sul traffico di rifiuti radioattivi).
1.3 – Audizione del teste “Billy” e coordinamento
investigativo con la procura di Matera. Nel marzo 1995 l’indagine si arricchì di
elementi importanti, riguardanti il traffico e la gestione delle scorie nucleari
in Italia, lasciando intravedere anche il coinvolgimento dell’Enea. Un
funzionario di questo ente, ingegner Carlo Giglio, chiese espressamente alla
polizia giudiziaria di essere sentito, dopo aver appreso dalla stampa che la
procura di Reggio Calabria si stava occupando di traffici illegali di rifiuti
radioattivi in Calabria. Il teste venne sentito a Roma, ove risiedeva, il 17
marzo 1995(doc. 681/44 allegato), dal dottor Neri e dai marescialli Scimone e
Moschitta. Riferì di essere riuscito a scoprire, nell’ambito della sua attività
istituzionale, che la registrazione degli scarti nucleari era truccata per
rendere incontrollabile il movimento in entrata e in uscita di tutto il
materiale radioattivo che doveva essere gestito presso tutti gli impianti
nucleari. Dichiarò che le sue relazioni ispettive effettuate presso i centri
Enea di Rotondella (MT) e di Saluggia (Vercelli) scatenarono all’interno
dell’ente azioni di ritorsione che sfociarono in denunce per diffamazione e
calunnia. Parlò, poi, di una presunta attività clandestina dell’Enea finalizzata
a fornire tecnologia e materiale nucleare all’Iraq (12.000 kg di uranio), delle
reazioni del governo americano e dei servizi segreti israeliani. Riferì, ancora,
in ordine allo smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dall’Enel, sotto la
supervisione dell’Enea, la cui destinazione sarebbe stata ignota. L’ingegner
Giglio, in quell’occasione, rese una serie di dichiarazioni attinenti ad una
presunta attività di fornitura da parte dell’Italia all’Iraq di armi da guerra
(comprese navi) e di tecnologie nucleari. Particolarmente significative si
rivelarono le dichiarazioni relative al traffico clandestino di materiale
nucleare: “(…) la scelta di Palermo come punto di riferimento per il traffico
clandestino di materiale nucleare non è occasionale, ma mirato, in quanto è
logico ritenere che solo la Mafia o le altre organizzazioni criminali operanti
al sud potevano garantire quella attività di copertura necessaria per detti
traffici. (…). Altro aspetto inquietante del traffico illecito di materiale
radioattivo concerne lo smaltimento effettuato, con la supervisione dell’Enea,
da parte dell’Enel di rifiuti radioattivi la cui destinazione è a tutt’oggi
ignota. Mentre la conferma che la Calabria è stata utilizzata come deposito
illecito di materiale radioattivo è data dalla scoperta di una discarica abusiva
di un tale Pizzimenti. L’ing. Giglio fa inoltre presente come la persecuzione
subita nell’ambito del suo ente sia dipesa essenzialmente dall’avere adempiuto
ai suoi doveri denunciando alla magistratura, al suo ente ed alle varie
Commissioni di inchiesta i fatti sin qui narrati (…)”.
In seguito, l’ingegner Giglio, per la delicatezza
delle dichiarazioni rilasciate, fu chiamato dagli investigatori con lo
pseudonimo “Billy”. Nacque, quindi, l’esigenza di coordinare le indagini con
quelle svolte dalla procura circondariale di Matera, in particolare dal
procuratore Nicola Maria Pace, dal momento che questi, sin dai primi anni ‘90,
stava svolgendo indagini in merito ad un presunto traffico di rifiuti
radioattivi provenienti dal Centro Trisaia Enea di Rotondella (procedimento
penale n. 254/93 R.G.N.R.). Secondo quanto riferito dal dottor Pace alla
Commissione era stato ipotizzato un interesse dell’Enea nell’attività di
smaltimento in mare attraverso le navi. Questa ipotesi aveva portato al
coordinamento investigativo con le attività svolte sul territorio limitrofo
dagli investigatori operanti in Calabria, guidati dal dottor Neri. Ed, in
effetti, Carlo Giglio venne successivamente sentito, in data 10 maggio 1995, dal
dottor Neri e dal dottor Pace, questa volta presso gli uffici del Corpo
forestale dello Stato di Brescia (alla presenza dei marescialli Moschitta e
Scimone). In tale occasione fornì talune precisazioni in merito a quanto già
riferito in precedenza: “i controlli da me effettuati in presenza dei
rappresentanti Enea presso i centri sono stati sempre oggetto di verbali di
sopralluogo firmati dal sottoscritto e dalla stessa direzione Enea (…) tali
verbali sono stati sempre trasmessi all’autorità giudiziaria competente per le
gravissime deficienze riscontrate nei sistemi di monitoraggio e di misura della
radioattività e per quanto riguarda specificatamente il Centro di Rotondella”.
Precisò, poi, che il processo avviato in merito a tali fatti si era concluso con
una sentenza emessa dal tribunale di Matera in data 28 maggio 1984 con la quale
furono assolti sia gli ispettori dell’Enea sia il direttore dell’impianto. In
sintesi, le dichiarazioni di Carlo Giglio hanno fatto riferimento a presunti
fatti di particolari gravità, quali:
- la non corretta tenuta della contabilità
all’interno del centro Enea di Rotondella tale da consentire l’uscita di rifiuti
radioattivi erroneamente definiti “scarti”;
- l’esistenza di un traffico illecito di rifiuti
radioattivi (negli anni ‘80/’90) destinati ai paesi del terzo mondo, in
particolare Irak, Pakistan e Libia, ove sarebbero stati utilizzati per la
produzione di ordigni atomici;
- l’insussistenza di un’effettiva ed efficace
attività di controllo tra Enea ed Enel, nonchè la totale inefficienza della
Nucleco, società costituita tra Enea ed Agip, per il trattamento dei rifiuti
radioattivi. Il successivo 16 giugno 1995, sempre innanzi ai pubblici ministeri
Neri e Pace e alla presenza del colonnello Martini e del maresciallo Scimone,
Carlo Giglio rese ulteriori dichiarazioni (questa volta presso la sede di Roma
del Corpo forestale dello Stato). In sostanza, secondo quanto affermato dal
Giglio, sarebbero state violate numerose norme penali (ma non sono specificate
né le norme violate né le modalità attraverso le quali sarebbero state violate).
Le ultime dichiarazioni rese da Carlo Giglio agli inquirenti, presso la procura
della Repubblica di Reggio Calabria, risalgono al 5 dicembre 1995. In quella
occasione il teste, in sostanza, evidenziò che:
- da quando aveva iniziato a collaborare con
l’autorità giudiziaria, lui e i suoi familiari avevano vissuto strani episodi
riconducibili a velate intimidazioni (così come era accaduto nel corso di
precedenti indagini riguardanti l’Enea);
- Giorgio Comerio aveva avuto rapporti con l’Enea:
“Non vi è dubbio che il Comerio ha avuto rapporti diretti con l’Enea se
intendeva smaltire rifiuti radioattivi in mare (…) Addirittura nella strategia
dell’ente si sta cercando di eliminare ogni prova o traccia di rapporti tra il
Comerio ed altri dirigenti dell’Ente. Il Comerio infatti ha offerto all’ente i
suoi servigi circa lo smaltimento in mare dei rifiuti radioattivi”;
- anche l’Italia aveva disperso in mare le scorie
radioattive: “è noto che anche l’Italia ha disperso in mare scorie radioattive
quindi l’Ente (Enea) è in grado di riferire dove, come e quando”;
- l’Enea sarebbe stata infiltrata dalla
massoneria: “proprio per il tramite della massoneria deviata i traffici illeciti
del materiale nucleare e strategico o quelli relativi allo smaltimento in mare
possono essere attuati nell’ambito dell’Ente ai massimi livelli e con la
copertura più ferrea compresa quella con i servizi deviati, da sempre e
notoriamente coinvolti in detti traffici”. Sui fatti riguardanti il centro Enea
di Rotondella la Commissione ha audito il dottor Pace. Lo stesso era stato,
peraltro, già ascoltato sia dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo
dei rifiuti presieduta dall’On. Russo (in data 10 marzo 2005) sia dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
(quest’ultima audizione è segretata). Secondo quanto dichiarato nel corso
dell’audizione del 10 marzo 2005:
- nel centro Enea di Rotondella era stata
riscontrata una situazione di grave pericolo, in quanto giacevano rifiuti
radioattivi liquidi ad alta attività all’interno di contenitori che, già
all’epoca, avevano esaurito il tempo massimo previsto dal progetto;
- una delle principali anomalie dell’Enea era
relativa alla mancanza di controlli esterni. La conservazione di materiali
pericolosi all’interno di contenitori inidonei era una regola avallata,
attraverso proroghe continue, da parte di due ingegneri i quali, dopo un
incidente verificatosi il 14 aprile del 1994, furono costretti a redigere un
documento di estremo allarme in merito alla situazione della centrale (documento
che il dottor Pace inviò al Presidente della Repubblica dell’epoca);
- nel prosieguo delle indagini il dottor Pace
aveva acquisito documenti da cui risultava che l’Italia, nel 1978, aveva ceduto
all’Iraq due reattori plutonigeni Cirene; aveva, poi, accertato che presso la
centrale Enea di Rotondella vi era la presenza continuativa di personale
iracheno (tale ultima circostanza è stata riferita alla Commissione anche dalla
dottoressa Genovese, nel corso dell’audizione del 21 ottobre 2009, allorquando
ha dichiarato che nel corso delle indagini era emerso da fonti dichiarative che
tecnici iracheni e pachistani “andavano e venivano” dall’Enea);
- il dottor Pace cercò di individuare i cosiddetti
siroi(cavità, risalenti al IV secolo a.C., scavate nella roccia) che da un
manuale dell’Enea risultavano impiegati per il deposito di scorie radioattive.
Si rivolse per questo sia al prof. Quilici dell’Università di Bologna – il quale
però gli disse che i siroi non erano più localizzabili -, sia ad un professore
rumeno, tale Amasteadu, che aveva condotto studi archeologici in Basilicata.
Anche quest’ultimo professore disse di non potere localizzare i siroi; aggiunse,
però, che era stato pubblicato un testo, ormai introvabile, contenente le mappe
dei siroi, testo che lui stesso aveva posseduto in passato, ma che gli era stato
trafugato dopo avere ricevuto una strana visita da parte di non meglio
identificati cittadini iracheni che gli avevano fatto numerose domande. Nel
corso dell’audizione resa avanti a questa Commissione, avvenuta in data 20
gennaio 2010, il dottor Pace ha, sostanzialmente, confermato le dichiarazioni
precedentemente rese, aggiungendo ulteriori particolari. Alla domanda posta dal
Presidente, on. Gaetano Pecorella: “vorrei sapere se al centro Enea giungessero
anche materiali radioattivi esterni, cioè provenienti da altri paesi o da altre
fonti di produzione. Vorrei chiederle inoltre se il sistema di controllo
dell’entrata e dell’uscita di questi materiali fosse in grado di garantire
almeno che ciò che usciva fosse verificato, cioè risultasse in modo documentale.
Uno dei punti sostenuti da Fonti, che stiamo verificando, è che questo materiale
radioattivo provenisse dall’Enea di Rotondella attraverso camion che uscivano
durante la notte. Vorremmo quindi capire se la situazione contabile potesse
offrire una qualche garanzia di ciò che entrava e di ciò che usciva”, il dottor
Pace ha risposto di avere attentamente valutato la contabilità dell’Enea, che
presentava delle anomalie, ma non tali da indurre a ritenere che camion di
materiali potessero uscire in modo incontrollato. E, tuttavia, secondo il
confronto tra i dati di contabilità e il magazzino nucleare mancava il plutonio:
“la contabilità risultava inveritiera soltanto per quanto riguarda il plutonio,
fatto di non poco conto, tanto che su questo tema c’è stata una notevole
dialettica con i massimi esponenti dell’Enea”. Con riferimento, invece, alla
contabilità concernente i materiali esterni (quelli provenienti dagli ospedali e
che dovevano avere la caratterizzazione, il registro di carico e scarico) tutta
la documentazione dei rifiuti trasportati avrebbe dovuto essere custodita in un
armadio, che invece fu trovato vuoto. Sul coordinamento investigativo tra la
procura di Reggio Calabria e quella di Matera ha riferito alla Commissione anche
il maresciallo Moschitta, in data 11 maggio 2010: “ (..) l’attenzione cadde
sull’Enea nel momento in cui il dottor Pace di Matera ci telefonò e ci chiese se
stavamo indagando sui materiali radioattivi. Alla nostra risposta affermativa,
ci propose di lavorare insieme, dal momento che lui aveva una centrale – così
disse – che stava esplodendo. Ci disse che era solo, che non aveva le strutture
e che quindi aveva paura a procedere nell’attività. Invece, unendosi a noi e
lavorando sullo stesso terreno, avremmo potuto raggiungere qualche risultato. A
seguito di questa collaborazione, il dottor Pace ci disse che Matera viveva una
situazione molto pericolosa, perché nella centrale nucleare della città, dentro
una piscina, vi erano 64 barre di uranio, acquistate prima della moratoria dalle
centrali Elk River degli Stati Uniti. La piscina era stata realizzata nel 1960,
quando ancora la normativa antisismica non esisteva. Matera è una zona sismica.
Quindi, ci mostrò la gravità della situazione e ci chiese come avremmo potuto
prenderla in mano. Ci disse che il personale dell’Enea gli faceva muro davanti,
che avrebbe voluto fare degli accertamenti e proseguire le operazioni, che lo
invitavano a fare delle verifiche personalmente, ma che lui non sapeva dove
andare a controllare. La situazione era incresciosa, se pensiamo – queste sono
le parole che sono state pronunciate allora – che il problema di Chernobyl è
nato da mezza barra di uranio e che a Matera ve ne erano 64. Apprese queste
notizie, acquisita da Giglio l’informazione che dalla centrale di Saluggia non
erano stati vetrificati i liquidi radioattivi e tante altre notizie che già
erano a conoscenza del dottor Pace, si rese necessario fare una relazione al
capo del Governo dell’epoca. Vi si recò il dottor Cordova personalmente”. In
sostanza, le indagini avviate a Reggio Calabria sugli interramenti di rifiuti in
Aspromonte si estesero rapidamente ai traffici di rifiuti radioattivi e agli
smaltimenti illeciti degli stessi effettuati in mare o destinati verso paesi
esteri. Inevitabile fu, quindi, il coordinamento investigativo con la procura di
Matera che già indagava in merito a presunte irregolarità concernenti il centro
di ricerche Enea Trisaia di Rotondella.
1.4 – L’inserimento nelle indagini del Corpo
forestale dello Stato di Brescia. Giorgio Comerio e il progetto O.D.M.
I procuratori Neri e Pace, dunque, unirono le loro
risorse e conoscenze investigative per proseguire le indagini. Queste, peraltro,
ebbero una svolta decisiva in conseguenza del contributo fornito dai militari
appartenenti al Corpo forestale dello Stato di Brescia, coordinati dal
colonnello Rino Martini, il quale si rivelò da subito un elemento chiave, sia
per la sua specifica competenza nella materia del traffico illecito di rifiuti
radioattivi, sia per le indagini che da tempo stava svolgendo sull’argomento.
Nella primavera del 1995 gli accertamenti svolti dal Comando di Brescia avevano,
infatti, consentito di acquisire notizie di estrema rilevanza in relazione ad un
imponente traffico di rifiuti radioattivi destinati ad essere smaltiti in mare.
In particolare, con nota informativa del 3 aprile 1995 (doc. 277/2), il
colonnello Rino Martini informò il dottor Neri circa l’esistenza di una holding,
denominata O.D.M. (Oceanic Disposal Management inc.), che si occupava
dell’inabissamento in mare di rifiuti radioattivi. A capo dell’organizzazione vi
era tale Manfred Convalexius, titolare della Convalexius trading con sede a
Vienna (personaggio definito nella nota come conosciuto in Austria ed in altri
Paesi nord-europei per il traffico di rifiuti e di rottami ferrosi), mentre il
referente italiano era un certo Giorgio Comerio, nato il 3 febbraio 1945 a Busto
Arsizio (VA), titolare della Comerio industry ltd., con sede legale a La
Valletta(Malta). La scoperta della società O.D.M. era scaturita dal controllo –
effettuato il 23.5.94 dal Corpo forestale dello Stato di Brescia – nei confronti
di tale Ripamonti Elio alla frontiera di Chiasso, all’esito del quale erano
stati sequestrati una serie di documenti che il Ripamonti portava con sé,
riguardanti il progetto della O.D.M. di smaltimento in mare di rifiuti
radioattivi (cosiddetto progetto DODOS), corredato dalle relazioni tecniche e da
documentazione dalla quale si ricavava che il progetto interessava nazioni come
l’Italia, l’Austria, la Cecoslovacchia, la Germania e la Lettonia (doc. 362/3
allegato). In realtà risulta che, già nell’anno 1993, Ripamonti era stato
controllato al confine dalla Guardia di finanza di Vigevano e trovato in
possesso di documentazione relativa a traffici illeciti riguardanti lo
smaltimento di rifiuti radioattivi. L’analisi dei documenti (in particolare di
una proposta di contratto trasmessa via fax dall’abitazione di Garlasco di
Giorgio Comerio) portò a ritenere che quest’ultimo, con la O.D.M., avesse
proposto lo smaltimento di rifiuti radioattivi tramite i cosiddetti penetratori,
da effettuarsi in paesi baltici, come l’ex Urss. Da ciò era scaturita una
perquisizione, ordinata dalla procura della Repubblica di Lecco, che aveva
aperto un procedimento nei confronti del Ripamonti e di Comerio (doc. 1180/1 e
1180/2). DODOS è l’acronimo di Deep Ocean Data Operative. Si trattava di un
progetto studiato ad Ispra sul lago Maggiore, presso il centro di ricerca della
Comunità europea, al quale avevano lavorato soggetti appartenenti a diversi
Stati compreso Giorgio Comerio nella sua qualità di ingegnere e di responsabile
di una società che originariamente avrebbe dovuto partecipare al progetto. Il
progetto riguardava le modalità di smaltimento dei rifiuti radioattivi
attraverso il loro inabissamento in mare. In sostanza, i rifiuti radioattivi
avrebbero dovuto essere inseriti in contenitori di acciaio e carbonio chiamati
cannister, a loro volta inseriti in un cilindro di 25 metri a forma di siluro
(cosiddetto penetratore). Infine, il siluro avrebbe dovuto essere buttato in
mare su un fondale marino adeguato, alla profondità di qualche migliaio di
metri, piantandosi in tal modo nel fondale stesso. Il progetto non fu, però,
portato avanti in ragione della opposizione manifestata da taluni Paesi che
avevano aderito a trattati internazionali che vietavano lo smaltimento in mare
dei rifiuti radioattivi. Dalla documentazione sequestrata al Ripamonti emerse
che questi avrebbe dovuto individuare clienti svizzeri per lo smaltimento in
mare di rifiuti radioattivi per il tramite dell’avvocato Forni di Lugano.
Emerse, altresì, che un primo ordine da parte di qualche governo estero era
stato già emesso (verosimilmente l’Austria per il tramite del Convalexius).
Ripamonti Elio venne sentito dal dottor Neri e dal colonnello Martini in data 11
maggio 1995 (doc. 277/12). In tale occasione confermò le circostanze emerse
dalla documentazione sequestratagli, precisando:
- di essere stato incaricato da Giorgio Comerio di
portare la documentazione relativa al progetto DODOS all’Avv. Forni di Lugano
per siglare un contratto in esclusiva conla Svizzera;
- che nel caso fosse stato concluso il contratto,
sarebbe stata versata la somma di 200.000 franchi svizzeri su un conto corrente
intestato a Giunta Giuliana (legata sentimentalmente a Comerio);
- che i rifiuti radioattivi svizzeri avrebbero
dovuto essere depositati su fondali marini del nord Europa;
- che il Comerio gli aveva confidato di avere
conoscenze all’interno dell’Enea e che si era riservato l’esclusiva per lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi italiani;
- che il progetto di smaltimento in mare adottato
dal Comerio (penetratori) era stato elaborato anche dall’Enea in collaborazione
con altri Stati esteri.
Sempre le indagini svolte dal Corpo forestale
dello Stato di Brescia, riportate nell’informativa del 3 aprile 1995 (doc.
277/2), permisero di individuare un’altra figura di rilievo, tale Renato Pent,
rappresentate della società Jelly Wax con sede in Opera, definito
nell’informativa come un personaggio noto nell’ambiente degli smaltitori per
avere organizzato nel 1986-1987 le navi dei veleni insieme allo svizzero
Ambrosini. Tali affermazioni, successivamente, non sono state supportate da
elementi concreti di riscontro. Come risulta dalla successiva annotazione dell’8
maggio 1995del Corpo forestale dello Stato di Brescia (doc. 277/3), da una fonte
confidenziale si apprese che:
- Giorgio Comerio aveva il domicilio in Malta;
- manteneva, in ogni caso, un ufficio della
Comerio Industry ltd. in via Colonna 9 a Milano;
- la sede legale della Comerio Industry ltd.. era
a La Valletta (Malta);
- il porto di Reggio Calabria era il luogo di
transito per l’imbarco di containers di materiale radioattivo diretto a Malta e
negli stati del Medio Oriente. Si ipotizzò, pertanto, che il domicilio in Malta
potesse servire al Comerio per seguire direttamente i suoi affari attinenti al
traffico di rifiuti nonché per evitare controlli quali quello subìto
precedentemente (in data 1993) ad opera della Guardia di finanza di Vigevano
(PV) su delega della procura di Lecco (nell’ambito del procedimento penale n.
6356/93). Venne precisato, infine, nell’annotazione che Giorgio Comerio
intratteneva rapporti commerciali con la Nucleco (Enea-Agip Nucelare) di Roma
per la gestione e/o smaltimento di rifiuti radioattivi. Particolarmente
importante è apparsa alla Commissione l’annotazione – redatta dal colonnello
Rino Martini, dal brigadiere Gianni De Podesta’ e dal brigadiere Claudio Tassi –
del 13 maggio 1995, trasmessa al procuratore F. Neri, nella quale vennero
riportate le dichiarazioni rese da una fonte confidenziale di sesso maschile
chiamata “Pinocchio”. Tali dichiarazioni riguardavano vari personaggi coinvolti
nel traffico di rifiuti pericolosi nonché l’affondamento di una nave carica di
rifiuti (doc. 118/7 e 277/5).
In sintesi, la fonte dichiarò agli investigatori
che:
1) tale Noè, funzionario Enea a La Spezia, aveva
la supervisione (non ufficiale) all’interno dell’Enea delle boe elettroniche per
la segnalazione, localizzazione e guida sottomarina spaziale e navigazione in
superficie. Si trattava, pertanto, di un soggetto che conosceva perfettamente i
fondali antistanti la rada di La Spezia, figurando per tale motivo quale
possibile uomo chiave per la criminalità organizzata. In sostanza, veniva
indicato come un personaggio che aveva la possibilità di far entrare e uscire
dal porto imbarcazioni di media grandezza, eludendo i controlli;
2) era a conoscenza di un caso specifico di
affondamento di nave con carico di materiale radioattivo. Testualmente: “La nave
affondata a Capo Spartivento, luogo della regione Calabria-provincia di Reggio
Calabria, di una portata di tonnellate 4-6000 caricata con materiale nucleare
(uranio additivato), altri rifiuti e carico vario, prima di giungere in
Calabria, dove viene affondata volontariamente per riscuotere il premio
assicurativo e nel contempo gettare a mare ogni sorta di rifiuti, ha come luogo
di provenienza la Grecia, successivamente tocca altri porti in Albania e nel
nord Africa e poi entra definitivamente nel mar Ionio. Qui viene affondata al
largo di capo Spartivento su un fondale di circa 400 metri. Tale punto
d’affondamento viene scelto per condizioni climatiche che, quasi sempre avverse,
non permetterebbero un futuro recupero”;
3) altri personaggi erano legati al traffico di
rifiuti radioattivi e tossico-nocivi nel tratto La Spezia/Napoli/Reggio Calabria
e oltremare, quali Duvia Orazio, Di Francia Giorgio, Conte Angelo, Mastropasqua
Domenico, Bini Renzo, Monducci Eros e Messina Ignazio, quest’ultimo titolare
dell’omonima compagnia di navigazione. Indicava, poi, tale Motta Giancarlo
(amministratore della Sistemi Ambientali) descritto come una persona a
conoscenza (per interesse diretto) dei vari passaggi di materiale di scarto
nucleare (possibile uranio) avvenuti via mare fra il Nord Africa, i paesi
meridionali balcanici e le coste Ioniche, passaggi che sarebbero avvenuti
tramite una compagnia di navigazione il cui titolare era Ignazio Messina di La
Spezia. Sin d’ora si deve precisare che gli spunti investigativi forniti dalla
fonte confidenziale non sono stati supportati da elementi di prova. Dunque, il
panorama investigativo, originariamente circoscritto a verificare se in Calabria
fossero state costituite abusive discariche di rifiuti radioattivi o pericolosi
(all’interno delle caverne naturali presenti in Aspromonte), si estese
notevolmente, profilandosi l’ipotesi che l’occultamento illecito di rifiuti
radioattivi venisse attuato anche mediante l’affondamento in mare degli stessi,
attraverso organizzazioni di respiro internazionale che agivano anche sulla base
di contatti con organi istituzionali e in accordo con gli stessi.
1.5 – La perquisizione presso l’abitazione di
Giorgio Comerio e le indagini conseguenti. Giovandosi delle attività
investigative avviate dal colonnello Martini sul traffico illecito di rifiuti
radioattivi, le indagini dei magistrati di Matera e Reggio Calabria si
incentrarono su Giorgio Comerio. Venne, pertanto, emesso un decreto di
perquisizione della sua abitazione sita in Garlasco e dei luoghi nella
disponibilità dello stesso. I documenti acquisiti all’esito della perquisizione
fornirono agli investigatori dell’epoca uno spaccato decisamente inquietante in
merito all’attività svolta dal Comerio, a suoi interessi nello smaltimento dei
rifiuti radioattivi, alle connessioni tra il traffico di armi e il traffico di
rifiuti. All’esito della perquisizione, eseguita il 12 e il 13 maggio 1995dalla
sezione polizia giudiziaria CC procura circondariale di Reggio Calabria, dal
reparto operativo CC Reggio Calabria, dal reparto operativo CC Matera e dal
Corpo forestale dello Stato-settore di polizia regionale di Brescia, venne
sequestrata una mole imponente di documentazione che permise agli inquirenti di
far luce sull’esistenza di progetti finalizzati allo smaltimento in mare di
rifiuti radioattivi. Secondo quanto riferito dal dottor Neri al suo procuratore,
con la nota sopra citata, l’importanza della documentazione sequestrata
“consentiva di incaricare le forze di polizia giudiziaria impegnate
nell’indagine di avvalersi dell’ausilio del Sismi che peraltro ha fornito ben
277 documenti sul Comerio a conferma della pericolosità di detto soggetto e a
riprova della bontà della ipotesi investigativa seguita” (doc. 362/3 allegato).
Sempre nella medesima nota a firma del dottor Neri si legge che nell’abitazione
di Comerio furono trovati: “Agende, video-tape, dischetti magnetici, fascicoli
relativi alla commercializzazione del progetto Euratom (DODOS) trafugato a detto
ente (centro Euratom di Ispra) clandestinamente dal Comerio stesso (…) Veniva
sequestrata anche numerosa corrispondenza (e fotografie) di incontri con
rappresentanti governativi della Sierra Leone per ottenere l’autorizzazione a
smaltire in mare rifiuti radioattivi. Si accertava così che soci nell’affare
erano tale Paleologo Mastrogiovanni (presunto principe dell’Impero di Bisanzio)
e tale Dino Viccica, uomo ricchissimo che avrebbe dovuto finanziare l’operazione
“Sierra Leone” (…) Al riguardo il Console Onorario della Sierra Leone sentito in
merito ha confermato che il Comerio ha concluso l’affare con i governanti di
detti Stati corrompendo un ministro. (…)” (doc. 362/3 allegato). E’ proprio in
questa fase che emerge chiaramente la partecipazione del capitano De Grazia alle
indagini, avendo lo stesso contribuito ad analizzare i documenti con riferimento
a tutti gli aspetti di sua specifica competenza nonchè a redigere l’informativa
sugli esiti della perquisizione e sulle attività investigative conseguenti. Gli
elementi raccolti sulla base della documentazione sequestrata e della successiva
attività di indagine, infatti, vennero riportati nell’informativa del 25 maggio
1995 n. 399/41 di prot. (a cura del capitano di fregata Natale De Grazia e del
maresciallo Moschitta) trasmessa alla procura di Reggio Calabria (doc. 118/5).
Vennero deferiti all’autorità giudiziaria procedente ed iscritti nel registro
indagati, per i reati previsti dal decreto del presidente della Repubblica n.
185 del 1964, dal decreto del presidente della Repubblica n. 915 del 1982, oltre
che per il reato di ricettazione:
- Giorgio Comerio
- la compagna Giuliana Giunta
- il socio Gabriele Molaschi
- altri personaggi, quali Gerardo Viccica
(aliasDino), Pietro Pagliariccio (alias Giampiero), Jack Mazreku, Giuseppe
Barattini, Mastrogiovanni Paleologo e Ezio Piero Toppino.
I principali elementi evidenziati nell’informativa
in questione e posti all’attenzione dei magistrati inquirenti furono:
- all’interno dell’abitazione di Comerio, sita in
Garlasco, era stata rivenuta documentazione attinente al progettoDODOS (Deep
Ocean Data Operating System) che prevedeva il lancio sui fondali marini,
attraverso i cosiddetti penetratori, di scorie radioattive, progetto in parte
già realizzato in zone africane e del nord Europa in violazione della
Convenzione di Londra;
- erano stati, poi, sequestrati un progetto
relativo alla costruzione ed alla vendita di telemine, strumento bellico
subacqueo, nonché documenti dai quali emergevano contatti con paesi arabi e
indiani e transazioni bancarie in dollari su banche svizzere che rendevano
concretamente ipotizzabile l’avvenuta vendita delle telemine;
- da alcuni disegni di navi sequestrati era
evidente che il Comerio avesse intenzione di modificare una nave Ro-Ro per la
costruzione delle telemine. I disegni si riferivano alla Jolly Rosso
(spiaggiatasi il 14 dicembre 1990 ad Amantea) ed alla nave Acrux, poi denominata
Queen Sea (all’epoca sotto sequestro presso il porto di Ravenna);
- erano stati sequestrati, inoltre, atti relativi
a navi aventi scarso valore commerciale e in degrado strutturale, sulle quali
erano stati abbozzati preventivi di spesa per la riparazione e per la
documentazione di cambio di bandiera;
- tutta la documentazione sequestrata a Comerio
portava a ritenere che lo stesso si occupasse dell’acquisto delle navi per il
loro successivo utilizzo a fini illeciti;
- conseguentemente, era stato effettuato un
accertamento presso i Lloyds di Londra – sede di Genova – ed erano state
acquisite le copie dei sinistri marittimi intervenuti dall’anno 1987 al 1993, al
fine di verificare quelli di natura eventualmente dolosa avvenuti nelle acque
territoriali calabresi;
- da tale attività era emerso che ben 23 navi
erano affondate nel mare antistante le coste calabresi;
- le risultanze delle indagini trasmesse dal Corpo
forestale dello Stato di Brescia relative al possibile affondamento di una nave
a capo Spartivento trovavano un primo riscontro nella documentazione acquisita,
dalla quale risultava l’affondamento della nave da carico Rigel di bandiera
Maltese, inabissatasi il 21 settembre 1987, a20 miglia Sud-Est da capo
Spartivento. La citata nave proveniva da Marina di Carrara ed era diretta a
Limassol e, prima della partenza, risultava avere avuto problemi giudiziari per
il carico a bordo;
- i punti di affondamento delle navi Anni ed
Euroriver, entrambe battenti bandiera maltese, trovavano riscontro con i punti
di dispersione delle scorie pericolose previste dal progetto O.D.M. di Comerio,
nella parte indicata dal punto C. Aree Nazionali Italiane, sequestrato nel corso
della perquisizione;
- era stato accertato che la Capitaneria di porto
di Vibo Valentia aveva richiesto ai locali Vigili del Fuoco accertamenti
radiometrici sulla motonave Jolly Rosso e sulla spiaggia circostante;
- il comandante Bellantone, della Capitaneria di
porto di Vibo Valentia, aveva riferito di avere richiesto lui stesso gli
accertamenti in quanto a bordo della nave erano stati reperiti sia documenti con
strani cenni a materiale radioattivo, sia documenti che lo stesso non aveva
saputo interpretare (gli erano sembrati un “piano di battaglia navale”) e che
poi riconosceva nei progetti O.D.M. sequestrati presso l’abitazione di Comerio.
Il comandante, in quell’occasione, aveva fornito copia del verbale di consegna
della citata documentazione al comandante della Rosso nonché copia dell’istanza
con la quale il capitano Bert M. Kleywegt – in rappresentanza della società
olandese Smit Tak – aveva chiesto l’autorizzazione al recupero della nave;
- il Comerio, per la realizzazione dei suoi
programmi, aveva creato una serie di società quali: Oceanic Disposal Management
Inc. (O.D.M.); Acquavision s.r.l.;Comerio Industry Ltd.; Georadar Ltd.; Mei ltd
Ltd., tutte società strumentali alla realizzazione di telemine, di boe di
rilevamento nonché al reperimento e alla modifica di navi destinate ad utilizzi
illeciti. Nell’informativa citata vennero riportate le dichiarazioni rese,
rispettivamente l’11 e il 12 maggio 1995, da Maria Luigia Nitti (legata
sentimentalmente a Giorgio Comerio dal 1986 al 1993) e da Renato Pent: La prima
dichiarò: “ho sentito parlare il Comerio di un altro suo progetto ossia quello
di creare dei depositi marini di rifiuti radioattivi e ricordo che voleva
coinvolgermi in questo suo affare e per ovvi motivi io non accettai avendo avuto
perdite in altre società. Preciso che il Comerio ha diverse società sparse in
varie citta’ del mondo e ricordo in particolare la Mei ltd (Marine Electronic
Industryes) che operava nella costruzione di boe di rilevamento marino o boe di
segnalazione. Detta società dovrebbe avere sede in Inghilterra. (…) io sapevo
che il suo progetto O.D.M. era ufficiale tant’e’ che aveva accordi con diversi
governi anche dell’est tra cui sicuramente quello russo. Preciso che non erano
accordi conclusi ma di trattative avviate. La mia collaborazione secondo la
richiesta fattami dal Comerio doveva consistere nella elaborazione al computer
di dati relativi al trasferimento dei materiali nella struttura da immergere in
mare. Difatti le operazioni prevedevano l’inabissamento di materiali radioattivi
di varia provenienza mediante l’impiego di un natante. Preciso che nel 1993 il
Comerio mi chiari’ che il progetto Euratom prevedeva l’affondamento in mare di
contenitori con scorie radioattive e che la O.D.M. era una sua società. Ricordo
di avere sentito il nome di tale Convalexius Manfred anche se non l’ho mai
conosciuto. (…) Le uniche volte che sentii parlare il Comerio di materiale
nucleare o radioattivo, riguardava il progetto O.D.M.. Ne parlava in termini
tali da far intendere che l’operazione doveva essere fatta in maniera legale,
tant’è che nell’affare era coinvolto anche l’avv. Gaspari-Vaccari. Tale progetto
di deposito del materiale radioattivo nelle profondità marine faceva seguito ad
attività di ricerca fatte presso il centro Euratom di Ispra, attività nella
quale aveva preso parte anche Comerio richiesto dal centro di fornire un apporto
esterno con la costruzione della BOA di rilevamento”. La Nitti riferì, inoltre,
che Comerio le aveva confidato di far parte dei servizi segreti (“il Comerio mi
esterno’ di appartenere ai servizi segreti tant’e’ che era ossessionato
dall’idea di avere i telefoni sotto controllo al punto che effettuava le sue
telefonate da cabine telefoniche. A seguito di attentati terroristici avvenuti
in quel periodo il Comerio si assento’ dicendo che era stato convocato per
collaborare nelle indagini….preciso che si trattava di attentati dinamitardi
primavera del 1993. Mi pare si trattasse del’attentato all’accademia dei
Georgofili di Firenze.”). Renato Pent, confermando quanto dichiarato dalla
Nitti, affermò (doc. 277/17):
- di avere conosciuto Giorgio Comerio il quale nel
1989/1990 gli aveva proposto di entrare in affari con lui nell’ambito di un
progetto finalizzato allo smaltimento in mare di sostanze radioattive (si tratta
del noto progetto elaborato presso il centro Euratom di Ispra). La
collaborazione richiestagli da Comerio riguardava la messa a disposizione da
parte sua di automezzi idonei per la fase relativa al prelievo del materiale
presso il produttore e al successivo trasporto su imbarcazioni del tipo RO-RO,
che avrebbero poi operato nella fase di affondamento del siluro (l’impiego di
imbarcazioni del tipo RO-RO si spiegava con l’esigenza di permettere agli
automezzi di entrare direttamente nella stiva evitando la fase di trasbordo e la
pubblicità che ne sarebbe derivata col rendere l’operazione visibile agli
estranei);
- di avere visto il filmato relativo alla
sperimentazione della fase di lancio in mare;
- di avere appreso da Comerio che il progetto non
era ancora operativo, ma che avrebbe potuto partire non appena avesse ricevuto
l’acconto da parte di un committente;
- Comerio non gli aveva mai parlato del mare
Mediterraneo, ma del mare prospiciente uno dei paesi dell’Unione sovietica, sul
quale avrebbe iniziato ad operare non appena avesse avuto tutte le
autorizzazioni governative;
- che l’operazione che il Comerio diceva di essere
pronto ad effettuare era relativa al Mar Baltico e sarebbe stata portata avanti
in società con Convalexius;
- di essersi recato a Vienna unitamente a Comerio
e di aver incontrato, per il tramite di Convalexius, alcuni ministri austriaci,
ai quali venne esposto il progetto di Comerio. Comerio aveva preso contatti
anche con il governo svizzero. Entrambi i paesi, pur essendo interessati
all’operazione subordinarono la loro adesione alla preliminare adesione di altri
paesi;
- che, verso la fine del 1994, Comerio gli aveva
riferito che un primo ordine era stato effettuato, ma non gli disse da parte di
quale paese;
- di non conoscere le navi che Comerio aveva
acquistato per effettuare lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- che Comerio aveva dei referenti molto importanti
presso il centro Enea, e ciò lo desumeva dalla gran massa di materiale
progettuale non solo cartaceo, ma anche magnetico proveniente dall’Enea o
comunque da strutture con le quali aveva collaborato l’Enea. Secondo quanto
riferito dal dottor Neri al procuratore capo Scuderi, con la nota più volte
citata (doc. 362/3 allegato), Comerio, subito dopo la perquisizione, trasmise
alla procura una lettera con la quale, dichiarandosi disponibile per ogni
chiarimento, riferiva che:
a) non erano stati acquisiti elementi utili alle
indagini;
b) i progetti e i documenti sequestrati erano
proposte di carattere commerciale;
c) non era stato concluso alcun contratto;
d) si era sempre impegnato per conto della
giustizia nel settore ambientale;
e) quale consulente navale nell’ambito della
difesa aveva sempre lavorato per società estere e solo “per la promozione di
attività fra governo e governo”.
Qualche tempo dopo, precisamente in data 12 luglio
1995, Giorgio Comerio si presentò spontaneamente in procura. In quella occasione
ebbe a dichiarare:
- quanto al progetto O.D.M., che si trattava di un
progetto legale che aveva propagandato presso vari governi per lo smaltimento di
rifiuti radioattivi;
- quanto alla Jolly Rosso, che le carte rinvenute
presso la sua abitazione e relative alla nave si giustificavano con pregresse
trattative finalizzate all’acquisto che lui aveva cercato di concludere per
conto del governo iraniano;
- di avere conosciuto Convalexius perché gli era
stato presentato da Renato Pent;
- di avere conosciuto Marino Ganzerla che aveva
acquistato, attraverso la società Soleana, quote della società O.D.M., e di non
avere avuto con lui proficui rapporti di lavoro, in quanto Ganzerla riteneva che
i penetratori dovessero essere realizzati in cemento. Alla perquisizione
dell’abitazione di Giorgio Comerio seguì quella a casa di Molaschi Gabriele,
conclusasi positivamente con il sequestro di copiosa documentazione che venne
attentamente esaminata dalla polizia giudiziaria procedente. L’esame portò a
ritenere che il Molaschi, così come il Comerio, fosse coinvolto in un complesso
traffico internazionale di armi nonché in attività di smaltimento dei rifiuti
radioattivi. Ritennero gli investigatori che Molaschi avesse contatti con
personaggi di alto livello politico all’estero e riuscisse a a muovere ingenti
flussi di danaro per il continuo rifinanziamento delle sue attività illecite.
Così si legge nell’informativa del 9 giugno 1995, a firma del maresciallo
Moschitta e del carabiniere Francaviglia (doc. 681/15). Si riportano di seguito
alcuni stralci tratti dalla predetta informativa, utili a comprendere in quante
e, soprattutto, in quali delicate direzioni stesse volgendo l’indagine nata
dalla denuncia di Legambiente: “con riferimento al progetto O.D.M., vale a dire
il programma di smaltimento dei rifiuti radioattivi, emerge dalla documentazione
del Molaschi che uno dei siti e’ stato localizzato in una zona africana per come
risulta da un fax che Giorgio Comerio trasmette a Giannantonio Gaspari-Vaccari e
allo stessoMolaschi, in data 30.12.1994, dal seguente tenore (testuale): “AUGURI
DI BUON 1995 – SITO LOCALIZZATO – FIRMA ACCORDI DAL 5 AL 10 GENNAIO A S. BIAGIO
(Comune di Garlasco, n.d.r.) RATIFICA FRA IL 15 ED IL 20 GENNAIO IN AFRICA (DATE
PREVISTE E CONFERMABILI ENTRO IL5.01.1995) CONTRATTI CON CLIENTI NEGOZIABILI DA
1 FEBBRAIO SALUTI ” segue firma. La stessa documentazione consente di appurare
che la O.D.M. e’ in fase di trattative, collocabili agli inizi del 1994, con
l’Ucraina, e precisamente con 4 suoi ministri, in quanto quest’ultimo paese e’
alla ricerca disperata di smaltire un ingente quantitativo di rifiuti
radioattivi. Nel contesto O.D.M. non vanno dimenticate le vicende delle navi
utilizzate come veicoli per l’inabissamento dei rifiuti radioattivi in mare e
anche il Molaschi sembra essere coinvolto (…) presso la sua abitazione questo
Comando ha rinvenuto fotocopia della documentazione della motonave “Jolly Rosso”
(…) La “Jolly Rosso” è così importante anche per MOLASCHI che di essa se ne
trova traccia anche nella sua agenda del 1992 e precisamente nel giorno
indicante il 31 marzo. Il nominativo di detta nave era accomunato a quello della
“ZANUBIA” e “CAREN B” ed a fianco ad ognuno di essi, rispettivamente, vi era
indicata una società’: per la”Jolly Rosso”, Acqua; per la “Zanubia”, Castalia e
per la “Caren B”, Eco-Servizi. (…) Ma, per ritornare al Molaschi, le sue “carte”
aprono, o confermano, altri scenari interessanti quali, per esempio, i depositi
abusivi in Italia di rifiuti radioattivi, di cui vi sono in corso altre indagini
della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Matera,
collegate con le presenti. Il documento, che in sostanza è un appunto
manoscritto datato24.04.1994, fa riferimento alla società’ Nucleco, costituita
dall’Agip e dall’Enea per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, che avrebbe
del materiale accumulato in magazzino. Evidentemente si riferisce al fatto che
detta società ha problemi di smaltimento di rifiuti radioattivi e ciò interessa
l’organizzazione del Comerio.
Tale assunto trova conferma in uno scambio
epistolare tra la Nucleco e la O.D.M., una delle quali datata 20.12.1993, con la
quale la Nucleco, in risposta ad un fax del 23.08.1993 della O.D.M., trasmette i
propri depliants illustrativi sul tipo di attività che svolge. Appare evidente
che alla O.D.M. serviva (alla data odierna non si è a conoscenza dell’esito dei
contatti) la struttura tecnica della Nucleco per coinvolgerla nello smaltimento
a mare dei rifiuti radioattivi (…)”.
Deve tenersi presente che già nel 1985 l’Enea
aveva pubblicato un opuscolo nel quale (alle pagine 8 e 9) si rappresentava la
possibilità di smaltimento di rifiuti radioattivi nei siti marini. Con nota del
4 novembre 1995 il comandante del nucleo oeprativo dei CC, A. Greco, trasmise
tale opuscolo ai magistrati titolari delle indagini (dottor Neri e dottor Pace)
evidenziando che il metodo di inabissamento dei rifiuti illustrato era identico
a quello previsto dal noto progetto O.D.M. di Comerio (doc. 681/31). Nel corso
delle indagini venne sentito un altro socio di Giorgio Comerio, Marino Ganzerla;
anche Ganzerla si presentò spontaneamente, in data 14 luglio 1995, a seguito
della perquisizione che aveva subito il giorno precedente (doc. 277/13).
Ganzerla dichiarò in quella occasione:
- di avere acquistato, quale procuratore della
società Soleana autorità giudiziaria di Vaduz, per la somma di lire 20 milioni,
il 3% di azioni della O.D.M. (società di Comerio), nonché’ il 50% della società
NTM (società di trasporto di rifiuti radioattivi) con sede in Ticino (Svizzera)
al prezzo di 29.000 dollari consegnati a Comerio in Lugano;
- che Comerio gli aveva parlato del suo progetto
di effettuare lo smaltimento dei rifiuti radioattivi in mare attraverso i
penetratori, ma lui si era subito reso conto dell’inattuabilità del progetto sia
perché non sarebbero riusciti a trovare siti idonei, sia perché i penetratori in
acciaio-cemento non sarebbero stati mai omologati perché non erano idonei a
resistere per migliaia di anni in fondo al mare;
- che Comerio non gli aveva mai comunicato punti
di affondamento dei penetratori nel Mediterraneo;
- che con la società O.D.M. non erano mai stati
effettuati smaltimenti di rifiuti radioattivi con i penetratori;
- “per quanto riguarda l’affondamento delle navi
devo dire che circa 10 anni fa venni a conoscenza di progetti di affondamenti di
navi cariche di rifiuti chimici, il cosiddetto sistema delle navi “a perdere,”
truffando così anche le assicurazioni. Se ricordo bene il porto più sospetto era
quello di La Spezia. E ricordo che anche che si diceva che le coste dello Ionio
erano preferite non solo perché gestite dalla ‘ndrangheta ma anche perché i
marinai una volta arrivati a terra con le scialuppe affidavano detti mezzi di
salvataggio a soggetti del luogo e provvedevano ad affondarle o comunque ad
occultarle in maniera definitiva per far sparire ogni traccia dell’affondamento
ed evitare così l’indagine giudiziaria. Mi risulta anche che dette navi facevano
capo ad armatori del Pireo. Nessuna rilevanza hanno le bandiere perché possono
essere cambiate con facilità. Aggiungo che i marinai potevano essere recuperati
anche da altre navi amiche che transitavano appositamente vicino al punto di
affondamento e trasportavano gli stessi in paesi esteri anche perché trattavasi
di marinai stranieri, anche se a volte il comandante o il direttore di macchine
erano italiani o comunque gente fidata degli spedizionieri. Ciò mi fu riferito
se ben ricordo da un greco nel corso di una cena avvenuta circa 10 anni fa a
Genova. Era preferito lo Ionio perché molto profondo. Mi risulta che il Comerio
trattava compravendita di navi”. E’ evidente che le testimonianze acquisite in
quella fase e i documenti sequestrati dagli investigatori fossero estremamente
preziosi al fine di ricostruire, al di là di quanto riferito dalle fonti
confidenziali, la figura e l’attività di Giorgio Comerio nonché di verificare
l’esistenza e – soprattutto – la concreta attuazione dei progetti di smaltimento
in mare di rifiuti radioattivi. La Commissione, nell’ambito degli
approfondimenti svolti nel corso della missione effettuata a Bologna nel
febbraio 2010, ha audito Renato Pent e Marino Ganzerla. Il Pent ha, innanzi
tutto, dichiarato di essere amministratore della Jelly Wax, che produce
paraffine, con sede in Opera, società attiva già nel 1987. Parte dei rifiuti
prodotti nell’ambito dell’attività venivano smaltiti attraverso l’esportazione
degli stessi a mezzo di navi. In particolare, ha riferito in merito
all’esportazione di rifiuti avvenuta a mezzo della nave Links (citata dall’ex
collaboratore Francesco Fonti in un memoriale pubblicato sul settimanale
l’Espresso nel mese di giugno 2005), nonchè della trattativa con il Governo
venezuelano per la realizzazione di una discarica di rifiuti industriali in
Venezuela (per il dettaglio si rimanda al resoconto stenografico relativo
all’audizione del 17 febbraio 2010). Riguardo al tema dell’affondamento di navi
e di rifiuti, il Pent ha dichiarato: “Conosco Comerio, ma non mi risulta che
abbia partecipato. Delle navi affondate ho appreso dai giornali (…). Mi chiedo
perché sia necessario affondare una nave con i rifiuti. (…)”. Il Pent ha
proseguito parlando dei rapporti intrattenuti con l’armatore della motonave
Zanoobia. Alla domanda circa il luogo ove fossero stati depositati i rifiuti
della Zanoobia, il Pent ha risposto che: “I rifiuti sono stati sbarcati a
Genova, dove la nave era stata portata da Marina di Carrara, e smaltiti dalla
Castalia (…) Come sono stati smaltiti non mi è dato di sapere.(…)”. Con
riferimento alle vicende che hanno interessato le motonavi Links e Zanoobia, il
Pent ha fatto riferimento al procedimento penale avviato dalla procura della
Repubblica presso il tribunale di Massa Carrara, conclusosi in primo grado con
sentenza di condanna, acquisita in copia dalla Commissione. I fatti oggetto del
processo attengono all’estorsione denunciata da Renato Pent ed imputata, tra gli
altri, all’armatore della motonave Zanoobia. A prescindere dalla specifica
fattispecie estorsiva, peraltro riconosciuta esistente, la sentenza è importante
perché ricostruisce le vicende originate dall’invio in Venezuela di 2.000
tonnellate di rifiuti industriali caricati sulla motonave Links (doc. 289/2). Se
ne riportano i passaggi fondamentali: “La Jelly Wax s.p.a. di cui Pent Renato
era il legale rappresentante, aveva stipulato in data 21/1/87 con la società
Ambrosini e con la Intercontract un contratto di smaltimento di 2.000 tonnellate
di residui industriali. I rifiuti erano stati caricati sulla nave Lynx nel porto
di Marina di Carrara e dovevano essere trasportati a Gibuti ma, a causa di un
inadempimento contrattuale da parte della Ambrosini, non vi erano mai
arrivati.La Jelly Wax, preso atto dell’inadempimento (per il quale aveva sporto
querela per truffa), aveva stipulato in data 18/3/87 un nuovo contratto di
smaltimento con la società Mercanti Lemport in esecuzione del quale i rifiuti
erano stati sbarcati in Venezuela. Tuttavia, dopo circa sei mesi, a seguito di
una campagna di stampa contraria allo smaltimento di quei rifiuti in Venezuela,
la Jelly Wax era stata di fatto costretta a riprendersi i rifiuti ed a
provvedere in altro modo al loro smaltimento. Il carico di rifiuti era stato
allora imbarcato sulla nave Makiri, che aveva fatto rotta verso il Mediterraneo.
(…) la nave si era diretta a Tartous (Siria). In quella località, aveva tentato
di sbarcare e smaltire il carico di rifiuti, ma non essendo riuscita
l’operazione, i rifiuti erano stati imbarcati sulla nave Zanoobia, al comando
dell’imputato Tabalo Ahmed. La Zanoobia si era quindi diretta in un primo
momento a Salonicco, dove però non era riuscita a scaricare il carico di
rifiuti, e successivamente aveva fatto rotta verso l’Italia, concludendo il suo
viaggio a Marina di Carrara. (…) è emerso che, a seguito delle pressioni del
governo venezuelano, (…) la Jelly Wax (…) aveva stipulato con la ditta Samin un
(secondo) contratto di presa in consegna ed assunzione di proprietà dei rifiuti.
L’accordo era stato concluso in data 10/11/87 tra la Jelly Wax e Tabalo Mohfimed
(…) proprietario della Makiri e della Zanoobia. (…) Successivamente, dopo circa
due mesi, l’imputato Tabalo Mohamed ed il suo legale avv. Rizzuto avevano
comunicato alla Jelly Wax che, per ordine del governo siriano, la merce era
stata caricata sulla nave Zanoobia e doveva essere trasportata fuori dal
territorio siriano perché era stato accertato che il carico era radioattivo.
Pertanto, il Tabalo ed il Rizzuto avevano chiesto al Pent (…) il pagamento di
una somma di 2-300mila dollari per lo smaltimento dei rifiuti, facendo presente
che, in caso di mancata accettazione della proposta, avrebbero rimesso
forzatamente a disposizione della Jelly il carico di rifiuti riportandolo a
Marina di Carrara, con le prevedibili ricadute a danno dell’immagine della Jelly
Wax (…). Quest’ultima non aveva accettato e perciò la Zanoobia, guidata dal
comandante Tabalo Ahmed (fratello di Tabalo Mohamcd), aveva riportato il carico
di rifiuti a Marina di Carrara”. Sono stati riportati i passaggi della sentenza,
depositata il 20 giugno 2003, in quanto le indagini effettuate dalla procura
circondariale di Reggio Calabria avevano riguardato anche le vicende della nave
Zanoobia e, più in generale, l’attività svolta dalla Jelly Wax nonché i rapporti
intercorrenti tra Renato Pent e Giorgio Comerio. La Commissione, sempre in data
17 febbraio 2010, ha audito Marino Ganzerla, il quale ha di fatto negato quanto
affermato innanzi al pubblico ministero Neri con riferimento al fenomeno delle
navi a perdere. In riferimento a Comerio, Ganzerla ha ammesso di avere acquisito
una partecipazione nella società O.D.M.. Ha, tuttavia, negato di aver
acquistato, per conto della Soleana (società che a suo dire non avrebbe mai
operato), il 50 per cento della NTM, società di trasporto dei rifiuti
radioattivi con sede in Svizzera, nel Ticino, versando al Comerio 29.000 dollari
USA. (Tale ultima circostanza, peraltro, era stata dallo stesso Ganzerla
riferita al dottor Neri, come risulta dal verbale di spontanee dichiarazioni del
14 luglio 1995, acquisito in copia dalla Commissione – cfr. doc. 277/13). Con
specifico riferimento alla possibilità di smaltire rifiuti radioattivi tramite
penetratori, il Ganzerla ha precisato di avere sempre nutrito dubbi sulla
legittimità dell’operazione e di essersi rivolto ad un esperto di diritto
internazionale per capire se i rifiuti radioattivi potessero essere scaricati
sotto il fondo marino. L’esperto gli comunicò che, in base alla normativa del
tempo si sarebbe potuto fare, ma che la normativa stessa, di lì a poco sarebbe
cambiata, rendendo illegittime le operazioni in parola. Conseguentemente, a
cavallo tra il 1995 e il 1996, Ganzerla contattò Comerio per comunicargli di non
voler più proseguire l’affare. Ha aggiunto alla Commissione: “Da quanto so, la
società non ha mai operato. Non so se sia andato avanti per conto suo. Non ha
mai fatto niente. Io ho rinunciato a tutto, non gli ho fatto causa per truffa,
mi sono tenuto la perdita e non l’ho più visto”. Con riferimento
all’affondamento di navi finalizzato allo smaltimento di rifiuti, Ganzerla ha
dichiarato di averne sentito parlare solo perché qualcuno (il cui nome non è
stato rivelato) venne a proporgli un affare su questo tipo di attività.
La Commissione ha tuttavia contestato al Ganzerla
di aver reso al dottor Neri dichiarazioni parzialmente diverse. Allorquando poi
la Commissione ha chiesto al Ganzerla il nominativo del personaggio greco dal
quale avrebbe avuto notizia dell’affondamento doloso di navi cariche di rifiuti
tossici nel mediterraneo, il Ganzerla non ha saputo o voluto fornire elementi
utili alla sua identificazione. In generale, può affermarsi che, nel corso
dell’audizione, il Ganzerla si è limitato a rendere informazioni alquanto
generiche e comunque già in possesso della Commissione, ripetendo, in risposta
alle insistenti domande dei commissari, di non ricordare. Dunque le indagini
svolte all’epoca dalla procura di Reggio Calabria, proprio sulla base degli
elementi acquisiti nel corso della perquisizione a carico di Giorgio Comerio, si
incentrarono su tale figura e sui personaggi che gravitavano intorno a lui.
1.6 – Gli affondamenti sospetti di navi nel
Mediterraneo. Gli approfondimenti investigativi svolti dal capitano Natale De
Grazia. L’interesse investigativo si concentrò via via sempre più sugli
affondamenti sospetti di navi avvenuti nel mare Mediterraneo, avendo preso
concretamente piede l’ipotesi che navi cariche di rifiuti radioattivi, o
comunque pericolosi, venissero inabissate dolosamente in modo tale da potere
ricavare il duplice vantaggio rappresentato, da un lato, dall’indebito
risarcimento ottenuto dalla compagnia assicurativa, dall’altro, dal guadagno
derivante dall’attività di illecito smaltimento. Come si è già sottolineato,
all’interno del gruppo investigativo creato dal sostituto procuratore dottor
Neri, un ruolo fondamentale ebbe il capitano di fregata Natale De Grazia, il
quale, a detta di tutti quelli che lavorarono con lui, profuse in questa
indagine un impegno straordinario. Il 30 maggio 1995 il capitano trasmise al
magistrato un appunto, riassuntivo degli elementi fino a quel momento acquisiti.
Se ne riporta il testo (doc. 681/32):
“Appunto per il dottor F. Neri del 30 maggio 1995:
A riepilogo dell’attività investigativa svolta, relativamente allo smaltimento
di rifiuti tossico nocivi e/o radioattivi in mare, si riferisce che da
informazioni confidenziali acquisite dal coordinamento regionale di Brescia del
Corpo forestale dello Stato, si è avuta notizia che era stata affondata al largo
di capo Spartivento una nave carica di materiale nucleare (uranio additivato).
Successivamente durante la perquisizione effettuata presso il signor Giorgio
Comerio si è acquisita documentazione relativa al progetto O.D.M che prevedeva
l’affondamento di rifiuti radioattivi nel sottofondo marino con penetratori
lanciati da navi. Nella documentazione sequestrata, inoltre, vi erano dei
progetti relativi a siluri a lenta corsa denominati “telemine”. Tra gli altri
documenti rinvenuti in casa del Comerio vi erano anche degli appunti/ progetti
preventivi relativi a navi che dovevano essere attrezzate per la realizzazione e
il trasporto delle citate telemine, nonché per l’affondamento dei penetratori
del progetto O.D.M.; inoltre vi erano alcuni appunti con documentazione tecnica
fotografica relativi a navi generalmente vecchie ed in disuso. Tra questi vi
erano gli appunti per l’acquisto del mototraghetto Guglielmo Mazzola, della
motonave SAIS, del f/b Transcontainer I , della motonave Acrux e della motonave
Jolly Rosso. Gli appunti in questione contenevano anche dei progetti di modifica
di una nave RO-RO per la costruzione degli ordigni, riferiti in particolare alle
navi Jolly Rosso e Acrux ora denominata Queen Sea I. Gli atti sequestrati ed
informazioni di polizia giudiziaria hanno fatto nascere il sospetto che il
Comerio avesse individuato le navi in questione per l’acquisto ed il successivo
utilizzo per attività illecite quali la costruzione e posa delle telemine nonché
il traffico e l’affondamento con a bordo rifiuti radioattivi. Onde effettuare
riscontro dei sospetti e delle informazioni confidenziali si è acquisita copia
dei registri Lloyd’s relativi agli incidenti accorsi alle navi in genere, nelle
varie parti del mondo. La documentazione è stata acquisita presso l’ufficio
Lloyd’s Register di Genova. Da un esame di detti registri si ha avuto riscontro
in prima analisi dell’affondamento di una nave a venti miglia a Sud-Est da capo
Spartivento il 21 settembre1997. Il sinistro non risulta dai registri delle
Autorità Marittime e le caratteristiche della nave e la tipologia dell’evento
davano una prima conferma delle informazioni confidenziali. La nave affondata,
denominata “Rigel”, di bandiera Maltese è andata perduta durante il viaggio da
Marina di Carrara a Limassol e l’equipaggio fu tratto in salvo da una nave
Jugoslava denominata “Kral” che sbarcò i naufraghi in un porto della Tunisia. Da
ulteriori informazioni si accertava che la procura della Repubblica di La Spezia
aveva in corso un procedimento a carico di numerosi imputati per l’affondamento
doloso della nave, per truffa all’assicurazione. Per gli imputati di quel
processo è stato richiesto dal tribunale di La Spezia il rinvio a giudizio con
ordinanza in data 20 novembre 1992. Dagli atti dell’ordinanza stessa emerge che
non si ha conoscenza dei carico effettivo della motonave “Rigel” tanto che viene
richiesto il rinvio a giudizio della funzionaria doganale di Marina di Carrara
per aver ricevuto una somma di danaro affinché omettesse di controllare il
carico destinato alla nave. La situazione poco chiara circa la tipologia del
carico è inoltre confermata da una richiesta di compenso all’assicurazione esosa
rispetto al valore della merce dichiarata dai caricatori. La tesi accusatoria e
gli accertamenti successivi dell’autorità giudiziaria. di La Speziafanno perno
su una telefonata tra il signor Gino ed il signor Vito Fuiano, ambedue imputati,
nel corso della quale veniva annunciata la mattina del 21 settembre 1987 la
nascita di un bambino, poi chiarito come allusione all’affondamento della nave.
Nelle agende del Giorgio Comerio sequestrate presso i propri uffici il giorno 21
settembre 1987 si rileva un’annotazione in lingua inglese relativa alla “perdita
della nave” come indicato nell’informativa del 25 maggio 1995; si è proceduto ad
estrarre dai registri Lloyd’s'citati in precedenza numero 23 navi che nei vari
anni sono affondate nel Mediterraneo e delle quali per la maggior parte non si
ha certezza degli eventi. Di questi potrebbero ritenersi dubbiosi, oltre alla
Rigel i seguenti affondamenti:
-M/N “ASO” affondata il 16.05.1979 al largo di
Locri carica con 900 Tonn. di solfato ammonico e da considerarsi un affondamento
a rischio per il tipo di carico e per le circostanze poco chiare emerse
nell’inchiesta sommaria;
- M/N “MIKIGAN” affondata il 31 ottobre 1986 nel
Tirreno in posizione 38:35′ N / 15° 42′ E con un carico di granulato di marmo
era partita dal porto di Marina di Massa lo stesso porto di origine della
“Rigel” dove i controlli sul carico potrebbero essere stati non effettuati;
- M/NA ‘FOUR STAR I” di bandiera Sry Lanka con
carico generale affondata il 9 dicembre1988 in, un punto non noto dello Jonio
Meridionale durante il viaggio da Barcellona ad Antolya (Turchia). Da una
ricostruzione stimata del punto di affondamento la nave in questione potrebbe
essere affondata al ‘largo di capo Spartivento, nei pressi del punto di
affondamento della”Rigel”.La nave potrebbe essere ritenuta sospetta in quanto
non risultano chiamate di soccorso alle Autorità Marittime né denunce di
Sinistro nonostante questo sia avvenuto nella ZEE italiana. La tecnica quindi
potrebbe collegarsi a quella della nave ‘”Rigel”, più volte citata, che non
emesse nessuna richiesta sulle frequenze di soccorso;
- M/N Anni di bandiera Maltese affondata il 01
agosto1989 in alto Adriatico;
- M/N Euroriver di bandiera Maltese affondata
anch’essa in Adriatico il 12 novembre 1991. Queste due navi. di bandiera Maltese
sono affondale in due punti dell’Adriatico che nel progetto O.D.M. reperito tra
i documenti di Comerio sono indicati quali punti previsti nel programma di
dispersione delle scorie nelle aree nazionali italiane e degli affondamenti si
ha notizia dai registri Lloyd’s;
- M/N “ROSSO” di bandiera Italiana arenatasi a
capo Suvero di Vibo Valentia il 14 dicembre 1990 durante il viaggio da Malta a
La Spezia. In merito al sinistro occorso a questa motonave si è riferito
‘nell’informativa del 25 maggio 1995 dove appunto si faceva rilevare la
richiesta di misurazione della radioattività fatta eseguire dalla Capitaneria di
porto di Vibo Valentia Marina per il ritrovamento di documenti che come riferito
dal Comandate di quell’Ufficio Marittimo sarebbero i progetti O.D.M.. Inoltre
dell’unità in questione furono trovati presso il Comerio i progetti di
trasformazione per la costruzione delle ‘telemine”. Circa le navi affondate
elencate nell’informativa inizialmente citata sospetti sul carico sono basati
sulla bandiera delle navi, quasi sempre di comodo e dal fatto che non si é a
conoscenza degli sviluppi del sinistro. Si fa riserva di comunicare tutte le
ulteriori informazioni necessarie qualora scaturissero ulteriori elementi dalle
indagini in corso. Reggio Calabria, li 30 maggio 1995 capitano De Grazia”. Gli
elementi riassunti nell’appunto del capitano De Grazia spinsero gli
investigatori a concentrarsi sull’ipotesi investigativa relativa
all’affondamento doloso di navi partendo dall’individuazione di tutti gli
affondamenti che parevano “sospetti” o per le circostanze dell’affondamento o
per la natura del carico. Il gruppo di lavoro si dedicò, innanzitutto,
all’affondamento della motonave Rigel, avvenuto il 21 settembre 1987 di fronte a
capo Spartivento, nonchè allo spiaggiamento della motonave Rosso, avvenuto di
fronte alle coste di Amantea il 14 dicembre 1990. Altri accertamenti furono
delegati in ordine ad altri sospetti affondamenti, come si evince dalla delega,
del 17 luglio 1995, emessa dal sostituto procuratore F. Neri ed indirizzata al
capitano De Grazia ed al maresciallo Moschitta, i quali avrebbero dovuto
accertare:
“a) i motivi del trasporto del materiale
radioattivo da parte della nave Acrux e quindi acquisire in copia tutta la
documentazione utile alle indagini;
b) richiedere alla Capitaneria di porto di Genova
quali siano le navi che normalmente caricano o scaricano materiale tossico
nocivo o radioattivo dalle banchine del Ponte Libia di Genova;
c) accertare in La Spezia presso gli uffici
competenti quali merci pericolosi siano transitate (tossico nocive o radiattive)
dalle banchine della Cont Ship italia;
d) vorranno contattare le forze di polizia
giudiziaria di La Spezia che possano fornire elementi utili di indagine sul
procedimento in corso. dato in Brescia 13.07.95”. Gli approfondimenti relativi
alla Rigel e alla Rosso verranno di seguito trattati in paragrafi separati in
quanto, in riferimento a ciascuna delle due vicende, gli investigatori svolsero
attività consistite nel ricostruire – partendo dagli atti di indagine già svolti
dalla procura di La Spezia e dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia – tutte
le circostanze relative all’affondamento, al carico delle navi, alla formazione
dell’equipaggio. Le due vicende, apparentemente separate, avevano in realtà dei
punti di connessione che furono individuati proprio nel corso delle indagini.
1.7 – L’affondamento della motonave Rigel:
l’indagine della procura della Repubblica presso il tribunale di La Spezia e le
successive attività investigative della procura di Reggio Calabria. La motonave
Rigel, di proprietà della Mayfair Shipping Company Limited di Malta, affondò,
secondo la versione ufficiale, a 20 miglia al largo di capo Spartivento –
promontorio situato nel Comune di Brancaleone (RC) – in acque internazionali, il
21 settembre 1987, dopo essere partita dal porto di Marina di Carrara il 2
settembre 1987, diretta a Limassol, Cipro. Secondo le indagini svolte dalla
procura della Repubblica di La Spezia nell’ambito del procedimento penale n.
814/1986RGNR, la Rigel fu affondata dolosamente. I responsabili, rinviati a
giudizio il 20 novembre 1992 per aver cagionato il naufragio della nave al fine
di truffare la società di assicurazioni, furono condannati con sentenza
confermata nei successivi gradi di giudizio. Appare opportuno ripercorre i
passaggi fondamentali della sentenza-ordinanza del 20 novembre 1992 in quanto
furono poi ripresi dal procuratore Neri e dal capitano De Grazia al fine di
approfondire il tema concernente il carico della nave e l’eventuale utilizzo
della stessa per lo smaltimento illecito di rifiuti radioattivi, aspetto questo
non affrontato nell’inchiesta di La Spezia. Secondo quanto si legge nel
provvedimento giudiziario citato, l’accordo per l’affondamento della nave
intervenne tra Luigi Divano (titolare della Trade Centre s.r.l.), Vito Bellacosa
(di professione agente marittimo, titolare dell’agenzia marittima “Spediamar”
corrente in la Spezia), Fuiano Gennaro (di professione funzionario doganale),
Cappa Giuseppe e Figliè Carlo, quest’ultimo titolare di un’agenzia marittima in
Marina di Carrara (quali organizzatori in Italia e ricercatori delle persone da
indurre ad effettuare un fittizio trasporto di merce destinata
all’affondamento), Khoury e Papanicolau (il primo quale fittizio acquirente
della merce caricata sulla Rigel, e il secondo quale fornitore del mezzo da far
naufragare), il capitano Vassiliadis come esecutore materiale nonché capitano
della Rigel. Nel corso dell’indagine erano state intercettate le utenze in uso a
Gennaro Fuiano, funzionario di dogana già sospeso, e a Luigi Divano,
intermediatore di affari di Rapallo. Particolarmente interessante per gli
investigatori calabresi si rivelò la conversazione telefonica del 24 marzo 1987
tra Gennaro Fujano e Vito Bellacosa (il quale si trovava a Limassol, Cipro,
presso la sede della società di Khoury) nella quale si parlava di un carico da
spedire “colà”, con un “carico buono e meno buono” (definito testualmente
“merda” da Bellacosa). Poiché in quel periodo i soggetti erano impegnati
nell’organizzazione della truffa assicurativa, il riferimento al carico della
nave apparve di sicuro interesse investigativo, tenuto conto del fatto che il
carico “buono” non poteva essere inteso come la parte del carico da far arrivare
a destinazione (atteso che tutta la nave era destinata ad affondare). Dunque,
gli investigatori interpretarono le espressioni utilizzate come riferite ai
rifiuti, in parte definiti buoni (cioè non pericolosi) e in parte non buoni
(quindi tossici). L’altra conversazione di interesse fu quella del 21 settembre
1987, sempre tra Gennaro Fujano e Vito Bellacosa, nella quale venne pronunciata
l’espressione: “il bambino è nato”, con ciò indicandosi, secondo l’ipotesi
investigativa, con una metafora, il buon esito della operazione di affondamento,
che infatti avvenne proprio in quella data. Gli atti del processo di La Spezia
offrirono agli investigatori coordinati dal dottor Neri elementi di conferma di
estrema importanza alle ipotesi investigative formulate, spingendoli ad
approfondire sempre di più l’aspetto che invece non era stato oggetto delle
indagini dell’autorità giudiziaria di La Spezia, ossia quello della natura del
carico della nave.
Nel processo di La Spezia, infatti, venne
definitivamente accertata la natura dolosa dell’affondamento della Rigel e la
truffa ai danni dell’assicurazione. Gli imputati vennero giudicati in relazione
ai reati di associazione a delinquere, truffa ai danni della società
assicurativa, corruzione ed altri reati connessi e finalizzati a conseguire il
premio assicurativo, ma nulla venne accertato in merito all’effettivo carico
della nave. In sostanza, nel processo di La Spezia non venne neppure ipotizzato
che la nave Rigel fosse stata caricata con rifiuti tossici e pericolosi: ed,
infatti, nessun elemento era emerso in questo senso né dalle testimonianze né
dai documenti, appositamente falsificati per far risultare un carico diverso da
quello effettivo. Gli atti del procedimento furono, pertanto, riesaminati dal
capitano De Grazia, al fine verificare quale fosse il carico della motonave
affondata, sospettandosi che unitamente alla stessa fossero stati inabissati
rifiuti radioattivi. Indicazioni precise in questo senso erano state fornite
dalla fonte confidenziale denominata “Pinocchio” (di cui all’informativa citata
del 13 maggio 1995 del Corpo forestale dello Stato, doc. 118/7), che aveva fatto
riferimento ad una nave affondata in Calabria, a largo di capo Spartivento, a
venti miglia circa dalla costa, nave che – secondo gli investigatori – poteva
appunto identificarsi con la Rigel (cfr. par. 1.4). Due importanti elementi di
riscontro, considerati unitariamente, convinsero gli investigatori a ritenere
più che fondate le dichiarazioni della fonte confidenziale anzidetta e li
spinsero a ricercare ulteriori prove. Posto che la motonave Rigel era affondata
il 21 settembre 1987 a largo di capo Spartivento, come accertato dal processo di
La Spezia, il primo elemento di riscontro fu ricavato dall’annotazione “lost the
ship” rinvenuta sull’agenda sequestrata a Giorgio Comerio proprio sulla pagina
corrispondente alla data 21 settembre 1987. Il secondo elemento proveniva
direttamente dalle informazioni acquisite dal capitano De Grazia presso i
registri Lloyds di Londra, che coprono il 90% della situazione mondiale di tutte
le navi affondate, e presso l’IMO, secondo cui l’unica nave affondata il 21
settembre 1987 era la motonave Rigel. Dunque, secondo gli investigatori,
l’annotazione di Comerio non poteva che riferirsi alla Rigel e, tenuto conto
della documentazione trovata in possesso del Comerio attinente al progetto Dodos
e alla società O.D.M., era legittimo ritenere che l’interesse del Comerio alle
sorti della Rigel potesse essere legato al carico di rifiuti tossici. Gli
investigatori cercarono – tra gli atti del processo di La Spezia – altri
elementi utili a rafforzare il quadro che velocemente si andava delineando. Da
subito si comprese che fondamentale era il ritrovamento della nave e del suo
carico. In particolare, il capitano De Grazia si concentrò in tale direzione,
cercando di individuare il punto esatto di affondamento della motonave Rigel.
Significative in merito sono alcune informative che il capitano De Grazia
trasmise al sostituto dottor Francesco Neri nel mese di giugno 1995, riportate
di seguito, nelle quali vengono riassunti gli elementi fino a quel momento
acquisiti, evidenziandosi che (cfr. inf. del 16, del 22 e del 26 giugno 1995 –
doc. 681/32, 681/18, 681/21):
- la procura della Repubblica di La Spezia aveva
accertato l’affondamento doloso della Rigel, finalizzato a truffare la compagnia
assicuratrice;
- nell’ambito del procedimento di La Spezia era
emerso che due degli indagati – in una telefonata del 21 settembre 1987 –
avevano fatto riferimento alla nascita di un bambino, poi chiarita dagli stessi
come allusione all’affondamento della nave;
- Giorgio Comerio aveva annotato sulla sua agenda
l’evento dell’affondamento, scrivendo alla data del 21 settembre 1987: “lost the
ship”;
- una copia dei progetti O.D.M. di Giorgio Comerio
era stata trovata sulla plancia della motonave Jolly Rosso, spiaggiatasi ad
Amantea il 14 dicembre 1990, dal comandante della Capitaneria di porto di Vibo
Valentia, Bellantone;
- per individuare il relitto della nave al largo
di capo Spartivento, stante la disponibilità dei mezzi offerta dal Comando
generale delle Capitanerie di porto, occorreva individuare la tipologia del
mezzo nautico da impiegare, quindi, acquisire notizie tecniche circa le
apparecchiature e le modalità d’impiego di sonar per l’individuazione dei
relitti, nonché di strumenti idonei alla misurazione della radioattività;
- per tale attività si chiedeva all’autorità
giudiziaria l’autorizzazione a recarsi a Roma per prendere contatti diretti con
l’ingegner Bertone del centro ricerche nucleari di Roma e con il reparto
pperazioni del comando generale delle Capitanerie di porto per la pianificazione
delle attività da porre in essere. Conclusivamente, con riferimento alla Rigel,
le attività del capitano De Grazia si concentrarono essenzialmente nell’esame
della documentazione sequestrata a Comerio, nell’individuazione di elementi di
collegamento con l’affondamento della Rigel e nella ricerca del punto esatto di
affondamento della motonave, condizione questa indispensabile per avviare
proficue attività di ricerca del relitto. Sebbene fosse stato ritenuto
necessario procedere ad una nuova escussione dei soggetti coinvolti
nell’inchiesta di La Spezia, con particolare riferimento alla natura del carico
e alle relative operazioni, tuttavia, il capitano De Grazia non ebbe la
possibilità di parteciparvi personalmente in quanto deceduto prima che venissero
svolte queste attività.
Successivamente, fu il maresciallo Scimone ad
effettuare le attività predette, di cui si renderà conto nel prosieguo della
relazione. Va detto, fin da subito, che – secondo la testimonianza del
magistrato Nicola Maria Pace – il capitano De Grazia sarebbe riuscito ad
individuare le coordinate relative al punto di affondamento, tanto che
insistette, proprio la mattina della sua partenza per La Spezia, per portarvi lo
stesso magistrato. Si riporta il passo dell’audizione del dottor Pace, avvenuta
avanti alla Commissione in data 12 gennaio 2010: “Quando è giunta la notizia
della morte di De Grazia io, Neri ed altri non abbiamo avuto dubbi sul fatto che
quella morte non fosse dovuta a un evento naturale. Avevo sentito De Grazia alle
10,30 di quella mattina, mi aveva detto che con una delega di Neri si sarebbe
recato prima a Massa Marittima e poi a la Spezia, mi avrebbe aspettato a Reggio
Calabria per portarmi con una nave sul punto esatto in cui è affondata la Rigel.
Alle 10,30 del 13 dicembre, giorno in cui è morto, ricevetti questa sua
telefonata in ufficio, ma non sono in grado di fornire elementi obiettivi”.
1.8 – Lo spiaggiamento della Jolly Rosso e Giorgio
Comerio. Gli approfondimenti svolti dal capitano De Grazia. Particolare
attenzione suscitò la vicenda della motonave Rosso, della compagnia di Ignazio
Messina. Tale nave naufragò al largo di capo Suvero, in Calabria, in data 14
dicembre 1990 (con immediato abbandono della stessa da parte di tutto
l’equipaggio), per arenarsi sulla costa di Amantea (CS) nella stessa giornata
(doc. 695/1). Sullo spiaggiamento, inzialmente, non venne avviata alcuna
indagine di carattere penale, ma solo un’indagine amministrativa da parte della
compagnia di assicurazione e un’inchiesta da parte della Capitaneria di porto di
Vibo Valentia di cui si dà atto nel rapporto riassuntivo a firma del comandante
Giuseppe Bellantone (doc. 695/19). Nel 1994 la vicenda della Rosso fu oggetto di
ulteriore approfondimento nell’ambito dell’indagine condotta da dottor Francesco
Neri. Il motivo dell’approfondimento era da collegarsi ad una serie di
circostanze sospette, prima fra tutte quella relativa al rinvenimento presso
l’abitazione di Comerio, in Garlasco, di documentazione attinente alla motonave
Jolly Rosso.
Particolarmente importanti furono le dichiarazioni
rese dal comandante Bellantone al capitano De Grazia, assunte da quest’ultimo
informalmente, delle quali si dà conto nell’informativa del 30 maggio 1995 (doc.
681/32): “(…) dall’indagine sommarla esperita dalla Capitaneria di porto di Vibo
Valentia Marina emerge che il comandante di quella Capitaneria ha richiesto, a
seguito dell’incaglio, degli accertamenti radiometrici sulla nave semi sommersa.
Data l’inusualità dell’accertamento si è contattato il comandante di quella
Capitaneria di porto Bellantoni il quale riferiva di avere lui stesso richiesto
detti accertamenti in quanto in alcuni documenti reperiti a bordo della nave vi
erano strani cenni a materiale radioattivo. Successivamente, il preddetto
comandante riferiva oralmente che sulla nave aveva rinvenuto della
documentazione che non aveva saputo interpretare ma che comunque gli sembravano
dei piani di “battaglia navale” che poi riconosceva nei progetti O.D.M.
sequestrati presso l’abitazione-laboratorio del Comerio.
Il citato Ufficiale in quella occasione forniva
copia del verbale di consegna della succitata documentazione al comandante della
“Rosso”, nonché copia dell’istanza con la quale il Capitano Bert M. Kleywegt in
rappresentanza della società Smit Tak, olandese, aveva chiesto- l’autorizzazione
al recupero della suddetta nave. Viene riferito ciò in quanto la ditta, pur
avendo operato per circa 30 giorni, non ha effettuato alcuna attività di
recupero nonostante abbia operato con dei subaquei, alcuni gommoni e un grosso
Tir”. Successivamente il comandante Bellantone fu sentito a sommarie
informazioni dai procuratori Scuderi e Neri (in data29 febbraio 1996) ed anche
in tale circostanza confermò quanto dichiarato informalmente al capitano De
Grazia sulla presenza – a bordo della Rosso – di documenti con strani cenni a
materiale radioattivo. Precisò ancora che, all’epoca, il capitano De Grazia gli
mostrò un opuscolo con uno stemma triangolare della società O.D.M. uguale a
quello dallo stesso notato a bordo della nave (doc. 695/7). Al verbale di
sommarie informazioni vi è il documento citato, di cui si riporta il
frontespizio: E’ importante sottolineare che il comandante Bellantone è stato
successivamente sentito sia dal pubblico ministero di Paola, Francesco Greco,
nell’anno 2004, sia dalla Commissione in data 8 marzo 2011. Le dichiarazioni
fornite in tale occasioni sono risultate contrastanti tra di loro nonché con
quanto precedentemente dichiarato ai magistrati e al capitano De Grazia. In
particolare, nel verbale di sit del 15 luglio 2004 (doc. 695/7), il comandante
ha dichiarato, quanto ai documenti rinvenuti sulla Rosso, di avere visto su
qualche documento uno stemma a forma di triangolo con la scritta O.D.M. nonché
di non conoscere all’epoca dello spiaggiamento il significato della scritta
O.D.M.. Tuttavia il comandante ha in qualche modo modificato le dichiarazioni
già rese ai magistrati di Reggio Calabria affermando: “Non ricordo di aver visto
sulla nave una cartografia raffigurante i siti di affondamento di navi che possa
raffigurare una battaglia navale. Ricordo però che la stessa mi fu mostrata dal
magistrato Neri di Reggio Calabria e o dal suo collaboratore Natale De Grazia.”
Nel corso dell’audizione dinnanzi alla Commissione il comandante Bellantone ha
oscillato tra smentite, parziali conferme e dichiarazioni di non ricordare,
palesando finanche la possibilità che le sue dichiarazioni avanti ai magistrati
di Reggio Calabria non fossero state fedelmente riportate. Risulta, quindi, allo
stato incerto quello che effettivamente fu rinvenuto a bordo della motonave
Rosso, in mancanza di verbali di sequestro redatti in quell’occasione. Non può
essere ignorato il fatto che le iniziali dichiarazioni rese dal comandante
Bellantone al Capitanto De Grazia, riportate nell’annotazione citata e
successivamente confermate ai magistrati di Reggio Calabria, sono quelle rese in
epoca più prossima ai fatti e, quindi, da ritenere, secondo criteri di comune
esperienza, più attendibili. Come si avrà modo di evidenziare, il capitano De
Grazia, pur incaricato di sviluppare questi aspetti, non ebbe la possibilità di
portare a termine l’attività per le ragioni che di seguito si andranno ad
esporre. 1.9 – Le verifiche effettuate dal capitano De Grazia in merito agli
ulteriori affondamenti sospetti. Come già evidenziato, il capitano De Grazia, in
ragione delle sue specifiche competenze, operò una verifica – presso la
compagnia di assicurazione Lloyd di Londra – in ordine agli affondamenti
sospetti di navi, stilando un elenco che avrebbe dovuto costituire la base di
ulteriori approfondimenti. E, pertanto, si può sostenere, senza timore di
smentita, che il capitano approfondì proprio l’aspetto attinente all’utilizzo di
navi per lo smaltimento illecito dei rifiuti radioattivi sia attraverso il loro
affondamento sia, più in generale, attraverso il loro utilizzo per il trasporto
verso paesi esteri. Ed è proprio in questo ampio contesto investigativo che va
esaminata la vicenda, dai contorni poco chiari, relativa alla motonave Latvia,
ormeggiata presso il porto di La Spezia, di cui si ha traccia in due informative
del Corpo forestale dello Stato di Brescia indirizzate al procuratore Neri.
Dell’esistenza di questa nave si dà conto per la prima volta nell’annotazione di
polizia giudiziaria redatta dal Corpo forestale dello Stato di Brescia in data
26 ottobre 1995 (doc. 277/8), nella quale si evidenzia che la nave, venduta ad
un prezzo superiore al valore reale, avrebbe potuto essere destinata al
trasporto di rifiuti nucleari e/o tossico-nocivi. Si riportano i passi di
interesse dell’informativa, redatta previaassunzione di informazioni di cui
all’articolo 203 del codice di procedura penale:
“(…) Motonave Latvia. Nell’area portuale di La
Spezia è presente la motonave Latvia. adibita al trasporto passeggeri,
ex-sovietica, giunta nei cantieri ORAM prima della caduta del blocco orientale.
Nave ritenuta come appartenente ai servizi segreti sovietici (KGB) (…).
Attualmente è ormeggiata alla diga di La Spezia, è stata messa in vendita (forse
dal tribunale) ed acquistata da una società Liberiana con sede in Monrovia,
tramite un ufficio legale di La Spezia. Da fonte attendibile risulta che il
prezzo pagato è superiore di quello del valore reale, e questo fa supporre che
potrebbe essere utilizzata come “bagnarola“ per traffici illegali di varia
natura, in particolare di rifiuti nucleari e o tossico-nocivi, (esempi pratici
sono le cosiddette navi dei veleni) (…)”. Ancora, la Latvia viene menzionata
nell’annotazione di polizia giudiziaria redatta, in data 10 novembre 1995, con
la quale il brigadiere Gianni De Podestà comunicò alle procure di Reggio
Calabria e di Napoli che fonte confidenziale attendibile aveva di recente
riferito in merito al coinvolgimento di famiglie camorristiche e logge
massoniche deviate nei traffici di rifiuti radioattivi e tossico nocivi
interessanti la zona di La Spezia e l’interland napoletano. Nell’annotazione si
dava atto che la Latvia, così come già era stato fatto per la Rigel e la Jolly
Rosso, avrebbe dovuto essere preparata per salpare nell’arco di 4 giorni con un
carico non ben definito (rifiuti tossico-nocivi e/o radioattivi) per poi seguire
la rotta La Spezia-Napoli (per un ulteriore carico, come accertato per la Rosso)
– Stretto di Messina-Malta – ritorno sulle coste joniche (per affondamento).
Dall’annotazione in parola si evince che la fonte confidenziale cui si fa
riferimento è la stessa di cui all’informativa del 13 maggio 1995 richiamata
espressamente, e dunque la fonte denominata “Pinocchio”. Si riporta parte del
testo dell’annotazione del 10 novembre 1995 (doc. 681/32): “Fonte confidenziale
attendibile ha qui riferito, in epoca recente, del traffico di rifiuti
radioattivi e tossico-nocivi che interessano in particolar modo la zona di La
Spezia e l’interland napoletano e quindi il coinvoglimerito di famiglie
camorristiche e logge massoniche deviate. Nella prima annotazione di p.g.
redatta in data 13.5.95 in questo ufficio, l’informatore riferiva di personaggi
legati al traffico La Spezia~Napoli-Reggio Calabria e oltremare (…). In merito
all’annotazione di p.g. prot. 1045 del. 26 ottobre u.s., ove la fonte
confidenziale (rimane tale per ragioni disicurezza personale, familiare e per la
p.g.. che lavora all’indagine) ha riferito che nell’area portuale di La Spezia
vi è presente la motonave Latvia (ex KGB russo) e che tale imbarcazione dovrebbe
essere preparata come è stato fatto per la Rigel e la Jolly Rosso e quindi
destinata sui fondali marini come quest’ultime. Ancora la Latvia, se vengono
rispettati i tempi di allestimento e caricamento della Jolly Rosso (dal
4.12.90all’8.12.1990) nell’arco di 4 giorni, risulterà pronta a salpare daLa
Spezia, con un carico non ben definito (rifiuti tossico-nocivi e/o radioattivi)
per poi seguire la seguente rotta marittima : — La Spezia >Napoli- (porto)
—>Stretto di Messina >Malta >ritorno sulle Coste Joniche (per affondamento).
Risulta tappa importante il porto di Napoli, dove al carico di La Spezia
dovrebbe essere aggiunto dell’altro (come accertato per la Jolly Rosso poi
Rosso) e seguito in via strettamente riservata da persone di fiducia (uomini di
fiducia del camorra napoletana legata al Di Francia e alla mafia sici1iana, che
ha una ramificazione in La Spezia con un certo Giarusso)”. Dunque, si iniziò ad
indagare anche sulla Latvia, per le ragioni che emergono nelle informative
appena riportate. In particolare, oggetto di attenzione fu il carico, la
provenienza della nave, la sua destinazione nonché le ragioni della lunga
permanenza presso il porto di La Spezia. E’ di tutta evidenza l’importanza che
gli approfondimenti sulla Latvia avevano nell’ambito dell’inchiesta. Si
trattava, infatti, di una nave che era possibile monitorare per così dire “in
diretta” e che consentiva, quindi, di superare i vuoti conoscitivi attinenti
alle altre navi delle quali si erano perse le tracce. Appare, quindi, del tutto
credibile la circostanza emersa nell’ambito dell’inchiesta svolta dalla
Commissione, secondo la quale il capitano De Grazia si sarebbe dovuto recare a
La Spezia anche per effettuare indagini con riferimento alla predetta nave e per
avere un contatto diretto con la fonte confidenziale che aveva già riferito
informazioni in merito alla Latvia (cfr. informative appena riportate nonché
paragrafo 1.10 nel quale si tratta delle indagini che a La Spezia avrebbe dovuto
effettuare il capitano De Grazia). Tale circostanza, invero, non risulta da
alcun documento, ma è stata rappresentata alla Commissione da un soggetto il cui
nome è rimasto segretato e che – all’epoca dei fatti – aveva collaborato con il
Corpo forestale dello Stato di Brescia. (verificare con il Presidente se si può
inserire il racconto fatto da questo soggetto in merito alle indagini fatte
sulla Latvia, parte tutta segretata). In data 15 dicembre 1995, due giorni dopo
il decesso del capitano De Grazia, l’ispettore Tassi trasmise un fax alla
procura circondariale di Reggio Calabria nel quale testualmente riferiva (doc.
634/1): “In data odierna è stata accertata la partenza della Motonave Latvia,
avvenuta all’incirca verso la terza decina del Novembre u.s. per raggiungere il
porto di ARIGA (Turchia). La Motonaveè stata acquistata tramite il tribunale di
La Spezia, da una Soc. Ciberiana la “DIDO STEEL Corporation S.A.” con sede in
Brod Street Monrovia Liberia, Il trasporto è avvenuto o sta avvenendo a traino
di un rimorchiatore denominato Kerveros di nazionalità greca. Le pratiche sono
state curate da una Agenzia Marittima Spezzina”. Lo stesso ispettore Tassi, nel
marzo 1996, trasmise, sempre al sostituto procuratore dottor Neri, sette
fotografie della motonave in questione (doc. 681/71): Nell’ambito dell’indagine
condotta dal dottor Neri gli approfondimenti relativi alla motonave Latvia
furono esclusivamente quelli contenuti nelle due informative dell’ispettore De
Podestà, sopra riportate, nonché la comunicazione dell’ispettore Tassi relativa
all’avvenuta partenza della nave, collocata temporalmente alla fine di novembre
(dopo il decesso del capitano De Grazia). Non può non sottolinearsi la
peculiarità della vicenda, tenuto conto dei seguenti dati:
- nel pieno di indagini concernenti l’utilizzo di
navi per lo smaltimento illecito di rifiuti tossici, vi era la possibilità di
monitorare una nave, la Latvia, rispetto alla quale vi erano concreti indizi in
merito al suo utilizzo per le predette finalità illecite;
- ebbene, nonostante la preziosissima fonte di
informazioni, rappresentata dalla motonave in questione, non solo non risultano
effettuate verifiche approfondite da parte degli ufficiali di polizia
giudiziaria della zona, ma neppure risultano essere stati mai sentiti gli
occupanti della nave;
- paradossale è poi che non sia stato predisposto
un servizio di osservazione in merito agli spostamenti della nave.
1.10 – Le indagini che il capitano De Grazia
avrebbe dovuto compiere a La Spezia. La Commissione ha ritenuto di fondamentale
importanza comprendere quale fosse l’oggetto specifico delle indagini che il
capitano De Grazia, unitamente al maresciallo Moschitta e al maresciallo
Francaviglia, avrebbe dovuto effettuare recandosi a La Spezia dal 12 dicembre
1995. Deve sin d’ora sottolinearsi come questo approfondimento, teoricamente
agevole in quanto erano state predisposte deleghe di indagine da parte del
pubblico ministero procedente, si è rivelato nei fatti difficoltoso.
La documentazione acquisita, costituita da ben sei
deleghe, alcune delle quali conferite specificatamente ai militari in missione,
non si è rivelata risolutiva in quanto le deleghe in questione sono state
formulate in modo alquanto generico. Non è noto se per ragioni precauzionali e
di riservatezza o per lasciare ampio margine di manovra agli ufficiali di
polizia giudiziaria. Neppure chiarificatrici sono state le dichiarazioni rese
sul punto da quegli stessi ufficiali che parteciparono alla missione in
questione. Contraddittorie, infine, sono state le informazioni acquisite dagli
altri investigatori impegnati nell’indagine. Poco chiara è stata anche la
vicenda attinente alla valigetta che il capitano De Grazia portava con sé,
valigetta che non è stata mai sequestrata, ma solo affidata in custodia al
maresciallo Moschitta e restituita, successivamente, al dottor Neri. Il
contenuto della valigetta in questione non risulta mai inventariato essendo
stata solo riportata genericamente (in un’annotazione di polizia giudiziaria) la
presenza al suo interno di documenti attinenti all’indagine di cui al
procedimento penale n. 2114/94 RGNR. La Commissione ha acquisito le copie delle
sei deleghe di indagine emesse in data 11 dicembre 1995 dai magistrati di Reggio
Calabria (sostituto F. Neri e procuratore F. Scuderi). Dall’analisi delle stesse
si ricava che la prima era finalizzata all’escussione di Cesare Granchi e
all’acquisizione in copia conforme di tutta la documentazione attinente ai
rapporti commerciali e societari con Giorgio Comerio, con particolare
riferimento a quelli concernenti la realizzazione del progetto O.D.M. (doc.
681/87); la seconda era indirizzata al presidente del tribunale di La Spezia,
affinché il capitano di fregata Natale De Grazia e il maresciallo Nicolò M.
Moschitta fossero autorizzati a visionare e estrarre copia degli atti del
procedimento penale nr. 814/1986 (a carico Fuiano Gennaro + altri – Affondamento
M/n Rigel) (doc. 681/87); la terza era indirizzata al procuratore della
Repubblica presso il tribunale di La Spezia, affinché il “vice ispettore Claudio
Tassi della sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato della
procura della Repubblica di La Spezia fosse autorizzato a svolgere le indagini
delegategli nell’ambito del procedimento penale 2114/94”. (doc. 681/87); con la
quarta si chiedeva al vice ispettore Tassi di voler svolgere tutte le indagini
già concordate nell’ambito del procedimento penale 2114/94 anche fuori sede
(doc. 695/16). Con le ultime due, indirizzate ai procuratori della Repubblica
presso la pretura circondariale e presso il tribunale di Salerno, si richiedeva
di consegnare al maresciallo Moschitta copia di tutti gli atti relativi agli
accertamenti effettuati in merito allo spiaggiamento di un container, avvenuto a
Positano nell’aprile del 1994, avente tracce di radioattività (Torio) e
riferibile all’affondamento della motonave Marco Polo (doc. 681/87). Dunque, le
attività delegate sarebbero dovute consistere in parte nell’esame di atti
processuali, in parte nel compimento di attività concordate precedentemente e
non esplicitate nelle deleghe. Come già evidenziato, la Commissione ha ritenuto
di audire tutti coloro in grado di fornire precisazioni in merito alle indagini
da compiersi a La Spezia.
In particolare, sono stati sentiti il maresciallo
Moschitta, il carabiniere Francaviglia, il maresciallo Scimone, l’ispettore
Tassi e un soggetto del quale non possono essere fornite le generalità per
ragioni di segretezza. A fronte dell’importanza della missione, così come
rappresentata dai magistrati e dagli stessi ufficiali di polizia giudiziaria,
nessuno di essi è stato in grado di specificare in modo puntuale quali fossero
effettivamente le attività da svolgere e per quale motivo il capitano De Grazia
fosse diretto a La Spezia. Peraltro, a bene esaminare le dichiarazioni, le
stesse risultano non solo generiche, ma anche in alcuni punti contraddittorie
tra di loro. Formalmente, dalla delega acquisita il capitano De Grazia avrebbe
dovuto esaminare gli atti processuali attinenti all’affondamento della motonave
Rigel. Stando però le dichiarazioni rese alla Commissione dalle persone sopra
indicate, il capitano De Grazia avrebbe dovuto:
- sentire a sommarie informazioni alcuni
componenti dell’equipaggio della Rosso;
- effettuare ulteriori approfondimenti in merito
agli affondamenti sospetti di navi rilevati dai registri Lloyd’s Adriatico;
- incontrare una fonte confidenziale già
utilizzata dall’ispettore Tassi al fine di apprendere notizie in merito alla
motonave Latvia, ormeggiata presso il porto di La Spezia.
Anche il pubblico ministero Neri, nel verbale di
sommarie informazioni rese al pubblico ministero Russo in data 9 aprile 1997
nell’ambito dell’indagine avviata in ordine al decesso del capitano De Grazia,
ha affermato genericamente che “la missione a La Spezia aveva lo scopo di
sentire testi presenti sulle navi affondate”. In particolare: ”il capitano era
partito per La Spezia e Massa Carrara per sentire testi delle navi oggetto delle
indagini. Lui stesso ci spiegò che vi era l’urgenza di fare questi accertamenti
per evitare anche inquinamenti probatori e che completata questa fase
investigativa fuori sede nel corso delle vacanze di Natale avrebbe avuto tutto
il tempo di studiarsi le carte ed arrivare a punti conclusivi dell’indagine. I
carabinieri che lo accompagnavano, Moschitta e Francaviglia, lo coadiuvavano in
modo assiduo e costante essendo a conoscenza di ogni aspetto della indagine,
trattandosi di un nucleo investigativo interforze appositamente da me
costituito”. In relazione alla missione a La Spezia, il maresciallo Scimone è
stato l’unico a dichiarare che originariamente alla missione avrebbe dovuto
partecipare lui e non il capitano De Grazia. Nessun’altro tra gli inquirenti ha,
infatti, accennato a tale circostanza. In particolare, nel corso dell’audizione
del 18 gennaio 2011, in merito alla suddivisione dei compiti ha dichiarato: “Sul
viaggio a La Spezia c’erano due programmi: il mio di acquisire documentazione
presso la dogana e quello di Moschitta, che avrebbe dovuto svolgere un’attività
che stava seguendo lui e che in questo momento non ricordo di preciso. Doveva
sentire forse qualcuno…(…) Se non ricordo male, doveva sentire delle persone in
merito a un aspetto della vicenda che stava curando lui come Nucleo operativo.
Io mi ero occupato invece della ricostruzione della Jolly Rosso e di un’altra
nave, per cui era necessario acquisire queste bolle di carico, tra cui anche
quelle della Rigel, come è stato fatto successivamente, perché dopo la morte di
De Grazia sono andato a prendere questa documentazione”. Secondo la versione del
maresciallo Scimone fu lo stesso De Grazia a chiedere di recarsi a La Spezia al
posto del maresciallo Scimone per l’esame della documentazione marittima presso
la dogana, in quanto munito di competenze specifiche che avrebbero agevolato
l’esecuzione della delega. In realtà, dopo la morte del capitano fu proprio il
maresciallo Scimone ad acquisire la documentazione in questione presso la dogana
di La Spezia, il che, evidentemente, dimostra che lo stesso disponeva delle
competenze adeguate per svolgere questo tipo di attività. Il maresciallo non ha
fatto alcun riferimento ad indagini interessanti la motonave Latvia. Partendo
proprio da quest’ultimo dato si deve evidenziare come anche il procuratore di
Paola, Francesco Greco, nel 2004 abbia cercato di comprendere quale fosse
l’oggetto delle indagini che avrebbero dovuto essere compiute in quel periodo a
La Spezia, senza riuscirvi compiutamente. In primo luogo va esaminata la
posizione dell’ispettore Tassi, appartenente al Corpo forestale dello Stato ed
applicato presso la sezione di polizia giudiziaria della procura di La Spezia.
Il pubblico ministero Greco aveva convocato l’ispettore Tassi proprio per sapere
se avesse portato a compimento la delega sopra indicata e l’oggetto della
stessa. Sul punto l’ispettore Tassi ha risposto in primo luogo precisando di
avere avuto la delega via fax in data 15 dicembre 1995 (dunque successivamente
al decesso del capitano De Grazia) e, in secondo luogo, dichiarando di aver
effettuato alcuni accertamenti, poi riassunti nell’annotazione del 29 febbraio
1996 (doc. 695/22). L’annotazione fu prodotta al pubblico ministero Greco in
occasione dell’escussione dell’ispettore. Dalla lettura dell’annotazione, si
evince che le attività richieste all’ispettore Tassi erano relative
all’accertamento di utenze telefoniche riferibili alla compagnia di navigazione
Ignazio Messina. Tuttavia nell’annotazione si fa riferimento espresso alla
delega della procura di Reggio Calabria nella quale era stati disposti
accertamenti in Livorno, Arezzo e Casale Monferrato. Di talchè l’annotazione
prodotta al dottor Greco non sembra riconducibile alla delega dell’11 dicembre
1995, bensì ad altra delega contenente richieste di accertamenti specifici
relative ad utenze telefoniche da eseguirsi anche nelle città menzionate.
Peraltro, lo stesso Tassi, nel verbale di sommarie informazioni reso davanti al
pubblico ministero Greco il 24 maggio 2005(doc. 695/22), nel produrre
l’annotazione in parola, ha specificato di “ritenere” che quella annotazione
contenesse la risposta alla delega dell’11 dicembre 1995, senza esprimersi in
termini di certezza. Pare strano, in ogni caso, (laddove la delega dell’11
dicembre si fosse riferita effettivamente ad accertamenti su utenze telefoniche
in vista di eventuali operazioni di intercettazione) che le attività siano state
compiute in un lasso di tempo così ampio (due mesi e mezzo). L’ispettore Tassi,
a differenza di quanto ha voluto far credere nel corso delle audizioni in
Commissione, era pienamente coinvolto nelle indagini, tanto che il procuratore
Neri aveva richiesto per iscritto l’11 dicembre 1995 al procuratore della
Repubblica presso il tribunale di La Spezia che fosse autorizzato a svolgere le
indagini delegategli nell’ambito del procedimento penale 2114/94. (doc. 681/87).
La richiesta di autorizzazione, come sopra evidenziato, rientra fra le sei
deleghe che Neri aveva consegnato al capitano De Grazia, il giorno prima della
sua partenza per La Spezia. Ad ulteriore sostegno di quanto esposto, vi è
l’altra delega, tra le sei consegnate a De Grazia, indirizzata specificatamente
al vice ispettore Tassi nella quale gli si chiedeva espressamente “di voler
svolgere tutte le indagini già concordate nell’ambito del procedimento penale
2114/94 anche fuori sede” (doc. 695/16). Il riferimento alle indagini già
concordate sul procedimento penale presuppone inequivocabilmente l’esistenza di
pregressi rapporti investigativi nonché l’esigenza di non rendere esplicito
l’oggetto della delega per ragioni di riservatezza e anche di tutela delle
persone che si occupavano delle indagini (cfr. capitolo due). Nel corso
dell’inchiesta la Commissione ha verificato che il Corpo forestale dello Stato
di Brescia si avvaleva di fonti confidenziali, una delle quali aveva come
immediato riferente – secondo quanto dichiarato dagli stessi ufficiali del Corpo
forestale dello Stato di Brescia – l’ispettore Tassi. Nel corso delle audizioni
in Commissione quest’ultimo ha riferito che le indagini che avrebbero dovuto
compiere il capitano De Grazia a La Spezia erano costituite dall’assunzione di
informazione di alcuni componenti dell’equipaggio della motonave Rosso, in
particolare gli ufficiali Zanello e Zembo, che lo stesso tassi avrebbe dovuto
escutere unitamente al capitano. Nessun riferimento è stato fatto dal Tassi alla
vicenda della motonave Latvia della quale ha parlato in Commissione una fonte
confidenziale affermando: “(…) sulla nave di capo Spartivento il capitano De
Grazia doveva venire a La Spezia a conferire con me e con Tassi con riferimento
ad un’altra nave, la Latvia, ex nave del KGB sovietico che era ormeggiata a
fianco di una struttura della marina militare nell’area del San Bartolomeo. Poi,
questa nave è stata monitorata. (…) Questa nave era stata poi acquistata da una
società fatta a La Spezia, non ricordo il nome ma non è difficile recuperarlo,
(…) E’ stata ormeggiata alcuni mesi sulla diga foranea a La Spezia. (…) questa
nave era rimasta ormeggiata prima ad un molo prospiciente il comando NATO
dell’Alto Tirreno a La Spezia, quindi nell’area del San Bartolomeo proprio sotto
la discarica Pitelli ed era stata acquistata da una società costituita da alcuni
industriali e altri di La Spezia (…). Non poteva prendere il mare, era
smantellata e priva di equipaggio. Poi, improvvisamente, questa nave dopo la
costituzione di questa società che aveva recuperato questa nave come rottame, ha
preso il largo trainata da un rimorchiatore che credo fosse turco ed è arrivata
in Turchia. Voci dicevano che fosse stata riempita, non riempita, ma che fosse
stato immesso del materiale particolare sulla nave prima della sua fuoriuscita
dalla rada di La Spezia. Questo era uno dei lavori che abbiamo fatto io e
l’ispettore Tassi del Corpo forestale dello Stato”. La nave probabilmente era
stata caricata con del mercurio rosso radioattivo e il sospetto era che i
rifiuti fossero stati buttati in mare. La nave pare l’abbiano poi demolita ad
Ariga. Il Presidente nel corso dell’audizione ha richiesto insistentemente
all’audito da chi avesse appreso quelle notizie. L’audito ha risposto che si
trattava di “voci” acquisite nell’ambiente dei trasportatori e di tutti coloro
che ruotano nel mondo dei rifiuti. si è trattato evidentemente di una risposta
evasiva soprattutto alla luce di quanto successivamente riferito dall’audito in
merito all’attività che lui personalmente svolse con riferimento alla Latvia. In
particolare ha dichiarato di essere salito sulla nave, di averla visionata, di
avere pagato per questo un membro dell’equipaggio. Ha poi affermato che il
capitano De Grazia avrebbe dovuto visionare la Latvia ma l’incontro non è
avvenuto per la prematura morte del capitano De Grazia. Testualmente ha
dichiarato: “Questo è un periodo che mi ricordo abbastanza bene in quanto
eravamo rimasti piuttosto allibiti sul fatto che il capitano – che era anche uno
sportivo da quello che mi veniva detto, perché io non l’ho mai conosciuto il
personaggio- fosse morto e la cosa non mi era piaciuta assolutamente. Già questo
aveva dato un forte rallentamento a quello che si poteva fare, parlo dei
rapporti fra me e Tassi: Poi credo che Tassi abbia avuto dei problemi con
Brescia, con la struttura del Corpo forestale dello Stato di Brescia, per
questioni loro sulle quali non sono mai andato ad indagare perché non erano
fatti che riguardavno me. Io ho continuato a sentire De Podestà (…) ho rivisto
Tassi, mi aveva detto lui, questo credo lo possa confermare, che la nave era
arrivata ad Ariga in Turchia e addirittura c’era il gruppo sommergibili di La
Spezia – due sommergibili della classe costiera che dovevano seguire la nave per
un certo percorso per vedere se aveva contatti con l’esterno con mezzi di
superficie o se buttasse qualcosa a mare. Tuttavia per un disguido, che non ho
mai capito quale fosse stato, non ero io che tenevo i rapporti tra gruppo di
sommergibili e tutta la struttura di intercettazione ma era evidentemente il
corpo forestale. La nave è praticamente scappata, il rimorchiatore è arrivato ed
in sei ore ha agganciato…. Ha ancorato la nave con i cavi, la nave
miracolosamente si è raddrizzata dallo sbandamento ed è uscita”. Evidenti sono
le discrepanze tra quanto dichiarato da Tassi e quanto riferito invece dalla
fonte confidenziale. Deve, infatti, sottolinearsi che la motonave Latvia era
effettivamente oggetto di indagini da parte della procura circondariale di
Reggio Calabria, tenuto conto delle informative già redatte dagli ufficiali del
Corpo forestale dello Stato di Brescia nelle quali si dava conto di una serie di
evidenti anomalie che suscitavano l’interesse investigativo sulla motonave. Di
sicuro rilievo è che la fonte audita abbia avuto la possibilità, secondo quanto
dichiarato, di salire sulla motonave versando denaro a membri dell’equipaggio
non meglio identificati. Non è stato chiarito in alcun modo quali soldi fossero
stati impiegati per questa operazione e dunque se sia stato utilizzato denaro
personale della fonte o denaro messo a disposizione dagli investigatori. Nessun
riferimento ad accertamenti riguardanti la motonave Latvia è stato fatto dal
maresciallo Moschitta nel corso delle due audizioni del 2010 avanti alla
Commissione. Lo stesso, infatti, ha riferito: “Stavamo andando a La Spezia ad
acquisire la documentazione in merito alla Rigel, la nave affondata a capo
Spartivento. Tale documentazione era di interesse perché il processo di La
Spezia aveva sancito che sul trasporto di quella nave erano state pagate dazioni
ed era stato coinvolto personale della dogana e della Rigel circa il carico. Era
necessario e importante avere con noi questi documenti per poi proseguire, se
non erro, per Como o per un’altra destinazione per sentire altri eventuali
testimoni, con tanto di delega del magistrato”. Ancora più generiche sono state
le dichiarazioni sul punto da parte del carabiniere Rosario Francaviglia, rese
in data 1 agosto 2012: “In data 12 dicembre 1995, insieme al maresciallo
Moschitta e al capitano di corvetta Natale De Grazia, alle ore 18.50 siamo
partiti a bordo di un’autocivetta per portarci a La Spezia, dove dovevano essere
sentite delle persone per l’indagine. (…) Ricordo che si trattava di persone che
facevano parte dell’equipaggio di una nave che era stata affondata, della Rigel
se non ricordo male. (…) Quello che veniva deciso era condiviso soltanto da noi
del pool; nessuno veniva informato. In quel periodo, avevamo anche la delega
nominativa con divieto di riferire, anche gerarchicamente, sulle indagini e su
ciò che facevamo, tanto che sui fogli di viaggio mettevamo varie regioni
d’Italia, come destinazione, non dichiaravamo che stavamo andando a La Spezia o
altrove”.
1.11 – Gli sviluppi investigativi in relazione
alla Somalia. Il mese di novembre 1995 fu denso di attività investigative in
quanto:
- erano in corso gli accertamenti sulla Rigel e
sulla Jolly Rosso. In particolare, per quanto riguarda la Rigel, è stato
riferito che il capitano De Grazia avesse individuato le coordinate precise del
luogo di affondamento della nave (cfr. quanto dichiarato dal magistrato Nicola
Maria Pace nel corso dell’audizione del 20 gennaio 2011);
- con riferimento alla Jolly Rosso erano state
programmate attività finalizzate ad identificare e a sentire a sommarie
informazioni componenti dell’equipaggio nonché a ricostruire le varie fasi dello
spiaggiamento e dello smantellamento del relitto;
- con riferimento alla motonave Latvia erano state
acquisite informazioni di notevole rilevanza nel contesto investigativo tanto
che (secondo quanto emerso nel corso dell’inchiesta svolta alla Commissione) il
capitano De Grazia, una volta giunto a La Spezia, avrebbe dovuto acquisire
direttamente informazioni;
- sempre nello stesso periodo gli investigatori
iniziarono a trovare sempre più riscontri agli elementi ricavati dalla
documentazione sequestrata a Giorgio Comerio nel maggio 1995, con riferimento
anche alla Somalia, che già da tempo figurava quale luogo di destinazione di
rifiuti tossici provenienti da diversi paesi. Il raccordo tra lo smaltimento di
rifiuti tossici e la Somaliaemerse ufficialmente, per quanto risulta alla
Commissione, in data 2 dicembre 1995, allorquando il Corpo forestale di Brescia
informò la procura circondariale di Reggio Calabria che, in data 11 novembre
1995, Ali Islam Haji Yusuf, membro dell’Autorità’ del servizio mondiale per i
diritti umani di Bosaaso aveva segnalato che “al largo della citta’ di Tohin,
del distretto di Alula, nella Regione del Bari, due navi sconosciute stavano
effettuando una operazione insolita, vale a dire che mentre una scavava sui
fondali del mare, l’altra seppelliva in dette buche dei containers dal contenuto
sconosciuto. Tale operazione stava creando tensione fra la popolazione locale”.
Tale documento era pervenuto al Corpo forestale dello Stato da Greenpeace. La
comunicazione del Corpo forestale dello Stato era di sicuro rilievo in quanto
tra i documenti sequestrati a Comerio ve ne erano alcuni attinenti in modo
specifico alla Somalia, contenuti in apposita cartellina recante la scritta
“Somalia”. Tali dati risultano compendiati nell’informativa 22 gennaio 1996 (cui
si rimanda), redatta dal comandante provinciale – R.O.N.O. di Reggio Calabria,
Antonino Greco (doc. 681/62), nella quale si fa riferimento a documentazione
sequestrata a Comerio dalla quale si desumeva l’esistenza di trattative avviate
per operazioni di smaltimento di rifiuti da realizzarsi in zone coincidenti con
quelle in cui stavano operando le navi segnalate da Ali Islam Haji Yusuf.
L’informativa, sebbene trasmessa dopo la morte del capitano De Grazia, dà conto
di informazioni già acquisite precedentemente e, quindi, va intesa come riferita
ad attività di indagine effettuate prima del decesso del capitano De Grazia.
Pare doveroso evidenziare anche in questa sede che gli elementi complessivamente
raccolti in ordine ai singoli indagati ed in particolare a Giorgio Comerio
evidentemente non sono stati ritenuti sufficienti a formulare precise accuse né
nei confronti di Comerio né nei confronti degli altri indagati, tanto che il
procedimento si è concluso con una richiesta di archiviazione accolta dal Gip.
Il tema relativo alla Somalia, come è noto, è stato ed è ancora oggi oggetto di
numerosi approfondimenti in quanto le regioni del nord Africa – sulla base di
dati investigativi anche recenti – sembrano essere la sede privilegiata di
destinazione di rifiuti altamente tossici. Tuttavia, l’ipotesi secondo la quale
in Somalia sarebbero giunti in quegli anni navi cariche di rifiuti radioattivi
ed interrati in loco non ha avuto sinora un riscontro probatorio in ambito
giudiziario. Con riferimento alla documentazione sequestrata a Comerio, occorre
evidenziare un altro dato emerso nel corso dell’inchiesta: nella cartellina
riportante la scritta “Somalia” erano contenuti una serie di documenti tra cui
anche uno concernente la morte di Ilaria Alpi. Il procuratore Neri, nel corso
dell’audizione avanti alla Commissione ha ribadito di aver visto – tra gli atti
sequestrati a Comerio – il certificato di morte di Ilaria Alpi. Tale
certificato, peraltro, non è stato mai ritrovato all’interno del fascicolo e
quindi – secondo quanto dichiarato dal magistrato – sarebbe stato verosimilmente
trafugato.
Questa specifica vicenda ha avuto già sviluppi
processuali, non essendo stata confermata la notizia che effettivamente nel
fascicolo vi fosse tale documento (vi è stato un procedimento penale a carico
dello stesso magistrato per falsa testimonianza). Il dato incontroverso è che
all’interno della cartellina in questione, dedicata alla Somalia, vi fosse un
documento in qualche modo attinente alla morte di Ilaria Alpi, documento che
secondo il maresciallo Scimone sarebbe consistito in una notizia Ansa. Resta in
ogni caso significativo che all’interno di una cartella intitolata “Somalia”,
nella quale erano contenuti documenti concernenti lo smaltimento di rifiuti
tossici e contatti con esponenti somali, vi fosse un atto riguardante la morte
della giornalista, in un’epoca in cui ancora nessun potenziale collegamento era
stato ipotizzato tra la morte della stessa e il traffico di rifiuti. Si
riportano le dichiarazioni del maresciallo Scimone sul punto: “Ho anche sentito
dire una cosa stranissima: che il comandante De Grazia avrebbe trovato tra gli
atti di Comerio il certificato di morte di Ilaria Alpi. Non mi risulta. (…) Non
era il certificato di morte di Ilaria Alpi perché sapete bene che il certificato
di morte non è stato redatto in Somalia: Ilaria Alpi fu portata su una nave
italiana e il primo certificato di decesso è stato fatto dal medico della nave.
Credo che poi il comune di Roma abbia redatto l’ultimo certificato. Comerio
aveva una «fascetta», la notizia Ansa della morte di Ilaria Alpi, che De Grazia
aveva trovato mentre cercavamo nelle carte e che mi aveva fatto vedere. Era una
notizia Ansa, non un certificato di morte. (…) Era un fascicolo della Somalia.
Lui aveva dei fascicoli tra cui questo, Somalia, in cui c’erano tutte le
proposte di smaltimento dei rifiuti, i suoi progetti, i contatti con i vari
ministri, roba di questo genere e c’era questa striscia”. Va sottolineato che,
man mano che l’indagine acquisiva maggiore consistenza, sarebbe stata naturale
un’intensificazione ed accelerazione delle attività investigative, che,
peraltro, fino a quel momento, si erano svolte regolarmente. Viceversa, deve
prendersi atto che fu proprio quello il momento in cui si assistette, non solo
ad un rallentamento dell’attività di indagine, ma anche al disfacimento del
gruppo investigativo costituito dagli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti a diverse forze dell’ordine, che fino a quel momento avevano
collaborato con il dottor Neri. Il decesso del capitano De Grazia deve essere
inserito in questo preciso contesto investigativo ed analizzato unitamente agli
eventi immediatamente precedenti e successivi al decesso. Prima di approfondire
la fase regressiva dell’indagine occorre necessariamente soffermarsi sul
rapporto di collaborazione tra la procura di Reggio Calabria e i servizi
segreti, di cui il dottor Neri ha dato ampiamente conto anche nel corso delle
audizioni.
1.12 La collaborazione tra la procura di Reggio
Calabria e i servizi segreti. Una delle peculiarità dell’indagine condotta dal
dottor Neri fu certamente quella della costante interlocuzione con il Sismi al
quale vennero richieste informazioni e documenti sia su Comerio sia, più in
generale, su tutti i temi oggetto di inchiesta (traffico di rifiuti radioattivi,
traffico di armi, affondamenti di navi). Come si legge nella relazione sullo
stato delle indagini inviata dal dottor Neri al procuratore capo in data 26
giugno 1995(doc. 362/3 allegato), l’importanza della documentazione sequestrata
a Giorgio Comerio (nella quale figuravano soggetti come Galli, Pazienza e
Kassoggi) consentì alla procura di autorizzare la polizia giudiziaria impegnata
nell’indagine ad avvalersi dell’ausilio del Sismi, che fornì “ben 277 documenti
sul Comerio a conferma della pericolosità di detto soggetto e a riprova della
bontà della ipotesi investigativa seguita”.
La documentazione acquisita venne studiata sia
dalle forze di polizia giudiziaria che dal Sismi. Riguardo l’inizio della
collaborazione, il dottor Neri riferì al pubblico ministero Russo, nell’aprile
1997: “Ricordo che unitamente al collega Pace della procura circondariale di
Matera comunicammo al capo dello Stato che le indagini potevano coinvolgere la
sicurezza nazionale, inoltre poiché fatti di questo tipo potevano essere a
conoscenza del Sismi ancor prima dell’ingresso del capitano De Grazia nelle
indagini chiese al direttore del servizio di trasmettermi copia di tutti gli
atti che potevano riguardare il traffico clandestino di rifiuti radioattivi con
navi. A dire il vero il Servizio molto correttamente mi trasmise degli atti
tramite la polizia giudiziaria. In particolare il passaggio degli atti avvenne
tramite il maresciallo Scimone appositamente delegato a ciò da me. Il
maresciallo Scimone faceva parte del gruppo investigativo da me diretto e teneva
i contatti con il Sismi. Il capitano De Grazia era a conoscenza di ciò, cioè
sapeva dei contatti istituzionali di Scimone con il Sismi per la acquisizione
delle notizie che chiedevamo. Ogni attività di rapporto con il Sismi è
formalizzata in specifici atti reperibili nel processo.” Sui rapporti con il
Sismi ha riferito anche il maresciallo Moschitta nel corso delle due audizioni
rese avanti alla Commissione (l’11 marzo e l’11 maggio 2010): “Un giorno mi
presento al Sismi e sequestro un documento, con tanto di provvedimento del
magistrato. Ho trovato grande collaborazione nel generale Sturchio, il capo di
gabinetto. Mi chiese se volessi il tale documento e me lo dettero
tranquillamente. (…) Chiedevamo se avevano qualcosa su Giorgio Comerio. Il primo
documento che emerse mostrava che Giorgio Comerio era colui il quale aveva
ospitato in un appartamento, non so se di sua proprietà, a Montecarlo l’evaso
Licio Gelli. Da lì comincia il nostro rapporto con i servizi segreti, i quali ci
hanno veramente fornito molto materiale. Si è sempre collaborato benissimo,
apertamente e senza problemi, tanto che nell’edificio della procura distrettuale
di Reggio Calabria avevano approntato per loro anche un piccolo ufficio per
esaminare documentazioni nostre ed eventualmente integrarle (…) i servizi
segreti, il Sismi, hanno lavorato con noi. Il primo impatto che ho avuto con i
servizi segreti è stato a seguito di un decreto di acquisizione di documenti
presso il Sismi. Sono andato personalmente ad acquisire un documento a carico di
Giorgio Comerio, titolare della O.D.M., oramai noto nell’inchiesta. In modo
particolare, si trattava della fuga di Licio Gelli da Lugano fino al suo rifugio
segreto nel principato di Monaco. Ci risulta che la casa in cui era ospitato
Licio Gelli era di Giorgio Comerio. In seguito, i servizi segreti sono entrati
ufficialmente con noi nell’indagine perché esaminavano la documentazione,
d’accordo con la magistratura. In effetti, è stata una collaborazione corretta,
leale e senza problemi”.
La collaborazione tra procura e Sismi proseguì
anche dopo che il fascicolo fu trasmesso alla direzione distrettuale antimafia
di Reggio Calabria, come si evince dal provvedimento con il quale il sostituto
procuratore dottor Alberto Cisterna, divenuto titolare dell’indagine, autorizzò
la polizia giudiziaria “ad avvalersi dell’ausilio informativo del Sismi” per il
tramite di persone nominativamente indicate appartenti all’ottava divisione
(doc. 681/39). Quello sopra descritto fu il rapporto “formale” tra procura e
servizi segreti, in merito alle indagini sulle “navi a perdere”. E’ emerso,
però, un ulteriore profilo di intervento dei servizi segreti nella materia
riguardante il traffico dei rifiuti radioattivi e tossico nocivi e il traffico
di armi, come emerge dalla documentazione acquisita dalla Commissione riferita
al medesimo periodo in cui erano in corso le indagini del dottor Neri. In
particolare il documento proveniente dal Copasir, archiviato dalla Commissione
con il n. 294/55, riguarda una comunicazione del Sismi al Cesis in merito alle
spese sostenute nell’anno 1994 per i servizi di intelligence connessi al
problema del traffico illecito di rifiuti radioattivi e di armi, indicati nella
misura di 500 milioni di lire. Si tratta di un documento desecretato dalla
Commissione particolarmente interessata a comprendere in che modo fossero stati
utilizzati i 500 milioni di lire nelle operazioni di intelligence relative al
traffico di rifiuti e di armi. Non è stato però possibile, nonostante le
numerose audizioni effettuate sul punto, sapere in che modo sia stata spesa la
somma di cui sopra, per lo svolgimento di quali attività e, ancor prima, per
quali ragioni i servizi, all’epoca, fossero interessati al tema dei rifiuti
radioattivi. E’ stato, inoltre, prospettato alla Commissione, ma non è stato
acquisito alcun riscontro al riguardo, un ulteriore ipotetico interessamento dei
servizi all’indagine svolta dal dottor Neri attraverso il controllo delle
attività poste in essere dalla procura e dagli ufficiali di polizia giudiziaria.
Proprio con riferimento a quest’ultimo punto si evidenziano le dichiarazioni
rese da Rino Martini alla Commissione, in data 17 febbraio 2010, allorquando ha
dichiarato: “In quel periodo, si verificarono due episodi, uno dei quali
ricordato dal procuratore Pace. Per una settimana siamo stati filmati da un
camper parcheggiato di fronte alla caserma in cui operavo. Una sera in cui erano
stati invitati anche altri magistrati, avevamo deciso di recarci in una bettola
sul Maddalena, che non è frequentata da nessuno durante la cena perché è aperta
solo di giorno, e dieci minuti dopo il nostro arrivo attraverso una strada nel
bosco è arrivata un’altra autovettura e si sono presentati a cena due ragazzi di
trent’anni, che hanno lasciato la macchina nel parcheggio. Siamo usciti per
primi e, attraverso due sottufficiali dei Carabinieri di Reggio Calabria
presenti, dalla targa dell’autovettura siamo risaliti al proprietario: il SISDE
di Milano. Non ho altri episodi da raccontare. Certamente, c’era un controllo
telefonico e attività ambientali di verifica su come ci muovevamo.” Come
specificato dall’ex colonnello, su domanda della Commissione, riguardo a questa
presunta attività di controllo, lo stesso aveva semplicemente formulato
un’ipotesi, senza avere alcun riscontro.
Riguardo poi alla vicenda del camper, il
colonnello ha specificato che le verifiche effettuate non hanno portato a
risultati di alcun tipo: “Dal pubblico registro automobilistico non abbiamo
trovato nulla di interessante e abbiamo preferito mantenere un basso profilo per
cercare di capire come avvenissero questi controlli. Sicuramente, non
apparteneva a nessuno degli abitanti del posto, perché di fronte ci sono ville
residenziali. All’interno comunque non c’era nessun operatore, ma era piazzata
una telecamera.(…) puntata verso l’ingresso”. Circa 20 giorni dopo la sua
audizione, il colonnello Martini ha trasmesso alla Commissione un appunto
relativo al secondo dei due episodi sopra riferiti, aggiungendo ulteriori
dettagli. Si riporta il contenuto del documento trasmesso (doc. 304/1): “Con
riferimento alla lettera sopracitata riguardante l’episodio della presenza delle
due persone come riferito nell’audizione, preciso quanto segue. Il punto di
ritrovo serale per un certo periodo è stato l’Antica Birreria alla Bornata di
V.le Bornata, 46 Brescia (ex Wurer), ma per la presenza di soggetti che
frequentavano la trattoria alla stessa ora (mai la stessa) avevamo deciso di
individuare un altro punto di ritrovo. A questo posto si arriva attraverso una
strada sterrata di qualche centinaio di metri all’interno del bosco della
Maddalena (collina adiacente alla città di Brescia) e dopo aver lasciato
l’autovettura in un parcheggio si percorrono a piedi 200-300 metri. A quel tempo
l’Osteria era denominata Briscola (Via Costalunga 18/4) ed alla sera era aperta
su prenotazione. Dopo circa 30 minuti sono arrivate due persone ben vestite e di
età sui 35 anni. Naturalmente io e gli altri presenti siamo usciti dopo pochi
minuti ed abbiamo così potuto prendere la targa della seconda autovettura
parcheggiata. Per poter ricostruire l’episodio ho chiesto al Coordinamento del
Corpo forestale dello Stato di Brescia di verificare se i fogli di viaggio di
quel periodo erano ancora in loro possesso per determinare la data del fatto. Ho
poi contattato il Dr. Nicola Pace, procuratore della procura di Brescia, che mi
ha riferito che probabilmente non era presente in quel periodo quindi mi sono
messo in contatto col Dr. Francesco Neri, consigliere della procura generale di
Reggio Calabria. Il contatto è avvenuto il 1/03/2010 in tarda mattinata. II Dr.
Neri invece ricorda perfettamente l’episodio e lui stesso all’epoca aveva
chiesto ai suoi collaboratori, sottoufficiali dei Carabinieri di verificare
l’appartenenza dell’autovettura. Dopo due giorni mi è stato riferito che
l’autovettura era in carico ai Servizi Civili di Milano. Alla fine dell’anno
1995 tutta la documentazione riguardante l’indagine è stata trasferita alla
procura della Repubblica di Reggio Calabria ed a Brescia presso il Nucleo sono
rimaste le pure annotazioni senza allegati”.
2. IL CLIMA DI INTIMIDAZIONE NEL CORSO DELLE
INDAGINI. Nel corso dell’inchiesta alla Commissione sono state rappresentate –
sia dai magistrati che dagli ufficiali di polizia giudiziaria impegnati
nell’indagine – talune difficoltà operative legate, in taluni casi, a problemi
burocratici e organizzativi, in altri, all’esistenza di un clima di
intimidazione percepito nitidamente dagli investigatori in più di un’occasione.
Sotto il primo profilo, si segnala che il capitano De Grazia, dopo essere stato
applicato presso la procura di Reggio Calabria per collaborare con il dottor
Neri nelle indagini sulle navi a perdere, era andato incontro a difficoltà
operative, non essendo stato dispensato dallo svolgimento delle ordinarie
incombenze del suo ufficio e ciò nonostante l’impegno particolarmente intenso
che l’indagine giudiziaria richiedeva. Risulta inoltre che, ad un certo momento,
il capitano De Grazia fu richiamato dall’ufficio di appartenenza e che i
magistrati dovettero reiterare per iscritto la richiesta di applicazione
dell’ufficiale in procura, definendo non solo importante il suo apporto, ma
indispensabile. Sul punto si è espresso il maresciallo Moschitta, audito dalla
Commissione in data 11 marzo 2010: “(…) quando le indagini arrivavano a un
picco, e quindi stavamo mettendo le mani su fatti veramente gravi, coinvolgenti
anche il livello della sicurezza nazionale…(…) A un certo punto De Grazia non
venne più a effettuare le indagini con noi, perché il suo comandante l’aveva
bloccato.(…) Se non erro, era il colonnello Maio o De Maio, non ricordo bene.
Era il comandante della Capitaneria di porto di Reggio Calabria. De Grazia mi
chiamò e mi riferì che non poteva più venire, perché il suo comandante gli aveva
mostrato un foglio matricolare… (…) Mi chiese se potevo parlare col giudice in
modo che scrivesse un’altra lettera per poterlo reinserire nelle indagini.
Accettai e promisi di parlarne col dottor Neri. Quest’ultimo scrisse un’altra
lettera di incarico di indagini affermando che De Grazia non era solo
necessario, ma indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Solo così è
ritornato con noi a lavorare. (…) Una volta morto lui, ci siamo un po’ fermati.
Io sono stato male e anche il giudice Neri ha avuto problemi pressori”. A parte
questo, devono essere richiamati altri episodi percepiti dagli inquirenti quali
presunte forme di controllo e di intimidazione nel’ambito delle indagini.
2.1 – Le dichiarazioni rese dagli ufficiali di
polizia giudiziaria del gruppo investigativo coordinato dal dottor Neri e dal
dottor Pace. E’ stato riferito alla Commissione che nel corso delle indagini si
sarebbero verificati diversi episodi (in particolare pedinamenti) che avevano
destato preoccupazione e che erano stati interpretati dagli inquirenti come
tentativi di intimidazione diretti sia nei confronti dei magistrati titolari
delle indagini sia nei confronti della polizia giudiziaria delegata. In
proposito, sono state raccolte le testimonianze dei diretti interessati nonché
le annotazioni di servizio redatte dall’epoca dei fatti. Sia il maresciallo
Moschitta che il Carabiniere Francaviglia, sentiti il 9 aprile 1997 dal pubblico
ministero Russo (titolare dell’indagine avviata in riferimento al decesso del
capitano De Grazia), hanno riferito in merito al clima che si respirava nel
corso delle indagini ed al fatto che, nel corso di alcune missioni alle quali
avevano partecipato, erano stati seguiti. Il maresciallo Moschitta, in
particolare, ha dichiarato: “confermo le relazioni di servizio anche a mia firma
in merito a pedinamenti effettuati da ignoti nei nostri confronti in particolare
durante il viaggio a Savona, a Firenze e a Roma nel mese di febbraio 1995,
all’inizio delle indagini. Oltre a questi episodi ci sono state anche altre
circostanze che ci hanno fatto credere seriamente di essere sotto controllo da
parte di qualcuno per le indagini che stavamo svolgendo. In particolare, ricordo
che vi fu uno strano episodio relativo alla forzatura della porta dell’ufficio
del dottor Neri e vi sono altresì state delle occasioni nelle quali il personale
della scorta e della tutela ha avuto l’impressione che alcune persone ci
seguissero”. Negli stessi termini si è espresso il carabiniere Francaviglia nel
verbale di sommarie informazioni testimoniali effettuato il medesimo giorno. Il
maresciallo Moschitta ha poi riferito a questa Commissione, nel corso delle
audizioni dell’11 marzo e dell’11 maggio 2010, ulteriori episodi che avevano
destato preoccupazione, verificatisi fin dall’inizio delle indagini. Si
riportano alcuni passi delle dichiarazioni rese:
“il muro di gomma su cui inevitabilmente andava a
cozzare l’attività degli inquirenti e della polizia giudiziaria ha rappresentato
il principale ostacolo da abbattere per poter entrare nei meandri del fenomeno
in esame. È sembrato che forze occulte di non facile identificazione
controllassero passo passo gli investigatori nel corso delle diverse attività
svolte. In effetti, sentivamo che c’era qualcosa. Qualcuno ci pedinava, però
nessuno si manifestava. L’unico dato certo è emerso a Roma (…)”. “Dopo aver
interrogato un funzionario dell’Enea, che in quel momento avevamo chiamato Billy
per evitare la divulgazione del suo nome, siamo andati ad alloggiare presso
l’albergo Ivanhoe di Roma. Ebbene, stranamente le nostre schede – la mia, quella
del giudice Neri, dell’autista e di altri colleghi, eravamo in cinque – non
erano ritornate, come accadeva di solito, dal visto del commissariato. Io stesso
sono stato chiamato dall’allora addetto alla reception che mi chiese ragione di
questa circostanza. Risposi che non ne sapevo nulla e chiesi se fosse normale.
L’addetto disse che non era normale, ma che poteva esserlo data l’occasione. A
quel punto, noi che avevamo svolto quell’attività ci siamo preoccupati, intanto
di preservare il magistrato che era con noi (Francesco Neri) (…) ad un certo
punto lo abbiamo accompagnato di peso, perché lui non voleva andarsene, presso
l’aeroporto di Ciampino e lo abbiamo fatto imbarcare alla volta di Reggio
Calabria. Il dottor Neri non ci voleva lasciare. Mi ha fatto promettere che nel
viaggio di ritorno – avevamo altre attività da svolgere, ma considerata la
situazione abbiamo interrotto le operazioni e ce ne siamo andati – avremmo
seguito un itinerario diverso da quello di andata. (…). In quel momento eravamo
molto preoccupati (…). In seguito, non abbiamo avuto più notizie di questa
vicenda. A Savona o a Firenze abbiamo avuto la sensazione che delle persone con
degli automezzi ci stessero sempre vicino. Una volta me ne accorgevo io, una
volta se ne accorgeva la tutela del dottor Neri, una volta se ne accorgeva
l’autista. In pratica, ci sembrava di essere all’attenzione di persone che non
conoscevamo. In quei casi, cercavamo di sottrarci alla loro vista, al loro
controllo e adottavamo le misure più elementari possibili per sfuggire. A parte
l’episodio di Roma, le altre situazioni sono derivate da nostre impressioni.
Tuttavia – attenzione – parlo di impressioni di investigatori, non di falegnami
o baristi. Capivamo che qualcosa attorno a noi non quadrava. Infatti, appena
arrivati a Savona, che è stata la nostra prima meta, il dottor Landolfi,
sostituto procuratore della procura della Repubblica, ci disse che i telefoni
già riferivano che il dottor Neri era in Liguria. In pratica, egli aveva dei
telefoni di mafiosi calabresi sotto controllo, dunque sapeva che questi signori
parlavano della presenza del dottor Neri a Savona. Nel corso del tempo, al
dottor Neri è stato assegnato un ufficio alla procura circondariale, la cui
porta venne forzata, anche se non fu sottratto nulla. Inoltre, sono successi
tanti altri avvenimenti, di cui la sua tutela, l’agente Luigi Bellantone, può
riferire. Vi riporto l’esempio più recente. Ad un certo punto, siamo stati
convocati dal GIP di Roma per la querela sporta nei nostri confronti da parte di
Ali Mahdi, il signore della guerra ed ex presidente della Somalia. Egli
affermava che non era vero quanto da noi riferito alla I Commissione circa i
rapporti tra Comerio ed Ali Mahdi. Invece, vi era una gran quantità di
documentazioni ufficiali in merito che abbiamo sequestrato a Comerio e prodotto
in tutte le sedi. In occasione di questo viaggio, all’aeroporto di Ciampino,
all’uscita del volo per Reggio Calabria, abbiamo notato due persone. Io ero già
in pensione, non avevo nulla in mano, solo un portavaligie e ho pensato che
all’occorrenza sarei potuto intervenire servendomi di quello. Come ho detto,
abbiamo notato la presenza di due persone che fissavano sia il dottore Neri che
il suo legale di fiducia, l’avvocato Gatto Lorenzo. Abbiamo segnalato alla
tutela data da Roma al dottor Neri la presenza di questi due soggetti che non ci
piacevano in modo particolare e abbiamo fatto intervenire la polizia
dell’aeroporto, che li ha identificati. Erano due marocchini che stranamente si
trovavano all’uscita per Reggio Calabria, mentre avrebbero dovuto prendere
l’aereo per Ancona che era nella parte di fronte, ma distante dalla nostra
uscita. Peraltro, era quasi l’ora di partenza dell’aereo per Ancona, tant’è vero
che i due soggetti sono partiti qualche minuto prima di noi. La situazione ci ha
insospettito. Successivamente, sono venuto a sapere che le Marche sono un punto
di concentramento di persone sospette provenienti dall’est europeo. Non voglio
dire altro perché non ho elementi su cui basarmi. Mi sembra, tuttavia, che la
questura abbia accertato che la zona di provenienza di questi due soggetti era
molto frequentata da personaggi poco raccomandabili, provenienti dall’Europa
dell’est”. Il maresciallo Moschitta, ha specificato che – in occasione
dell’esame del dipendente Enea – erano in cinque ossia il magistrato Neri, due
autisti, la tutela e lui stesso. Richiesto di far conoscere il nome del soggetto
audito, ha così risposto: “Era l’ingegnere Carlo Giglio, il quale ha rilasciato
delle dichiarazioni, con riferimento alla situazione delle centrali nucleari in
Italia. A detta dell’ingegnere, si trattava di una circostanza molto delicata,
critica, per non dire esplosiva. Queste sono state le sue parole. Basta leggere
il suo verbale, per capire effettivamente quello che si nascondeva dietro
l’affare nucleare. Avevamo un verbale molto importante e nel momento in cui non
sono ritornate le schede ci siamo molto preoccupati”. Riguardo gli eventuali
accertamenti sui motivi per i quali le schede non fossero rientrate, il
maresciallo ha dichiarato: “Non ho saputo più nulla di questa storia. In tutto
eravamo in cinque a svolgere le indagini e abbiamo scardinato tutta questa
storia. Era stata segnalata alla questura di Roma. La sera stessa in cui siamo
partiti è stato inviato un fax per la questura di Reggio. Quindi, la questura
era interessata a questo tipo di discorso. Com’è andata a finire non lo so”.
2.2 – Le dichiarazioni rese dal dottor Neri e dal
dottor Pace. Le circostanze rappresentate nel 1997 dai militari menzionati sono
state confermate e specificate ulteriormente dal dottor Neri, sentito dal
pubblico ministero Russo sempre in data 9 aprile 1997. Testualmente, lo stesso
ha dichiarato: “sin dall’inizio delle indagini e in particolar modo allorché fui
costretto col nucleo investigativo da me coordinato a recarmi fuori sede sono
stato oggetto di intimidazioni di varia natura ed in particolare con autovetture
e persone munite di radiotrasmittenti che, a mio giudizio, avevano l’evidente
scopo di scoraggiare la mia attività di indagine (…)”. Nel corso della
testimonianza il dottor Neri ha riferito di alcune preoccupazioni del capitano
De Grazia in merito alla sua carriera, in quanto, successivamente all’esecuzione
di un decreto di perquisizione a carico di un indagato, tale Gerardo Viccica,
erano emersi elementi circa un presunto coinvolgimento dei vertici militari
della Marina in fatti di corruzione legati alla realizzazione di Boe. Il Viccica
avrebbe detto a De Grazia in modo minaccioso che conosceva molte persone
nell’ambito della Marina, e che, quindi, in qualche modo, avrebbe potuto
danneggiarlo. Il De Grazia, inoltre, in qualche occasione aveva espresso al
dottor Neri le preoccupazioni che aveva per la sua incolumità e per l’incolumità
del magistrato. Nel corso dell’audizione del dottor Nicola Maria Pace, tenutasi
il 20 gennaio 2010 avanti a questa Commissione, lo stesso, richiesto di riferire
in merito ad eventuali episodi di intimidazione subìti all’epoca in cui era
titolare di indagini collegate con quelle condotte dal sostituto Neri, ha
dichiarato: “ …vi espongo alcuni fatti oggettivi. Gli episodi più gravi si sono
verificati nell’ambito di 15 giorni: nell’arco di due settimane muore De Grazia,
si dimette il colonnello Martini, regista delle indagini e delle attività
strettamente investigative. Per sviare gli antagonisti con Neri decidiamo di
vederci non a Matera o a Reggio Calabria, ma a Catanzaro e durante la trasferta,
mentre personalmente non mi accorsi di niente perché nella mia macchina non
avevo scorta e durante il viaggio sonnecchiavo, Neri che aveva una scorta si
accorse con i suoi e verificò con i computer di bordo di essere seguito da una
macchina della ‘ndrangheta. Fece scattare l’allarme, mi telefonò, prendemmo
direzioni diverse e riuscimmo a tornare. Riferisco il fatto nella sua
oggettività, senza averlo mai interpretato in chiave di paura. Per quanto
riguarda l’essere filmati, sono invece testimone diretto, perché fui proprio io
a Brescia, mentre fervevano le attività, a scoprire che qualcuno ci stava
filmando da un camper parcheggiato a poca distanza dalla sede del Corpo
forestale dello Stato di Brescia. Proposi al team investigativo di perquisire il
camper, ma si considerò più opportuno far finta di niente. Proprio il colonnello
Martini, uomo di poche parole, al quale ho sempre riconosciuto una grande
capacità di strategie, disse di non preoccuparsi. Lavoravamo giorno e notte nel
periodo in cui effettuammo le 16 perquisizioni a Comerio e agli altri, fatto che
poi ha portato alla definitiva scoperta del progetto O.D.M. e al suo
collegamento con il progetto di partenza DODOS, che credo sia ancora negli
scaffali della procura di Matera, perché ho disposto l’acquisizione di questi
otto volumi del progetto DODOS, che, impressionante per lo spessore scientifico,
aveva tutta la dignità per rappresentare una validissima alternativa al sistema
dell’interramento dei rifiuti in cavità geologiche. Questi sono gli episodi che
posso riportare”.
2.3 – Annotazioni di servizio della scorta del
dottor Neri. Nelle relazioni di servizio redatte dall’agente scelto Giovanni
Bellantone, addetto alla tutela del magistrato titolare delle indagini, dottor
Neri, si fa riferimento, oltre che a pedinamenti subìti ad opera di ignoti in
diverse città d’Italia ove gli inquirenti si erano recati per ragioni
investigative, anche ad intercettazioni telefoniche tra ignoti interlocutori
nelle quali si parlava della necessità di far “saltare” anche la scorta del
magistrato. Si riporta un estratto della relazione di servizio del 20 marzo
1995: “durante il nostro soggiorno nella città di Savona, ci accorgevamo della
presenza insistente di alcuni individui nei vari percorsi che facevamo nelle vie
della città. Le persone di cui sopra si contattavano tra di loro tramite
cellulare, e indicavano come “cellule” gli uomini che erano di “scorta”.
Venivamo comunque notiziati che vi era stata un’intercettazione telefonica dove
si parlava di far saltare pure la “scorta” e un’altra dove si parlava della
presenza del giudice (dottor Neri) in città: inoltre la stampa locale pubblicava
e veniva a conoscenza di cose che nessuno di noi aveva comunicato loro. Stesso
controllo nei nostri confronti veniva notato nella città di Firenze, ed ancora
più insistentemente nella città di Roma dove persone non identificate prendevano
posto anche in ristoranti dove noi eravamo intenti a consumare i pasti”. Si
riporta poi un estratto della relazione di servizio del 18 maggio 1995: “in data
odierna unitamente al dottor Neri ci recavamo alla procura circondariale di
Catanzaro, durante il tragitto sull’autostrada A3 SA-RC corsia nord ci
accorgevamo della presenza insistente di una BMW 520 nei pressi dello svincolo
di Vibo-Pizzo, rallentavamo la corsa e l’autovettura di cui sopra era costretta
a superarci cosicchè per motivi di sicurezza decidevamo di uscire allo svincolo
e di proseguire dalla statale per Catanzaro. Dopo qualche chilometro venivamo
agganciati da un’altra autovettura: trattasi di una Fiat Croma che con fare
sospetto ci ha dapprima superato e successivamente si è posizionata dietro la
nostra autovettura. Anche in questo caso eravamo costretti a rallentare la corsa
per cercare di farci superare, e facevamo una sosta di qualche minuto presso
un’area di servizio. Arrivati sul posto cui eravamo diretti e preoccupati per
queste vicende, decidevo di telefonare al mio ufficio di appartenenza per
effettuare accertamenti, ed il collega Bosco, in maniera tempestiva, mi faceva
pervenire i dati qui sotto riportati:
- Bmw 520 tg. RC 476645 intestata ad Alvaro
Antonio, nato a Siderno il 15 dicembre 1947 ivi res. in via Palermo,
pregiudicato per reati finanziari;
- Fiat Croma tg. SV 413337 risultata rubata il 26
marzo 1993. Faccio inoltre presente che la persona sul sedile posteriore della
bmw era munita di una radio portatile e di queste situazioni ci siamo resi conto
immediatamente tutti gli abitanti dell’autovettura blindata (dottor Neri,
comandante De Grazia della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, autista
Barberi)”.
2.4 – Le dichiarazioni dell’ex colonnello Rino
Martini. Il colonnello del Corpo forestale dello Stato Rino Martini, è stato
audito dalla Commissione in data 17 febbraio 2010. In tale occasione ha reso
dichiarazioni anche in merito agli episodi di intimidazione di cui sopra. Tali
dichiarazioni sono state riportate già nel paragrafo relativo ai rapporti con i
servizi (cfr. cap. 1, par. 1.12).
2.5 – Le dichiarazioni dell’Ispettore De Podestà.
In data 17 febbraio 2010 è stato audito dalla Commissione l’ispettore De
Podestà, appartenente al Corpo forestale dello Stato di Brescia. Alla domanda,
posta dalla Commissione se lo “smantellamento” del gruppo investigativo fosse
stato determinato anche dal fatto “che stavate pestando piedi importanti” , lo
stesso ha risposto in questi termini: “Come sensazione sì, come riferimenti
precisi no. I rapporti, finché c’è stato il colonnello Martini, li teneva lui
con gli uffici superiori, sia con il comando regionale sia con il comando
centrale di Roma. Quanto al fatto che, mentre si svolgeva attività
investigativa, sorgevano incombenze ingiustificate a livello amministrativo, se
n’é occupata anche la stampa e se ne occupò addirittura la magistratura,
specificando che stavamo svolgendo delle indagini in campo nazionale e
internazionale, quindi sembrava improprio che l’ufficio fosse smembrato per
occuparsi anche dei compiti di carattere amministrativo”.
2.6 – Accertamenti svolti in conseguenza degli
episodi denunciati. A fronte degli episodi sopra descritti non pare che siano
state avviate specifiche indagini finalizzate ad accertare se gli episodi
medesimi fossero effettivamente intimidatori nei confronti degli inquirenti né
risultano svolti accertamenti finalizzati ad individuarne gli autori. Peraltro
deve evidenziarsi che gli inquirenti hanno più volte dichiarato di sentirsi
controllati e seguiti nel corso delle attività investigative fuori sede. Ebbene,
data l’importanza delle indagini e la gravità dei fatti esposti, sfugge la
ragione per la quale non siano state avviate immediatamente indagini mirate.
Quando è stato chiesto al dottor Pace (nel corso dell’audizione avanti alla
Commissione) per quale motivo non furono immediatamente effettuate verifiche sul
camioncino che ritenevano li seguisse e costituisse una sorta di postazione di
controllo della loro attività, lo stesso ha risposto che non si intervenne
immediatamente onde evitare che ciò potesse pregiudicare l’esito di ulteriori
successivi accertamenti. Tuttavia, deve osservarsi come, per quanto risulta alla
Commissione, neanche in seguito sia stata avviata alcuna indagine sul punto. Ad
oggi, in mancanza di elementi di supporto, non è possibile sostenere nulla di
più di quanto già all’epoca affermato dai magistrati e dai soggetti coinvolti
nella vicenda in esame.
3. LO SFALDAMENTO DEL GRUPPO INVESTIGATIVO E
L’ESITO DELLE INDAGINI. Come evidenziato, la morte del capitano De Grazia segnò,
obiettivamente, un forte rallentamento nelle indagini. Nello stesso periodo di
tempo, il colonnello Rino Martini assunse altro incarico presso un’azienda
municipalizzata, il maresciallo Moschitta andò in pensione, il carabiniere
Francaviglia fu trasferito, l’ispettore Tassi cessò di prestare la sua
collaborazione.
Lo stesso magistrato che aveva fin dall’inizio
assunto la direzione delle indagini, il dottor Neri, appena sei mesi dopo la
morte di De Grazia si spogliò del procedimento, trasmettendolo per competenza
alla procura presso il tribunale di Reggio Calabria, avvendo ipotizzato reati di
competenza del tribunale. In merito agli avvenimenti successivi alla morte del
capitano De Grazia, il maresciallo Scimone, nel corso dell’audizione del18
gennaio 2011 avanti alla Commissione, ha dichiarato: “In seguito alla morte di
De Grazia c’è stato praticamente un terremoto (…) C’è stato un momento di
sbandamento e sei o sette mesi dopo la morte di De Grazia fu diffusa questa
notizia dei Morabito e a quel punto abbiamo dovuto alzare le mani.
Io mi sono
offerto anche di collaborare con la DDA in qualità di polizia giudiziaria per
conoscere il fascicolo, che ho catalogato e consegnato personalmente”.
3.1 – L’incarico assunto dal colonnello Rino
Martini presso la società municipalizzata di Milano per lo smaltimento rifiuti.
Il 1° dicembre 1995, pochi giorni prima della morte del capitano De Grazia, il
colonnello Martini lasciò l’incarico di colonnello del Corpo forestale dello
Stato per assumere il ruolo di direttore operativo della società municipalizzata
di Milano impegnata a fronteggiare l’emergenza rifiuti. In merito alle ragioni
che determinarono tale scelta, l’ex colonnello ha dichiarato alla Commissione in
data 17 febbraio 2010: “Era un salto di qualità dal punto di vista professionale
e anche uno stimolo, quindi ho deciso di accettare (…) Mi sono dimesso il 16
ottobre 1995, e il 17 ottobre avevo già il decreto del Ministero
dell’agricoltura firmato che accettava le mie dimissioni, quindi era già passato
all’Ufficio regionale, era già andato al Ministero dell’agricoltura, ove era già
stato accettato (…) È stata una scelta consapevole. Se avessi ricevuto pressioni
esterne tali da portarmi ad accettare un posto migliore, non avrei mai dato le
dimissioni. Alcune componenti ambientali quell’anno mi hanno un fatto capire che
stavamo toccando interessi che andavano ben oltre le nostre possibilità, in
particolare quelle di un Corpo forestale che non gode di protezioni di servizi o
di altri apparati dello Stato, perché fra le cinque Forze di polizia è la
struttura più debole da questo punto di vista.
Si sono verificate situazioni delicate come i
controlli cui siamo stati oggetto durante l’attività investigativa, ma si
percepiva tutti i giorni un’atmosfera molto difficile e delicata.” Deve,
peraltro, essere sottolineata una circostanza che suscita qualche perplessità in
ordine alle risposte fornite dal colonnello Martini. Lo stesso, invero, venne
sentito a sommarie informazioni dal magistrato dottor Neri in data 7 marzo 1996,
sempre nell’ambito del procedimento 2114/94 RGNR. Alla domanda – subito posta
dal magistrato – circa le ragioni che lo avevano indotto a lasciare l’incarico
all’interno del Corpo forestale dello Stato, il colonnello Martini rispose di
averlo fatto per motivi personali e “per altri motivi che al momento mi riservo
di comunicare in seguito (…) Non appena mi sarà possibile chiarirò eventualmente
ed in dettaglio i motivi che mi hanno indotto a lasciare il mio Corpo. Non
escludo di poter rientrare nuovamente in servizio” (doc. 681/33). E’ evidente,
allora, che vi fossero motivazioni di ordine non personale che – né all’epoca né
successivamente – il colonnello Martini ha voluto riferire.
3.2 – Il decesso del capitano De Grazia. Nel tardo
pomeriggio del 12 dicembre 1995 il capitano De Grazia partì, unitamente al
maresciallo Moschitta e al Carabiniere Francaviglia, con autovettura di
servizio, alla volta di La Spezia per dare esecuzione alle deleghe di indagine,
firmate dal procuratore Scuderi e dal sostituto Neri, finalizzate ad acquisire
maggiori elementi di conoscenza in merito all’affondamento di alcune navi.
Durante il viaggio, sul tratto autostradale di Salerno, alle prime ore del 13
dicembre 1995, il capitano De Grazia venne colto da malore e, quindi,
trasportato, dall’ambulanza nel frattempo intervenuta, presso il pronto soccorso
dell’ospedale di Nocera Inferiore, ove giungeva cadavere. In data 22 dicembre
1995 il capitano Antonino Greco, comandante del nucleo operativo del reparto
operativo CC di Reggio Calabria, rimise al procuratore della Repubblica presso
la pretura di Reggio Calabria, dott. Scuderi, le sei deleghe di indagine datate
11 dicembre 1995 “non potute evadere a causa del decesso del capitano di
corvetta Natale De Grazia”.
3.3 – Il pensionamento del maresciallo Moschitta e
il trasferimento del carabiniere Francaviglia. Il 14 ottobre 1996 (all’età di 44
anni), il maresciallo Moschitta andò in pensione, su sua domanda avanzata nel
giugno 1996, come dallo stesso dichiarato al pubblico ministero Russo, in data
9.4.97. Nel corso dell’audizione dell’11 marzo 2010 avanti alla Commissione, il
maresciallo ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Dopo aver depositato
l’ultimo atto in merito alle indagini sui radioattivi, sono andato in pensione.
Era il 14 ottobre 1996, due giorni dopo aver depositato l’informativa che avevo
promesso alla buonanima di Natale De Grazia. Anche se lui in quel momento non
c’era più, gli avevo promesso che, anche se fosse stato l’ultimo atto della mia
carriera, avrei portato avanti le sue indagini fino a quando avessi potuto. Dopo
la sua morte mi sono sentito male, i miei valori si sono sballati, tanto che
successivamente ho avuto un infarto e mi sono stati applicati due by-pass” .
Nella successiva audizione del 10 maggio 2010 il maresciallo Moschitta ha
precisato di essere stato collocato in pensione con la dicitura «per massimo
periodo previsto» in quanto all’epoca, la normativa prevedeva, quale periodo
massimo per il pensionamento, venticinque anni di servizio effettivi, più cinque
di abbuono. Il maresciallo si è così espresso: “Sarei potuto rimanere, ma mi
sentivo stanco. Dopo la morte di De Grazia, i miei valori sono sballati. Non mi
sentivo bene, tanto che, a distanza di un anno, ho avuto un infarto e, a
distanza di un altro anno, ho dovuto fare un’operazione per impiantare due
bypass al cuore. Questa indagine mi ha effettivamente stressato oltre il
consentito”. L’altro compagno di viaggio del capitano De Grazia, il carabiniere
Rosario Francaviglia, ha dichiarato, in sede di audizione avanti alla
Commissione, di aver chiesto il trasferimento a Catania, vicino casa, subito
dopo la morte del capitano. Ha specificato che già in precedenza aveva avanzato
diverse richieste di trasferimento, ma tutte avevano avuto esito negativo.
Secondo quanto riferito, per l’ultima domanda “stavano ritardando il
trasferimento proprio perché avevamo l’indagine in corso. Mi era già arrivato
esito negativo, dopodiché ho ripresentato domanda e il trasferimento è avvenuto
nel 1996”. La Commissione ha domandato al carabiniere Francaviglia cosa avesse
fatto successivamente e lui ha risposto: “ Ho smesso, anzitutto perché
l’indagine era passata al dottor Cisterna, se non erro, in procura. Ero stato
interpellato per continuare a partecipare all’indagine e ho rifiutato, perché
non ne avevo più intenzione, non ero più interessato. Avevo perso interesse per
quell’indagine, non so se a causa di quell’episodio ”.
3.4 – La cessata collaborazione da parte
dell’ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato Claudio Tassi. Nel
corso dell’audizione avanti alla Commissione avvenuta in data 24 febbraio 2010,
l’isp. Tassi (il quale aveva avuto un ruolo importante nelle indagini,
soprattutto per i suoi contatti con la fonte confidenziale “Pinocchio”) ha
confermato la circostanza di non essersi più occupato delle indagini dopo
qualche mese dal decesso del capitano De Grazia. Alla domanda se si fosse
trattato di una sua iniziativa, l’ispettore ha risposto negativamente.
Testualmente, ha dichiarato (pag. 6): “non posso dire di essere stato escluso
dall’attività investigativa, ma era un filone di Brescia, quindi può anche darsi
che chi seguiva quel filone abbia deciso di proseguire da solo”.
3.5 – La trasmissione del procedimento n. 2114/94
per competenza alla procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio
Calabria. In data 27 giugno 1996 il dott. Francesco Neri trasmise alla procura
della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria il procedimento penale
n. 2114/94 iscritto a carico di Giorgio Comerio + altri, ipotizzando la
sussistenza dei reati di competenza del tribunale di cui agli articoli 110, 428
e 110, 434 del codice penale. Dal procedimento trasmesso nacquero, presso la
procura presso il tribunale di Reggio Calabria, i seguenti procedimenti,
affidati entrambi al dottor Alberto Cisterna:
- il primo, recante il n. 100/1995 R.G.N.R., volto
a verificare l’ipotesi di traffico di armi;
- il secondo, recante il n. 1680/96 R.G.N.R.,
volto a verificare l’ipotesi del traffico di rifiuti radioattivi tramite
affondamenti di navi (in particolare la Rigel e la Rosso) nonché la
riconducibilità di tali azioni a Giorgio Comerio ed altri indagati. In data 9
ottobre 1996 venne depositata l’informativa riassuntiva delle indagini sino a
quel momento svolte dalla procura circondariale di Reggio Calabria, informativa
firmata dal comandante Greco, ma redatta dal maresciallo Nicolò Moschitta pochi
giorni prima del suo pensionamento (doc. 319/1). Entrambi i procedimenti
menzionati furono definiti con decreto di archiviazione. Nel procedimento n.
1680/96, peraltro, alcune ipotesi di reato non furono archiviate ed i relativi
atti vennero trasmessi alle procure di La Spezia e di Lamezia Terme, ritenute
competenti territorialmente.
PARTE SECONDA – LE CAUSE DELLA MORTE DEL CAPITANO
DE GRAZIA E L’INCHIESTA DELLA MAGISTRATURA
1.
1.1 – Il decesso del capitano De Grazia. Il 13
dicembre 1995, a soli 39 anni, il capitano De Grazia è deceduto per cause che a
molti, compresi i pubblici ministeri titolari dell’indagine allora in corso,
apparvero quanto meno sospette e che ancora oggi, a distanza di anni, continuano
ad essere considerate tali (in questi termini si sono espressi sia il dottor
Neri che il dottor Pace nel corso dell’audizione innanzi a questa Commissione
parlamentare). Il dottor Pace, in particolare, nell’audizione del giorno
20.1.10, ha dichiarato: “Quando è giunta la notizia della morte di De Grazia io,
Neri ed altri non abbiamo avuto dubbi sul fatto che quella morte non fosse
dovuta a un evento naturale. Avevo sentito De Grazia alle 10,30 di quella
mattina, mi aveva detto che con una delega di Neri si sarebbe recato prima a
Massa Marittima e poi a la Spezia, mi avrebbe aspettato a Reggio Calabria per
portarmi con una nave sul punto esatto in cui è affondata la Rigel. Alle 10,30
del 13 dicembre, giorno in cui è morto, ricevetti questa sua telefonata in
ufficio, ma non sono in grado di fornire elementi obiettivi”. Cosa accadde quel
giorno? Ciò che accadde è stato ricostruito dagli inquirenti esclusivamente
sulla base della relazione di servizio e delle testimonianze rese dal
maresciallo Nicolò Moschitta e dal carabiniere Rosario Francaviglia, i quali il
12 dicembre 1995 si trovavano con il capitano De Grazia, diretti al porto di La
Spezia, ove avrebbero dovuto dare esecuzione ad alcune deleghe dell’autorità
giudiziaria cui si è fatto riferimento nei paragrafi precedenti. Si trattava di
un’attività alla quale avrebbe dovuto necessariamente partecipare il capitano De
Grazia, in ragione di una competenza specifica nella materia marittima, tale da
renderlo elemento insostituibile nello svolgimento delle indagini. Sono state
acquisite dalla Commissione le copie delle deleghe di indagini emesse dal
magistrati di Reggio Calabria in data 11 dicembre 1995 (di cui si è trattato
nella parte prima, capitolo 1, paragrafo 1.10).
Dunque, il capitano De Grazia partì, unitamente al
maresciallo Moschitta e al carabiniere Francaviglia, alla volta di La Spezia, in
data 12 dicembre 1995, nel tardo pomeriggio. Secondo quanto emerso dalle
indagini, durante il viaggio, sul tratto autostradale di Salerno, alle prime ore
del 13 dicembre 1995 il capitano venne colto da malore e, quindi, trasportato in
ambulanza presso l’ospedale civile di Nocera Inferiore, ove giunse cadavere.
Come già evidenziato, il decesso del capitano De Grazia ha coinciso con una fase
di rallentamento (e successivamente) di vero e proprio arresto delle indagini
che lo stesso stava portando avanti. Dal momento della sua morte in poi vi è
stato un progressivo sfaldamento dell’attività investigativa concomitante a
quello del pool che fino ad allora aveva profuso impegno ed energie negli
accertamenti connessi al traffico di rifiuti radioattivi.
1.2 – Il procedimento aperto presso la procura
della Repubblica di Nocera Inferiore. A seguito del decesso del capitano De
Grazia venne aperto un procedimento dalla procura della Repubblica di Nocera
Inferiore, territorialmente competente in relazione al luogo del decesso. Gli
atti del procedimento sono stati acquisiti in copia dalla Commissione (doc.
321/1 e 321/2). E’ importante seguire la scansione temporale degli atti
procedimentali compiuti nell’ambito della suddetta indagine, per poi entrare nel
merito delle risultanze processuali. In sostanza, le indagini si sono articolate
in due fasi: 1) la prima fase è consistita essenzialmente nell’espletamento
dell’autopsia sul corpo del capitano De Grazia (effettuata per rogatoria dalla
procura di Reggio Calabria) nonché nell’acquisizione dell’annotazione redatta
dai carabinieri di Nocera Inferiore intervenuti sul posto e della relazione di
servizio redatta dal maresciallo Moschitta e dal carabiniere Francavilla nei
giorni successivi al decesso. In questa fase non sono stati svolti ulteriori
accertamenti né presso il ristorante “Da Mario”, ove il capitano De Grazia cenò
per l’ultima volta unitamente ai suoi compagni di viaggio, né presso altri
luoghi. E neppure sono state sentite a sommarie informazioni le persone che
avevano assistito ai fatti, come il maresciallo Moschitta, il carabiniere
Francaviglia, i medici del pronto soccorso, il personale dell’ambulanza e gli
appartenenti al nucleo mobile della stazione Carabinieri intervenuti sul posto.
Nessuna informazione dettagliata è stata, poi, acquisita formalmente in merito
alle indagini che il capitano De Grazia si accingeva a svolgere a La Spezia.
Sulla base, dunque, dei risultati dell’autopsia contenuti nella relazione
depositata nel marzo 1996 dal medico legale nominato dal pubblico ministero è
stata richiesta ed ottenuta l’archiviazione del procedimento. La seconda fase
del procedimento è stata avviata un anno dopo, a seguito della istanza di
riapertura delle indagini presentata dai congiunti del capitano De Grazia.
Seguendo in parte le indicazioni contenute in detta istanza, il pubblico
ministero titolare del procedimento (sostituto procuratore Giancarlo Russo) si
recò a Reggio Calabria per sentire personalmente a sommarie informazioni il
sostituto Francesco Neri, i carabinieri Moschitta e Francaviglia, la signora
Vespia e il signor Pontorino (rispettivamente moglie e cognato del capitano De
Grazia) ed, infine, il dottor Asmundo (consulente medico legale di parte) e la
dottoressa Del Vecchio. Dispose, quindi, una nuova consulenza medico legale,
affidandosi allo stesso consulente che aveva espletato la prima, ossia alla
dottoressa Simona Del Vecchio, successivamente risentita a sommarie informazioni
dal magistrato. Delegò, infine, i Carabinieri per effettuare accertamenti presso
il ristorante “Da Mario”. Anche in questa seconda fase delle indagini si è
rivelata dirimente, ai fini della successiva archiviazione, la relazione di
consulenza tecnica medico legale con la quale si è ribadito che il decesso era
riconducibile a cause naturali, non essendo state riscontrate anomalie neanche a
seguito degli ulteriori esami tossicologici e istologici effettuati sui tessuti
prelevati.
1.3 – Gli atti del procedimento. Si riporta, di
seguito, la cronologia degli atti contenuti nel fascicolo aperto dalla procura
di Nocera inferiore, utili alla ricostruzione degli eventi e delle indagini che
furono compiute:
- alle ore 00:15 del 13 dicembre 1995 la centrale
operativa dei Carabinieri ordinò all’aliquota radiomobile della Compagnia di
Nocera Inferiore di recarsi presso l’autostrada A/30, un chilometro prima della
barriera autostradale di Mercato San Severino (SA), in quanto all’uscita di una
galleria vi era un’autovettura con a bordo persona colta da malore.
Contestualmente venne allertata l’autoambulanza;
- dall’annotazione di servizio redatta in data 13
dicembre 1995 alle ore 6:30 dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile risulta
che i Carabinieri e l’autoambulanza arrivarono contemporaneamente sul posto ove
trovarono sulla corsia di emergenza, di fianco allo sportello posteriore destro
di una Fiat Tipo, un uomo (poi identificato con il capitano De Grazia) posto sul
manto stradale, in posizione supina, subito soccorso e trasportato presso
l’ospedale di Nocera Inferiore. Giunti presso il nosocomio, i militari
appurarono, tramite il sanitario di guardia, dottor Amodio, che il capitano era
deceduto durante il tragitto verso l’ospedale (come da referto 2618 del 13
dicembre 1995). Vennero avvisati i familiari. La borsa e gli effetti personali
del capitano De Grazia vennero consegnati ad un militare in caserma, mentre la
valigetta 24 ore contenente gli atti di cui al procedimento n. 2114/94 R.G.N.R.
venne consegnata al maresciallo Moschitta;
- alle ore 11.40 del 13 dicembre 1995, i
carabinieri della stazione CC Nocera Inferiore trasmisero un fax alla locale
procura della Repubblica, comunicando che alle ore 0.50 era giunto, presso il
Pronto soccorso dell’ospedale civile di Nocera Inferiore, il corpo del cap. De
Grazia e che il medico di guardia aveva accertato come causa della morte
“infarto del miocardio” con conseguente arresto cardio-circolatorio;
- il referto 2618 del 13 dicembre 1995,
sottoscritto dal medico di guardia dottor Amodio, risulta acquisito dai CC di
Nocera Inferiore: in esso si attesta che il Capitanto giunse cadavere al pronto
soccorso (doc. 1245/3);
- venne iscritto, presso la procura circondariale
di Reggio Calabria, il procedimento modello 45 (da riferire ad atti non
costituenti notizia di reato) avente n. 1611/95;
- sempre in data 13 dicembre 1995 venne rilasciato
dal pubblico ministero titolare del procedimento, dottor Giancarlo Russo, il
nulla osta al seppellimento, ove venne indicata, quale causa della morte,
“infarto miocardico – arresto cardiocircolatorio” e, quale medico legale
intervenuto, il dottor Contaldo;
- il giorno seguente, il procuratore capo della
procura circondariale di Reggio Calabria, dottor Scuderi, segnalò, con una nota
scritta alla procura di Nocera Inferiore, l’opportunità di disporre l’esame
autoptico sulla salma del capitano De Grazia;
- a seguito di tale nota, il 15 dicembre 1995 il
pubblico ministero di Nocera Inferiore delegò la procura della Repubblica di
Reggio Calabria ad effettuare per rogatoria il disseppellimento del cadavere,
nel frattempo trasportato a Reggio Calabria, e l’esame autoptico; nella medesima
delega, il pubblico ministero Russo segnalò, inoltre, l’opportunità di escutere
a sommarie informazioni testimoniali i carabinieri che avevano viaggiato con il
capitano e ogni altra persona (familiari, investigatori) in grado di riferire
circostanze utili alle indagini “volte a chiarire con certezza la causalità del
decesso”;
- nella stessa data il pubblico ministero della
procura di Reggio Calabria (dottoressa Apicella) dispose il disseppellimento del
cadavere del Cap. De Grazia;
- il 18 dicembre 1995 Anna Maria Vespia (moglie
del capitano De Grazia) nominò consulente tecnico di parte il dottor Asmundo,
primario presso l’Istituto di medicina legale dell’Università di Messina.
- il 19 dicembre 1995 venne conferito l’incarico
alla dottoressa Del Vecchio per effettuare l’autopsia nonché l’esame istologico
e chimico tossicologico dei tessuti;
- il 22 dicembre 1995 il comandante del reparto
operativo – nucleo oeprativo dei Carabinieri di Reggio Calabria, Antonino Greco,
trasmise al procuratore capo della procura circondariale di Reggio Calabria,
dottor Scuderi, una nota con la quale restituiva le sei deleghe ricevute e non
potute evadere in ragione del decesso del capitano De Grazia, allegando la
relazione redatta dal maresciallo Moschitta e dal carabiniere Francaviglia in
merito ai fatti occorsi in data 12 e 13 dicembre 1995, nonché la relazione di
servizio redatta dal nucleo radiomobile dei carabinieri di Nocera Inferiore
intervenuti sull’autostrada su richiesta del maresciallo Moschitta. Nella nota
di trasmissione il comandante Greco specificò che la valigetta che De Grazia
aveva a con sé il giorno del decesso, consegnata al maresciallo Moschitta dai
carabinieri di Nocera Inferiore intervenuti, era stata riconsegnata al dottor
Neri il giorno 21 dicembre 1995;
- in data 8 gennaio 1996 la nota e le relazioni
allegate furono trasmesse via fax dal procuratore Scuderi al sostituto
procuratore Giancarlo Russo;
- il 12 marzo 1996 il medico legale, dottoressa
Del Vecchio, depositò la relazione di consulenza tecnica: il decesso del
capitano venne ricondotto “ad una morte di tipo naturale, conseguente ad una
insufficienza cardiaca acuta, inquadrabile più specificatamente nella
fattispecie della morte improvvisa”;
- vennero, quindi, trasmessi gli atti alla procura
della Repubblica di Nocera Inferiore;
- il 9 luglio 1996 il sostituto procuratore dottor
Russo richiese l’archiviazione, accolta dal Gip il successivo 28 settembre 1996;
- nessuna altra indagine venne svolta in questa
fase: in sostanza, l’archiviazione venne chiesta e disposta sulla base della
relazione redatta dai carabinieri Moschitta e Francaviglia e dei risultati
dell’autopsia, mentre non ebbero seguito le ulteriori (e pur generiche) attività
investigative di cui alla delega del pubblico ministero Russo del 15 dicembre
1995;
- In data 8 marzo 1997 i prossimi congiunti del
capitano De Grazia chiesero la riapertura delle indagini (allegando la
consulenza tecnica di parte, redatta dal dottor Asmundo, che fino a quel momento
non risultava essere stata depositata) sulla base di una serie di
considerazioni: la necessità di chiarire per quale motivo i due consulenti
(quello d’ufficio e quello di parte) fossero giunti a conclusioni diverse; la
necessità di sentire altre persone informate sui fatti (parenti, ufficiali di
polizia giudiziaria, magistrati) nonché di identificare gli ufficiali del
S.I.O.S. della Marina militare con cui De Grazia avrebbe avuto contatti prima a
Messina e poi a Roma;
- negli atti trasmessi alla Commissione non vi è
traccia del provvedimento di riapertura delle indagini; in ogni caso, dagli
stessi si ricava che venne iscritto un procedimento a carico di ignoti
(procedimento penale n. 251/97, mod. 44) per il reato di cui all’articolo 575
del codice penale (omicidio);
- in data 1° aprile 1997 il pubblico ministero
conferì una delega ai CC per accertamenti in merito al ristorante “da Mario”,
ove si fermarono a cenare De Grazia, Moschitta e Francaviglia;
- l’esito delle indagini, per la verità poco
produttive perchè disposte a distanza di tempo dai fatti, venne trasmesso in
data 8 aprile 1997;
- in data 8 e 9 aprile 1997 vennero sentiti
personalmente dal pubblico ministero di Nocera Inferiore le seguenti persone: il
maresciallo Moschitta e il maresciallo Rosario Francaviglia, il dottor Neri,
Francesco Postorino (cognato di De Grazia), il dottor Asmundo, Anna Maria Vespia
(moglie del capitano De Grazia);
- il 23 aprile 1997 il pubblico ministero dottor
Russo sentì a chiarimenti la dottoressa Del Vecchio in merito alle osservazioni
formulate dal consulente tecnico di parte dottor Asmundo nonché in merito agli
ulteriori possibili accertamenti tossicologici;
- in data 12 giugno 1997 il pubblico ministero
dispose il disseppellimento del cadavere del capitano De Grazia;
- il 18 giugno 1997 venne conferito nuovo incarico
alla dottoressa Del Vecchio al fine di effettuare ulteriori accertamenti
chimico-tossicologici;
- in data 11 dicembre 1997 venne depositata la
consulenza medico legale e, nello stesso giorno, fu sentita a chiarimenti la
dottoressa Del Vecchio;
- in data 28 luglio 1998 venne nuovamente
formulata richiesta di archiviazione, accolta dal Gip a quattro anni di distanza
con provvedimento consistente nell’apposizione, in calce alla richiesta di
archiviazione, di un timbro recante, in luogo della parte motiva del
provvedimento, la dicitura prestampata “letti gli atti, condivisa la richiesta
del pubblico ministero”. Il timbro reca la sottoscrizione del Gip, dottoressa
Raffaella Caccavela e la data di deposito 26 novembre 2002 (doc. 1276/3).
1.4 – Gli elementi emersi nel corso delle
indagini. 1.4.1 – La relazione di servizio e le dichiarazioni del maresciallo
Moschitta e del carabiniere Francaviglia. I militari che si trovavano con il
capitano De Grazia al momento dell’evento redassero una relazione di servizio il
22 dicembre successivo, descrivendo analiticamente il viaggio, le tappe
effettuate e le circostanze che accompagnarono il decesso del loro collega.
Nell’aprile 1997 gli stessi vennero sentiti a sommarie informazioni dal pubblico
ministero Russo. Dalla relazione e dalle loro dichiarazioni risulta quanto
segue: i militari partirono da Reggio Calabria alle ore 18.50 del 12 dicembre
1995 a bordo di autovettura di servizio, una Fiat Tipo con targa di copertura,
appartenente al reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di
Reggio Calabria e nel corso del viaggio vennero effettuate quattro soste:
- la prima, presso l’autogrill di Villa San
Giovanni, ove scese dal mezzo solo il capitano De Grazia per acquistare delle
sigarette;
- la seconda, presso l’autogrill di Cosenza, ove
scesero il maresciallo Moschitta e il carabiniere Francaviglia;
- la terza, presso l’autogrill di Lauria, ove
venne effettuato rifornimento di carburante (nessuno scese dall’auto);
- la quarta, in località Campagna, dove i militari
decisero di fermarsi intorno alle ore 22.30 per recarsi presso il ristorante “Da
Mario”. A detta dei militari, quest’ultima tappa non era stata programmata.
Dalla relazione di servizio risulta che i tre militari non furono avvicinati da
alcuno durante le soste. Nel ristorante, a parte il cameriere e il titolare,
c’erano solo altre due persone che stavano per ultimare la loro cena e che, dopo
poco, andarono via salutando il titolare del ristorante amichevolmente (in modo
tale da potersi dedurre che ci fosse tra loro un rapporto di pregressa
conoscenza o familiarità). Secondo il racconto conforme dei due Carabinieri,
presso il ristorante mangiarono tutti le stesse cose, a parte una fetta di torta
che fu ordinata solo dal capitano De Grazia, bevvero tutti un po’ di vino e del
limoncello e intorno alle 23.30 ripresero il viaggio. Alla guida
dell’autovettura si pose il Carabiniere Francaviglia, sul sedile lato passeggero
si sedette il capitano De Grazia e sui sedili posteriori il maresciallo
Moschitta. Il capitano si addormentò e iniziò a russare rumorosamente. Quando
giunsero nei pressi del casello autostradale Caserta-Roma, il capitano chinò la
testa in modo anomalo (erano le ore 24:00 circa), tanto che gli altri occupanti
dell’autovettura cercarono di svegliarlo; quando gli toccarono il volto si
resero conto che era freddo e sudato; quindi, superata la galleria in cui si
trovavano, si fermarono nella corsia di emergenza. Il maresciallo Moschitta,
resosi conto della gravità della situazione, chiamò il 112 affinché venisse
inviata un’ambulanza. Rispose un operatore del 112 di Napoli che allertò – alle
00:15- i Carabinieri di Nocera Inferiore (come risulta dall’annotazione di
servizio da questi ultimi redatta). Nel frattempo il Carabiniere Francaviglia
provò ad effettuare una serie di massaggi cardiaci e la respirazione bocca a
bocca, ciò che determinò una parziale fuoriuscita di cibo dallo stomaco del
capitano De Grazia. Dopo circa venti minuti dalla chiamata giunse un’autoradio
dei carabinieri del nucleo radiomobile di Nocera Inferiore unitamente ad
un’ambulanza che trasportò il capitano presso il pronto soccorso dell’ospedale
civile di Nocera Inferiore. Dall’annotazione di servizio redatta dai CC di
Nocera Inferiore intervenuti sul posto risulta che, non appena giunsero presso
il pronto soccorso (circa alle 00:50), vennero informati dal sanitario di
guardia, dottor Amodio, che il capitano era deceduto durante il trasporto verso
l’ospedale. I militari riferirono tale notizia ai loro superiori.
Nell’annotazione si dà atto che vennero informati i familiari del capitano e che
la valigetta “24 ore” appartenente al capitano De Grazia fu consegnata al
maresciallo Moschitta.
Solo il mattino seguente il corpo venne esaminato
tramite visita esterna dal medico legale dell’ospedale, dottor Contaldo, il
quale diagnosticò la morte del capitano De Grazia per “infarto miocardico”. Il
maresciallo Moschitta ha riferito di aver sottolineato subito l’opportunità di
sottoporre il cadavere ad esame autoptico, circostanza che indusse il medico
legale ad interpellare il magistrato di turno, dottor Russo. Questi, peraltro,
sentito il parere del medico circa la causa naturale della morte, decise di non
disporre l’autopsia, concedendo, poche ore più tardi, il nulla osta al
seppellimento. In proposito va evidenziato che – secondo quanto invece riferito
al pubblico ministero Russo da Francesco Postorino (cognato del capitano De
Grazia, intervenuto presso l’ospedale) – né il maresciallo Moschitta né i
congiunti stessi del capitano avanzarono richieste affinché fosse disposto
l’esame autoptico. Va rilevato che non c’è nessuna testimonianza in ordine a ciò
che accadde dal momento dell’arrivo al pronto soccorso fino al mattino
successivo, allorquando giunse il medico legale. Si riporta, di seguito, la
relazione di servizio citata, redatta il 22 dicembre 1995, firmata dal
maresciallo Moschitta e dal carabiniere Francaviglia e vistata dal comandante
del Nucleo operativo A. Greco (doc. 319/1).
1.4.2 – La decisione di procedere all’accertamento
autoptico. L’incarico al medico legale dottoressa Del Vecchio
Come detto, della morte del capitano fu informato
anche il procuratore capo della procura circondariale di Reggio Calabria, dottor
Scuderi, il quale, venuto a conoscenza del fatto che il pubblico ministero di
Nocera Inferiore aveva dato il nulla osta al seppellimento, inviò, in data 14
dicembre 1995, una nota alla procura della Repubblica di Nocera Inferiore
sottolineando l’opportunità di far eseguire l’esame autoptico sulla salma, al
fine di sgomberare il campo da ogni sospetto circa le cause della morte. Il
procuratore Scuderi motivava la richiesta in ragione delle delicate e complesse
indagini che stava seguendo il capitano De Grazia tendenti ad accertare se
dietro il naufragio di vecchie navi si celassero episodi di illecito smaltimento
di rifiuti radioattivi. Sottolineava, in particolare, “l’enorme rilevanza degli
interessi in gioco, l’accertato coinvolgimento di governi, istituzioni,
personalità influenti nel campo politico ed economico, il fatto che in passato
le attività degli inquirenti hanno registrato inquietanti presenze (pedinamenti)
sulle quali ai distanza di mesi, per quanto a conoscenza di questo ufficio, non
si è fatta luce, la circostanza che l’attività di indagine che il cap. De Grazia
si accingeva a svolgere poteva essere decisiva per l’individuazione di
fatti–reato e responsabilità, le gravi conseguenze che sul piano investigativo
provocherà il venir meno del contributo della elevatissima professionalità del
succitato ufficiale” (doc. 681/87). Dunque, i primi sospetti circa un eventuale
collegamento tra la morte del capitano e le indagini che lo stesso stava
portando avanti furono sollevati proprio dai titolari dell’indagine sulle “navi
a perdere”. La richiesta del procuratore Scuderi venne recepita dal pubblico
ministero Russo il quale, il giorno successivo, delegò la procura della
Repubblica di Reggio Calabria affinché venisse disposto il disseppellimento del
cadavere (nel frattempo trasportato a Reggio Calabria) ed espletato l’esame
autoptico; nella delega il pubblico ministero segnalò, inoltre, l’opportunità di
escutere a sommarie informazioni testimoniali i carabinieri che accompagnavano
il capitano e ogni altra persona (familiari, investigatori) in grado di riferire
circostanze utili alle indagini “volte a chiarire con certezza la causalità del
decesso”. L’autorità giudiziaria delegata (nella persona del pubblico ministero
presso il tribunale di Reggio Calabria, dottoressa Apicella) dispose, quindi, il
disseppellimento del cadavere che avvenne lo stesso 15 dicembre 1995, alla
presenza del sanitario di polizia mortuaria dell’USL 11, nonché del maresciallo
Domenico Scimone atteso che la dottoressa Apicella aveva delegato per il
controllo della regolarità delle operazioni proprio gli Ufficiali della sezione
di polizia giudiziaria dei CC della procura presso il tribunale di Reggio
Calabria, sezione alla quale apparteneva appunto il maresciallo Scimone.
L’incarico di eseguire l’autopsia e gli esami tossicologici venne affidato alla
dottoressa Simona Del Vecchio (in proposito, il dottor Russo, sentito da questa
Commissione in data 22 febbraio 2011, ha precisato che era stata la dottoressa
Apicella, pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Calabria, a scegliere
la dottoressa Del Vecchio quale consulente). Anche i familiari del capitano
nominarono un consulente medico legale (il dottor Alessio Asmundo). La scelta
del dottor Asmundo avvenne su indicazione del dottor Neri, al quale la famiglia
di De Grazia aveva chiesto consiglio. Il dottor Neri, sentito su questa
circostanza nell’aprile 1997 dal PM Russo, ha dichiarato: “Effettivamente i
familiari del capitano De Grazia mi chiesero a chi avrebbero potuto rivolgersi
per una consulenza medico-legale di parte ed io indicai che noi di solito ci
rivolgevamo all’Istituto di medicina legale di Messina presso il prof. Aragona o
il professor Asmundo, periti di ottima preparazione”. Va evidenziato che le
indagini preliminari si sostanziarono, in questa fase, esclusivamente nel
conferimento dell’incarico di consulenza tecnica per l’espletamento
dell’autopsia e nell’acquisizione della relazione di servizio redatta dai
carabinieri Moschitta e Francaviglia. Il 19 dicembre 1995 la dottoressa
Apicella, pubblico ministero presso la procura di Reggio Calabria, conferì
incarico di consulenza tecnica alla dottoressa Del Vecchio in merito ai seguenti
quesiti:
- accerti il consulente, previo esame autoptico
della salma del capitano De Grazia la natura, le modalità e i mezzi che ne hanno
cagionato il decesso;
- accerti, mediante esame istologico e
chimico-tossicologico, l’eventuale presenza di sostanze tossiche o con analoghe
caratteristiche, che abbiano cagionato il decesso di cui sopra. Le operazioni di
consulenza si svolsero presso la camera mortuaria dell’ospedale di Reggio
Calabria, alla presenza del dottor Asmundo. La dottoressa Del Vecchio, nella sua
relazione depositata il 12 marzo 1996, concluse nel senso che la morte del
capitano De Grazia doveva ricondursi alla cosiddetta “morte improvvisa
dell’adulto, che trova origine per lo più in un’ischemia del miocardio con
successive gravi turbe del ritmo cardiaco, che si manifestano anche in assenza
di segni premonitori e che, dal punto di vista anatomopatologico, addirittura
nella metà dei casi circa, sono caratterizzati dall’assenza di segni specifici,
non solo macroscopici, ma anche microscopici e ultramicroscopici”. La morte
improvvisa viene definita nella relazione come un evento repentino e inatteso
caratterizzato dal fatto che il soggetto passa da una condizione di completo
benessere o, almeno, di assenza di sintomi, alla morte in un arco di tempo
inferiore alle 24 ore. La causa scatenante può essere determinata (oltre che da
uno sforzo fisico) anche da una condizione di permanente tensione emotiva e di
allarme conseguente all’espletamento di attività professionali particolarmente
impegnative, delicate e rischiose, fonte di enormi responsabilità (come nel caso
del capitano De Grazia) che possono determinare una condizione di stress
continuo che alla fine precipita la situazione cardiaca.
1.4.3 – La relazione del consulente di parte.
Differenze rispetto alla relazione del consulente del pubblico ministero
La consulenza tecnica del 18 giugno 1996 redatta
dal dottor Alessio Asmundo contiene conclusioni analoghe a quelle della
dottoressa De Vecchio per quanto concerne l’individuazione della natura cardiaca
della morte. Se ne differenzia, invece, quanto alla descrizione dei reperti
obiettivi:
- il consulente d’ufficio aveva descritto “un
cuore di forma normale e volume diminuito”, mentre il consulente tecnico di
parte lo descrive come un cuore leggermente globoso, con punta formata dal
ventricolo sinistro e maggiore prevalenza del destro rispetto alla norma;
- il consulente d’ufficio aveva descritto “il
tessuto adiposo sottoepicardico molto rappresentato con colorito grigiastro ed
aspetto translucido…… il tessuto adiposo si approfondisce a tratti financo nei
piani muscolari; il consulente tecnico di parte definisce, invece, il tessuto
adiposo subepicardico quantitativamente e qualitativamente normo-rappresentato;
- il consulente d’ufficio aveva evidenziato
un’evidente sofferenza delle arterie di piccolo e medio calibro, che presentano
ispessimento sia avventiziale che intimale, con lumi ristretti; mentre il
consulente tecnico di parte afferma che le coronarie sono apparse esenti da
alterazioni di natura aterosclerotica. In merito poi alle cause della morte, il
consulente tecnico di parte conclude nel senso che “la morte di De Grazia Natale
rappresenta caratteristico accidente cardiaco improvviso per insufficienza
miocardica acuta da miocitosi coagulativa da superlavoro in soggetto affetto da
cardiomiopatia dilatativa”. Il dottor Asmundo è stato sentito a sommarie
informazioni dal pubblico ministero dottor Russo al fine di fornire chiarimenti
in merito alla sua relazione ed, in tale occasione, ha sostenuto che:
- il capitano De Grazia era morto per una causa
patologica naturale essendo affetto da cardiomiopatia dilatativa da
catecolamine;
- non condivideva quanto sostenuto dalla
dottoressa Del Vecchio in merito al volume del cuore ed all’eccesso di grasso,
non avendo riscontrato tali anomalie;
- si era trattato, quindi, di una morte improvvisa
da causa cardiaca, che però il consulente tecnico d’ufficio ricollegava ad un
meccanismo patogenetico diverso, connesso a problemi di trasmissione
dell’impulso cardiaco. Il dottor Asmundo, pur non avendo partecipato agli esami
tossicologici per non essere stato avvisato, a suo dire, dalla collega, ha però
affermato che erano stati effettuati tutti gli accertamenti tossicologici in
merito all’eventuale ingestione di sostanze venefiche.
1.4.4 – Gli ulteriori accertamenti disposti su
richiesta dei familiari del capitano De Grazia. A seguito del deposito della
relazione da parte del consulente tecnico di parte, i familiari della vittima
depositarono – nel marzo 1997 – una richiesta di riapertura indagini. In
sostanza, lamentavano le carenze investigative dell’inchiesta svolta, non
essendo state ascoltate le persone che avrebbero potuto fornire maggiori
informazioni sulle circostanze particolari del decesso (ad esempio i carabinieri
che viaggiavano con il capitano De Grazia, il dottor Neri, il maresciallo
Scimone) e non essendo stato effettuato alcun accertamento in merito al
ristorante ove il capitano aveva presumibilmente mangiato il 12 gennaio 1995.
Vennero, quindi, effettuati gli ulteriori approfondimenti richiesti a distanza
di un anno e mezzo dai fatti. Si accertò che effettivamente in località Campagna
era attivo (anche all’epoca dei fatti) il ristorante “Da Mario”, gestito dal
titolare Desiderio D’Ambrosio, dalla madre Antonina Adelizzi e dalla convivente
Antonina D’Elia, tutti esenti da pregiudizi penali. Si accertò che la conduzione
era di tipo familiare e che i titolari si avvalevano di personale esterno solo
in occasione di banchetti o cerimonie. Deve, peraltro, rilevarsi che non furono
mai sentiti i gestori del ristorante né fu mai effettuato un sopralluogo.
Vennero, invece, sentiti a sommarie informazioni i congiunti del capitano De
Grazia, il consulente tecnico di parte dottor Asmundo, il sostituto procuratore
dottor Neri e i carabinieri Moschitta e Francaviglia, ma non il maresciallo
Scimone. Per primo, in data 8 aprile 1997 venne sentito Postorino Francesco,
cognato del capitano De Grazia, il quale, oltre a riferire in merito alle
preoccupazioni che il capitano aveva per la sua incolumità in relazione alle
indagini che stava svolgendo (preoccupazioni che aveva confidato al cognato),
parlò dei sospetti che il capitano nutriva sul maresciallo Scimone. Il signor
Postorino si espresse in questi termini: “Posso dirle che mio cognato mi ha
riferito in qualche occasione di un comportamento strano del maresciallo Scimone
del nucleo operativo dei carabinieri di Reggio il quale faceva parte dello
stesso gruppo investigativo coordinato dal dottor Neri. In particolare si riferì
ad una strana condotta del maresciallo Scimone durante una certa perquisizione o
un sopralluogo in Roma o nelle vicinanze senza però chiarirmi altro. Mi disse
che in quella occasione la persona che si trovava in casa gli riferiva di essere
amico di ammiragli e persone influenti, senza però chiarirmi altro. Qualche
giorno prima della morte, sicuramente tra il giorno dell’Immacolata ed il 12
dicembre mi confessò in modo esplicito di essersi accorto che un suo
collaboratore nelle indagini passava informazioni riservate ai servizi segreti
deviati. Quando sulla base di quei sospetti da lui esplicitati in precedenza io
gli feci il nome del maresciallo Scimone lui mi confermò facendo un cenno di
assenso. Oltre questo non mi ha mai detto nient’altro che possa essere utile
alle indagini. ADR: mio cognato mi ha anche ritento in più di una occasione di
aver subito pressioni ma non ha specificato da parte di chi, so soltanto che una
volta mi disse che se voleva poteva essere già ammiraglio. Presumo pertanto che
lui facesse riferimento a pressioni che in qualche modo riceveva per le indagini
che andava svolgendo da ambienti interni alla Marina o ad altri organismi
statali (…) ricordo che mio cognato mi riferì, dopo l’inizio della sua
partecipazione alle indagini, che era stato chiamato presso lo Stato maggiore
della Marina a Roma per riferire sulle indagini. All’inizio delle indagini mi
disse che doveva andare a Messina per incontrarsi con una persona dei servizi
segreti della Marina, come da sua richiesta, proprio in relazione alle indagini
che avrebbe compiuto”. In data 8 aprile 1997 venne sentita anche la moglie del
capitano De Grazia, Anna Maria Vespia. La stessa riferì, in sintesi:
- che era a conoscenza delle delicate indagini
condotte dal marito sui rifiuti radioattivi, per le quali lo stesso appariva
pensieroso e preoccupato;
- che il marito non le aveva mai riferito di aver
ricevuto minacce, seppur le aveva fatto capire la delicatezza delle indagini;
- che le sembrava strano il fatto che i
carabinieri che accompagnavano il marito, invece di portarlo subito in ospedale,
si fossero fermati sulla strada in attesa dei soccorsi;
- che il marito aveva posticipato la partenza per
La Spezia di un giorno in quanto lei aveva la febbre;
- che nutriva dei dubbi sulla “causa naturale”
della morte del marito, il quale aveva sempre goduto di ottima salute e si
sottoponeva, come membro della Marina, ad analisi periodiche (ogni due anni);
- che il maresciallo Moschitta si era contraddetto
in quanto da un lato le aveva parlato dei rapporti informali ed amichevoli che
lo legavano a suo marito, dall’altro aveva scritto nella relazione di aver fatto
accomodare suo marito sul sedile anteriore dell’autovettura per una questione di
rispetto;
- che il marito era solito addormentarsi dopo i
pasti ed amava mangiare con tranquillità. Il 9 aprile 1997 venne sentito dal
pubblico ministero Russo il maresciallo Moschitta. Dal verbale risulta che
l’escussione si svolse presso la procura di Reggio Calabria alla sola presenza
del magistrato. Moschitta confermò la relazione fatta a suo tempo. Aggiunse che
la cena presso il ristorante “Da Mario” non era stata programmata e che era
stato proprio il capitano De Grazia a proporre di mangiare con calma e non
fugacemente presso un autogrill. Per questo Moschitta aveva proposto di cenare
in quel ristorante, presso il quale aveva pranzato già altre volte. Il
ristoratore, al termine della cena, aveva rilasciato regolare ricevuta fiscale.
Il maresciallo Moschitta precisò che “L’unico cibo che fu ingerito dal capitano
De Grazia e non da noi fu un pezzettino di torta, una specie di crostata, che
era su un carrello esposto nella sala e che lui stesso richiese e scelse
spontaneamente.” Con riferimento al momento in cui lui e il carabiniere
Francaviglia si accorsero che il capitano russava in modo insolito e che era
freddo e sudato, il maresciallo Moschitta disse al dottor Russo: “All’altezza
del casello, credo di Mercato San Severino, la testa si è di nuovo abbassata
sulla sinistra, io gli ho dato la solita pacca ma mi sono accorto che era freddo
e sudato, mentre Francaviglia trovava lo scontrino. Mi sono allarmato dicendo al
Francaviglia che non mi rispondeva. Abbiamo subito capito a quel punto che
avesse avuto un malore ed ho detto a Francaviglia di superare la galleria
fermarsi subito dopo per prestare i soccorsi del caso, anche perché non
conoscevamo i luoghi. Telefonai subito col mio cellullare al 112 e chiesi
soccorso immediatamente. Lo abbiamo tirato fuori dall’auto e lo abbiamo disteso
per terra prima col dorso a terra, allorché Francaviglia ha tentato di
rianimarlo con una respirazione bocca a bocca. Per effetto di questa operazione
vedevamo ritornare fuori l’aria e notavamo per ciò un movimento delle labbra che
a noi profani sembrò un sintomo di vitalità, il che ci spinse a continuare nella
respirazione, notando tra l’altro un rigurgito del cibo ingerito in precedenza.
A quel punto lo abbiamo preso e curvato sul guardrail cercando di farlo vomitare
pensando che vi fosse una ostruzione alle vie respiratorie a causa del cibo
rigurgitato ma il capitano non ha dato segni di vita. Nel frattempo infuriava un
temporale con una forte pioggia. E’ arrivata dopo circa 20 minuti
l’autoambulanza e l’abbiamo seguita all’ospedale. Ricordo che all’ospedale un
infermiere uscendo dalla sala di rianimazione disse che era morto sul colpo per
un infarto fulminante. Credo che le escoriazioni sul petto siano state causate
dal fatto che lo avevamo messo riverso sul guardarail cercando di trattenerlo
ovviamente”. Riguardo alle indagini che stava svolgendo insieme al capitano De
Grazia, il maresciallo Moschitta asserì che, pur non avendo (né lui né il
capitano) mai ricevuto minacce, tuttavia, sin dall’inizio delle indagini,
avevano avuto la sensazione di essere controllati; in particolare avevano notato
pedinamenti o strani episodi che li avevano allarmati, spingendoli ad adottare
sempre maggiori cautele (su questo si è ampiamente trattato nel capitolo 2 della
parte prima). Aggiunse che il capitano gli aveva fatto capire di avere
incontrato “difficoltà di movimento all’interno della Capitaneria di Reggio”, in
quanto “i superiori non vedevano di buon occhio questa indagine, capiva dunque
di non essere appoggiato dalla gerarchia e di dover in sostanza lottare su due
fronti”. Immediatamente dopo l’escussione del maresciallo Moschitta (il 9.4.97
alle ore 12:22), il pubblico ministero Russo sentì il Carabiniere Francaviglia.
Le dichiarazioni di quest’ultimo combaciano con quella rese dal collega. Lo
stesso giorno venne sentito dal pubblico ministero Russo anche il sostituto
procuratore Francesco Neri. Il dottor Neri espose in breve l’oggetto delle
indagini di cui al procedimento penale n. 2114/94 RGNR, nelle quali era
impegnato il De Grazia. Ha, poi, dichiarato: “Unitamente al collega Pace della
procura circondariale di Matera comunicammo al capo dello Stato che le indagini
potevano coinvolgere la sicurezza nazionale, inoltre poiché fatti di questo tipo
potevano essere a conoscenza del Sismi ancor prima dell’ingresso del capitano De
Grazia nelle indagini chiese al direttore del servizio di trasmettermi copia di
tutti gli atti che potevano riguardare il traffico clandestino di rifiuti
radioattivi con navi. A dire il vero il Servizio molto correttamente mi trasmise
degli atti tramite la polizia giudiziaria. In particolare il passaggio degli
atti avvenne tramite il maresciallo Scimone appositamente delegato a ciò da me.
Il maresciallo Scimone faceva parte del gruppo investigativo da me diretto e
teneva i contatti con il Sismi. Il capitano De Grazia era a conoscenza di ciò,
cioè sapeva dei contatti istituzionali di Scimone con il Sismi per la
acquisizione delle notizie che chiedevamo. Ogni attività di rapporto con il
Sismi è formalizzata in specifici atti reperibili nel processo. (…) II capitano
De Grazia era ovviamente molto preoccupato per le indagini come tutti noi, in
considerazione della enormità e particolarità delle vicende che emergevano e per
le persone ed istituzioni coinvolti a livello internazionale. A parte gli
episodi a cui ho fatto cenno in precedenza e di cui alle relazioni predette il
capitano non mi ha mai parlato di altre minacce esplicite o intimidazioni fatte
personalmente a lui. Lui era preoccupato molto dell’episodio accaduto a Roma nel
corso della perquisizione al Viccica. A volte per scherzare e sdrammatizzare mi
diceva che comunque prima avrebbero ammazzato me e poi forse lui, senza con ciò
smorzare il suo ammirevole ed encomiabile sforzo per le indagini che lo ha
distinto fino alla fine.” Questa è stata, dunque, l’attività integrativa svolta
dal pubblico ministero con riferimento all’acquisizione di informazioni. Con
riferimento, poi, all’aspetto medico legale, le differenze tra le due relazioni
depositate, poste in luce dai familiari del capitano De Grazia nella richiesta
di riapertura delle indagini, spinsero il pubblico ministero Russo, dapprima, a
sentire li consulenti tecnici a chiarimenti e, successivamente, a conferire alla
dottoressa Del Vecchio ulteriore incarico, previa riesumazione del cadavere.
Dunque, il 23 aprile 1997, la dottoressa Del Vecchio precisò al pubblico
ministero che le sue valutazioni conclusive finali coincidevano con quelle
espresse dal consulente di parte dottor Asmundo e che, in ogni caso, le
valutazioni parzialmente diverse su aspetti anatomoistopatologici non avevano
influito minimamente sulla diagnosi causale della morte. La dottoressa chiarì,
poi, che gli accertamenti tossicologici già effettuati avevano escluso la
presenza di sostanze tossiche e stupefacenti, in particolare l’alcool, gli
oppiacei, la cocaina, i barbiturici, le benzodiazepine, le anfetamine, i
cannabinoidi e tutte le altre T.L.C, evidenziando che il materiale prelevato per
tali accertamenti (bile e sangue) non era in quantitativo tale da rendere
possibile una ripetizione di queste analisi, mentre avrebbero potuto essere
effettuate analisi tossicologiche più mirate mediante prelievo di capelli, ossa,
quote parte di organi di accumulo “per verificare fino in fondo per quanto
possibile l’esistenza di eventuali sostanza tossiche e velenose diverse, in
particolare la ricerca potrebbe riguardare i veleni metallici”. Le illustrate
nuove indagini medico legali furono, pertanto, oggetto del secondo incarico
affidato alla dottoressa del Vecchio da parte del pubblico ministero Russo, il
quale, in data18 giugno 1997, le pose i seguenti quesiti: “ad integrazione ed
approfondimento della consulenza medico-legale già espletata con riferimento al
decesso del cap. De Grazia Natale, esegua il CT ulteriori accertamenti
chimico-tossicologici per la ricerca di sostanze tossiche e velenose, nonché
approfondisca, con l’allestimento di ulteriori preparati, l’aspetto istologico.
Accerti ed approfondisca altresì quant’altro utile ai fini delle indagini volte
a verificare la causa del decesso, anche tenendo conto di quanto emerge dagli
atti e dalla consulenza di parte depositata”. La dottoressa Del Vecchio, in
questa occasione, si avvalse della collaborazione di consulenti tecnici chimici
nelle persone del prof. Enrico Cardarelli, della facoltà di Scienze matematiche
fisiche e nucleari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, e della
dottoressa Luisa Costamagna, dell’Istituto di medicina legale e delle
assicurazioni della medesima Università. Gli ulteriori accertamenti svolti non
portarono, peraltro, a risultati diversi da quelli già acquisiti. Nella seconda
relazione depositata il consulente ha evidenziato che gli ulteriori esami
chimici hanno escluso la presenza di sostanze tossiche di natura esogena nei
campioni esaminati. La ricerca era stata condotta con particolare riferimento
alle sostanze che possono portare alla morte in tempi brevi con sintomatologie
quali quelle descritte (ipnotici, farmaci cardiaci, depressori del sistema
nervoso centrale, cianuri). E’ stata inoltre effettuata una ricerca di arsenico
nei capelli e nel fegato e la ricerca è risultata negativa. Il mancato
rilevamento di tracce di alcool etilico nel sangue (sebbene, secondo quanto
dichiarato dai testi, il capitano avesse bevuto un bicchiere di vino e del
limoncello) era giustificabile, a detta del consulente, per il fatto che il
decesso era avvenuto a poco più di un’ora dall’ingestione dei cibi, e quindi
l’alcool non aveva avuto il tempo sufficiente per entrare in circolo e,
peraltro, risulta che il capitano De Grazia avesse rigurgitato parte del cibo
durante le manovre di rianimazione messe in atto dal maresciallo Moschitta e dal
carabiniere Francaviglia. La dottoressa Del Vecchio, in data 11 dicembre 1997,
venne nuovamente sentita a chiarimenti dal dottor Russo, in occasione del
deposito della relazione relativa al secondo esame autoptico effettuato (cfr. il
prossimo par. 3.2).
1.4.5 – I provvedimenti di archiviazione. Il
procedimento avviato in merito alla morte del capitano De Grazia si è concluso,
nella prima fase, con un provvedimento di archiviazione emesso il 28 settembre
1996, su richiesta del pubblico ministero del 9 marzo 1996, e basato sui
risultati della prima autopsia che riconduceva il decesso ad un evento naturale.
(doc. 1276/2). La seconda fase si è conclusa un provvedimento di archiviazione
emesso il 26 novembre 2002 dal Gip dottoressa Raffaella Caccavela su richiesta
del pubblico ministero formulata nel luglio 1998 sulla base delle seguenti
considerazioni (doc. 1276/3):
- il decesso del capitano De Grazia era da
ricondurre, secondo quanto accertato dalla consulenza medico legale e autoptica,
ad un evento naturale del tipo “morte improvvisa dell’adulto”;
- gli ulteriori esami chimici disposti a seguito
della riesumazione della salma avevano escluso la presenza di sostanze tossiche
di natura esogena;
- la presunta incompatibilità tra il dato
laboratoristico relativo alla negatività per la presenza di alcool etilico nel
sangue e la circostanza (acquisita sulla base delle testimonianze assunte) della
assunzione di vino e limoncello, appariva spiegata dalle considerazioni
medico-legali evidenziate nel verbale di sit dell’undici dicembre 1997.
2 – GLI ELEMENTI ACQUISITI DALLA COMMISSIONE. La
Commissione ha approfondito la vicenda relativa alla morte del capitano De
Grazia sia attraverso l’acquisizione di copia degli atti del procedimento aperto
presso la procura della Repubblica di Nocera Inferiore sia attraverso numerose
audizioni. Sono stati, in particolare, ascoltati:
- i magistrati Francesco Neri, Nicola Maria Pace,
Francesco Greco che si occuparono delle inchieste sulle navi a perdere;
- il magistrato che condusse le indagini sulla
morte del capitano, Giancarlo Russo;
- il cognato del capitano, signor Postorino
Francesco;
- il maresciallo Niccolò Moschitta, il carabiniere
Rosario Francaviglia, il maresciallo Domenico Scimone, facenti parte, unitamente
al capitano, del gruppo investigativo creato dal dottor Neri;
- i carabinieri Angelantonio Caiazza e Sandro
Totaro, appartenenti al nucelo mobile della Stazione CC di Nocera inferiore,
intervenuti al momento del decesso del capitano.
Sono stati anche ascoltati:
- l’ex colonnello del Corpo forestale dello Stato
di Brescia, Rino Martini;
- il brigadiere del Corpo forestale dello Stato di
Brescia, Gianni De Podestà;
- il vice ispettore del Corpo forestale dello
Stato, Claudio Tassi;
- l’ex collaboratore di giustizia, Francesco Fonti
- il comandante in seconda, ufficiale presso la
Capitaneria di porto di Vibo Valentia, Giuseppe Bellantone.
Si è, poi, ritenuto, di approfondire anche
l’aspetto medico legale, sia attraverso l’audizione dei medici che, all’epoca
delle indagini, eseguirono gli accertamenti autoptici (dottoressa Del Vecchio e
dottor Asmundo) sia affidando al prof. dottor Giovanni Arcudi (direttore
dell’Istituto di medicina legale nella facoltà medica dell’Università di Roma
“Tor Vergata” nonchè consulente della Commissione), l’incarico di valutare gli
accertamenti medico legali compiuti dai predetti consulenti, al fine di
acquisire un parere tecnico anche sotto questo profilo.
2.1 – Le dichiarazioni rese alla Commissione dal
maresciallo Domenico Scimone. In data 18 gennaio 2011 è stato audito dalla
Commissione il maresciallo Domenico Scimone. Lo stesso, dopo aver specificato di
aver preso parte attivamente alle indagini condotte dal sostituto Neri, fin dal
loro inizio, insieme al capitano De Grazia, ha parlato anche dei rapporti con
quest’ultimo, definendolo amico d’infanzia e compagno di regate. In merito al
giorno della morte del capitano, ha dichiarato: “Il giorno della morte di De
Grazia che è la cosa più grave ci eravamo visti di mattina, alle 9.00, con De
Grazia e Moschitta. Il programma era il seguente: io dovevo andare a La Spezia
con Moschitta per acquisire documentazione presso la dogana, De Grazia con la
mia macchina della sezione della polizia giudiziaria insieme al mio autista
avrebbe dovuto recarsi a Crotone per sentire il signor Cannavale, quello che ha
demolito la nave Jolly Rosso. Si doveva quindi occupare della ricostruzione
della Jolly Rosso, mettendo a verbale le dichiarazioni di questo signore.
Alle 10.30-11.00 mi telefona De Grazia dicendomi
che visto che si trattava di un atto di polizia giudiziaria in cui non era
ferrato come me che ne facevo tutti i giorni, preferiva andare con Moschitta
perché avendo navigato per tanti anni sapeva dove mettere le mani nelle dogane e
leggere le polizze di carico. Ho risposto che non c’erano problemi: lui sarebbe
andato a La Spezia mentre io mi sarei recato a Crotone. Intendevo partire verso
le cinque del mattino per andare verso Crotone, mentre non so per quale motivo
De Grazia decise di partire quella sera, nonostante avessi consigliato loro di
partire presto la mattina seguente, arrivando con calma, senza partire di notte.
Avevano però ribattuto che tanto avrebbe guidato l’autista, che si sarebbe
riposato dopo mentre loro visionavano gli atti. Alle 19.00 ho sentito Moschitta:
mi ha detto che stavano partendo e che era tutto a posto. La mattina alle 5.00
sono partito per Crotone. Mentre stavo mettendo a verbale, verso le 8.30-9.00,
mi ha chiamato un collega della sezione di polizia giudiziaria di cui facevo
parte, che mi chiede: «che è successo a De Grazia, è morto?». Ho pensato a un
incidente stradale e ho subito chiamato al telefono. Quando mi ha risposto
Moschitta ho sperato che fosse un’invenzione. Ho chiesto se De Grazia fosse
morto e lui mi ha chiesto chi me lo avesse detto e mi raccomandò di non
preoccuparmi. Continuai quel verbale nonostante ciò e, finito il verbale verso
le 19.00, partimmo con la macchina e scoppiò una gomma, per cui alle 19.30 feci
aprire un garage per aggiustarla. Partiti da Crotone e arrivati all’autostrada
di Lamezia Terme, mi vidi passare davanti il carro funebre e dietro
l’autovettura Ritmo del reparto operativo. Avendo riconosciuto la macchina, mi
sono messo dietro e siamo andati ad accompagnarlo fino a casa. Questa è la
realtà dei fatti. Nessuno poteva conoscere il programma di De Grazia: ha deciso
lui quando partire, dove fermarsi a mangiare, per cui non c’è un mistero: è
morto, su questo ci sono dubbi, quale sia la causa della morte non lo so perché
ho assistito anche all’autopsia effettuata a Reggio Calabria e per un attimo
quando hanno aperto la bara non era lui, poi mi sono reso conto che era lui.
Questa è la realtà dei fatti.”
Riguardo alla partecipazione del maresciallo
Scimone alle operazioni autoptiche, è stato già evidenziato che lo stesso era
stato autorizzato a presenziare alle operazioni di disseppellimento dal pubblico
ministero dottoressa Apicella.
Tuttavia il maresciallo Scimone ha dichiarato alla
Commissione di aver partecipato proprio all’autopsia, che sarebbe stata
effettuata dal dottor Aldo Barbaro: “l’autopsia non è stata in grado di
stabilire nemmeno la causa della morte. (…) è stata fatta a Reggio Calabria dal
dottor Aldo Barbaro. (…) Quando poi la salma è arrivata a Reggio Calabria l’ho
portata io in camera mortuaria e ho assistito all’autopsia del dottor Aldo
Barbaro”. Tuttavia, da nessun atto processuale emerge che il dottor Barbaro
abbia partecipato alle operazioni autoptiche, effettuate solo dalla dottoressa
Del Vecchio e dal consulente di parte dottor Asmundo. Le dichiarazioni del
maresciallo Scimone destano qualche perplessità sotto vari profili. In primo
luogo, come detto, il maresciallo Scimone è l’unico che ha riferito in merito al
cambio di programma, avvenuto – a suo dire – all’ultimo minuto, per cui il
capitano De Grazia decise solo la mattina del 12 dicembre di non andare più a
Crotone, ma di recarsi a La Spezia. Nessun’altro tra gli inquirenti ha, infatti,
accennato a tale circostanza, che peraltro sembrerebbe smentita dalle
dichiarazioni della moglie del capitano, Anna Maria Vespia. Ulteriore motivo di
perplessità riguarda l’indicazione del dottor Barbaro quale medico legale che
avrebbe effettuato l’autopsia, dato che contrasta con le emergenze processuali e
con gli esiti degli ulteriori approfondimenti effettuati dalla Commissione.
2.2 – Le dichiarazioni del maresciallo Moschitta.
Il maresciallo Niccolò Moschitta è stato audito dalla Commissione in due diverse
occasioni. La prima, in data 11 marzo 2010 e la seconda in data 2010. Nel corso
della prima audizione, lo stesso Moschitta ha fornito indicazioni in merito al
motivo della missione a La Spezia, affermando: “Stavamo andando a La Spezia ad
acquisire la documentazione in merito alla Rigel, la nave affondata a capo
Spartivento. Tale documentazione era di interesse perché il processo di La
Spezia aveva sancito che sul trasporto di quella nave erano state pagate dazioni
ed era stato coinvolto personale della dogana e della Rigel circa il carico. Era
necessario e importante avere con noi questi documenti per poi proseguire, se
non erro, per Como o per un’altra destinazione per sentire altri eventuali
testimoni, con tanto di delega del magistrato”. Quanto alle circostanze
specifiche del decesso del capitano De Grazia, il maresciallo Moschitta, ha
rappresentato quanto segue: “Partiamo poco dopo le 19 con la macchina di
servizio, con alla guida il carabiniere. Io ero seduto davanti e il capitano
dietro. Ci siamo fermati 2 o 3 volte per fare benzina, per prenderci qualcosa,
neanche il caffè. Erano soste di servizio senza alcun problema, fino ad arrivare
nella zona prima di Salerno. Ormai era tardi, intorno alle 22.30, quando Natale
ci propose di fermarci per mangiare. Gli dissi che più avanti c’era l’autogrill
di Salerno; avremmo potuto fermarci là, eventualmente mangiare un pasto leggero
e proseguire. De Grazia insistette che voleva mangiare, che aveva fame. Eravamo
proprio presso lo svincolo di Campagna. In passato, insieme a molti altri
colleghi, mi sono occupato anche di Tangentopoli a Reggio Calabria, quindi mi è
capitato di recarmi spesso a Roma presso i differenti ministeri ad acquisire
documenti. Arrivati verso Campagna, gli indicai che c’era un ristorante a due
passi (…) Lui si è seduto davanti in macchina. Erano più o meno le 23.30 e
abbiamo cominciato a dirigerci verso Salerno. Volle sedersi davanti perché
voleva distendere le gambe e cercare di dormire un po’. Allora io mi misi
dietro. Cercavo di dare da parlare il più possibile all’autista perché con lo
stomaco pieno temevo potesse venirgli un colpo di sonno. A un certo punto, il
capitano cominciò a russare, almeno a me sembrò che russasse. Invece poi scoprii
che erano rantoli. Gli sistemai la testa e ripresi a parlare con l’autista.
Quando siamo arrivati al casello di Salerno, il capitano abbassò di nuovo la
testa, ma siamo andati avanti. Alla prima galleria illuminata, lo toccai ed era
sudato freddo. Dissi al collega di guardarlo in faccia, visto che era davanti,
perché era sudato freddo e non mi rispondeva; lo volevo svegliare. Lui mi
rispose che aveva gli occhi storti. Gli dissi di fermarsi alla prima piazzola
non appena usciti dalla galleria; poi, in realtà, ci fermammo sulla corsia di
emergenza perché non c’era piazzola. Nel frattempo, si scatenò un temporale
incredibile e si mise a piovere”. Le altre dichiarazioni rese dal Moschitta alla
Commissione hanno riguardato prevalentemente gli elementi raccolti nel corso
dell’indagine sulle navi a perdere, compediati nell’informativa finale dallo
stesso redatta e depositata nell’ottobre 1996 (v. allegato). 2.3 – Le
dichiarazioni del carabiniere Rosario Francaviglia. La Commissione ha ritenuto
di dover ascoltare anche il carabiniere Francaviglia, il quale, pur avendo preso
parte alle indagini e alla missione durante la quale perse la vita il capitano
De Grazia, fu ascoltato in un’unica occasione dal dottor Russo, rendendo
dichiarazioni sostanzialmente identiche a quelle del suo collega Moschitta e
verbalizzate nello stesso modo. Nel corso dell’audizione avanti alla
Commissione, avvenuta in data 1° agosto 2012, il carabiniere Francaviglia ha
aggiunto alcuni elementi utili a ricostruire più nel dettaglio i drammatici
momenti in cui si accorse, unitamente al maresciallo Moschitta, che il capitano
De Grazia non stava bene. Si riportano i passaggi dell’audizione di maggiore
interesse: “Quando sono arrivato nei pressi dell’autostrada, al casello
autostradale per Salerno, forse nei pressi di Nocera (ma non ricordo bene), il
maresciallo Moschitta si è accorto che il capitano aveva fatto un movimento
strano con la testa e lo ha chiamato; non ha ottenuto risposta e lo ha toccato
in viso per cercare di svegliarlo mentre io, nel frattempo, ripartivo. A quel
punto il maresciallo mi ha detto che qualcosa non andava perché il capitano non
rispondeva; mi sono girato, l’ho guardato negli occhi e ho visto che aveva lo
sguardo assente. Spento (…) Lo sguardo non c’era, non era vivo (…) Si era
addormentato prima, quando siamo partiti. Durante il tragitto, ogni tanto si
sentiva brontolare, cioè russare, a seconda di com’era seduto. Poco prima di
fermarci, ho notato che si era come aggiustato nel sedile, ma non abbiamo notato
nulla di strano; quando sono ripartito dai caselli ed ero arrivato quasi sotto
la galleria, il maresciallo mi ha avvertito che Natale non stava bene ed era
sudato. Mi sono girato per guardarlo in viso e siccome era rivolto verso di me,
ho visto che aveva gli occhi semichiusi, ma lo sguardo non era quello di una
persona viva; non so come altro spiegarlo. L’ho guardato e c’era qualcosa che
non andava; chiaramente, siamo usciti dalla galleria e ci siamo fermati; abbiamo
cercato di fare qualcosa, convinti che stesse male ma che la situazione non
fosse così drammatica. Lo abbiamo tirato fuori dalla macchina e gli ho praticato
massaggio cardiaco e respirazione.(…) La cosa strana, però, è che gli veniva
fuori il cibo da solo e mi arrivava in bocca mentre, nella disperazione,
continuavo a praticargli la respirazione. Nel frattempo si era messo pure a
piovere e pensando che fosse un problema dovuto a qualcosa lo abbiamo piegato
sul guardrail per cercare di fargli liberare l’esofago. Nel frattempo, il
maresciallo Moschitta aveva chiamato soccorso ed è arrivata l’autoambulanza, ma
era già…” Il carabiniere Francaviglia ha fornito, poi, una serie di
precisazioni, affermando che:
- verso le 23:30, al termine della cena, tutti e
tre ripartirono e che il capitano De Grazia non disse alcunchè, addormentandosi
immediatamente;
- sentirono il capitano brontolare o russare;
- ad un certo punto il carabiniere Francaviglia
notò che il capitano si era raddrizzato sul sedile, come a volersi sistemare
meglio. Contemporaneamente, il russare apparì diverso, strano. Ciò accadeva
qualche minuto prima del momento in cui il maresciallo Moschitta si accorse che
De Grazia stava male;
- quando il maresciallo Moschitta lo toccò, lo
trovò freddo e sudato;
- tra l’uscita dal ristorante ed il momento in cui
si accorsero dello stato del capitano passò circa mezz’ora;
- appena notarono lo stato del capitano,
accostarono l’auto sul ciglio della strada;
- il maresciallo Moschitta chiamò i soccorsi, che
arrivarono in circa 10 minuti, (sia ambulanza che auto dei carabinieri);
- il personale dell’ambulanza che visitò il
capitano fece un cenno, come a dire che non c’era più niente da fare;
- giunti in ospedale, dopo che il medico comunicò
il decesso del capitano, il maresciallo Moschitta insistette affinché venisse
eseguito l’esame autoptico;
- venne chiamato al telefono anche il magistrato
di turno, che parlò con il medico e convenne con questo che non era necessario
eseguire alcuna autopsia.
2.4 – Le dichiarazioni dei carabinieri intervenuti
sul posto, Angelantonio Caiazza e Sandro Totaro. Al fine di acquisire ogni
notizia di specifica relativa a quanto accadde la notte in cui il capitano De
Grazia perse la vita, la Commissione ha audito i componenti dell’equipaggio
dell’aliquota radiomobile dei CC della stazione di Nocera Inferiore intervenuti
sul posto, peraltro mai ascoltati dai magistrati che indagarono sui fatti.
Entrambi sono stati auditi nel luglio 2012. Per primo è stato audito il
carabiniere Caiazza, il quale ha dichiarato: “Quella notte avevamo appena
intrapreso il servizio di un turno 00.00-06.00, un turno notturno, e fummo
informati dalla centrale operativa che sull’autostrada, a bordo di
un’autovettura – una Tipo o una Punto – una persona era stata colta da malore.
Ci recammo sul posto unitamente a un’unità sanitaria e trovammo una persona
riversa supina tra lo sportello posteriore dell’auto e l’asfalto. Intervennero i
sanitari, mentre noi provvedemmo a identificare gli altri militari presenti, che
gli praticarono un massaggio cardiaco e lo portarono in ospedale, dove ci
consegnarono una borsa contenente gli effetti del povero De Grazia, che fu
identificato pure da noi. (…) Abbiamo ritirato anche un borsone contenente una
valigia ventiquattrore, che fu consegnata al maresciallo Moschitta su sua
richiesta (….) L’unità sanitaria intervenne mentre noi provvedemmo a
identificare gli altri due militari. In ogni caso, credo fosse ancora vivo
perché gli stavano praticando un messaggio cardiaco. (…) Lì (in ospedale)
abbiamo ritirato il referto stilato dal medico. Sembra che fosse morto per
arresto cardiaco. Poi abbiamo ritirato gli effetti personali.(….) Il borsone ci
è stato consegnato dai colleghi del nucleo operativo. Della destinazione
sapevamo solo che stavano transitando sulla A30, direzione nord, la
Caserta-Roma. (…) Una volta ritirato il referto, siamo tornati in caserma e
abbiamo stilato gli atti”. Il Carabiniere Caiazza ha poi specificato di non
essere stato mai sentito da alcun magistrato in merito ai fatti. Le
dichiarazioni dell’appuntato scelto Sergio Totaro combaciano sostanzialmente con
quelle del suo collega. Si riportano i passaggi più significativi: “ La vettura
in questione l’abbiamo trovata all’uscita della prima galleria dell’autostrada
A30, barriera Salerno-Mercato San Severino, direzione nord. (…) C’erano una
persona supina sull’asfalto e due persone in abiti civili accanto, che poi
abbiamo identificato come un maresciallo e un appuntato dell’Arma. (…) È stata
chiamata, contestualmente, anche l’ambulanza. Dal momento che il comando dei
carabinieri si trova 100 metri prima dell’ospedale siamo intervenuti
contemporaneamente. (…) C’era una persona supina, sdraiata sull’asfalto, e due
persone in abiti civili accanto, che si sono poi presentati per un maresciallo e
un collega dell’Arma. Mentre li stavamo identificando i signori dell’ambulanza
prestavano soccorso alla persona in terra. (…) Penso che abbiano tentato i primi
interventi per rianimarlo. Quella in cui siamo arrivati era una fase un po’
concitata, tanto è vero che subito dopo l’hanno messo in ambulanza e siamo
andati direttamente all’ospedale Umberto I, loro davanti e noi dietro, che era a
circa due chilometri di distanza. (…). Con riferimento alla valigetta “24 ore”
che il capitano De Grazia portava con sé, il carabiniere Totaro ha riferito che:
“Gli effetti personali del capitano De Grazia furono consegnati al militare di
servizio alla caserma in quanto andavano consegnati ai parenti. Inoltre, c’era
la classica busta di colore nero in cui l’ospedale mette gli ambiti che la
persona indossa al momento. C’era anche un borsone di colore blu del capitano De
Grazia che mi pare contenesse una valigetta e una macchina fotografica. Mi pare
che il tutto fu consegnato, su sua richiesta, al maresciallo Moschitta con
ricevuta”. Il carabiniere ha specificato di non avere controllato il contenuto
della valigetta e che la stessa fu restituita, senza essere stata aperta, al
maresciallo Moschitta, il quale la richiese espressamente: “No, ci fu chiesta.
Ci dissero che conteneva materiale che dovevano portare via, con cui dovevano
continuare. Ci fu chiesta proprio, se non erro, dal maresciallo Moschitta. Ci
disse cortesemente che c’erano dei fascicoli. Abbiamo menzionato di proposito
nell’annotazione «che veniva consegnata, previa richiesta, a Tizio e Caio per il
prosieguo dell’operazione». Il carabiniere ha poi specificato la tempistica
della restituzione degli effetti personali e della valigetta: dopo essere stati
in ospedale, i militari andarono in caserma per formalizzare gli atti,
unitamente al maresciallo Moschitta e al carabiniere Francaviglia, “ il
maresciallo disse che a loro occorreva la valigetta con gli atti perché dovevano
proseguire per il loro viaggio. A quel punto consegnammo a lui quel materiale
(…) Presumo che il tutto sia avvenuto in ufficio davanti a noi o che il
maresciallo abbia detto che conteneva fascicoli processuali. Se l’abbiamo
scritto, qualcuno ce lo avrà detto o l’ha aperta davanti a noi. Si tratta di
tanti anni fa, ricordo la sera, ma non tutti i dettagli. Fu una fase concitata,
in mezz’ora una semplice richiesta d’aiuto diventò una morte. Il nostro
intervento è terminato proprio in ospedale”. La Commissione ha formulato
numerose domande volte a comprendere quale fosse il contenuto della valigetta e
se questo fosse stato in qualche modo verificato, anche per capire le ragioni
della restituzione della valigetta al maresciallo Moschitta. In particolare,
alla domanda della Commissione sul motivo per il quale, nonostante la valigetta
non fosse stata aperta, fosse stato redatto un verbale nel quale si dava conto
del numero di procedimento penale cui si riferivano gli atti contenuti nella
valigetta stessa, il Carabiniere ha risposto:
“Personalmente, non ricordo. Eravamo in due e
forse l’avrà letto il brigadiere, poi abbiamo firmato in due. Materialmente,
però, non ho visto il fascicolo. In genere, uno di noi scrive e alla fine
sottoscriviamo, ma io non ho visto quel fascicolo e, se l’avessi visto, non lo
ricordo”. Sul punto è stato interpellato anche il carabiniere Caiazza, il quale
ha riferito, che se era stato riportata a verbale che nella valigetta era
contenuto un fascicolo riferito al procedimento penale n. 2114/94 RGNR,
evidentemente doveva aver visionato il fascicolo stesso, pur non potendo
confermare la circostanza non ricordando più tale particolare.
2.5 – Le dichiarazioni di Francesco Fonti in
merito alla morte del capitano De Grazia. Per completezza di trattazione si
ritiene di dover dare conto anche delle informazioni acquisite nel corso
dell’inchiesta dall’ex collaboratore di giustizia Francesco Fonti, già
appartenente alla ‘ndrangheta calabrese, audito dalla Commissione in data 5
novembre 2009 nel corso della missione effettuata a Bologna. Deve essere subito
chiarito che la Commissione non ha trovato riscontri obiettivi alla quasi
totalità delle dichiarazioni che Francesco Fonti ha reso nella varie sedi sul
tema del traffico di rifiuti radioattivi o comunque tossici da parte della
‘ndrangeta calabrese. Si tratta di un’inattendibilità intrinseca in quanto più
volte Fonti si è contradetto e ha fornito versioni diverse rispetto ad elementi
essenziali della narrazione nonché di un’inattendibilità estrinseca in quanto
non sono stati fornite indicazioni adeguate per riscontrare le dichiarazioni da
lui rese. Fonti è stato interpellato anche con riferimento al decesso del
capitano De Grazia. Sul punto, ha dichiarato di avere sentito dire, all’interno
dell’organizzazione criminale cui era legato, che il capitano Natale De Grazia
era stato ucciso.
Ha aggiunto, poi, che i servizi segreti facevano
sparire sia i rifiuti sia le persone che potevano rappresentare un concreto
ostacolo alla prosecuzione dei traffici illeciti: l’ipotesi era, quindi, quella
che il capitano fosse stato eliminato perché stava scoprendo cose che avrebbero
dovuto restare segrete. In realtà, Fonti ha precisato che si trattava di notizie
non certe ed acquisite da altre persone. La Commissione ha chiesto al Fonti
chiarimenti in merito alle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso di una
trasmissione radiofonica sull’emittente “Radio anch’io”, andata in onda nella
seconda metà del 2009. In tale trasmissione il Fonti aveva dichiarato che il
comandante De Grazia sarebbe stato ucciso dai Servizi.
Alla domanda se tale affermazione fosse supportata
da elementi di riscontro o meno il Fonti ha risposto: “Sono chiacchiere, cose
che ho sentito dire. Sicuramente sono considerazioni svolte da altre persone
come me. (…) Le chiacchiere si facevano anche fra di noi. Quando ci si trovava
per riunioni ufficiali, concordate, oppure anche per caso, fra le famiglie c’era
sempre un certo antagonismo: io so di più, faccio di più, ho fatto questo
traffico, tu non l’hai fatto, io ho preso questi miliardi, tu li hai presi. Vi
era la megalomania di poter fare di più di un’altra famiglia”. Il Fonti ha poi
specificato di aver sentito tali chiacchiere all’interno della sua
organizzazione. Data la delicatezza delle affermazioni effettuate, si ritiene di
riportare il passaggio dell’audizione sul punto:
“PRESIDENTE. Sulla base di che cosa davano queste
notizie?
FRANCESCO FONTI. Con i rifiuti si trattava con i
servizi segreti, e, se qualcosa non va, questi decidevano di far sparire anche
le persone. L’ipotesi era quella che anche il capitano fosse stato eliminato,
perché stava andando a scoprire qualcosa che non doveva emergere.
PRESIDENTE. Lei non parlò mai con Pino (soggetto
non meglio identificato, già indicato da Fonti come appartenente ai servizi
segreti ed elemento di collegamento con il Fonti e con la ‘ndrangheta) di questa
vicenda?
FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Poiché nella trasmissione, che anch’io
ho sentito, lei dava come una notizia importante, quasi certa, il fatto che
fosse stato ucciso.
FRANCESCO FONTI. Non penso, non era questa la mia
intenzione, anche perché è una vicenda che non ho vissuto”.
Con riferimento alle dichiarazioni di Fonti,
indipendentemente dall’attendibilità di base o meno del personaggio, è evidente
che, in questo caso, la loro assoluta genericità unita al fatto di essere
dichiarazioni cosiddette “de relato”, apprese direttamente, ma riferite da altre
persone, tra l’altro mai indicate nominativamente, impedisce di prenderle
seriamente in considerazione. Tanto più che lo stesso Fonti, richiesto sul
punto, le ha definite “chiacchiere”.
2.6 Le dichiarazioni fornite dal magistrato
dottor Francesco Neri. In data 23 settembre 2009 la Commissione ha audito il
dottor Francesco Neri, il quale ha reso corpose e importanti dichiarazioni in
merito a tutte le fasi dell’indagine nonché in merito anche alle fasi successive
alla trasmissione del fascicolo alla procura presso il tribunale di Reggio
Calabria. Su sua espressa richiesta le dichiarazioni sono state segretate. La
Commissione ha tuttavia ritenuto di disporre la desegretazione almeno con
riferimento alle parti delle audizioni concernenti i riferimenti al capitano di
fregata Natale De Grazia. In particolare, significative ai fini della presente
inchiesta sono le dichiarazioni che il magistrato ha reso con riferimento a
talune attività svolte dal capitano De Grazia e alla documentazione dallo stesso
raccolta ed esaminata.
Si riportano testualmente i passaggi
dell’audizione: «A questo (Rigel, Jolly Rosso, tutte collegate a Comerio)
aggiungiamo le dichiarazioni e i documenti che accertammo sulla Somalia, che vi
ho portato, i fax di Ali Mahdi che autorizzava il Comerio ad affondare in
Somalia i suoi penetratori, il certificato di morte che il comandante Di Grazia
trovò tre, quattro giorni prima di partire e mi disse nella mia stanza che aveva
bisogno del tempo per verificarne la provenienza, in quanto si trattava di una
fotocopia sulla quale era trascritto un numero di fax. Egli voleva accertare i
collegamenti con Comerio. Poi, come ben sapete, il capitano De Grazia morì.
Rimangono tuttora in me sospetti sulla sua morte, ma non ho prove certe perché
vi ho portato tutte le minacce che subivamo, tutte le relazioni di servizio.
Eravamo pedinati, minacciati spiati, vi erano microspie anche da Porcelli, il
procuratore di Catanzaro. Chiedo che il procuratore Pace venga sentito perché è
importante. Addirittura si presentò un agente del Mossad. Intorno a questa
indagine c’erano molta attenzione e molta pressione, io ero un procuratore
circondariale, non ero la DDA». «(…) Intorno all’indagine si era creata una
pressione non indifferente che credo abbia comportato anche la morte di De
Grazia per cause naturali o – come ho scritto in una relazione mandata al
Presidente della Repubblica che vi consegno – nell’ipotesi più funesta, ucciso.
In questo caso si tratterebbe di un’operazione chirurgica perché De Grazia era
veramente il motore dell’indagine, colui che era riuscito a trovare gli elementi
investigativi che collegavano le navi agli affondamenti delle carrette,
soprattutto la Rigel e la Jolly Rosso, a Comerio».
«(…) PAOLO RUSSO. Vorrei partire proprio dal 1996
e capire meglio come lei “passa la mano”: sulla base di quale sollecitazione
inevasa o di quale richiesta diretta alla quale vi è una risposta non funzionale
al suo obiettivo. Probabilmente vi è anche una mia scarsa conoscenza delle
procedure. Insomma, per quale motivo lei, nel giugno del 1996, “passa la mano”?
FRANCESCO NERI, Sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. Il 27 giugno. Vi
è una mia nota di trasmissione che spiega tutto. A prescindere da questo, il
primo motivo è stato la morte di De Grazia, che aveva depotenziato il mio pool
investigativo. Investigavo con il comandante De Grazia, con un maresciallo e un
brigadiere dei carabinieri, e con un carabiniere: questo era il mio pool
investigativo. In procura ci sono 47 scatoloni sigillati di documenti derivati
dai sequestri e dalle perquisizioni compiute nei confronti dei vari indagati,
che mi pare siano stati esaminati e studiati per il 30 per cento. Il resto è
rimasto ancora inevaso, non studiato: l’indagine è troppo vasta. Il secondo
motivo riguardava la competenza. Potevamo continuare a cercare i siti dove erano
stati affondati rifiuti, perché la discarica abusiva in mare poteva essere di
nostra competenza; però se ormai eravamo dell’idea che il sistema di smaltimento
non consistesse nel prendere dei fusti e gettarli in mare, bensì nell’affondare
navi, allora vi era anche il reato di affondamento doloso, che non è di
competenza pretorile, bensì della procura della Repubblica. Quindi, dovevamo per
forza spogliarci del processo». «(…)Per quanto mi riguarda, tuttavia, molto
dipese dalla morte di De Grazia, e anche da una certa resistenza istituzionale a
volerci dare credito. Capisco che potevo non essere creduto, poiché quello che
accertavamo superava l’immaginario collettivo. Abbiamo trovato filmati sulle
prove in mare dell’affondamento dei penetratori (o siluri, o canister), che
sembravano film di fantascienza. Basta connettersi al sito de L’Espresso, nella
sezione di Riccardo Bocca, e si può vedere l’intero filmato.
ALESSANDRO BRATTI. Sulla morte di De Grazia sono
state aperte indagini e sono stati svolti approfondimenti?
FRANCESCO NERI, Sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. Sì, io e il
procuratore Scuderi chiedemmo immediatamente l’autopsia. Eravamo minacciati –
ora lascerò anche tutte le denunce che abbiamo fatto – e c’era un clima di
tensione intorno a noi, quindi la morte ci sembrò improvvisa e sospetta.
Chiedemmo l’autopsia anche perché la famiglia non si rassegnava a questa morte
di un ufficiale di 38 anni. E’ morto il13 dicembre 1995. Non ci spiegavamo la
sua morte e abbiamo pensato di chiedere l’autopsia, che fu disposta a Reggio
Calabria a distanza di 12-13 giorni. Il cuore era intatto, nessun infarto. Non è
vero che ebbe un infarto. Non risultò alcuna traccia tossicologica, alcun
elemento patologico che potesse spiegare la morte; infatti il perito
necroscopico ha dichiarato che si era trattato di morte improvvisa. Tuttavia,
morte improvvisa significa tutto e niente. So che la famiglia ha chiesto una
nuova autopsia, che è stata fatta dallo stesso medico che aveva eseguito la
prima. La famiglia nutre dubbi sul risultato della prima autopsia e la nuova
autopsia viene affidata allo stesso medico che ha fatto la prima… La famiglia
non si è mai rassegnata (e neanche io) ad una morte di cui ancora si sa molto
poco».
« (…) FRANCESCO NERI, Sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. Da
quello che so, partirono la sera – c’era brutto tempo – per La Spezia, perché
avevo dato una delega. Bisognava acquisire i piani di carico di 180 navi che
erano partite da La Spezia, da Marina di Massa e da Livorno, ufficialmente con
carichi di sostanze radioattive, ma sulle quali non avevamo alcun dato riguardo
ai porti di arrivo. Partivano navi cariche di torio, di uranio, di plutonio;
russi, tedeschi, francesi, però non si sapeva il porto di arrivo. De Grazia
perciò volle verificare dove andavano a finire queste navi e aveva questo
importante compito. Inoltre, doveva sentire alcuni marinai della Rigel che era
riuscito a rintracciare. Queste, almeno, erano le ultime attività che doveva
compiere. Attività delicate, indubbiamente; soprattutto i piani di carico delle
navi erano molto importanti ai fini delle nostre indagini. Dopo la sua morte,
rimandai gli ufficiali a prendere quelle carte, ma la capitaneria di porto di
Massa Carrara si allagò e tutti i documenti andarono distrutti.
PRESIDENTE. In che anno questo?
FRANCESCO NERI, Sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. Nel 1996 o a
fine 1995, l’alluvione; comunque dopo il 13 dicembre 1995.
GERARDO D’AMBROSIO. Il presidente aveva fatto una
domanda precisa: non solo quando morì, ma come, in che luogo, in che contesto (a
casa sua, in viaggio)?
FRANCESCO NERI, Sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. Erano in viaggio
e si fermarono per mangiare; De Grazia fu l’unico a mangiare il dolce, secondo
quanto mi disse la moglie (e questo risulta). Successivamente risalirono in
automobile e ad un casello autostradale i due carabinieri che erano con lui si
accorsero che rantolava e non respirava più. Quindi morì. Questo è quello che
so. Non c’ero.
GERARDO D’AMBROSIO. Si sa dove si erano fermati a
mangiare?
FRANCESCO NERI, Sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. Sì, ora non
ricordo esattamente, in un ristorante a Campagna. Ma non voglio dire cose di cui
non sono certo, perché non ho svolto io le indagini sulla morte di De Grazia.
RESIDENTE. Restando ancora su questo argomento: De
Grazia ha trovato – perché lei l’ha visto -il certificato di morte che si
trovava nel fascicolo di Comerio.
FRANCESCO NERI, Sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte dì Appello di Reggio Calabria. Mi disse: “Ho
trovato questo tra le carte di Comerio”.
PRESIDENTE. Lei lo ha visto?
FRANCESCO NERI, Sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. Sì, l’ho visto.
PRESIDENTE. Che fine ha fatto?
FRANCESCO NERI, Sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. De Grazia partì
e mi disse: “Lo tengo io”. Il certificato era in fotocopia e conteneva un numero
di fax di partenza; per lui era importante, dal punto di vista investigativo,
accertare a chi appartenesse. II certificato poi non lo vidi più. Quando andai
alla Commissione Alpi mi ricordai del certificato e dissi al presidente:
“Sicuramente è agli atti; io non ho fatto in tempo a guardare perché occorrono
decine di giorni per esaminare tutta la documentazione contenuta in 47 scatoloni
sigillati”. Mi chiesero: “Ma allora questo documento lo troviamo?”. Risposi:
“Presidente, per me esiste, lo aveva De Grazia”. Mandò i suoi esperti, che nel
fascicolo non trovarono il certificato. Però la procura della Repubblica, che
fece ricerche dirette cercando il certificato, aprì tutti gli scatoloni
sigillati dell’indagine e accertò che il plico di De Grazia, che conteneva la
documentazione investigativa sulla quale egli lavorava, era stato danneggiato da
un lato. Fu il pubblico ministero dottoressa Cama, vi è un verbale».
« (…)PRESIDENTE. Di quale procura?
FRANCESCO NERI, Sostituto procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. La procura di
Reggio Calabria. Se volete poi posso inviarlo, a corredo della documentazione.
Questo plico era stato violato, danneggiato da un lato, e delle 21 carpette
numerate rinvenute, 11 erano prive di documenti. De Grazia prendeva un elemento
investigativo, faceva una carpetta, sviluppava le indagini e poi mi trasmetteva
l’informativa; questo era il suo metodo. Queste ricerche avvennero nel 2005,
dopo che il processo era stato archiviato. L’archiviazione del processo era
avvenuta nel 2000».
3 – GLI APPROFONDIMENTI SVOLTI DALLA COMMISSIONE
IN ORDINE ALLE CONSULENZE MEDICO LEGALI. Un capitolo a parte la Commissione ha
inteso dedicarlo agli approfondimenti medico legali svolti nel procedimento
aperto presso la procura di Nocera Inferiore e, quindi, in merito agli esami
autoptici effettuati sulla salma del capitano De Grazia. Si tratta di uno snodo
centrale della vicenda e delle indagini, in quanto di fatto le consulenze
tecniche espletate hanno individuato quale causa del decesso un fenomeno
definito nella letteratura scientifica come “morte improvvisa dell’adulto” che,
secondo quanto precisato dal consulente della Commissione, professor Arcudi, può
essere individuato solo allorquando siano state escluse tutte le possibili
ipotesi alternative. Le consulenze hanno costituito poi l’elemento fondante sia
delle richieste di archiviazione sia dei relativi conformi provvedimenti del
Gip.
3.1 – Le conclusioni dei consulenti medico legali
nominati nell’ambito del procedimento avviato dalla procura di Nocera Inferiore.
Le prime consulenze. Come già evidenziato, la dottoressa Del Vecchio, consulente
del pubblico ministero, effettuò due consulenze tecniche, la seconda delle quali
finalizzata ad accertare mediante esame istologico e chimico-tossicologico
l’eventuale presenza di sostanze tossiche o con analoghe caratteristiche, che
avessero cagionato il decesso. Si riportano, di seguito, le conclusioni della
dottoressa Del Vecchio, di cui alla prima relazione di consulenza, depositata
il12 marzo 1996: “La morte di Natale De Grazia, constatata l’assenza di lesività
traumatica con caratteristiche di vitalità e accertata la negatività degli esami
chimico-tossicologici, considerati i dati macroscopici rilevati all’esame
autoptico (cuore di volume diminuito, si acquatta sul tavolo anatomico; il
tessuto adiposo sottoepicardico è molto rappresentato e mostra colorito
grigiastro e aspetto translucido; miocardio torbido, grigiastro, assottigliato,
diminuito di consistenza; coronarie serpiginose, specillagli, con intima
interessata da diffuse deposizioni ateromasiche intimali) e quelli microscopici
forniti dall’esame istologico (è presente miocitolisi coagulativa, ma i
preparati sono abbastanza ben conservati. In alcuni campi si osserva aumento del
grasso subepicardico; il tessuto adiposo si approfonda, a tratti, financo nei
piani muscolari. E’ presente notevolissima frammentazione terminale delle
miocellule che risultano rigonfie, torbide, con nuclei ipocromici ed acromici.
Evidente sofferenza delle arterie di piccolo e medio calibro, che presentano
ispessimento sia avventiziale che intimale, con lumi ristretti. Si nota,
inoltre, incremento degli spazi fra le fibre muscolari, dove la quota
connettivale presenta caratteri di fibrosi interstiziale che in qualche campo
sostituisce la struttura -miocardioangiosclerosi-), può ricondursi per sua
natura ad una morte di tipo naturale, conseguente ad una insufficienza cardiaca
acuta, inquadrabile più specificatamente nella fattispecie della morte
improvvisa. La morte improvvisa è un evento repentino ed inatteso caratterizzato
dal fatto che il soggetto passa da una condizione di completo benessere o almeno
di assenza di sintomi alla morte in un arco di tempo inferiore alle 24 ore. La
definizione di morte improvvisa secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è
la seguente: “morte naturale avvenuta in presenza o in assenza di testimoni e
dovuta ad arresto cardiaco improvviso, verificatosi inaspettatamente in un
soggetto che fino a sei ore prima godeva di buona salute”. La classica
impostazione medico legale del Borri prevede ai fini della classificazione di un
evento letale come morte improvvisa, che questo soddisfi i seguenti requisiti:
assenza di una eventuale azione violenta esteriore; rapidità del decesso;
esistenza di uno stato di buona salute o di apparente buona salute, o comunque
di una malattia che non minacci un’evoluzione letale. Molte sono le cause di
questo tipo di decesso, ma tra quelle cardiache un posto preminente è occupato
dalla patologia cardiaca (coronarica e miocardica) che costituisce la causa di
gran lunga più frequente di questo genere di morti (Puccini C.. Istituzioni di
medicina legale: Ambrosiana, Milano, 1995).L’exitus è provocato, solitamente, da
gravi turbe del ritmo culminanti in fibrillazione ventricolare. L’evento
scatenante è di natura ischemica ma solo in meno della metà dei casi si
riscontra una trombosi coronarica occlusiva o ad esempio un infarto recente,
perché negli altri casi le alterazioni elettriche sono precipitate da altre
cause ischemiche. Il meccanismo di molte morti improvvise cardiache è costituito
da uno stato di instabilità elettrica da ipossia cronica, cosicché un aumento
delle richieste metaboliche del cuore, in conseguenza di uno sforzo fisico
ovvero di un’intensa emozione, ma anche una condizione di permanente tensione
emotiva e di allarme conseguente all’espletamento di attività professionali
particolarmente impegnative, delicate e rischiose, fonte di enormi
responsabilità, (come nel nostro caso) può determinare uno stato di stress
continuo che alla fine precipita la situazione cardiaca. La fibrosi miocardica
(presenta nel nostro caso), inoltre, determina un rischio aggiuntivo di
interruzione della continuità del sistema di conduzione, che può determinare
vari gradi di blocco o di difetto di propagazione del’impulso contrattile,
rendendo il cuore più sensibile all’ischemia ed all’arresto (Umani Ronchi G.,
Botino G., Grande A., Mannelli E.: Patologia Forense. Giuffrè, Milano, 1995).
Inoltre, come dalle risultanze dell’esame istologico da noi eseguito,
l’infiltrazione di tessuto adiposo che dalla consueta sede subepicardica si
insinua in profondità fino ad interessare la parete miocardica, dissociando i
fasci muscolari, è tipica anche della cosidetta displasia aritmogena, condizione
caratterizzata da aritmie e spesso da morte improvvisa. Pertanto, la morte del
capitano Di Grazia, sembra possa riconoscere una dinamica di tipo naturale e più
precisamente della cosidetta “morte improvvisa dell’adulto”, che trova origine
per lo più in una ischemia del miocardio con successive gravi turbe del ritmo
cardiaco, che si manifestano anche in assenza di segni premonitori e che, dal
punto di vista anatomopatologico, addirittura nella metà dei casi circa, sono
caratterizzati dall’assenza di segni specifici, non solo macroscopici, ma anche
microscopici e ultramicroscopici”.
Parzialmente diverse, nella parte descrittiva
degli organi e dei tessuti, appaiono le conclusioni del dottor Asmundo nella
relazione depositata otto mesi dopo quella del consulente del PM. Il dottor
Asmundo, pur riconoscendo la natura cardiaca della morte improvvisa del De
Grazia, la riconduce a “accidente cardiaco improvviso per insufficienza
miocardica acuta da miocitolisi coagulativa da superlavoro in soggetto affetto,
appunto, da cardiomiopatia (dilatativa) da catecolamine”: A seguito della
richiesta di riapertura indagini, vennero risentiti i due consulenti, del
pubblico ministero e di parte. Entrambi convennero sulla possibilità di
effettuare ulteriori accertamenti, in particolare per verificare la presenza di
veleni. La dottoressa Del Vecchio chiarì al pubblico ministero Russo che gli
accertamenti tossicologici già effettuati avevano escluso la presenza di
sostanze tossiche e stupefacenti, in particolare l’alcool, gli oppiacei, la
cocaina, i barbiturici, le benzodiazepine, le anfetamine, i cannabinoidi e tutte
le altre T.L.C, evidenziando che il materiale prelevato per tali accertamenti
(bile e sangue) non era in quantitativo tale da rendere possibile una
ripetizione di queste analisi, mentre avrebbero potuto essere effettuate analisi
tossicologiche più mirate mediante prelievo di capelli, ossa, quote parte di
organi di accumulo “per verificare fino in fondo per quanto possibile
l’esistenza di eventuali sostanza tossiche e velenose diverse, in particolare la
ricerca potrebbe riguardare i veleni metallici”.
Si riportano, di seguito, i verbali delle
dichiarazioni rese dai due consulenti.
3.2 – La seconda consulenza tecnica espletata su
incarico del pubblico ministero. In data 18 giugno 1997, il pubblico ministero
Giancarlo Russo affidò, quindi, un secondo incarico alla dottoressa del Vecchio
sottoponendole ulteriori quesiti: “ad integrazione ed approfondimento della
consulenza medico-legale già espletata con riferimento al decesso del cap. De
Grazia Natale, esegua il CT ulteriori accertamenti chimico-tossicologici per la
ricerca di sostanze tossiche e velenose, nonché approfondisca, con
l’allestimento di ulteriori preparati, l’aspetto istologico. Accerti ed
approfondisca altresì quant’altro utile ai fini delle indagini volte a
verificare la causa del decesso, anche tenendo conto di quanto emerge dagli atti
e dalla consulenza di parte depositata”. Venne dunque effettuato un secondo
accertamento sul cadavere del capitano De Grazia, in esito al quale vennero
rassegnate dalla dott.ssa De Vecchio le seguenti conclusioni :
“La riesumazione del cadavere del capitano Natale
De Grazia, ci ha permesso di eseguire ulteriori prelievi da utilizzare per gli
accertamenti chimico-tossicologici e per l’approfondimento delle indagini di
consulenza tecnica. A tal fine gli ulteriori esami chimici eseguiti hanno
escluso la presenza di sostanze. tossiche di natura esogena nei campioni
esaminati. La ricerca è stata compiuta con particolare riferimento alle sostanze
che possono portare a morte in tempi brevi, con sintomatologie quali quelle
descritte (ipnotici, farmaci cardiaci, depressori del sistema nervoso centrale,
cianuri). Per completezza è stata effettuata anche la ricerca dell’arsenico nei
capelli (perla verifica di un’eventuale intossicazione cronica) e nel fegato
(perla verifica di eventuale intossicazione acuta). La ricerca è risultata
negativa. La negatività per la presenza di alcool etilico nel sangue ottenuta
con il prelievo del medesimo eseguito in sede di autopsia (19 dicembre 1995)
anche se sembra contrastare con le notizie di specifica (vien riferito nella
relazione di servizio redatta da Moschitta Nicolo e carabiniere Francaviglia
Rosario che il De Grazia si fermava durante il viaggio per la cena alle ore
22.30, consumava abbondanti quantitativi di carboidrati e proteine assumendo
contemporaneamente quantitativi non riportati di vino e un bicchierino di
liquore denominato limoncello), non desta perplessità, in quanto è noto che la
curva di assorbimento dell’alcool etilico a stomaco pieno (soprattutto quando
sono j stati assunti abbondanti quantitativi di carboidrati), si appiattisce
determinando valori di alcoolemia non rilevabili nel tempo immediatamente
successivo all’assunzione. Poiché il decesso si è verificato poco più di un’ora
dall’ingestione dei cibi e delle bevande l’alcool presente nello stomaco non
aveva avuto il tempo sufficiente per entrare in circolo. Era presente, infatti,
in quantità non dosabile. Inoltre viene riferito sempre nella relazione di
servizio che durante le manovre rianimatorie il De Grazia rigurgitava parte di
quanto introdotto nello stomaco durante la cena. All’esame autoptico il
materiale alimentare fu rinvenuto in quantità tale da sembrare in contrasto con
l’abbondante pasto riferito, ma ciò è invece facilmente spiegabile se
confrontato con le testimonianze acquisite agli atti. Per quanto attiene
all’esame istologico, invece, la visione preliminare di organi già esaminati,
conferma i reperti impressi, in particolare riguardo per l’aumento, in alcuni
campi, del grasso subepicardico. Per le ulteriori colorazioni tricromiche
allestite sul cuore, quella di Gomori da conferma della presenza di microaree di
sostituzione connettivale non recenti, mentre il PTH, nei limiti di lettura a
causa della cattiva conservazione dell’organo, non sembra mettere in evidenza
alterazioni cromatiche riferibili a presenza di fibrina recentemente
neoformatasi, nell’insieme, il diagnostico sembra dunque essere quello di una
miocardioangiosclerosi diffusa senza apprezzabili fenomeni-di necrosi
recentissima o recente di tipo focale anche se anche se l’ultima osservazione
(su quote parte di cuore riesumato) deve prudenzialmente tenere conto dello
stato di conservazione dell’organo (ormai preda di avanzati fenomeni
putrefattivi). Pertanto si ritiene, anche alla luce delle ulteriori indagini di
laboratorio eseguite, che la causa della morte del capitano De Grazia Natale sia
da ricondurre ad un evento naturale tipo “morte improvvisa dell’adulto”, come
già ci esprimemmo in merito nella precedente relazione di consulenza tecnica
medico-legale affidataci”. La dottoressa Del Vecchio, allorquando depositò le
conclusioni della seconda consulenza tecnica espletata, venne risentita dal
pubblico ministero Russo a chiarimenti. In tale occasione confermò in pieno i
risultati cui era pervenuta con la prima consulenza. Si riporta il verbale
all’epoca redatto.
3.3 – Le audizioni in Commissione dei consulenti
tecnici. La Commissione ha ritenuto di dover risentire entrambi i consulenti
medico legali al fine di chiarire alcuni aspetti legati soprattutto al fatto che
nel corso della prima autopsia non furono eseguiti tutti gli accertamenti
possibili per la ricerca di sostanze tossiche o assimilate, tanto che fu
disposta un’integrazione degli accertamenti stessi, limitata peraltro a quelli
ancora possibili nonostante il tempo trascorso.
Il 12 gennaio 2011 sono stati, pertanto, auditi
sia la dottoressa Del Vecchio che il dottor Asmundo. La dottoressa ha affermato
che:
- non aveva esaminato le precedenti risultanze e
cartelle cliniche del capitano De Grazia per verificare se vi fossero tracce di
patologie pregresse, precisando che all’epoca si facevano comunque esami che non
potevano essere rivelatori di uno stato così fine di patologia che invece adesso
viene valutato, come è obbligo dal 31 dicembre scorso;
- in occasione della prima autopsia le analisi
tossicologiche furono limitate alla ricerca di sostanze stupefacenti, alcooliche
e psicotrope, mentre la ricerca non fu estesa ai veleni, per i quali
generalmente vi è una richiesta specifica da parte del magistrato;
- il quesito riguardante la ricerca di sostanze
tossicologiche o simili non comprende generalmente anche la ricerca dei veleni.
Questo perché per i veleni, data anche la quantità e varietà delle sostanze
velenose, occorrono indagini diverse e più ampie e, dunque, quesiti più
specifici;
- la maggior parte delle sostanze velenose non è
rilevabile a distanza di tempo, salvo alcune sostanze, come l’arsenico.
Si riportano i passaggi più significativi
dell’audizione in parola: “L’autopsia è stata svolta in perfetta regola, come da
circolare Fani, per cui non solo ho svolto l’autopsia, ma ho anche prelevato
parte di tessuto e di organo e tutti i liquidi biologici che potevo prelevare,
quindi sangue e bile (non l’urina perché la vescica era vuota) e una quota di
visceri per fare l’esame chimico tossicologico (…) non ho dubbi e anzi forse
potrei fare un’aggiunta per sviare altri dubbi: come ho potuto vedere perché
avevamo colorato questi tessuti con colorazioni particolari che mettono in
risalto aree di cicatrizzazione in cui il normale tessuto cardiaco viene
sostituito quando ha degli insulti, purtroppo il cuore del capitano De Grazia
era soggetto a ipossia cronica (…) a mio parere – più forte oggi di ieri – è
morto per un arresto cardiocircolatorio o per insufficienza cardiaca acuta che è
la stessa identica cosa per uno stress miocardico, un insulto di ipossia
cronica. Lo si vedeva nel cuore, nei reni e addirittura in alcune aree del
cervello in cui c’erano le cellule del famoso neurone rosso, che sono un segno
di ipossia cronica. (…) Tutti noi possiamo andare incontro a questo e io stessa
ho una cardiopatia ipertensiva perché il problema è quello dell’impegno
lavorativo, che non fa dormire la notte e impone responsabilità, laddove quelle
del capitano erano certamente maggiori delle mie e forse anche delle vostre.
Per quanto riguarda invece i veleni, quando
facemmo la riesumazione l’unico veleno su cui potevamo indagare era l’arsenico
perché è l’unico che rimane, e questo si è rivelato negativo, perché in chimica
clinica abbiamo fatto lo spettrofotometro ad assorbimento atomico che ha dato
esito negativo. In assenza di lesività traumatica si pensa al veleno, ma
chiaramente tutti gli altri veleni come il cianuro, il bromuro, il potassio
danno sintomatologie particolari. La stricnina provoca contrazioni, il bromuro
provoca vomito, sintomatologie molto pesanti che non possono passare inosservate
né essere confuse con un malore. Si tratta di qualcosa di cui ci si accorge e
che qualcuno comunque deve somministrare. Non abbiamo trovato neppure l’anidride
arseniosa, che forse ha minore sintomatologie e si può mescolare nei cibi ed
essere ingerita senza essere percepita. Tutti gli esami per i derivati della
morfina e degli oppiacei non come sostanza stupefacente a sé stante, ma anche
per i derivati farmacologici della codeina, cocaina e così via, le
benzodiazepine sono stati effettuati in prima battuta, quando fu effettuata
l’autopsia, per cui posso affermare che purtroppo la morte del capitano De
Grazia è stato un evento naturale stress …”. Nel corso della medesima audizione
è intervenuto anche il dottor Asmundo il quale, richiesto di chiarire se vi
fossero elementi di dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunta la
dottoressa De Vecchio, ha dichiarato: “No, dissenso rispetto alla definizione
della causa di morte no, ma ci sono alcuni aspetti che riguardano comunque la
morte improvvisa da causa patologica naturale cardiaca che dal punto di vista
tecnico-scientifico mi sentirei di definire in altro modo. Non ho però dubbi che
si sia trattato di una morte improvvisa da causa patologica naturale cardiaca da
superlavoro rispetto alle analisi condotte, alle circostanze che ci furono
riferite e all’esclusione di altre cause che non sono emerse nel corso delle
indagini eseguite dalla dottoressa. (…) Elementi di dissenso soltanto dal punto
di vista tecnico-scientifico. Ho partecipato all’indagine autoptica e ho
esaminato i preparati istologici allestiti da frammenti di visceri di cadavere e
segnatamente del cuore.
Più che presentare una patologia di tipo
aterosclerotico, il cuore è danneggiato da un’iperincrezione catecolaminica cioè
degli ormoni dello stress, che hanno cronicamente intossicato la cellula
miocardica, producendo un quadro che non è del tutto sovrapponibile a quello da
causa ischemica e quindi ipossica, ma che deriva proprio dall’azione diretta di
questi ormoni sulla cellula cardiaca che la danneggia. Ci sono evidenti reperti,
focolai e aree anche abbastanza estese della cosiddetta «miocitolisi
coagulativa» nel 1995, che oggi definiamo «necrosi a bande di contrazione». È
quindi sostanzialmente condivisibile il terminale fisiopatologico, ma non
esattamente in senso eziologico, nel senso che le coronarie, che sono i vasi che
portano il sangue ossigenato al cuore per farlo ben lavorare, erano pressoché
integre e non presentavano i segni tipici del soggetto cardiopatico ischemico,
dell’infartuato, che presenta placche che ostruiscono la circolazione arteriosa
coronarica e quindi danneggiano le cellule miocardiche non essendo apportato
ossigeno. Qui il discorso è ben diverso e deriva proprio dall’iperincrezione
catecolaminica, che caratteristicamente produce questo danno della cellula
miocardica a focolai, che nel tempo possono arrivare a produrre una cardiopatia
dilatativa se non interviene una causa aritmogena, cioè se il disarrangiamento
dell’architettura del tessuto muscolare cardiaco non produce una
desincronizzazione dell’attività cardiaca stessa tanto in senso elettrico quanto
in senso meccanico, producendo quanto è accaduto al capitano De Grazia, cioè la
morte improvvisa probabilmente da causa elettrica su base miocitolitica
coagulativa (…) Le fibrocellule cardiache sono interconnesse tra loro e
subiscono effetti che derivano da un impulso sostanzialmente elettrico, che
deriva da una differenza di potenziale a livello della membrana cellulare per il
passaggio di ioni dall’interno all’esterno della cellula, che attivano un
meccanismo biochimico che fa contrarre la cellula. Se gruppi di cellule muoiono,
evidentemente le interconnessioni non funzionano più e quindi la continuità
dell’impulso elettrico non è garantita. Se i focolai sono multipli a livello del
tessuto miocardico come in questi soggetti soprattutto la parete ventricolare
sinistra, che è la parte più nobile del cuore, quella che pompa il sangue nella
circolazione sistemica, in quella cerebrale fondamentalmente, questo può
comportare in un altro momento, indipendentemente da una causa scatenante, una
desincronizzazione dell’attività elettrica e quindi meccanica di pompa del
cuore. Questo comporta un improvviso arresto cardiaco che può essere chiamato
sincope o arresto cardiaco elettrico, che può comportare una fibrillazione
ventricolare non conducente alla contrazione per il pompaggio del sangue e, in
definitiva, a uno stupore e quindi a uno stop dell’attività cardiaca, che
determina la morte improvvisa (…) Sono stati effettuati studi molto particolari
su soggetti per i quali è stato percepito il «clic» nel senso dell’accensione
del momento emozionale, sui quali si è dimostrato un rapporto sostanzialmente
diretto. Ci sono però soggetti che come il De Grazia muoiono nel sonno
probabilmente perché hanno anche una predisposizione – è difficile dirlo oggi –
su base genetica.
Negli ultimi 5-7 anni si è svolta una grande
ricerca sulla genetica dei recettori cioè di quelle zone della cellula cardiaca
che servono per l’attacco dell’adrenalina e della noradrenalina, gli ormoni
dello stress, per l’attivazione della cellula. Alcuni soggetti hanno questi
recettori alterati o comunque non perfetti e quindi in loro una situazione di
stress può comportare molto facilmente una desincronizzazione dell’attività e
quindi una morte elettrica”. La dottoressa Del Vecchio ha sottolineato, poi, che
in assenza di lesività esterna “(De Grazia non aveva segni traumatici da arma da
fuoco, armi bianche o colpi contusivi, non era politraumatizzato, non era caduto
da una finestra)” il medico legale indaga sulle cause della morte (semplice
ictus, attacco di cuore o qualsiasi altra cosa) cercando eventuali sostanze:
“In questo caso non avevamo neanche le urine, ma
abbiamo attentamente indagato nel sangue, nella bile, nei visceri, come sempre
facciamo per verificare se un soggetto abbia ingerito un farmaco, sia rimasto
vittima di un’allergia o – non è il caso del capitano – abbia fatto uso di
sostanze stupefacenti. Il caso dei veleni è più particolare, perché il pubblico
ministero, il giudice che assegna l’incarico dovrebbe quantomeno indirizzare il
perito verso una ricerca perché alla luce della gamma dei veleni possibili
un’indagine del genere può avere per lo Stato un costo incredibile. Io sarei
molto favorevole a effettuare un’indagine del genere su tutti i morti per morte
naturale“. La dottoressa Del Vecchio ha, quindi, ribadito le sue conclusioni,
dopo aver descritto gli effetti delle sostanze velenose: “Una delle sostanze con
cui le persone vengono anche curate e che si possono assumere anche a piccole
dosi fino a intossicazione è proprio l’arsenico, che infatti era negativo,
perché alle altre sostanze si diventa assuefatti. Con il potassio, che deve
essere iniettato, si muore immediatamente. (…) Con «immediatamente» s’intende
che non si riesce a rientrare in macchina. Altre sostanze come la stricnina
provocano convulsioni, particolari che qualcuno avrebbe dovuto riferire”. Allo
stesso modo il dottor Asmundo ha confermato il suo giudizio, affermando: “Il
reperto tossicologico non è mai lontano dal reperto anatomopatologico. Se
infatti una sostanza altera l’organismo in modo tale da ucciderlo, evidentemente
a livello polmonare, epatico e renale, organi deputati alla detossificazione
dell’organismo, si rileva un’alterazione. Noi non abbiamo un reperto
anatomopatologico che ci possa consentire tecnicamente di affermare una cosa
simile. A fronte di un reperto patologico cardiaco di una consistenza più che
discreta, l’orientamento nel senso dell’epicrisi non può che essere quello”.
Riguardo alla prima autopsia effettuata, la dottoressa ha chiarito di aver
eseguito alcuni esami tossicologici (“avevamo il sangue, i visceri, la bile, che
sono indagini istologiche di tessuti. Abbiamo utilizzato il metodo RYE, metodica
che si usa per analizzare questi reperti, abbiamo visto l’alcol (l’etanolo) che
era negativo, tutti i derivati della morfina e degli oppiacei, della cocaina,
codeina e quant’altro”), ma di non aver indagato sui veleni, affermando che
ciascun veleno richiede uno studio a parte, per cui l’indagine in tal senso
sarebbe stata eseguita se vi fosse stato il sospetto della presenza di un
veleno. Alle richieste di chiarimenti avanzate dei componenti della Commissione,
l’audita ha risposto, così come riportato nel resoconto stenografico:
“ALESSANDRO BRATTI. Si può escludere
categoricamente che non sia stato avvelenato o, dato che per tutta una serie di
motivi non si è ipotizzata la presenza di determinati veleni, si fa fatica ad
andarli a cercare? Questa è una domanda importante, perché si può escludere
totalmente qualsiasi tipo di veleno oppure ammettere questa eventualità.
SIMONA DEL VECCHIO. In base alla mia esperienza
ritengo che l’unico veleno che potesse uccidere una persona così giovane e sana
potesse essere appunto l’arsenico, che infatti dopo siamo andati a ricercare e
non c’era. È l’unico che si può cercare e trovare anche dopo tranquillamente
perché è l’unico che non senti: o viene iniettato, ma non c’erano segni di
agopuntura.
ALESSANDRO BRATTI. Avendo bevuto e mangiato magari
poteva anche sentire un sapore strano. Chiaramente, voi siete esperti e lo
sapete.
SIMONA DEL VECCHIO. Le assicuro che le quantità
dovrebbero essere minime, non in grado di far morire una persona.
PRESIDENTE. Per chiarire fino in fondo il nostro
problema, noi abbiamo una serie di indizi esterni quali il fatto che sia stato
completamente disfatto tutto il gruppo che stava svolgendo un’indagine
particolarmente importante sulla presenza di sostanze tossiche (noi abbiamo
anche accertato ulteriori elementi di particolare importanza di quello specifico
viaggio). Se quindi voi ci dite che al cento per cento era assolutamente
impossibile che nel momento in cui è morto ci fosse una causa o una concausa
diversa dal fatto che il cuore non ha più funzionato perché non sono arrivati
gli impulsi elettrici e ha avuto quello che comunemente si definisce un infarto,
interpretiamo quegli indizi in un senso. È invece diverso se ci dite che a voi
risulta questo, però ad esempio avete fatto un’indagine accuratissima sulla
presenza di una possibile puntura.
SIMONA DEL VECCHIO. Posso assicurare che quello lo
effettuo su tutti, anche su chi non fa il lavoro del capitano De Grazia, per cui
glielo assicuro personalmente anche se non c’è nella relazione. Il collega era
presente, abbiamo fatto le foto del corpo e addirittura, riscontrando
un’escoriazione sul lato sinistro, ho prelevato quel pezzetto di cute perché
preferivo analizzare anche questo tessuto. Non era nulla, perché evidentemente
hanno tentato di rianimarlo e si trattava dei segni della rianimazione.
ALESSANDRO BRATTI. Escludete comunque
l’avvelenamento per ingestione a meno che non sia quella sostanza.
SIMONA DEL VECCHIO. Sì, perché dovrebbe essere
troppa la sostanza somministrata a una persona per ottenere quell’effetto.
PRESIDENTE. Vorrei sapere se sia stato analizzato
il cibo che aveva ingerito, per sapere che tipo di cibo fosse e a che livello di
digestione fosse.
SIMONA DEL VECCHIO. No, perché il cibo era già a
uno stadio avanzato come l’alcol prima, perché non è morto subito: aveva già
cominciato la sua digestione, c’era del liquame.
ALESSANDRO BRATTI. Nonostante avesse già
cominciato la digestione, le tracce di alcol.
SIMONA DEL VECCHIO. Perché l’alcol si assorbe
prima, ecco perché si raccomanda di aspettare mezz’ora dopo mangiato per evitare
l’eventuale ritiro della patente, qualora si sia fermati. Il capitano non è
morto subito, per cui oltre il liquame non potevamo vedere più nulla. Occorrono
tre ore per svuotare uno stomaco.
PRESIDENTE. Quanto tempo occorre perché il cibo si
trasformi in liquame?
SIMONA DEL VECCHIO. Al massimo tre ore, ma anche
di meno: dipende da cosa e quanto abbiamo mangiato.
ALESSANDRO BRATTI. Uno shock anafilattico si
vedrebbe chiaramente dall’autopsia?
SIMONA DEL VECCHIO. Sì, come diceva il collega
prima il fegato e la milza, organi in cui passa tutto il circolo refluo,
avrebbero subìto effetti allucinanti. Tutti i veleni che provocano l’atrofia
giallo-acuta avrebbero dato quadri epatici disastrosi, mentre mi pare che il
fegato fosse l’organo in assoluto più tranquillo perché si trattava di una
persona giovane, attenta a quanto mangiava e beveva.
PRESIDENTE. Avrei ancora alcune cose da chiarire
per arrivare sino in fondo. Per quanto riguarda i polmoni, qui si dichiara che
«è presente intensissima congestione con abbondanti travasi emorragici
endoalveolari». Vorrei sapere quale origine possa avere la congestione.
SIMONA DEL VECCHIO. La morte di tipo asfittico e
cioè tutte le morti che avvengono per mancanza d’aria, quindi la morte cardiaca
o per strangolamento.
PRESIDENTE. La morte cardiaca è contemporanea,
cioè nel momento in cui il cuore si ferma.
SIMONA DEL VECCHIO. No, non è detto che si fermi
subito: si può avere un malore che può avere un suo decorso.
PRESIDENTE. Se invece fosse una morte per
asfissia?
SIMONA DEL VECCHIO. Ci sarebbero stati segni di
asfissia, che in questo caso mancano. È il meccanismo della morte: in questo
caso parlo della mancanza di aria negli organi interni, non della morte per
asfissia.
Prima ho precisato che non c’erano segni di
lesività traumatica di alcun genere.
PRESIDENTE. Parliamo dei polmoni.
SIMONA DEL VECCHIO. La congestione è tipica di una
morte cardiaca.
PRESIDENTE. Ma può essere anche tipica di un
soffocamento?
SIMONA DEL VECCHIO. Di tantissime altre morti,
anche di un soffocamento, ma un uomo di 39 anni come il capitano De Grazia non
si sarebbe fatto soffocare senza reagire. Questo è doveroso dirlo”.
3.4 – La consulenza del professor Giovanni Arcudi.
Come già evidenziato, la Commissione ha ritenuto di voler approfondire l’aspetto
medico legale legato alla morte del capitano De Grazia. A tal fine, dopo avere
audito i consulenti medico legali che effettuarono le operazioni peritali nel
corso dell’indagine condotta dalla procura della Repubblica di Nocera Inferiore,
ha affidato, in data 16 maggio 2012, al professor dottor Giovanni Arcudi
(direttore dell’Istituto di medicina legale nella facoltà medica dell’Università
di Roma “Tor Vergata”, nonchè consulente della Commissione) l’incarico di
esaminare gli atti acquisiti e le consulenze tecniche medico legali effettuate
dalla dottoressa Del Vecchio e dal dottor Asmundo nonché di eseguire gli esami
di natura ripetibile, ritenuti utili, sui preparati istologici e le relative
inclusioni in paraffina eventualmente ancora custoditi presso il laboratorio di
istologia dell’Istituto di medicina legale – Università La Sapienza di Roma. In
data 10 dicembre 2012, il professor Arcudi ha depositato una relazione nella
quale sono esposti i risultati della sua consulenza. Si ritiene di riportare
integralmente il testo della relazione depositata in ragione del tecnicismo
della materia e delle conclusioni, non coincidenti per diversi aspetti ripetto a
quelle cui pervennero la dottoressa Del Vecchio e il dottor Asmundo: «Gli
accertamenti medico legali sono stati effettuati da una parte sulla base della
documentazione acquisita agli atti e, dall’altra, sulla revisione dei preparati
istologici a suo tempo allestiti su frammenti di visceri prelevati in occasione
della autopsia effettuata sul cadavere del De Grazia e della successiva
esumazione. «Nulla è stato possibile fare sul versante delle indagini
tossicologiche forensi poiché non risulta che siano state conservate parte dei
prelievi di liquidi biologici e di visceri che sembrerebbe siano stati fatti nel
corso degli accertamenti necroscopici e utilizzati, all’epoca, per esami chimico
tossicologici forensi. «Quindi sulla scorta del predetto materiale che avevo a
disposizione ho svolto gli accertamenti medico legali all’esito dei quali posso
proporre le seguenti considerazioni. «Preliminarmente è opportuna una
osservazione sugli accertamenti effettuati all’epoca della morte del capitano De
Grazia, disposti dapprima dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria in
data 19 Dicembre 1995 e quindi dalla procura della Repubblica di Nocera
Inferiore in data 23 Aprile 1997. «Come ho avuto modo di anticipare nella mia
relazione preliminare (sostanzialmente ripresa in questa relazione definitiva,
ndr), non posso che ribadire, ora, come gli accertamenti di natura medico
legale, allora disposti, risultino condotti in maniera piuttosto superficiale
con incomprensibili carenze e contraddizioni che rendono i risultati tutti
incerti, poco affidabili e quindi non concretamente utilizzabili per gli scopi
per i quali erano stati disposti. Scopi che erano stati indicati nella serie di
quesiti posti al perito, sempre lo stesso nel primo e nel secondo accertamento,
e che erano tutti finalizzati a chiarire, anche con l’ausilio della indagine
tossicologica, la causa della morte del De Grazia. «Più in particolare deve
essere evidenziata la piuttosto evidente difformità tra il verbale di autopsia
del CT del PM e quello del consulente della parte: nel primo il contenuto
gastrico è riferito come costituito da alcuni cc di liquame blunerastro mentre
il CT della parte parla di un abbondante quantità di materiale alimentare
parzialmente digerito, ed è evidente che sia più veritiera quest’ultima
versione, essendo inconcludente l’affermazione della dottoressa Del Vecchio che
lo stomaco era vuoto perché il Cap. De Grazia aveva vomitato poco prima della
morte.; la CT del PM dice di un cuore con coronarie serpinginose, specillabili,
con intima interessata da diffuse deposizioni ateromasiche intimali, mentre il
CT della parte dice che nulla c’è alle coronarie, e probabilmente ha ragione lui
visti gli esami istologici. «E poi c’è, nella descrizione della seconda autopsia
su cadavere esumato, la non attendibilità di un dato relativo ai prelievi di
parti di visceri che verosimilmente dovevano essere putrefatti e, più
sorprendentemente, di sangue che non poteva più esserci dopo una prima autopsia
e dopo che erano trascorsi circa sedici mesi da quest’ultima. E tante altre cose
ancora. «Insomma si trae quasi l’impressione che in questa indagine medico
legale si sia badato più alla forma di particolari processuali privi di valore
che invece alla sostanza della indagine in patologia forense che sembra del
tutto trascurata nel rigorismo obiettivo e nella valutazione del significato
patologico dei quadri autoptici. «E questo per quanto riguarda gli accertamenti
autoptici ed istologici. Altro capitolo è quello degli accertamenti
tossicologici per i quali non posso che riproporre le stesse considerazioni,
condivise dal tossicologo forense della medicina legale di “Tor Vergata”, già
fatte pervenire con la relazione preliminare che ora possono essere ritenute
definitive. «Sono state prese in esame le indagini chimico tossicologiche che,
secondo l’allora CT del PM, dottoressa Del Vecchio, sono state eseguite in due
riprese: una in occasione della prima autopsia eseguita in data 19.12.1995 con
contestuali prelievi; un’altra quando è stata fatta la esumazione del cadavere
del Di Grazia in data 23.04.1997. «Prima ancora di entrare nel merito, appare
opportuno segnalare una macroscopica contraddizione tra quanto riportato nelle
tre relazioni di consulenza, riguardo al contenuto dello stomaco.Nella prima
relazione della dottoressa Del Vecchio, relativa all’esame autoptico da lei
eseguito in data 19 dicembre 1995, si legge: “…Stomaco contenente alcuni cc di
liquame brunastro…”, mentre nella relazione di consulenza di parte, il dottor
Asmundo, presente all’esame autoptico, scrive: “….Nello stomaco abbondante
quantità di materiale alimentare parzialmente digerito, d’aspetto cremoso e
colorito giallastro-roseo nel quale sono riconoscibili frammenti di formaggio
biancastro e carnei rosei-scuri…”. Nella seconda relazione, infine, relativa
all’autopsia del 19 giugno 1997 (30 mesi dopo la prima !) la dottoressa Del
Vecchio riporta che “, si poteva procedere al prelievo di quota parte di visceri
(fegato, reni, polmoni, cuore milza, stomaco) di muscolo, di osso (vertebra,
osso del bacino e costa) e di sangue per gli ulteriori esami di laboratorio”.
«Anche se le quantità di materiale biologico
prelevato non vengono mai riportate, si deve ragionevolmente ritenere che il
contenuto dello stomaco rinvenuto all’autopsia del 1997 non dovesse essere
costituito solo da alcuni cc di liquame, come affermato nella relazione del
1995, perché su tale materiale sono state effettuati una serie di accertamenti
chimico-tossicologici – ricerca dell’alcool etilico, ricerca dei cianuri,
ricerca di altre sostanze ad azione farmacologica (barbiturici, benzodiazepine,
antidepressivi, ipnotici e tranquillanti) – che necessitano di quantitativi di
materiale non esigui.
«Anche se solo parzialmente compreso nelle
competenze tossicologico-forensi appare doveroso ricordare qui l’importanza del
dato della presenza di cibo nello stomaco, in funzione, non solo delle
valutazioni tanato-cronologiche, ma anche nell’identificazione del materiale
ingerito, per un possibile riscontro con quanto dichiarato da eventuali
testimoni.
«In quest’ottica, purtroppo, nessun prelievo e
nessun accertamento è stato effettuato nel corso della prima autopsia e quelli
relativi alla seconda hanno sicuramente scarso rilievo tossicologico in quanto,
dato il tempo trascorso (30 mesi) sicuramente il materiale era interessato da
profonde trasformazioni putrefattive.
«Entrando nello specifico delle problematiche
tossicologico-forensi, sul contenuto dello stomaco sono state effettuate analisi
per la ricerca dell’alcol etilico, che, come è noto, è una sostanza
particolarmente volatile. Appare pertanto sorprendente che, in un campione
prelevato 30 mesi dopo il decesso, in uno stomaco che era stato aperto dopo la
prima autopsia (il medico legale aveva visto pochi cc di liquame brunastro!) vi
sia ancora la presenza, seppur in quantità esigua ma significativa (0,3
g/litro), di alcool etilico.
«E tale dato è ancora più sorprendente se viene
paragonato all’esito dello stesso accertamento effettuato sul sangue, sia quello
prelevato nel corso dell’autopsia del 1995, sia quello (!!) prelevato nel 1997:
in entrambi i campioni l’analisi da esito negativo (anche se nel campione del
1997 viene utilizzata la dicitura “non dosabile”).
«Alla luce di tali risultati è verosimile che il
consulente abbia confuso per alcol etilico il picco cromatografico di sostanze
volatili di origine putrefattiva ovvero che l’alcol riscontrato sia esso stesso
di origine putrefattiva. In questa seconda ipotesi, tuttavia, tracce di alcol
sarebbero dovute essere presenti anche nel sangue.
«Nel contenuto dello stomaco è stato effettuato
anche un saggio colorimetrico per la ricerca della eventuale presenza di
cianuri. Anche per questa sostanza vale quanto già detto per l’alcol etilico.
«Nello stomaco, in presenza di acido cloridrico, i cianuri si trasformano in
acido cianidrico, sostanza particolarmente volatile e, come ricavabile dalla
letteratura, se le analisi non vengono eseguite tempestivamente, è molto
improbabile che possano essere rilevati.
«Focalizzando l’attenzione sulle indagini
chimico-tossicologiche relative ai prelievi effettuati nel corso dell’autopsia
del 1995, così come desunte dalla relazione si può osservare quanto segue.
«Le analisi descritte, ad eccezione della
determinazione dell’alcol etilico, appaiono molto generiche e non in grado di
determinare la presenza di eventuali sostanze tossiche, soprattutto se presenti
in concentrazione non particolarmente elevate. L’unica tecnica impiegata dotata
di qualche validità scientifica e quella RIA (radio immuno assay) impiegata per
la ricerca di oppiacei e cocaina. «Avendo fornito esito negativo è possibile
escludere la presenza nel sangue e nella bile di oppiacei (particolarmente
morfina) e cocaina.
«Tutte le altre tecniche descritte – la
spettrofotometria U.V., cromatografia su strato sottile (TLC), l’estrazione
secondo la tecnica di Stass-Otto, il metodo di Felby per la ricerca degli
oppiacei – sono (e lo erano anche nel 1995) tecniche obsolete, dotate di scarsa
o nulla specificità e/o sensibilità e che nessun tossicologo applicherebbe per
l’accertamento di una eventuale intossicazione o avvelenamento.
«Sui liquidi biologici prelevati nel corso della
prima autopsia non sono stati effettuati accertamenti per la ricerca dei
principali veleni metallici (arsenico, tallio, ecc.) né di altre possibili
sostanze tossiche, soprattutto quelle che possano agire a piccole dosi (cianuri,
esteri fosforici, digitale, ecc.).
«Sulla base di quanto sopra detto appare di tutta
evidenza come le indagine sono state del tutto inappropriate dovendosi, per
questo, concludere che, ai fini di chiarire se nel caso in discussione si è
trattato di una intossicazione o un avvelenamento, le analisi allora effettuate
sono del tutto inutilizzabili, restando insoluto l’interrogativo circa
l’influenza di fatto tossico nel determinismo della morte.
«Per quanto concerne le analisi effettuate sui
liquidi biologici prelevati nel corso della seconda autopsia (1997),
preliminarmente è doveroso evidenziare che, a causa del tempo trascorso dal
decesso, il materiale era sicuramente interessato da gravi fenomeni
trasformativi dovuti allo stato di putrefazione. In tali condizioni, qualsiasi
accertamento risulta sicuramente compromesso dallo stato del materiale biologico
che rende assai difficile l’identificazione di eventuali sostanze tossiche
esogene.
«Entrando nello specifico delle analisi eseguite,
nonostante il quesito del Magistrato richiedesse “ulteriori” accertamenti
chimico-tossicologici, in pratica i consulenti si sono limitati a ripetere
analisi già effettuate, e non si comprende se sui prelievi della prima autopsia
o su quelli, del tutto improbabili, della esumazione.
«Ancora una volta sono state utilizzate tecniche
obsolete e generiche (spettrofotometria U.V., cromatografia su strato sottile,
saggi colorimetrici); la gascromatografia con rivelatore di massa,
indispensabile in un laboratorio di tossicologia forense, è stata utilizzata
solo per l’analisi del contenuto dello stomaco e di un omogeneizzato di visceri,
trascurando gli altri campioni biologici. I tracciati relativi alle analisi
mediante gascromatografia con rivelatore di massa non sono stati allegati alle
relazioni peritali e, pertanto, non possono essere commentati.
«In queste analisi, inoltre, le perplessità
maggiori sono fornite dalle tecniche utilizzate per estrarre le eventuali
sostanze tossiche dal materiale biologico: la tecnica è specifica e sensibile ma
se l’estrazione non lo è altrettanto, l’analisi diventa inutile. Infine,
l’abitudine ad analizzare omogenati di organi mescolati tra loro è assolutamente
da censurare: un tossico presente in un solo organo viene “diluito” nella massa
complessiva e può essere non più rilevabile (concentrazione inferiore al limite
di rilevabilità del metodo).
«Anche sul materiale prelevato (?) dal cadavere
esumato sono state eseguite indagini mediante tecniche immunochimiche (RIA)
focalizzate sulle due principali sostanze stupefacenti (oppiacei e cocaina). Ma
se i liquidi biologici sono stati prelevati in tempi diversi ma dallo stesso
cadavere, perché ripetere le stesse analisi che avevano già dato esito negativo?
«L’analisi del materiale pilifero è superflua in
quanto, nel caso in cui si fosse trattato di una intossicazione acuta (ad es. un
avvelenamento), la morte sopravvenuta rapidamente avrebbe comunque impedito al
tossico di raggiungere la matrice cheratinica. Affinché una sostanza dal sangue
raggiunga il bulbo pilifero, venga inglobata nel capello nel momento in cui si
sta formando, il capello fuoriesca dal cuoio capelluto e cresca quel tanto che
basta per consentirne il taglio con forbici (in genere non si usa, se non per
esperimenti scientifici, di rasare i capelli), è necessario un periodo temporale
che può essere calcolato tra 15 e 30 giorni, periodo temporale incompatibile con
l’ipotesi di una intossicazione acuta.
«Nelle analisi su materiale pilifero,
l’identificazione delle sostanze è possibile solo in caso di assunzioni
ripetute, abituali o croniche quando le quantità presenti sono compatibili con
la sensibilità della strumentazione utilizzata.
«Anche per quanto attiene a questo secondo gruppo
di analisi si deve ripetere quanto sopra detto a proposito delle prime, e cioè
che sono del tutto inutilizzabili.
«Premesso quanto sopra, e preso atto della scarsa
affidabilità degli accertamenti a suo tempo esperiti, ho ritenuto utile in
questa sede un tentativo di approfondimento in ambito istopatologico essendo le
inclusioni in paraffina e gli allestimenti dei vetrini l’unico reperto che è
pervenuto utilizzabile dai precedenti accertamenti medico legali.
«Ho provveduto, pertanto, con l’assistenza della
Anatomia ed Istologia Patologica dell’Università di Roma “Tor Vergata, alla
revisione dei preparati istologici che ho acquisito nella sezione di Istologia
dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Roma “Sapienza” e ad un
ulteriore allestimento di vetrini anche con nuove e più specifiche tecniche di
colorazione.
«La lettura dei preparati così ottenuti ha
permesso di obiettivare quanto segue:
«Cuore.
«Presenza di aspetti isolati in cui i
miocardiociti assumono aspetto ondulato ed allungato (“a dune di sabbia”),
talora con ipereosinofilia del citoplasma (miocitolisi coagulativa) come da
processo coagulativo microfocale delle proteine e con quadri morfologici
compatibili con bande da ipercontrazione, peraltro molto limitati e ristretti a
piccoli segmenti.
«Presenza di aspetti non conclusivi ma suggestivi
per edema interstiziale.
«Presenza di congestione acuta vascolare.
«Presenza di modificazioni morfologiche dei
miocardiociti riconducibili a fenomeni postmortali.
«La valutazione immunofenotipica (LCA, CD3) non ha
evidenziato un aumento dell’infiltrato infiammatorio intramiocardico, come
segnalato in letteratura nelle condizioni di morte improvvisa di tipo cardiaco,
nella maggior parte dei pazienti.
«Assenza di alterazioni significative dei vasi
presenti nei vetrini esaminati.
«NON si osservano, nei vetrini in esame:
frammentazione terminale delle miocellule, anomalie nucleari riconducibili ad un
danno ischemico, fibrosi interstiziale significativa, miocardioagiosclerosi,
(”evidente sofferenza delle arterie di piccolo e medio calibro”…), aumento del
grasso periviscerale (che appare nella norma laddove valutabile in maniera
adeguata) significativo per patologia cardiaca congenita.
«Si concorda con la valutazione istologica per gli
altri organi, in particolare per l’intenso e diffuso edema polmonare e per
l’altrettanto marcata congestione vascolare. La maggior parte delle alterazioni
a livello dei vari organi sono peraltro di verosimile natura putrefattiva, fatta
eccezione per la congestione vascolare.
«Dalla lettura di questi preparati istologici, in
confronto con gli esami istologici fatti dal CT dottoressa Del Vecchio si
possono trarre queste conclusioni: «Il quadro macroscopico descritto a livello
del cuore esclude l’ipotesi di displasia aritmogena, tipica del ventricolo
destro del cuore, non del sinistro.
«NON è presente fibrosi interstiziale nel cuore.
«NON è documentata in maniera certa una
significativa coronarosclerosi che potrebbe giustificare una morte cardiaca
improvvisa su base ischemica.
«La descrizione macroscopica del cuore sembra
indicare una degenerazione bruna del miocardio di tipo terminale, la cui genesi
è riconducibile a svariate cause, non ultima il cuore polmonare acuto.
«Conclusioni.
«Al termine delle indagine di consulenza tecnica
che mi era stata affidata da Cotesta Commissione posso rilevare quanto segue.
«Innanzitutto i limiti della presente indagine
sono apparsi subito evidenti al momento in cui ci si è resi conto che, ad
eccezione del materiale istologico, nessun reperto dei precedenti accertamenti
era più disponibile per poter ripetere le analisi e magari per approfondirle in
un’ ottica più indirizzata ad individuare con sufficiente certezza la causa
della morte del capitano Natale De Grazia.
«Allo stato non è possibile reperire nuovi reperti
da utilizzare con profitto dovendosi escludere che una eventuale, rinnovata
esumazione della salma possa dare la possibilità di indagare sui temi che qui
interessano e cioè quelli della causa della morte con particolare riferimento
alla presenza di sostanze tossiche.
«Non rimane che fare delle deduzioni sostenute dai
pochi elementi di certa obiettività desunti dagli atti, tenendo anche conto di
quanto acquisito nel corso delle audizioni delle persone che in qualche modo
ebbero ad assistere nella circostanza della morte del capitano De Grazia.
«Bisogna subito sgombrare il campo da un equivoco
che sembra essersi creato nel percorso investigativo sulle cause della morte.
«L’indagine medico legale condotta dalla
dottoressa Del Vecchio si è conclusa con una diagnosi di morte improvvisa
dell’adulto, facendo intendere che vi fossero in quel quadro anatomo ed
istopatologico elementi concreti che potevano ben sostenere detta diagnosi.
Questo non corrisponde alla verità scientifica.
«Ho poco sopra evidenziato come la lettura dei
preparati istologici effettuata in questa sede smentisca quella della dottoressa
Del Vecchio, la quale ha ritenuto di cogliere, nella sua indagine anatomo ed
istopatologica, elementi deponenti per un preesistente danno miocardico di cui
sarebbe stato portatore il capitano De Grazia; danno che poi è stato utilizzato
per sostenere la morte improvvisa dell’adulto.
«Questo significa che, allo stato, non c’è
nell’intera indagine alcun dato certo che possa supportare la morte improvvisa
dell’adulto; diagnosi causale di morte, questa, che deve essere ritenuta non
provata e nemmeno connotata da apprezzabili probabilità.
«Se noi qui dobbiamo fare una conclusione al
termine di questa indagine dobbiamo dire che il capitano De Grazia non è morto
di morte improvvisa mancando qualsivoglia elemento che possa in qualche modo
rappresentare fattore di rischio per il verificarsi di tale evento. Si trattava
infatti di soggetto in giovane età, in buona salute, senza precedenti
anamnestici deponenti per patologie pregresse, che conduceva una vita attiva e,
come militare in servizio, era sottoposto alle periodiche visite di controllo
dalle quali non sembra siano emersi trascorsi patologici. E per altri versi
l’esame necroscopico, al contrario di quanto è stato prospettato attraverso una
analisi non attenta e piuttosto superficiale dei reperti anatomo ed
istopatologici, non ha evidenziato nessuna situazione organo funzionale che
potesse costituire potenziale elemento di rischio di morte improvvisa.
«E nemmeno quanto riferito dalle persone che erano
presenti alla morte e che ne seguirono le fasi immediatamente precedenti, si
accorda con una ipotesi di morte cardiaca improvvisa.
«Si sa infatti che il capitano De Grazia, subito
dopo aver mangiato e messosi in macchina ha cominciato a dormire e quindi a
russare in modo strano; ad un certo punto reclina la testa sulla spalla e per
questo viene scosso dall’occupante il sedile posteriore dell’autovettura; a
questa sollecitazione egli reagisce sollevando il capo ma non svegliandosi e
senza dire alcunchè se non emettendo un suono indefinito; quindi poco dopo
reclina definitivamente la testa e non risponde più alle sollecitazioni.
«Bene, mi risulta difficile avvalorare l’ipotesi
di una morte cardiaca da ischemia miocardica su base aterosclerotica senza
manifestazioni anginose, senza dolore che si sarebbe dovuto manifestare specie
in quel momento in cui il capitano De Grazia è stato scosso ed ha avuto in
momento di reazione seppure, come è stato riferito, in una specie di
dormiveglia.
«Piuttosto, se si volesse proporre una ipotesi di
causa di morte diversa da quella sopradetta, sembrerebbe più trattarsi di morte
cardiaca secondaria a insufficienza respiratoria da depressione del sistema
nervoso centrale, come suggestivamente depone il quadro di edema polmonare così
massivo, incompatibile quasi con un arresto cardiaco improvviso del tutto
asintomatico; come suggestivamente depongono le manifestazioni sintomatologiche
riferite da chi ha potuto osservare il sonno precoce, il russare rumoroso, quasi
un brontolo, la risposta allo stimolo come in dormiveglia, il vomito; tutte
manifestazioni queste che, anche se non patognomoniche, ben si accordano con una
progressiva depressione delle funzioni del sistema nervoso centrale.
«Quest’ultima, in carenza di incidenti
cerebrovascolari, esclusi dall’autopsia, può riconoscere solo la causa tossica.
Quale essa potrà essere stata, e se c’è stata, non lo si potrà più accertare.
«Purtroppo è stata irreversibilmente dispersa la
possibilità di indagare seriamente sul versante tossicologico, da una parte per
superficialità e forse inesperienza di chi aveva posto i quesiti con scarsa
puntualità e poco finalizzati; dall’altra per l’insipienza della indagine medico
legale che ha ritenuto trovarsi di fronte ad una banale morte naturale ed
inopinatamente si è subito indirizzata, trascurando l’indagine globale, alla
esclusiva ricerca di droghe di abuso in un caso nel quale, se c’era una ipotesi
se non da scartare subito almeno da considerare per ultima, era proprio quella
di una morte per abuso di sostanze stupefacenti; e pervicacemente ha insistito
sulla stessa linea anche nella seconda indagine necroscopica.
«Oramai l’indagine tossicologica non è più
ripetibile, neppure, come sopra accennato, con l’esumazione del cadavere, e
quindi il caso, dal punto di vista medico legale deve essere, ad avviso del
sottoscritto, considerato chiuso».
La Commissione, non avendo avuto la possibilità di
audire nuovamente la dott.ssa Del Vecchio in ragione della cessazione delle
attività d’inchiesta dovuta allo scioglimento anticipato delle Camere, ha
comunque ritenuto opportuno inviare alla stessa una copia delle consulenza
depositata dal professor Arcudi. La dott.ssa Del Vecchio ha fatto pervenire alla
Commissione una nota di cui si ritiene doveroso dar conto perché in essa sono in
qualche modo contenute le sue controdeduzioni rispetto ai rilievi effettuati dal
Prof. Arcudi: Conclusioni. Le conclusioni della consulenza medico-legale del
professor Arcudi impongono di valutare le risultanze dell’inchiesta
precedentemente svolta in una chiave nuova e non poco allarmante. E’ vero che,
come si ricorderà tra poco, già emergevano elementi di sospetto in relazione
alla morte del capitano De Grazia, per tutto ciò che l’ha preceduta, e che non
appare trasparente, e per ciò che è accaduto dopo la sua scomparsa. La
consulenza del professor Arcudi, che appare analiticamente motivata, e
scientificamente inattaccabile, arriva ad una conclusione inequivoca: escluse le
altre cause, per l’assenza di elementi di riconoscimento, la morte è la
conseguenza di una “causa tossica”. Aggiunge il professor Arcudi: “quale essa
potrà essere stata, e se c’è stata, non lo si potrà accertare”. Ciò che risulta
è che il capitano De Grazia ha ingerito gli stessi cibi di chi lo accompagnava
nel viaggio, salvo un dolce: queste almeno sono state le dichiarazioni dei
testimoni. Se così è, appare difficile ricondurre la tossicità ad una causa
naturale, anche se non lo si può escludere in forma assoluta. Il capitano De
Grazia, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, stava conducendo indagini su
tutte le vicende più oscure riguardanti il traffico illecito di rifiuti
pericolosi e aveva costituito un gruppo di lavoro assai efficiente. Ciò
nonostante, come ha riferito il maresciallo Moschitta “quando le indagini
arrivarono a picco, e quindi stavamo mettendo le mani su fatti veramente gravi,
coinvolgenti anche i livelli della sicurezza nazionale”, “De Grazia non venne
più a effettuare le indagini con noi, perchè il suo comandante lo aveva
bloccato”. Elementi di poca chiarezza sono stati riscontrati altresì in
relazione alle ragioni del viaggio a La Spezia, essendo state fornite alla
Commissione versioni del tutto diverse, tra le quali anche un contatto con un
confidente. Fatto non meno significativo è che risulta violato il fascicolo
giudiziario che conteneva la documentazione relativa alle indagini che aveva
svolto il capitano De Grazia e che era stato esaminato dalla procura di Reggio
Calabria alla ricerca vana del certificato di morte di Ilaria Alpi, che lo
stesso capitano De Grazia aveva sequestrato a Comerio: stando alle dichiarazioni
del dottor Neri, infatti, “delle 21 carpette numerate rinvenute, 11 erano prive
di documenti”. Ma ciò che è parso inquietante alla Commissione è stato
l’improvviso smembramento del gruppo investigativo che faveva capo a De Grazia,
subito prima e subito dopo il suo decesso. Pochi giorni prima della morte del
capitano De Grazia il colonnello Martini, che aveva avuto un ruolo di primo
piano nell’attività investigativa, lasciò l’incarico di colonnello del Corpo
forestale dello Stato per assumere il ruolo di direttore operativo della società
municipalizzata di Milano impegnata nell’emergenza rifiuti. Le perplessità, in
ordine alle ragioni di questa scelta, sono già state illustrate. Dopo la morte
del capitano De Grazia il maresciallo Moschitta andò in pensione all’età di
quarantaquattro anni. Il carabiniere Francaviglia chiese il trasferimento a
Catania. L’ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi,
dopo qualche mese dal decesso del capitano De Grazia, non si occupò più
dell’indagine: a suo dire, non per sua iniziativa. Lo smembramento del nucleo
investigativo, che stava operando in profondità sul riciclo illegale dei
rifiuti, se si unisce alla causa della morte, identificata in un evento tossico,
getta una luce inquietante sull’intera vicenda. Non è compito di questa
Commissione pronunciare sentenze, né sciogliere nodi di competenza dell’autorità
giudiziaria: tuttavia, non si può non segnalare che la morte del capitano De
Grazia si inscrive tra i misteri irrisolti del nostro Paese.
Ecco
il testo in cui Giorgio Comerio racconta la "sua" verità sul sistema per mandare
in fondo al mare siluri pieni di rifiuti tossici.
"Su di me dette e scritte solo fantasie". Il memoriale dell'affondatore di
veleni, riportato da Anna Maria De Luca e Paolo Griseri su “La
Repubblica”. Ecco il memoriale di Giorgio Comerio, l'uomo al centro delle
inchieste delle procure italiane sul traffico di veleni di cui per anni è stato
accusato di essere uno dei registi. Al punto che, intervenendo in Parlamento a
nome del governo, Carlo Giovanardi lo ha definito "noto trafficante". Comerio ci
ha inviato il testo per posta elettronica. Si tratta delle tesi difensive che lo
stesso Comerio intende sostenere per replicare a quelle che lui definisce
"fantasie" e che sono state invece oggetto delle inchieste dei pm. Il memoriale.
Nel memoriale Comerio dà le sue spiegazioni sui punti più controversi della sua
attività dalla Somalia connection alla scoperta del certificato di morte di
Ilaria Alpi ritrovato tra le sue carte. E poi ancora: l'agenda con la scritta
"lost ship" annotata proprio il giorno in cui affondò la "Rigel", al largo di
Reggio Calabria, una delle presunte navi dei veleni. Comerio inizia spiegando i
suoi progetti di affondamento dei rifiuti tossi sotto i fondali marini, portati
avanti con i governi di mezzo mondo: "La tecnologia Free Fall penetror's -
scrive - è stata sviluppata dagli Stati Membri della Comunità europea,
congiuntamente con gli Stati Uniti, Svizzera e Canada per un investimento totale
di circa 300.000.000 dollari USA. La tecnologia è una libera proprietà comune di
tutti i cittadini delle nazioni che hanno investito su questo. I risultati sono
pubblici e disponibili. E' possibile acquistare numerosi volumi a Parigi, in una
libreria specializzata in tecnologia, che mostrano tutti gli studi e le analisi
effettuate nell'Oceano Atlantico e dove si possono trovare anche le immagini
delle testate penetratrici. Ma gli studi non sono stati continuati a causa della
indisponibilità di fondi". In realtà il sistema di affondamento dei rifiuti con
siluri sarebbe stato bloccato perché una convenzione internazionale vieta questa
pratica. Comerio contesta questa versione spiegando che la rinuncia a utilizzare
il sistema "non ha niente a che fare con la London Dumping Convention che in
quel periodo non era in vigore e non era stata firmata da diverse nazioni come
Stati Uniti, Australia, Russia, ecc". Addirittura, aggiunge, "la Federazione
Russa per diversi anni (ma anche ora?) ha disperso rifiuti radioattivi
incapsulati in elementi di cemento nel mare di Barents e Kara, vicino all'isola
Novaja Zemija. Nessuno poteva fermare quella attività". Infatti, sostiene
Comerio, "la London Dumping Convention riguardava solo lo smaltimento illegale
dei rifiuti in mare e non un sistema ben realizzato e sicuro per depositare
penetratori sotto il letto del mare in zone sicure, con una precisa mappatura
subacquea e test di prova per la procedura". Comerio iniziò quindi in quegli
anni la sua attività "ma solo dopo aver ricevuto una risposta positiva circa
l'uso dei Free Fall Penetrators". La risposta veniva "da un consulente di
diritto internazionale con sede a Locarno (Svizzera). Solo a quel punto iniziai
l'attività di marketing offrendo la tecnologia (e non i servizi di dumping) agli
enti governativi interessati". Comerio definisce l'uso della Free Fall
Penetrators "un modo per risolvere il livello medio dello smaltimento dei
rifiuti radioattivi (composto da elementi radiologici ospedalieri, tute di
lavoro ecc ma non da elementi ad alta energia). Una soluzione capace di ridurre
la dipendenza dall'uso del petrolio e dai signori del petrolio". E racconta come
"la tecnologia sia stata presentata ufficialmente dall'European Joint Research
Centre in numerosi eventi pubblici dedicati alla tecnologia, mostrando i
modelli, immagini, video, diagrammi, per vendere l'uso di un certo numero di
elementi hardware che compongono il sistema, sia ai privati che alle società".
Niente di illegale quindi, secondo l'autore del memoriale, perché "è stata una
strategia finanziaria della Comunità europea per provare a recuperare un minimo
degli investimenti fatti, incassando royalties dallo sviluppo dei diversi
elementi di tecnologia che compongono il sistema di smaltimento. Con nessun
risultato.. Uno dei team leader di quel periodo, il prof. Dr. Avogadro, potrebbe
confermarlo". In questo quadro Comerio si definisce "uno dei diversi fornitori
di elementi che compongono il sistema: "Ho venduto al Jrc la boa in grado di
raccogliere dati sott'acqua e di trasmettere tutte le informazioni da un
satellite ad una stazione centrale di controllo che si trova in Germania". Anni
dopo Giorgio Comerio fonda Odm, "come un provider che offre la sua tecnologia
solo a organi di Governo o a società governative. Odm non è mai stato in
contatto con soggetti privati, ma solo con le istituzioni nazionali tramite le
ambasciate. Odm non è mai stato coinvolto in alcuna attività illegale.
L'attività iniziale di marketing è stata fatta presso l'Ufficio del Lugano,
illegalmente attaccato dagli attivisti di Greenpeace. Ogni tipo di documento è
stato analizzato dalla polizia svizzera e dal Procuratore di Lugano e, dopo due
settimane di dettagliate analisi, la Corte svizzera ha riconosciuto che
l'attività Odm era solo un legal marketing preliminare senza connessioni con
qualsiasi tipo di attività illegale o criminale. In seguito gli attivisti di
Greenpeace tedeschi sono stati condannati dalla Corte di Lugano. L'attività di
marketing è stata realizzata contattando solo le ambasciate delle possibili
nazioni interessate. Senza alcun risultato (testualmente with no result at all).
Dopo questi eventi l'ufficio Odm è stato chiuso e l'attività di marketing è
stata stoppata". Questa versione dei fatti contrasta con il fatto che Comerio è
stato accusato dalla magistratura italiana di aver partecipato, in realtà, a un
vasto traffico di armi e veleni. Ecco le risposte che l'accusato ha voluto
fornirci. Comerio inizia dicendo che "la fantasia italiana è uno sport
nazionale" e che "copie dei documenti di Comerio sono stati presi in consegna,
come 'corpo del reatò da parte della procura di Catanzaro e delle copie sono
state "diffuse" da attivisti di Greenpeace su testate "specializzate" come
"Cuore", "Il Manifesto", "L'Espresso", ecc ecc. Risultato: una serie di
fantastiche "connessioni" riportate dalla stampa italiana". E le affronta una
per una. Somalia connection. Comerio dice che la tecnologia Odm era pubblica e
totalmente disponibile sul web in diverse lingue. Senza segreti, nessun modo di
agire "sotto il tavolo". E spiega: "Odm è stato avvicinato da un gran numero di
studenti, ricercatori e anche uomini d'affari. Uno di loro ha proposto di
prendere contatto con il Governo somalo. Ma prima di prendere qualsiasi contatto
con l'ambasciata somala, Odm ha chiesto all'Ufficio delle Nazioni Unite a
Ginevra (Svizzera) un chiarimento sul governo della Somalia. La risposta è stata
negativa. Al momento sembrava non ci fossero ufficiali in ricognizione per conto
del Governo. Così Odm non ha proceduto in ulteriori contatti con l'uomo d'affari
privato". Ilaria Alpi connection. Scrive Comerio: "Si tratta di una pura
falsità. Sembra che in casa mia sia stato trovato un inesistente certificato di
morte della signorina Alpi. L'unico certificato di morte che avevo era quello
della signora Giuseppina Maglione, morta il 9 febbraio 1996, per il cancro, mia
suocera". "Jolly Rosso". "Sulla stampa è stata pubblicata una storia divertente.
A bordo della Jolly Rosso sarebbe stata trovata una mappa dei fondali del mare
realizzata da Odm con possibili sedi di dumping nel mare Mediterraneo. Ma
nessuna delle autorità ha mai mostrato questa mappa. Del tutto normale. Odm ha
iniziato la sua attività anni dopo lo spiaggiamento della Jolly Rosso, e non
sono stati individuati luoghi valutati da Odm come aree di smaltimento nel mare
Mediterraneo". La connessione "Rigel" e la differenza tra "Lost" e "affondato".
"Per Greenpeace e la Procura di Palermo c'è una connessione tra Comerio e una
nave "Rigel" scomparsa presso l'isola di Ustica. Il motivo? Dentro una delle
agende del signor Comerio è stata scritta la frase 'perso la navè nella
settimana nella quale sembra scomparsa una nave nei pressi di Ustica .. In
effetti il signor Comerio a quel tempo perso il traghetto dalla Gran Bretagna
alla Francia. (Vela da St. Peter Port - Guernsey - a St. Malo - Francia). Era
abbastanza difficile da spiegare che "perso" non significa "sommerso" .. Dopo
mesi di indagini la connessione con Comerio è stata abbandonata". Affondamenti
illegali nel Mediterraneo. È il capitolo più scottante nelle vicende che lo
riguardano. Comerio risponde in modo articolato e parlando in terza persona.
"Per un certo numero di giornalisti - scrive - lo scarico dei rifiuti illegali
nel Mediterraneo era legato ai piani di ODM". Ma questo, dice, è falso per
diverse ragioni: "Prima di tutto nelle mappe del ODM tra le possibili aree di
smaltimento non c'era nessuno punto nel Mar Mediterraneo. Tutti i settori
considerati erano solo in oceano aperto. In secondo luogo: il signor Comerio non
è mai stato in contatto con elementi criminali: non vi è alcuna prova di un
contatto del genere in tutta la sua vita. In terzo luogo, per un lungo periodo
il signor Comerio ha lavorato con la sua società Georadar proprio per
smascherare le discariche di rifiuti chimici pericolosi. Georarad ha goduto di
importanti citazioni in letteratura scientifica. È stata citata su riviste e nei
servizi della Rai3 Lombardia. La tecnologia Georadar è stata presentata dal
dottor Comerio al Collegio degli ingegneri di Milano con positivi riscontri.
Quella stessa tecnologia è stata utilizzata dalle Ferrovie, da Enel, Sirti, Agip
e da importanti società in Italia, Svizzera e Germania. Le attività di Georadar
sono iniziate nel 1988-89". Grazie a quella tecnologia (un sistema di indagine
sotterranea), Comerio sostiene di "essere stato incaricato di collaborare con i
giudici di Milano Antonio Di Pietro e Francesco Greco. Con il primo per scoprire
alcuni fusti nascosti in diverse località del Nord Italia, con il secondo
durante le indagini su un rapimento". Nel memoriale si aggiunge che "Comerio ha
collaborato a diverse ricerche archeologiche in antiche chiese nel Nord Italia e
ha collaborato alla scoperta a Roma dei resti del ponte di Muzio Scevola.
All'epoca ha lavorato per il ministero dei Beni Culturali. Per un breve periodo
è stato anche iscritto al Partito dei Verdi a Milano". Ecco dunque la
conclusione: "La storia personale del signor Comerio mette in evidenza come egli
abbia sempre lavorato a fianco della Legge e della difesa dell'ambiente e mai
contro".
TARANTO E VADO LIGURE. C’E’ INQUINAMENTO ED
INQUINAMENTO. E’ SALUBRE SE E’ DI SINISTRA.
“I vari servizi giornalistici dedicati negli
ultimi giorni da Panorama, il Giornale e dai telegiornali Mediaset alla centrale
elettrica Tirreno Power di Vado Ligure lanciano con ampio rilievo accuse
infondate e palesemente strumentali nei confronti di Carlo De Benedetti e del
gruppo Cir”. E’ quanto precisa in una nota il portavoce Cir. “La centrale non è
di Carlo De Benedetti. Né lui né alcun rappresentante di Cir hanno ruoli in
Tirreno Power. L'impianto è stato costruito dall’azienda elettrica di Stato alla
fine degli anni ’60 e gestito dall’ex monopolista pubblico per oltre 30 anni,
fino al 2002. Uno degli azionisti di Tirreno Power, con una quota di minoranza
del 39% detenuta indirettamente, è Sorgenia (società controllata da Cir).
Sorgenia non gestisce in alcun modo la centrale di Vado Ligure". "Carlo De
Benedetti -continua la nota - , inoltre, non è più azionista del gruppo Cir.
Nonostante ciò sia De Benedetti sia il gruppo Cir sono chiamati in causa
strumentalmente con informazioni errate o distorte, fingendo di ignorare
peraltro che nella proprietà di Tirreno Power ci sono altre società che non
vengono quasi mai citate. Quanto alle accuse sull’impatto ambientale
dell’impianto - senza entrare nel merito delle indiscrezioni relative
all’inchiesta giudiziaria in corso sulla centrale - si ricorda che la società
Tirreno Power ha sempre dichiarato di operare nel rispetto delle leggi nazionali
e internazionali”.
Centrale di Vado: dieci domande a De
Benedetti, scrive “Il Secolo XIX”. Dieci domande
rivolte all’ingegner Carlo De Benedetti, socio forte della Tirreno Power
attraverso Sorgenia, firmate da personaggi autorevoli sul progetto di
ampliamento della centrale a carbone di Vado Ligure. Le domande sono contenute
in una lettera che domani verrà pubblicata su diverse testate nazionali. A De
Benedetti (che attraverso Sorgenia detiene il 78% di Energia Italiana, a sua
volta proprietaria del 50% di Tirreno Power, mentre l’altro 50% e in mano a
EblAcea, società detenuta per il 70% da GdfSuez e per il 30% da Acea) viene
chiesto perché l’azienda si ostina a procedere a questo intervento «contro ogni
logica democratica (contro il volere del 90% della cittadinanza, dei Partiti, di
tutti i Comuni, della Regione, dell’Ordine dei Medici, di tutto
l’Associazionismo) e ambientale (dopo 40 anni di dati drammatici in termini di
mortalità e di inquinamento nella nostra città, con migliaia di morti in più
rispetto alla media regionale)». Le dieci domande sono state raccolte in un
documento frutto del lavoro di sintesi di molti esperti, amministratori, medici,
giornalisti, associazioni e comitati. Tra questi figurano Margherita Hack, Beppe
Grillo, Maurizio Maggiani, Luigi De Magistris, Oliviero Beha, Ferdinando
Imposimato e ancora Sergio Staino, Angelo Bonelli, Massimo Carlotto, Lella
Costa, Marco Pannella, Don Andrea Gallo, Lidia Ravera, Paolo Ferrero, Vittorio
Agnoletto, Ennio Remondino, Bruno Gambarotta, Patrizia Gentilini, Giovanni
Impastato e Mimmo Lombezzi. «Perché non volete ammettere» si chiede fra l’altro
a De Benedetti «che le centrali a carbone uccidono? Perché mistificate la realtà
dicendo che avete il “carbone pulito” (concetto smentito dalle principali
ricerche internazionali), così giocando con la vita della gente?». E ancora:
«perché continuate a propagandare con ogni mezzo di comunicazione che il Vostro
progetto di ampliamento della centrale e di ristrutturazione dei gruppi 3 e 4
esistenti diminuirebbe l’inquinamento, mentre ricerche scientifiche indipendenti
dimostrano esattamente il contrario?».
La lettera pone a De Benedetti 10 domande sul
perchè la sua ditta Tirreno Power vuole ampliare la centrale a carbone di
Savona, contro ogni logica democratica (contro il volere del 90% della
cittadinanza, dei Partiti, di tutti i Comuni, della Regione, dell'Ordine dei
Medici, di tutto l'Associazionismo) e ambientale (dopo 40 anni di dati
drammatici in termini di mortalità e di inquinamento nella nostra città, con
migliaia di morti in più rispetto alla media regionale), un documento frutto del
faticoso lavoro di sintesi di molti esperti, amministratori, medici,
giornalisti, associazioni e comitati. E' una battaglia di civiltà, e per la
vita. Da settembre la dirigenza Tirreno Power vuole decidere per l'ampliamento,
incurante della contrarietà della comunità savonese.
10 DOMANDE ALL’ING. DE BENEDETTI SULLA CENTRALE A
CARBONE TIRRENO POWER DI SAVONA.
Egr. ing. Carlo De Benedetti, a Lei che si vanta
di essere la tessera numero uno del Partito Democratico, poniamo 10 questioni in
merito alla Sua decisione di ampliare la centrale a carbone Tirreno Power di
Vado Ligure (Savona), da Lei controllata attraverso CIR Sorgenia, con tutte le
conseguenze in termini di mortalità prematura della popolazione e nonostante la
quasi totale contrarietà di cittadini, istituzioni, partiti, associazioni,
medici e biologi. 10 le domande, alle quali Le chiediamo di dare risposta:
1) CONTRARIETA’ DELLA CITTA’ AL PROGETTO - perché
vi ostinate a perseverare nel vostro progetto di ampliamento, in spregio alla
contrarietà dell’85%-90% della popolazione savonese, quella dei partiti (tra cui
anche il PD), della Regione, dei Sindaci, dei Consigli comunali, delle
Circoscrizioni, dell’Ordine dei Medici, di tutto l’associazionismo provinciale,
delle principali personalità della società civile? E’ questo il personale
concetto di democrazia del tesserato numero uno del Partito Democratico? Tutto
questo non va contro non solo ai valori fondanti sanciti nello Statuto del PD,
ma anche ai più elementari principi di democrazia del nostro paese? Hanno
approvato delibere contro l’ampliamento della centrale Tirreno Power tutti i
comuni interessati: i Comuni di Savona, Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi,
Spotorno, Noli, Finale Ligure, Balestrino, Vezzi Portio, Albissola Marina, Celle
Ligure, Altare, Carcare, Cairo.
2) DI CARBONE SI MUORE - perché Lei e la dirigenza
Tirreno Power non volete ammettere che le centrali a carbone uccidono? Perché
mistificate la realtà dicendo che avete il “carbone pulito” (concetto smentito
dalle principali ricerche internazionali), così giocando con la vita della
gente? Secondo il referente scientifico dell’Ordine dei Medici di Savona “in
tutta la provincia di Savona (con dati che peggiorano quanto più ci si avvicina
alla centrale) diversi tumori e altre patologie vascolari, aumentano
drammaticamente rispetto alla media nazionale (in particolare i tumori al
polmone, vescica e laringe, le patologie cardiovascolari come infarti, emorragie
cerebrali, ictus ed altre)”. Le ricordiamo che in provincia di Savona in 16 anni
sono morte circa 2.664 persone in più rispetto all’atteso (in base ai tassi
standardizzati di mortalità della Liguria). I calcoli commissionati dalla
Comunità Europea asseriscono che nel nostro territorio savonese abbiamo valori
di inquinamento fra i più alti in Italia, cui si associa una significativa
riduzione dell’aspettativa di vita (la speranza di vita in Liguria è ridotta di
quasi un anno per via dell’inquinamento). Ricordiamo che, secondo un’altra
ricerca, a Vado Ligure il tumore maligno al polmone colpisce il 30% in più degli
uomini rispetto al resto della Provincia. Per le malattie ischemiche del cuore,
a Vado le donne fanno registrare il 71,9% di casi in più rispetto alla media
regionale, mentre per le malattie respiratorie croniche ostruttive, a Vado gli
uomini fanno registrare il 150% (centocinquanta) in più sulla Regione.
3) IL CARBONE PRINCIPALE MINACCIA CONTRO IL CLIMA
- perché, in collaborazione con il Governo, volete perseverare con il Vostro
dannoso progetto di ampliamento della centrale a carbone, quando questo va
ancora di più contro gli importantissimi accordi presi dall’Italia e dagli altri
Stati nel protocollo di Kyoto? Il carbone rappresenta la prima minaccia per
l’equilibrio climatico mondiale: oltre un terzo delle emissioni mondiali di CO2
si devono all’uso di carbone, che è il combustibile fossile con le più alte
emissioni specifiche di gas serra, circa il triplo del gas. Greenpeace denuncia
che “il Governo italiano è contro il Protocollo di Kyoto, che obbliga il Paese a
ridurre i gas serra del 6,5% rispetto al 1990. A oggi le emissioni sono
aumentate del 10% e il Governo, già inadempiente e in disaccordo con gli impegni
presi, continua ad autorizzare nuovi impianti a carbone, come la nuova centrale
Enel a Civitavecchia e l’ampliamento di quella di Vado Ligure (la quale quindi
aumenterà notevolmente la produzione di CO2). Il carbone porterà maggiori
profitti nelle casse degli amministratori delle centrali, ma saranno i cittadini
italiani a pagare le multe per Kyoto”.
4) IMPIANTI NON ALLINEATI ALLE NORMATIVE - perché
continuate a far funzionare i gruppi 3 e 4 della centrale, nonostante non siano
allineati alle norme IPPC dell’Unione Europea, alla direttiva 96/61/CE, e al
decreto legislativo 59/05, e nonostante siano privi della certificazione AIA?
Perché il solo fatto che il Governo abbia prorogato i tempi per la valutazione
dell’istruttoria per la certificazione AIA della Vostra centrale (che dovrà
recepire le normative europee e italiane in materia, sulle quali non vi siete
ancora allineati), vi fa sentire in diritto di definirvi su tutti i giornali
ancora formalmente a norma, quando in realtà siete sostanzialmente e moralmente
inadempienti da 40 anni verso la comunità savonese per i livelli di inquinamento
che state producendo? Perché evidenziate sempre sui giornali che siete in
possesso del V.I.A. ministeriale (al quale peraltro si oppone il V.I.A.
regionale negativo, approvato dalla Regione Liguria) senza invece mai segnalare
alla cittadinanza che non siete allineati rispetto alle principali leggi in
materia ? Ricordiamo che il V.I.A. ministeriale è soltanto una Valutazione
d'Impatto Ambientale gestito da un organo di nomina politica, fra l’altro
dichiarato illegittimo 3 mesi fa dalla Corte dei Conti, e contro il quale la
Regione Liguria ha fatto ricorso. E ancora: perché, come dice l’ex Assessore
Regionale all’Ambiente, “non vi siete conformati alle disposizioni regionali in
materia, né al Piano Energetico Regionale, né al Piano Regionale di risanamento
della qualità dell’aria?”. Perché secondo i medici del MODA “non si è più
discusso della completa metanizzazione degli impianti che la città attende da
più di 20 anni, come votato dagli enti locali savonesi fino al 2007 (compreso il
Comune di Savona) e come indicava l’Istituto Superiore di Sanità già nel 1988?”
Anche il Segretario Provinciale del PD (del suo Partito) ha dichiarato in questi
giorni ai giornali: “Tirreno Power sta dicendo e facendo di tutto meno che
l’unica cosa che dovrebbe fare: i monitoraggi, la copertura dei parchi e in
generale investimenti per diminuire l’impatto del carbone sul territorio (…) Di
questo progetto non ce n’è bisogno, non è in sintonia con i tempi (…) Da anni
continuiamo a parlare di cose che avrebbero già dovuto essere fatte e la Tirreno
Power non ha fatto (...) Si usa sempre la logica ricattatoria occupazionale per
non fare! È ora di finirla (…) È questione di credibilità: mi spiace ma Tirreno
Power non è più un interlocutore affidabile”.
5) MAGGIOR INQUINAMENTO CON IL PROGETTO DI
AMPLIAMENTO - perché continuate a propagandare con ogni mezzo di comunicazione
che il Vostro progetto di ampliamento della centrale e di ristrutturazione dei
gruppi 3 e 4 esistenti diminuirebbe l’inquinamento, mentre ricerche scientifiche
indipendenti dimostrano esattamente il contrario? Sui giornali avete dichiarato
che volete investire e mettere a norma la centrale esistente (affermazione che
peraltro, secondo molti esperti, non corrisponde alla verità in quanto le
modifiche che apportereste ai gruppi 3 e 4 sarebbero insufficienti), ma che non
lo farete se non si concede in cambio anche l’ampliamento della centrale stessa.
Da quando vale il ricatto per cui si seguono le leggi solo se si concede
qualcosa in cambio? Perché deve valere per Lei questa deroga che non è concessa
ai singoli cittadini? Una società come Tirreno Power che ha prodotto 100 milioni
di euro di utili netti all'anno non è forse economicamente in grado di
allinearsi alle normative europee? E perché riproporre l’eterno ricatto delle
centinaia di milioni di investimento e di 40 nuovi posti di lavoro, da mettere
sull’altro piatto della bilancia rispetto ai danni ambientali e ai tassi di
mortalità? La Provincia di Savona su questo tema ha già storicamente pagato
prezzi molto alti, con conflitti laceranti tra salute e lavoro, e non ha bisogno
di essere sottoposta a una nuova prova di forza. Ricordiamo inoltre che, come
dice il Presidente Regionale di Italia Nostra “realizzare l’ampliamento
porterebbe Vado ad una potenza complessiva di 1880 MW, al terzo posto in Italia
(dopo Montalto di Castro e Brindisi). Ci deve essere un limite al gravame su un
territorio, e questo limite a Vado (dopo decenni di industrializzazione in buona
parte scomparsa ma che ha lasciato altre pesantissime eredità negative sul
territorio) è certamente già stato superato”. Secondo il referente scientifico
dell’Ordine dei Medici “gli attuali gruppi 3 e 4 a carbone della centrale
(risalenti agli anni ’60 del secolo scorso e obsoleti da decenni), una volta
ristrutturati secondo il Vostro progetto di ampliamento (propagandato come un
adeguamento secondo le migliori tecnologie), emetteranno, per ogni Megawatt
installato, 3,4 volte in più ossidi di zolfo, 2,5 volte in più ossidi di azoto,
il doppio delle polveri primarie rispetto al nuovo gruppo, dimostrazione
evidentissima che, pur disponendo di una tecnologia meno inquinante, questa non
sarà applicata in modo significativo a tutti i gruppi a carbone, ma solo a uno,
al gruppo nuovo”. E’ evidente che solo finalmente con un ampio confronto con i
Comuni, la Regione, i comitati, e con l’ausilio di esperti indipendenti (e solo
dopo aver rinunciato al progetto di ampliamento), si potrà valutare se
l’adeguamento alla legge 59/05 (che prevede l’utilizzo delle migliori tecnologie
esistenti) sarà fattibile in modo significativo nella ristrutturazione dei
vecchi gruppi 3 e 4, o se (come sostengono efficacemente molte personalità
autorevoli in materia) tali gruppi invece risulteranno non più ristrutturabili.
6) CENTRALE COME INCENERITORE - rispondono al vero
le voci che si stanno diffondendo, secondo le quali un vostro obiettivo potrebbe
essere quello di usare i gruppi a carbone anche per bruciare i combustibili
derivati da rifiuti (CDR), utilizzando quindi la centrale anche come
inceneritore? Questo (la gente non lo sa, ma voi ben lo sapete) aggraverebbe in
modo devastante la situazione, perché ai fumi velenosi derivanti dal carbone
(polveri sottili e ultrasottili, metalli pesanti, diossine, solfati, nitrati,
ecc, oltre che radiazioni superiori a quelle delle centrali nucleari) si
aggiungerebbero altre pericolosissime emissioni di diossine, polveri, e metalli
pesanti.
7) INSUFFICIENTE MISURAZIONE DEI LIVELLI DI
INQUINAMENTO - perché accetta il paradosso che il controllo delle emissioni
dalle ciminiere della Sua centrale a carbone sia eseguito dalla stessa Tirreno
Power (per cui gli inquinatori sono i CONTROLLORI DI SE STESSI, senza che sia
prevista alcuna verifica da parte di enti terzi) e non invece da un Ente
Pubblico, il quale finalmente dopo decenni potrebbe garantire la cittadinanza
sui reali livelli di inquinamento? Per quanto riguarda invece le centraline
esterne alla centrale, secondo il referente scientifico dell’Ordine dei Medici
“i dati sull’inquinamento vengono misurati dall’ARPAL in modo superficiale,
obsoleto e insufficiente (per numero e dislocazione delle postazioni, e per
tipologia di inquinanti misurati)”. Come può peraltro la comunità savonese avere
fiducia nell’ARPAL, un’agenzia la cui intera dirigenza è indagata dalla Procura
della Repubblica di Genova per falso, turbativa d’asta ed altri gravissimi capi
d’accusa? Come si può dire, ing. De Benedetti, che l’inquinamento è sotto
controllo, quando si sceglie di non misurare efficacemente le polveri
inquinanti?
8) RIFIUTO DEL CONFRONTO - perché i Responsabili
della centrale rifiutano da anni qualsiasi confronto pubblico con l’Ordine dei
Medici, con i Medici per l’Ambiente e più in generale con la cittadinanza,
lasciando alle migliori agenzie pubblicitarie una massiccia comunicazione fatta
di slogan facilmente smentibili dai dati scientifici (“abbiamo la tecnologia”,
“carbone pulito”, “ampliamo per migliorare l’aria”)? Anche questo, ing. De
Benedetti, è il Suo personale concetto di democrazia, oppure è solo perché ben
sapete che il vostro progetto non può reggere il confronto con le principali
istituzioni mediche locali? Perché su questo tema si è messo in atto da decenni
a Savona un fruttuoso e perverso meccanismo misto: da un lato si ‘addolcisce’
(si promette, si sostiene, si sponsorizza…) e dall’altro si minaccia? Sono state
minacciate di ritorsioni di vario tipo (“ti faccio licenziare”, “ti querelo”,
“ti massacro politicamente”, ed altre pressioni) varie categorie di persone che
avevano tentato di spiegare la verità, inclusi importanti amministratori locali,
medici e giornalisti.
9) SOVRAPPRODUZIONE - perché volete perseverare
con il Vostro dannoso progetto di ampliamento, in una città come Savona che NON
ha bisogno di nuova energia elettrica, dato che la Centrale già attualmente
produce una quantità di energia superiore di ben 5 (cinque) volte a quella che
viene consumata in tutta la Provincia? Perché, ing. De Benedetti, deve essere di
nuovo la Provincia di Savona a essere martoriata e sottoposta ai Vostri
interessi economici, una Provincia che da anni sta cercando faticosamente di
sviluppare la sua importante e strategica vocazione turistica? Ricordiamo che in
Liguria (che secondo studi della UE è una delle regioni più inquinate d’Italia),
una terra tanto bella a livello paesaggistico e naturalistico quanto devastata
dalle industrie e dal cemento, vi sono già ben 3 centrali a carbone (il 27% di
quelle rimaste in funzione in Italia), peraltro pericolosamente vicine a città
densamente abitate.
10) ENERGIE RINNOVABILI - perché volete
perseverare nella produzione di energia dal carbone (una produzione più
economica, usata ancora tra moltissime critiche in altri Stati, ma estremamente
dannosa per la salute e per questo con un consumo in continua riduzione in
Europa), senza investire significativamente nel metano e soprattutto nelle
energie rinnovabili realmente pulite? Come ha detto il Premio Nobel Carlo Rubbia
proprio sul suo giornale, ‘La Repubblica’: “Il carbone è la fonte energetica più
inquinante, più pericolosa per la salute dell'umanità. La CO2 dura in media fino
a 30.000 anni. Il ritorno al carbone sarebbe drammatico, disastroso…”.
In sintesi, perché Lei che si dichiara il primo
tesserato del PD, calpesta buona parte dei principi e dei valori propri del
centrosinistra (e presenti nello Statuto del PD): rispetto della volontà
popolare, rispetto della vita umana, rispetto e cura per l'ambiente, confronto e
dibattito nelle decisioni, adeguamento alle normative dell’Unione Europea,
adeguamento alle leggi non come merce di scambio, considerazione delle opinioni
degli esperti e degli organi medici competenti, sviluppo delle energie
rinnovabili, ecc.? Non conviene con noi, ing. De Benedetti, che il rispetto per
la vita e per l’ambiente non può e non deve far parte di un mero gioco di
interessi politici ed economici, ma deve invece far parte dei valori primari ed
inalienabili di ogni popolo civile? Produrre energia non è un fine ma un mezzo
per far funzionare la società in cui viviamo: è etico e doveroso investire
capitali per produrre energia con le metodiche meno inquinanti possibili,
compatibili con la salute dei cittadini, evitando il combustibile più inquinante
di tutti che è il carbone. Nessun calcolo economico può giustificare la
richiesta di perpetuare lo scempio ambientale e le morti premature causate dalla
combustione del carbone. Le chiediamo quindi di rispettare la volontà della
nostra comunità, desistendo dal Suo progetto di ampliamento della centrale a
carbone e riducendo fortemente i livelli di inquinamento adeguando la centrale
alle migliori tecnologie esistenti, così come previsto dalla legge. Certi di una
sua Risposta, Le porgiamo distinti saluti. Firmatari savonesi: PAOLO FRANCESCHI
(pneumologo, referente scientifico dell’Ordine dei Medici Savona) AUGUSTO PERSEO
(Presidente Comitato ‘Amare Vado’) ADOLFO MACCHIOLI (prete) AGOSTINO TORCELLO
(medico pneumologo, MODA Savona) ANTONINO FRISONE (ex Comandante del Porto di
Savona, ex Ammiraglio) BRUNO MARENGO (Presidente Provinciale ANPI Savona, ex
Sindaco) CARLO TONARELLI (medico, scrittore, ambientalista, Consigliere
Comunale) CARLO VASCONI (Portavoce Provinciale dei Verdi) CLAUDIO GIANETTO
(Segretario Provinciale PdCI Savona) CLAUDIO PORCHIA (giornalista) DARIO
FRANCHELLO (Presidente del Parco del Beigua) DAVIDE CAVIGLIA (Presidente
Provinciale ACLI Savona) DAVIDE MONTINO (docente universitario) ELIO BERTI
(attore, Direttore artistico dell’associazione Timoteo) ENZO MOTTA (Presidente
del circolo Pirandello) FABIO RINAUDO (musicista, Presidente associazione
Corelli) FRANCESCA MARZADORI (Portavoce UAAR Savona) GIAMPIETRO FILIPPI (ex
Assessore all’Ambiente della Provincia di Savona) GIANCARLO ONNIS (Presidente
Legambiente Savona) GIANFRANCO GERVINO (Portavoce di ‘Uniti per la salute’)
GIORGIO AMICO (scrittore) GIOVANNI DURANTE (Presidente Provinciale ARCI Savona)
MARCELLO ZINOLA (Segretario Ordine dei giornalisti liguri) MARCO CAVIGLIONE
(medico ambientalista ISDE, Consigliere Provinciale) MARCO MOLINARI
(giornalista) MARCO RAVERA (Segretario Provinciale Rifondazione Comunista di
Savona) MAURIZIO LOSCHI (Referente Provinciale Medicina Democratica) NICOLA
STELLA (giornalista) PIERO BORGNA (Capogruppo Consiglio Comunale Vado “Viva con
Caviglia”) RENATO ALLEGRA (vicepresidente NuovoFilmstudio) RICCARDO CICCIONE
(Ufficiale Marina mercantile Direttore settore macchine) ROBERTO CUNEO
(Presidente Regionale Italia Nostra) ROBERTO MELONE (Portavoce del Comitato
Acqua Pubblica Savona) ROSARIO TUVE’ (Coordinatore Provinciale Italia dei
Valori) SAMUELE RAGO (Segretario Provinciale ANPI Savona) SERGIO ACQUILINO
(Portavoce provinciale Sinistra Ecologia Libertà Savona) SIMONE GAGGINO
(Coordinatore di Banca Etica di Savona-Imperia) STEFANO MILANO (titolare
libreria UBIK) STEFANO SARTI (Presidente Legambiente Liguria) VALERIA ROSSI
(giornalista) VIRGINIO FADDA (biologo, MODA Savona) VIVIANA PANUNZIO (Portavoce
Emergency Savona) WALTER MASSA (Presidente ARCI Liguria) Comuni che hanno
approvato delibere contro l’ampliamento della centrale Tirreno Power: I Comuni
di Savona, Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure,
Balestrino, Vezzi Portio, Albissola Marina, Celle Ligure, Altare, Carcare, Cairo
Montenotte. Associazioni savonesi che hanno firmato la lettera contro
l’ampliamento della centrale Tirreno Power, e a favore di un suo adeguamento
alle normative: ARCI, ACLI, Emergency, Libera, Meetup di Beppe Grillo, Rete
Lilliput, Unione Donne in Italia, Donne in Nero, Legambiente, Greenpeace, ANPI,
Italia Nostra, UAAR, Comitato Acqua Pubblica, Uniti per la Salute, Amare Vado,
Banca Etica, GaSSa acquisto solidale, Vivere Vado, Medicina democratica,
Libreria UBIK, NuovoFilmstudio, Altromondo, Centro culturale P.Impastato,
Associazione Energie Rinnovabili Vallebormida, ecc.
Ringraziamo vivamente tutti gli esperti, i medici,
i biologi, gli amministratori, i giornalisti, i comitati che si sono
pazientemente adoperati nello stilare questo documento. Iniziativa a cura della
libreria UBIK.
La legge è uguale per tutti?
A Vado Ligure, alle porte di Savona, si registrano
mille morti in più per cancro rispetto ai parametri scientifici presi a
riferimento, scrive “Il Radar”. Secondo un’altra fonte, l’Istituto tumori di
Genova, nel decennio 1988-98 a Vado sono morte di cancro 112 persone su 100mila
contro una media nazionale di 54, più del doppio. Tutti puntano il dito sulla
centrale a carbone della Tirreno Power, che, come riporta Il Giornale, da
quarant’anni brucia fino a 4.000 tonnellate di carbone al giorno. La storia va
avanti dal 1971, quando Enel inaugura la centrale che produce energia elettrica.
Trent’anni dopo, nel novembre 2002, l’impianto passa a Tirreno Power, una
cordata di imprenditori tra i quali primeggia Carlo De Benedetti. La procura di
Savona apre un fascicolo per omicidio colposo, lesioni colpose e disastro
ambientale. Niente sequestri, niente arresti, niente confische. In Liguria la
Tirreno Power (che è il quarto produttore elettrico nazionale) sfrutta un ampio
sostegno trasversale, un intreccio tra politica e imprenditoria che fa da scudo
alla gigantesca centrale, una delle 13 ancora alimentate a carbone in Italia.
Governa la sinistra e tutti devono stare zitti, soprattutto se c’è De Benedetti
di mezzo…
Ciò che vale per l’Ilva non conta se c’è
di mezzo De Benedetti, scrive “Tempi”. A Vado Ligure,
vicino a Savona, «si registrano mille morti in più per cancro rispetto ai
parametri scientifici presi a riferimento. (…) I cittadini, gli ambientalisti,
gli esperti, la magistratura, perfino la curia puntano il dito sulla centrale a
carbone della Tirreno Power, che da quarant’anni brucia fino a 4.000 tonnellate
di carbone al giorno». Così si legge in un articolo pubblicato dal Giornale
e scritto dall’inviato Stefano Filippi, che sembra raccontare una storia simile
all’Ilva, ma con differenze importanti. Nel 2002 l’impianto inaugurato da Enel
nel 1971 passa a Tirreno Power, «una cordata di imprenditori tra i quali
primeggia Carlo De Benedetti, che però non ne ha il controllo». Nonostante le
riconversioni a gas di due gruppi termici, le unità a carbone bruciano ancora e
ci vuole Greenpeace «per attirare l’attenzione sulle due enormi ciminiere
bianche e rosse che scaricano nell’aria enormi quantità di polveri sottili: è il
luglio 2009». La procura di Savona «apre un fascicolo per omicidio colposo,
lesioni colpose e disastro ambientale» e viene realizzata una consulenza da tre
esperti depositata a fine giugno. Ma se a Taranto, per l’Ilva, sono scattati
dalla magistratura provvedimenti clamorosi, in Liguria «niente sequestri, niente
arresti, niente confische»: «Mancano ancora conferme sui legami tra emissioni
della centrale termica ed effetti sulla salute pubblica». La differenza di
trattamento tra Ilva e Tirreno Power è forse dovuta a «un intreccio tra politica
e imprenditoria». A Vado Ligure, infatti, la sinistra governa da sempre ma
soprattutto nella centrale è fortemente implicato Carlo De Benedetti. L’editore
di Espresso e Repubblica, tessera numero uno del Pd, «controlla il 39 per cento
della centrale attraverso Sorgenia (gruppo Cir). Tirreno Power appartiene a due
società al 50 per cento: da un lato i francesi del gruppo Gdf Suez, dall’altro
Energia Italiana Spa. Le cui quote sono così ripartite: 78 per cento a Sorgenia,
11 per cento ciascuna alle multiutility quotate Hera e Iren, ex aziende
municipalizzate di città storicamente in mano alla sinistra come Torino, Genova,
Bologna e l’intera dorsale emiliano-romagnola». Anche Legambiente è «socia di De
Benedetti: ha il 10 per cento della società Sorgenia MenoWatt che si occupa di
soluzioni per l’efficienza energetica». Sta qui il motivo della disparità di
trattamento tra Tirreno Power e Ilva?
Vado Ligure? Repubblica tace,
scrive Annalisa Chirico su “Panorama”. Tra l’Ilva di Taranto e la centrale
elettrica di Vado Ligure non ci sono soltanto mille chilometri di autostrada. In
Liguria la magistratura ha operato sino a oggi senza clamori. Niente sequestri
né arresti alla tarantina, per intenderci. Eppure non è stato smentito dalla
Procura che una perizia abbia stimato, fra il 2000 e il 2008, un deciso aumento
della mortalità nella popolazione: si parla di mille morti in più. I magistrati
indagano per disastro ambientale e omicidio colposo. A Taranto e a Vado Ligure
il copione è identico: impresa inquinante e magistratura inquirente. Il caso
savonese è ancora agli inizi, ma le «cimitiere» e i fumi lenti e inesorabili che
si scorgono dal Golfo dei poeti sarebbero un buon motivo per un’incursione
giornalistica nella terra di Ponente, dove tramonta la dignità del lavoro
soffocata da capitalisti senza scrupoli. E la fantasia dei cronisti della
Repubblica potrebbe sfogarsi in rivoli di inchiostro colpevolista, della stessa
risma di quello iniettato per mesi nell’opinione pubblica per il caso di Taranto
e dei Riva condannati preventivi. Invece niente, sull’impianto della Tirreno
Power, di cui dal 2002 la Sorgenia del gruppo Cir è stata importante azionista,
neppure una riga. Anche dal 19 settembre, quando il Secolo XIX riporta la
notizia della relazione dei periti della procura, La Repubblica tace.
Evidentemente la notizia sfugge all’occhio selettivo del Grande Editore. Non
solo quel giorno, ma anche in quelli successivi. Vado Ligure? Non esiste. Dato
che il garantismo è estraneo alla logica dei due pesi e delle due misure, va
detto si parla di una perizia di parte: nessuna verità rivelata. E si dovranno
attendere le controdeduzioni dell’azienda, perché De Benedetti ha il sacrosanto
diritto di difendersi. E va detto anche che secondo l’Assocarboni quasi un terzo
della domanda di energia europea viene soddisfatta dal carbone. Ma intanto La
Repubblica impone la regola del silenzio. A Taranto, cari colleghi, avete
lanciato i sassi di un’intifada indegna perché faziosa e ideologica. Mille
chilometri a nord, invece, non solo deponete le armi, ma riponete le penne
perché avete deciso che i cittadini non devono sapere. Vado Ligure non esiste.
Adriano Sofri, per citarne uno, non ha trovato ancora il tempo per una
passeggiata tra gli abitanti di questo paesino a due passi da Genova. Tra «le
rovine ciclopiche dell’Ilva», invece, Sofri c’è stato a più riprese. Ogni volta
ha ritratto «l’inferno dell’archeologia contemporanea» dove i Riva, ha stabilito
Sofri con l’inoppugnabile certezza che non abbisogna di processi, sono
responsabili di aver «prosciugato la cassaforte dell’Ilva trasferendone le
risorse a un labirinto di società industriali e finanziarie». E a chi dice che
le bonifiche del territorio costerebbero un paio di centinaia di miliardi di
euro, ecco servita la rampogna sofriana: «Non è una cifra, è un’amara
barzelletta». Il 31 marzo, sotto il titolo «L’aprile crudele dell’Ilva»,
l’editorialista fa di conto: «I lavori indispensabili a mettere in ordine lo
stabilimento costerebbero poco meno dei 10 miliardi del cosiddetto salvataggio
di Cipro». A Vado Ligure, Sofri lo attendono ancora. Prima o poi arriverà.
Intanto intervista i dipendenti dalla fabbrica pugliese: «Dicono gli operai più
anziani che una volta che l’Ilva fosse disertata e smantellata [...] si
scoprirebbe quale irredimibile discarica tossica abbia via via sedimentato il
suolo su cui poggia lo stabilimento, e i canali dai quali avvelena i mari». E a
metà settembre, quando in seguito al maxisequestro preventivo i Riva annunciano
la chiusura di alcuni stabilimenti, Sofri impugna la penna contro «la ritorsione
che vuol mettere questi lavoratori contro quelli dell’Ilva tarantina, e gli uni
e gli altri contro procura e gip di Taranto». Sofri mobilita persino Papa
Francesco: «Se fossi il papa visiterei le discariche dell’Ilva». Il titolo
dell’articolo, manco a dirlo, è «La pelle degli operai». Non è omerico come
quello del 5 giugno: «L’Iliade di Taranto». Chissà se a Repubblica qualcuno si
accorgerà dell’Odissea di Vado Ligure: anche lì gli abitanti hanno qualcosa da
raccontare. Gli operai della Tirreno Power hanno una pelle pure loro, prima o
poi l’impeto operaistico sofriano soffierà sulle loro sofferenze. Oppure no? C’è
poi il procuratore di Torino Raffaele Guariniello, quello della condanna
dell’Eternit , il fautore della Procura nazionale per i reati ambientali.
Guariniello finisce su Repubblica tv per la seguente dichiarazione: «La sentenza
Eternit ha delle analogie con il caso di Taranto, per il quale potrebbe essere
un precedente». Applausi. Quando però il 17 agosto lo stesso Guariniello
partecipa all’evento organizzato dalla rete ambientalista «Fermiamo il carbone»
contro la centrale di Vado Ligure, sul lungomare di Zinola non compare nessun
cronista della Repubblica. Silenzio. Come non citare poi la fanfara anti-Ilva
del vicedirettore Massimo Giannini, che a Ballarò si scaglia contro il
«capitalismo rapace e irresponsabile» dell’Ilva, dove «la gente muore e i
mesoteliomi aumentano del 400 per cento l’anno», e poi esalta i magistrati:
«Invece di dire che la magistratura è la responsabile dei nostri guai, dovremmo
ringraziarla». Finora, va detto, i ringraziamenti di Giannini alla procura
savonese non sono pervenuti. Per chiudere il cerchio debenedettiano tocca
menzionare Roberto Saviano. Lo scorso 6 dicembre sulle colonne dell’Espresso
descrive la sua «prima volta alla Camera». All’ingresso scorge un corteo di
operai dell’Ilva, che manifestano «per il loro diritto al lavoro compromesso da
politiche inadeguate, distratte, ladre». Poi aggiunge con tono profetico: «Ma la
cosa più triste è che le uniche forze economiche nel nostro paese in grado di
rilevare l’Ilva, di bonificarla e di rimetterla sul mercato sarebbero proprio le
organizzazioni criminali». Per Saviano quella città è lo «specchio del paese
Italia» che «paga le conseguenze di politiche industriali dissennate», mentre è
sempre più urgente «immaginare un umanesimo che possa difendersi
dall’aggressività del profitto». E dell’Editore. Applausi.
Così la Liguria rossa copre l'azienda
tossica dell'Ingegner De Benedetti. Enti locali,
sindacati, ambientalisti: De Benedetti, socio della centrale di Vado Ligure,
gode di ampie coperture. Anche se il caso è simile all'Ilva, nell'inchiesta
nessuna svolta, scrive Stefano Filippi su “Il
Giornale”. Era il 1985, e Carlo De Benedetti acquisì in saldo il gruppo Sme
dall'Iri prodiana in fase di privatizzazioni. L'operazione poi saltò, ma è
un'altra storia. Nel 2002 è andata molto meglio all'Ingegnere con la
liberalizzazione dell'energia. Perché è così che l'editore di Repubblica e
l'Espresso ha consolidato la presenza nel settore: comprando alcuni impianti
dall'Enel (cioè dal Tesoro) in base alle «lenzuolate» del ministro Pier Luigi
Bersani. Tra queste centrali c'era quella di Vado Ligure, contestatissima perché
alimentata a carbone. Come l'acciaieria Ilva di Taranto. Secondo i periti della
procura della Repubblica di Savona, la centrale di Vado inquina e uccide. Le
indagini procedono con grande prudenza senza i clamorosi provvedimenti di
Taranto. Amicizie e buone coperture accompagnano il tesserato numero 1 del
Partito democratico in questa avventura imprenditoriale. A partire dai
sindacati, preoccupati per i posti di lavoro. Legambiente ha il 10 per cento di
Sorgenia MenoWatt, società della galassia debenedettiana. E poi gli enti locali:
mentre le altre due centrali termoelettriche a carbone liguri (a Genova e La
Spezia) faticano a ottenere permessi per ampliamenti e ristrutturazioni, quella
di Vado ha avuto i via libera richiesti. Dei quattro gruppi produttivi, i due
che vanno a carbone non sono ancora stati riconvertiti. Tirreno Power, società
proprietaria dell'impianto (De Benedetti ne controlla il 50 per cento), promette
interventi per abbattere le emissioni delle due ciminiere. Oggi Tirreno Power è
attenta a non coinvolgere De Benedetti nella propria attività. Ogni volta che si
cita l'impianto di Vado e le indagini della magistratura savonese, piovono le
precisazioni: l'Ingegnere è un semplice azionista di minoranza attraverso la
società Sorgenia (gruppo Cir). Non andò così nel 2002, ai tempi
dell'acquisizione dall'Enel. «Interpower al gruppo Cir», titolava Repubblica
attribuendo il successo alla «cordata messa a punto dalla Cir» e in particolare
«ai rapporti personali tra Carlo De Benedetti e Gerard Mestrallet, numero uno
della Suez». Come andarono le cose? Per liberalizzare il mercato dell'energia,
Bersani impose a Enel di non produrre più del 50 per cento dell'elettricità
italiana. La società guidata da Piero Gnudi mise dunque sul mercato una capacità
pari a 15 gigawatt divisa in tre Genco (Generation company). La Genco 1 chiamata
Eurogen (7 gw) andò a Edipower e la seconda, Elettrogen, agli spagnoli di Endesa
(5,5 gw). Alla gara per la terza Genco, Interpower (2,611 gw), furono presentate
19 manifestazioni di interesse da ogni parte del mondo ridotte a quattro offerte
non vincolanti. Ma al dunque, giunse una sola offerta vincolante: quella della
cordata Cir. L'Enel voleva un miliardo di euro, valore calcolato dall'advisor
Mediobanca. De Benedetti offrì poco più di 800 milioni. Enel e governo (allora
guidato da Silvio Berlusconi) chiesero un rilancio. I tempi giocavano a favore
dell'Ingegnere, perché il decreto Bersani imponeva alla cessione una scadenza
che si avvicinava. Enel avrebbe potuto azzerare la gara e chiedere un altro anno
di tempo, come previsto in caso di offerta considerata non congrua. Ma Antitrust
e Authority dell'energia non erano favorevoli. Alla fine il prezzo fu di 874
milioni, compresi 323 di debiti accollati. La cifra corrisponde a circa 336
milioni di euro per gigawatt. Enel incassò complessivamente 8,3 miliardi dalla
cessione di 15 gw: all'incirca 550 milioni per gw. Significa che, per rilevare
la Genco 3, De Benedetti ha sborsato in proporzione molto meno delle cordate per
Genco 1 e 2. L'Ingegnere agiva attraverso la società Energia, di cui controllava
il 74 per cento. I suoi partner nell'operazione furono Acea, municipalizzata del
comune di Roma (allora il sindaco era Walter Veltroni) e i belgi di Electrabel
(gruppo Suez), vecchi avversari quando l'Ingegnere tentò la scalata alla Société
Générale de Belgique: Mestrallet ne era il presidente. Ma i due nel frattempo
erano diventati buoni amici grazie alla comune frequentazione dell'Ert (European
round table), associazione che riunisce i maggiori manager europei.
DEPURATORI E SCARICO IN MARE DELLE ACQUE
REFLUE. A PROPOSITO DEL DEPURATORE CONSORTILE DI SPECCHIARICA.
CONTRO IL DEPURATORE CONSORTILE SAVA-MANDURIA
AD AVETRANA E SCARICO A MARE. LOTTA UNITARIA O FUMO NEGLI OCCHI?
Sentiamo la voce del dissenso dell’Associazione
Contro Tutte le Mafie e dell’Associazione Pro Specchiarica entrambe di Avetrana.
La prima a carattere nazionale e la seconda prettamente di interesse
territoriale. Il perché di un rifiuto a partecipare alla lotta con gli altri,
spiegato dal Dr Antonio Giangrande, componente del direttivo di entrambe le
associazioni avetranesi.
«L’aspetto da affrontare, più che legale (danno
emergente e lucro cessante per il territorio turistico di Avetrana) è
prettamente politico. La gente di Avetrana non si è mobilitata in massa e non vi
è mobilitazione generale, come qualcuno vuole far credere, perché è stufa di
farsi prendere in giro e conosce bene storia e personaggi della vicenda. Hanno
messo su una farsa poco credibile, facendo credere che vi sia unità di intenti.»
Esordisce così, senza giri di parole il dr Antonio Giangrande.
«Partiamo dalla storia del progetto. La spiega
bene il consigliere comunale Arcangelo Durante di Manduria: “Che la
realizzazione a Manduria di un nuovo depuratore delle acque reflue fosse
assolutamente necessario, era già scontato; che la scelta del nuovo depuratore
non sia stata fatta dall’ex sindaco Francesco Massaro, ma da Antonio Calò,
sindaco prima di lui, ha poca importanza. Quello che invece sembra molto grave,
è che il sindaco Massaro, in modo unilaterale, nel verbale del 12 dicembre 2005
in allegato alla determina della Regione Puglia di concessione della Via
(Valutazione d’Impatto Ambientale), senza informare e coinvolgere il consiglio
comunale sul problema, ha indicato il mare di Specchiarica quale recapito finale
del depuratore consortile”. Bene. Da quanto
risulta entrambi gli schieramenti sono coinvolti nell’infausta decisione.
Inoltre questa decisione è mirata a salvaguardare il territorio
savese-manduriano ed a danneggiare Avetrana, in quanto la
localizzazione del depuratore è posta sul litorale di Specchiarica, territorio
di Manduria (a poche centinaia di metri dalla zona residenziale Urmo Belsito,
agro di Avetrana)».
Continua Giangrande, noto autore di saggi con il
suffisso opoli (per denotare una disfunzione) letti in tutto il mondo.
«L’unitarietà della lotta poi è tutta da verificare. Vi sono due schieramenti:
quello di Manduria e quello di Avetrana. Quello di Manduria è composto da un
coordinamento istituito solo a fine maggio 2014 su iniziativa dei Verdi e del
movimento “Giovani per Manduria” con il comitato “No Scarico a mare” di
Manduria. Questo neo coordinamento, precedentemente in antitesi, tollera il sito
dell’impianto, purchè con sistema di filtrazione in tabella IV, ma non lo
scarico in mare; quello di Avetrana si oppone sia alla condotta sottomarina che
alla localizzazione del depuratore sul litorale di Specchiarica. Il comitato di
Avetrana (trattasi di anonimo comitato ed è tutto dire, ma con un solo e
conosciuto uomo al comando, Pino Scarciglia) ha trovato una parvenza d’intesa
fra tutti i partiti, i sindacati e le associazioni interpellate, per la prima
volta sabato 17 maggio 2014, e si schierano compatti (dicono loro), superando
ogni tipo di divisione ideologica e ogni steccato, che sinora avevano reso poco
incisiva la mobilitazione. In mattinata del 17 maggio, il Consiglio Comunale di
Avetrana si è riunito per approvare, all’unanimità, la piattaforma di
rivendicazioni già individuata nella riunione fra il comitato ristretto e i
rappresentanti delle parti sociali. In serata, invece, maggioranza e minoranza
sono saliti insieme sul palco di piazza Giovanni XXIII per rivolgere un appello
alla comunità composta per lo più da forestieri. Si legge nel verbale
dell’ultima riunione del Movimento. “E’ abbastanza chiaro, inoltre, che le
Amministrazioni Comunali di Manduria, che si sono succedute nel tempo da 15 anni
a questa parte, non hanno avuto nè la volontà nè la capacità di modificare o di
bloccare questo obbrobrio, trincerandosi dietro a problematiche e a questioni
tecniche/burocratiche, a parer loro, insormontabili”. Il gruppo di lavoro
unitario avetranese è composto da consiglieri di maggioranza e minoranza (Cosimo
Derinaldis, Antonio Baldari, Pietro Giangrande, Antonio Lanzo, Emanuele Micelli
e Rosaria Petracca). “Vorrei innanzitutto far notare come, finalmente, si stia
superando ogni tipo di steccato politico o ideologico – afferma l’assessore
all’Agricoltura e al Marketing Territoriale, Enzo Tarantino. Steccato veramente
superato? A questo punto reputo poco
credibile una lotta portata avanti da chi, di qualunque schieramento, continui a
fare propaganda politica contrapposta per portare voti a chi è ed è stato
responsabile di questo obbrobrio ai danni dei cittadini e ai danni di un
territorio incontaminato. Quindi faccio mia la domanda proposta da
Arcangelo Durante “Bisogna dire però, che il presidente Vendola è in misura
maggiore responsabile della questione, poichè di recente ha firmato il decreto
di esproprio, nonostante che, prima il consiglio comunale dell’ex
amministrazione Massaro e dopo quello dell’amministrazione Tommasino, si siano
pronunciate all’unanimità contrarie allo scarico a mare. Presidente Vendola, ci
può spiegare come mai, quando si tratta di opere che riguardano altri territori,
vedi la Tav di Val di Susa, reclama con forza l’ascolto e il rispetto dei
cittadini presenti sul territorio; mentre invece, quando si tratta di realizzare
opere che interessano il nostro territorio, (dove lei ha il potere) non
rivendica e utilizza lo stesso criterio, come l’ultimo provvedimento da lei
adottato in qualità di Commissario Straordinario sul Depuratore?”»
A proposito del depuratore consortile con scarico
nel mare incontaminato di Specchiarica.
Un comitato si è formato per fermare quello che il
Comune di Manduria, l'Acquedotto Pugliese e la Regione Puglia vogliono fare in
prossimità della località "Ulmo Belsito", frazione turistica di Avetrana, ossia
il depuratore con lo scarico a mare nella marina incontaminata di Specchiarica,
frazione di Manduria; nessuno, invece, ha mai alzato la voce per obbligare a
fare quello che si ha sacrosanto diritto a pretendere di avere come cittadini e
come contribuenti che sul posto pagano milioni di euro di tributi.
Comunque, i comitati in generale, non questo in
particolare, sono composti da tanti galletti che non fanno mai sorgere il sole e
guidati da personaggi saccenti in cerca di immeritata visibilità o infiltrati
per parte di chi ha interesse a compiere l'opera contro la quale lo stesso
comitato combatte. Questi comitati sono formati da gente compromessa con la
politica e che ha come referenti politici gli stessi che vogliono l'opera
contestata, ovvero nulla fanno per impedirlo. Valli a capire: combattono i
politici che poi voteranno alle elezioni. Spesso, poi, ci sono gli
ambientalisti. Questi a volte non sanno nemmeno cosa significhi amore per la
terra, la flora e la fauna, ma per ideologia impediscono il progresso e
pretendono che si torni all'Età della Pietra. Ambientalisti che però non
disdegnano i compromessi speculativi, tanto da far diventare le nostre terre
ampie distese desertiche tappezzate da pannelli solari che fanno arricchire i
pochi. Pannelli solari che offendono il lavoro dei nostri nonni che hanno
conquistato quei terreni bonificandoli da paludi e macchie. Sicuramente non vi
sono professionisti competenti a intraprendere le azioni legali e giudiziarie
collettive adeguate, anche con l'ausilio delle norme comunitarie. Di sicuro i
membri del comitato non vogliono sborsare un euro e si impelagano in proteste
infruttuose fine a se stesse. Se il singolo può adire il Tar contro un atto
amministrativo che lede un suo interesse legittimo (esproprio), la comunità può
tutelare in sede civile il diritto alla salute ed all'immagine ed alla tutela
del proprio patrimonio.
Per quanto riguarda la costruzione ed il
funzionamento del depuratore vi sono norme attuative regionali che regolano la
materia. A livello nazionale invece, si fa riferimento ai due decreti
legislativi il n. 152/06 (“Norme in materia ambientale”) e il n. 152/99 (recante
“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”) che,
recependo la normativa comunitaria allo scopo di tutelare la qualità delle acque
reflue, disciplinano che gli scarichi idrici urbani siano sottoposti a diverse
tipologie di trattamento in funzione della dimensione degli agglomerati urbani.
Altro è il controllo successivo rispetto ai parametri microbiologici di
riferimento, gli stessi fissati dal D. lgs. 116 del 30 maggio 2008 ad
integrazione del D.p.r. n. 470 dell’ 8 giugno 1982, norma emanata in recepimento
della direttiva 79/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione e ora
sostituita dalla più recente direttiva 2006/7/CE. Il trattamento delle acque
reflue urbane costituisce uno dei punti chiave della politica ambientale
dell’Unione Europea. Gli agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti che
scaricano i loro affluenti in zone particolarmente sensibili (nel nostro caso
l'Area Marina Protetta), dovranno intervenire per rispettare tali obblighi.
Naturalmente questa direttiva rafforza la nostra convinzione che il progetto
della Regione e dell'AQP non dovrebbe neanche essere più discusso. Che senso
avrebbe, infatti, realizzare un'opera faraonica di decine di milioni di euro,
che come ammette la stessa Europa sarebbe dannosa verso l'Ambiente, se sappiamo
che sarà in contrasto con le indicazioni Comunitarie e quindi si dovranno
spendere altri milioni di euro (che avremmo a disposizione se e chissà
quando...), per adeguare il sistema di smaltimento a mare dei reflui fognari
entro tre anni. Cioè quando l'eventuale opera dovrebbe essere appena terminata.
Sarebbe davvero il colmo! Si rafforza, quindi, la necessità di modificare il
piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, ormai superato dai fatti e dal
prossimo quadro normativo dell'Unione Europea, nella direzione auspicata del
riuso in agricoltura e/o per altri usi. Possibile che Regione ed AQP non siano a
conoscenza di tali prossime disposizioni comunitarie e vogliano "buttare a mare"
oltre ai reflui, anche milioni di euro? Comunque in base alla normativa
imminente che incombe, ovvero alla lesione del diritto d’immagine e di
proprietà, vi sono ampi spazi per intraprendere azioni giudiziarie collettive,
anche d’urgenza, senza che ci si avvalga di strumentali proteste fine a se
stesse. Insomma, con l'accidia e la negligenza si fa di tutto per impedire il
turismo e con l'illogica inerzia o mala fede si frena la volontà imprenditoriale
che crea lavoro ed investimenti.
I NOSTRI VELENI QUOTIDIANI.
Il grande assedio al nostro cibo, la salute
minacciata dalle truffe, scrive Monica Rubino su “La Repubblica”. In aumento gli
allarmi legati a cibi potenzialmente pericolosi che nel 2013 sono già stati 268.
L'ultimo caso, il pesto al botulino. Cresce la preoccupazione dei consumatori:
sette famiglie su dieci temono di trovarsi nel piatto sostanze nocive. Ogni anno
una grossa catena di supermercati ritira dai propri scaffali 4-500 prodotti per
motivi diversi. Come funzionano i controlli in Italia e in Europa. L'ultimo
allarme è quello del pesto al botulino. Ed è scattato dallo stesso produttore,
la ditta Ferrari-Bruzzone di Genova: il sospetto è che in alcune migliaia di
vasetti sia contenuto uno dei tipici batteri da intossicazione alimentare, il
clostridium botulinum, che in alcuni casi può portare alla morte. Ma se è vero
che finora il pesto genovese non ha intossicato nessuno, non possiamo
permetterci di abbassare la guardia sulla sicurezza alimentare. Lo dicono i
numeri diffusi dalla Coldiretti che segnala un aumento degli allarmi per cibi
potenzialmente pericolosi che nel 2013 sono già stati 268. I casi riguardano
ogni genere alimentare e agli inganni ai danni del consumatore o del made in
Italy si sommano veri e propri attentati alla salute. Ecco la mozzarella di
bufala prodotta con latte vaccino, gli ormoni usati negli allevamenti, l'olio
deodorato e colorato, il latte contaminato da sostanze cancerogene, le conserve
di San Marzano ricavate da pomodori provenienti da paesi lontani, la carne di
cavallo fatta passare per manzo, fino a uno degli ultimi casi alla ribalta delle
cronache: i frutti di bosco infetti dal virus dell'epatite A. Senza dimenticare
l'emergenza Escherichia Coli, che tanto ha spaventato e confuso i cittadini di
tutta Europa.
Italiani preoccupati. Gli episodi sempre più
frequenti di alterazioni, falsificazioni e contraffazioni di prodotti alimentari
mettono in allerta un numero vastissimo di italiani. Secondo un'indagine di
Accredia (Ente unico di accreditamento) e Censis sul tema della sicurezza e
della certificazione dei prodotti alimentari, quasi 18 milioni di famiglie, pari
al 71% del totale, sono spaventate dalla possibilità di imbattersi in cibo
adulterato, mentre il 70% dichiara di leggere frequentemente le etichette e di
prestare attenzione ai marchi di qualità del cibo che sta per acquistare.
Oltre le contraffazioni: i nemici invisibili. A
spaventare non sono solo le sofisticazioni dei prodotti. I pericoli nel mondo
alimentare non si vedono nel piatto e non si avvertono in bocca, come è accaduto
per l’epidemia di Escherichia coli in Germania. In genere, si tratta di
microrganismi come Salmonella, Listeria, Campylobacter, oppure di aflatossine e
micotossine. Per non parlare della temibile diossina. Il topo nei surgelati o
l'insetto nello yogurt sono eventi rari; mentre la presenza di corpi estranei
nel cibo, le contaminazioni da sostanze pericolose e da batteri patogeni sono
problemi abbastanza diffusi. Ogni anno una grossa catena di supermercati ritira
dagli scaffali 400/500 prodotti alimentari per diversi motivi: etichette
scorrette, difetti di produzione, avviso spedito dall'azienda alimentare. Solo
Carrefour ha iniziato timidamente a pubblicare in rete la lista dei prodotti con
il suo marchio sottoposti a richiamo.
I dati sui controlli. Le cifre di Coldiretti,
elaborate sulla base delle relazioni sul sistema di allerta comunitario, dicono
che nel 2013 sono state 268 le segnalazioni di rischi alimentari arrivate
dall'Italia. La tendenza rispetto al 2012 è in aumento. Un anno fa infatti i
casi furono 517 in totale. In Europa nessun paese dirama più segnalazioni
dell'Italia. Ma è un buon segno. La prova che il nostro sistema dei controlli è
capillare e riesce a scoprire - quasi sempre in tempo - i pericoli che
minacciano i nostri pranzi e le nostre cene. E in otto casi su dieci l'allarme
riguarda un prodotto proveniente dall'estero. Se il 2013 potrebbe concludersi
con più casi rispetto al 2012, l'anno scorso a sua volta è stato peggiore del
precedente. Nella terza edizione del rapporto sull'agropirateria pubblicata
dall'associazione FareAmbiente-Movimento ecologista europeo emerge infatti che
le frodi alimentari sono cresciute del 5% nel 2012 rispetto al 2011, con
sequestri per un valore di 467.653.967 euro. Lo scorso anno, inoltre, sul fronte
delle truffe sul cibo sono state registrate sanzioni amministrative per
18.268.460, ben 36.540 i controlli effettuati e 12.927 gli illeciti riscontrati.
E ancora, 17.546 le sanzioni amministrative, 3612 quelle penali, 10.465 le
persone segnalate all'autorità amministrative, 2096 a quella giudiziaria, 12 gli
arrestati.
Il sistema dei controlli. Dopo lo scandalo mucca
pazza, l'Unione europea si è dotata di un avanzato centro di controllo e allarme
(Rasff), che nel 2012 ha gestito più di 3000 casi. Il Rasff, acronimo inglese di
Rapid alert aystem on food and feed, Sistema di allerta europeo per cibo e
mangimi, è stato inaugurato otto anni fa a Bruxelles per segnalare i prodotti
alimentari contaminati presenti sul mercato. Come ci spiega il Fatto
alimentare.it, sito specializzato in materia, il meccanismo è semplice. Ogni
settimana, le autorità sanitarie dei vari Paesi inviano a Bruxelles l'elenco dei
prodotti esportati, o importati da altri Stati, che sono stati ritirati dal
commercio. L'ufficio raccoglie le informazioni e le dirama in rete con tutti i
riferimenti per procedere al blocco delle merci. In Italia le notifiche arrivano
al ministero della Salute che le smista alle Asl, cui spetta il compito di
contattare le aziende e i punti vendita per procedere al ritiro del prodotto. I
problemi più diffusi riguardano la presenza di micotossine nella frutta secca
importata da paesi extra-Ue, la contaminazione da Salmonella e Campylocter nelle
carni. Altri elementi abbastanza frequenti sono la presenza del batterio
Listeria nel salmone affumicato, mentre il pesce spada in arrivo dalla Spagna e
dal Vietnam contiene spesso mercurio. Sono anche frequenti i ritiri di
gamberetti e crostacei importati dal Sud-Est asiatico, trattati con additivi non
consentiti. A volte le motivazioni del ritiro sono più banali, come la presenza
di micotossine nei semi di arachidi e nei pistacchi.
Le segnalazioni vengono classificate dal Rasff in
tre categorie.
Allarme. Si tratta del livello più urgente e
richiede un intervento rapido da parte delle autorità sanitarie. La notifica
viene inviata a Bruxelles entro 48 ore dal momento in cui lo Stato viene a
conoscenza e deve essere diffusa entro 24 ore.
Informazione. È una segnalazione di routine e
riguarda il ritiro di un prodotto con un livello di rischio che non richiede
un'azione rapida.
Respingimenti alla frontiera. Si tratta di merci
importate da Paesi extra-Ue bloccate dalle autorità sanitarie alla frontiera,
che non arrivano al dettaglio. Le segnalazioni settimanali del Rasff oscillano
da 60 a 80 e riguardano solo la merce importata o esportata. A questo gruppo si
aggiungono centinaia di altri ritiri e sequestri che le autorità sanitarie
effettuano per prodotti alimentari fuori norma commercializzati all'interno del
loro Paese.
Il ruolo dell'Efsa. A livello europeo il primo
passo verso la comunicazione del rischio è stato l'istituzione dell'Autorità
europea per la sicurezza alimentare (European food safety authority), che ha
sede a Parma. Come agenzia indipendente, si presta a offrire ai consumatori
informazioni obiettive e attendibili, basate su dati scientifici aggiornati, in
merito ai rischi sulla catena alimentare. Dall'aspartame agli ogm, dai pesticidi
al bisfenolo, dagli integratori agli additivi alimentari come i coloranti, fino
ai fabbisogni nutrizionali: sul sito internet dell'agenzia sono disponibili
tutti i pareri scientifici delle varie commissioni e molteplici indicazioni sui
temi di attualità.
Le falle nel sistema: il caso delle mozzarelle
blu. Non sempre il sistema di allerta funziona come dovrebbe. Ce lo spiega
Roberto La Pira, direttore del Fatto Alimentare: "Nel caso delle mozzarelle blu,
la prima segnalazione italiana inviata al Rasff di Bruxelles è datata 9 giugno
2011, e riguarda lotti della società tedesca Milchwerk Jager Gmbh & Co venduta a
Verona. Il sistema però si inceppa perché l'azienda tedesca non si attiva, non
avverte i fornitori e quindi non si procede al ritiro immediato". Una settimana
dopo, il 17 giugno, a Torino, una signora fotografa il corpo del reato, si
rivolge alle Asl e la notizia arriva ai giornali. "Da quel momento - continua
La Pira - la mozzarella blu diventa una notizia da prima pagina. La vicenda si
trasforma in un evento nazionale perché l'azienda casearia tedesca non rispetta
le regole. La lista con i marchi delle mozzarelle contaminate vendute in 13
paesi viene comunicata solo dopo due settimane, nonostante l'invio di tre
richieste da parte del ministero della Salute italiano per avere informazioni
precise sui prodotti coinvolti".
Il Piano del ministero della Salute. Da noi c'è un
documento vasto e articolato che riassume i dati di tutti i controlli effettuati
su sicurezza alimentare e qualità merceologica di cibi e bevande. Si tratta del
Piano nazionale Integrato (Pni o Mancp), che nel rispetto del Regolamento (CE)
n.882/2004, descrive il "Sistema Italia" dei controlli ufficiali in materia di
alimenti, mangimi, benessere animale e sanità delle piante ed ha una durata
triennale (2011-2014). Il Piano costituisce il livello massimo di coordinamento
tra tutte le numerose autorità che vigilano sulle catene di produzione e
commercializzazione dei nostri alimenti. Di sicurezza e nutrizione, per esempio,
si occupano il ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome, le Asl
e i Nas (nuclei antisofisticazioni) dei Carabinieri. Un dato aiuta a capire la
portata del fenomeno: nelle Asl della sola Emilia Romagna, il personale deputato
ai controlli di sicurezza alimentare - tra medici igienisti, medici veterinari
e tecnici della prevenzione - ammonta a oltre 800 persone. Di qualità
merceologica, invece, si occupano il ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, le Capitanerie di porto, i Nac (nuclei antifrodi dei
Carabinieri) e la Forestale. Senza contare il coinvolgimento generale delle
autorità doganali e della Guardia di Finanza. Una macchina complessa, dunque,
impegnata in un'azione capillare e quotidiana sul territorio.
Mense e ristoranti. "Uno dei principali strumenti
per combattere le frodi - ha spiegato Vincenzo Pepe presidente nazionale di
FareAmbiente - è la tracciabilità degli alimenti, anche nei menù degli esercizi
pubblici". Per questo l'associazione è tra i promotori di una proposta di legge
sulla tracciabilità dei prodotti nelle mense e nei ristoranti: "Dai dati
raccolti sui controlli effettuati dalle diverse forze dell'ordine - ha
aggiunto Pepe - si è visto che uno dei settori più problematici ed esposti
alle truffe è proprio quello della ristorazione. Per questo proponiamo di
realizzare un sistema informatico per tracciare i prodotti utilizzati nei menu
dei ristoranti e un apparato informativo che consenta di leggere meglio le
etichette e le allert rapide dell'Ue".
Ue, nuove etichette alimentari, più dettagli e più
sicurezza.
Un regolamento della Commissione stabilisce tutte
le caratteristiche dei fogli che accompagnano i cibi, dalle calorie alle
indicazioni del paese di provenienza, scrive Monica Rubino su “La Repubblica”.
Dopo 32 anni di onorato servizio va in pensione la vecchia direttiva sulle
etichette alimentari (la 79/112/CEE), sostituita da un un nuovo regolamento (UE
1169/2011 ), varato dalla Commissione europea. Dopo anni di dibattiti è arrivata
finalmente una legge univoca, tradotta nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione
(dal 1° luglio 2013 si è aggiunto il croato), da applicare contestualmente in
tutti gli stati membri. La riforma europea dell'etichetta ha lo scopo di
armonizzare tutte le norme nazionali su tre fronti: la presentazione e la
pubblicità degli alimenti, l'indicazione corretta dei principi nutritivi e del
relativo apporto calorico e l'informazione sulla presenza di ingredienti che
possono provocare allergie. Il regolamento si compone di 55 articoli e descrive
in modo molto dettagliato quali devono essere le indicazioni da fornire ai
consumatori. In breve, l'intento è rafforzare la salvaguardia della salute dei
cittadini senza intaccare la libera circolazione delle merci - preoccupazione
costante di Bruxelles. I paesi Ue hanno ancora un anno e mezzo di tempo per
adeguarsi alle nuove norme, che entreranno in vigore inderogabilmente il 13
dicembre 2014.
Ecco allora le principali novità sulle etichette
dei prodotti che metteremo nel carrello.
Tabella nutrizionale. Oltre agli ingredienti di
cui è costituito un alimento, è importante che vengano indicate le calorie in
esso contenute. Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale
con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati,
proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà
essere affiancata da dati riferiti a una singola porzione. Si possono utilizzare
altri schemi come i semafori attualmente in auge nel Regno Unito, solo se di
facile comprensione. L’eccesso di consumo di sale può provocare dei problemi
alla salute, per questo si deve evitare la dicitura "cloruro di sodio" e
scrivere più semplicemente "sale". Entro tre anni, inoltre, sarà necessario
stabilire nuove norme per l’etichettatura dei prodotti contenenti alcol.
Caratteristiche delle scritte. Le diciture devono
avere un carattere tipografico di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).
Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative
all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di
vendita. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è
sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni
eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione ("da
consumarsi preferibilmente entro …") o data di scadenza ("da consumarsi entro
…"). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad
esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta del
consumatore.
Indicazione d'origine. È obbligatorio indicare il
Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e
il pollame (l’obbligo scatta entro due anni dall'entrata in vigore del
regolamento). La Commissione europea valuterà entro il 2016 se estendere
l’origine a latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente e ad alcuni
ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella
preparazione di altri cibi, o altri quando rappresentano più del 50%
dell’alimento. Tuttavia i legislatori nazionali potranno introdurre ulteriori
prescrizioni sulla provenienza quando esista "un nesso tra qualità dell'alimento
e la sua origine", come nel caso delle indicazioni geografiche italiane DOP e
IGP. Inoltre l'informazione sull'origine del prodotto è obbligatoria quando la
sua omissione possa indurre in errore il consumatore, ad esempio nel caso di una
mozzarella fabbricata in Germania e venduta in Italia. Una precisazione utile a
ostacolare il fenomeno dell'Italian sounding, ossia alimenti presentati come
made in Italy ma fabbricati altrove.
Surgelati. Un alimento congelato o surgelato
venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola "scongelato".
Preparati a base di carne e pesce. La carne, le
preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti,
fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore
al 5% devono indicarne la presenza sull’etichetta. Le porzioni, i filetti o le
preparazioni composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi, devono
specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più parti (per
esempio: la carne separata meccanicamente).
Insaccati. I salumi insaccati devono indicare
quando l’involucro non è commestibile.
Sostanze allergizzanti. Gli allergeni devono
essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici
(grassetto o colore).
Oli e grassi. La scritta "oli e grassi" deve
essere abbinata all’indicazione del tipo di olio o grasso utilizzato (es. soia,
palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura "in proporzione
variabile". Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, inoltre,
verrà redatto un rapporto per valutare l’opportunità di riportare la presenza di
acidi grassi 'trans' (una tipologia di grassi insaturi, i cosiddetti TFA's)
nella tabella nutrizionale.
Caffeina. Le bevande diverse da tè, caffè e dai
drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono
riportare sull'etichetta, oltre alla scritta "Tenore elevato di caffeina"
(introdotta nel 2003), anche l’avvertenza "Non raccomandato per bambini e donne
in gravidanza o nel periodo di allattamento".
Scadenza. La data di scadenza deve essere
riportata, oltre che sulla scatole, anche sull'incarto interno del cibo. La
carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati
non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o
del congelamento.
Rimangono esclusi dal regolamento le bevande
alcoliche, gli alimenti sfusi (come l'ortofrutta) e quelli pre-incartati dai
supermercati, come carni, formaggi e salumi che la grande distribuzione
"porziona", avvolge nel cellophane e colloca sui banchi di vendita. Per cinque
anni dall'entrata in vigore verrà fatto un monitoraggio per verificare
l'applicazione delle nuove norme che, se sarà necessario, potranno essere
aggiornate alla luce delle informazioni acquisite.
GLI SCANDALI CHE HANNO SPAVENTATO L'ITALIA.
Metanolo, mucca pazza, maiali alla diossina,
scrive Federica Formica su “La Repubblica”.
1. VINO AL METANOLO - 1986. Il primo grande
scandalo alimentare italiano colpisce al cuore uno dei nostri prodotti più
amati, sia in patria che all'estero: il vino. Tutto nasce dalla sofisticazione
di un vino di bassa qualità: per alzarne la gradazione alcolica i produttori
aumentavano infatti la concentrazione di metanolo, trasformando la bevanda in un
veleno mortale. Il bilancio è gravissimo: 19 morti tra Lombardia, Liguria e
Piemonte. Diverse altre persone hanno subito danni permanenti alla vista. Il
metanolo, infatti, è un prodotto naturale della fermentazione dell'uva e in
piccole quantità è innocuo. Nelle bottiglie, che nella maggior parte provenivano
da cantine del Nord Italia questa sostanza era presente molto al di sopra della
soglia minima consentita. Il composto che ha ucciso quei 19 consumatori,
oltretutto, normalmente era usato per le vernici. Lo scandalo fu talmente grave
che il personale dei Nas (nati nel 1962) è stato quadruplicato subito dopo la
fine della vicenda.
2. MUCCA PAZZA - 2000. Esaurita la psicosi
collettiva del millennium bug, ecco che ne arriva un'altra, stavolta molto più
seria. Tra il 2000 e il 2001 si diffonde dal Regno Unito la notizia che decine
di migliaia di mucche, alimentate con farine prodotte con carcasse di animali
infetti, avevano contratto la Bse (encefalopatia spongiforme bovina). Una
malattia neurologica degenerativa che portava gli animali a stati di ansia e
forte aggressività: da qui termine "mucca pazza". La malattia, però, si poteva
trasmettere all'uomo, che consumando carne infetta rischiava di contrarre una
variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob (vCJD), un male incurabile. Nonostante
gli allarmismi, comunque, le vittime della vCJD saranno 41 in tutto: 40 in
Inghilterra e una in Francia. Nessuna in Italia. Tutti gli altri casi sono
risultati slegati dal consumo di carne bovina. Tuttavia, la Bse almeno qualcosa
di buono lo ha portato: da allora l'Italia ha istituito l'anagrafe bovina e
l'etichettatura delle carne bovine, per consentire al consumatore di verificarne
la provenienza.
3. INFLUENZA AVIARIA - 2003. La malattia dei
volatili è nota da oltre un secolo. Nel 2003, però, viene accertato che un ceppo
- il virus H5N1 - si può trasmettere anche agli umani. Sviluppatosi nel Sudest
asiatico, il virus si è diffuso in tutta l'Asia per poi arrivare anche in
Europa, Italia compresa. I sintomi per gli esseri umani sono quelli di una forte
influenza che, in alcuni casi, può portare anche alla morte. Oltre a diffondersi
con grande rapidità, H5N1 è un virus in grado di attaccare diverse specie:
uccelli, uomini, maiali, ma anche gatti e topi moltiplicando così il rischio di
pandemia. In Italia l'impatto dell'aviaria è bassissimo, ma l'allarme che si è
generato ha comunque portato a un crollo dei consumi di pollo, tacchino e
galline. Contro l’aviaria nel 2005 è stata introdotta in Italia l’etichettatura
del pollame nazionale che ricostruisce tutta la storia del prodotto,
dall'allevamento alla distribuzione.
4. MAIALI E DIOSSINA - 2008 E 2011. Nel 2008 tocca
ai maiali: alcuni animali allevati in Irlanda presentano tracce di diossina -
una sostanza cancerogena - superiori anche di cento volte ai limiti massimi
consentiti all'interno dell'Unione Europea. Le autorità irlandesi ritirano tutta
la carne suina prodotta sull'isola e l'allarme si estende in tutta Europa. Nel
2011 succede più o meno la stessa cosa, ma in quel caso la carne di maiale è
tedesca. E la diossina è presente anche in tacchini, galline e, di conseguenza,
uova. In entrambi i casi la sostanza nociva proviene da mangimi contaminati. Nel
caso della Germania all'origine dello scandalo c'era una partita di olii
prodotti da una fabbrica di bio-diesel e utilizzati per produrre il mangime.
5. FEBBRE SUINA - 2009. Il quadriennio 2008-2011 è
un inferno per i produttori di carne suina. Nel 2009 lo scandalo diossina nei
maiali irlandesi è ancora caldo, quando si sviluppa una nuova psicosi. Dal
Messico, infatti, circa 20 persone sono morte a causa di una forte influenza (un
sottotipo della A) trasmessa proprio dai maiali. Nei primi giorni il Messico
arriva a sospendere ogni attività pubblica per limitare il contagio. Ma ormai è
troppo tardi: il virus AH1N1 arriva presto anche in Italia, dove la percentuale
di decessi è però inferiore persino rispetto alla normale influenza. C'è però
una profonda differenza tra la "swine flu", e il caso Mucca Pazza: la febbre
suina non si trasmette mangiando carne infetta (la cottura elimina il virus) ma
come una normale influenza. Cioè soprattutto per via aerea. Sulle etichette
delle carni di maiale, di cavallo e di pecora e capra (eccetto eventuali DOP o
IGP) non è obbligatorio indicare l’origine sino all’entrata in vigore del nuovo
regolamento UE n. 1169/2011. Occorre attendere quindi fino il 13 dicembre 2014
per la sua applicazione.
6. MOZZARELLA BLU - 2010. Aprire il frigorifero,
scartare una mozzarella e accorgersi che il candore ha lasciato il posto a
un'inquietante colorazione bluastra. E' successo a due donne di Trento e Torino.
Ed è stato il principio di un nuovo tormentone alimentare che non si è ancora
del tutto spento. Dietro allo scandalo della mozzarella blu c'è quasi sempre un
batterio, lo Pseudomonas Fluorescens, che non ha alcun effetto nocivo sulla
salute dell'uomo. Ma al di là dei rischi, inesistenti, la mozzarella blu ha
indotto i consumatori a riflettere sulle condizioni igieniche con cui vengono
prodotti gli alimenti. Il batterio infatti entra nella filiera proprio durante
la lavorazione attraverso le acque di raffreddamento o perché i locali non sono
sterili.
7. OLIO DEODORATO. E' una pratica piuttosto
diffusa da anni: chi produce un olio di qualità inferiore - succede soprattutto
quando tra raccolta e spremitura delle olive passa molto tempo - lo riscalda
leggermente per togliere il cattivo odore che si crea. L'obiettivo: camuffare un
normale olio di oliva da "extravergine di oliva", con maggiore valore
commerciale proprio perché di miglior qualità. E' sempre stato molto difficile
scoprire queste frodi ma dall'università di Bologna potrebbe essere arrivata una
svolta: i ricercatori hanno individuato un particolare tipo di analisi chimiche
dalle quali si riescono a individuare gli olii "taroccati". Nel frattempo, per
tutelare i produttori italiani, l'Unione Europea ha stabilito regole piuttosto
ferree sull'etichettatura dell'olio che entreranno in vigore dal 2014. Origine e
categoria commerciale dovranno essere ben visibili e le nuove bottiglie avranno
un metodo di chiusura che impedirà il riutilizzo dopo l'esaurimento del
contenuto originale.
8. ESCHERICHIA COLI - 2008 e 2010. Nella galleria
degli scandali c'è spazio anche per il latte. Sia nel 2008 che nel 2010 alcuni
bambini si ammalano di sindrome emolitico-uremica, un'infezione renale molto
grave. In entrambi i casi, il responsabile viene individuato nel latte crudo.
Latte che viene venduto senza pastorizzazione e - spesso - bevuto senza
bollitura. L'infezione è provocata dal batterio dell'Escherichia coli, che vive
"ospite" nell'intestino delle mucche senza causare alcun sintomo. Il guaio,
però, è quando le mucche vengono munte senza una pulizia perfetta delle
mammelle, che durante la giornata si trovano spesso a contatto con le feci. Nel
2010 si ammalano 40 bambini; una bimba muore.
9. CARNE DI CAVALLO - 2013. In pieno inverno 2013
gli italiani scoprono che non si può stare tranquilli neanche con i ravioli e i
tortellini. La Nestlè infatti è costretta a ritirare due prodotti dai
supermercati di Italia, Spagna, Francia e Portogallo. Il motivo? Nel ripieno di
carne, che teoricamente sarebbe dovuto essere 100% manzo, vengono trovate tracce
minime di carne di cavallo. Di per sé il fatto non costituisce un pericolo per
la salute dell'uomo, ma una frode commerciale. I dubbi sulla salute però
rimangono: il sospetto che i cavalli macellati provenissero dal mondo delle
corse è forte. In questo caso i rischi vengono dagli anti-infiammatori che gli
animali da competizione assumono nel corso della loro carriera. Non a caso i
cavalli da corsa non possono entrare in alcun modo nel circuito alimentare. In
Italia, però, i Nas non trovano alcuna traccia né di anti-infiammatori né di
sostanze dopanti neanche nei prodotti ritirati dal mercato.
10. FRUTTI DI BOSCO ED EPATITE A - 2013. L'ultimo
allarme a livello europeo in termini di tempo è quello dei frutti di bosco
contaminati con il virus dell'epatite A. Tutto nasce da una segnalazione della
Danimarca, che osserva un aumento anomalo di casi di epatite A attribuendo la
responsabilità a un frullato a base di frutti di bosco congelati. In breve anche
altri paesi europei - tra i quali il nostro - osservano la stessa anomalia e
anche dagli scaffali dei supermercati italiani vengono ritirati alcuni prodotti
a rischio. All'origine di tutto ci sarebbero frutti di bosco provenienti da
Bulgaria, Polonia, Serbia e Canada. Intanto nel Trentino Alto Adige sono stati
registrati 27 contagi solo nei primi cinque mesi dell'anno. Cifre sproporzionate
rispetto alla normalità.
OGGETTI PERICOLOSI INTORNO A NOI.
Siamo circondati da oggetti pericolosi. Triplicati
i sequestri di prodotti tossici, scrive Valeria Ferrante su “La Repubblica”.
Solo nei primi sei mesi del 2013 sono state bloccate dai Nas 848 mila merci
fuori regola e con sostanze chimiche rischiose soprattutto per i bambini. Se non
ci sarà un'inversione di tendenza il bilancio finale porterà a 1 milione e 800
mila i 600 mila oggetti interdetti l'anno scorso. Un aumento dei controlli. Ma
soprattutto un segnale dell'aumento degli agguati alla nostra salute. Scarpe,
abiti, borse. Oggetti di bigiotteria. Piastre per capelli. Contenitori monouso
per il cibo. Padelle, scodelle, cucchiai in plastica. Pellicole trasparenti.
Accendini. Prodotti cosmetici. Coprivolante, candele decorative. Ecco i nostri
veleni quotidiani. Privi di etichettatura in lingua italiana. Pericolosi per la
loro somiglianza con alimenti. A rischio chimico se a contatto con l'organismo o
i cibi. Sprovvisti di marchiatura CE, o con il marchio contraffatto, per trarre
in inganno gli acquirenti. Solo nei primi sei mesi del 2013, 848.697 prodotti
sono stati sequestrati dal Comando dei Carabinieri Tutela per la Salute (Nas),
per un valore di 6.491.000 euro. Tutta merce senza le obbligatorie norme di
sicurezza e con sostanze chimiche in percentuali pericolose. Un fenomeno
decisamente in crescita rispetto al 2012, quando i sequestri eseguiti dal Nas
erano stati in tutto 603.298. Un aumento dei controlli, certo, ma anche e
soprattutto un segnale della crescita dei prodotti rischiosi: mantenendo questo
ritmo il risultato finale sarà quasi triplicato rispetto ai dodici mesi
precedenti. Negli utensili che circondano la nostra vita in cucina. Nelle
stoviglie che abitualmente adoperiamo. Nelle giacche, nei pantaloni, nelle
magliette, nell'intimo, con i quali ci vestiamo. In quegli orecchini, nelle
collane, nei bracciali che amiamo indossare. In ognuno di questi oggetti è stato
trovato di tutto. Nichel nei bijoux e nelle scarpe. Cromo, in alcuni stivaletti
di pelle. Piombo, nelle scatole composte da carta riciclata, in cui viene chiusa
la pizza d'asporto. Formaldeide nelle ciotole in plastica. Mercurio su rossetti,
ombretti, smalti per unghie, cosmetici e creme schiarenti. Un lungo e
dettagliato elenco che chiunque può consultare sul sito del ministero della
Salute dove puntualmente si segnalano ( e si aggiornano) tutti quei prodotti a
rischio e ritirati dal commercio, con il decisivo contributo delle attività di
controllo delle forze dell'ordine (oltre ai Nas è impegnata la Guardia di
Finanza) e le analisi di laboratorio effettuate dall'Istituto Superiore della
Sanità.
La classifica. Un problema che non interessa
solamente l'Italia ma tutta l'Unione Europea. Secondo il rapporto RAPEX 2012
sono state 2.278 le misure prese contro i prodotti pericolosi (non alimentari)
commercializzati fra gli Stati dell'Eurozona. Le notifiche sono avvenute proprio
grazie al sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari,
chiamato Rapex, che ha registrato una crescita del 26% rispetto al 2011. In cima
alla classifica delle merci con sostanze chimiche nei confronti dei quali sono
state prese misure correttive, ci sono vestiti e capi di moda, apparecchiature
elettriche, veicoli a motore, cosmetici. Nella maggioranza dei casi si tratta di
di oggetti di consumo provenienti da paesi extraeuropoei. In particolare: Cina,
Indonesia, Hong Kong, Taiwan, Malesia. "Quando si parla di stanze chimiche
bisogna stare attenti", spiega la dottoressa Rosaria Milana dell'Istituto
Superiore di Sanità. "Nessun oggetto che entra in contatto con il consumatore è
inerte. Questo è un concetto importante perché in chimica non esiste
l'immobilità tra gli elementi, c'è sempre un'interazione: più usiamo un oggetto,
più le sostanze sono migrabili. Bisogna anche dire che non esiste un prodotto
che sia tossico in assoluto. Tutto dipende sempre dal contatto, dall'uso che se
ne fa e dal soggetto a cui è destinata la merce. Per esempio se si tratta di un
adulto o di un bambino. Negli oggetti esistono dei livelli, stabiliti attraverso
studi e sperimentazioni, da rispettare per salvaguardare la salute degli esseri
umani, ed evitare quindi l'eccesiva migrabilità delle sostanze e di conseguenza
la loro contaminazione". Criteri di sicurezza che purtroppo non sempre vengono
rispettati. Così un'innocua scodella di plastica dura, acquistata al mercato,
può rilasciare percentuali eccessive di formaldeide. "Nel caso delle ciotole da
noi analizzate", precisa Milana, "provenienti quasi tutte dalla Cina, i livelli
di tossicità, e quindi il rischio chimico, va considerato a lungo termine. Non
esistono cioè veleni acuti, ma percentuali minime; parliamo di milligrammi che
distribuiti nel tempo e assimilati di volta in volta dall'organismo, possono
creare problemi più o meno gravi a seconda della sensibilità di ciascun
individuo, peso corporeo, età".
I più esposti. I bambini restano i soggetti più
esposti. La maggior parte degli allarmi riguardano prodotti loro rivolti. Sempre
secondo il rapporto Rapex 2012, i rischi maggiori si trovano nel 19% dei casi
nei giocattoli. Anche per questa categoria l'elenco fornito dal ministero della
Salute è purtroppo lungo. Spade di plastica al cromo, bolle di sapone con
batteri mesofili (psedomonas aeruginosa) in grado di provocare infezioni. Torce
elettriche, come gadget-sorpresa racchiusi all'interno di patatine e uova di
Pasqua, che si surriscaldano e si sciolgono. Giocattoli con sostanze pericolose
(come acetofenone, isottanolo, cromo) rilevate nelle confezioni di plastica e
classificate irritanti se poste a contatto con gli occhi o ingerite. Così quella
splendida principessa da vestire con abiti scintillanti, quei teneri bambolotti
da coccolare, quelle colorate maschere con cui travestirsi a Carnevale, quelle
eroine e supereroi che appassionano e fanno sognare schiere di bambini, possono
trasformarsi in potenziali mostri "farciti"di ftalati dalla testa ai piedi. Si
tratta di composti chimici usati come agenti plastificanti, per modellare i
giocattoli e renderli più morbidi. L'allarme aumenta in modo considerevole a
seconda dei periodi dell'anno: durante le vacanze estive (quando si usano
braccioli e materassini), alla ripresa della scuola (per gli zainetti, le
matite, le gomme per cancellare), le festività natalizie (con i giocattoli, 60
mila dei quali sequestrati dai Nas solo nel 2012), il periodo di Carnevale.
Tutte occasioni legate all'acquisto di doni e giocattoli. Il ministero della
Salute li considera periodi di massima attenzione la nostra difesa. Ha redatto
una sorta di guida sui prodotti a rischio e sui comportamenti da adottare. Si
può consultare online ed è scaricabile in pdf. Il titolo spiega tutto:
"Attenzione agli ftalati. Difendiamo i nostri bambini".
I sequestri. "Le verifiche, gli accertamenti, i
sequestri sono costanti", spiega il capitano Dario Praturlon, ufficiale dei
carabinieri del Nas. "Facciamo ispezioni presso i distributori e i negozianti.
Molti prodotti per fortuna vengono immediatamente bloccati alla dogana. In
questo modo si evita che entrino nel territorio italiano e vengano
commercializzati". È il caso dei container sequestrati, nel porto di La Spezia,
pieni di confezioni di "bolle di sapone", provenienti dalla Repubblica Popolare
Cinese ed importati da un operatore commerciale fiorentino. Prodotti privi di
idonea certificazione sanitaria, nei quali sono state evidenziate massicce
presenze di microrganismi (tra i quali il micidiale "pseudomonas aeruginosa") in
quantità tale da costituire un concreto pericolo per la salute pubblica. Persino
i "tappetini a mattoncini" dove i bambini di un anno di solito gattonano e
giocano, sono stati ritirati dal commercio per la presenza, nell'amalgama
plastica, di sostanze chimiche (acetofenone ed isoottanolo), irritanti e
tossiche se ingerite. Cosa fare? Come comportarsi? Come difendersi da pericoli
invisibili ma spesso presenti? "Ci vuole molta prudenza", suggerisce il capitano
Praturlon. "Bisogna sempre acquistare i giocattoli nei negozi specializzati,
autorizzati, di fiducia". La fretta, le occasioni, i facili risparmi possono
essere deleteri. "Evitate i rivenditori estemporanei", esorta l'investigatore.
"Verificate sempre la presenza di istruzioni in italiano, soprattutto in fatto
di precauzioni e modalità d'impiego. Accertate la presenza della certificazione
CE. Diffidate dei prezzi troppo bassi". Suggerimento quest'ultimo difficile da
seguire, soprattutto per una famiglia in cui, pur di non negare un gioco al
proprio bambino, si compra, ma cercando di risparmiare.
Creme al mercurio e rossetti al piombo, scrive
Valeria Ferrante su “La Repubblica”. Cresce la richiesta di prodotti schiarenti.
Soprattutto su internet. Ma nella maggior parte dei casi di tratta di materiale
insicuro nel quale, spesso, sono state scoperte alte concentrazioni di sostanze
velenose, come l'idrochinone il cui uso è vietato. Ma il loro uso alla fine crea
delle vere e proprie dipendenze che genera malattie di tipo psicologico. Tanto
che oggi si comincia a parlare di "bulimia da cosmetici". G. ha vent'anni e una
carnagione olivastra. Ma ha deciso di diventare bionda e quindi pensa di dover
schiarire il più possibile il colore naturale del suo viso. C'è poi B. che
vorrebbe a tutti i costi eliminare le fastidiose macchie scure formatesi sulla
pelle. C'è la trentaseienne R. che dichiara guerra al sole e ai raggi UV. E per
questo pensa che bisogna mantenere, in ogni modo, la pelle chiara. Infine fra la
folta schiera di donne di colore c'è chi considera necessario, per superare
discriminazioni razziali ed essere accettate nelle società occidentali,
sbiancare il più possibile la pelle scura. La richiesta di cosmetici schiarenti
è in continua crescita. Ma non sempre si tratta di prodotti sicuri. Anzi. In
molte di queste lozioni sono state trovate alte percentuali di mercurio, tanto
da destare serie preoccupazioni e indurre l'Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) ad intervenire. Tra i maggiori prodotti ritirati dal mercato dell'Unione
Europea nel 2012 ci sono proprio gli sbiancanti per la pelle: contenevano
idrochinone, il cui uso è vietato nei cosmetici e nei prodotti per l'igiene
personale. All'appello non mancano certo i makeup per le più piccole: kit
cosmetici, dedicati alle bambine, trovati privi delle prescritte indicazioni in
etichetta, di marcatura CE. Sono risultati pieni di nichel e piombo. La
pubblicizzazione e la vendita di questi prodotti avvengono anche su internet; ed
è sulla rete, attraverso siti, forum, blog, video, che molte donne si scambiano
opinioni, consigli, suggerimenti. Parole, frasi che rivelano, spesso sotto
traccia, il sintomo di un malessere più diffuso di quello che sembra che
andrebbe affrontato non tanto con delle lozioni, tra l'altro non del tutto
sicure, ma con il contributo di esperti. Il ricorso a qualsiasi tipo di cosmesi,
quando non è oculato, libero da implicazioni psicologiche, aspettative
miracolose, è un boomerang: genera vere e proprie dipendenze. È un disagio
sottovalutato e sottostimato, mentre invece risulta diffusissimo tra adolescenti
e donne più mature. Non è un caso che si cominci a parlare di "vittime da
cosmetici", "bulimia da cosmetici". Anche in questo caso basta consultare i
tanti forum al femminile presenti su internet per farsi un'idea. Nell'universo
dei prodotti estetici, soprattutto quelli non convenzionali, non prodotti nei
paesi UE (nonostante esistano purtroppo delle eccezioni) è bene muoversi con
cautela. Il rischio è incorrere in prodotti che possono rivelarsi di scarsa
qualità o peggio dannosi quando le sostanze contenute non sono nelle percentuali
giuste, non sono autorizzate o non sono riportate correttamente nell'INCI
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), denominazione
internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti del
prodotto cosmetico. L'Organizzazione mondiale della sanità ha infatti lanciato
un allarme: "Attenzione a creme e saponi, soprattutto quelle acquistabili sul
mercato online". Alcuni prodotti contenevano mercurio come agente attivo. Il
mercurio è un metallo, può procurare danni ai reni, alla pelle, perché tossico.
Eppure c'è ancora chi lo usa nei prodotti detergenti per gli occhi, come il
mascara o le creme schiarenti, dove può provocare: decolorazione, cicatrici,
riduzione della resistenza della pelle a infezioni batteriche e fungine.
L'utilizzo del mercurio è stato proibito sia nell'Unione Europea che in varie
nazioni africane, dove il fenomeno della decolorizzazione è maggiormente
diffuso, mentre i sali di mercurio fenile per i trucchi e i detergenti degli
occhi sono consentiti in concentrazioni fino allo 0.007%. Negli Stati Uniti
invece la concentrazione è di 65 mg/kg. In Italia il consiglio lanciato dal
Ministero della Salute è identico ad altri del settore: "Leggere sempre le
etichette". Ma chi ha delle conoscenze chimiche elementari o nulle, come può
decifrare le composizioni presenti in un flaconcino beauty per il viso, corpo,
capelli? Sembra un'impresa impossibile. "In questo caso conviene scegliere
prodotti di qualità, in grado di offrire garanzie al consumatore", spiega la
dottoressa Rosaria Milana, dell'Istituto Superiore della Sanità. Il punto però è
che con una riduzione delle possibilità economiche da parte degli acquirenti,
comprare prodotti di marca, in genere costosi, diventa difficile. E spesso pur
di mantenere una certa abitudine legata al benessere personale o a esigenze
estetiche, si ricorre a prodotti sconosciuti, sottomarche distribuite un po'
ovunque. Ed è così che si può diventare facilmente vittime del prodotto
acquistato. Un'azienda, nella provincia di Bologna, si era improvvisata
nell'attività di produzione e confezionamento di cosmetici. Creme di bellezza, a
basso costo: "Utilizzavano materie prime, di provenienza tedesca e cinese",
ricordano i carabinieri dei Nas di Bologna, "senza disporre di personale
qualificato, né dei prescritti dossier tecnici, relativi alle caratteristiche ed
alla composizione dei prodotti". Il lavoro dei militari, sempre più attivi sui
sequestri, sembra però vanificato da abitudini difficili da cambiare. Il settore
della cosmetica è tra i pochissimi a non essere toccato dalla crisi. Donne e
uomini spendono sempre molto per la cura del proprio corpo. E chi non se la può
permettere è anche disposto a mettere a rischio la salute.
Dilagano i traffici dei rifiuti tossici nelle
fabbriche dei lavoratori in nero, scrive ancora Valeria Ferrante. La
delocalizzazione di migliaia di industrie ha lasciato il posto ad altrettante
aziende con manodopera clandestina. Tutto questo ha incrementato il sommerso,
azzerato le misure di prevenzione, aumentato i rischi per la salute dei
lavoratori. Con smaltimento in roghi velenosi delle sostanze nocive utilizzate,
inquinamento dell'aria, del terreno, delle falde acquifere. Un pericolo che ci
riguarda tutti. Nell'ultimo anno e mezzo la recessione ha investito tutti i
principali settori produttivi. Lo sostiene il rapporto annuale 2013 dell'Istat.
Circa 3.000 imprese, pari al 13,4 per cento delle grandi e medie aziende, dei
servizi, pur di abbattere i costi, hanno avviato processi di delocalizzazione. E
non è certo un caso che la Cina, il Bangladesh, siano diventati i due maggiori
"importatori" di lavoro. Tutto questo in Italia si è tradotto con una riduzione
dell'occupazione. Solo nel 2012 sono andati perduti 34 mila posti di lavoro. Uno
scenario preoccupante. E c'è dell'altro. La contrazione della crescita
industriale, la minore disponibilità di risorse economiche, l'assenza di
incentivi alle imprese, la difficoltà di accesso al credito per le piccole
realtà produttive, incrementa il lavoro nero. «Se esitono dei rischi per la
salute dei lavoratori, si amplificano nel momento in cui entra in gioco il
"sommerso". Un mondo dove, è chiaro, non possiamo intervenire - piega Liliana
Frusteri, chimico Inail per la consulenza tecnica accertamento rischi e
prevenzione- E dove soprattutto non esistono regole». Lavoro in nero è sinonimo
di: manodopera clandestina. E ancora: di smaltimento illecito dei rifiuti, roghi
tossici. Inquinamento dell'aria, del terreno, delle falde acquifere. A Nord di
Napoli, in particolare nelle zone del basso casertano, ad Acerra, San Giuseppe
Vesuviano, Nola, Polvica, Marigliano, Roccarainola, Tufino, Palma Campania San
Gennaro. Qui è localizzato, il "Triangolo della morte". Qui si concentrano le
fabbriche abusive, soprattutto per abbigliamento. E sempre qui lo sversamento
degli scarti di produzione è a dir poco selvaggio. A San Giuseppe Vesuviano è
stata scoperta una ditta di confezionamento abiti del tutto fuorilegge che
operava nel più completo degrado igienico. Perché gli extra comunitari che lì
lavoravano, senza mai essere stati assunti, in quegli stessi locali ci vivevano.
Mangiavano. Dormivano. Dentro un ambiente interrato senza alcuna areazione.
Ammassati in 200 mq con macchine e apparecchiature, tagliavano, cucivano gli
abiti, vi apponevano i marchi di note aziende tessili. Una condizione del tutto
simile alla schiavitù. Più di un "operaio", hanno scoperto i Vigili Urbani
durante il blitz, era clandestino. Infine sacchi pieni di ritagli di stoffa
erano pronti per finire nelle tante discariche abusive dislocate nel territorio.
In attesa di essere bruciati. E basta fare un giro tra via Macedonio Melloni (a
San Giuseppe Vesuviano), via Lavinaio (a Poggiomarino) per trovare kilometri e
kilometri di tonnellate di balle di pezze che vengono scaricate dalle industrie
tessili. Ma insieme a queste si trova di tutto: liquidi tossici, copertoni,
resti di roghi precedentemente appiccati. A denunciare i continui attentati che
il territorio campano subisce sono i componenti di rifiutarsi.it. Nel loro sito
internet, nella loro pagina di facebook, pubblicano foto, caricano video, che
puntualmente documentano un disastro ambientale dalle proporzioni gigantesche.
Un sfregio che avviene nell'indifferenza o forse peggio nell'impotenza delle
amministrazioni locali. «I clan approfittano delle strade al confine o, meglio
ancora, di quelle contese tra più enti, per smaltire illegalmente i rifiuti -
scrive a commento alle immagini il team di rifiutarsi.it - Per facilitare il
lavoro e aumentare ulteriormente il loro guadagno, i camorristi hanno pensato
bene di installare due discariche di pneumatici. Le gomme vengono usate per
aumentare il potere calorifico della combustione tossica e sono posizionate alla
base del rogo, su cui poi vengono gettati gli scarti tessili. Un mix che
bruciando rilascia nell'aria grandi quantità di diossina. Non è escluso che i
panni tessili siano anche utilizzati come spugne per assorbire i rifiuti tossici
liquidi. In questo modo si brucia tutto in un sol colpo, si eliminano le prove e
si crea spazio per i nuovi scarichi». La quantità di diossina che si disperde
nell'aria è incalcolabile. Per questo non si esita a definirlo un vero e proprio
"Biocidio". Sono in aumento anche i casi di incidenza tumorale: più del 15%
delle donne tra i 30 e 35 anni, contrae un cancro alla mammella, tumori allo
stomaco, linfomi. Gravi patologie, che in altri territori hanno percentuali
molto più basse. Sempre in Campania i Carabinieri del Noe di Caserta hanno
bloccato un traffico di rifiuti illeciti e d'indumenti, destinati poi alla
vendita nel mercato di Resina. Un business superiore ai 10 milioni di euro.
Perché la "monnezza" per la camorra vale oro. I rifiuti tessili, importati
soprattutto dalla Germania, venivano poi esportati all'estero (Bolivia, India,
Tunisia ecc.): etichettati falsamente come merci recuperate, e senza alcuna
igienizzazione, come invece previsto dalle norme ambientali e sanitarie. «La
"merce" -si legge nel comunicato della Direzione Distrettuale Antimafia della
Procura di Napoli- venduta verso i Paesi "poveri" dell'America Latina, Asia,
Africa, era frammista a rifiuti di ogni altra tipologia: escrementi, farmaci
scaduti, cibi avariati e simili». Ma la situazione non è migliore neppure nel
distretto industriale di Prati. Loculi dormitorio, nascosti con tramezzi e
impalcature, erano diventati la casa per alcuni immigrati, che in nero
lavoravano dentro fabbriche dove si confezionavano capi di abbigliamento. A
gestire la produzione erano persone di nazionalità cinese, che avevano importato
circa 74mila rotoli di tessuto sprovvisto d'etichettatura, per un peso
complessivo di 1.265 tonnellate e un valore commerciale di 13 milioni di euro.
Massima allerta nei vestiti che indossiamo, uno su
dieci provoca infezioni sulla pelle, continua Valeria Ferrante. Riguardano
questo settore il 34 per cento delle misure del Rapex, la struttura che
sorveglia i prodotti non alimentari. Una denuncia della Lega antivivisezione
sulle pellicce tossiche negli abiti per bambini è sul tavolo del pm Guariniello.
Una situazione preoccupante confermata anche dal rapporto RAPEX 2012 (sistema
europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari) che mette al primo
posto della classifica per sostanze chimiche a rischio: vestiti e capi di moda,
con il 34% di misure correttive avviate. Non più solo un'esigenza estetica. Non
più solo un modo per proteggere, coprire il corpo. Vestirsi rischia adesso di
trasformarsi in un serio problema. Se l'abito, la t-shirt, l'intimo, il jeans
sono stati trattati con inchiostri plastisol o contengono nichel,
pentaclorofenolo, coloranti. Tutte sostanze chimiche che superiori ai parametri
eco-tossicologici possono diventare pericolose. Non è un caso che il 7-8 % delle
patologie dermatologiche sono dovute a capi d'abbigliamento. Ed è proprio
l'Associazione Tessile e Salute diretta da Massimo Rossetti a rendere noto il
dato. Dopo aver svolto un'indagine sul territorio nazionale, analizzato campioni
prelevati dal mercato per cercare la presenza di sostanze pericolose, il
resoconto che ne viene fuori non è affatto positivo. Tra i tessuti analizzati
dall'Associazione, responsabile dell'Osservatorio Nazionale Tessile, voluto dal
Ministero della Salute, si è riscontrato che i livelli di PH nel 29% dei casi
non venivano rispettati. Non solo. Nei tessuti è stata riscontrata la presenza
di metalli pesanti (6%), ammine aromatiche cancerogene (4%), coloranti
allergenici (4%), formaldeide (4%). Mentre su calzature in pelle o cuoio,
soprattutto d'importazione, si è scoperto che il 50% di queste conteneva cromo
VI: un agente cancerogeno. Secondo un'altra inchiesta svolta dalla SIDAPA
(Società Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale e Ambientale sulle
dermatiti da tessuti) su 401 pazienti (dai 5 agli 84 anni) i tessuti erano causa
di allergie per il 69,1% dei casi; gli accessori metallici dell'abbigliamento
per il 16,5%; le scarpe per il 14,4%. Una situazione preoccupante confermata
anche dal rapporto RAPEX 2012 (sistema europeo di allerta rapido per i prodotti
non alimentari) che mette al primo posto della classifica per sostanze chimiche
a rischio: vestiti e capi di moda, con il 34% di misure correttive avviate. E
non va meglio neppure per l'abbigliamento dei bambini. "Abbiamo acquistato 6
capi, piumini, cappottini, per minori dai 18 mesi ai 12 anni, delle migliori
marche italiane", racconta Simone Pavesi responsabile LAV (Lega Anti
Vivisezione), "un laboratorio specializzato ne ha analizzato le parti in
pelliccia. Abbiamo trovato: pentaclorofenolo, formaldeide, tetraclorofenolo,
nonilfenolo etossilato". Un caso shock. I dati elaborati dalla LAV sono finiti
in mano alla magistratura, al Pm Raffaele Guariniello, della Procura di Torino,
che sta aspettando adesso il risultato delle nuove analisi, rielaborate proprio
dall'Associazione Tessile e Salute, per volere del Ministero. La merce intanto è
stata tutta ritirata dal commercio e posta sotto sequestro. "Le leggi vigenti in
materia di tutela del consumatore sono obsolete o carenti", afferma Massimo
Rossetti, "in più, nel 34% dei casi, la composizione delle fibre riportate in
etichetta è sbagliata". Ma come difendersi allora? Alcuni consigli per
orientarsi nel mondo dell'abbigliamento tra fibre sintetiche, cotoni Ogm, falsi
tessuti certificati bio, coloranti e altro sono disponibili nel sito
dell'Associazione Tessile e Salute. "Cerchiamo di informare gli utenti sulle
normative, sull'acquisto dei prodotti e su come interpretare le etichette di
composizione", spiega sempre Rossetti. Tra le altre sostanze ad avere un forte
impatto sul tessile, considerate dannose, ci sono le SVHC - Substances of Very
Hight Concern- che comprendono le sostanze CMR -cancerogene, mutagene e
tossiche per il sistema riproduttivo; le sostanze PBT -persistenti,
bioaccumulabili e tossiche; le sostanze vPvB -molto persistenti e molto
bioaccumulabili. Purtroppo nono sono le uniche. "Nei nostri vestiti, in ogni
fase del loro ciclo di vita, quantità apparentemente piccole di NPE
(nonilfenoloetossilati) permangono sui tessuti", dichiara Chiara Campione
responsabile Greenpeace, "Queste sostanze, oltre ad essere potenzialmente
rischiose per la salute, cumulandosi negli scarichi, durante il lavaggio,
possono disperdersi nelle acque, contaminando l'ambiente". Questo fatto non
sembra proprio in cima ai pensieri del mercato, che soprattutto nella moda esige
collezioni nuove a tempi record, chiedendo ai fornitori consegne sempre più
rapide. A quale prezzo? La cosiddetta "moda veloce", condiziona i cicli
produttivi delle imprese italiane, battute sui tempi da Cina, Vietnam, Taiwan,
Arabia Saudita. Paesi dove il rispetto per i lavoratori o il territorio non è
garantito. Dove i prodotti spesso non sono conformi ai requisiti
eco-tossicologici. Eppure lo stesso vengono importati e venduti in Europa. Una
situazione paradossale. Le imprese della UE devono rispondere a requisiti
inerenti la sicurezza della merce, dei processi produttivi, come prevede il
REACH (il Regolamento per la Registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche). Però articoli tessili contenenti
sostanze tossico-nocive, il cui utilizzo è vietato o ristretto in Europa, sono
comunque introdotti nel territorio comunitario. E così non sono poche le aziende
che hanno deciso di delocalizzare parti delle loro fasi produttive in paesi
extra UE. "Nei casi in cui è stato possibile correlare la patologia al tessuto
che l'ha determinata si è trattato nel 100% dei casi di capi d'importazione",
sostiene lo studio dell'Associazione Tessile e Salute. E il consumatore? Non è
messo in condizioni di conoscere la provenienza delle merci, e neppure le
potenziali criticità eco-tossicologiche correlate.
ANTIBUFALA: LA BARRA COLORATA SUI DENTIFRICI.
Antibufala: la barra colorata sui tubetti di
dentifricio identifica quelli “chimici”. Sta circolando, in particolare sui
social network, un allarme-consiglio che propone una tecnica semplice per
distinguere i dentifrici “naturali” da quelli “chimici” (qualunque cosa voglia
dire questa distinzione, come se la natura non fosse basata sulla chimica ma
sulla magia o le flatulenze di unicorno): basta guardare il colore della
barretta in fondo al tubetto. Ecco il consiglio che viene diffuso: Ecco cosa
significano i colori sotto i tubetti di dentifricio. Sembrerebbe messo a caso ,
nessuno fa caso ad un piccolo colore posto in fondo al tubetto di dentifricio. E
invece dobbiamo imparare a fare caso a tutto se vogliamo preservare la nostra
salute. Al momento dell’acquisto è bene prestare attenzione ai colori al fondo
di ogni tubetto di dentifricio. Vi è una barra di colore, che indica la
composizione del dentifricio.
Ecco come leggerle:
Verde: Composizione Naturale
Blu: Composizione Naturale + Medicina
Rosso: Composizione Naturale + chimica
Nero: Composizione chimica
Inutile dire che è meglio scegliere dentifrici
contrassegnati da quadratino colorato verde in fondo. E Senza fluoro... C'è
anche la versione grafica.
Il consiglio è una panzana colossale e chi lo
diffonde pensando di essere utile in realtà fa soltanto danni disseminando
frottole. La barra colorata, infatti, è semplicemente un segno usato dai sensori
delle macchine di confezionamento per sapere dove tagliare e sigillare il
tubetto. Se volete sapere cosa c'è in un dentifricio, invece di affidarvi ai
diversamente furbi che pensano di dispensare conoscenze riservate agli eletti,
considerate l'ipotesi meno sensazionale ma molto più pratica di leggere l'elenco
degli ingredienti.
ILVA, LE VERITA' NASCOSTE DELL'INCHIESTA.
Ilva, le verità nascoste dell'inchiesta. Milano è
più tossica di Taranto. L’accusa parla di 386 morti, ma 140 non hanno nulla a
che fare con l’inquinamento, scrive Vittorio Feltri su “Il Giornale”. La materia
che stiamo per trattare è scottante e va presa con le pinze, tanto più in questo
momento. Ci riferiamo all'Ilva di Taranto, accusata di produrre un inquinamento
micidiale a causa del quale sarebbero morte centinaia e centinaia di persone:
cancro ai polmoni. La fabbrica, tra le più importanti d'Europa nel settore
dell'acciaio, rischia addirittura di fare una brutta fine: è in corso
un'inchiesta della magistratura, dalle cui carte emerge una situazione
drammatica tale che, se fosse confermata da una sentenza di condanna, la
speranza di salvare l'azienda si ridurrebbe al lumicino. Naturalmente noi non
abbiamo le conoscenze scientifiche necessarie per esprimere giudizi in merito.
Ma leggendo i documenti abbiamo constatato alcune incongruenze tali da suscitare
dubbi sulla fondatezza delle responsabilità attribuite ai gestori dello
stabilimento. Tra l'altro, nei giorni scorsi il commissario dell'Ilva, nominato
dal governo, Enrico Bondi (già collaboratore dell'ex premier Mario Monti e
risanatore della Parmalat) ha inviato una lettera ai vertici della Regione
Puglia in cui, riassumendo le osservazioni di quattro consulenti dell'impresa,
fa notare che non esistono prove certe che l'elevato numero di decessi sia
rapportabile alle cosiddette polveri sottili emesse dagli impianti industriali.
Non l'avesse mai fatto: Bondi è stato travolto dalle critiche. Vari partiti,
tutti impegnati in una gara a chi è più ambientalista, si sono sollevati
all'unisono per protestare contro il commissario reo di aver contraddetto le
tesi colpevoliste. Essi non hanno tenuto conto che Bondi era considerato
all'unanimità l'uomo più adatto alla luce del suo impeccabile curriculum, a
risolvere i problemi. Non siamo in grado di accertare se abbia ragione lui o il
gruppo dei suoi improvvisati detrattori: rimane il fatto che chiunque osi
manifestare perplessità sull'effettiva dannosità delle scorie dell'Ilva viene
messo al bando quale complice di Sorella Morte, benché la discussione
sull'inquinamento a Taranto sia circoscritta all'ambito delle ipotesi.
Spulciando tra gli atti dell'inchiesta è difficile dare torto a Bondi: essi sono
disseminati di contraddizioni meritevoli di attenzione. La più grossolana è
contenuta in una perizia acquisita dall'Ufficio del giudice per le indagini
preliminari, Patrizia Todisco, dove si legge che i morti per cause naturali sono
stati, in tredici anni, 386, un dato impressionante. Peccato che in un altro
punto della documentazione si scopra che, invece, 140 dei 386 decessi
denunciati, siano attribuibili a cause non naturali: cioè dovuti a incidenti
stradali, suicidi eccetera. Le cifre sono state alterate di sicuro in buona
fede, ma ciò non giustifica l'errore, soprattutto non giustifica la mancata
correzione del medesimo, visto che le conclusioni sono state tratte dal quadro
statistico falsato. In un'altra perizia ordinata dal Tribunale si sostiene che
le sostanze nocive per essere tollerabili non devono superare il limite di 20
milligrammi per metro cubo, come raccomanda - o sogna - l'Organizzazione
mondiale della sanità. Ma uno degli stessi autori, in un altro documento
riguardante una consulenza richiesta dalla Regione Lombardia, afferma che la
media annua e tollerabile delle polveri sottili è di 40 milligrammi per metro
cubo, esattamente come recita la disposizione europea tramutata in legge
dall'Italia. Da sottolineare che la media delle sostanze tossiche emesse
dall'Ilva non è mai andata oltre il limite fissato dalla citata legge. Quindi
non si capisce in che cosa consistano le presunte violazioni commesse dalla
fabbrica in questione. Immagino che le obiezioni di Bondi - che non è l'ultimo
arrivato - sorgano anche dagli elementi che abbiamo riportato in sintesi e con
un linguaggio semplice. C'è da aggiungere, per rimarcare la confusione regnante
in questo campo, una curiosità. Legambiente, nel 2012, ha elaborato una ricerca
su scala nazionale relativamente al Pm10 (polveri sottili) da cui si evince che,
nella classifica delle città più inquinate, Taranto figura al 46° posto. Milano,
per intenderci, è in vetta insieme con Torino, seguite da Verona, Alessandria e
Monza. L'incidenza delle sostanze tossiche presenti nell'atmosfera sulla
mortalità non è mai stata misurabile né lo sarà, presumibilmente, per parecchio
tempo ancora. Milano, per esempio, pur avendo un'aria irrespirabile, in teoria,
in pratica offre ai suoi abitanti le migliori aspettative di vita: sotto il
Duomo si campa più a lungo che sotto le Dolomiti. Ergo, andiamoci piano con i
catastrofismi degli ambientalisti professionali. Se anche la magistratura si
lascia influenzare dai luoghi comuni e dai luogocomunismi della vulgata,
seguiteremo a morire, e moriremo poveri. Emergenza Ilva e i medici che la
pensano come Bondi.
Tirelli e Serraino, dell'Istituto tumori di
Aviano, a Panorama.it: "Rapporto Sentieri non idoneo a scoprire tutte le cause
dei tumori", scrive Marino Petrelli su “Panorama”. “L’ipotesi che l’Ilva sia la
causa di tutti i tumori evidenziati è in disaccordo con le evidenze scientifiche
riportate dalle più grandi agenzie di ricerca sul cancro del mondo. La tipologia
dello studio Sentieri non è idonea a investigare le cause delle malattie, ma
solo a descriverne la frequenza”. E' l'idea di Umberto Tirelli, direttore del
dipartimento di Oncologia medica dell'Istituto tumori di Aviano , e Diego
Serraino, direttore della struttura complessa di Epidemiologia e biostatistica
del medesimo istituto. Che a Panorama.it aggiungono all'unisono: “Si tratta di
uno studio descrittivo che serve a formulare ipotesi sulle cause delle malattie,
in questo caso dei tumori, ma non serve a stabilire relazioni. Su questo punto i
ricercatori di Sentieri sono d’accordo”. Dunque, secondo gli esperti del centro
friulano, la relazione dei consulenti Ilva e le dichiarazioni del commissario
Bondi potrebbero avere un fondamento, sostenute anche da una indagine presentata
nel 2012, in collaborazione con l'Istituto tumori Pascale di Napoli , che
evidenziava nell'aria di Taranto una mortalità per tumori uguale alla media
delle altre provincie del sud Italia. Tirelli e Serraino non sembrano né
sorpresi né contrari alle affermazioni del commissario Ilva. Per quali motivi?
“Se per scoprire le cause dei tumori bastasse usare i tassi di incidenza o di
mortalità non ci sarebbe bisogno del National Cancer institute, dell’Agenzia
internazionale per la ricerca sul Cancro dell'Organizzazione mondiale della
sanità, l’Università di Oxford o il Karolinska Institute di Stoccolma, o il New
England Journal of Medicine. Senza contare le decine di migliaia di ricercatori
nel mondo che studiano i tumori e pubblicano le loro ricerche”, sottolineano.
"Purtroppo non è così. Gli studi descrittivi sono solo la prima fase di un lungo
processo conoscitivo che deve necessariamente passare per gli studi di
epidemiologia analitica in cui è possibile misurare le esposizioni individuali –
dicono i due medici - . Questo è uno dei punti cruciali, negativi secondo noi,
di Sentieri: la residenza al momento della diagnosi del tumore è usata come
proxy della esposizione ai carcinogeni ambientali. Si da, cioè, per scontato,
che le persone abbiano sempre abitato lì, e che siano state esposte ai vari
carcinogeni nel corso di almeno tre decenni, tempo medio necessario per lo
sviluppo dei carcinomi, e che questi vari carcinogeni abbiano causato il cancro
e queste persone siano per il resto paragonabili a chi non abita li”.
CRITERI EPIDEMIOLOGICI
Tirelli spiega che le malattie neoplastiche sono
circa 230 tipi diversi tra loro per eziologia, patogenesi, presentazione
clinica, prognosi: pensare che i fattori di rischio per i tumori dell’apparato
respiratorio siano gli stessi per i tumori dell’apparato digerente o urinario o
riproduttivo non ha fondamento scientifico. Per alcune sedi neoplastiche,
innanzitutto l’apparato respiratorio, è più che plausibile che l’inquinamento
ambientale abbia aumentato il rischio di malattia mentre per altre è, in base
alle conoscenze attuali, molto poco probabile. Ma per un'analisi epidemiologica
più ampia si dovrebbe, ad esempio, usare almeno la georeferenziazione degli
indirizzi, che andrebbero associati ai residenti in modo uninominale per mappare
le residenze nel tempo. “Bisogna partire dai dati del Rapporto Sentieri per
identificare ipotesi di lavoro e procedere con studi epidemiologici analitici.
Ci sono voluti 50 anni di studio e decine di migliaia di lavori scientifici per
stabilire l’associazione tra fumo e tumori, tra infezione da HPV e tumore della
cervice – aggiunge il direttore di Oncologia medica -. Le scorciatoie non
servono allo scopo e sono dannose perché spostano l’attenzione dai veri fattori
di rischio noti, accertati e accettati”. Cosa salvare dunque del Rapporto
Sentieri e cosa dire ai tarantini che combattono contro un inquinamento sempre
maggiore? “E' una ottima indagine descrittiva che serve a produrre ipotesi di
lavoro, ma non va oltre. Il fatto che tutti la ritengano un modello è limitato
al nostro Paese e ai media. Penso che l’ideologia abbia giocato e giochi un
ruolo molto negativo da questo punto di vista – conclude Serraino -. La scienza
non deve essere tirata per la giacca, non è di destra o di sinistra. Le
conoscenze attuali delle cause del cancro dicono che l’inquinamento ambientale
ha un ruolo marginale nei tumori per l'1-2 per cento. C’è qualcuno in grado di
dimostrare che a Taranto questa percentuale è del 400 per cento come pubblicato
da alcuni giornali nel 2012?”. Una domanda che non tarderà di avere una
risposta.
LA LOTTA CON GLI IDOLI DELLA PIAZZA.
Montepaschi e Ilva, la nostra lotta con gli idoli
della piazza. Con Nomura tutto a posto, lo dicono i giudici (adesso). Il fumo
provoca il cancro, ma non se lo dice Bondi, scrive Giuliano Ferrara su “Il
Foglio”. Comporre un giornale quotidiano, offrire informazioni e analisi, è un
mestiere sempre più complicato e ingrato. La correttezza politica e ideologica è
un mostro dai molti tentacoli, che ha afferrato e imprigionato, fino a
soffocarla, l’intelligenza media del pubblico, basta fare la prova Twitter.
Mandagli 140 caratteri dotati di una qualche autenticità psicologica, logica,
morale, e vedrai quanto fiele sarà vomitato. Certe verità, una volta affermate
come idoli della piazza, non sopportano l’emergere delle controverità. La
reazione è di silenzio e nascondimento oppure di rigetto e odio: non puoi dire,
come questo giornale ha fatto, che è falso lo scandalo del Monte dei Paschi di
Siena. Non puoi dire che le imputazioni importanti si sgonfiano, che erano
formulate in modo specioso e a tratti grottesco, che destra e sinistra
tribunizia hanno usato l’ipotesi di una maxitangente derivata dall’acquisto a un
costo elevatissimo della Banca Antonveneta da parte dell’istituto senese per
specifici e generici scopi di bassa propaganda politica (per non parlare dei
somari dell’antipolitica grillina). Non puoi rilevare la stranezza di uno
“scandalo del millennio” in cui le grandi cifre del maltolto, la sostanza dello
scandalo, sono sparate dai giornali e dalle tv condiscendenti alla mentalità
correttista, mentre le cifre di malversazioni accertate sono pochi spiccioli
finiti nelle tasche di qualche funzionario infedele. Non puoi dire che è strana
una inchiesta così rilevante senza arresti eccellenti, perché evidentemente non
esistevano i termini, spesso così spicciativamente fissati in altri casi, per
procedere. Non puoi onestamente fissare una distinzione tra i fallimenti e le
disinvolture strategiche di una banca che ha fatto il passo più lungo della
gamba, che ha cucinato i bilanci anche con operazioni di rischio su titoli
derivati, come fanno quasi tutte le banche del mondo, che ha dovuto chiedere
prestiti allo stato, ciò che è successo ovunque, e se non riuscisse a
restituirli, a tassi di interesse peraltro molto consistenti, perderebbe la sua
autonomia come sempre avviene nei patti convertendo. Non puoi parlare di cose
vere con un tono controargomentativo, e spiegare quel che traspare, cioè un
retroterra massonico e d’influenza carico di segreti e drammi anche personali,
vecchie storie di politica e fondazioni creditizie, scontri al vertice, nei
vertici e nelle successioni al vertice. Scontri risolti ieri con l’apertura
della banca, lodevole, a capitali esterni che possono diventare determinanti: un
atto di riforma e normalizzazione incompatibile con la dimensione scandalistica
che tutta la faccenda del crollo e della grande rapina avevano imposto. Nei
giorni scorsi per la seconda volta il tribunale del riesame ha bocciato
l’ipotesi accusatoria maggiore, quella che riguarda il contratto sui derivati
con la banca d’affari giapponese Nomura, che peraltro si era mostrata parecchio
infastidita dalle intromissioni dei magistrati, che giudicava speciose, in una
vicenda di commercio finanziario internazionale. Si va, secondo tutti gli
osservatori, verso l’archiviazione del dossier Antonveneta, e sarà archiviata
l’inchiesta sul suicidio di David Rossi, misterioso come tutti i suicidi. Ora
uno dice. Qualcuno di questi furboni & cialtroni che hanno lucrato sullo
scandalo del millennio, in politica, nel giornalismo, nella finanza, nell’ordine
giudiziario, sarà chiamato a qualche responsabilità. Ma non succederà. Resterà
un piccolo club di fortunati, la fetta di pubblico che ha per le mani un
giornale come questo, in possesso delle controverità fattesi dato oggettivo, e
per il resto un grido aspro e stupido contro l’insabbiamento emesso dal cretino
che passa su Twitter, il silenzio indifferente, l’incapacità di capire che così
un paese va letteralmente a finire in giochi idolatrici di quart’ordine. Veniamo
all’Ilva di Taranto, già per molti anni Italsider, acciaio, salute e lavoro,
stato e privati, insomma vita. E’ un dossier ancora più penoso, per chiare
ragioni. I dobloni vabbè, ma con la vita delle persone, la malattia e il dolore,
non si deve scherzare. Ma chi è che scherza? Chi pone le questioni con
leggerezza, non importa se collocandosi dalla parte dell’umanitarismo e
dell’ambientalismo o da quella dell’industrialismo e del capitalismo? A noi, con
l’iniziativa del giudice per le indagini preliminari Patrizia Todisco,
confermata in numerosi passaggi dalla procura di Taranto, è stato inculcato
questo, devo dire con sistemi oggettivi, un uso non sconsiderato e non ciarliero
dei grandi poteri della magistratura: la produzione dell’acciaio uccide, è una
strage, i morti si contano come nell’esplosione di una bomba, le storie di
malattia sono crudeli, l’epidemiologia non può farla passare liscia a
capitalisti che puntano al profitto, corrompono la gente per coprire le
situazioni malsane, e ben gli sta se passano parte della loro vita in galera
domiciliare anche sopra gli ottant’anni, questi industriali luciferini. Tra i
coinvolti per il giro della politica c’è un Nichi Vendola presidente della
Puglia, che si è messo nella scia dei magistrati, ma con molte contraddizioni e
incertezze. C’è la sinistra, che è stata regolarmente finanziata dalla potenza
economica dei Riva, e ha dato, in un certo senso ha offerto in olocausto, uno
dei suoi pupilli, il prefetto Bruno Ferrante, ex capo di gabinetto di Giorgio
Napolitano all’Interno ed ex candidato sindaco a Milano, al tentativo di
risolvere il conflitto fra salute e lavoro, come si dice. Poi c’è la linea del
governo Monti, con la sua maggioranza di larga coalizione, confermata dal
governo Letta: decreti e leggi per contrastare la tendenza del circo
mediatico-ambientalista-giudiziario a chiudere semplicemente l’Ilva, progetto
quasi impossibile e comunque molto dannoso alla vita dell’industria e di chi ne
dipende, e farlo rilanciando le pratiche ambientali costosissime ma doverose
intese a risolvere il conflitto eliminando il più possibile. Con le bonifiche e
gli standard acconci di produzione. I fattori di rischio. Su cosa si basa tutto
questo, dall’accusa di strage al dramma sociale e politico di un bastione
industriale da abbattere? Si basa su dati epidemiologici, e su come essi vengono
recepiti dall’opinione pubblica e dalla gente di Taranto, lavoratori e abitanti,
gente che risponde con dolore, con spavento, con offesa e con costernazione a
quei dati, ed esprime l’esperienza stessa che sta dietro la parola asettica di
epidemiologia. Taranto però è divisa in materia, come sanno tutti coloro che non
cedono alla demagogia spicciola, e una parte consistente della comunità, che nel
referendum è rimasta maggioritariamente assente dalla battaglia, pensa che si
sia esagerato e che le cose non siano così chiare come le descrivono i comitati
militanti. E allora? Allora il problema è che questo giornalino si permise di
esprimere delle riserve sul modo in cui sono costruite le ricerche
epidemiologiche del progetto Sentieri e dell’Arpa, l’agenzia che deve valutare
in loco, a livello regionale, i danni sanitari. In queste ricerche
epidemiologiche, per stabilire se i tumori e le affezioni polmonari e cardiache
siano sopra la media, se dipendano interamente o parzialmente, e in quale
proporzione, da vari aspetti della produzione dell’acciaio nelle zone a caldo
oppure siano ascrivibili anche e in qualche caso soprattutto ad altri fattori,
come l’amianto dei cantieri navali eccetera, hanno lavorato persone di qualità
e di presumibile, per non dire sicura, indipendenza. Ma ecco che arriva
l’ultimo, e il più prestigioso, della filiera dei Grand Commis de l’Etat
chiamati a sbrogliare la matassa incandescente, il commissario Enrico Bondi,
l’uomo delle situazioni difficili, della scuola di Enrico Cuccia, che ha risolto
il problema industriale e finanziario della Parmalat e ha impedito il crollo di
una grande fonte di lavoro e di ricchezza sociale. Bondi ha per le mani un
documento in cui Paolo Boffetta, Carlo La Vecchia, Marcello Lotti e Angelo
Moretto – tutti epidemiologi e studiosi delle criticità sanitarie di livello e
impegno rilevante, anche in campo internazionale – sostengono che il progetto
Sentieri e il rapporto dell’Arpa sono criticabili per moltissimi aspetti. Il
documento è lungo e richiede anche competenza specialistica per essere letto,
ma il suo senso è chiaro. C’è anche un passaggio, non necessariamente centrale
nelle analisi varie ivi condotte, in cui si afferma che alcuni dati storici
dell’area tarantina (la grande disponibilità di tabacco da contrabbando per
generazioni, l’alcolismo e lo stato di vita miseranda a cui fette importanti di
popolazione furono condannate) alludono a cause epidemiche del danno sanitario
in una forma che è sbagliato sottovalutare. Bondi trasmette a chi di dovere
questo rapporto strettamente scientifico, nato come iniziativa prima della sua
nomina a commissario dell’Ilva, e il risultato è questo, per gli stessi giornali
e siti che ingrassano sullo scandalismo in tutti i campi: Bondi dice che il
cancro a Taranto dipende dal fumo e dall’alcol, non dalla produzione
dell’acciaio. Da quel momento Bondi non vive più. E’ costretto a precisare,
attività sempre sospetta, a essere audito dal ministro, si minacciano nuovi
comitati esperti per giudicare gli esperti eccetera. Il clima è di
colpevolizzazione. La affermazione analitica del rapporto scientifico diventa
una barzelletta: è il tabacco, bellezza, e tu non puoi farci niente. La teppa
mediatica si scatena. Invece, come per l’Mps, lo scandalo venuto dal nulla e
finito nel nulla, anche in questo caso c’è la coincidenza con i nostri dubbi di
minoranza, le nostre tremebonde intuizioni su chi la fa sempre troppo facile.
D’altra parte comporre un giornale e offrire informazioni e analisi è cosa
complicata, come dicevamo, e nella legge del politicamente corretto sta scritto
che ieri puoi far stampigliare sui pacchetti di sigarette che IL FUMO PROVOCA IL
CANCRO, a grandi lettere, e oggi puoi sbeffeggiare il rapporto degli esperti che
dice la stessa cosa in un contesto diverso.
ILVA. TARANTO. TUTTI DENTRO.
Tutta la stampa ne parla. La Provincia nella
Bufera, arrestato il presidente. Ilva, "ambiente svenduto": 4 arresti. Provincia
decapitata, in manette anche Florido. Le ordinanze di custodia cautelare
spiccate dal gip Patrizia Todisco: in manette anche il presidente e l'ex
assessore all'Ambiente, Conserva. Al centro del nuovo terremoto giudiziario le
manovre per ottenere l'autorizzazione della discarica realizzata all’interno
dello stabilimento, scrive Mario Diliberto e Giuliano Foschini su “La
Repubblica”. Nuova pioggia di manette a Taranto nell'ambito dell'inchiesta
"ambiente svenduto". Tra gli arrestati anche il presidente della Provincia
Gianni Florido, 61 anni, alla guida dell'amministrazione dal 2004 (eletto per il
secondo mandato nel 2009 col Pd) ed in passato segretario generale della Cisl
ionica. L'operazione è scattata alle prime luci del mattino del 15 maggio 2013.
I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito quattro ordinanze di custodia
cautelare spiccate dal gip Patrizia Todisco. Gli arrestati sono, oltre a Florido
per il quale l'accusa sarebbe di concussione; l'ex assessore all'Ambiente
Michele Conserva (Pd) e l'ex segretario della Provincia di Taranto, Vincenzo
Specchia, per il quale sono stati disposti i domiciliari. Tra i destinatari dei
provvedimenti di custodia cautelare anche Girolamo Archinà, ex responsabile
delle relazioni istituzionali del colosso siderurgico che avrebbe lavorato per
agevolare l'attività della grande fabbrica accusata di disastro ambientale. Ad
Archinà l'ordinanza è stata notificata in carcere, l'ex dirigente Ilva è
detenuto dal 26 novembre. Al centro del nuovo terremoto giudiziario le manovre
attivate per ottenere l'autorizzazione della discarica "Mater Gratiae",
realizzata in una cava all’interno dello stabilimento Ilva. Nel sito vengono
smaltiti i rifiuti industriali e le polveri prodotte dagli impianti ritenuti la
fonte dell'inquinamento killer inquadrato con l’indagine per disastro
ambientale. Florido e Conserva sono accusati di aver indotto, dal 2006 al 2011,
dirigenti del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto a
rilasciare autorizzazioni per la discarica gestita dall'Ilva "in carenza dei
requisiti tecnico-giuridici". Quella procedura autorizzativa sarebbe stata
viziata da una serie di passaggi sospetti e di pressioni indebite tutte
fotografate dall'attività condotte dalle Fiamme Gialle del comando provinciale.
Nel mirino l'attività svolta dagli uffici della Provincia, compente al rilascio
delle autorizzazioni ambientali. In quegli uffici la pratica relativa alla
discarica sarebbe stata accompagnata da pressioni illecite che hanno portato
alla emissione dei provvedimenti restrittivi. Anche in questo caso regista delle
operazioni condotte sottotraccia dall'Ilva sarebbe stato Girolamo Archinà, l'ex
potentissimo responsabile dei rapporti istituzionali dell'azienda, in carcere
dallo scorso 26 novembre. Per questo all'ex dirigente è stato notificato in
cella un nuovo provvedimento restrittivo. Ma a far rumore è soprattutto il
coinvolgimento di Florido. Tarantino, sposato e con due figlie, con alle spalle
una lunga militanza nella Cisl, di cui è stato anche segretario provinciale, è
stato eletto per la prima volta nel 2004 e nel 2009 è stato confermato con oltre
centomila preferenze. Nel 2007, all'indomani del dissesto finanziario del Comune
di Taranto, si era anche candidato sindaco di Taranto con una coalizione di
centrosinistra ma al ballottaggio era stato sconfitto dall'attuale sindaco Ezio
Stefano. Negli ultimi mesi si era anche parlato di una possibile candidatura di
Florido al Parlamento, tant'è che si ipotizzavano sue dimissioni anticipate
dalla carica di presidente della Provincia anche in relazione al ventilato
scioglimento delle stesse Province, cosa che poi non si è più verificata. E
comunque la maggioranza di centrosinistra votò in aula, in Consiglio, un
documento chiedendogli di restare alla guida dell'ente. Da vedere adesso che
accade in Provincia perché all'indomani delle dimissioni del vice presidente
Costanzo Carrieri, del Pd, eletto presidente del consorzio Asi, non sarebbe
stata formalizzata la nomina di un nuovo vice presidente, mentre la delega
all'Ambiente lasciata da Conserva è stata subito trasferita a Giampiero
Mancarelli, del Pd, che è anche titolare del Bilancio. In questo capitolo
dell'inchiesta condotta dal pool della Procura della Repubblica di Taranto,
guidata da Franco Sebastio, non ci sarebbero altri indagati.
Pressioni e minacce di licenziamento ai dirigenti
che non si dimostravano propensi a favorire l’Ilva, scrive Francesco Casula su
“Il Fatto Quotidiano”. È il nuovo terremoto giudiziario che si è abbattuto su
Taranto e ha travolto la politica locale. All’alba del 15 maggio 2013, infatti,
la Guardia di finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere
nei confronti del presidente della provincia Gianni Florido, dell’ex assessore
provinciale all’ambiente Michele Conserva e dell’ex responsabile delle relazioni
istituzionali dell’Ilva Girolamo Archinà, già detenuto dal 26 novembre scorso.
Arresti domiciliari invece per l’ex direttore generale della provincia di
Taranto e attualmente in servizio nella provincia di Lecce, Vincenzo Specchia.
Le ipotesi di reato contestate dalla procura ionica nell’ambito dell’inchiesta
“Ambiente svenduto” vanno dalla concussione per induzione alla tentata
concussione per costrizione. I quattro, secondo le accuse, avrebbero esercitato
direttamente o indirettamente, pressioni sui dirigenti dell’amministrazione
provinciale perché si adeguassero ad “assumere un atteggiamento di generale
favore nei confronti dell’Ilva”. Nell’ordinanza firmata dal gip Patrizia
Todisco, gli investigatori documentano le pressioni nei confronti dell’ex
dirigente del settore ecologia Luigi Romandini “colpevole” di aver negato le
autorizzazioni in materia ambientale allo stabilimento e finito così al centro
di “pressioni reiterate nel tempo accompagnate da minacce di licenziamento,
dall’invito a presentare le dimissioni, da minacce di trasferimento ad altro
incarico” e infine anche di “pretestuose riorganizzazioni dell’ufficio” che in
realtà avevano come unico scopo quello di “influire sui poteri del dirigente”.
L’obiettivo era di costringere Romandini a firmare “a vista” tutte le richieste
formulate dall’azienda anche facendo a meno di “un esame approfondito delle
pratiche”. In particolare il presidente Florido e l’ex assessore Conserva
avrebbero caldeggiato la concessione dell’autorizzazione richiesta dall’Ilva per
l’uso della discarica di rifiuti speciali nella “Cava Mater Gratiae”. Un via
libera che avrebbe permesso all’azienda di smaltire i rifiuti prodotti nel ciclo
di lavorazione ottenendo così un significativo vantaggio economico. Una
discarica nella quale, come già mostrato da ilfattoquotidiano.it, l’azienda
stoccava anche sacche contenenti amianto accanto a scorie di lavorazione ancora
fumanti. Pressioni vane, però, perché Romandini non solo decise di non firmare
quelle autorizzazioni, ma dopo il suo trasferimento in un altro ufficio
dell’amministrazione denunciò tutto alle fiamme gialle guidate dal maggiore
Giuseppe Dinoi. Una rimozione che Girolamo Archinà commentò pochi giorni dopo
dicendo “abbiamo tolto una peste… e ne abbiamo tre di pesti” perché anche il
successore di Romandini, il dirigente Ignazio Morrone, si mostrò altrettanto
riottoso nei confronti della grande industria. Secondo quanto emerso dalle
indagini, Gianni Florido (presidente della provincia al suo secondo mandato e
presidente del Partito democratico di Taranto) si interessa personalmente alle
vicende che riguardano l’Ilva. Parla al telefono direttamente anche con Fabio
Riva, interviene su assessori e sull’operato dei dirigenti. “Circostanze –
scrive il gip Todisco – che confermano il sollecito, premuroso, fattivo e
perdurante interessamento del Florido in soccorso delle esigenze di natura
economica della proprietà dell’Ilva”.
Ma non c’è solo la Provincia ad essere coinvolta.
Il comune nella Bufera; indagato il Sindaco. Niente più dimissioni, scrive
Domenico Palmiotti su “Il Sole 24ore”. Ezio Stefáno, sindaco di Taranto al suo
secondo mandato e a capo di una maggioranza di centrosinistra, rimane al suo
posto. «Non sarebbe responsabile dimettersi e lasciare ora, in un momento molto
particolare per la città», ha dichiarato il 29 aprile 2013. Tutto si é consumato
a cavallo dell'ultimo week end, annuncio delle dimissioni e loro rientro. Il
sindaco, politicamente vicino al governatore della Puglia, Nichi Vendola, aveva
infatti annunciato la sua intenzione di dimettersi venerdì scorso dopo aver
appreso di essere stato iscritto dalla Procura di Taranto nel registro degli
indagati per l'inchiesta sull'inquinamento dell'Ilva. Abuso di ufficio e
omissioni di atti d'ufficio: ecco le due ipotesi di reato contestate al sindaco
- ex senatore Pci-Ds, ex primario dell'ospedale di Taranto - sulla base di un
esposto presentato ai pm dal consigliere comunale Pdl, Aldo Condemi, alle
comunali di maggio 2012 sfidante del sindaco. Per Condemi, il sindaco non
avrebbe fatto il suo dovere in materia di controlli ambientali sull'Ilva.
Stefáno, invece, ha ricordato che l'inchiesta che ha portato al sequestro degli
impianti del siderurgico, si sviluppa anche dietro un suo esposto alla
Magistratura, di aver emesso delle ordinanze contro l'Ilva poi sospese dal Tar
su ricorso dell'azienda, e infine di aver portato l'Ilva a pagare milioni di
euro di Ici fatta evadere, negli anni scorsi, dalle amministrazioni comunali
precedenti. «Sono tranquillo e ribadisco di essere a disposizione della
Magistratura per ogni chiarimento in merito alla mia posizione», ha detto
Stefáno. Il sindaco ha disertato la seduta del Consiglio comunale di Taranto
benché delle sue annunciate dimissioni si sia molto parlato in aula. Lontano dal
Municipio, Stefáno ha pensato sul da farsi mentre, in parallelo, partiva su di
lui un fitto pressing degli alleati ma anche, pare, del governatore Vendola e
del sindaco di Bari, Michele Emiliano. Che alla fine lo hanno convinto a
desistere giocando su un elemento "forte": il blocco cui sarebbe andata incontro
la città con un anno di commissariamento, il secondo nel giro di pochi anni. E
stavolta le dimissioni del sindaco sarebbero coincise con un momento molto
particolare per Taranto, che si trova a vivere la complessa gestione
dell'Autorizzazione integrata ambientale per il risanamento dell'Ilva e l'avvio
delle prime bonifiche nell'area esterna alla fabbrica. Si dovrebbe infatti
partire a giugno dalle scuole del quartiere Tamburi con i progetti predisposti
proprio dal Comune. A ciò si aggiunga l'utilizzazione di una serie di aree da
poco lasciate libere dalla Marina Militare e la chiusura del dissesto
finanziario dichiarato anni fa, risolvendo - dopo aver pagato debiti per
centinaia di milioni sia pure con la transazione al 50 per cento - quello
rimasto con la banca che accordò al Comune un prestito obbligazionario
attraverso i Boc per 250 milioni di euro.
Lunedi 29 aprile Stefàno si dimette? Ma no,
aspetta! Scrive “facias de culis” su “Agorà Magazine”. «Una domenica che spinge
sull’acceleratore della crisi comunale, dopo che da sei mesi si sa che il
Sindaco di Taranto è nel registro degli indagati, difatti, domenica 3 febbraio,
avevo scritto: mi dimetto o non mi dimetto e se mi dimetto dove mi metto. Rinvio
a quello per la cronaca. Cosa cambierebbe oggi? Nulla, i sei mesi sono trascorsi
e la Procura fa sapere che occorrono altri sei mesi. Solo che ora l’esposizione
mediatica è stata amplificata da una Ansa che ha girato tutte le redazioni ed
ora leggo: lunedì le dimissioni in Consiglio Comunale. Anche se per la verità
oggi, così si legge nella cronaca, il nome del Sindaco è riportato nero su
bianco nella richiesta di proroga, con l’aggiunta del tema: abuso di ufficio e
omissione di atti di ufficio (una denuncia esplicita che ha un mittente Aldo
Condemi). Io credo che invece la strada sarà un altra, rimandare per indecisione
o eludere il compimento di una determinata azione ricorrendo a pretesti o
sotterfugi, che è la spiegazione del tergiversare, abile presupposto del
mantenimento della poltrona, che è sinonimo di traccheggiare, ma che nella sua
origine latina tergiversari, composto di tergum ossia tergo e versare ossia
volgere, quindi voltare le spalle, si riporta a me. Eh si cari amici,
bisognerebbe avere la mia faccia per mostrare il tergo cosi! Ma è quello che
accadrà lunedì. Qual’è l’oggetto? L’oggetto è la città che si sente tradita.
Ridotto in parole semplici: se si svende qualcosa, è perché la congiuntura vuole
che si deprezzi il valore della stessa, perché si ha fretta di concludere; nel
caso in cui sia l’ambiente a essere disprezzato come la si mette? Parola di
facias de culis: la si mette come quello che per cambiare aria si butta dalla
finestra.»
Taranto. Il sindaco è come il Re Nudo scrive
ancora “facias de culis” su “Agorà Magazine”. «Cari amici, la storia delle
dimissioni del sindaco erano una burla entrata nel circo mediatico, come ora la
storia del “non mi dimetto”. Ma se scorrete i titoli dei giornali online,
l’unico correttore di bozze che ha riportata la notizia come sarebbe andata,
sono io. Ora mi va di pensare a questa storia del Re nudo tratto da una fiaba
trovata, letta e riletta durante la mia scuola elementare. Per chi non la
conosce è la storia di un Re noto per la sua arroganza; per l’iraconda gestione
dello stato e dei suoi sudditi e per la sua totale sordità ad opinioni
contrastanti. Trovate la similitudine? Uno che amministra con assessori a tempo
determinato mostra con chiarezza che comanda con cipiglio e determinazione. Del
resto a sentire chi lo conosce è proprio così. Come continua la favola? Atri
personaggi della narrazione sono un sarto astuto e scaltro e la sincerità
inopportuna di un bambino. La fiaba narra del Re che commissionò al sarto un
vestito che in eleganza e preziosità non temesse rivali. Il sarto, consigliato
da un sogno, finge di confezionare il vestito commissionato e alla prova
generale, con un eloquio efficace convince il Re di stare indossando un vestito
senza rivali come: eleganza, preziosità della stoffa, taglio e comodità. Tutto
ciò lasciando indossare al Re solo l’aria che lo circonda. Nella corte, presente
alla prima uscita del Re con il nuovo abito, nessuno ebbe il coraggio di svelare
la truffa. Impauriti dalle conseguenze e dalla possibile ira del Re, la corte
trasmise al popolo l’ipocrita bugia di un vestito degno di un dio, creando
aspettative e curiosità nei sudditi. Alla Reale cavalcata verso il castello
d’estate il Re indosso l’abito, contro il parere dei suoi consiglieri, lasciando
esterrefatti i sudditi mentre cavalcava in costume adamitico. Anche in questo
caso nessuno ebbe il coraggio di proferir parola, temendo la reazione
indispettita del Re e tutto continuò come sempre finché un bambino di 5 anni,
salito sulle spalle del padre per vedere meglio gridò "Il Re è Nudo!!!" avviando
un’ondata di risa e lazzi tra il popolo tale da costringere il Re, ora rosso
come un peperone e cosciente della propria stupidità, a battere in ritirata nel
castello appena lasciato. Ora mettete al posto del sarto, l’astuto industriale
siderurgico, che consiglia al Sindaco di credere che l’aria di Taranto sia
pulita, e lo convince tanto che la corte, che vive accanto all’alcalde trasmette
al popolo tale convinzione, e nessuno osa contraddirlo, fino a quando il popolo,
che ha realizzato il più bel primo maggio tarantino gli grida, proprio con la
inopportuna sincerità di un bambino,: “ Il Sindaco è nudo” . La fine è
temporalmente slittata a data da destinarsi. Ma noi, da Padova, aspettiamo.»
Ed ancora la storia coinvolge anche la Regione.
Vendola ed Ilva, rapporti ambigui. Il gip: “Costanti contatti tra Ilva e
Vendola”, continua Casula. “Numerosi e costanti contatti di Girolamo Archinà,
direttamente, e di Fabio Riva, indirettamente, con vari esponenti politici tra
cui il governatore della Puglia Nichi Vendola“. Parola, anzi penna del gip di
Taranto nell’ordinanza di custodia cautelare per i vertici dell’Ilva. Un
documento in cui emergono rapporti quanto meno ambigui tra il presidente della
Regione ed i vertici del siderurgico. Tutta da leggere una mail del 22 giugno
2010, che Archinà invia a Fabio Riva e con la quale lo informa di un incontro
avuto a Bari con il governatore. Incontro che è successivo al documento
dell’Arpa Puglia del giugno 2010, in cui si sottolineavano i livelli di
inquinamento prodotti dall’azienda. Nella mail, Archinà “comunicava che il
presidente Vendola si era fortemente adirato con i vertici dell’Arpa Puglia,
cioè il direttore scientifico Blonda e il direttore generale Assennato,
sostenendo che loro non devono assolutamente attaccare l’Ilva di Taranto e
piuttosto si dovevano occupare di stanare Enel ed Eni che cercavano di aizzare
la piazza contro l’Ilva”. Sempre secondo quanto scrive Archinà a Riva, inoltre,
“Vendola aveva pubblicamente dichiarato che il "modello Ilva" doveva essere
esportato in tutta la regione riferendosi, chiaramente, alla famosa "legge sulla
diossina" la cui gestazione era stata evidentemente frutto della concertazione
tra la Regione e l’Ilva che aveva sempre osteggiato il cosiddetto "campionamento
in continuo", ottenendo, appunto, in tale legge che ciò non fosse imposto”.
Altro “elemento di rilievo” scrive ancora il gip, è rappresentato dalla promessa
“del presidente Vendola di occuparsi personalmente della questione Arpa al suo
ritorno dalla Cina”. Un intendimento che “veniva mantenuto” tanto che Vendola
“appena tornato… contattava personalmente l’Archinà rassicurandolo di non aver
dimenticato la promessa fatta nella riunione precedente”. ”State tranquilli, non
e’ che misono scordato!!… Il presidente non si è defilato” dice Vendola il 6
luglio 2010 al telefono con Archinà. Parole finite nell’ordinanza e che ora sono
al vaglio della magistratura tarantina. In quella chiamata, scrive il gip, il
leader di Sel “proseguiva nel discorso con Archinà dicendo che "col mio capo di
gabinetto… Siamo rimasti molto colpiti… Siccome ho capito qual è la situazione…
Volevo dire che… Mettiamo subito in agenda un incontro con l’ingegnere… State
tranquilli, non è che mi sono scordato"”. Nel corso della conversazione, poi,
Vendola ribadiva questa posizione “allorquando affermava chiaramente di non
volere rinunciare a una realtà industriale qual è l’Ilva, invitando Archinà a
comunicare a Riva che lui non si era defilato”. “Va bene, va bene – dice il
governatore – noi dobbiamo fare… Ognuno fa la sua parte… E dobbiamo però sapere
che… A prescindere da tutti il procedimento, le cose, le iniziative… L’Ilva è
una realtà produttiva… cui non possiamo rinunciare… E, quindi… fermo restando
tutto dobbiamo vederci… dobbiamo ridare garanzie… Volevo dirglielo perché poteva
chiamare Riva e dirgli che.. il presidente non si è defilato”. Ci sarebbe ”la
regia” del governatore della Puglia, Nichi Vendola, nelle “pressioni” per “far
fuori” il direttore generale dell’Arpa Puglia, Giorgio Assennato, autore della
relazione sulle emissioni inquinanti prodotte dall’Ilva. Lo scrive il gip di
Taranto Patrizia Todisco nell’ordinanza d’arresto per i vertici dell’azienda, in
cui sono riportate anche alcune telefonate che proverebbero la tesi del giudice.
Il 30 giugno 2010, ad esempio, vengono intercettati Archinà e il segretario
provinciale della Cisl di Taranto Daniela Fumarola, nella quale l’ex funzionario
dell’Ilva sostiene che “l’avvocato Manna (allora capo di gabinetto del
presidente della Regione) e l’assessore Fratoianni fossero stati incaricati dal
presidente Vendola di "frantumare Assennato"”. In un’altra telefonata, del 2
luglio del 2010, a parlare sono invece l’ex direttore dello stabilimento di
Taranto Luigi Capogrosso e uno degli avvocati dell’Ilva. Quest’ultimo, annota la
Guardia di finanza, “riferisce che Archinà ha avuto contatti con il capo di
gabinetto di Vendola il quale ha riferito che sono contro Assennato e che
cercheranno di farlo fuori”. “Il complesso delle intercettazioni relative alle
pressioni sul professor Assennato – scrive il gip – è da ritenersi, oltre ogni
ragionevole dubbio, assolutamente attendibile, così come è altrettanto evidente…
che il tutto si era svolto sotto l’attenta regia del presidente Vendola e del
suo capo di gabinetto avvocato Manna”.
C'è «la regia» di Nichi Vendola dietro le
pressioni dell’Ilva sull'Arpa, si scrive anche su “La Gazzetta del Mezzogiorno”
e c'è una Regione che «invece di imporre misure urgenti» all’azienda, per
ridurre l'inquinamento, mette in atto una serie di escamotages «per non
risultare inoperosa» di fronte all’opinione pubblica: è un’accusa pesantissima
quella che il Gip di Taranto Patrizia Todisco rivolge al governatore pugliese,
che non è indagato, e alla sua squadra di governo, chiamando in causa anche
funzionari e assessori di quella Regione che ha fatto proprio della battaglia
ambientale una bandiera. Nelle oltre 500 pagine dell’ordinanza con cui spedisce
nuovamente agli arresti la famiglia Riva e i vertici dell’azienda, il giudice
dedica infatti ampi passaggi a Vendola e a quel che accade nelle stanze della
Regione. Riportando telefonate e mail e parlando di «numerosi e costanti
contatti» tra l’ex grande capo delle relazioni istituzionali dell’Ilva Girolamo
Archinà e rappresentanti della Regione, Vendola compreso. L’obiettivo
dell’azienda è sempre lo stesso: cacciare il direttore generale dell’Arpa
Giorgio Assennato, colpevole di aver prodotto una relazione nel giugno 2010 in
cui si affermava la necessità di ridurre la produzione dello stabilimento di
Taranto per ridurre le emissioni inquinanti. Il governatore però smentisce
qualsiasi tipo di pressione. «Assennato può raccontare se ha mai subito o
pressioni o tirate d’orecchie da parte mia. Le mie pressioni sono andate sempre
nella direzione di essere inflessibili in termini di ambientalizzazione». E
anzi, aggiunge Vendola, tutte le azioni fatte sono state «molto caute, per
evitare quello che purtroppo stiamo per vedere nelle prossime ore».
Nell’ordinanza il Gip scrive però che «è evidente che i ripetuti interventi
della presidenza della Regione Puglia, in persona del presidente Vendola e del
suo capo di Gabinetto avv. Manna, su sollecitazione dei vertici Ilva, avevano
sortito gli effetti auspicati nei confronti del professor Assennato, che era
sicuramente molto più accomodante ed accondiscendente verso la predetta azienda,
anche nel timore che, alla scadenza, il proprio mandato potesse non essere
rinnovato dal presidente Vendola». Il gip cita poi una mail inviata il 22 giugno
del 2010 da Archinà a Fabio Riva, nella quale il primo informa il secondo di un
incontro avuto a Bari con Vendola. Il governatore, scrive Archinà. «si era
fortemente adirato con i vertici dell’Arpa Puglia», sostenendo che «non devono
assolutamente attaccare l'Ilva». In quell'incontro, sostiene ancora Archinà, il
governatore «aveva pubblicamente dichiarato che il "modello Ilva" doveva essere
esportato in tutta la regione riferendosi, chiaramente, alla famosa "legge sulla
diossina" la cui gestazione era stata evidentemente frutto della concertazione
tra la Regione e l’Ilva che aveva sempre osteggiato il cosiddetto 'campionamento
in continuò, ottenendo, appunto, in tale legge che ciò non fosse imposto». Ma
c'è di più: dopo quella riunione Vendola parte per la Cina e, quando rientra,
chiama Archinà: «state tranquilli - dice all’uomo dell’Ilva – non mi sono
scordato, non mi sono defilato». Riferendosi, scrive il Gip, alla vicenda
Assennato. «Col mio capo di gabinetto... Siamo rimasti molto colpiti... Siccome
ho capito qual è la situazione... – dice Vendola - volevo dire che... Mettiamo
subito in agenda un incontro con l'ingegnere... State tranquilli, non è che mi
sono scordato.». E poi ancora: «Noi dobbiamo fare... Ognuno fa la sua parte... E
dobbiamo però sapere che... A prescindere da tutti il procedimento, le cose, le
iniziative... L’Ilva è una realtà produttiva... cui non possiamo rinunciare...
E, quindi... fermo restando tutto dobbiamo vederci... dobbiamo ridare
garanzie... Volevo dirglielo perchè poteva chiamare Riva e dirgli che.. il
presidente non si è defilato». Non si è scordato a tal punto che il Gip parla di
«regia» del governatore quando cita due telefonate – una tra il solito Archinà e
una sindacalista e l’altra tra l’ex direttore dello stabilimento di Taranto
Luigi Capogrosso e uno degli avvocati dell’Ilva – dalle quali emerge che, con il
benestare di Vendola, bisogna «frantumare Assennato» e «farlo fuori». «Il
complesso delle intercettazioni relative alle pressioni sul professor Assennato
– scrive il gip – è da ritenersi, oltre ogni ragionevole dubbio, assolutamente
attendibile, così come è altrettanto evidente... che il tutto si era svolto
sotto l'attenta regia del presidente Vendola e del suo capo di gabinetto
avvocato Manna». Dunque, conclude il giudice, «è di tutta evidenza che la
Regione Puglia, invece di imporre misure urgenti atte a monitorare in continuo
le emissioni dell’Ilva, di concerto con i suoi vertici cercava di ricorrere ad
escamotages, quali l’attivazione di 'tavoli tecnicì, al fine di far guadagnare
tempo all’industria nella realizzazione delle strutture di monitoraggio in
continuo delle emissioni e, dall’altra parte, consentire alla stessa regione
Puglia di non apparire inoperosa sul fronte ambientale agli occhi dell’opinione
pubblica».
Inoltre si viene a sapere da Massimiliano
Scagliarini su “La Gazzetta del Mezzogiorno” che i lucani sono creditori
dell’Ilva di Taranto di una somma che supera abbondantemente i tre milioni e
mezzo di euro. Dal 2009 a oggi, nonostante un’aspra polemica, la più grande
acciaieria d’Europa ha infatti «dimenticato » di versare alla Basilicata gli
oneri ambientali collegati al consumo idrico dello stabilimento. Ma è ancora più
incredibile che la Regione non abbia finora fatto nulla per recuperare quei
soldi. L’Ilva di Taranto utilizza per i propri impianti circa 250 litri al
secondo di acqua prelevati dall’invaso del Sinni. La «bolletta » vera e propria,
che copre il costo industriale dell’acqua, viene incassata dall’ex Ente
irrigazione e risulta regolarmente pagata. Ma l’accordo di programma tra Puglia
e Basilicata prevede anche una componente ambientale, che ristora i lucani per
il «disagio» e dovrebbe finanziare le opere di manutenzione e salvaguardia del
territorio. Soldi che la Basilicata non incassa da anni, né - per quanto è stato
possibile verificare - ha mai sollecitato: 707mila euro per il 2009, 594mila
euro per il 2010, 703mila euro per il 2011. Dal 2012 la componente ambientale
per l’uso industriale è stata incrementata di due volte e mezzo, a 20 centesimi
al metro cubo: il totale dovuto dall’Ilva non è ancora stato determinato
ufficialmente (dovrà farlo il Comitato di coordinamento dell’accordo di
programma che dovrebbe riunirsi a giugno), ma si parla di circa 1,767 milioni.
In totale fanno 3,7 milioni, dei quali 2 possono considerarsi già un credito
certo. L’incremento degli oneri ambientali fu richiesto dall’ex assessore
pugliese ai Lavori pubblici, Fabiano Amati, come arma per indurre l’Ilva a non
usare più l’acqua potabile accettando quella ultra-affinata che dovrebbe essere
prodotta dall’impianto del Gennarini. L’Ilva ha impugnato invano al Tar sia la
delibera con le nuove tariffe, sia l’Aia che tra le prescrizioni conteneva
proprio l’obbligo a utilizzare acqua affinata. Tuttavia il «depuratore» (il
termine è improprio) di Gennarini- Bellavista non è ancora stato realizzato,
nonostante la Protezione civile abbia da anni messo a disposizione i 14 milioni
necessari e Aqp abbia da tempo effettuato l’aggiudicazione provvisoria della
gara: per gestire l’impianto, infatti, l’Acquedotto chiede un contributo pari a
circa 1 milione l’anno, soldi che la Regione Puglia aveva chiesto all’Ilva
ottenendo un rifiuto.
E poi ci sono i sindacati. Non soltanto la
politica. "In questi anni nella vicenda Ilva c'è stato un silenzio deflagrante
da parte dei sindacati". A denunciarlo è il procuratore generale di Lecce,
Giuseppe Vignola, in un convengo giuridico organizzato dall'università del
Salento proprio sulla legge salva Ilva. Il resoconto è pubblicato anche su “La
Repubblica”. "Il loro silenzio - ha detto - e quello della politica ha permesso
ai Riva di non rispettare le regole. La magistratura ha fatto soltanto il
proprio dovere applicando l'obbligatorietà dell'azione penale". La magistratura
non è soltanto contro la politica. Dall'8 maggio 2013 nella vertenza Ilva
entrano come imputati anche i sindacati. "Dov'era chi doveva denunciare? Dove
sono stati in tutti questi anni i sindacati?" è la domanda deflagrante che ha
posto il procuratore generale di Lecce, Giuseppe Vignola, in un convegno
giuridico organizzato in Salento sulla legge "Salva Ilva". "Sull'Ilva - ha detto
Vignola - si è registrato negli anni un fragoroso silenzio da parte dei
sindacati e una disattenzione dei governi che si sono succeduti a livello locale
e nazionale". Un silenzio che ha permesso, è il ragionamento di Vignola,
all'azienda di fare il bello e il cattivo in questi anni sfruttando l'assenza di
controlli politici ma anche di denunce sindacali. Un tema - quello della
complicità sindacale - lanciato da Vignola ma che rischia di diventare
preminente dopo anni di silenzi e non detti: da tempo le sigle autonome
lamentano la presenza di troppi sindacalizzati tra i capi turno e fece scalpore
in uno degli ultimi scioperi, dopo il sequestro della magistratura, che a
mandare panini e bibite al picchetto era proprio l'azienda. "I sindacati non
hanno fatto quello che era lecito attendersi - ha detto Vignola - Ma lo stesso
si può dire anche della politica. Gli unici che hanno rispettato il compito sono
proprio i magistrati che hanno l'obbligo dell'azione penale: di fronte al
disastro in corso non potevano fare diversamente. Ma oggi non si può chiedere
loro la soluzione della vicenda. Quella tocca alla politica". Al convegno ha
partecipato anche l'assessore regionale all' Ambiente, Lorenzo Nicastro, a cui è
toccato difendere le piccole conquiste di via Capruzzi: "Governare la Puglia non
è facile - ha detto - e come nel caso Ilva spesso ci possiamo muoversi solo in
spazi legislativi interstiziali". Anche dalle sue parole emerge una
responsabilità chiara del Governo, "mai così produttivo nei mesi di agosto come
quando ha dovuto fare legiferare in favore dell'Ilva", e addirittura si adombra
una volontà persecutoria - manifestata durante alcune riunioni a Palazzo Chigi -
"nei confronti dei magistrati di Taranto" che hanno scoperchiato il vaso. I
magistrati, dal canto loro, continuano a fare quadrato. Il presidente della
Corte d' appello di Lecce Mario Buffa lancia l'allarme sulla possibilità che
"grazie ad una legge di dubbia costituzionalità tutto resti come prima".
Non ci stanno, i sindacati. Le parole del
procuratore generale Vignola lasciano il segno ed aprono uno scontro senza
precedenti tra la magistratura, nella persona del pg di Lecce che ha preso parte
ad un convegno sul caso Ilva, ed i rappresentanti dei lavoratori, nella
fattispecie i metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm. “Sull’Ilva si è
registrato negli anni un fragoroso silenzio da parte dei sindacati e una
disattenzione dei governi che si sono succeduti a livello locale e nazionale
(...) il sindacato ha mantenuto il silenzio nonostante la gravità di una
situazione visibile a tutti”. Parole come pietre, quelle del magistrato. “Un
attacco pesante di cui non si sentiva la necessità” è quanto dichiarato su
“Taranto Sera” da Antonio Talò, leader della Uilm ionica, il sindacato più
rappresentativo nel Siderurgico al centro della bufera giudiziaria ormai da
mesi. “Abbiamo sempre denunciato quello che potevamo e dovevamo, certo i
controlli sul benzo(a)pirene non spettavano a noi, che non siamo mai stati nè
silenti nè conniventi. Se volessi fare polemica, chiederei a Vignola dove è
stato, sino al 2012” è la chiosa del capo tarantino dei metalmeccanici della
Uil. “Non devo difendermi da nulla” dichiara invece Donato Stefanelli,
segretario provinciale della Fiom, “perchè noi parliamo con i fatti e con la
costituzione come parte civile nei processi contro la proprietà”. “A
testimoniare il nostro impegno ci sono carte, documenti, denunce, interventi
proposte in merito alle questioni dell’ambientalizzazione e della sicurezza” è
invece la replica di Mimmo Panarelli della Fim Cisl. “Questa fabbrica è
migliorata, e questo è accaduto anche grazie al lavoro dei sindacati. Che sono
stati sempre vigili”.
"Peccato che le esternazioni del procuratore
generale di Lecce, dott. Giuseppe Vignola, arrivino solo adesso, con notevole
ritardo. Peccato perché avrebbero potuto contribuire a rompere un lungo periodo
di fragoroso silenzio che certo non appartiene al sindacato, che ha, al
contrario, spesso espresso le proprie ragioni senza trovare nessun
interlocutore, agendo da solo perché isolato da chi, invece, aveva le
competenze, mai messe in pratica, per intervenire con decisione ed efficacia
sulla questione Ilva”. Aldo Pugliese, Segretario Generale della UIL di Puglia,
si chiede con una nota pubblicata su “Il Quotidiano Italiano” “dove fossero,
dal 1960 ad oggi e dal 1995 in poi, ovvero da quando l’Ilva è divenuta
un’azienda privata a tutti gli effetti, lo Stato, i Governi che nel frattempo si
sono succeduti e i vari ministri all’ambiente? Dov’era e cosa ha fatto la
Regione Puglia? Dov’erano e cosa hanno fatto le istituzioni locali, a cominciare
dalla Provincia di Taranto e dal Comune? E ci fermiamo qui in quella che sarebbe
una lunghissima elencazione di istituzioni competenti e di coloro i quali
avrebbero comunque dovuto attivarsi contro un disastro ambientale di dimensioni
impressionanti e a favore della tutela della salute dei cittadini e dei
lavoratori ionici e pugliesi e invece hanno agito poco e male”. “Additare il
sindacato – chiosa Pugliese – significa conoscere ben poco la storia dell’Ilva e
le conseguenze di una scellerata gestione del siderurgico che il sindacato ha
invece denunciato sempre con fermezza e puntualità, pagando tuttavia lo scotto
di un ingiusto isolamento che ha penalizzato ogni iniziativa mirata a proteggere
l’ambiente e i diritti calpestati, senza troppe remore, dei cittadini e dei
lavoratori. Piuttosto che dar vita a processi in contumacia, invitiamo quindi il
dott. Vignola, sempre e quando lo ritenga opportuno, a promuovere un confronto
schietto con le parti in causa, quantomeno per offrire agli "accusati" la
possibilità di difesa e di replica”.
Intanto il 14 maggio 2013 la battaglia giudiziaria
sulle merci dell'Ilva è finita, scrive Domenico Palmiotti su “Il Sole 24ore”.
Con un provvedimento firmato oggi dal gip Patrizia Todisco e che domani la
Guardia di Finanza notificherà all'azienda e ai custodi giudiziari, un milione e
700mila tonnellate di semilavorati e prodotti finiti tornano nella disponibilità
dell'Ilva alla quale erano stati sottratti lo scorso 26 novembre, quando la
seconda pesante ondata dell'inchiesta "Ambiente svenduto" provocò arresti e,
appunto, il sequestro delle merci. L'accusa dei giudici fu: l'Ilva ha prodotto
le merci con acciaio che non avrebbe potuto produrre perché aveva gli impianti
dell'area a caldo - dagli altiforni alle acciaierie - sotto sequestro senza
facoltà d'uso. I sigilli scattarono il 26 luglio. Nell'area produttiva, infatti,
i sigilli erano scattati il 26 luglio con la prima fase dell'inchiesta
giudiziaria. Dopo pochi giorni dal sequestro di semilavorati e prodotti finiti,
il Governo corse però ai ripari e varò un decreto legge che inizialmente
autorizzava solo l'Ilva a continuare la produzione e in seguito previde anche la
possibilità che l'azienda potesse commercializzare quanto realizzato prima del
decreto stesso. Il decreto, numero 171 del 4 dicembre 2012, è stato poi
convertito nella legge 231 del 24 dicembre 2012, legge approvata a grande
maggioranza dal Parlamento e che ha appunto confermato la doppia impostazione:
via libera alla produzione e alla commercializzazione. Le istanze dell'azienda
respinte dai giudici, Approvata la legge, l'Ilva ha subito cercato di riottenere
la disponibilità delle merci ma qui è cominciato uno scontro durato cinque mesi
e che ha visto tutte le istanze dell'azienda respinte dai giudici. Dai pm al
gip, dal Tribunale del Riesame a quello dell'Appello, ogni qualvolta l'Ilva ha
chiesto di "liberare" semilavorati e prodotti ha collezionato solo no. Anzi, ad
un certo punto si era anche profilata la possibilità che le merci venissero sì
sbloccate, ma vendute dai custodi giudiziari su mandato della Procura e il loro
ricavato sottratto all'Ilva e destinato invece in un fondo vincolato a valere
sull'eventuale confisca. Il gip Todisco aveva già dato mandato ai custodi di
lavorare in tal senso ma un ricorso dell'Ilva, stavolta accolto dal Tribunale
dell'Appello, ha stoppato l'operazione. Il senso dell'opposizione dell'Ilva era:
non possono i custodi vendere le merci quando la Corte Costituzionale sta per
pronunciarsi sulla legge e sulle eccezioni di incostituzionalità sollevate
proprio dai giudici di Taranto. Dall'Ilva nuova richiesta di dissequestro. Si
arriva così al 9 aprile, quando la Corte Costituzionale respinge, perché in
parte infondate e in parte inammissibili, le eccezioni contro la legge 231
avanzate dai giudici e dice che la 231 è costituzionale. L'Ilva torna quindi
alla carica e richiede il dissequestro delle merci: nulla da fare, però, anche
in quest'occasione. E per più volte. Nessun dissequestro sin quando le
motivazioni della Consulta sulla costituzionalità della legge non saranno state
rese note, dicono i magistrati. Le motivazioni arrivano il 9 maggio. Il resto è
cronaca delle ultime ore, con la nuova istanza dell'Ilva avanzata ieri in
Procura e il verdetto favorevole del gip di oggi. Il valore delle merci
dissequestrate è compreso fra gli 800 milioni di euro e un miliardo di lire.
Soldi che vanno nelle casse dell'Ilva che dovrebbe impiegarli per finanziare
parte dei lavori di risanamento ambientale prescritti dall'Aia. Lavori
imponenti, onerosi, il cui fine è quello di abbattere l'inquinamento dell'area a
caldo, proprio quella sequestrata a luglio e che resta tutt'ora sequestrata
anche se l'Ilva può utilizzare gli impianti. Il costo di questi interventi è
stato per ora stimato dall'azienda in 2 miliardi e 250 milioni di euro. Lo
sblocco delle merci avrà riflessi anche sull'occupazione. Ma lo sblocco delle
merci dovrebbe avere un riflesso anche occupazionale con la piena ripresa del
lavoro nell'area a freddo, i cui impianti erano stati quasi tutti fermati dopo
il sequestro di novembre e che hanno ripreso a funzionare in parte da qualche
mese. Fra gli impianti che riprenderanno a marciare c'è il Treno nastri 1 (230
gli addetti) visto che occorrerà rilavorare le bramme sino ad oggi sotto
sequestro.
TARANTO. CASO ILVA. TUTTI DENTRO. FLORIDO E GLI
ALTRI.
L’ARRESTO DI GIANNI FLORIDO NON E’ MICA UNA
RIPICCA? SE NON LO E’, PERCHE’ ORA?
La magistratura tarantina, in testa Patrizia
Todisco, arresta il presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido (PD),
ed il suo assessore all’ambiente, Michele Conserva. La stessa magistratura si
limita ad indagare il Sindaco di Taranto, Ippazio Stefàno. Nulla per Niki
Vendola nonostante, a loro dire, vi siano “Costanti contatti tra Ilva e
Vendola”. Silenzio su Stampa e tv locali, così come sui sindacati ed oltremodo
sui magistrati che per 50 anni hanno omesso ogni intervento atto ad impedire
tutto ciò di cui oggi su Taranto si parla a livello mediatico e giudiziario.
Florido e Conserva sono accusati di aver indotto, dal 2006 al 2011, dirigenti
del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto a rilasciare
autorizzazioni per la discarica gestita dall'Ilva «in carenza dei requisiti
tecnico-giuridici».
Il Dr. Antonio Giangrande, scrittore e presidente
dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, aborra l’uso spregiudicato delle
manette. Tintinnio di manette che distrugge l’esistenza degli individui e dei
loro incolpevoli familiari. E proprio perché la vita di Florido e Conserva ormai
è distrutta, così come per tutti gli altri malcapitati, esprime il suo pensiero
nel pieno diritto di critica pur nel rispetto della magistratura e senza alcun
intento diffamatorio nei confronti dell’ufficio della procura e del giudice per
le indagini preliminari. Lo manifesta in un contesto ambientale ed ideologico
dove nessuno ha il coraggio di farlo, attraverso l’utilizzo di domande in
apparenza retoriche, ma fondamentalmente legittime.
«L’arresto del Presidente della Provincia di
Taranto, il dr. Gianni Florido, sembrerebbe avere tutta l’aria di una ripicca.
Se non lo è come si spiega lo strano tempismo adottato. Va da se che la
fondatezza delle accuse vanno vagliate in dibattimento, ma era necessaria la
carcerazione preventiva di un presunto innocente, con il paradosso che in
carcere troverà Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Entrambe detenute con tutti i
dubbi del caso? E poi perché ora una misura cautelare in carcere solo per Gianni
Florido e non per Stefàno o per Vendola per il quale non vi è nemmeno un
procedimento aperto? Dall'ordinanza emerge che le fiamme gialle, in
un'informativa riportata da “Il Giornale”, ipotizzano un episodio di concussione
anche per Nichi Vendola. E perchè le manette non sono scattate anche per Filippo
Penati per la presunta mazzetta da 2 milioni di euro dal costruttore Pasini per
l'ex area Falk di Sesto San Giovanni (di cui Penati è stato sindaco) e
dall'imprenditore Pino di Caterina per l'affare Milano-Serravalle?
Qualcuno mi chiederà di quale tempismo io parli in
riferimento all’arresto di Florido effettuato il 15 maggio. Quale tempismo?!?
Il tempismo che il 14 maggio 2013 la battaglia
giudiziaria sulle merci dell'Ilva è finita e da qui la cronologia è presto
spiegata!
26 luglio 2012. I sigilli scattano nell'area
produttiva.
26 novembre. Il sequestro delle merci prodotte.
24 dicembre 2012. Il decreto, numero 171 del 4
dicembre 2012, è stato convertito nella legge 231. Legge approvata a grande
maggioranza dal Parlamento e che ha appunto confermato la doppia impostazione:
via libera alla produzione e alla commercializzazione.
Approvata la legge, l'Ilva ha subito cercato di
riottenere la disponibilità delle merci ma qui è cominciato uno scontro durato
cinque mesi e che ha visto tutte le istanze dell'azienda respinte dai giudici.
Dai pm al gip, dal Tribunale del Riesame a quello dell'Appello, ogni qualvolta
che l'Ilva ha chiesto di "liberare" semilavorati e prodotti ha collezionato solo
no. Accanimento giudiziario tanto da indurre il presidente dell'Ilva Bruno
Ferrante a denunciare in procura a Potenza i magistrati tarantini che si stanno
occupando del siderurgico. Il presidente del siderurgico ha chiesto ai
magistrati potentini di verificare se sono ravvisabili reati nei loro confronti:
oggetto del contendere è l'atteggiamento avuto nel corso della diatriba
giudiziaria, dal sequestro dell'impianto sino al blocco dell'acciaio prodotto.
Procura e giudice hanno fatto sempre muro creando grave danno all'azienda e di
conseguenza minato i diritti dei lavoratori.
Si arriva così al 9 aprile 2013, quando la Corte
Costituzionale respinge, perché in parte infondate e in parte inammissibili, le
eccezioni contro la legge 231 avanzate dai giudici e dice che la 231 è
costituzionale. L'Ilva torna quindi alla carica e richiede il dissequestro delle
merci: nulla da fare. E per più volte. Nessun dissequestro sin quando le
motivazioni della Consulta sulla costituzionalità della legge non saranno state
rese note, dicono i magistrati di Taranto. Le motivazioni arrivano il 9 maggio.
14 maggio 2013 il verdetto favorevole del gip. Il
valore delle merci dissequestrate è compreso fra gli 800 milioni di euro e un
miliardo di lire.
15 maggio 2013 arresto di Gianni Florido.
Perché l’arresto di Florido, ove non sussistesse
la condizione necessaria della reiterazione del reato e/o dell’inquinamento
delle prove e/o del pericolo di fuga? Perché?!? Perché i magistrati devono avere
sempre e comunque l’ultima parola e se ignominia deve essere, ignominia sia per
il malcapitato di turno.
I magistrati, tutti, fanno quadrato. A tirarla per
le lunghe è inevitabile riportare quanto scritto sui giornali: Il presidente
della Corte d' appello di Lecce Mario Buffa lancia l'allarme sulla possibilità
che "grazie ad una legge di dubbia costituzionalità tutto resti come prima". Ed
ancora “Sull’Ilva si è registrato negli anni un fragoroso silenzio da parte dei
sindacati e una disattenzione dei governi che si sono succeduti a livello locale
e nazionale (...) il sindacato ha mantenuto il silenzio nonostante la gravità di
una situazione visibile a tutti”. Parole come pietre, le parole del procuratore
generale Vignola. In effetti, in base ad un accordo stilato nel 1996 tra Fim,
Fiom, Uilm e l’Ilva stessa, sono stati versati 438 mila euro annue alle
segreterie dei 3 sindacati. Il tutto giustificato da una fondazione in cambio di
una colonia per i figli dei dipendenti, borse di studio e contributi scolastici,
oltre ad attività sportive e ricreative. “Un attacco pesante di cui non si
sentiva la necessità” è quanto dichiarato da Antonio Talò, leader della Uilm
ionica, il sindacato più rappresentativo nel Siderurgico al centro della bufera
giudiziaria ormai da mesi. “Abbiamo sempre denunciato quello che potevamo e
dovevamo, certo i controlli sul benzo(a)pirene non spettavano a noi, che non
siamo mai stati nè silenti nè conniventi. Se volessi fare polemica, chiederei a
Vignola dove è stato, sino al 2012” è la chiosa del capo tarantino dei
metalmeccanici della Uil. La chiosa vale anche per tutti i magistrati di
Taranto?
A volte però non c'è molto spazio per
l'interpretazione. Il sostituto procuratore generale Gabriele Mazzotta è
chiarissimo: «Una serie di indicatori consentono di individuare un'emotività
ambientale tale da contribuire all'alterazione delle attività di acquisizione
della prova». Mazzotta parla davanti alla prima sezione penale della Cassazione
dove si sta discutendo la richiesta di rimessione del processo per l'omicidio di
Sarah Scazzi: i difensori di Sabrina Misseri, Franco Coppi e Nicola Marseglia,
chiedono di spostare tutto a Potenza perché il clima che si respira sull'asse
Avetrana-Taranto «pregiudica la libera determinazione delle persone che
partecipano al processo». Ed a sorpresa il sostituto pg che rappresenta la
pubblica accusa sostiene le ragioni della difesa e chiede lui stesso che il caso
venga trasferito a Potenza per legittima suspicione. A Taranto, in sostanza, non
c'è la tranquillità necessaria per giudicare le indagate.
Stante, appunto, la situazione ambientale, non
pare che sia necessario ed urgente che le difese si attivino a chiedere la
rimessione dei processi anche sul caso Ilva per legittimo sospetto che non vi
sia serenità di giudizio, specie con la contrapposizione di piazza tra le
rispettive parti, anche politiche? Sempre che gli avvocati in causa abbiano il
coraggio di Franco Coppi, che ai magistrati tarantini ha prima presentato
l’istanza di rimessione e poi alla Cesarina Trunfio ed alla Fulvia Misserini
(giudici togati del caso Scazzi) ha paventato l’ipotesi di una ricusazione:
perché parafrasando Don Abbondio “se uno il coraggio non ce l’ha, non se lo può
dare”.»
Anzi, gli sviluppi successivi sono clamorosi.
Esigenze cautelari attenuate. Il giudice per le
indagini preliminari Patrizia Todisco, accogliendo l’istanza presentata dagli
avvocati Carlo e Claudio Petrone e sulla scorta del parere positivo espresso
dalla Procura, ha concesso il 22 maggio 2013 gli arresti domiciliari al
presidente della Provincia Gianni Florido, arrestato mercoledì 15 maggio dai
finanzieri del Gruppo di Taranto nell’ambito dell’inchiesta denominata «Ambiente
svenduto». La Procura aveva espresso parere favorevole alla concessione degli
arresti domiciliari all’esponente del Pd, scrivendo che «alla luce di una
valutazione complessiva delle dichiarazioni rese dall’indagato Florido in sede
di interrogatorio di garanzia e tenuto conto del fatto che il predetto ha
presentato le sue irrevocabili dimissioni dalla carica rivestita, è possibile
ritenere che le esigenze cautelari nei suoi confronti si siano attenuate». Il
gip Todisco nella sua decisione sostiene che «pur persistendo concrete ed
attuali esigenze di cautela» riguardo sia alla reiterazione dei reati che
all’inquinamento delle prove, «solo parzialmente e momentaneamente scongiurate
dalle dimissioni, asseritamente irrevocabili, rassegnate da Florido all’indomani
della sua carcerazione dalla carica di presidente della Provincia di Taranto»,
le stesse esigenze «anche in considerazione dell’avvenuto interrogatorio di
tutti i coindagati del Florido, possono essere adeguatamente soddisfatte con la
sottoposizione del medesimo indagato alla meno afflittiva misura degli arresti
domiciliari, e con l’imposizione del divieto assoluto di comunicare
telefonicamente, telematicamente o in qualsiasi altro modo, con persone diverse
da quelle che con lui convivono».
Il dott. Franco Sebastio Procuratore capo della
Repubblica di Taranto mi ricorda Filonide che piscia sulla toga dei romani. Il
potere romano gli ha detto che lui non può sequestrare i beni prodotti dalla
fabbrica perchè la fabbrica è strategica in quanto l'occupazione di 20.000
persone è sacra e dunque l'occupazione è espressione di un altro diritto
costituzionale? Bene, allora lui sfida di nuovo il potere romano (come fece
Filonide) sequestrando tutti i beni della famiglia Riva.
ILVA. SEQUESTRO RECORD. AI MAGISTRATI SEMPRE
L’ULTIMA PAROLA CON IL PARADOSSO DI FAVORIRE I RIVA.
Ilva, sequestro record da 8,1 miliardi ai Riva, ma
per il procuratore: "La fabbrica non si tocca". Sequestro da oltre otto miliardi
di euro su beni riconducibili alla famiglia Riva e in particolare alla società
Riva Fire spa. Il provvedimento di sequestro per equivalente è stato disposto
dal gip Patrizia Todisco su richiesta del pool guidato dal procuratore capo
Franco Sebastio, titolare dell'inchiesta per disastro ambientale in cui è
indagato anche il presidente dell'Ilva Bruno Ferrante. La procura ha ottenuto il
sequestro. In pratica i consulenti dei pubblici ministeri hanno quantificato la
somma che Ilva avrebbe dovuto investire negli anni per abbattere l'impatto
ambientale della fabbrica. Gli investimenti non eseguiti, secondo i magistrati
tarantini, si sono tradotti in un guadagno per la proprietà ritenuto però fonte
di reato. Di qui i sigilli per un valore di otto miliardi e centomila euro.
«Il sequestro - ha spiegato il procuratore
Sebastio a “La Repubblica” - riguarda solo i beni della società Riva Fire.
Abbiamo tenuto conto della legge 231 (legge salva Ilva), e dunque il sequestro
non colpisce i beni dell'Ilva. E questo provvedimento non intacca la produzione
dello stabilimento. La ratio del sequestro è quella di bloccare le somme
sottratte agli investimenti per abbattere l'impatto ambientale della fabbrica.
La produzione non si tocca - ha sottolineato Sebastio - Si tratta di un
sequestro preventivo per equivalente sulla base della legge 231 del 2001 sulla
responsabilità giuridica delle imprese che dal 2011 contempla anche i reati
ambientali. Ma in ogni caso - ha voluto specificare il procuratore - non
potranno essere sequestrati beni funzionali all'attività e alla produzione della
fabbrica.»
Molti hanno esultato a questo escamotage
giuridico, ma evidentemente costoro sono a digiuno di prassi giudiziaria. Il
sequestro preventivo non è una confisca,che interviene al termine del naturale
decorso giudiziario con esito positivo per le toghe, ma una semplice forma di
garanzia a futuro adempimento di obbligazione. Ciò significa che il sequestro di
quei beni comporterà che fino alla sentenza definitiva quei soldi non li può
toccare più nessuno perchè posti proprio a garanzia del risanamento. La
lungaggine dei processi in Italia insegna che la sentenza definitiva dopo primo
grado, appello, Cassazione arriverà fra non meno di cinque o sei anni. Nel
frattempo la famiglia Riva non potrà risanare, proprio perchè spogliato di tutte
le sue risorse. Va da se che per logica, a questo punto, non saranno applicabili
le sanzioni previste dalla legge n. 231/2012 in caso di inadempienze nel
risanamento dopo i tre anni. Quindi non ci potrà essere la nazionalizzazione
dell'azienda, perchè è proprio lo Stato ad aver posto Riva nelle condizioni di
non potere adempiere. Insomma i Magistrati hanno dato a Riva l'alibi per non
adempiere al risanamento.
Il Dr. Antonio Giangrande, scrittore (su Taranto
ha scritto un libro) e presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie,
esprime il suo pensiero nel pieno diritto di critica pur nel rispetto della
magistratura e senza alcun intento diffamatorio nei confronti dell’ufficio della
procura e del giudice per le indagini preliminari. Lo manifesta in un contesto
ambientale ed ideologico dove nessuno ha il coraggio di farlo, attraverso
l’utilizzo di domande in apparenza retoriche, ma fondamentalmente legittime.
«E’ chiaro a tutti che se prima “alla stampa
locale dovevasi tagliare la lingua”, riuscendovici, oggi la stessa stampa
continua a tacere anche su questioni fondamentali di diritto. Non è lo stare
contro o a favore dei magistrati il punto del contendere, ma se si sta
nell’alveo della legge o meno. Giusto affinchè da fuori non si dica: ma a
Taranto nessuno conosce la legge?
Dall’arresto del Presidente della Provincia di
Taranto, il dr. Gianni Florido, al sequestro dei beni della famigli Riva il
tutto sembrerebbe avere l’aria di una ripicca. Se non lo è come si spiega lo
strano tempismo adottato. Qualcuno mi chiederà di quale tempismo io parli. Quale
tempismo?!?
Il tempismo che il 14 maggio 2013 la battaglia
giudiziaria sulle merci dell'Ilva è finita e da qui si è aperto un varco
inatteso con atti tardivi rispetto alle esigenze cautelari con conseguenze
imprevedibili.
Qualcuno mi dirà: di quale cronologia si parla? La
cronologia di cui si parla è presto spiegata!
Per 50 anni si è permesso all’Italsider, poi Ilva,
di inquinare a piacimento, poi un bel giorno ci si è scoperti, tutto ad un
tratto, ambientalisti radicali.
26 luglio 2012. I sigilli scattano nell'area
produttiva.
26 novembre 2012. Il sequestro delle merci
prodotte.
24 dicembre 2012. Il decreto, numero 171 del 4
dicembre 2012, è stato convertito nella legge 231. Legge approvata a grande
maggioranza dal Parlamento e che ha appunto confermato la doppia impostazione:
via libera alla produzione e alla commercializzazione.
Approvata la legge, l'Ilva ha subito cercato di
riottenere la disponibilità delle merci ma qui è cominciato uno scontro durato
cinque mesi e che ha visto tutte le istanze dell'azienda respinte dai giudici.
Dai pm al gip, dal Tribunale del Riesame a quello dell'Appello, ogni qualvolta
che l'Ilva ha chiesto di "liberare" semilavorati e prodotti ha collezionato solo
no. Accanimento giudiziario tanto da indurre il presidente dell'Ilva Bruno
Ferrante a denunciare in procura a Potenza i magistrati tarantini che si stanno
occupando del siderurgico. Il presidente del siderurgico ha chiesto ai
magistrati potentini di verificare se sono ravvisabili reati nei loro confronti:
oggetto del contendere è l'atteggiamento avuto nel corso della diatriba
giudiziaria, dal sequestro dell'impianto sino al blocco dell'acciaio prodotto.
Procura e giudice hanno fatto sempre muro creando grave danno all'azienda e di
conseguenza minato i diritti dei lavoratori.
Si arriva così al 9 aprile 2013, quando la Corte
Costituzionale respinge, perché in parte infondate e in parte inammissibili, le
eccezioni contro la legge 231 avanzate dai giudici e dice che la 231 è
costituzionale. L'Ilva torna quindi alla carica e richiede il dissequestro delle
merci: nulla da fare. E per più volte. Nessun dissequestro sin quando le
motivazioni della Consulta sulla costituzionalità della legge non saranno state
rese note, dicono i magistrati di Taranto. Le motivazioni arrivano il 9 maggio
2013.
14 maggio 2013 il verdetto favorevole del gip. Il
valore delle merci dissequestrate è compreso fra gli 800 milioni di euro e un
miliardo di lire.
15 maggio 2013 arresto di Gianni Florido.
24 maggio 2013 sequestro del GIP Patrizia Todisco
di 8,1 miliardi di euro alla società Riva Fire spa.
Arresto e sequestro che potevano essere adottati
molto tempo prima. E da qui l’infondatezza della necessità ed urgenza
dell’adozione di quei provvedimenti.
Cioè in sostanza le conseguenze sono che i Riva
vengono privati di ogni disponibilità finanziaria e quindi non potranno più
ottemperare ai dettami della legge n. 231/2012 con due possibili esiti nefasti:
nazionalizzazione dell’azienda e confisca dei beni
sequestrati (8,1 miliardi di euro), in parole povere espropriazione proletaria
per buona pace dei sinistri;
risanamento dell’ambiente a carico dello Stato,
liberando i Riva dall’onere economico e restituzione a questi dei beni
sequestrati (in caso di buon esito del procedimento penale o dell’esito del
ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo), per buona pace dei destri.
Comunque sia la Corte Europea dei diritti Umani ne
ha da lavorare sulle nefandezze italiane.
Appare chiaro che in un quadro ambientale normale
è necessitata l’avocazione delle indagini da parte della Procura generale per
due ordini di motivi: per quanto attiene l’ufficio del Pubblico Ministero non è
stata esercitata la facoltà di astensione per gravi motivi di convenienza; così
come il giudice Patrizia Todisco va sostituito con altro Magistrato dell'Ufficio
del GIP in quanto esso, a norma dell’art. 36 c.p.p., ha l'obbligo di astenersi e
non si è astenuto a seguito di inimicizia grave instauratasi fra lei e una delle
parti private, per la denuncia penale e l’esposto in via disciplinare subito.
Ma i magistrati, tutti, fanno quadrato. A tirarla
per le lunghe è inevitabile riportare quanto scritto sui giornali: Il presidente
della Corte d' appello di Lecce Mario Buffa lancia l'allarme sulla possibilità
che "grazie ad una legge di dubbia costituzionalità tutto resti come prima". Ed
ancora “Sull’Ilva si è registrato negli anni un fragoroso silenzio da parte dei
sindacati e una disattenzione dei governi che si sono succeduti a livello locale
e nazionale (...) il sindacato ha mantenuto il silenzio nonostante la gravità di
una situazione visibile a tutti”. Parole come pietre, le parole del procuratore
generale Vignola. In effetti, in base ad un accordo stilato nel 1996 tra Fim,
Fiom, Uilm e l’Ilva stessa, sono stati versati 438 mila euro annue alle
segreterie dei 3 sindacati. Il tutto giustificato da una fondazione in cambio di
una colonia per i figli dei dipendenti, borse di studio e contributi scolastici,
oltre ad attività sportive e ricreative. “Un attacco pesante di cui non si
sentiva la necessità” è quanto dichiarato da Antonio Talò, leader della Uilm
ionica, il sindacato più rappresentativo nel Siderurgico al centro della bufera
giudiziaria ormai da mesi. “Abbiamo sempre denunciato quello che potevamo e
dovevamo, certo i controlli sul benzo(a)pirene non spettavano a noi, che non
siamo mai stati nè silenti nè conniventi. Se volessi fare polemica, chiederei a
Vignola dove è stato, sino al 2012” è la chiosa del capo tarantino dei
metalmeccanici della Uil. La chiosa vale anche per tutti i magistrati di
Taranto?
A volte però non c'è molto spazio per
l'interpretazione. Il sostituto procuratore generale Gabriele Mazzotta è
chiarissimo: «Una serie di indicatori consentono di individuare un'emotività
ambientale tale da contribuire all'alterazione delle attività di acquisizione
della prova». Mazzotta parla davanti alla prima sezione penale della Cassazione
dove si sta discutendo la richiesta di rimessione del processo per l'omicidio di
Sarah Scazzi: i difensori di Sabrina Misseri, Franco Coppi e Nicola Marseglia,
chiedono di spostare tutto a Potenza perché il clima che si respira sull'asse
Avetrana-Taranto «pregiudica la libera determinazione delle persone che
partecipano al processo». Ed a sorpresa il sostituto pg che rappresenta la
pubblica accusa sostiene le ragioni della difesa e chiede lui stesso che il caso
venga trasferito a Potenza per legittima suspicione. A Taranto, in sostanza, non
c'è la tranquillità necessaria per giudicare le indagate.
Il caso Scazzi ed il caso Ilva: stessa solfa.
Stante, appunto, la situazione ambientale, non
pare che sia necessario ed urgente che le difese si attivino a chiedere la
rimessione dei processi anche sul caso Ilva per legittimo sospetto che non vi
sia serenità di giudizio, specie con la contrapposizione di piazza tra le
rispettive parti, anche politiche? Sempre che gli avvocati in causa abbiano il
coraggio di Franco Coppi, che ai magistrati tarantini ha prima presentato
l’istanza di rimessione e poi alla Cesarina Trunfio ed alla Fulvia Misserini
(giudici togati del caso Scazzi) ha paventato l’ipotesi di una ricusazione:
perché parafrasando Don Abbondio “se uno il coraggio non ce l’ha, non se lo può
dare”. Qualcuno mi dirà: Tu cosa proponi? C’è un principio generale: chi inquina
paga. Quel principio non dice: chi inquina perseguitalo e fai chiudere la
fabbrica e manda i lavoratori a casa. In questo modo si dà la stura ad ogni
iniziativa avversa di tutela. Impedire la vendita dei prodotti e sequestrare i
beni non è la soluzione. Vendere i prodotti e investirne i proventi fino alla
totale sanificazione ambientale sarebbe una espropriazione velata, ma
inattaccabile dal punto di vista legale, in quanto la gestione dell’attività
economica (produzione e risanamento) rientra tra le prerogative dei consulenti
giudiziari nell’ambito della gestione aziendale. Ed ove non fosse così, comunque
c’è sempre l'art. 388 c.p. rubricato "Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice", che va bene per tutte le stagioni.»
A Taranto, comunque, si è stati sempre un po’
naif.
TARANTO E I SUOI PREDONI NEL DESERTO DELLE
CIMINIERE. Così scriveva Giovanni Valentini su “La Repubblica” nel lontano 19
novembre 1991. Anche se ha cambiato nome, la "cattedrale" è sempre lì, in mezzo
al "deserto", con la sua selva di ciminiere fumanti. Ma a distanza di trent'
anni il "deserto" è diventato, se possibile, ancora più arido e desolato. E quel
che è peggio, adesso è infestato da bande di predoni, alcuni travestiti da
giustizieri o addirittura nei panni di Robin Hood. Nell' emergenza criminalità
che ormai ha contagiato la Puglia, quello di Taranto rappresenta il caso più
critico, in un calderone esplosivo dove ribollono ingredienti politici,
economici e sociali, con il condimento di una delinquenza disperata. All'inizio
degli anni Sessanta, questa doveva essere la città-pilota dei grandi
insediamenti pubblici, il polo dell'industrializzazione meridionale, il
laboratorio in cui trasformare i "cafoni" da contadini in operai. E invece,
all'inizio degli anni Novanta, a dispetto di un paesaggio naturale che conserva
la suggestione del grande porto commerciale e militare aperto sul Mediterraneo,
Taranto appare come la vetrina dei mali d'Italia: malavita organizzata, crisi
economica, disoccupazione, degrado civile e culturale. La "cattedrale"
dell'Italsider, ribattezzata due anni fa Ilva dall'antico nome dell'isola d'Elba
in omaggio alla tradizione della nostra siderurgia, non solo è rimasta nel
"deserto" delle attività e delle iniziative locali, ma anzi ha contribuito
paradossalmente ad allargarlo in una storia di occasioni fallite, speranze
mancate, illusioni cadute. Dal 1988, per effetto di una crisi mondiale, i
dipendenti sono scesi da 15.700 ai 12.000 previsti a dicembre prossimo, con
conseguenze ancor più pesanti sull'indotto che ruota sulla fornitura di tubi e
laminati piani. Eppure, con una superficie complessiva di 11 milioni di metri
quadri ai quali ne vanno aggiunti altri quattro di aree esterne, vale a dire
almeno tre volte l'intera città, questo è tuttora il più grande stabilimento
siderurgico d'Europa e resta il nodo strategico del settore a livello nazionale,
dove si concentra il 70-80 per cento della produzione italiana. Tutt'intorno la
città langue. Su circa 250 mila abitanti, si stima che i disoccupati siano oltre
un quarto: 70-80 mila nell' intera provincia. Le cifre ufficiali, contenute
nell'ultimo rapporto congiunturale della Camera di Commercio, dicono che a fine
maggio gli iscritti alle liste di collocamento risultavano 52.088, con una
diminuzione del 10,4 per cento rispetto a febbraio e del 5,3 rispetto a un anno
fa. Ma, a parte il massiccio ricorso alla cassa integrazione per un monte-ore
che equivale al tempo pieno lavorativo di oltre duemila persone per un anno, lo
stesso documento segnala che il dato è positivo soltanto a prima vista: in
realtà, si legge, "potrebbe anche essere collegabile a un abbassamento del tasso
di partecipazione al mercato del lavoro, più che a una vera e propria capacità
di assorbimento di manodopera da parte delle imprese". Chi ha perso
un'occupazione o non la trova, insomma, non si preoccupa neppure d'iscriversi
alle liste di collocamento. Ognuno s'arrangia come può. A portata di mano, c'è
per molti la nuova industria della criminalità: traffico di droga, contrabbando,
racket, riciclaggio e strozzinaggio, bische clandestine. Centocinquanta morti
negli ultimi tre anni, 51 da gennaio a ottobre, sono il bilancio di un
"fatturato" che comprende, solo nel primo semestre '91, 181 rapine gravi, 58
estorsioni, 42 attentati dinamitardi o incendiari, 80 incendi dolosi. E' tale la
massa di disperati allo sbando che ormai a Taranto, dicono gli esperti, si può
commissionare un omicidio anche per meno di mezzo milione. E il racket, non
accontentandosi più delle estorsioni a carico dei commercianti per "difendere" i
loro negozi, adesso offre "protezione" addirittura ai condominii. E' del primo
ottobre scorso la mattanza "stile Chicago" consumata in una barbieria, quattro
morti e due feriti. Armati di pistola e mitraglietta, due sicari uccisero in una
sparatoria selvaggia il proprietario del locale, Giuseppe Ierone, e tre clienti.
Ma poi si scoprì che la strage, maturata in seguito a una frattura nel potente
clan cittadino dei fratelli Modeo, era stata inutile: le vittime designate erano
già uscite dalla sala da barba. I killers, feroci quanto sprovveduti, furono
catturati una settimana dopo. Più recente è l'attentato dinamitardo,
intimidazione o avvertimento, compiuto all'inizio di novembre contro la
parrocchia del Corpus Domini, nel quartiere dormitorio intitolato a Paolo VI,
ventimila abitanti. In piena notte, una bomba ha fatto saltare in aria i locali
della Polisportiva, attigui alla chiesa, a due settimane di distanza da un
analogo episodio contro la caserma dei carabinieri. Appena qualche giorno prima,
durante l'omelia nella messa funebre per un giovane tossicodipendente morto di
Aids, il parroco don Luigi Larizza aveva invitato pubblicamente la madre del
ragazzo a denunciare gli spacciatori di droga del quartiere, esortando tutti i
presenti a fare altrettanto. Per spiegare la frammentazione e l' ingovernabilità
della malavita tarantina, i cronisti locali raccontano che da quando fu
assassinato il boss "Ciccio" Basile, è scoppiata una guerra di successione
spietata e sanguinaria tra i maggiori clan cittadini: la famiglia Modeo da una
parte, i De Vitis-D'Oronzo dall'altra. Tra cinque o sei gruppi organizzati, si
calcola che gli affiliati effettivi siano in totale più di 350. Ma l'
arruolamento è sempre aperto, quasi quotidiano. Con i fratelli Modeo -
Gianfranco e Riccardo - in carcere per omicidio, non c'è più un capo
riconosciuto; qualunque disperato può diventare un delinquente o un killer;
entrare in un clan, tradirlo e uscirne da un giorno all' altro. Il fatto è che,
in questi ultimi tempi, tra il degrado economico-sociale e l'aggressione della
criminalità organizzata Taranto è sopravvissuta senza un governo, né legale né
illegale. Dalle elezioni amministrative del maggio '90, nell'arco di diciotto
mesi, l'amministrazione comunale è cambiata tre volte, con tre maggioranze e tre
sindaci diversi: prima un quadripartito con Dc, Psi, Psdi e Pri; poi una giunta
di "salute pubblica", con dentro anche il PdS, incapace alla prova dei fatti di
risolvere i problemi cittadini; e infine, da pochi giorni, un altro
quadripartito che ha fatto esplodere la polemica all'interno della stessa
Democrazia cristiana per l'avvicendamento del sindaco uscente, Alfengo Carducci,
uno stimato uomo di scuola che risultò primo eletto dello Scudo crociato con
3.497 preferenze, sostituito ora da Roberto Della Torre, già capolista con
appena 2.642 voti, a cui guarda con maggiore fiducia il "partito degli affari".
Nel Consiglio comunale in carica, secondo un rapporto consegnato al Parlamento
dall' ex commissario Antimafia, Domenico Sica, su un plenum di cinquanta eletti
"sei consiglieri risultano denunciati o imputati per reati contro la pubblica
amministrazione o interesse privato in atti d'ufficio, mentre per altri otto
consiglieri risultano precedenti penali per reati di vario genere". In questa
assortita compagnia, il personaggio emergente, il più popolare e discusso, amato
e odiato, si chiama Giancarlo Cito: 46 anni, all'anagrafe geometra e
imprenditore, proprietario e amministratore unico di "Antenna Taranto 6", una
battagliera e spregiudicata emittente privata attraverso la quale ha ottenuto un
clamoroso successo elettorale, conquistando oltre ventimila voti, quasi
quindicimila preferenze personali e sette seggi al Comune, dove una volta s'è
presentato in aula con indosso il giubbotto antiproiettile. Ex militante di
estrema destra, in base alle indagini dell'Alto commissario, "Cito risulta avere
numerosi precedenti penali, tra i quali: rissa aggravata, lesioni, violenza
privata, ricettazione in concorso con tre pregiudicati". Per di più, "è
sospettato di contiguità con ben individuati elementi della criminalità
organizzata" e "indicato come molto vicino al clan dei fratelli Modeo", per
essere stato sorpreso da una Volante in casa loro quand'erano agli arresti
domiciliari, la notte di Natale del 1989. Chiamato in causa da una recente
trasmissione televisiva, durante la quale il ministro delle Poste Carlo Vizzini
ha confermato il proposito di non concedere l'autorizzazione alle emittenti che
risultassero infiltrate dalla mafia, questo Masaniello tarantino aveva già
replicato alle accuse citando in giudizio Sica e chiedendogli tre miliardi di
danni a titolo di risarcimento, insieme a due parlamentari del PdS e a tre
giornalisti del "Corriere del Giorno" di Taranto che avevano diffuso il
contenuto del rapporto. Nel merito, Cito sostiene che i precedenti penali a lui
addebitati non sono che "alcune ragazzate di quando era missino". Quanto alla
presunta "contiguità" con il clan Modeo, quella notte del Natale ' 89 si trovava
in casa loro con una troupe televisiva per uno scoop giornalistico, nel
tentativo d'intervistare due tarantini "eccellenti" agli arresti domiciliari.
"Si tratta", afferma Cito, "di una campagna politica, giornalistica, giudiziaria
priva di scrupoli e di inaudita gravità, per screditare me, la mia iniziativa
politica autonoma, la mia emittente tv". Telegiustiziere o telebandito che sia,
non c'è dubbio che il "patron" di Antenna Taranto 6 è diventato un personaggio
scomodo per il potere locale. Tra le vittime illustri delle sue campagne
scandalistiche, si contano anche l'ex sindaco socialista Mario Guadagnolo e
perfino l'ex procuratore capo della Repubblica di Taranto, Nicola Cacciapaglia,
messo alle strette da alcune rivelazioni televisive che ricordano il "caso
Thomas", il giudice americano di colore imputato di molestie sessuali. Anche qui
il magistrato è finito sotto processo per abuso di poteri: l' accusa, secondo il
rinvio a giudizio, è di "aver palpato la spalla e il seno" di una signora contro
la sua volontà, "sbottonato i pantaloni, estratto il membro e facendo forza
sulla testa" costretto la donna "a portare la bocca all'altezza del membro". Sui
muri della città, i graffiti urbani offrono un campionario di umori e giudizi
diversi sul leader del leghismo locale, già definito "il Bossi del Sud", capace
di mettere in scena davanti alle telecamere una traversata a nuoto di dieci
chilometri nel porto per protestare contro l'inquinamento del mare: "Forza Cito
sei tutti noi"; "Cito fatti un litro!"; "Cito=Modeo". Nel bene o nel male, anzi
più nel male che nel bene, si può dire comunque che anche lui è figlio di questa
Taranto, come oggi appare, nato e cresciuto tra i "predoni del deserto".
Ingloriosa fine carriera di un alto magistrato, scriveva il 4 febbraio 1993 “Il
Corriere della Sera”. Il Tribunale di Potenza ha condannato a venti mesi di
reclusione (pena sospesa) e al pagamento di una provvisionale di cinque milioni
di lire Nicola Cacciapaglia, 69 anni, procuratore della Repubblica di Taranto
dall'87 al '90. I giudici lo hanno riconosciuto colpevole del reato di atti di
libidine nei confronti di Anna De Pasquale, cinquantacinque anni, casalinga, di
Taranto. I fatti risalgono al 1989, quando la donna chiese al magistrato di
aiutarla a recuperare una figlia tossicodipendente che rischiava la prigione.
Nell'ufficio del Procuratore, Anna De Pasquale visse momenti allucinanti: il
magistrato non si fermò alle avance, ma le mise le mani addosso e per poco non
la violentò.
LA TARANTO DEI TALEBANI E LA CADUTA DEGLI DEI.
Il progresso, si sa, porta sviluppo tecnologico e
sociale, ma produce anche inquinamento. Inquinamento prodotto dalle industrie,
prodotto dalla circolazione dei veicoli, prodotto dal riscaldamento domestico.
In inverno, spesso, si sente che le grandi città limitano la circolazione dei
veicoli e l’uso del riscaldamento domestico, connubio velenoso, per render più
respirabile l’aria. Proprio a Taranto l’ex sindaco Rossana Di Bello emise
un’ordinanza di divieto al transito in città alle corriere della Sud Est che
portavano i pendolari dalla provincia. Nei paesi sottosviluppati dove si muore
ancora di fame il problema dell’inquinamento non esiste: aria pura e panza
vuota. Ecco perché a nessuno verrebbe in mente di vietare i riscaldamenti o
impedire la circolazione dei veicoli per le strade urbane ed extraurbane, ne
tanto meno si proverebbe a chiudere qualsiasi attività economica, che
direttamente o indirettamente produce inquinamento. Certo è che vige un
principio: tutta quanto è dannoso deve stare lontano da noi, in casa d’altri!!
Purtroppo spesso gli altri siamo noi e dobbiamo farci una ragione. Ovviamente
non manca chi auspica la giunglalizzazione delle città, ma, per fortuna, ancora
sono in pochi.
Inoltre, c’è da considerare un altro aspetto, a
proposito di inquinamento, non c’è solo l'Ilva e non c’è solo Taranto. Ma anche
Gela, Priolo, Bagnoli, Porto Torres, le miniere dell'Iglesiente, Marghera e
decine di altri siti industriali ancora in funzione o abbandonati. Quelli di
interesse nazionale sono 57. Da una stima approssimativa, per la bonifica
servirebbero 30 miliardi di euro, ma nel bilancio del ministero dell'Ambiente,
alla voce "bonifiche" sono disponibili 164 milioni. E la salute delle persone
che lavorano negli impianti ancora in funzione, quelle che vivono nelle
vicinanze, cosa rischiano? Nessuno osa negare, compresi i dirigenti e i
proprietari delle aziende, che qualche problema c'è. E il perenne ricatto è:
bonificare vuol dire chiudere la fabbrica e mandare a casa decine di migliaia di
lavoratori. Ma cosa si è fatto nel passato, cosa si fa oggi e quali sono i
programmi futuri per sanare i siti? Una cosa da non dimenticare: le persone
coinvolte sono più di 6 milioni. In Italia si calcola che i siti potenzialmente
inquinati siano circa 13 mila e di questi 1.500 impianti minerari abbandonati, 6
mila e 500 ancora da indagare e 5 mila sicuramente da bonificare. Poco meno di
13 mila siti sono di competenza regionale (dai distributori di benzina alle
piccole fabbriche che lavorano i combustibili), mentre 57 sono sotto la
giurisdizione statale. Questi ultimi sono definiti dalla sigla SIN, vale a dire
Siti di Interesse Nazionale.
Allora ci si chiede: perché si parla tanto e solo
di Taranto e di ILVA?
«Perché a Taranto ci sono i “talebani”, ossia chi
non sente ragioni contrarie alle proprie – spiega il dr Antonio Giangrande,
presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie” e scrittore-editore
dissidente, che proprio su Taranto ha scritto un libro. – Quelli che nel
privilegio dell’impiego pubblico si dedicano alla pseudo tutela dell’ambiente.
Questi, nel nome della tutela della salute, non chiedono la sanificazione
dell’Ilva, ma pretendono la sua chiusura. Non dell’Eni o della Cementir,
anch’esse gravemente inquinanti: no, dell’Ilva. Questi che vogliono la chiusura
dell’Ilva sono nati con l’Ilva o dopo che questa ha iniziato a produrre. Sono
cresciuti con essa ed anche grazie ad essa. Però, si sa, non c’è gratitudine in
questo mondo. E’ vero che sin da piccolo (ed i decenni son passati) quando mi
apprestavo ad entrare in Taranto, la città da lontano la vedevo avvolta da una
cappa di fumo, ma è anche vero che con l’Italsider (odierna Ilva) la gente non
emigrava più. Tutti lavoravano in Ilva e tutti lavoravano per l’Ilva. Taranto
senza l’Ilva e le altre grandi industrie sarebbe solo una città di cozzari.
Ripeto. Non c’è gratitudine. Per esempio, anche Trieste ha la sua Ilva. Lì è
stato perseguito per calunnia l’ambientalista che denunciava l’esistenza
dell’inquinamento. Paese che vai, usanza che trovi. A Taranto affianco agli
ambientalisti di maniera troviamo chi da operaio è stato traviato dall’azienda e
per gli effetti gli si ritorce contro. Troviamo ancora il capo della procura con
i suoi sostituti e l’ufficio del Gip-Gup che, in generale dai dati elaborati in
Italia, delle procure è la longa manus. Uomini della Procura che nell’inerzia
quarantennale ha deciso di essere deus ex machina senza controllo alcuno e di
decidere, da uomini soli, per un’intera nazione. A proposito degli ambientalisti
sprono della magistratura. Il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli, e il
presidente di Peacelink Taranto, Alessandro Marescotti hanno fornito i dati
dello studio del progetto “Sentieri”. Nel periodo 2003-2008 a Taranto è stato
rilevato un aumento del 24% dei tumori del fegato e dei polmoni, del 38% per i
linfomi e del 38% per i mesoteliomi. Bonelli e Marescotti hanno dichiarato “Il
dato veramente preoccupante è quello dei bambini, per i quali si registra un
+35% di decessi sotto un anno di età e per tutte le cause. Per quanto riguarda
le morti nel periodo perinatale +71%. Questi sono i dati dell’aggiornamento che
il ministro Balduzzi non ha voluto comunicare perché diceva che erano in fase di
elaborazione. E’ falso perché questi dati sono stati elaborati, stampati e
comunicati alla procura della Repubblica il 30 marzo di quest’anno”. Corrado
Clini sostiene che questi dati siano falsi. Per questo motivo ha dato mandato
all’avvocatura dello Stato di procedere nei confronti di Bonelli, che ha
ripetutamente accusato il ministro dell’Ambiente di nascondere i dati sulla
mortalità e di fornire informazioni false sullo stato della salute degli
abitanti di Taranto. Clini ha detto “Fra l’altro mi preoccupa la diffusione di
notizie false che generano allarme tra la popolazione e mirano a intimidire le
autorità competenti in materia di protezione ambiente e tutele della salute”.
Certo è che l’annunciata chiusura dell’Ilva di Taranto potrebbe rappresentare
uno dei più grandi disastri industriali e sociali del nostro Paese degli ultimi
anni, così come il suo funzionamento sembrerebbe esserlo stato per le condizioni
di salute della città. E’ questa la considerazione che viene più spontaneo fare
di fronte ai numeri sconvolgenti che lo stop degli altoforni di Taranto potranno
portarsi come conseguenza più immediata. D’altronde stiamo parlando di
un’azienda che rappresenta il 20esimo gruppo siderurgico del mondo, e dunque non
è difficile immaginare l’impatto che ci sia sull’economia nazionale, sia in
termini occupazionali che finanziari. E cominciamo allora proprio da qui, dal
mettere in fila le prime drammatiche cifre sugli effetti umani e sociali di una
sempre più probabile serrata dell'Ilva. Nella sola zona di Taranto andrebbero in
fumo circa 12mila posti di lavoro, che rappresentano gli addetti diretti allo
stabilimento, cifra che sale però a quota 20mila se si considera l’indotto.
Quello di Taranto infatti rappresenta il più grande sito produttivo siderurgico
d’Europa e allo stesso tempo lo stabilimento industriale con più addetti in
Italia. Un particolare non da poco se si pensa che sorge in un contesto
cittadino dove recenti statistiche parlano di un tasso di disoccupazione che
viaggia intorno al 30%. In pratica chiudere l’Ilva potrebbe significare mettere
in ginocchio l’economia di Taranto e a cascata di altre zone della Provincia e
della Regione Puglia, visto che dei citati 12mila addetti diretti, solo 4mila
sono tarantini, mentre gli altri vengono da fuori. Ma le conseguenze negative
non finiscono qui sul fronte occupazionale, perché lo stop di Taranto si porta
come conseguenza il blocco della produzione anche del sito Ilva di Genova, dove
altri 1.760 dipendenti sono in agitazione perché vedono a rischio il proprio
posto di lavoro. E il fatto che la chiusura dello stabilimento di Taranto si
porti dietro conseguenze occupazionali così pesanti, si lega, come accennato, al
rilievo che la sua produzione di acciaio riveste per l’intera economia italiana.
Secondo i dati forniti dalla Confindustria pugliese infatti, la capacità
produttiva di circa 10 milioni di tonnellate l’anno di acciaio che arrivano da
Taranto, rappresentano circa il 40% del fabbisogno nazionale. Se l’Italia
dovesse essere costretta a importare quantità di questo rilievo, andrebbe
incontro ad una spesa del valore di circa 9 miliardi di euro. Una cifra che
rappresenta circa un punto di Pil nazionale, e il 7-8% del Pil regionale
pugliese. Un vero e proprio disastro economico dunque per il nostro Paese, che
rischia, come accennato, di sfociare in dramma sociale a Taranto, dove monta la
rabbia degli operai rimasti senza lavoro dalla sera alla mattina. Ma chi vive
sulle spalle degli altri con la busta paga pubblica degli operai se ne fotte
(l’intercalare spiega bene l’idea). Gli operai, talebani anche loro. Pronti a
marciare su Taranto o a bloccare la circolazione dei veicoli, usando violenza
sui malcapitati che si son trovati a passar dalle loro parti. Spintoni o gomme
tagliate per chi non solidarizza con loro. L’esasperazione dirà qualcuno. In
Italia, infatti, lavorano solo 23 milioni di persone e il nostro è il paese
europeo col minor tasso di occupazione. In compenso, come è noto, abbiamo 16
milioni di pensionati oltre a un bel po' di disoccupati e un sacco di altra
gente che il lavoro manco lo cerca. E' emergenza disoccupazione. Secondo le
ultime stime provvisorie dell'Istat il tasso generale si è attestato all'11,1%.
Per questo quando si dice che l'Italia lavora, non è vero. L’Italia non lavora e
se ne fotte degli altri, ma il punto è che non vota sfiduciata da questa
politica. Mai così tanti disoccupati, mai così tanti non votanti. C’è difetto di
rappresentanza e la contrapposizione tra interessi è l’effetto. Per questo
motivo, nel venire incontro a tutti gli interessi in campo il decreto legge
varato dal Consiglio dei ministri "stabilisce che la società Ilva abbia la
gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti e che sia
autorizzata a proseguire la produzione e la vendita per tutto il periodo di
validità dell'Aia". Il rilascio a ottobre 2012 da parte del Ministero
dell'Ambiente dell'autorizzazione integrata ambientale ha anticipato gli
obiettivi fissati dall'Unione europea in materia di BAT - best available
technologies (tecnologie più efficienti per raggiungere obiettivi di
compatibilità ambientale della produzione) di circa 4 anni. Con il
provvedimento - spiega il comunicato di Palazzo Chigi - all'Aia è stato
conferito lo status di legge, che obbliga l'azienda al rispetto inderogabile
delle procedure e dei tempi del risanamento. Qualora non venga rispettato il
piano di investimenti necessari alle operazioni di risanamento, il decreto
introduce un meccanismo sanzionatorio che si aggiunge al sistema di controllo
già previsto dall'Aia. "I provvedimenti di sequestro e confisca dell'autorità
giudiziaria - spiega ancora il comunicato stampa - non impediscono all'azienda
di procedere agli adempimenti ambientali e alla produzione e vendita secondo i
termini dell’autorizzazione". "L'Ilva - spiega il comunicato stampa - è tenuta a
rispettare pienamente le prescrizioni dell’autorizzazione ambientale". Palazzo
Chigi definisce il decreto legge "un cambio di passo importante verso la
soluzione delle problematiche ambientali, il rispetto del diritto alla salute
dei lavoratori e delle comunità locali interessate, e la tutela
dell'occupazione". "In questo modo - prosegue la nota - vengono inoltre
perseguite in maniera inderogabile le finalità espresse dai provvedimenti
assunti dall’autorità giudiziaria". Il Cdm stabilisce che la società "abbia la
gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti e che sia
autorizzata a proseguire la produzione e la vendita per tutto il periodo di
validità dell'Aia (sei anni). L'Ilva è tenuta a rispettare pienamente le
prescrizioni. Le bozze del decreto sono state continuamente limate e ritoccate
nel corso del Consiglio. Importante era evitare lo scontro frontale con la
magistratura. Confermata, l'introduzione di una 'figura di garanzia', una
'figura terza' che possa dare fiducia a tutte le parti coinvolte: non un
commissario ma un 'garante' che vigili sull'applicazione rigorosa ed efficace
delle prescrizioni Aia. "Il garante - ha spiegato il sottosegretario Antonio
Catricalà - deve essere persona di indiscussa indipendenza, competenza ed
esperienza e sarà proposto dal ministro dell'Ambiente, dal ministro
dell'Attività Produttive, e della Salute e sarà nominato dal presidente della
Repubblica". Il Garante acquisirà dall'azienda, dalle amministrazioni e dagli
enti interessati le informazioni e gli atti ritenuti necessari, segnalando al
presidente del Consiglio e al ministro dell'Ambiente le eventuali criticità
riscontrate nell'attuazione delle disposizioni e potrà proporre le misure
idonee, tra le quali anche provvedimenti di amministrazione straordinaria.
"Qualora non venga rispettato il piano di investimenti necessari alle operazioni
di risanamento, il decreto introduce un meccanismo sanzionatorio che si aggiunge
al sistema di controllo già previsto dall'Aia", si legge nella nota di Palazzo
Chigi. In caso di inadempienze per l'Ilva - ha spiegato a questo proposito il
ministro dell'Ambiente Corrado Clini - "restano tutte le sanzioni già previste e
in più introdotta la possibilità di una sanzione sino al 10% del fatturato annuo
dello stabilimento". Non solo. "Abbiamo introdotto interventi possibili sulla
proprietà stessa - ha aggiunto il ministro dello Sviluppo Corrado Passera - che
potrebbero togliere enorme valore a quella proprietà: se non fa quello che la
legge prevede, vede il suo valore fino al punto di perderne il controllo di
fronte a comportamenti non coerenti. E' possibile che variamo la procedura di
amministrazione controllata. Insomma, se non si fanno gli investimenti e gli
adempimenti di legge, viene messo qualcun altro a farlo". "Non possiamo
ammettere - ha detto Monti in conferenza stampa - che ci siano contrapposizioni
drammatiche tra salute e lavoro, tra ambiente e lavoro e non è neppure
ammissibile che l'Italia possa dare di sé un'immagine, in un sito produttivo
così importante, di incoerenza. L'intervento del governo è stato necessario
perchè Taranto è un asset strategico regionale e nazionale", ha aggiunto.
"Questo caso è la plastica dimostrazione per il passato degli errori reiterati
nel tempo e delle incoerenze di molte realtà, sia imprenditoriali che
pubblico-amministrative, che si sono sottratte, nel corso del tempo, alla regola
della responsabilità, dell'applicazione e del rispetto della legge". La strada
del decreto è stata intrapresa per evitare - aveva spiegato Monti - "un impatto
negativo sull'economia stimato in otto miliardi di euro annui". Il provvedimento
salva i 12mila dipendenti di Taranto e i lavoratori dell'indotto pugliese. Ma
anche Genova, Novi Ligure, Racconigi. La possibilità di togliere l'azienda alla
proprietà era stata prospettata anche da Clini intervenuto a Servizio Pubblico:
aveva fatto intendere che il governo sarebbe stato pronto a prendere in mano la
situazione nel caso in cui la famiglia Riva non voglia o non possa far fronte
alle prescrizioni. "Sappiamo - aveva spiegato - che per essere risanato quel
sito deve continuare ad essere gestito industrialmente. I Riva hanno detto che
sono ponti a farlo. Il piano degli interventi prevede parchi minerari,
altoforni, batterie delle cokerie. Se non fai questo, è la nostra posizione, non
puoi continuare a gestire gli impianti. Se non sono in grado dobbiamo farci
carico noi con un intervento che consenta di garantire la continuità produttiva
ed il risanamento". Questo è il potere esecutivo, il cui operato sarà
convalidato dal potere legislativo. I magistrati, però hanno una loro ben
definita contrapposizione: «Prendiamo atto che il governo, di fronte ad una
situazione complessa e con gravi ripercussioni occupazionali, si è assunto la
grave responsabilità di vanificare le finalità preventive dei provvedimenti di
sequestro emessi dalla magistratura e volti a salvaguardare la salute di una
intera collettività dal pericolo attuale e concreto di gravi danni», dice il
segretario dell'Associazione magistrati (Anm), Maurizio Carbone, proprio a
Taranto sostituto procuratore. Per Carbone «resta tutta da verificare la
effettiva disponibilità dell'azienda ad investire i capitali necessari per
mettere a norma l'impianto e ad adempiere alle prescrizioni contenute nell'Aia»,
tenuto conto che «sino ad ora la proprietà ha dimostrato di volersi sottrarre
all'esecuzione di ogni provvedimento emesso dalla magistratura». Ed ancora non
ha lesinato critiche al provvedimento d'urgenza di Palazzo Chigi: «È
un'invasione di campo, dov'è finito il principio della separazione dei poteri?
Il decreto legge vanifica di colpo tutti gli effetti dei provvedimenti presi dai
magistrati per la tutela della salute dei cittadini. Il governo, così facendo,
si è preso una grossa responsabilità». Per il gip di Taranto Patrizia Todisco la
nuova Aia per l'Ilva «non si preoccupa affatto della attualità del pericolo e
della attualità delle gravi conseguenze dannose per la salute e l'ambiente».
L'attività produttiva dell'Ilva è «tuttora, allo stato attuale degli impianti e
delle aree in sequestro, altamente pericolosa». I tempi di realizzazione della
nuova Aia sono «incompatibili con le improcrastinabili esigenze di tutela della
salute della popolazione locale e dei lavoratori del Siderurgico», scrive il
gip. Tutela che «non può essere sospesa senza incorrere in una inammissibile
violazione dei principi costituzionali» (articoli 32 e 41). Come è possibile,
sulla base di quanto emerso dalle indagini, «autorizzare comunque l'Ilva alle
attuali condizioni e nell'attuale stato degli impianti in sequestro, a
continuare da subito l'attività produttiva», senza «prima pretendere» gli
interventi di risanamento? aggiunge il gip dicendo no al dissequestro degli
impianti. La partita con l'Ilva non è finita, «abbiamo ancora qualche cartuccia
da sparare», sorride amaro il procuratore capo di Taranto, Franco Sebastio, che
proprio non ci sta a passare per «il talebano», così come viene definito sui
giornali, «il pazzo nemico di 20 mila operai», «se solo avessi cinque minuti per
un caffè con il presidente Napolitano e con Mario Monti racconterei loro dei
bambini che qui nascono già malati di tumore...», si sfoga il vecchio
magistrato. La Procura solleva eccezioni di incostituzionalità del decreto legge
di Palazzo Chigi, chiedendo l'intervento della Corte Costituzionale. Il diritto
all'eguaglianza, ad esempio: la legge è uguale per tutti, no? Ma se la legge è
nata per l'Ilva, dove finiscono i principi di astrattezza e generalità? Intanto,
oltre al sindaco di Taranto, alcuni preti della città, alcuni giornalisti
tarantini, alcuni parlamentari locali, l’inchiesta coinvolge anche la provincia.
Così come per il delitto di Avetrana: nel dubbio, tutti dentro, avvocati
compresi. L'inchiesta afferra il Presidente della provincia di Taranto, Gianni
Florido, un passato importante da sindacalista quale ex segretario regionale
della Cisl e un presente da dirigente locale del Pd. Un'informativa di 182
pagine in parte mutilata da omissis e allegata all'ordinanza di custodia
cautelare che aveva già bussato al palazzo della Provincia, relegando agli
arresti domiciliari l'ex assessore all'ambiente Michele Conserva, lo fulmina in
poche righe. "Si evidenzia - scrivono i militari della Finanza - che alla luce
di quanto accertato, vanno ascritte al dottor Gianni Florido, Presidente della
Provincia di Taranto, specifiche responsabilità penali per il delitto di
concussione o, in subordine, di violenza privata". Certo è che qualcuno dovrebbe
spiegare ai magistrati, che si lamentano quando la legge si stila senza la loro
dettatura, che non vi è scontro tra poteri, proprio perché la magistratura non è
un potere. Se l’articolo 1 della Costituzione detta che “La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, ne
consegue che Potere è quello Legislativo che legifera in modo ordinario e quello
Esecutivo che legifera in modo straordinario. La Costituzione all’art. 104
afferma che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.” Ne conviene che il dettato vuol significare non equiparare
la Magistratura ad altro potere, ma differenziarne l’Ordine con il Potere che
spetta al popolo. Ordine costituzionalizzato, sì, non Potere. Ordine, non
potere, come invece il più delle volte si scrive, probabilmente ricordando
Montesquieu; il quale però aggiungeva che il potere giudiziario é “per così dire
invisibile e nullo”. Solo il popolo è depositario della sovranità: per questo
Togliatti alla Costituente avrebbe voluto addirittura che i magistrati fossero
eletti dal popolo, per questo sostenne le giurie popolari. Ordine o potere che
sia, in ogni caso è chiaro che di magistrati si parla. Per gli effetti l’art.
101 dichiara che “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.” Ergo: i magistrati devono applicare la legge,
rispettarla e farla rispettare, non formarla, né criticarla. Non devono sentirsi
portatori di una missione non loro. E nessuna risonanza mediatica può essere
ammessa, in special modo quando vi sono interessi più grandi che quelli castali.
E si deve ricordar loro, ai magistrati ed alla claque che li santifica, che c’è
anche quella legge ambientale che prevede il dogma “chi inquina paga”. Non
esiste il dettato tutto di stampo tarantino: “chi inquina, chiude i battenti e
tutti a casa”, specialmente se l’industria che viene chiusa, con le tasse che
paga, mantiene i suoi detrattori.»
A tanto fondamentalismo si contrappone una realtà
misconosciuta.
CHI INQUINA PAGA?
I protagonisti di questa storia sono: uno 007, un
Avvocato dello Stato, un Pubblico Ministero, scrive Milena Gabanelli su “Il
Corriere della Sera”. L’Avvocato dello Stato è Giampaolo Schiesaro, che ha
curato il maggior numero di cause giudiziarie in materia di risarcimento del
danno ambientale, (circa 600 milioni di euro da parte di soggetti ritenuti a
vario titolo responsabili per riparare la laguna di Porto Marghera, quasi 2
miliardi liquidati dal Tribunale di Torino per i danni presenti nel lago
Maggiore e nel sito di Pieve Vergonte). Per questa sua competenza era stato
incaricato dal ministro dell’Ambiente, sul finire del 2006, di coordinare
l’attività amministrativa di riparazione ambientale con le più rilevanti
iniziative giudiziarie in tutto il territorio nazionale in applicazione del
principio “chi inquina paga”. A carico dei responsabili, ha fatto recuperare
all’incirca altri 200 milioni di euro, con cui cominciare a finanziare gli
interventi di messa in sicurezza nei siti di Napoli-orientale, Brindisi,
Augusta-Priolo. È evidente che questo nuovo modo di affrontare le questioni
ambientali, presentando direttamente il conto agli inquinatori, ha incontrato
ostacoli e resistenze, fino a quando, con il Governo Monti, la sua
collaborazione non è stata più richiesta e di conseguenza mai più concluse le
intese in corso per finanziare il completamento delle bonifiche.
Su un altro versante Manuela Fasolato, autrice di
rilevanti inchieste sui crimini ambientali in Polesine negli ultimi 15 anni in
qualità di sostituto procuratore presso il Tribunale di Rovigo, si è vista
sottoporre ad ispezione ordinata dal ministro della Giustizia Alfano e a
procedimento disciplinare, tuttora in corso, avanti il Csm. Attualmente la
Fasolato sostiene l’accusa nel dibattimento per i reati connessi alla
riconversione a carbone della Centrale Enel di Porto Tolle.
Prese singolarmente le vicende personali dei due
funzionari dello Stato erano apparse sin qui essere soltanto un’ennesima
testimonianza di una burocrazia statale malata, inefficiente ed incapace di
valorizzare adeguatamente le competenze professionali dei singoli. Oggi
emergono, però, gli esiti di un’indagine penale che suscita interrogativi più
inquietanti, collegando proprio le sorti dei due funzionari dello Stato che
avevano lavorato insieme. Si tratta di un’inchiesta svolta a Padova per minaccia
a pubblico ufficiale, che pochi giorni fa il Gip ha archiviato, ma in compenso
ha fornito lumi su quanto era accaduto.
È stato così accertato che nel giugno del 2007
Ettore Mantovan, funzionario di polizia in forza ai servizi segreti Aisi, si è
presentato a casa di un collaboratore dell’Avvocato Schiesaro per riferirgli che
gli stessi Servizi erano molto interessati all’esito di due procedimenti penali,
allora in fase di indagini, affidati al Pm di Rovigo, Manuela Fasolato, ed in
cui l’Avvocato dello Stato difendeva il Ministero dell’Ambiente. I procedimenti
riguardavano la costruzione dell’impianto di rigassificazione a Porto Viro (Ro)
e la riconversione della centrale Enel di Porto Tolle (Ro): due importanti
interventi industriali, che avrebbero dovuto essere realizzati nelle aree
naturalistiche del Parco del Delta del Po. In quell’occasione fu riferito che i
Servizi stavano “tirando la tela” sia al Pubblico Ministero che all’Avvocato
dello Stato e che, se non avessero interrotto le iniziative processuali, ci
avrebbero pensato loro (i servizi segreti) a fermarli, delegittimando il loro
operato di pubblici ufficiali. Il decreto di archiviazione conferma proprio
questi fatti; tuttavia ha ritenuto che quelle frasi non avessero scopo
intimidatorio, bensì quello di mettere in guardia l’Avvocato dello Stato dai
rischi che stava correndo. Non una minaccia, dunque, ma soltanto una sorta di
amichevole consiglio, proveniente, per ragioni di stima personale, da un
funzionario dei servizi segreti. Lo stesso funzionario dei servizi aveva, poi,
assunto informazioni per conto dei suoi superiori, anche sugli interventi di
riconversione della Centrale Enel, sulla composizione della Commissione
provinciale VIA e sugli studi svolti dal consulente della Procura di Rovigo, dr.
Scarselli, che avevano smentito i risultati tranquillizzanti sui possibili
effetti sulla salute umana che sarebbero derivati da quel progetto di
riconversione a carbone.
Intanto sapere che i servizi segreti
ordinariamente si occupino dell’andamento di alcuni procedimenti penali,
controllino il merito dell’attività svolta da altri organi dello Stato e persino
agiscano concretamente per condizionare o “consigliare”, è notizia che preoccupa
non poco chi crede nel principio della “separazione dei poteri dello Stato”.
Dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini emerge che vi sarebbe
stata anche una richiesta di bloccare l’attività svolta dall’Avvocatura dello
Stato di Venezia nel processo per la costruzione del rigassificatore, da parte
di un rappresentante di uno Stato estero che aveva interesse alla pronta
realizzazione di quell’impianto, per non vedere sfumare un colossale affare,
stipulato nell’aprile del 2008, legato allo sfruttamento di quel gas. Nel corso
di questi anni però Ettore Mantovan viene arrestato dai carabinieri a Padova
(marzo 2011) mentre intasca 50.000 euro da un privato, al quale aveva promesso
il suo interessamento per comporre un accertamento fiscale a suo carico. Per
questa storia di ordinaria concussione Mantovan ha patteggiato 3 anni e due
mesi. Quello che non si sa è se sia stato o meno sospeso dal servizio e
destituito, come dovrebbe avvenire per i pubblici dipendenti che si rivelino
essere una "mela marcia". Così come non si sa se risultino provate altre vicende
analoghe a carico di Ettore Mantovan. In tal caso, infatti, si porrebbe
l'interrogativo su che fine abbiano fatto tutti i soldi "incassati" in quel
modo: li avrebbe davvero tenuti tutti per sé per pagare i propri debiti (di
quali debiti si tratta?) o avrebbe agito su ordine altrui (di chi?), utilizzando
il ricavato per alimentare un sistema "in nero" di finanziamento?
L'AMBIENTALISMO E L'ECOLOGISMO DEI LUOGHI
COMUNI.
Ilva, Bondi intossicato dai luoghi comuni. L'uomo
delle missioni impossibili crocifisso per una banalità. Perché chi tocca certi
pregiudizi muore, scrive Claudio Borghi Aquilini su “Il Giornale”. L'Italia è
il paese delle sentenze già scritte e dei luoghi comuni presi come Vangelo da
folle vocianti. Basta sfiorare il filo elettrificato del luogocomunismo che
anche il più immacolato degli eroi diventa un traditore, un poco di buono, uno
da segnare a dito digrignando i denti. Di questo clima da Barabba ne ha fatto
recentemente le spese un manager quasi divenuto anch'egli un luogo comune
vivente, Enrico Bondi, l'esecutore chiamato a risollevare le sorti dell'Ilva di
Taranto dopo numerose esperienze di «risanatore» fra cui spiccò la rimessa in
carreggiata della Parmalat. Agli occhi del pubblico Bondi è ormai una specie di
agente speciale incaricato delle missioni impossibili, in grado persino di farsi
nominare «supertecnico» dal non rimpianto governo dei tecnici guidato da Monti
senza suscitare indignazione. Bondi ormai non domanda più nemmeno compensi per
la sua attività e, una volta insediato all'Ilva prima come amministratore e
subito dopo come commissario straordinario, ha fatto una cosa banalissima:
chiedere una relazione ad un gruppo di esperti per poter capire meglio il da
farsi. Incauto lui. Vista l'esperienza avrebbe dovuto capire che è obbligatorio
confermare le aspettative degli urlatori dei luoghi comuni, ogni altro esito è
inconcepibile. Nella relazione infatti pare si indichino delle concause che
potrebbero spiegare dati anomali sulle malattie nell'area di Taranto, fra cui il
diffuso smercio di sigarette di contrabbando che vedono nel porto pugliese uno
dei principali centri di importazione di tabacco non trattato e quindi nocivo.
La teoria del resto non è nemmeno nuova, ne ha fatto cenno per esempio in altre
occasioni il professor Franco Battaglia e anche altri studiosi hanno in passato
fatto rilevare che l'Ilva non è certo l'unico «agente inquinante» della città,
come stabilì la relazione del servizio ciclo rifiuti e bonifica dell'assessorato
all'ambiente datata 2011 dove si evidenziavano le responsabilità dell'Arsenale
Militare della Marina nell'inquinamento delle acque. Non importa. Prima ancora
di leggere la relazione, la semplice indiscrezione su contenuti difformi dalla
«voce del popolo» che vuole l'Ilva come origine di tutti i mali del mondo è
stata sufficiente persino ad infangare l'icona Enrico Bondi che ieri si è dovuto
profondere in distinguo, smentite e precisazioni. L'Ilva è morte e non la
vogliamo. I rigassificatori non si devono fare. I rifiuti e le discariche non ne
parliamo, non appena si pensa ad aprirne una ecco che i tumori si impennano e
tutti trovano un morto in casa la cui fotina esibire in favore di telecamere
anche se fosse il nonno quasi centenario. Le relazioni scientifiche servono solo
se funzionali alla tesi: quando dimostrano che certe baggianate come gli
ecoblocchi del traffico non hanno alcun impatto ecco subito i sindaci come
Pisapia a Milano affermare che è vero, contro l'inquinamento non servono ma si
faranno lo stesso per «educare i cittadini». L'ambiente è importantissimo e
bisogna essere inflessibili contro l'inquinamento, specialmente se doloso, però
la salute dei cittadini passa anche attraverso la prosperità economica. Nei
paesi sottosviluppati non c'è mezza fabbrica e l'aria è cristallina, però i
bambini muoiono come mosche. Ogni anno gli incidenti stradali causano 1,24
milioni di morti ma nessuno pensa di vietare le automobili. Un'economia
industriale passa anche per cose che puzzano come centrali, fabbriche e rifiuti.
Secondo la rilevazione 2013 di Legambiente delle 10 città più inquinate d'Italia
9 sono in Pianura Padana (con il non invidiabile primato di Alessandria) e
l'unica «intrusa» non è Taranto, bensì Frosinone, eppure l'aspettativa di vita
in Nord Italia è fra le più alte al mondo. Le paure irrazionali vanno governate
perché la salute è fondamentale ma non cade dal cielo, bisogna guadagnarsela.
CONTRO L'AMBIENTALISMO DEL SEMPRE NO!
Per un ambientalismo del sì. Tempo fa, Barack
Obama si trovava sotto il caldo asfissiante – neanche fosse scritto in uno dei
copioni banali da pomeriggi estivi alla Rosmund Pilcher – dell’atrio
quadrilatero della Georgetown University di Washington. Dalle sue labbra
uscivano le parole del discorso sull’ambiente e sui cambiamenti climatici; dalle
sue labbra pendeva, per certi versi, la futura lettura di certe tematiche,
scrive Emanuele Rossi su “Europa Quotidiano”. Un gran discorso a detta dei
commentatori: non senza polemiche, non ineccepibile, ma di sicuro un indirizzo.
Michael Oppenheimer, professore di geosciences and international
affairs all’Università di Princeton, lo ha definito sul New York Times come uno
«spartiacque» e ha aggiunto che il presidente è andato «oltre il cuore del
problema». Adesso Obama attenderà il prossimo giugno, data entro cui
l’Enviromental Protection Agency dovrà stilare il piano ambientale preliminare –
che con ogni probabilità comunque non sarà operativo prima del 2017. Ci vuole
tempo per certe cose. L’ambiente è tema caro a Obama da sempre (come è tema caro
alla sinistra in genere) e sul quale ha costruito parte del proprio consenso
elettorale fin da subito. Anche se complici circostanze a contorno – la crisi
economica per dirne una, la spinta alla riforma sanitaria per dirne un’altra –
il presidente ha però lasciato in qualche scantinato buio della Casa Bianca, una
buona parte dei buoni propositi del 2008.
Ma da noi come va? So so.
Onestà vorrebbe che ci si guardasse in faccia e ci
si dicesse con serenità che all’interno del dibattito della sinistra riformista
italiana si è un po’ tralasciato il tema. Sembra come se si fosse deciso di
regalarlo a posizioni più radicali, come fossero argomenti di loro esclusiva. Si
è perso tempo, probabilmente è così: magari valutando l’interesse che le istanze
ecologiste occupano all’interno degli orientamenti culturali e politici –
diciamo pure elettorali – degli italiani, come questione marginale. Da “sedile
posteriore”, per dirla come la dicono in Usa. Che magari sarà pure così, poi,
perché in fondo in Italia si parla di ambiente sempre in modo un po’ stanco. E
forse il motivo è anche che gli interessi e le speculazioni hanno spesso finito
per inquinare ogni cosa buona. Ma non c’è da disperare, perché come dice il
saggio, “il meglio deve ancora venire” e sarà da quel meglio che su certe
tematiche si troverà il bandolo della matassa. Sarà infatti soltanto attraverso
una cultura riformista, e chi la incarna, che diventerà possibile affrontare in
modo laico tutti i complessi aspetti delle questioni ambientali. A cominciare da
quella cultura del “NO”, a prioristico, molto nimby, molto più ottusa
disinformazione. Sull’ambiente si è cavalcata la paura. Su quei no si sono
basate le progettazioni. Su quei no e su quelle paure si è scelto il futuro.
Affrontare le tematiche ambientali in modo laico – dando al termine riformista
questa sorta di accezione – significa analizzare con serietà e profonda
competenza ogni possibile situazione senza lasciare spazio a quelle paure,
infondate e spesso speculative. Serve essere freddi, razionali, pragmatici,
serve guardare oltre. Serve progettare. Serve comprendere e condividere. Davanti
alla nostra realtà si pone la necessità di governare il complicato processo di
transizione che trasformerà il nostro sistema produttivo e di utilities e lo
posizionerà nel nido della sostenibilità. Sarà un passaggio fondamentale, anche
nell’ottica della competitività internazionale. Ma nel lavorare per le tematiche
ecologiche del rendere le nostre vite e i nostri consumi equi e sostenibili, la
cultura riformista dovrà operare anche nella tutela dei nostri beni comuni dalle
evenienze ambientali. Su questo aspetto tanto si è già fatto per la prevenzione
sismica, con risultati ampiamente soddisfacenti (nell’ambito del rispetto delle
regole). Buona parte si sta facendo per ridurre le emissioni e abbattere gli
inquinamenti. Poco, troppo poco, invece si fa nella tutela del suolo, che poi
coincide inevitabilmente con la tutela del territorio, del paesaggio e di
quel genius loci che ci portiamo nei nostri geni. Basta pensare che l’Italia è
un paese in cui il dissesto idrogeologico interessa molte fasce del territorio:
8,9 per cento del territorio collinare è in frana, molto di più quello
suscettibile e/o vulnerabile. Si parla di aree collinari, ma anche di zone
produttive e di porzioni di insediamenti abitativi. Discorso analogo vale per le
aree soggette a inondazioni. Frane e alluvioni sono una piaga ancora più aperta,
ancora più dolorosa, degli eventi sismici. Colpiscono continuamente, passano
alla ribalta della cronaca soltanto in situazioni parossistiche, ma i movimenti
del suolo e gli allagamenti, continuano a recare danni ogni volta che piove. E
purtroppo ai danni materiali, spesso si associa la perdita delle vite umane. Il
conto per la sistemazione di tutte le condizioni legate a questi rischi è
oneroso. Si parla di miliardi di euro. Occorre però iniziare a metterci la
testa, il pensiero, ma anche le mani. Una proposta semplice, per dire, sarebbe
di pensare, anziché ad abolire l’Imu – battaglia ideologica, di dubbia
provenienza, e di certo appeal –, di destinare quel gettito per intervenire
sulla difesa idrogeologica. Ma al di là della proposta da bar – poi mica tanto –
occorre che si dia un indirizzo, dettando regole strette per la programmazione
urbanistica, intervenendo con quello che è disponibile, preservando e
prevedendo, incrementando – questo sì – i fondi per i sistemi di studio ricerca
e monitoraggio. Affrontare il problema in modo diretto, senza nascondersi in
confortevoli scorciatoie, mezze soluzioni, arrangiamenti e rimedi casalinghi:
perché è ora, adesso. Inculcare negli italiani una sorta di ambientalismo
responsabile, deve essere uno degli obiettivi della cultura riformista.
Permettere il ragionamento, il confronto, l’analisi. Senza chiudersi in custodie
ideologiche. Ambientalismo è dire “sì”, è essere propositivi e risolutivi. Ed
occorre essere fermi, controllare e regolare, senza lasciare spazio tra le
maglie delle norme. Mi riferisco per esempio alle tante centrali a biogas nate
come funghi: con le colture dedicate (vero schiaffo antisociale al buon senso,
senza ricorrere a disturbare la sovranità alimentare), con dimensioni quasi
sempre inferiori ad 1MW (fino a 0,99 non è richiesta la valutazione d’Impatto
ambientale, e dunque la procedura amministrativa è più snella e meno soggetta
controlli). Ma ampio il discorso anche agli abusi, al fuorilegge: a quelle
attività mafiose legate all’ambiente, le Ecomafie, che secondo
Legambiente produrrebbero un valore annuo di 16,7Mld e 34120 reati, 8286
sequestri e 302 clan coinvolti. Per affrontare certe questioni e le complessità
tentacolari connesse, serve determinazione, serietà, ma anche coraggio e
leadership, e serve certe volte di essere impopolare. Di andare oltre il
visibile, la miopia del presente con tutte le sue contestazioni, progettando per
il futuro.
AUTO ELETTRICHE: LA MENZOGNA DELL’EMISSIONE
ZERO.
L'auto elettrica sarà anche verde, ma è un verde
sporco, scrive Roberto Iasoni su “Il Corriere della Sera”. Mentre quella
tradizionale, con il motore a benzina o a gasolio, è più pulita. A lanciare
l'accusa è il Wall Street Journal . Niente di più falso della retorica eco-chic
dell'auto a «emissione zero». Che si tratti della Fisker Karma da 100 mila
dollari (circa 77 mila euro) dell'attore Leonardo Di Caprio o di una più
popolare - si fa per dire - Nissan Leaf (in Italia 29.950 euro con gli
incentivi, che scatteranno il 14 marzo; negli Usa 28 mila dollari, circa 21.500
euro), secondo l'autore dell'articolo, Bjorn Lomborg, scienziato e
«ambientalista scettico» (autodefinizione messa come titolo a un libro del
2001), l'auto elettrica sarebbe un pessimo affare. TUTTO SULLE ELETTRICHE:
PREZZI E SCHEDE
Lomborg non è certo sceso in campo contro un
fenomeno di massa: l'anno scorso negli Usa sono state immatricolate 50 mila auto
con la spina, su 14 milioni e mezzo di veicoli venduti. Il mercato non è neppure
«di nicchia». Il gruppo Renault-Nissan ha venduto nel mondo il maggior numero di
auto a batteria: 68 mila nell'ultimo biennio. Ma sono quelli che nel 2011
vagheggiavano un milione e mezzo di veicoli elettrici su strada. Il caso
italiano è addirittura invisibile: meno di 500 auto nel 2012, quasi tutte nelle
flotte (quelle acquistate da clienti privati sono una trentina...). Eppure
Lomborg va giù duro. La demolizione si concentra sulla CO2. «Emissioni zero»?
Balle. Perché per produrli l'anidride carbonica sviluppata è imponente e supera
di molto (a causa delle batterie al litio) quella delle auto tradizionali.
«L'elettrica non è ancora uscita dalla fabbrica - è la sintesi - che ha già
emesso 14 mila kg di CO2, più del doppio rispetto alle altre». Lomborg ha fatto
i suoi conti: nel ciclo di vita (calcolato in 80.500 km), l'auto elettrica
emette 8,7 tonnellate di CO2 in meno rispetto alla «cugina» convenzionale. Ora,
posto che ogni tonnellata di anidride carbonica provoca un danno sociale
quantificato in 5 dollari, meno di 4 euro, il risparmio ottenuto con i veicoli a
batteria risulta di 44 dollari (34 euro) a veicolo. «Un pessimo affare anche per
il contribuente - conclude il WSG - se si considera l'incentivo di 7.500 dollari
concesso dallo Stato americano». «La solita storia della CO2», risponde per il
«partito» dell'auto elettrica l'ingegner Pietro Menga, presidente del Cives, la
Commissione italiana veicoli elettrici. I dati di Lomborg, per Menga, tengono
conto della realtà Usa: «Dove il mix di fonti da cui si ricava l'energia
elettrica - spiega l'ingegnere - è pesantemente condizionato dal carbone. In
Italia il mix è più pulito: il carbone incide per il 13 per cento, mentre le
fonti rinnovabili, solare, eolico e geotermico, sono il 32». Così «in 1 km
l'auto elettrica emette alla fonte, cioè al camino delle centrali, 60/70 grammi
di CO2, contro i quasi 200 delle auto a combustione interna». In linea con la
media europea. Un vantaggio, rispetto allo scenario Usa, certificato da uno
studio del Politecnico norvegese apparso a fine 2012: «Il mix energetico europeo
consente una riduzione del contributo all'effetto serra fra il 10 e il 24 per
cento rispetto ai veicoli tradizionali». Senza contare, prosegue Menga, che
ridurre tutto alla CO2 è un errore: «L'anidride carbonica provoca l'effetto
serra, d'accordo, ma non è un inquinante - tiene a precisare -. Infatti le città
vengono chiuse per la concentrazione di polveri sottili, monossido di carbonio e
ossidi di azoto. Tutti veleni che l'auto elettrica, non avendo un tubo di
scarico, non può soffiare nell'aria».
L'auto elettrica? Inquina già da ferma. La
produzione di vetture ecocompatibili causa maggiori emissioni di anidride
carbonica di quelle "normali", scrive Valerio Boni su “Il Giornale”. L'Italia
si appresta ad avviare una nuova fase di incentivi riservata ai cosiddetti
veicoli ecocompatibili, che scontenterà molti per come è stata concepita, e dal
resto del mondo fioccano studi che incrinano l'integrità delle auto a emissioni
zero. Dall'Università delle Scienze di Norvegia sono infatti rimbalzati, negli
Usa, i risultati di uno studio che analizza in modo più imparziale l'impatto
sull'ambiente di una vettura elettrica. In sostanza, non è corretto considerare
come quintessenza dell'ecocompatibilità un veicolo solo perché non emette alcun
tipo di gas quando è in movimento. Bisogna infatti considerare l'intero ciclo
vitale, dalla costruzione allo smaltimento di ogni componente. Il rapporto
specifica che per la costruzione di una vettura a emissioni zero i siti
produttivi emettono maggiori quantità di rifiuti tossici, a partire dalle
emissioni di CO2, rispetto a quanto avviene per un modello alimentato a benzina
o a gasolio. In più, la produzione di motori elettrici e delle batterie
necessarie per la loro alimentazione richiede l'impiego di materiali
potenzialmente tossici come nichel, alluminio e rame. L'ultimo aspetto riguarda
l'impiego dell'energia per dare movimento a questi veicoli. Si dice che siano a
impatto zero sull'ambiente, ma questo è vero solo quando si muovono sulle
strade. Quando invece sono collegati alla rete elettrica per la ricarica,
consumano e inquinano come qualunque elettrodomestico, visto che attingono da un
circuito alimentato in parte da combustibili fossili. E tutto questo, secondo lo
studio, non può essere trascurato. In America il Journal of Industrial Ecology
ha a sua volta recentemente analizzato l'intero ciclo di vita di un veicolo
elettrico, partendo dall'impatto tutt'altro che «verde» dell'estrazione del
litio, indispensabile per realizzare le batterie dell'ultima generazione. Di
conseguenza, circa la metà delle emissioni di anidride carbonica disperse
nell'ambiente pesa su un'auto definita a emissioni zero, già prima della sua
commercializzazione. Mentre per un veicolo classico, il bilancio si ferma al 17
per cento. Si può pertanto dire che quando si acquista una quattro ruote
elettrica, si parte con un debito equivalente alla quantità di CO2 che
disperderanno nell'ambiente le centrali per fornire le ricariche necessarie per
percorrere circa 130mila km. I conteggi vanno anche oltre, considerano che la
vita media di un veicolo elettrico non vada oltre le 50mila miglia, vale a dire
80mila km, quindi il bilancio va rivisto. Ma anche considerando che si possa
arrivare a 150mila km, il vantaggio per l'ambiente si ridurrebbe al 24 per cento
rispetto alle auto che guidiamo ogni giorno. Quindi ben lontano dalle emissioni
zero. Le analisi sul reale impatto potrebbero rallentare l'esplosione di un
mercato che negli Stati Uniti n(ma anche da noi) non è mai veramente decollato.
L'anno scorso si è chiuso con 14.287 veicoli venduti, e nel 2013 si potrebbero
superare i 30mila. Ma difficilmente sarà possibile raggiungere la soglia del
milione di auto elettriche, obiettivo di Obama entro il 2015. In Italia le cose
non vanno meglio, con le vendite che incidono in modo ancora irrilevante sul
totale. Sono raddoppiate, è vero, in un anno che ha visto una forte contrazione.
Però si è passati dallo 0,02 allo 0,04 per cento, che su 1,4 milioni di auto
vendute significa circa 520 esemplari. L'aiuto allo sviluppo sarebbe dovuto
arrivare dagli incentivi che saranno varati a partire dal prossimo 14 marzo: 40
milioni di euro per l'acquisto delle vetture meno inquinanti. Ma per i privati
lo stanziamento si limita a 4,5 milioni di euro: circa 3.800 pratiche, che si
esauriranno molto presto.
ENERGIA PULITA? SPORCO AFFARE.
Energia pulita, sporco affare. In cinque anni 126
arresti. Per le truffe sull'eolico altri 106 denunciati. Corruzione e manette
anche per il fotovoltaico. Alle mafie fanno gola gli incentivi pubblici scrive
Gianpaolo Iacobini su “Il Giornale”. Soffia il vento. E fa girare gli affari.
Non sempre leciti, sempre più in odor di mafia. L'energia pulita è diventata un
business, e come tutti i business attira voglie inconfessabili. Quelle delle
cosche, ad esempio. In Molise, che insieme a Sicilia, Calabria, Puglia,
Basilicata e Campania ospita quasi l'80% dei parchi eolici esistenti in Italia
(erano 807 quelli censiti alla fine del 2011 dal Gestore dei Servizi Energetici:
quasi il doppio rispetto all'anno precedente) quattro mesi fa l'associazione
«Caponnetto» ha presentato un dossier per denunciare le infiltrazioni della
Camorra nel settore. Ma l'allarme lo aveva lanciato già la Commissione
parlamentare antimafia due anni fa, indicando le crepe attraverso le quali
infila i suoi tentacoli la piovra mafiosa per far cassa con vento e sole: i
cospicui finanziamenti pubblici, spesso a fondo perduto; la farraginosità delle
procedure burocratiche, che favorisce l'attività di mediazione illecita dei
burocrati dalle mani lunghe; il mercato dei terreni candidati ad ospitare
aerogeneratori e pannelli solari. E ancor più preciso era stato il Cnel, che nel
maggio del 2012, in un rapporto forse troppo in fretta dimenticato, aveva dato i
numeri. Drammatici: tra il 2007 ed il 2011 ben 17 sono state le inchieste aperte
da 14 Procure sui parchi eolici, tutte concentrate nelle cinque regioni
meridionali; 106 le persone denunciate, 126 quelle arrestate. L'ultimo blitz
della serie è scattato l'altro ieri, nel Messinese: cinque persone sono finite
in galera per un appalto da 120 milioni legato ad un nuovo parco eolico: su quei
soldi, secondo la Dda, s'erano fiondate le cosche della zona. E con loro il
sindaco di Fondachelli Fantina, Francesco Pettinato: per gli inquirenti avrebbe
prima bloccato l'iter dei lavori. Poi, ottenuta la certezza che nei cantieri
sarebbero entrati la ditta del cugino e operai di fiducia, avrebbe dato il via
libera. Li hanno fermati i carabinieri alla vigilia della concessione, da parte
della Regione, d'un finanziamento di 80 milioni. Fiumi di denaro che scatenano
appetiti e spingono la mafia a fare impresa. Lo scorso dicembre, nel Trapanese,
i ferri erano scattati ai polsi dell'imprenditore Salvatore Angelo e di cinque
persone (tra cui un consigliere provinciale): le microspie lo avevano
intercettato mentre si vantava d'essere «un grande amico di Matteo, anche se per
adesso non ci posso andare a incontrarlo». Per gli investigatori, il Matteo in
questione era Messina Denaro, capo di Cosa Nostra, spendendo il cui nome Angelo
era riuscito a mettere in piedi una rete di società attive nella realizzazione
di impianti di energia pulita. Eccezioni? A quanto pare, la regola. O quasi. E
non solo in Sicilia: a metà dicembre in Puglia 13 ordinanze custodiali avevano
raggiunto altrettanti indagati, sospettati di truffe architettate per prendersi
i fondi regionali destinati al fotovoltaico. A Novembre indagini chiuse, in
Toscana, sul parco solare di Spicciano, realizzato con fondi europei e modalità
ritenute illegittime. Il 13 luglio del 2012, invece, in Calabria, i riflettori
della Dda si erano accesi sulla cosca degli Arena, che nel loro feudo di Isola
Capo Rizzuto, con l'ipotizzata complicità di 31 tra imprenditori e funzionari
regionali (sotto inchiesta l'intero nucleo di valutazione di impatto ambientale
della Regione), avevano tirato su un impianto eolico tra i più grandi d'Europa,
al prezzo di diversi reati ambientali ed urbanistici, aggravati dalle modalità
mafiose. I pali del vento? «Robba bona. Si nun si svigghia uno nun pigghia».
Tradotto: «Roba buona, se non ci svegliamo non si prende», si dicevano al
telefono due picciotti. Stavano svelando, a chi li ascoltava, la rotta per il
nuovo Eldorado di mamma mafia: l'eolico.
I tralci contro i tralicci. A prima vista, quella
della Terra del Primitivo contro i giganti dell’energia eolica, sembra una
guerra impari, scrive Massimo D’Onofrio su “Il Corriere del Giorno”. Non per
questo i proprietari di aziende agricole, ma anche di altri settori produttivi,
che hanno fatto nascere il comitato “La strada delle masserie” pensano che non
valga la pena di combatterla. A costo di lottare, letteralmente, contro i mulini
a vento che tre società hanno intenzione di impiantare «nella culla del
Primitivo», la prima Docg, denominazione d’origine controllata e garantita, di
Puglia: «La zona più vocata per la produzione di vino di altissima qualità».
Qualcosa di molto simile alle colline del Brunello, in Toscana, che nessun
individuo sano di mente penserebbe di “manomettere”. Il problema, basti
ricordare la vicenda del comune di Scansano e di Jacopo Biondi Santi, il patron
del Brunello e del Morellino, è che le pale eoliche sono arrivate pure lì.
Tornando a Manduria, le richieste di autorizzazione sono approdate in Regione
Puglia ad ottobre 2011 per la verifica di assoggettabilità alla Via, valutazione
d’incidenza ambientale. Un percorso non semplice e molto ben “mimetizzato” nei
faldoni degli uffici regionali, che solo dopo un anno è “emerso” sull’albo
pretorio del Comune di Manduria scatenando la rivolta di ambientalisti,
associazioni di diversa estrazione, un partito politico (i Verdi) e, ora, delle
aziende che operano sul territorio che va da Manduria ad Avetrana. Il commento
più ricorrente è uno solo: «Assurdo». «Come è possibile – ci si chiede – che
nessuno si ricordi che questa è la terra del Primitivo?». Già. Del comitato
fanno parte 19 proprietari, piccoli, medi e grandi, di aziende come la vinicola
Gianfranco Fino, agriturismi, ma anche eccellenze come la masseria Potenti
oppure un’azienda che produce vetri artistici che adornano le più belle chiese
del mondo. Non riescono a capacitarsi all’idea di vedere pale eoliche piantate
tra vigneti e muretti a secco, tra siti archeologici e masserie storiche.
«Stiamo inviando le nostre osservazioni, come singoli e come comitato alla
Regione Puglia», fanno sapere, soprattutto perchè, oltre a considerazioni di
tipo ambientale, vorrebbero capire perchè dalle cartografie risulta che «torri
eoliche potrebbero sorgere sulle nostre terre senza che noi ne sappiamo nulla».
«Un impatto devastante – sottolineano – che potrebbe distruggere il paesaggio e
senza alcuna utilità per il territorio». Il business, evidentemente, segue altre
dinamiche. Il che, tuttavia, non è in grado di far svanire i dubbi che aleggiano
su un’operazione da centinaia di milioni di euro: «Com’è possibile che tre
società nate lo stesso giorno, il 13 ottobre 2010 e domiciliate allo stesso
numero civico di una via di Manduria, pur risultando inattive sono in grado di
portare avanti un progetto di queste proporzioni?». Il deus ex machina,
scorrendo le visure camerali, parrebbe Enrico Minoli, fratello del più noto
Giovanni, che risulta amministratore e tra i proprietari delle tre “s.r.l.”,
società da 10mila euro di capitale (Manduria Green, Messapia Energia e Monte),
che hanno aperto la caccia grossa al vento che spira tra i vigneti. Aria che
diventando energia elettrica – e grazie ai lauti incentivi statali, seppur
ridimensionati – può fruttare milioni di euro di introiti. Alla faccia
dell’ambiente.
Non sono 63 ma 136 le torri eoliche che
circonderebbero Manduria qualora i progetti presentati dovessero essere
approvati, scrive “La Voce di Manduria”. Lo si apprende dalla voluminosa
documentazione che accompagna le domande di valutazione di impatto ambientale
presentate (Via) alla Regione Puglia dalle società «Monte», «Messapia energia» e
«Manduria Green», tutte riconducibili agli ingegnerei Santo Masilla di Erchie,
Leonardo Filotico di Manduria, Enrico Minoli di Torino ed altri soci del Nord
Italia. Oltre alle 63 torri dei parchi eolici già noti (zona Castelli e via Per
San Pancrazio), infatti, sono in programma altri 5 aerostazioni in contrada
Giustiniani (tra la via per Maruggio e Uggiano Montefusco), 21 ad Avetrana e 30
ad Erchie, tutti al confine con i territori di Manduria, che si sommerebbero ai
17 già autorizzati e in fase di installazione sempre ad Erchie. Una vera foresta
di pali, quasi tutti alti 100 metri, 140 metri compreso il braccio rotore, nel
raggio di circa dieci chilometri dall’abitato manduriano (i più vicini
addirittura e poco più di 2 chilometri). Il loro impatto visivo, anche questo
illustrato negli elaborati che accompagnano la richiesta di Via, sarebbe
impressionante per occhi abituati alle distese di vite e uliveti delle nostre
terre. Per i progettisti, invece, su una scala di valori classificati in «nullo,
basso, medio e alto», i parchi in questione avrebbero un effetto impattante
valutato tra «basso e medio». Dalla «mappa di visibilità» della Via, ad esempio,
l’analisi fatta dai progettisti prevede questa percezione per chi guarda da
Manduria verso Avetrana o Lecce: «Dal Punto 3 (centro abitato di Manduria) – si
legge – si potrebbero vedere gli aerogeneratori del parco eolico Manduria 48,
Manduria 84, Manduria 57, Erchie 32 e Eolico-Erchie e 4 aerogeneratori del campo
eolico Erchie 28». Ma veniamo all’affare degli investitori. Tutti i parchi
previsti messi insieme (136 torri) comportano un investimento di 272 milioni di
euro. I ricavi previsti (dati elaborati su un parco eolico e rapportati sul
totale delle torri) saranno pari a 72 milioni di euro circa per ogni anno di
funzionamento (durata media degli aerogeneratori, 20 anni). L’energia prodotta
che sarà di 497 MW, è sufficiente al fabbisogno di 181mila famiglia, cioè per
una citta grande quasi quindici volte Manduria. A vantaggio della comunità ci
saranno i posti di lavoro, i royalty per il comune e naturalmente il risparmio
di immissioni inquinanti nell’atmosfera come accade per le fonti di energia
tradizionali.
Da qui la presa di posizione degli ambientalisti
ed altri comitati tematici. Su “Manduria Oggi” i Verdi: «A causa della
speculazione legata alle fonti di energia rinnovabili, la nostra città rischia
di ritrovarsi circondata da una ben poco decorativa “cintura” di parchi eolici».
I Verdi intervengono per denunciare l’“ennesimo attacco al territorio e al
paesaggio”. «Si tratta di tre impianti per i quali è avviata presso la Regione
Puglia la procedura di VIA, i cui avvisi sono comparsi sull’albo pretorio
on-line del Comune di Manduria, per un totale di 63 torri da 3 MW/cad. Due di
tali impianti dovrebbero sorgere approssimativamente lungo la via per Lecce,
andando a sommarsi a quelli già in fase di realizzazione, su territorio di
Erchie. Il terzo e, a nostro avviso, più impattante, dovrebbe interessare una
vasta porzione di territorio che dalle adiacenze della via per S. Pietro in
Bevagna si spinge sino alla via per Avetrana, andando a compromettere, con le 28
torri previste, zone di grande interesse paesaggistico ed archeologico, quali il
cosiddetto monte dei Diavoli, le colline di contrada Serpente, il bosco dei
Cuturi, le aree intorno alla collina di Castelli, con i resti della città
preromana e tutti i siti archeologici circostanti. In questo caso vediamo
minacciata l’integrità di un territorio e di un paesaggio che andrebbero
tutelati per ciò che conservano di integro dal punto di visto naturalistico e
culturale, anche, ma non solo, in vista di uno sviluppo turistico di cui tanto
parliamo, ma che costantemente compromettiamo con i nostri comportamenti
pubblici e privati».
Ed ancora su “Manduria Oggi” è stata pubblicata
questa lettera. «Noi componenti del Comitato Cittadino Antinucleare di Maruggio,
non come cittadini spettatori passivi, ma come protagonisti attivi nel proprio
territorio, riteniamo un diritto-dovere prendere parte alla discussione ed
esprimere le proprie posizioni circa qualunque iniziativa volta al cambiamento
sul nostro territorio. L’impatto ambientale di qualsiasi opera non può essere
limitato ad una valutazione soltanto paesaggistica o ambientale in senso
stretto. Non si può scollegare un ambiente, inteso come micro e macro sistema,
dal suo percorso evolutivo naturale, dal suo percorso evolutivo antropico
(evolutivo o involutivo); non lo si può considerare indipendentemente dalle
scelte, volute o imposte, di tipo economico e politico che ne hanno indotto le
trasformazioni. Non si può valutare l’impatto di una pala eolica (e qui si parla
di ben 84 megatorri di 3 MW ciascuna!) non legandolo al contesto complessivo del
territorio su cui essa verrà eretta. In tutto questo tempo il territorio
tarantino ha subito pesantemente un certo percorso trasformativo. La provincia
jonica, oggi, non ha più primati di vino, olio, mitilicoltura, prodotti
lattiero-caseari, artigianato del legno e della pietra; tutti questi si sono
trasformati in primati di acciaio, diossine, discariche per rifiuti speciali. La
presenza per più di mezzo secolo dell’industria pesante, della monocoltura
dell’acciaio, dell’Eni, degli apparati militari, della cementificazione del
territorio, dello scippo dei terreni agricoli ad opera di discariche e di mega
impianti di energia rinnovabile, ha letteralmente distrutto questo territorio,
lo ha reso pressoché sterile nelle sue economie e culture/colture autoctone,
condannandolo ad una desertificazione ambientale, sociale ed occupazionale. Per
questo motivo, non quello di 84 ma nemmeno il progetto di una sola pala eolica
dovrebbe essere ancora autorizzato. Diversamente qualsiasi progetto del genere,
al di là se interessa le zone orientali od occidentali di Taranto, assumerebbe
di fatto il significato di accanimento su un ambiente già moribondo, di un
ulteriore massacro su un territorio già cadavere. Ma cos’è la realizzazione di
un “parco” eolico di 84 torri se non una centrale elettrica privata di tipo
industriale costruita su terreni destinati ad un uso agricolo?
- La prima considerazione da fare riguarda la
produzione di energia elettrica. Da troppo tempo la produzione di energia verde
da fonti rinnovabili viene sbandierata come la salvezza dall’uso dei carburanti
fossili. In realtà a tutt’oggi non un solo kWh di energia da carburanti fossili
è stato sostituito da energia verde. Proprio la Puglia ne è l’esempio più
eclatante. Nonostante sia diventata la regione leader nella produzione di
energia verde, continua a mantenere alta ed intaccata la sua enorme produzione
energetica da carburanti fossili, esportando almeno il 90 % dell’energia
prodotta. Di fatto, altri usufruiscono del prodotto finito e pulito (l’energia),
mentre sul nostro territorio rimangono le conseguenze impattanti e contaminanti
della produzione di questo surplus energetico; veleni che si sommano a quelli
del ritorno degli scarti industriali prodotti altrove e destinati a quelle
discariche per rifiuti speciali di cui il territorio tarantino vanta il triste
primato delle tre discariche più grandi a livello europeo.
- La seconda considerazione è di ordine economico.
Al di là del fumo negli occhi della gente, della parvenza di energia pulita non
inquinante, questi mega impianti servono soltanto ad incrementare gli interessi
privati del business dell’energia. Si tratta per lo più di multinazionali o di
vera e propria criminalità organizzata che, attraverso regolamentazioni
nazionali, regionali e locali permissive, sfruttando il cosiddetto “libero”
mercato dell’energia, operano un vero e proprio saccheggio del territorio.
Inoltre molti di questi finanziamenti/capitali non rimangono nemmeno in loco e
facilmente prendono la via dell’estero. Ma chi finanzia tutto questo? L’intera
collettività spesso è ignara di pagarsi le proprie torture. Le nostre sono le
bollette più care d’Europa e sono tali perché gli italiani, all’oscuro di tutto,
con queste finanziano anche gli incentivi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili (Cip6 in cui c’è di tutto e di più) e persino l’eterna eredità del
nucleare. Si tratta di voci che non compaiono direttamente sulle bollette, ma
vengono mascherate con la dicitura di “oneri generali di sistema”, gestite da
aziende non più pubbliche bensì private che, come per esempio l’Enel spa,
addirittura partecipano alla costruzione ed alla gestione di centrali nucleari
all’estero … ma con quali risorse? Forse servono anche a questo i rincari delle
nostre bollette? E che dire della mascherata contraddizione dei due percorsi di
produzione energetica (da fonti fossili e da fonti rinnovabili) che continuano a
viaggiare sempre perfettamente paralleli? Ma di quale salvezza verde si parla se
continuano costantemente e massivamente le ricerche con i trafori petroliferi?
L’esempio della Shell, chiaramente nel golfo di Taranto, è uno dei più
eclatanti. Forse è proprio questo uno degli scopi dei certificati verdi che gli
italiani continuano a pagare con le super-bollette?
- La terza considerazione è di ordine
occupazionale, culturale e giurisdizionale. Un semplice cittadino incontra una
miriade di difficoltà ed è soggetto ad una moltitudine di vincoli per avere
autorizzazioni anche per piccoli lavori; al contrario gli imprenditori del
mercato energetico, nonostante siano coinvolti in mega opere che interessano
superfici di migliaia di ettari, sono enormemente facilitati nell’autorizzazione
dei loro progetti. Spesso questi riguardano zone con vincoli assoluti quali zone
Sic, zone in prossimità di parchi naturali o della battigia, e contemplano
persino l’esproprio di terreni di piccoli agricoltori con la giustifica della
pubblica utilità. Con la solita scusa del ricatto occupazionale si continua a
cementificare sempre di più il territorio. In realtà l’occupazione che si riesce
a garantire con questo tipo di opere non solo è veramente ridotta, ma
soprattutto è temporanea e precaria, vista la sua dissoluzione con la messa in
opera del manufatto. Al contrario volutamente non si calcola quanta mano d’opera
viene sottratta all’agricoltura sia perché costantemente avviene il furto di
terreni agricoli fertili, sia per il deprezzamento del valore del terreno e
della stessa produzione agricola. La svalutazione ed il deprezzamento dei
prodotti agricoli hanno raggiunto oggi una tale insostenibilità da far diventare
legittima la domanda: c’è forse un programma appositamente costruito per
costringere gli agricoltori a svendere ed abbandonare quella terra che ha
rappresentato la storia, la cultura ed il sostentamento di chissà quante
generazioni della provincia jonica? Non è un caso che volutamente si parla di
sostenibilità e non di compatibilità continuando a recitare la commedia per la
salvaguardia e la tutela della qualità di agricoltura e turismo.
- La quarta considerazione è di natura tecnica
generale. Come al solito, quando si parla di una qualsiasi fonte energetica non
si prende mai in considerazione l’intera filiera. In realtà sarebbe opportuno,
doveroso e necessario fare una valutazione complessiva comprendente il prima e
il dopo dell’installazione del manufatto; di come e quanto necessita per
arrivare a quella pala; qual è il suo rendimento e bilancio energetico; di cosa
ne sarà quando questa non funzionerà e non servirà più … ma di tutti questi
discorsi post pala nemmeno l’ombra! Forse anche per questo motivo queste energie
vengono definite rinnovabili? perché le loro presenze si rinnoveranno di
generazione in generazione, nel solito rimpallo di responsabilità ed
incompetenze di chi si sente padrone di tutto e concepisce la vita ed il mondo
solo come oggetto di profitti contingenti … scordandosi che esistono anche
l’etica e la dignità altrui. Oggi, la comunità tarantina può vantare l’appoggio
dell’Amministrazione provinciale che, con il suo secco No alle 84 pale fra
Manduria ed Avetrana, dimostra una volontà ambientalista veramente sorprendente.
Certo c’è da chiedersi dov’era questa stessa Amministrazione quando in passato
erano in itinere altri progetti di parchi eolici riguardanti addirittura il
pregiato Parco delle Gravine. Come dire … meglio tardi che mai. Noi auspichiamo
in futuro una continuità con la posizione presa attualmente. Per questo, lo
scrivente, propone alla Provincia di Taranto l’istituzione di un COMITATO
PROVINCIALE con lo scopo almeno di censire l’intero territorio evidenziando sia
le opere già realizzate che quelle in progetto visto che facilmente queste
possono sfuggire o rifugiarsi nei meandri burocratici di Regione, Provincia o
Comuni. Non dimentichiamo che alla Puglia spetterebbe soltanto una quota
dell’intera produzione nazionale di energia da fonte rinnovabile mentre invece
di questo passo rischia di produrla quasi per intero. Il COMITATO PROVINCIALE,
proprio per evitare situazioni di “nicchie”, è auspicabile che sia composto ed
esteso a tutti i comitati territoriali che già operano e si impegnano nel
proprio circondario per contrastare il continuo massacro della propria terra».
«Ci avevano fatto credere che ci sarebbero stati
ritorni economici per il nostro comune e vantaggi occupazionali per il
territorio, ma non è niente vero. Stiamo valutando strade di natura
giudiziarie». La confessione a “La Voce di Manduria” è del sindaco di Erchie,
Giuseppe Margheriti il primo a cedere alle lusinghe degli investitori della
green energy che in casa sua hanno già ottenuto 17 autorizzazioni per
altrettante torri eoliche nelle campagne di Erchie ed altre 30 sono in fase di
valutazione. Il primo cittadino si lascia così andare nell’ultimo servizio
prodotto dal movimento Giovani per Manduria, «10 minuti per Manduria», che
potrete seguire domani nella sua forma integrale. «Per realizzare gli impianti
previsti nel progetto – spiega Margheriti – occorrevano 45 milioni di euro», una
cifra impossibile per gli imprenditori nostrani. «Così tutto è stato venduto
alla Toshiba che non sa nemmeno dove si trovi Erchie così tutti i lavori sono
stati subappaltati a imprese esterne senza nessuna ricaduta sull’economia
locale». Incalcolabile poi il danno ambientale prospettato dal sindaco di Erchie
che riconosce il proprio errore anche in questo settore. «Credevo che l’impatto
ambientale riguardasse solo i 40 metri quadrati che occupa una torre, ma non
avevo considerato le opere necessarie per collegare tra loro le turbine e per
mettere in rete l’energia: centinaia di metri di muretti a secco, ettari di
macchia mediterranea e cinquecento alberi di ulivo secolari». E questo solo per
17 torri. Provate ad immaginare lo stesso impatto sull’ambiente rapportato alle
63 pali che le stesse società che risiedono in Via dei Mille a Manduria
vorrebbero realizzare nelle terre del Primitivo. Le relative istanze di
valutazione di impatto ambientale sono state presentate alla Regione Puglia che
ha già chiesto pareri alle istituzioni locali e provinciali. Il comune di
Manduria ha già espresso parere contrario alla Via e la parola ora tocca alla
Regione. Per un’altra domanda il cui iter è iniziato prima, relativa a una
piccola stazione eolica di cinque torri in contrada Giustiniani, sulla Manduria
Maruggio, la fase autorizzativa è già in uno stato avanzato. Pare che per queste
cinque torri, nonostante il parere contrario del comune, nessuno possa più
opporsi anche per l’assenso ottenuto dalla competente commissione paesaggistica
comunale.
Antonio Giangrande: “Manduria, gli ambientalisti
della porta accanto”. Quando l’istallazione di Depuratori delle acque e dei
Parchi eolici mette in crisi, per convenienza, le convinzioni ambientaliste dei
Verdi. «A Manduria, è noto, c’è la diatriba del depuratore consortile
Sava-Manduria da installare, di fatto, ad Avetrana e con lo scarico a mare delle
acque reflue nel mare prospiciente Specchiarica, zona balneare degli avetranesi
– spiega il dr Antonio Giangrande, presidente della “Associazione Contro Tutte
le Mafie” e scrittore-editore dissidente, che proprio sul tema dell’ambiente
truccato ha scritto un libro inserito nella collana editoriale “L’Italia del
Trucco, l’Italia che siamo” pubblicata su www.controtuttelemafie.it ed altri
canali web, su Amazon in E-Book e su Lulu in cartaceo, oltre che su Google
libri. Saggi pertinenti questioni che nessuno osa affrontare. Opere che i media
si astengono a dare loro la dovuta visibilità e le rassegne culturali ad
ignorare. – Meno nota, ma recente, è la questione delle 63 pale eoliche da
installare a Manduria lungo la strada per Lecce e per San Pietro in Bevagna, la
cui messa in posa è contestata dai Verdi manduriani. Da premettere che la
depurazione delle acque sporche (urbane o industriali) o le fonti alternative di
energia pulita sono il cavallo di battaglia degli ambientalisti e della loro
rappresentanza politica nelle liste dei Verdi. Anzi, oltre alla forestazione
delle campagne con la tutela indiscriminata di piante ed arbusti autoctoni, sono
le sole battaglie che portano avanti. Certo è che sono condivisibili le
battaglie a difesa del territorio, ma è palese la contraddizione insita tra le
pretese dei Verdi e la loro attuazione. Si possono capire le prese di posizione
di tutti gli altri movimenti o partiti politici, ma è paradossale che i Verdi di
Manduria si mettano a protestare per l’istallazione di strutture “Verdi” e
pretese dalle politiche dei Verdi, come può essere un depuratore o un parco di
pale eoliche o di impianti fotovoltaici. E’ nota la battaglia di Vittorio Sgarbi
contro la mafia dell’energia alternativa. Protesta che si è chiusa con lo
scioglimento della sua amministrazione immaginate un pò con quale ipotesi. Non
vorrei che, anche i Verdi di Manduria, siano come i “Verdi della porta accanto”:
ossia gli impianti Verdi sono necessari ma che siano installati nel territorio
altrui.»
CULTO E PARADOSSI DEL SALUTISMO.
Salutismo. s.m.
Atteggiamento caratterizzato da una particolare cura per la propria salute, che
si manifesta spec. con l'attenzione a una sana condotta di vita.
MAGNA MAGNA CAPITALE – IL BANDO PER LA BUVETTE DEL
CAMPIDOGLIO È UN MISTO DI SALUTISMO E GRAN GOURMET – REGOLE PRECISE PER LA
FARCITURA DEI TRAMEZZINI E PER LA QUALITÀ DEI SALUMI – E OGNI MESE DEVONO
CAMBIARE FRUTTA E VERDURA – ISTRUZIONI MINUZIOSE ANCHE PER PREPARARE IL CAFFÈ
FREDDO. Se il consiglio comunale di Roma facesse delibere e regolamenti
con la stessa cura con la quale organizza il lussuoso bar interno forse la città
avrebbe un altro volto. L’assortimento dei formaggi è degno dei migliori
ristoranti: in frigorifero non devono mancare Gruyiere francese, caprini
freschi, tomini stagionati, Roquefort, Sbrinz, Feta, Camembert e, naturalmente,
mozzarelle e caciocavallo a volontà…scrive Fosca Bincher per “Libero quotidiano”
del 16 giugno 2015. Chissà se l’idea è venuta leggendo quelle intercettazioni
giudiziarie che lo riguardavano da vicino: «Se Ignazio Marino resta altri tre
anni e mezzo, noi se magnamo Roma». Fatto sta che quasi in contemporanea alla
divulgazione di quel grande appetito dei boss di Mafia Capitale, al primo
cittadino di Roma è venuta l’acquolina in bocca. Fame vera ed umanissima, non
metaforica e di tipo criminale. Marino e i suoi più stretti collaboratori hanno
voglia di mangiare diversamente da come è accaduto fin qui. Così all’albo
pretorio del comune di Roma è stato affisso il bando per la gestione della
buvette del Palazzo Senatorio. All’interno delle grandi istituzioni si chiama
buvette quella sorta di bar nei pressi dell’aula consiliare che serve a
dissetare e sfamare rapidamente gli eletti. Alla buvette del palazzo Senatorio
del comune di Roma possono accedere i consiglieri comunali, i membri della
giunta a partire dal sindaco scendendo per i vari assessorati, i collaboratori
autorizzati ed eventuali ospiti. Clienti di pregio, e si capisce dal capitolato
d’appalto allegato al bando di gestione. Perché Marino & Co. anche al bar hanno
le loro esigenze. Raffinate, esclusive e salutiste. Sono contenute in pagine
dettagliatissime le richieste per fame e sete dei consiglieri e assessori della
Capitale. Che vogliono mangiare e bere bene, e in modo sano. Le istruzioni sono
da buvette di alta classe. È consentita lì ad esempio la preparazione di piatti
a base di frutta e verdura solo se di stagione. Di più: solo se la freschezza è
mensile. In questo mese di giugno dovresti trovare asparagi, barbabietole,
cavolfiori, cetrioli, coste, fagiolini, finocchi, funghi, insalatine da taglio,
melanzane, peperoni, piselli, pomodori, ravanelli e zucchine. Ma da luglio
devono sparire gli asparagi, i finocchi, i cavolfiori e le barbabietole. In
compenso si devono trovare le coste e la zucca. E così via di mese in mese:
qualche prodotto può entrare, altri debbono uscire. Per la frutta a giugno si
possono gustare ciliege e nespole, ma dal primo di luglio via e possono entrare
anguria e pesche. Sono stabilite le caratteristiche perfino delle tazzine da
caffè (ceramica o vetro a seconda delle miscele) e da cappuccino, così come per
infusi di ogni natura. La miscela di caffè ha regole rigidissime: «La miscela
può essere Arabica, Canephora o Robusta. Nel caffè macinato la granulometria
deve essere omogenea, e non troppo fine», e così via con altre amenità. Deciso
pure il caffè freddo che d’estate va moltissimo: «Caffè 30 millilitri, sciroppo
di zucchero 10-15 millilitri, ghiaccio quanto basta». Regole stringenti per
spremute di frutta fresca e frullati. Per i tramezzini, regola comune: non più
di 90 grammi di peso. Possono essere farciti con cotto + edamer, oppure con
«cotto e insalata capricciosa», «cotto e funghi prataioli», tonno, e ancora
«gamberetti + salsa cocktail» e «uovo + insalata capricciosa». Dettaglio
minuzioso anche per le farciture di panini e toast, come per tutte le insalate
possibili, di verdura o di frutta. Regole stringenti per gli ingredienti di
qualsiasi altro spuntino. A disposizione degli augusti ospiti in buvette debbono
esserci in caso di fame improvvisa anche piattini di salumi, pesce affumicato
(salmone, tonno, pesce spada e merluzzo) e formaggi di ogni tipo. Per la sola
bresaola della Valtellina le regole sono queste: «Deve essere preparata a
partire dalle masse muscolari in un solo pezzo della coscia bovina; il processo
di stagionatura deve essere compreso fra le 4 e le 8 settimane; la consistenza
deve essere soda, senza zone di rammollimento, umidità massima 65%...». Per i
salami previsti i tipi «Milano, Felino, Soppressa veneta, Finocchiona e
Ungherese», ma la forma deve essere intera «e non confezionata», il Ph minore di
5, l'umidità al 35%. Ok anche alla Mortadella Bologna IGP, ma «l’aroma non deve
essere eccessivamente speziato». Per coppa e capocollo «il processo di
stagionatura e maturazione deve compiersi lentamente». Al banco dei formaggi
Marino e i suoi vogliono trovare di tutto, in modo da soddisfare qualsiasi tipo
di palato: mozzarelle fiordilatte, di bufala, scamorze, scamorze affumicate,
caiocavallo, caciotte di latte vaccino, caciotte di pecora, crescenza, Asiago
dop pressato, Asiago dop D'allevo, Montasio, Fontina, Cheddar, Edamer,
Emmentaler svizzero, Emmental francese, Beaufort, Groviera svizzero, Gruyiere
francese, Grana Padano, Prmigiano reggiano, Taleggio, Quartirolo, tomini
stagionati, Italico, Brie, Gorgonzola, Roquefort, caprini freschi, Feta, Sbrinz,
Pecorino, Camembert Aoc. Nemmeno nei grandi ristoranti c’è una varietà così. E
per ogni forma regole severissime di preparazione e confezionamento. Basteranno?
A quanto pare in quel palazzo Senatorio di Marino & c la fame non manca.
Nazismo e Salutismo,
scrive Alberto Mingardi il 13 agosto 2002. Mica tutti lo sanno, ma la prima
grande, maestosa campagna antifumo della storia porta la firma di Adolf Hitler.
Lo spiega Robert Proctor in un bel libro tradotto per i tipi di Cortina, in cui
avanza una lettura del nazismo come "grande esperimento igienista disegnato allo
scopo di realizzare una selettiva utopia sanitaria”. Per anni s’è intravisto
nell’ideologia la medicina infallibile per curare tutti i mali dell’uomo, e si
sono confuse le carte, e quanto ci è costato imparare a non scambiare malattia e
dottore. Nel 1934, arringando il Reichstag, Hitler era stato chiaro: "Ho dato
l’ordine di bruciare fino alla carne viva le ulcere del nostro avvelenamento
interno". Werner Best, il luogotenente di Reinhaurd Heydrich, rincarò la dose
spiegando che il compito della polizia era quello di "sradicare tutti i sintomi
di malattia e i germi di distruzione che minacciano la salute politica della
nazione". Non solo metafore. Le parole del reichgesundheistführer lasciano poco
spazio all’interpretazione: "nessuno ha il diritto di considerare la salute una
materia personale e privata, che può essere accantonata a seconda delle
preferenze individuali. La terapia deve essere amministrata negli interessi
della razza e della società piuttosto che in quelli dell'individuo malato". Ora,
non ci azzarderemmo nemmeno a tracciare un paragone improbabile, a immaginare
Girolamo Sirchia coi baffetti e il braccio teso. Epperò ci resta l’amaro in
bocca, la sensazione spiacevole d’esser stati presi in giro. Appena nominato da
Berlusconi, Sirchia si affrettò a buttar giù un manifesto della "sua" sanità, e
lo declinò orgoglioso in un paio d’interviste. Pugno di ferro con la droga, e
guanto di velluto con la nicotina: suonava come un’inversione di tendenza
rispetto al suo predecessore Veronesi. Ma gli ultimi exploit del ministro ci
hanno ricordato che invertendo l’ordine dei fattori il risultato non cambia. Mi
spiego. Sirchia ha rilanciato, e con imperturbabile violenza, la crociata
antifumo lasciata a metà dal governo Amato. E’ una svolta che si è consumata in
quel silenzio ovattato con cui si annuncia un golpe bianco. Il provvedimento è
entrato in vigore all’albeggiare dell’anno nuovo, in tandem con l’euro, e adesso
il ministro propone di estenderlo ai locali privati aperti al pubblico, e
all’improvviso i fumatori s’accorgono, mentre soppesano le nuove monetine, di
essere diventati dei lebbrosi ipotetici. Paria sospesi fra un presente d’inferno
e la tenebrosa attesa della "soluzione finale". "Braccati dai Nas", ha scritto
Gianni Mura su "Repubblica", e un po’ da una cattiva coscienza sapientemente
seminata, dalla consapevolezza greve di aver torto, da un mea culpa obbligatorio
e definitivo. Sarà anche vero che ogni sigaretta che ti accendi è un piccolo
patto col diavolo, è mendicare un altro mutuo alla banca della vita. Sarà anche
vero che fa male, che è un anticipo di agonia, che ogni boccata è truccare le
carte al destino. Ma al diavolo: cosa non lo è? Cosa c’è che non sia uno stare
sospesi, barcollando leggeri, uno scivolare lento verso l’oblio? Si chiama
vivere, ed è tutto un rischio. Si dice che ci siano dei rischi diversi da altri.
Che alcuni presentano misteriosi "costi sociali", il conto girato alla comunità
per le pirlate di un individuo. Ed è quando uno si incaglia su questi argomenti
che s’intuisce che il Novecento non è finito, che siamo rimasti gli stessi, che
stiamo solo ricamando vestiti nuovi addosso ai nostri maledetti istinti. Dire
che i fumatori (pardon, i "malati di nicotina", come li chiama Sirchia in un
crescendo politicamente corretto) rappresentano, potenzialmente, un costo
sociale, perché alla fine vanno a marcire negli stessi ospedali di chi è vergine
alla sigaretta, è un aver già deciso. Un essere sicuri a priori, in partenza,
che il mondo si divide in due, e che basta avere i polmoni un po’ più scuri per
non varcare le porte dell’Olimpo. I fumatori non sono un "costo" sociale, come
non lo sono gli obesi (prossime vittime del ministro), come non lo sono i malati
di aids, come non lo sono gli spericolati che si fracassano il cranio, come non
lo sono gli omosessuali, e i lussuriosi, e gli automobilisti, e gli psicanalisti
junghiani, e i lettori di Topolino. Pagano tutti le tasse, vengono rapinati
tutti allo stesso modo. I fumatori, semmai, di più: ci sono fior di imposte
indirette appiccicate a un pacchetto di Malboro. Un conto approssimativo lascia
intendere che, dal 1 gennaio 2000, i fumatori hanno contribuito per circa 33400
miliardi di lire (traducete voi in euro) al bilancio dello Stato. Il loro letto
in corsia se lo sono pagato. Ma per questo Stato, contrabbandiere e poliziotto,
spacciatore e proibizionista assieme, questo Stato che guai agli spot alla
nicotina e poi tappezza di pubblicità "Ms" l’Aprilia di Macio Melandri, forse
non basta. Forse c’è ancora la tentazione di non limitarsi a pigliare gli uomini
come sono, questi insopportabili zozzoni, questi egoisti impenitenti. C’è ancora
il desiderio nascosto, e nemmeno tanto nascosto, di "bruciare le ulcere della
società", di spalancarci un domani virtuoso. E chissenefrega se basterebbe un
briciolo di buon senso, una goccia di libertà, per avere locali per fumatori e
locali per "non", e lasciare alla gente il verdetto. C’è chi sussurra che ormai
la legge è fatta, e ci tocca obbedire. No. Le leggi ingiuste non si obbediscono:
si combattono. E anche se scavare la trincea costa, se immaginare un gesto di
solidarietà paradossale come una spipazzata, un tiro di sigaretta, è forse
troppo per uomini senza fantasia, la mia impressione è che "ci tocca". Persino
ai non-fumatori professionisti, o fumatori timidi, come chi scrive. Meglio
sacrificare i nostri polmoni che la nostra libertà. Ai fumatori incalliti si
richiede lo sforzo contrario: coltivare il rispetto, inventarsi un galateo
anarchico per sopravvivere a qualsiasi legge.
Il nazismo tra ecologismo, salutismo,
esoterismo. Come un'ideologia distruttiva si è
nutrita di vecchi e nuovi miti. Scritto da Rino Cammilleri l'1/01/1993 su
“Europa Oggi”. "Quando il cielo si vuota di Dio, la terra si popola di idoli"
(Karl Barth). Tratto da: I Mostri della Ragione, di Rino
Cammilleri, Edizioni Ares 1993. A cinquant'anni dall'inizio della seconda
guerra mondiale non so se sia un bene continuare a parlare del nazismo, almeno
così come se ne è parlato finora. Tonnellate e tonnellate di carta stampata,
biografie, diari veri e falsi, rivelazioni e controrivelazioni, film (anche
porno-sado-maso), fumetti, fascicoli settimanali, pièces teatrali sono
stati profusi sull'argomento, e tutto con un unico scopo: demonizzare.
Intendiamoci: terrificante realtà fu il nazismo, ma il demonio, brutto per
quanto sia, ha pur sempre un suo fascino e l'esperienza insegna che a furia di
parlar male di qualcuno si può ottenere l'effetto opposto, cioè far sorgere
prima la curiosità e poi l'interesse. È come dire ai bambini di non toccare la
presa di corrente e poi accorgersi che malgrado tutte le nostre raccomandazioni
stanno lì come ammaliati, cercando di infilarci le dita. Il sistema migliore
rimane quello di mostrare serenamente di che si tratta (e poi comprare un
tappo). Non sarà infatti sfuggito come certi movimenti giovanili spontanei
(punk, skinhead) usino simboli nazisti per testimoniare la loro volontà di
essere «contro» — per non parlare del neonazismo tedesco che riesce anche a
raccogliere preoccupanti consensi. Nel film The Wall dei Pink Floyd è
acerbamente descritto — visto da «dentro» — come in molti giovani disadattati
possa nascere una volontà distruttiva contro il «sistema», inteso come fonte
unica di ogni insoddisfazione: il modo più conseguente di andargli contro è
sposare la causa del dichiarato suo peggior nemico. Da quel tipo di avversione
al «sistema» alla simpatia per il nazismo, il passo è breve; anche perché quel
che spesso affascina del nazismo sono le rapide soluzioni «igieniche» e il
semplicistico manicheismo. È da ritenersi che gli stretti legami tra il mondo
del rock «duro» e il satanismo abbiano la stessa spiegazione. Il relativamente
recente — e notevolmente interessante — libro di Giorgio Galli Hitler e il
nazismo magico (Rizzoli, Milano 1989), potrebbe essere guardato anche alla
luce di quanto detto, anche se l'autore tratta l'argomento con la serenità dello
studioso, evitando di abbandonarsi a dichiarazioni di fede politica e a
declamazioni di principio inopportune in un'opera storica rigorosa. Tuttavia,
come fece notare lo studioso di destra Marco Tarchi in un dibattito con l'autore
svoltasi presso l'Accademia Nazionale dell'Ussero a Pisa poco dopo la
pubblicazione, la tesi di fondo del libro (cioè che tutto il nazismo sia stato
un fenomeno da leggersi in chiave esoterica, perché questa era l'intenzione dei
suoi fondatori e dei suoi uomini di punta) può provocare in molti giovani,
approdati a una certa destra per un fenomeno di rifiuto, una simpatia per il
nazismo tanto più dannosa perché fondata anche — e ovviamente non solo —
sull'irrazionale. Giustamente, dal suo punto di vista, il Galli replicò in
quell'occasione che lo storico «laico» non scriverebbe più niente se dovesse
curarsi delle conseguenze che certe sue ricerche potrebbero avere su alcune
minoranze esaltate. Ma è proprio vero che il nazismo fu «magico»? Che Hitler e i
suoi consultassero astrologi è cosa risaputa, così come è noto che qualche pezzo
grosso del nazismo si considerava la reincarnazione di grandi personaggi del
passato. La svastica tibetana, le teorie sulla terra cava, la stessa ossessione
ariana avevano senz'altro questa valenza. Qualcuno (e per l'esattezza Rosemberg,
un nazista della prima ora) aveva addirittura teorizzato un Ordine
nazionalsocialista, da fondare dopo la vittoria finale, con Hitler come gran
maestro e le SS come cavalieri. L'idea fu lanciata proprio a Marienburg,
l'antica sede dei Cavalieri teutonici, e provocò il decreto del 15 settembre
1935 che divise i tedeschi in due ranghi: Reichsbürger e Bürger semplici.
Solo i primi avevano diritti politici. Non solo, ma forse da questo punto di
vista possiamo qui aggiungere qualcosa che è sfuggito al Galli e cioè
l'ossessione del Fuhrer per il numero sette, «magico» per eccellenza. Hitler,
quando militava come caporale nella prima guerra mondiale, venne ferito il 7
ottobre 1916 e fu ricoverato nell'ospedale di Beelitz, non lontano da Berlino.
Qui vide il disfattismo degli imboscati e potè assistere agli scioperi nelle
fabbriche di munizioni, organizzati dalle quinte colonne avversarie. Secondo le
sue stesse parole, fu in quella circostanza che la sua vocazione politica prese
corpo. A ciò va aggiunto che il suo capitano (Rohm, che poi divenne uno degli
uomini di punta delle SA e fu in seguito eliminato nella notte dei «lunghi
coltelli»), evidentemente in obbedienza a ordini superiori, gli aveva affidato
una missione un po' particolare: infiltrarsi in quella nuova associazione
politica di cui tanto si parlava a Monaco. Era un gruppetto fondato proprio il 7
marzo 1918 dal fabbro Drexler e si chiamava «Comitato indipendente di operai a
favore di una pace onesta». Perduta la guerra, prenderà il nome di Partito
operaio tedesco (e più tardi nazionalsocialista). Il caporale Hitler esegue e
riferisce: niente paura, sono pacifisti ma anticomunisti. Ma qui cominciano i
misteri. Hitler ottenne la tessera numero sette (ancora il sette). Ma se
l'associazione aveva già quell'importanza che Rohm le dava, come mai la tessera
numero sette era ancora disponibile? E se invece si trattava di un gruppo di
sole sei persone del quale Hitler avrebbe occupato il settimo posto, perché mai
questo partito sarebbe stato tanto notorio e importante da richiedere una
missione così riservata e l'infiltrazione? Indagare tuttavia in questo senso ci
porterebbe lontano, in una direzione che tutto sommato esula dallo scopo del
presente lavoro. Qui ci basta rilevare la predilezione di Hitler, da quel
momento, per il numero sette, predilezione che lo accompagnò tutta la vita.
Basti pensare che quasi tutte le sue campagne furono iniziate il settimo giorno
e precisamente all'alba di una domenica Comunque, l'incidenza dell'esoterismo e
dell'occultismo nel Reich secondo molti va senz'altro ridimensionata. Già si è
accennato agli stretti rapporti che intercorrono tra razionalismo e occultismo,
tra neopaganesimo ed esoterismo. L'ambiente tedesco — e non solo quello — prima
dell'avvento di Hitler era saturo di tutte queste cose. Ancor oggi però
assistiamo a inquietanti revival, senza che da noi vi siano totalitarismi, anzi
in pieno pluralismo ideologico. Tutte le grandi imprese tedesche dell'epoca —
Siemens, AEG, IG Farben, Vereinigte Stahlwerke, Krupp, Schering — avevano
sezioni dì grafologia e psicometria, e lo stesso Hitler ebbe in alta
considerazione l'astrologia finché ne ottenne predizioni favorevoli. Ma quando
all'inizio del 1941 i pronostici non furono più di suo gradimento, cominciò a
prendere le distanze dai maghi. Infine, sparito Hess, dalla freddezza si passò
apertamente alla persecuzione. La verità è che Hitler odiava la scienza
accademica e non ne faceva mistero, ma il motivo era da ricercarsi nel fatto che
egli non era in possesso di alcun titolo dì studio. Da qui il favore per tutto
ciò che era «alternativo». Quelli che traevano vantaggio da questa situazione
non erano certo personaggi esperti e corretti, bensì i ciarlatani e i
piaggiatori. I centri dove le scienze astratte erano studiate seriamente erano
tutto sommato pochi in Germania e furono quelli che finirono nelle liste di
proscrizione. In omaggio ai gusti del Fiihrer in tutta la Germania
pullularono ben presto i praticoni delle medicine alternative. Fu, col sesso,
l'unica cosa veramente libera nel Reich. Chiunque poteva scrivere sulla propria
porta Heilprakciker (esperto in guarigioni), purché di razza ariana e
maggiore degli anni ventuno: fu stabilito da un decreto del 12 ottobre 1935, con
la sola esclusione per la cura delle malattie veneree e delle vaccinazioni.
Hitler era infatti, come è noto, un salutista (anche se nessuno lo vide mai in
maniche di camicia né in costume da bagno) col suo vegetarianismo, la sua
avversione agli alcolici e alle sigarette, il suo amore morboso per gli animali
e il suo odio viscerale per la medicina universitaria. Nel 1934 venne inaugurato
a Dresda un ospedale naturista, intitolato a Rudolf Hess, delfino di Hitler e
come lui fissato per tutte queste cose. Il centro era destinalo a studiare tutti
i metodi terapeutici alternativi, come l'idroterapia, il vegetarianismo, la
talassoterapia, l'aeroterapia, il nudismo. Non vi erano medici, ma solo Heilpraktiker.Da
quel momento queste «scienze» ebbero un tale impulso che gli adepti fondarono
addirittura un sindacato con tanto di albo professionale, lo Heilpraktiker Bund.
Ci si scagliò anche contro le attività che il decreto del 1935 aveva proibito
agli Heilpraktiker. Il Gauleiler di Fran-conia, Julius Streicher, editore
dei settimanale pomo-politico Der Sturmer (che faceva propaganda di
nudismo), uno dei pochi che si permettevano di dare del tu al Fuhrer, iniziò una
violenta campagna contro i sieri e i vaccini, arrivando a dire che si trattava
di invenzioni ebraiche per corrompere il sangue tedesco, poiché Koch e Behring,
scopritori dei vaccini, quantunque tedeschi, avevano mogli di razza ebraica. Il
nudismo, poi, si diffuse talmente che arrivarono a esistere vere e proprie città
di nudisti, con più di diecimila abitanti, come quella di Kladow, presso
Berlino. Si giunse a incoraggiare il nudismo in tulle le circostanze. Non erano
pochi i casi in cui anche i ricevimenti ufficiali finivano con uno strip
collettivo in omaggio alle nuove tendenze. Il nudismo, quale culto del corpo e
della natura, oltre che di ascendenze paganeggi ami, è anch'esso strettamente
collegalo al razionalismo. Ne troviamo manifestazioni durante la Rivoluzione
francese e in quella sovietica. Nei primissimi anni del colpo di stato
bolscevico si potevano vedere nei parchi delle principali città russe uomini e
donne nudi prendere il sole tranquillamente. Anzi, il fenomeno raggiunse tali
eccessi che si dovette vietarlo. Sempre per quanto riguarda l'Unione Sovietica,
c'è da dire che il regime comunista non aveva nulla da invidiare a quello
hitleriano in materia di scienze «alternative». Il Partito infetti spendeva
somme colossali per le ricerche para-psicologiche, per le quali manteneva circa
venti istituti sparsi in tutta l'Urss. L'unica cosa che mancava a Hitler per
essere un ecologista radicale ante litteram era il femminismo.
Incoraggiava sì il libero amore: le procreazioni extraconiugali erano legalmente
parificate alle altre e fu creato un clima teso allo svuotamento culturale della
famiglia; anzi, essendo la famiglia un duro scoglio per ogni totalitarismo, non
era nascosta la predilezione per le nascite illegittime, perché tali creature
appartenevano allo Stato più dì quelle nate all'interno di un nucleo familiare
costituito (si arrivò persino a ordinare che si facessero invisibili
perforazioni nei preservativi perché il Reich potesse avere più figli). Ma che
cosa pensasse effettivamente Hitler delle donne gli scappò detto di fronte a
ventimila rappresentanti del gentil sesso riunite in congresso a Norimberga nel
1937: «Che cosa ho dato a tutte voialtre? Che cosa vi ha dato il
nazionalsocialismo? L'uomo!» In ogni caso il continuare a esasperare gli aspetti
occulti di Hitler finisce per portare acqua alla tesi della pazzia e non
contribuisce a spiegare un fenomeno in realtà molto lucido che ha i suoi
fondamenti nella geopolitica, scienza trascurata nelle epoche fortemente
ideologizzate come la nostra, ma che non ha mai cessato di dettare direttrici di
politica estera (e, dì conseguenza, interna), come gli studiosi più avveduti non
mancano di mostrare, infastiditi in questo da interessi di partito e di moda.
Tra gli istituti-laboratori del Terzo Reich posizione centrale aveva proprio
l'Istituto di geopolitica, diretto dal professor Karl Haushofer a Monaco. Nei
suoi schedari trovava posto il mondo intero. Si proponeva di classificare tutto:
istituzioni, imprese, individui — specialmente quelli che emergevano a qualsiasi
titolo, con tutti i dati possibili e immaginabili, fisici e psichici, con le
ambizioni inespresse e perfino le tare morali e familiari. Perché tutta questa
importanza alla geopolitica, pianificata fino alle minuzie? Perché Hitler voleva
dividere il mondo con l'Inghilterra, «sorella» ariana. A essa i mari, a lui la
terra. Questa è sostanzialmente la lesi che lo stesso Galli esprime nel suo
libro, sebbene con due varianti: l'una è che questo scopo sia stato perseguito
da Hitler per via delle sue fissazioni «magiche»; l'altra è che per questo
stesso motivo cercò di evitare fino all'ultimo lo scontro con l'Inghilterra.
Ora, la seconda ipotesi è confutata da un certo fatto. Dopo l'incontro di Hitler
e Chamberlain a Monaco il 15 settembre 1938, e a Godesberg il 22 dello stesso
mese, il Fuhrer passò un breve ordine, scritto di suo pugno e firmato,
all'Oberkommando des Heeres. C'era scritto: «Voglio far la guerra
all'Inghilterra. Si proceda a prepararla. Si diano disposizioni senza perdita di
tempo. Dobbiamo essere pronti entro un anno. Adolf Hitler». Evidentemente Hitler
aveva capito che la pazienza degli inglesi cominciava a esaurirsi e che se
ancora non gli avevano dichiarato guerra era perché non si sentivano pronti.
Bisognava precipitare gli eventi prima che l'Inghilterra potesse impedire la
realizzazione dei piani germanici in oriente. Infatti il vero obiettivo era la
Russia e le sue vaste risorse (che nella mente dei tedeschi dell'epoca erano
diventate quasi leggendarie). Questa era l'idea fissa di Hitler o lui soggiogava
la Russia o la Russia avrebbe soggiogato la Germania. E questo per puri, quanto
ineluttabili, imperativi geopolitici. Stalin era dello stesso avviso. Il
generale Krivisky, capo del controspionaggio militare sovietico nell'Europa
occidentale fino al 1939, scriveva: «La politica internazionale di Stalin
durante questi ultimi sei anni non è stata altro che una serie di manovre
destinate a metterlo in posizione favorevole per trattare con Hitler. Quando
aderì alla Società delle Nazioni, quando propose il sistema di sicurezza
collettiva, quando cercò l'amicizia della Francia e fece la corte
all'Inghilterra, quando flirtò con la Polonia e quando intervenne in Spagna,
misurò i suoi movimenti con gli occhi fissi a Berlino». Quando Hitler capì che
l'Inghilterra gli avrebbe messo i bastoni fra le ruote, si mosse immediatamente.
Non intendeva distruggerla, ma solo sconfiggerla. E se non la invase fu perché
non vi riuscì. Ne fu distolto dai suoi uomini. L'ammiraglio Raeder lo dissuase
da un'operazione navale (e Hitler, che si sentiva male solo a metter piede su
una nave, si lasciò facilmente convincere), appoggiato anche da von Ribbentrop,
ministro degli Esteri ed esperto di questioni inglesi. D'altro canto Goering
assicurava che con i bombardamenti dall'aria si sarebbe ottenuto lo stesso
effetto. A ciò si aggiunga l'opinione diffusa dell'invincibilità
dell'Inghilterra sul mare, complesso di inferiorità di cui non era esente
nemmeno la nostra marina. Ma anche su questo argomento rischiamo di spingerci
troppo lontano. Al neopaganesimo nazista non potevano non opporsi i cattolici,
che costituirono praticamente — anche in virtù del loro riferimento
transnazionale — l'unico movimento di opposizione al nazismo fin dal suo inizio.
Il concordato del 20 giugno 1933 non fu una resa al regime da parte del Vaticano
— questo è ormai universalmente assodato — bensì una chance da cogliere per
assicurare la libertà religiosa in Germania, dove il nazismo non faceva mistero
delle sue idee in materia. La violazione degli accordi iniziò ben presto.
Nell'estate del 1935 cominciò la campagna anticattolica. Si scoperse, grazie
alle «rivelazioni» di un aderente alla gioventù hitleriana, che i religiosi di
un convento si dedicavano a corrompere i fanciulli della scuola da essi tenuta.
Seguirono immediatamente altre «rivelazioni» (del tipo di quelle dei romanzi di
Diderot) sui conventi di Fulda, Padeborn, Münster. Seguirono gli arresti e i
clamorosi processi, con la stampa di regime che soffiava sul fuoco. Si chiusero
le scuole cattoliche, si soppressero le pubblicazioni religiose, si sciolsero le
organizzazioni confessionali e se ne incamerarono i beni. Aboliti i conventi
(con annesse brutalità da parte delle SS), si convertirono gli edifici religiosi
in case del partito e birrerie. La persecuzione si estese ai Paesi occupati.
Quasi tutto il clero polacco finì a Dachau. Per il resto il copione fu quello
tipico dei totalitarismi: la Hitlerjugend organizzava le attività domenicali in
modo che i ragazzi non potessero mai assistere agli uffici religiosi; lo stesso
avveniva nell'esercito e nell'amministrazione. Chi reclamava, si ritrovava a
pulire latrine tutte le domeniche e subiva ogni sorta di vessazioni.
L'enciclica Mìt brennender Sorge del 1937 proclamò al mondo che cos'era il
nazismo. Il seguito è noto. Le manie ecologiste del nazismo sono tornate di
moda, anche se spacciate per novità. Naturalmente non sono più nere, ma verdi,
rosso-verdi, bianco-rosse. A uno a uno tutti cedono, come i rinoceronti di
Ionesco, al nuovo credo del duemila che reclama a gran voce molte di quelle
«libertà» (aborto eugenetico, eutanasia) per le quali il nazismo era stato posto
al bando della storia. La medicina «alternativa», le pratiche
prano-talasso-omeoierapeutiche (e rispettivi praticoni), l'alimentazione
«naturale», il nudismo, il sesso vissuto e usato come tonificante psicofisico,
l'attenzione morbosa per i mammiferi o i volatili (non per gli insetti e gli
animali «schifosi»), il volgersi a pratiche e credenze orientali e
orientaleggianti, il ritorno in grande stile dell'occultismo e dell'esoterismo,
per non parlare dello spiritismo e del satanismo come fenomeni «di massa», li
ritroviamo oggi sotto i nostri occhi dopo averli visti campeggiare a tutto tondo
nel nazionalsocialismo. Prima era nazismo, oggi tutto ciò lo si pretende
«pluralismo». Il termine «pluralismo» è stato precipitato nella stessa
confusione semantica che ha coinvolto parole come «democrazia» e «liberalismo».
Tutti e tre i termini sono diventati di fatto sinonimi e hanno finito per
significare che ognuno è libero di fare quel che gli pare. E tuttavia curioso
che in un mondo dove ognuno è libero dì fare quel che vuole tutti si finisca per
fare e pensare le stesse cose. Naturalmente chi non si accoda al conformismo
imperante (anzi, chi non dimostra sufficiente entusiasmo) viene accusalo di
essere nemico della libertà ed emarginato con la tipica intolleranza dei
totalitarismi. E questo ci riporta all'assunto precedente, che, cioè, del
nazismo vengono tutto sommato demonizzati più che altro gli aspetti folklorici,
come le divise e le adunate obbligatorie. Si deprecano gli stermini di quelle
minoranze che hanno un'organizzazione sufficiente a ricordarcelo (anche gli
zingari finirono nelle camere a gas naziste, ma quasi nessuno lo rammenta). Ma
il totalitarismo e l'intolleranza stanno ritornando con i loro tipici connotati
— anche se in modo subdolo — servendosi del caos ideologico, che ne è l'opposto
solo in apparenza. Al di là degli sforzi di quanti cercano di conciliare
l'inconciliabile, i più lontani dal modo di vita del paganesimo contemporaneo
sono i cristiani. E proprio parlando dei cristiani nel mondo contemporaneo,
Eliot diceva che può forse rivelarsi più intollerabile essere «tollerati» che
perseguitati. Oggi in effetti sono tanti — e aumentano — gli argomenti di
divisione tra i cristiani e gli altri (ovviamente qui non ci si riferisce ai
battezzati, ma a coloro che prendono sul serio la loro fede). Sempre più il
cristiano è costretto a tacere, sul luogo di lavoro o altrove, per non
scontrarsi continuamente con le idee di moda. I più non possono reggere a lungo
una situazione di conflittualità (e conseguente emarginazione) quotidiana, per
cui finiscono con l'arretrare sui «valori comuni», il cui spazio si fa però
sempre più esiguo. Quando al cristiano capita — che so — di trovarsi invitato a
un pranzo dove ci sono due naturisti, tre seguaci di Sai Baba, un «verde», un
vegetariano semplice, due femministe e un punk, la conversazione finisce col
diventare, per amor di pace, quanto mai superficiale e noiosa. Ovvio: quel che
divide è talmente esteso da rendere assolutamente risibile ciò su cui si può
essere d'accordo. È l'esito di quel che si intende oggi per «pluralismo» (che
non è sociale, che sarebbe una bella cosa, ma ideologico). Almeno nelle vecchie
battaglie sessantottarde c'era un terreno comune di scontro, la politica. Adesso
il regno dell'opinione investe istanze così vaste e globali che l'unico terreno
comune finisce per essere quello fornito dagli slogan di volta in volta lanciati
dai mass media e da chi li controlla. Questo pluralismo non si limita a
dividere, ma atomizza, disarmando completamente l'individuo — e al livello del
pensiero — nei confronti del Grande Fratello. Nemmeno il clero è indenne dal
fenomeno. La Congregazione per la dottrina della fede ha messo in guardia sulle
pratiche yoga e simili applicate alla preghiera cristiana. Massimo Introvigne,
il maggior esperto italiano di culti alternativi, ha dimostrato che tali
pratiche non sono neutre, ma veicolano credenze contrarie al cristianesimo, come
quella della reincarnazione. Non solo, ma i mantra segreti che l'adepto deve
ripetere, spesso non sono solo innocue vibrazioni, bensì precise invocazioni
alla Trimurti. Anche le tecniche di respirazione yoga e il tantrismo
soggiacciono alle stesse critiche. Generalmente, quando la Chiesa decide di
prendere posizione aperta su certi fenomeni, è perché essi sono arrivati a
livelli preoccupanti. È difficile tuttavia che abitudini acquisite possano
essere dismesse volentieri. Ecologismo radicale, pacifismo (ricordiamo che il
partito di Hitler iniziò proprio come movimento pacifista), animalismo,
naturismo, salutismo, esoterismo, occultismo. E tutte le varianti. Ma sono
varianti dell'antica gnosi, anche se adeguate ai tempi. E nazismo e comunismo ne
sono state versioni politiche. Nel ventesimo secolo ancora una volta il
cristianesimo si è misurato e continua a misurarsi con la sua nemica di sempre.
Dal nazismo al comunismo.
L'ideologia di Report per il salutismo di
Stato: Milena Gabanelli come i talebani ci dice come dobbiamo vivere,
scrive “Libero Quotidiano” ill 4 giugno 2015. Nel mirino di Report, il programma
di Milena Gabanelli, sono finiti alcuni tra i simboli dell'enogastronomia made
in Italy, distruggendoli. Dalla pizza al caffè, passando per l'olio d'oliva, la
crociata della giornalista per insegnare al volgo come e dove si deve mangiare
ha toccato nell'ultima tappa anche i cornetti dei bar per la colazione.
Su l'Intraprendente, Corrado Ocone lancia l'allarme su un pericolo ben peggiore
del vivere e mangiare un po' come ci pare, che la Gabanelli potrebbe non
approvare, e cioè il diffondersi di una vera e propria ideologia estremista, un
talebanesimo del mangiar sano, in una parola: il milenagabanellismo. Report vuol
far passare il salutismo come una conquista del progresso, un errore nel merito
e nel metodo secondo Ocone che ribadisce il diritto proprio di una società
libera di buttar nello stomaco quel che pare a ognuno. Quella della Gabanelli
richiama più la convinzione diffusa durante il Terzo Reich o i regimi comunisti,
lanciati a plasmare le abitudini dei cittadini in base a criteri stabiliti dai
burocrati e ideologi di regime. L'ombra di una prospettiva di questo genere è
andata in onda con l'ultima inchiesta sui cornetti letali dei bar che per la
stragrande maggioranza dei casi è scongelato e strafarcito di grassi. La
sorpresona per il giornalista di Report è successa niente di meno che in piazza
San Marco a Venezia, dove secondo lui il prezzo del cornetto surgelato era
troppo alto. Ocone si sforza anche di spiegare come un prezzo non è altro che il
risultato dell'incontro tra domanda e offerta, quindi non dovrebbe stupire se il
menu di un locale messo in una delle piazze più belle del mondo riporti numeri
più alti del solito. Forse a Report sperano che si statalizzi il prezzo del
cornetto, farne una versione "di Stato", come nei paesi comunisti durante la
guerra fredda.
Il salutista a mezzo stampa, ultimo
stronzo che s’impiccia della tua ciccia, scrive
Stefano Di Michele il 14 Ottobre 2014 su “Il Foglio”. Certe volte, il salutismo
sfiora il cretinismo. Il salutista militante, poi, è una vera catastrofe
sociale. Una molestia continuata. La petulanza del muscolo. La lagna della
chiappa soda. La litania del giro vita. Parecchi salutisti, tutto il fiato che
recuperano con i chili persi lo sprecano poi per rompere i coglioni a chi i
chili vuole tenerseli. E’ il moralista nella versione più “cool”, il salutista.
Il pedalatore incallito. L’antitabagista dalle sensibilissime narici, prefica
vociante in servizio permanente. Il maratoneta che ti guarda schifato se aspetti
il tram invece di andare deambulando da una fermata all’altra. Il consumatore
bio (o della sottospecie bio-dinamico), che a tavola passa in rassegna
carciofini e caciotte. Il salutista militante non solo tiene alla sua salute – e
questo va a suo merito, oltre che a suo indiscutibile vantaggio; ma soprattutto
alla tua – e questo va a suo demerito, oltre che a procurare un’indiscutibile
tentazione di sonoro vaffanculo. Predica, informa, sghignazza, ironizza, prevede
sciagure, sa tutto del suo e del tuo (per scienza infusa: di tisana biologica)
colesterolo. Sta all’erta. Vigila. Scruta. Arriva in soccorso. Patisce della
perduta altrui verginità con una ciambella fritta. Pesa. Soppesa. Fa il lordo.
La tara. Il netto. Si compiace. Si dispiace. In Belgio (che pure tra le cose da
mettere in mostra, oltre i cioccolatini, molto altro non ha) sono andati oltre.
Un giornalista – la figura del giornalista salutista, poi, è un’ulteriore
complicazione – della tv fiamminga Vrt, Tom van de Weghe, è partito all’assalto
della nuova ministra della Salute, Maggie De Block, 52 anni, con una fenomenale
motivazione. E’ la signora forse un’incapace? Non pare, è persino medico. E’
antipatica? Non lo dicono. E’ sospettata di bustarelle e affini? Per niente. E’
poco stimata? Al contrario. Insomma, dovrebbero tenersela stretta,
nell’esecutivo. Ecco, forse tenersela stretta, fuor di metafora, non è magari la
cosa più semplice. Perché la signora è un po’, pure un po’ tanto, a guardare le
foto, sovrappeso. Ha un bel faccione sorridente e intelligente. Il collega belga
ha scritto un tuìt (i tuìt sono arrivati pure in Belgio) per lamentarsi del
fatto che il paese “ha d’ora in poi una ministra della Salute pubblica obesa.
Qual è la sua credibilità?”. Altri gli sono corsi dietro (i tuìt sono sempre
come locomotive cariche di matti): “De Block è anche un medico. Come ci si può
fidare di lei vedendo che rispetto ha per il suo corpo?” (il rispetto del corpo,
per il salutista militante, viene spesso prima della logica e del buongusto). La
signora, a leggere le cronache considerata da tutti “tra i politici più stimati
del Belgio”, in passato responsabile della Giustizia, ha replicato saggiamente
che “i miei pazienti non guardano alle mie misure, ma vengono da me per la
qualità delle mie cure”, e pure che “alla Camera i miei colleghi non mi
giudicano in base al mio aspetto fisico, ma mi fanno i complimenti sulla
conoscenza che ho dei miei dossier”. Come è logico. Speriamo si sia consolata
con una bella scatola di cioccolatini. Tanto, in nome della campagna Bilance
pulite, ci sarà sempre un gradasso pronto, tra Churchill e Lord Chamberlain, a
preferire il secondo: fesso sì, ma segaligno soprattutto.
La tirannia del salutismo,
scrive Gilberto Corbellini il 23 dicembre 2012 su “Il Sole 24 ore”. Anche se il
titolo principale non è che ci azzecchi con il contenuto, L'Anopheles sintetizza
con efficacia, precisione e documentata competenza l'evoluzione della sanità
pubblica in Italia negli ultimi due secoli. La forma letteraria nel titolo, che
riflette la passione dell'autore medico-radiologo per le suggestioni
impressionistiche indotte dall'arte medica, si riferisce alle zanzare che
trasmettono la malaria, e quindi a una delle conquiste più significative della
sanità pubblica nell'Italia unita, cioè l'eradicazione della malaria. Ma sulla
malaria in Italia si dice l'essenziale. Mentre il libro ricostruisce con ritmo
incalzante e un buon gioco tra dimensione sincronica e diacronica dei problemi,
colti in un'ottica non solo sanitaria, ma anche medica e quindi biopsicologica,
le trasformazioni epocali della salute degli italiani negli ultimi due secoli.
Nonché l'evoluzione dell'organizzazione delle pratiche medico-sanitarie che
hanno prima messo sotto controllo le principali malattie infettive, poi
inseguito l'illusione politica che la salute possa mai diventare quel «benessere
fisico, psichico e sociale completi» di cui dice all'articolo 1 la costituzione
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1946. Il libro lavora su diversi
registri storiografici: per circa metà, cioè fino all'indomani della Seconda
guerra mondiale, riassume gli elementi salienti della letteratura storica,
mentre gli ultimi cinquant'anni sono improntati a una cronaca di quel che è
accaduto sul piano delle scelte di politica sanitaria. Il libro arriva quasi
fino a oggi: nel senso che l'autore illustra la filosofia dell'attuale ministro
Balduzzi, e solo per poco non fa in tempo a registrare l'allarme del presidente
Mario Monti per la sostenibilità futura del nostro sistema sanitario, e in
particolare per il suo impianto universalistico. A chi si culla, abitando in
case riscaldate, dotate di frigorifero e con nelle vicinanze supermercati,
farmacie e ospedali, nel l'idea bucolica e pericolosa che nel passato si vivesse
meglio di oggi, la lettura di questo libro andrebbe prescritta come terapia a
tutela della salute pubblica. Perché predicare la decrescita, stramaledire il
progresso tecnologico (salvando solo qualche balocco come internet e il
telefonino), praticare il culto tribale dei cibi naturali e vagheggiare
stupidamente di pericoli dovuti alle vaccinazioni e ai farmaci, o di vantaggi
ottenibili usando medicine cosiddette alternative o anche naturali (omeopatia,
erboristeria, psicoanalisi, eccetera) sono un viatico sicuro per tornare ai
tempi in cui i bambini e le puerpere morivano come mosche, l'aspettativa di vita
non arrivava a quaranta anni e le diseguaglianze economiche e sociali
nell'accesso alle cure erano disgustose secondo i criteri di una morale umana
anche minimamente altruista. Tempi non lontani come racconta Savignano. E quel
che appare più disturbante nella vulgata tecnofobica e antiscientifica che
ammorba i Paesi occidentali in declino, come l'Italia, è l'ingratitudine verso
il lavoro degli scienziati e dei medici, da cui sono venuti i soli mezzi per
tutelare finalmente e davvero la qualità della vita propria e delle persone che
si amano. Le riflessioni di Savignano non nascondono i problemi e il capitolo
finale è un'ottima sintesi anche di questi. L'autore critica l'aziendalizzazione
e le logiche econometriche che guidano la sanità pubblica, anche se il suo
ragionamento scivola forse in modo troppo scontato verso i luoghi comuni. Ovvero
vede le cause principali di alcuni squilibri fuori dal sistema sanitario,
piuttosto che proprio dentro di esso e in una logica che, di fatto, sociologizza
e politicizza la salute. Nel senso che nel momento in cui, con lo sviluppo del
welfare state sanitario, la medicina è stata investita del compito di promuovere
la salute, piuttosto che limitarsi, più ragionevolmente e nel rispetto di valori
un po' più liberali, a curare e prevenire le malattie, si è andati verso quella
che il medico e scrittore inglese Michael Fitzpatrick ha chiamato «tirannia
della salute». Nel senso che i medici occidentali, ispirati da una concezione
sociologico-politica e davvero poco scientifica della medicina, hanno evoluto un
nuovo paternalismo, sentendosi caricati del mandato morale e inquisitorio di
diffondere una consapevolezza ossessiva dei rischi e promuovere un salutismo
esasperato e costoso. E non c'è ragione di essere ottimisti per l'arrivo di una
medicina, quella fondata sulla genomica, indubbiamente più scientifica in linea
di principio. Ma anche già troppo piegata da logiche di facile consumo. In
questo quadro d'incertezza sarebbe "salutare" rileggere le pagine scritte nel
lontano 1959 dal prestigioso batteriologo e grande intellettuale René Dubos in
The mirage of health. Dubos svolgeva una spietata critica dell'idea positiva di
salute, che stava per essere abbracciata dal welfare state sanitario. Ragionando
a partire da una visione evoluzionistica della salute e della malattia, visione
che i medici faticano ovviamente a capire anche per il modo fuorviante in cui
viene insegnata la medicina, Dubos prevedeva che l'aspettativa utopica di
superare le sofferenze e la morte, inevitabili data la nostra biologia, avrebbe
pesanti frustrazioni e alla lunga, per un'eterogenesi dei fini, un nuovo genere
di danni. A cominciare da una crescita inarrestabile dei costi, prodotta da una
domanda di salute in costante crescita e, di fatto incomprimibile dato che la
salute è, appunto, un miraggio. Senza contare gli irresponsabili inviti a
invecchiare il più possibile, senza dire che i vecchietti più o meno arzilli che
vanno in televisione a dire cose quasi sempre intellettualmente penose, sono la
punta di un iceberg che nasconde una popolazione in crescita di persone dementi
e cronicamente sofferenti, che minaccia il dinamismo e l'efficienza, cioè la
sopravvivenza di una società aperta al futuro. Curiosamente proprio quella che
loro hanno costruito. Ma da giovani.
Abitare lo spazio della fragilità. Oltre
la cultura dell'«homo infirmus» libro di Giovanni
Cucci. "Il messaggio che viene trasmesso fin dalla più tenera età è che siamo
troppo fragili per affrontare le difficoltà della vita e che è possibile al
massimo limitare i danni, facendosi curare. È il paradosso del salutismo, che ha
creato nuove forme di dipendenza: più ci si sottopone a cure e controlli, peggio
si continua a stare." La nostra cultura è sempre più sensibile al tema della
salute, fino all'ossessione. Una ossessione alla base del suo attuale disagio di
vivere: più ci si cura e più ci si scopre fragili, ansiosi, impauriti. Da qui la
tendenza a esasperare l'aspetto malato delle persone, non solo nell'ambito della
salute mentale ma nei contesti più diversi della vita, come la politica, le
relazioni affettive, l'educazione. Con effetti devastanti. Nel libro si
presentano le molteplici sfaccettature di questa preoccupante novità del nostro
tempo, cercando di risalire alle sue radici culturali. La salute a tutti i costi
ha comportato un grave impoverimento culturale e spirituale che sta lentamente
spegnendo il gusto di vivere dell'uomo occidentale.
SCOPPIATI DI SALUTE.
Scrive Massimo Recalcati il 27 maggio 2011 su “La Repubblica”. L'
anziano protagonista di uno degli ultimi film di Woody Allen, Incontrerai l'uomo
dei tuoi sogni, recitato da un raro Anthony Hopkins, esulta scoprendo che il suo
DNA gli garantirà una vita inaspettatamente protratta. Il rifiuto dell'avanzare
degli anni lo mobilita alla ricerca di una giovinezza perpetua che non implica
solo il progetto tragicomico di sposare una escort in carriera, ma anche
l'assoluta dedizione al potenziamento atletico e alla purificazione salutista
del suo corpo come per suffragare scaramanticamente la previsione esaltante
offertagli dal discorso medico. Questo personaggio non è un alieno ma una
maschera tipica del nostro tempo. Il corpo diventa un tiranno esigente che non
lascia riposare mai. In uno dei suoi ultimi libri titolato Il governo del corpo
(Garzanti 1995), Piero Camporesi aveva abbozzato l'idea che una nuova "religione
del corpo" si stesse imponendo nella nostra Civiltà. Peccato non abbia avuto il
tempo per elaborare con la giusta ampiezza questa intuizione che oggi si impone
ai nostri occhi come un'evidenza. Aveva ragione Camporesi: il nostro tempo ha
sposato l'ideale del corpo in forma, del corpo del fitness, del corpo in salute,
come una sorta di comandamento sociale inedito. Si tratta di una religione senza
Dio che eleva il corpo umano e la sua immagine al rango di un idolo. Così il
corpo sempre in forma, obbligatoriamente in salute, assume i caratteri di un
dover-essere tirannico, di un accanimento psico-fisico, di una prescrizione
moralistica: ama il tuo corpo più di te stesso! La nuova religione del corpo si
suddivide in sette agguerrite. Ma il loro comune denominatore resta
l'esasperazione della cura di sé che diventa la sola forma possibile della cura
come tale. Quella dimensione - la dimensione della cura - che per Heidegger
definiva in modo ampio l'essere nel mondo dell'uomo e la sua responsabilità di
fronte al fenomeno stesso dell'esistenza, sembra oggi restringersi al culto
narcisistico della propria immagine. La nuova religione del corpo rine? Le
espressioni psicopatologiche di questa cultura si moltiplicano. La
classificazione psichiatrica dei disturbi mentali (DSM) si arricchisce in ogni
edizione di nuove sindromi che sono spesso l'effetto diretto di questa invasione
sconsiderata della cura eccessiva di sé. Si pensi, per fare solo un esempio,
alla cosiddetta ortoressia che etimologicamente deriva dal greco orhtos
(corretto) e orexis (appetito). Si tratta di una nuova categoria psicopatologica
che definisce, accanto all' anoressia, alla bulimiao all' obesità, una
particolare aberrazione del comportamento alimentare caratterizzata dalla
preoccupazione eccessiva per il "mangiare sano". Ma come è possibile che una
giusta attenzione a quello che si mangia sia classificato come una patologia?
L'ortoressia esibisce un tratto essenziale del nostro tempo; il perseguimento
del benessere, dell'ideale del corpo in salute, del corpo come macchina
efficiente, può diventare un vero incubo, un'ossessione, può trasformarsi da
rimedio a malattia. Il corpo che deve essere perennemente in forma è in realtà
un corpo perennemente sotto-stress. La vita medicalizzata rischia di diventare
una vita che si difende dalla vita. Il corpo si riduce ad una macchina di cui
deve essere assicurato il funzionamento più efficiente. Il medico non è più,
come indicava Georges Canguilhem, l'"esegeta" della storia del soggetto, ma il
"riparatore" della macchina del corpo o del pensiero. La malattia chiede infatti
una dedizione assoluta per se stessi. Volere il proprio bene, volersi bene,
diventa il solo assioma che può orientare efficacemente la vita. Ogni sacrificio
di sé, ogni arretramento rispetto a questo ideale autocentrato, ogni operazione
di oltrepassamento dei confini del proprio Ego, ogni movimento di dispendio
etico di se stessi viene guardato con sospetto dai fedeli di questa nuova
religione. La stessa domanda rimbalza come una mantra dalla stanza dello
psicoterapeuta sino negli studi dei talk show televisivi: perché non ti vuoi
bene, perché non vuoi il tuo ben o n è un'occasione di trasformazione, ma un
semplice disturbo da eliminare il più rapidamente possibile cancellandone ogni
traccia. L' ortoressia riflette questa curvatura paradossale dell'ideologia del
benessere mostrando come le attenzioni scrupolose alla protezione del proprio
corpo possano trapassare nel loro contrario. Roberto Esposito ha da tempo messo
in valore nei suoi studi di filosofia della politica sul paradigma immunologico
questa contraddizione interna all' igienismo ipermoderno: il rafforzamento delle
procedure di protezione della vita rischia di capovolgersi nel loro contrario
facendo ammalare la vita. Lo sfondo antropologico della nuova religione del
corpo è quello del narcisismo ipermoderno che costituisce l'esito più evidente
del tramonto di ogni Ideale collettivo. Se la dimensione dell'Ideale si è
rivelata fittizia, se il nostro tempo è il tempo che non crede più alla potenza
salvifica e redentrice degli Ideali, ciò per cui vale la pena vivere sembra
allora ridursi al solo culto di se stessi. La nuova religione del corpo è un
effetto (non certo l'unico) del declino nichilistico dei valori, del perdere
valore dei valori. Il corpo eletto a principio assoluto sfida, nel suo furore
iperedonista, ogni Ideale per mostrarne tutta l'inconsistenza di fronte alla
sola cosa che conta: il proprio corpo in forma come realizzazione feticistica
dell'Ideale di sé. L' igienismo contemporaneo opera così un rovesciamento
paradossale del platonismo. Il corpo salutista non è affatto il corpo liberato,
ma è un corpo che da carceriere è divenuto carcerato. Se per Platone il corpo
era il carcere dell'anima, se era la sua follia impropria, il corpo salutista
appare invece come un corpo che è divenuto ostaggio, prigioniero di se stesso,
carcere vuoto, puro feticcio, idolo senza anima. Il comandamento del benessere,
come accade per tutti gli imperativi che si impongono come obbligazioni sociali,
come misure standard alle quali dover uniformare le nostre vite perché siano
considerate "normali", rischia di scivolare verso l'integralismo fanatico del
salutismo ortoressico. Soprattutto se si considera che questo comandamento punta
a rigettare lo statuto finito e leso dell'uomo, la sua insufficienza
fondamentale. L' ideologia del benessere è infatti una ideologia che prova ad
esorcizzare lo spettro della morte e della caducità. In questo svela il suo
fondamento perverso se la perversione in psicoanalisi è il modo di rigettare la
castrazione dell'esistenza, cioè il suo carattere finito. L' ideologia del
benessere che alimenta la nuova religione del corpo sbatte la testa contro il
muro della morte. E' questo ostacolo inaggirabile che il nostro tempo vorrebbe
espellere, cancellare, sopprimere e che invece ci rivela tutto il carattere di
commedia che circonda il culto ipermoderno del corpo. Dobbiamo ricordarci che la
cura di sé non esaurisce la dimensione della vita. La cura è innanzitutto cura
dell'Altro. Nietzsche aveva indicato la virtù più nobile dell'umano nella
capacità di saper tramontare al momento giusto. Rara virtù nei nostri tempi, da
celebrare come una preghiera. (L' autore è psicanalista e saggista, il suo
ultimo libro "Che cosa resta del padre?", è pubblicato da Raffaello Cortina).
Scrive Carlo Lottieri. Lo Stato
salutista? Fa male alla salute. Il paternalismo
trionfante, proiettato al controllo della corporeità di tutti e di ognuno è
sotteso da un vasto e sinistro progetto politico. Quella del proibire è una
pratica antica. Fin nelle epoche più lontane si rinvengono tabù e interdetti, e
ogni società esige regole che definiscano un quadro legale ben preciso, che
limiti l’imprevedibilità dei comportamenti altrui. Ma un certo tipo di
proibizionismo è abbastanza recente, poiché è legato a specifici cambiamenti
culturali che hanno caratterizzato la civiltà occidentale degli ultimi
cent’anni. Un ottima introduzione a questi temi si deve a Mark Thornton, un
ricercatore del Mises Institute di Auburn (in Alabama) che nel suo volume del
1991 intitolato L’economia della proibizione – ora disponibile in italiano
grazie all’editore Liberilibri di Macerata – ha sviluppato un’ampia riflessione
su tale aspetto peculiare della modernità: esaminando dapprima il proibizionismo
sugli alcolici (e il suo fallimento conclamato) e di seguito quello sulle droghe
(e l’analogo fallimento, che però molti faticano ad ammettere). Le tesi
principali della riflessione di Thornton non sono estranee al dibattito italiano
sul tema, poiché almeno in parte egli usa argomenti dibattuti anche da noi:
specie quando evidenzia che la proibizione porta a un aumento del prezzo degli
stupefacenti e di conseguenza induce la criminalità a investire somme massicce
per commercializzare tali sostanze. Il risultato è che oggi le droghe sono
ovunque e a caro prezzo, arricchiscono mafie e politici corrotti, causano un
gran numero di morti, riempiono le carceri, sono una fonte costante di conflitti
e tensioni internazionali. Ma c’è anche dell’altro. Thornton mostra ad esempio
come le origini del moderno proibizionismo – che nasce contro l’alcol e poi
investe pure la droga – siano tutt’altro che limpide. L’ispirazione degli
intellettuali che vollero bandire birra e whiskey era un mix di greve
positivismo e di puritanesimo secolarizzato. Quella che si voleva era un’America
più industriosa e addomesticata, e il campione di tale prospettiva culturale –
l’economista Irving Fischer – non nascose che il suo progetto di un’umanità
senza alcol doveva condurre ad un ordine tecnocratico e socialista, orientato
verso una crescente produttività. L’argomento principale di Fischer era che la
proibizione arrecava all’America un beneficio di circa 6 milioni di dollari ogni
anno: la cifra era buttata lì e senza il minimo fondamento, ma serviva a
giustificare la legislazione liberticida. Quel proibizionismo crollò su se
stesso, nei duri anni della Grande Depressione, travolto dagli effetti
disastrosi che aveva prodotto. Ma, come Thornton sottolinea, lo spirito
millenaristico che l’animava, incapace di fare i conti con l’imperfezione umana,
non è scomparso. Il disinteresse per la libertà individuale che caratterizzava
la propaganda del primo proibizionismo si ritrova in larga misura nell’igienismo
di Stato del nostro tempo. La guerra alla droga condotta dagli Usa e anche da
altri Stati va per giunta collocata ormai entro un quadro più ampio: se da un
lato trae origine dalla stessa cultura che ha proibito gli alcolici, d’altro
lato è molto connessa allo svilupparsi di crescenti attenzioni regolamentari
volte a proibire non solo la pratica suicidante dell’eroinomane, ma anche il
fumo delle sigarette e dei toscani, i cibi grassi e artefatti, la sedentarietà.
Specialmente in Nord America l’isteria salutista sta infittendo di proibizioni
la vita di ognuno, al punto che vi sono taluni comuni della California in cui è
proibito fumare una sigaretta nelle abitazioni private e perfino in automobile.
Dopo gli studi pionieristici dello psichiatra libertario Thomas S. Szasz, ormai
sono molti gli autori che denunciano apertamente l’avvento di uno “Stato
terapeutico”, quale ultima versione dello Stato moderno. Lo ha fatto ad esempio
James L. Nolan in The Therapeutic State: Justifying Government at Century’s End,
del 1999, mostrando come il potere s’insinui sempre più nelle nostre scelte
personali, decidendo al nostro posto e per il nostro bene. Se un tempo il
diritto indicava norme che avevano la funzione fondamentale di proteggere i
diritti altrui, adesso pretende di sostituirsi a noi in tutto: dicendoci cosa
dobbiamo fare anche quando le eventuali conseguenze negative della nostra
condotta non sono invasive dell’esistenza di altri. È insomma un vasto programma
biopolitico (per usare la terminologia foucaultiana) quello che sottende il
paternalismo trionfante, proiettato al controllo della corporeità di tutti e di
ognuno. Uno degli intellettuali più vicini a Barack Obama, Cass Sunstein, è
arrivato a elaborare la formula paradossale del “paternalismo libertario”, al
fine di giustificare un progressivo intervento pubblico che ci tratti da minori
con lo scopo di allargare il raggio delle nostre facoltà. L’idea è che
bisognerebbe perdere la libertà per rafforzarla. Ma quando lo Stato mette in
discussione la possibilità di agire in maniera viziosa anche se questo
comportamento non è aggressivo (mentre, nella sua saggezza, San Tommaso d’Aquino
aveva ben chiaro che vi sono peccati che non sono reati), ci si trova su una
china che conduce verso prospettive totalitarie. Da economista della scuola
austriaca e quindi attento alla lezione di Mises e Hayek, l’autore de L’economia
della proibizione evidenzia che “la domanda di politiche interventiste quali
quella della proibizione nasce dalla percezione che il processo di mercato ha
fornito risultati insufficienti o che non correggerà le sue inefficienze”. Il
proibizionismo o è illiberale o non è, dato che incarna una pericolosa
presunzione del ceto politico, che punta ad arrestare ogni evoluzione
imprenditoriale: “il processo di scoperta del mercato porta alla circolazione di
prodotti meno costosi, di qualità migliore e più sicuri. La proibizione pone
fine al processo di scoperta e lo rimpiazza con un mercato nero e un processo
burocratico, ognuno con i suoi mali”. È come se il mondo si fermasse e nessun
futuro migliore fosse possibile. Gli imprenditori escono di scena e il loro
posto è preso da politici e burocrati. Ma come rilevò Mises, “se si abolisce la
libertà dell’uomo di determinare il proprio consumo di beni, si tolgono tutte le
libertà”. Vi è allora un’ultima, decisiva questione da tenere presente: e cioè
che la responsabilità individuale può crescere solo nella libertà. Un’umanità
regolamentata ed eterodiretta può forse evitare le conseguenze nefaste dei
trigliceridi, degli oppiacei, della nicotina e dell’alcol, ma non riuscirà certo
ad acquisire la forza interiore di chi resiste a questa o quella tentazione in
virtù della propria temperanza: e quindi della propria maturità. Il
paternalismo, insomma, ci condanna a un’esistenza da eterni bambini. Va anche
aggiunto che chi come Thornton difende la libertà contro la proibizione non
intende promuovere la diffusione di pratiche irresponsabili: dal consumo
eccessivo di alcol all’assunzione di cocaina. Semplicemente, egli evidenzia come
il proibizionismo sia inefficace e – quel che è peggio – irrispettoso della
dignità dell’uomo. Il quale, quando regna lo Stato terapeutico, si vede negare
la libertà di sbagliare. E non si tratta di una libertà di poco conto. Da Il
Giornale, 14 ottobre 2009.
Schiavi del salutismo Un futuro (troppo)
vicino. Ne " prigionieri del Caduceo", Moore racconta
un mondo dominato da dottori e tecnici dello star bene. Una dittatura buonista
ma feroce, scrive Luca Gallesi Venerdì 29/05/2015 su “Il Giornale”. L'idea che
ogni desiderio dell'uomo sia finalmente realizzabile, e che, grazie al progresso
scientifico, si possano valicare i limiti della realtà oggettiva è alla base di
alcune illusioni dalle conseguenze assai pericolose per molti e altrettanto
redditizie per, pochi, altri. Immaginare, a esempio, che si possa sconfiggere la
morte usando trattamenti estetici o grazie a protocolli farmacologici è
semplicemente ridicolo, anche se molto proficuo per case farmaceutiche e
chirurghi senza scrupoli. Allo stesso modo, ritenere che la vecchiaia sia una
malattia da affrontare con cure adeguate, o che l'iperattività infantile debba
essere trattata con psicofarmaci, oppure che le turbe dell'adolescenza vadano
sempre portate davanti allo psicoanalista sono atteggiamenti sbagliati, che
finiscono per togliere libertà e sicurezza agli individui, aumentando
contemporaneamente il potere della classe medica. Come gli sciamani euroasiatici
o gli uomini di medicina nordamericani di un tempo, spesso, oggi, sono i medici
ad avere l'ultima parola su questioni che riguardano scelte fondamentali come la
vita e la morte degli individui. La dilagante moda salutista del «mangiare
bene», possibilmente biologico, per «vivere bene», ci avverte che «il fumo
uccide», condannando tutte le abitudini un tempo considerate bagaglio
ineludibile della condizione umana, come la passione per il rischio o l'amore
per la sfida, oggi disapprovate da una società sempre più medicalizzata, che ha
finito per ridurre definitivamente in cenere Bacco, Tabacco e Venere. Cosa
potrebbe succedere se queste tendenze diventassero obblighi di legge, e se i
medici finissero per conquistare il potere politico è raccontato nel romanzo di
fantascienza I prigionieri del Caduceo, scritto da Ward Moore nel 1978 e
presentato oggi per la prima volta al pubblico italiano nel fascicolo di maggio
della collana Urania. La storia si svolge in un futuro prossimo, dove il mondo è
stato definitivamente globalizzato e sottoposto alle amorevoli cure della
Mediarchia, ovvero della classe medica. I camici bianchi, radunati sotto il
simbolo del Caduceo, sono l'unica classe dirigente del pianeta, Gran Bretagna
esclusa, e impongono la dolce dittatura salutista e le sue regole, che prevedono
la «tanatizzazione» a chi è troppo debole per vivere, la vasectomia obbligatoria
per tutti, la riproduzione consentita solo a chi è in forma fisica eccellente, e
il controllo ossessivo di tutti i parametri fisiologici, come la pressione
arteriosa e i valori ematici, trascritti su cartelle cliniche diventate
documenti di identità obbligatori. Nessuno, o quasi, tenta di ribellarsi, dato
che «i dottori e gli scienziati sono coloro che sanno», e quindi non possono che
agire per il nostro bene. Tutti i libri sono stati bruciati, per le stesse
ragioni di monopolio del sapere, e il motto mondiale è diventato «In DOC we
trust», con i dottori che hanno preso il posto di Dio. Il lutto viene
scoraggiato, la buona salute è obbligatoria, e ai bambini viene insegnato a
segnalare alle Autorità Mediche ogni violazione delle regole sanitarie da parte
dei genitori, regole che un ristretto gruppo di ribelli, definiti Anormali,
decide di rifiutare. Come fanno notare i curatori, Gianfranco de Turris e
Sebastiano Fusco, nella loro introduzione (da cui, forse un po' pavidamente,
sembra prendere le distanze il direttore della collana Giuseppe Lippi), la
Mediarchia ipotizzata da Moore sta diventando una realtà in molte parti del
mondo: se in Cina viene imposta la politica del figlio unico, in Occidente il
fumo viene proibito anche all'aperto e i carnivori sono considerati orrendi
selvaggi, mentre i figli troppo grassi vengono tolti alle famiglie e cominciano
a dilagare apparecchietti da polso che tengono costantemente monitorati i valori
della nostra pressione, il battito cardiaco etc...Il Governo, insomma, vuole
preoccuparsi di noi, come il Grande Fratello orwelliano, «dalla culla alla
tomba», con la presunzione di sapere sempre, e meglio di noi, cosa ci fa bene, e
quello che dobbiamo fare. L'arroganza di certe «maestrine dalla penna rossa»,
che pretendono di cancellare il passato per plasmare il futuro, è ben descritta
da Moore, che non avrebbe probabilmente immaginato che quanto da lui raccontato
quasi quarant'anni fa si sarebbe materializzato così presto, anche se, per ora,
la classe medica non è al potere, ma si limita a mettersi al servizio di quella
politica, ansiosa di mostrarsi più realista del Re, prostrandosi al Moloch del
politicamente corretto.
Lűtz: «Sì alla vita sana, ma non fate i
sadici», scrive Andrea Galli il4 febbraio 2015 su
“Avvenire”. La Germania detta la linea in Europa. Per ora quella dei conti,
domani chissà, anche quella del girovita. Tra i settori in crescita
dell’economia teutonica spicca infatti l’industria del fitness: un tedesco su
dieci, tra i 15 e i 65 anni, è iscritto a una palestra, un numero che dovrebbe
toccare nel 2017 quota 10 milioni, con relativi 200mila lavoratori nell’indotto.
Cosa non sorprendente in un Paese che è tra i primi in Europa e nel mondo per
sensibilità ecologica, per campagne sulla qualità dell’alimentazione, per la
promozione del cibo bio ecc. A far da controcanto a questa euforia da vita
salubre, tonica e asciutta è ormai da diversi anni Manfred Lütz, psichiatra,
teologo, saggista di successo, membro del Pontificio Consiglio dei laici e della
Pontificia Accademia per la vita. Tra i suoi libri figurano Dio. Una piccola
storia del più grande (Queriniana 2008) bestseller in patria, e il recente Il
piacere della vita. Contro le diete sadiche, i salutisti a tutti i costi e il
culto del fitness (San Paolo).
Professor Lütz, l’uomo occidentale ha lottato
per secoli per l’avanzamento della scienza, della medicina, della farmacologia,
per migliorare le sue condizioni di vita. Ora siamo giunti a un paradosso, anzi
a diversi paradossi: più si allunga la vita e più il welfare, le pensioni
diventano difficili da sostenere; più si allunga la vita e più si allunga la
vecchiaia, l’età che tutti vorrebbero evitare… e molti, anzi, pensano ora di
accorciare con il suicidio assistito… sembra una nemesi. C’è qualcosa che non
torna in questa dinamica. Dove sta l’errore?
«Qual è una società felice, quella che onora la
gioventù o quella che onora gli anziani? C’è solo una risposta logica: è quella
che onora gli anziani. Se una società onora in primo luogo la gioventù, un
sedicenne che guardasse al proprio futuro vedrebbe un orizzonte oscuro. Se onora
l’età della vecchiaia, quel sedicenne può pensare al giorno in cui, seduto nel
senato della vita, guardato con rispetto e sazio di anni, come dice in modo
l’Antico Testamento, morirà. L’odierno culto dell’essere giovani è una via
all’infelicità, perché, come fa notare lei, la vecchiaia diventa sempre più
lunga grazie all’avanzamento della medicina, ma allo stesso tempo viene sempre
più svilita. A chi è vecchio, malato, portatore di handicap o limitato in altro
modo, alcuni vogliono offrire la possibilità di non essere più un peso per se
stesso, per la famiglia e la società. L’introduzione nella legislazione del
suicidio assistito sarebbe la rottura dell’argine, che metterebbe in pericolo il
proprio diritto all’autodeterminazione dell’anziano, del malato, del disabile e
che sarebbe radicalmente in contraddizione le nostre costituzioni e il principio
cristiano che ancora portano in sé, quello dell’uguale dignità di ogni essere
umano, incluso il più debole. Per questo le associazioni mediche e le Chiese
sono contrarie. Bisogna vedere quanto a lungo l’argine reggerà».
Anche quell’ansia collettiva che è il salutismo
sembra un paradosso: non abbiamo mai vissuto in una società così salubre come
quella odierna… non pensa?
«Un medico mio collega, piuttosto spiritoso, ha
detto una volta: sana è la persona che non è stata visitata abbastanza. Già
Aldous Huxley disse: la medicina ha fatto tali progressi, che nessuno si può più
ritenere sano...»
Lei ha parlato a più riprese, in libri e
interviste, di una vera e propria "religione della salute". Quali sono i tratti
"religiosi" che vede nel salutismo? Quanto c’entra la volontà di esorcizzare la
morte?
«La mia impressione è che oggi molti non credano
più in Dio ma nella salute e tutto quanto una volta si faceva per il Dio –
pellegrinaggi, digiuni e opere buone – oggi lo si faccia per la salute. Ci sono
persone che non affrontano più la vita in modo lineare, ma vivono in modo
"preventivo" e alla fine muoiono sane. Però anche chi muore sano, purtroppo è
morto. Così anche le manifestazioni tipiche dell’esperienza religiosa sono
entrate nel campo della salute. Si può osservare il passaggio dalle tradizionali
processioni alla visite in processione dal medico, ai pellegrinaggi dallo
specialista. Nelle palestre si possono incontrare persone che vivono una vita di
rinunce e mortificazioni in confronto alle quali la regola degli ordini
religiosi di più stretta osservanza sembra una passeggiata. E la morte è il
nemico mortale di questa religione della salute. Per evitare la morte si corre
per strada, nei boschi, si mangiano granaglie e peggio... per arrivare a morire
lo stesso, purtroppo».
Tra i tratti "religiosi" del salutismo possiamo
annoverare anche il fatto che pratiche come il fumo sono percepite oggi come
veri e propri peccati, personali e sociali? O che la bruttezza (avere difetti
fisici, essere grassi, ecc.) è spesso squalificante e fonte di imbarazzo?
«Certamente, il peccato è un concetto presente
oggi quasi solamente nell’ambito della religione della salute. Perfino in chiesa
i parroci sono diventati prudenti a usare l’espressione "peccato". È una parola
che non si pronuncia più volentieri, perché suona dura, sgradevole, molto meglio
dire "essersi allontanati dalla via". Se in Germania uno osserva in quale
contesto la parola peccato risuona ancora, si può accorgere che è appunto quello
della salute, dove c’è un dio che punisce subito anche i più piccoli peccati…
Tutto ciò ha delle conseguenze rilevanti. Se l’uomo autentico è quello sano,
allora l’uomo malato, soprattutto malato cronico, diventa un uomo di seconda o
terza classe. Il che porta alla discriminazione dei non sani, dei non giovani,
dei non belli è dietro l’angolo. E la pressione sociale su queste categorie
cresce sensibilmente».
Filippo Facci su “Libero Quotidiano” del 25
dicembre 2015. Facci, la terribile profezia sul futuro: "Perché vieteranno pizza
e caffè". Nella Terra dei fuochi hanno spento il forno a legna, almeno quello: a
San Vitaliano (6mila abitanti, provincia di Napoli) il sindaco pensa che lo
sforamento dei limiti sulle polveri sottili sia colpa delle pizze, cioè dei
forni a legna, dunque ha imposto costosi impianti di abbattimento oppure niente
pizze. L' ordinanza vale sino ad aprile ma potrà essere prorogata. Ora: siamo
nel napoletano e in pratica vietano le pizze (immaginatevi le scene pazzotiche)
ma non interessa, ora, difendere la degnissima categoria dei pizzaioli che
peraltro hanno anche e probabilmente ragione: non si capisce, infatti, perché
incolpino i forni a legna quando la vicina Napoli (meno inquinata) ne ha molti
di più. Che cosa pensiamo di tutti i discorsi sulla "vera pizza" già lo
scrivemmo quando le associazioni dei pizzaioli volevano escludere le catene
McDonald' s dagli sponsor dell'Expo: è una categoria che fa spallucce mentre due
pizze su tre, in Italia, sono fatte con farina e pomodoro e mozzarella e olio
non italiani, inoltre la presunta mozzarella è fatta con cagliate dell'est
Europa, il pomodoro è cinese o americano, l'olio tunisino o spagnolo mentre la
farina è francese o tedesca o ucraina. Si straparla della superiorità della
pizza italiana anche se è infornata quasi sempre da extracomunitari e anche se
la maggioranza degli americani e dei cinesi ignora che la pizza sia italiana, e
il maggior fornitore di "mozzarelle" mondiale è neozelandese. Ma è un altro
discorso, appunto. Il discorso, rassegnato e un po' da vecchi, è su un certo
mondo che ci attende. I pizzaioli di San Vitaliano hanno poco da illudesi: i
forni a legna vecchia maniera, prima o poi, li vieteranno tutti e dappertutto.
Ufficialmente per lo smog, certo, per gli odori e le esalazioni: qui al Nord,
del resto, molte città hanno già vietato i caminetti e le stufe a legna. Il
trend è quello, ma non è solo una questione di inquinamento, il punto è che il
mondo moderno parla con nostalgia dei vecchi profumi ma tende a scacciarli dalla
vita quotidiana, è una specie di sindrome mirata al desiderio di un solo odore:
nessuno. Un paio d' anni fa il sindaco di Mosca si era messo in testa
addirittura di piazzare dei giganteschi diffusori nelle zone strategiche della
città, voleva scacciare le puzze residue del socialismo reale: nafta e benzina
col piombo, miasmi industriali di chi se n' è sempre fottuto dell'inquinamento,
olezzi di cavolfiore alimentati dai milioni di fornellini per il pranzo che si
accendevano nei retrobottega della Russia socialista. E via, scio', allontanare
i tabaccai e le fabbriche di sigarette, le torrefazioni e gli odori di caffè.
Intransigenze alla Putin? Per niente. In alcune zone del Canada e degli Usa, da
anni, hanno messo al bando i profumi: dicono che disturbino l'olfatto. Avete mai
fatto caso che certi prodotti già riportano la scritta "non profumato"? In
alcuni uffici sono vietati persino deodoranti e dopobarba e colluttori. A Ottawa
i mezzi pubblici sono interdetti a chi usa l'acqua di colonia: i profumi hanno
cominciato a nutrire le stesse ossessioni maturate contro il fumo e sono
stupidamente associati a batteri e a sostanze inquinanti. Sono stati chiusi
centinaia di panifici e tostature di caffè, e questo anche negli Usa, e vedrete
che - more solito - le peggiori fobie d' oltreoceano presto o tardi sbarcheranno
anche qui. Alcune chiese cattoliche hanno già abolito l'incenso (l'incenso
passivo) e persino le candele. Hanno già inventato una malattia senza senso (la
"sensibilità chimica multipla") che associa ogni odore a un campanello d'
allarme. Figurarsi se prima o poi non spunteranno associazioni di allergici ai
forni a legna: andranno dai vari Santoro e grideranno tutta la loro indignazione
per le malattie dei loro figli. Anche lasciando da parte l'inquinamento, laddove
il benessere crea allergie praticamente a tutto (quella al glutine è solo
l'ultima) è chiaro che i forni a legna hanno le pizze contate.
Filippo Facci su “Libero Quotidiano” del 13
gennaio 2015: "Vogliono vietare il fumo persino al parco". «Viva l’Occidente e
viva libertà»: poi ti arriva la Lorenzin che vuole vietare il fumo persino in
spiaggia o nei parchi, in ossequio a quell’altra religione fondamentalista che è
diventata il salutismo. Ma niente battute, anzi ricominciamo da capo, che il
tema merita repliche razionali e informate, non solo di principio. Allora: si
apprende che il ministro della Salute Beatrice Lorenzin si accinge a una stretta
ulteriore in materia di fumo e sigarette, ossia: niente sigarette nei parchi
pubblici, negli stadi e nelle spiagge attrezzate; niente sigarette nella tua
auto se hai minori a bordo; non possono fumare neppure gli attori dei film (nei
film) o meglio non più di tanto. Questi i tre caposaldi, imperniati su
ragionamenti e luoghi comuni che il ministro rilancia beatamente anche se
appaiono perlomeno discutibili.
1) Il primo luogo comune vuole che la famosa Legge
Sirchia, varata nel 2005, sia stata una legge toccasana e apprezzatissima in
tutto e per tutto: dunque il suo percorso andrebbe proseguito, dice ora il
ministro. Orbene, cominciamo col riconoscere i meriti della legge: in pratica ha
significato il divieto di fumare nella maggioranza dei ristoranti (le salette
con gli impianti di areazione sono costose) e c’è molta più attenzione in mezzi
pubblici, scuole, ospedali, uffici e aziende: che è quanto in teoria già
prevedeva la legge amministrativa del 1975. La norma dell’ex fumatore Sirchia
(gli ex sono i più intransigenti) è dunque servita a ridonarci l’educazione
necessaria per non fumare laddove era già vietato. Di recente si sono aggiunti i
divieti di fumare negli spazi esterni delle scuole, e la vendita di prodotti
legati al tabacco - anche le sigarette elettroniche, che col tabacco non
c’entrano niente - è interdetta ai minorenni. Detto questo, la legge Sirchia è
stata un fallimento per quanto riguarda i famosi «sceriffi antifumo» (che non
esistono più per una sentenza del Tar) e per i cosiddetti «luoghi aperti a
utenti» intesi come studi professionali, condomini, stazioni, circoli, club,
feste private e nondimeno il Parlamento italiano: in questo caso c’è stato un
accomodamento all’italiana e si continua elasticamente a fumare come prima. Il
fatto che a un anno dall’applicazione della Legge ci fossero state solo 327
infrazioni accertate (perlopiù per l’irregolarità dei cartelli, perché i
fumatori beccati in flagrante furono 112) fu un viatico per la situazione
attuale: le multe sono una rarità assoluta. Una sentenza del Consiglio di Stato
del 2009 ha annullato ogni sanzione ai proprietari di locali che non segnalino i
fumatori in contravvenzione: tanto che gli strappi alla regola, se nessuno
protesta, non si contano. L’importante è non esibire posacenere, perché
dimostrerebbero una complicità. L’entourage del ministro fa sapere che solo il
2% delle 35.800 ispezioni fatte dai Nas hanno beccato persone che fumavano, e
traducono il dato in un successo: non nella probabilissima ipotesi che i Nas
abbiamo altro da fare che sanzionare i ragazzini che fumano nelle discoteche, i
quali - aggiungiamo noi - per farsi cogliere in flagrante devono essere anche
discretamente stupidi.
2) L’altro luogo comune vuole che la lotta al fumo
debba essere proseguita costantemente con campagne di sensibilizzazione che
comprendono provvedimenti - aggiungiamo noi - khomeinisti. Divertente,
anzitutto, che l’Organizzazione mondiale della sanità suggerisca - e il ministro
pure - che le sigarette in Italia dovrebbero costantemente aumentare di
prezzo: forse non ricordano che è quanto già accade regolarmente perché i
governi vogliono fare cassa; il giorno in cui gli italiani dovessero smettere di
fumare sarebbe anzitutto una catastrofe per l’erario, e parliamo di miliardi di
euro. Ma a parte questo, si insiste con la direttiva europea (aprile 2014)
secondo la quale sul 65% della superficie dei pacchetti dovranno apparire
immagini dissuasive: non solo le scritte iettatorie, anche foto con polmoni
incatramati come già accade in Brasile e in altri Stati. Ora: senza annoiare con
troppi dati, la verità che salta all’occhio palesemente è che le campagne di
dissuasione non funzionano; il calo dei fumatori come numero assoluto in Italia
è inferiore a quello di altri Stati che hanno leggi molto più permissive, senza
contare che i dati sul decremento (dal 23 al 19% in dieci anni) sono fondati
solo sulla vendita legale di sigarette e non considerano il contrabbando, che è
tornato a prosperare per via dei continui aumenti; non sappiamo poi - non lo
sappiamo davvero - quanto i dati considerino il grandissimo aumento delle
vendite di cartine e tabacco sfuso. Il primo dato mondiale è che in Occidente le
sigarette andavano sparendo perché perdevano appeal e facevano socialmente
arretrato, mentre l’altro dato mondiale (e italiano) è che proprio le campagne
di sensibilizzazione stiano facendo aumentare il fumo tra i minori e le donne,
categorie che, in modi diversi, associano la sigaretta all’emancipazione. Ai
ministri e all’Oms non viene il sospetto che i famosi giovani - proprio perché
sciame, orda, gruppo - abbiano già tranquillamente in mente quel che dovrebbero
apprendere, e che proprio da questa consapevolezza muova il loro desiderio di
devianza. Il ministro, semmai, rovescia il ragionamento: «Le statistiche dicono
che c’è stato un incremento importante tra i fumatori giovanissimi, in età 11-12
anni, e questo vuol dire che si è abbassato il livello di guardia e di
consapevolezza ma anche di una stigmatizzazione del fumo». Ossia? Forse che i
dodicenni fumano perché il ministero non gliel’ha proibito abbastanza? Non è che
fumano - come per l’alcol, la velocità in auto eccetera - proprio perché un
tempo faceva sfigato, mentre oggi, grazie alle campagne khomeiniste, la cicca è
tornata a far trasgressione?
Si chiamano domande retoriche, queste. Fondate su
dati. E le poniamo senza far volare stracci, come pure meriterebbe il solo
pensiero che non si possa fumare più nella propria auto o in spazi apertissimi
come un parco o una spiaggia. Non vorremmo, poi, che i lettori pensassero che i
fanatici siamo noi.
Filippo Facci su “Libero Quotidiano” del 8 luglio
2015: "Vietano le sigarette in auto. Ma i politici cosa fumano". A causare
le peggiori sciagure è sempre della gente che vuole il tuo bene e quello
dell'umanità, ma forse non c'è da farla tanto lunga per commentare l'ennesimo
tentativo di vietare il fumo nella propria auto. C'è solo da dire che il
problema è statistico: prima o poi rischiano di farcela, rischiano di approvare
un divieto del genere, anche perché per due cose non esiste limite: per la
deriva salutistica e per la stupidità. Ma ricominciamo dall'inizio, anche se la
storia è sempre quella: è spuntata una pattuglia di senatori (di Forza Italia,
oltretutto) che vuole vietare le sigarette dentro le auto. Primo firmatario
è Antonio Razzi più altri senatori tra i quali Domenico Scilipoti, il che
dovrebbe garantire l'insuccesso del disegno di legge: ma siccome il divieto è un
pallino anche della ministra della Salute Beatrice Lorenzin (presunta liberale)
non si sa mai che cosa possa succedere. I senatori comunque vorrebbero
modificare il codice della strada (articolo 173 bis, «È vietato al conducente
fumare durante la marcia») con pene fino a 646 euro e ritiro della patente per
chi venisse beccato due volte in due anni. Ragione ufficiale: la solita
di «ridurre gli incidenti stradali» con rimando esterofilo genere «lo fanno
anche Inghilterra e Svezia». Parentesi: se il discorso è questo, allora
potrebbero informarsi meglio e aggiungere che dal 2008 il divieto c'è anche a
San Marino e in alcune regioni del Canada e a Bangor, una città degli Usa, nel
Maine. Invece la nostra pattuglia ha preferito spiegarci che «il conducente
getta fuori dal finestrino il mozzicone acceso con conseguenze imprevedibili per
l'ambiente esterno» e non bastasse «può causare incendi all'interno del veicolo
stesso». Una vera emergenza nazionale. Vogliamo commentare? No, prima va
ricordato che nel 2013 la Lorenzin aveva già provato ad introdurre il
divieto (ma solo in presenza di minori, che è già un altro discorso) e che
presentò una legge ad hoc in Consiglio dei ministri: poi fu convinta a lasciare
il tema al dibattito parlamentare e, nel febbraio scorso, a tentare d'infilarla
nel Milleproroghe o in qualche altro taxi parlamentare. Andò buca.
Ora rispuntano Razzi e Scilipoti - una garanzia - che in realtà stanno
riciclando un'altra genialata dell'Italia dei valori più un paio di parlamentari
del Pd: nella primavera 2010 proposero la stessa cosa (modificare l'articolo 173
del Codice stradale) anche se non fecero che riciclare, pure loro, un
emendamento dell'ex senatore leghista Piergiorgio Stiffoni, altra garanzia. Che
vogliamo dire? L'assurdità di una legge del genere dovrebbe balzare all'occhio
immediatamente: se tanto mi dà tanto, presto, il Codice della strada potrebbe
vietarci direttamente di guidare. La sigaretta può essere una fonte di
distrazione e causare incidenti, non c' è dubbio, ma se la scienza statistica
divenisse a tutti gli effetti fonte di legge, beh, sarebbe davvero finita. Dire
che presto vieteranno anche di parlare in auto - e ascoltare musica,
mangiare, insomma tutto - sempre una battutaccia benaltristica, ma forse non
sapete che il nuovo codice stradale inglese lo dice sul serio: mangiare o bere,
inserire il cd nel lettore, cercare una stazione radio, ascoltare musica ad alto
volume o discutere coi passeggeri, ebbene, tutto questo «può essere usato come
prova a carico in un processo». Perfetto, ma allora vietino anche di sposarsi,
perché avere la moglie affianco spesso è un fattore stressante che aumenta la
probabilità di incidenti; vietino le auto ai bambini, soprattutto alle suocere:
pericolo di morte. Vietino di pensare troppo intensamente - non so se Razzi e
Scilipoti abbiano presente - perché pensare è senz'altro la prima fonte di
distrazione. Anche guidare, come detto, aumenta sicuramente la probabilità di
incidenti. E comunque non è il caso di fare troppo gli esterofili, perché
all'estero si trova di tutto. Nei paesi tedeschi sono molto più tolleranti. È
vero che in Inghilterra hanno vietato di fumare nella propria auto: ma in alcune
città statunitensi, in compenso, si può fumare solamente nella propria auto. A
Hollywood vogliono vietare ai minori tutti i film dove si vedono attori che
fumano (qualcuno l'ha proposto anche in Italia: sorvoliamo) e la Rai, qualche
giorno fa, ha fatto sapere che non trasmetterà una mia intervista (fatta a me,
all'aperto) perché si vede che fumo. In Canada e negli Stati Uniti ci sono
chiese dove hanno proibito l'incenso perché equiparato al fumo passivo. L'Unione
europea, tempo fa, ha dato il benestare alla possibilità di non assumere un
fumatore in quanto semplicemente fumatore, questo mentre le autorità britanniche
mettono i fumatori e gli obesi agli ultimi posti delle liste sanitarie. È già da
un pezzo che un terzo dei datori di lavoro americani, ai neo assunti, chiede
esami del sangue e delle urine: cercano tracce di nicotina. Dite pure che il
discorso è fuorviante, dite pure che stiamo parlando solo di vietare il fumo in
automobile perché oggettivamente distrae. Ma l'auto è uno spazio privato per
definizione: presto, di conseguenza, potrebbero vietare di fumare in casa, come
in alcuni condomini degli Usa: questo ridurrebbe sicuramente la probabilità di
incendi. Dopodiché passeremmo, probabilmente, ad altre neo-fobie
occidentali. Del tipo: occhio a vivere troppo, che a quanto pare la cosa -
dicono le statistiche - aumenta le probabilità di morire.
Filippo Facci su “Libero Quotidiano” del 29
ottobre 2015: Mangio carne e me ne fotto. La prima causa di morte al mondo -
dice la battuta - è la vita. Oppure: basta nascere e hai una probabilità su tre
di avere un tumore, e questa è già meno una battuta. Altre piccole verità sono
che una parte del mondo non riesce a mangiare e che l'altra metà non riesce a
non farlo, e che i libri più venduti d' Occidente sono rispettivamente i manuali
di cucina che servono a ingrassare e i prontuari dietetici che servono a
dimagrire. In mezzo a tutto questo, basandosi su studi epidemiologici su base
statistica, tutto può essere detto e sostenuto: sta a noi (noi singoli, perché è
inutile spalmarsi sugli esperti) restituire senso delle proporzioni a ciò che è
causa di morte perché inevitabilmente fa parte della vita. E ci piacerebbe
chiuderla qui, ma non è possibile: perché non passa giorno senza che un'alterata
percezione del rischio trasformi in cause di morte, appunto, anche le cause di
vita. Ora il macro-messaggio è «la carne è cancerogena» e così ritroviamo le
salsicce accanto all'arsenico e all'amianto nel gruppo 1, quello in cui
l'Organizzazione mondiale della sanità racchiude gli agenti più pericolosi per
la salute. Tra l'altro non c' è nessun nuovo studio rivoluzionario: hanno
banalmente revisionato 800 studi già esistenti e fondati sul solito criterio
statistico. Il punto è che si sa da decenni che la prima causa di morte è il
cibo: ma sino a poco tempo fa era considerata una causa «non rimovibile» e
allora ci si accapigliava sul tabacco. Ora che la battaglia sul fumo pare vinta
(il calo è costante in tutto l'Occidente) si passa meno timidamente
all'alimentazione. C'è qualcosa che non sapevamo? La dieta mediterranea è la
migliore e gli eccessi di carne rossa (o lavorata e in scatola) non sono il
massimo per la salute: lo sapevamo eccome, la differenza tuttavia può stare
nell'organizzazione di una campagna mediatica e «scientifica» da parte di una
sanità che tende a inglobare anche le dimensioni comportamentali dell'esistenza,
in pratica uno Stato-madre che nel libero arbitrio veda una minaccia da ridurre
a malattia e che decida a tavolino i prossimi nemici della nostra salute.
Sparare da un giorno all'altro che «la carne provoca il cancro» tende a
terrorizzare l'opinione pubblica come fanno quei governi che vorrebbero negare
la mutua agli obesi, e preparano etichette per cibi e vini come quelle dei
pacchetti di sigarette, questo mentre in alcuni stati americani il peso dei
bambini è diventato un voto sulla pagella. Eppure sì, con un po' di buonsenso
sapevamo già tutto: l'attenzione spasmodica al rapporto tra salute e
alimentazione risale agli anni Sessanta, quando il World Cancer Research
Fund annunciò al mondo che il 40 per cento dei tumori avrebbe potuto essere
evitato semplicemente cambiando dieta. Da allora abbiamo scoperto che fa male
tutto: lo zucchero e il sale, i carboidrati e la carne, certa frutta e certa
verdura, il latte e i formaggi, l'olio, il burro, la margarina, il cioccolato e
le merendine, le caramelle, il caffè, l'acqua gassata e quella del rubinetto, la
Coca-Cola, il vino e ovviamente tutti gli alcolici, nondimeno i fumi di cucina,
le pentole, quelle antiaderenti, i contenitori di plastica, le bottiglie di
plastica, le lattine, il forno a micro-onde, i fritti, i conservanti, i quattro
salti in padella, i pesticidi, il cibo in scatola. Fa maleanche
il digiuno. Fanno male le diete. E i farmaci per dimagrire. E dimagrire. Per
dimagrire peraltro c'è questo modo: fumare. E per morire c'è quest'altro modo:
non mangiare. Questo non è un modo di buttarla in caciara o di peccare di
benaltrismo, inteso come sostenere che ci siano cause di morte più gravi di cui
dovremmo occuparci: ma, se tutto è cancerogeno, nulla lo è più. In molti studi
dell'Oms si legge che ogni anno il fumo causa un milione di morti per cancro,
l'alcol 600mila e l'inquinamento 200mila: bene, ora la carne figura nella stessa
lista del fumo. È legittima un po' di confusione? Piccolo esempio: il Sunday
Times, l'8 giugno 1997, scrisse che il governo britannico aveva approvato un
rapporto secondo il quale una percentuale dal 30 al 70% di tutti i tumori
(l'intervallo di rischio è po' vago, ma le statistiche sono così) era
attribuibile al tipo di alimentazione. Questo mentre, nello stesso periodo, il
90% dei tumori al polmone era attribuito al fumo. Questo mentre, nello stesso
periodo, una ricerca dell'Environmental Protection Agency spiegava che il gas
radon era responsabile del 30% delle morti per tumore ai polmoni. Questo mentre,
nello stesso periodo, un altro studio attribuiva alla professione del deceduto
il 40% delle morti per tumore ai polmoni. Questo mentre altre percentuali,
ricavate da altri studi, legavano i morti per tumore ai polmoni nondimeno a
cause disparate come i motori diesel, il caffè e persino gli uccellini da
voliera. Ora: capite bene, anche qui, che un po' di confusione è legittima:
eppure sono tutti studi «scientifici» e pubblicati anche sui giornali. La
sostanza è che i titoloni allarmistici restano nell'immaginario anche se gli
studi rilanciati dall'Oms, a legger bene, ne contengono gli antidoti: perché
alla fine, a badarci, nessuno studio ha ancora stabilito che che la dieta
migliore sia quella vegetariana o che bisognerebbe limitarsi a carne di pollo o
a pesce; né è stata stabilita una dose massima o minima (anche minima: perché la
carne è nutriente) di carne rossa. Da anni si raccomanda di consumare dai 160 ai
300 grammi di carne alla settimana: lo studio rilanciato in questi giorni ha
cambiato le cose? Non risulta. Morale: è meglio limitare il consumo di carne.
Grazie tante. Anzi buon appetito.
Il salutismo dell'impiegato medio
tv-dipendente e consumista, scrive Nico Valerio.
L'impiegato - meglio se pubblico, perché ha più tempo a disposizione e può, al
limite, giocare alle parole crociate e navigare a sbafo su Internet - è
diventato l'uomo-simbolo della società di massa. Basta il confronto quotidiano
con i colleghi, con l'inevitabile ripasso di tutti i luoghi comuni, i
pettegolezzi del "Villaggio Globale", le ironie sul Capo e le leggende
metropolitane, a farne una perfetta e oliatissima rotellina del meccanismo
perverso per il quale "chi meno sa, più sa", "chi meno comanda, più comanda", e
perfino "se tutti sono stupidi, il Gruppo però è intelligentissimo". E così via,
di paradosso in paradosso. Insomma, esattamente quello che accade, in piccolo,
al futuro impiegato e "praticante" uomo-massa, cioè allo studente a scuola. Al
contrario, l’uomo antico delle società familiari e patriarcali era saggiamente
ignorante e non informato. Era un bel vantaggio. Comunicava con i suoi simili,
per sapere o confrontarsi sulle leggende di allora, solo nelle periodiche
assemblee di tribù o villaggio. Invece, l’uomo moderno della società di massa è
informatissimo in tempo reale sul Tutto e sul Nulla, grazie al dannato
passa-parola, e ai veloci, inutili e ottusi mezzi di comunicazione di massa. Ma
in realtà è sempre ignorantissimo, sia pure ad un diverso livello di ignoranza.
Infatti, non afferra o non ritiene i “perché” e i “come”, i “se” e i “tuttavia”,
i "ma" e i "purché", che gli altri uomini-massa adibiti alla trasmissione delle
notizie, sempre necessariamente parziali e perciò leggendarie, non dicono o
sfiorano en passant alla penultima riga, o per brevità o perché poco simpatiche
e fotogeniche, come tutte le eccezioni che contrastano con un titolo
accattivante e da scoop che è stato messo a priori dal titolista sulla notizia
che non ha letto. Così anche il salutismo spicciolo, insomma le norme per la
buona salute tradotte in suggerimenti consumistici adatti all'uomo-massa, viene
letto in modo stralunato, nevrotico, umoristico e paradossale. Sfugge
completamente all'Uomo-medio la logica del tutto. Così, figurando di sapere
Tutto, non sa Nulla. La giovane dottoressa di base, per esempio, dopo aver
inserito davanti al paziente (aggettivo) paziente (sostantivo) il disco
elettronico di dietologia, gli appioppa oltre alle bustine di Polase una dieta
di banane, solo perché la lista dei cibi ricchi di potassio comincia giustamente
in ordine alfabetico (ananas, banana ecc). Ignora o sottovaluta, poverina, che
tutti gli alimenti sono straricchi di potassio, e specialmente i vegetali. E
allora, com'è che le analisi denunciano una "carenza di potassio"? Non sarà, per
caso, che il paziente è, appunto, malato, e dunque il suo equilibrio salino è
saltato, e che comunque la sua dieta è rovinata dall'eccesso di sodio (sale da
cucina, patatine, salumi ecc) che è il naturale antagonista elettrolitico del
potassio nell'organismo? Macché, le "verità", anche quelle scientifiche, nella
società di massa si dicono sempre a metà. Questo lo scotto che dobbiamo pagare
per “sapere tutto” oggi: sapere tutto a metà. Contenti noi...Ma l’uomo medio è
contento lo stesso nella sua sapienza ignorante: è la prima volta nella Storia
che sa qualcosa, più o meno alla pari con gli esperti. Cent'anni fa neanche
conosceva - ma solo perché non esisteva il casco da parrucchiere - quei risibili
spezzoni di verità che oggi fanno apparire ogni massaia quasi una Madame Curie
della scienza dell'alimentazione, per esempio che il pomodoro contiene il tenace
rosso licopene, che resiste anche al ragù di otto ore della nonna Antonietta di
Ragusa, e che la solita banana, poveretta (ma perché solo la banana?), è "ricca
di potassio". Beati gli Antichi che non lo sapevano. Vivevano felici. Certo,
senza l'ironia dissacrante dell'impiegato-tipo, e quindi senza le sue ulcere
psico-somatiche. Almeno, non avrebbero capito male le pseudo-verità del
Villaggio Globale pubblicitario, dette a metà e per secondi fini consumistici,
come testimonia il racconto divertente, arrivatomi per posta elettronica, di
ogni impiegato medio attento alla tv e succube di ogni messaggio "promozionale"
e subliminale: Si sente nevrotico e ipocondriaco, e dunque "intelligente", ma in
realtà è solo cretino. E il suo humour amabilmente reazionario lo dimostra:
"Dicono che tutti i giorni dobbiamo mangiare una
mela per la salute in generale, gli spiaci per il ferro e una banana per il
potassio.
Anche un'arancia per la vitamina C e una tazza di
tè verde senza zucchero, per prevenire il diabete.
Tutti i giorni dobbiamo bere due litri d'acqua
(sí, e poi pisciarli, che richiede il doppio del tempo che hai perso in
berteli).
Tutti i giorni bisogna bere un liquido biancastro
e acidulo "probiotico" e uno yogurt speciale per avere i "L. Casei", che nessuno
sa bene che cosa cavolo sono, peró sembra che se non ti ingoi per lo meno un
milione e mezzo di questi bacilli tutti i giorni, inizi a vedere sfocato.
Ogni giorno un'aspirina, per prevenire l'infarto,
e un bicchiere di vino rosso per la circolazione in generale.
E un altro di bianco, per il sistema nervoso.
E uno di birra, che giá non mi ricordo per che
cosa era.
Se li bevi tutti insieme, ti puó venire
un'emorragia cerebrale o il mal di fegato, peró non ti preoccupare perché non te
ne renderai neanche conto.
Tutti i giorni bisogna mangiare fibra. Molta,
moltissima fibra, finché riesci a cagare un maglione.
Si devono fare tra i 4 e 6 pasti quotidiani,
leggeri, senza dimenticare di masticare 100 volte ogni boccone. Facendo i
calcoli, solo in mangiare se ne vanno 5 ore.
Ah, e dopo ogni pranzo bisogna lavarsi i denti,
ossia: dopo lo yogurt e la fibra lavarsi i denti, dopo la mela i denti, dopo il
banano i denti... e cosí via finché ti rimangono dei denti in bocca, senza
dimenticarti di usare il filo interdentale, massaggiare le gengive,
risciacquarti con l'apposito liquido disinfettante per la bocca...
Meglio ampliare il bagno e metterci il lettore cd,
perché tra l'acqua, le fibre e i denti, le pisciatine, il bidet e le docce, ci
passerai varie ore lí dentro.
Bisogna dormire otto ore e lavorare altre otto,
piú le 5 necessarie per mangiare = 21.
Te ne rimangono 3, sempre che non ci sia traffico.
Secondo le statistiche, vediamo la tv per tre ore
al giorno...
Giá, ma non si puó, perché tutti i giorni bisogna
camminare velocemente per almeno 45 minuti. Dopodiché doccia, ovviamente.
Poi bisogna mantenere le amicizie perché sono come
le piante, bisogna innaffiarle tutti i giorni. E anche quando vai in vacanza,
suppongo.
Inoltre, bisogna tenersi informati, e leggere per
lo meno due giornali e un paio di articoli di rivista, per una lettura critica.
Poi leggere almeno un libro al mese, perché se no
le statistiche ci bollano come trogloditi. Quindi, almeno mezz'ora al giorno di
libro.
Ah!, poi si deve fare sesso tutti i giorni, peró
senza cadere nella routine: bisogna essere innovatori, creativi, e rinnovare la
seduzione. Tutto questo ha bisogno di tempo. A patto che si trovi a tempo debito
un partner pronto alla cosa. E senza parlare del sesso tantrico, oggi
indispensabile.
Bisogna anche avere il tempo di spazzare per
terra, lavare i piatti, i panni sporchi. E non parliamo se hai un cane o peggio
dei figli!
Insomma, per farla breve, i conti mi danno 29-30
ore al giorno. L'unica possibilitá che mi viene in mente é fare varie cose
contemporaneamente; per esempio: ti fai la doccia con acqua fredda e con la
bocca aperta cosí ti bevi i due litri d'acqua. Mentre esci dal bagno con lo
spazzolino in bocca fai l'amore (tantrico) al compagno/a, che nel frattempo
guarda la tele e ti racconta, mentre tu lavi anche per terra. Ti é rimasta una
mano libera? Chiama i tuoi amici! E i tuoi familiari!
Bevi il vino (dopo aver chiamato i tuoi ne avrai
bisogno).
Il BioPuritas con la mela te lo puó dare il tuo
compagno/a, mentre si mangia la banana con l'Actimel, e domani fate cambio.
E meno male che siamo cresciuti, se no dovremmo
trangugiare un Alpinito Extra Calcio tutti i giorni. Uuuuf!
Peró se ti rimangono due minuti liberi, invia
questo messaggio ai tuoi amici (che bisogna innaffiare come una pianta), fallo
mentre mangi una cucchiaiata di Total Magnesium, che fa un mondo di bene. Adesso
ti lascio, perché tra lo yogurt, la mela, la birra, il primo litro d'acqua e il
terzo pasto con fibra della giornata, giá non so piú cosa sto facendo, sento
peró che devo andare urgentemente al cesso. Così ne approfitto per lavarmi i
denti....Un caro saluto uomini e donne moderni!". L'impiegata pubblica che
scrivendo questo pezzo brillante ha sottratto allo Stato, cioè a tutti noi, una
buona oretta di lavoro retribuito ha dimenticato - per fortuna - altri
"obblighi" del nuovo consumismo salutisticamente corretto, come la spesa nella
bottega di alimenti bio e la tisana di erbe, se no, l'avrebbe fatta ancora più
lunga, e avrebbe perso e fatto perdere ancora più tempo nelle solite battute in
corridoio...
Salute, non salutismo. E lasciateci
mangiare. Lo stop dell'Oms alle carni rosse non è una
novità, gli allarmi si ripetono da anni. Alla fine ognuno fa le sue scelte,
valutando pro e contro e tenendo conto del piacere del cibo, scrive Corrado
Benzio su “Il Tirreno” del 27 ottobre 2015. Negli anni Sessanta arrivò il primo
allarme serio. Le carni alla griglia potevano provocare il cancro. In
particolare le parti bruciaticce, carbonizzate. E già prima degli anni Sessanta
salumi e carni rosse erano sott'accusa in America per i livelli altissimi di
colesterolo dei maschi adulti benestanti. L'allarme lo lanciò Ancel Keys,
l'inventore della dieta mediterranea e prima ancora, da dietologo, quello che
rivide il rifornimento in combattimento dei soldati americani, inventando le
mitiche razioni K (che sta appunto per Keys). Utile premessa per segnalare che
dagli anni Cinquanta gli allarmi salutistici sulle carni rosse si ripetono con
monotona frequenza. Come gli allarmi sull'inquinamento da allevamento bovino.
Per produrre miliardi di hamburger si consumano acqua e terreno (senza
dimenticare le emissioni gassose delle bestie) come neppure la peggiore Ilva.
C'è un altro aspetto che in passato è stato esaminato. Per lungo tempo si è
pensato che l'alta incidenza di tumori allo stomaco che colpiva la Toscana di
terra fosse dovuto all'alto consumo di carni rosse. Poi la colpa si è data
all'eccessiva radioattività dei nostri terreni. E poi, alla fine,
all'inquinamento nel suo complesso. Il medico Vasco Merciadri: danni anche da
ormoni e antibiotici, senza carne si vive 9-10 anni di più. Il buon Dario
Cecchini, macellaio-poeta del Chianti, ha facile gioco a ricordare che ne uccide
più la strada che la carne. Aggiungiamo che nei fatidici anni Sessanta un nome
celebre della salumeria (la Molteni di Arcore, sponsor di Eddy Merckx) venne
sputtanato per lo scandalo che passò alla storia come “Le mortadelle alla
merda”. Certo rispetto ad un petto di pollo o ad una fesa di tacchino la
Fiorentina ha ben altri contenuti di grassi e di zuccheri. Ma non ti sembra di
cenare in corsia, come accade con le carni bianche. Ed infatti i nostri mezzadri
pollo e coniglio lo facevano fritto, tanto problemi di colesterolo non ne
avevano. Insomma c'è la salute e c'è il piacere. La carne di manzo più buona al
mondo arriva dal Texas: tenera, grassa, saporita. «Ma come l'allevano? Con cosa?
Boh» commenta Michele Marcucci che sulla brace ha fondato 25 anni di successo
come ristoratore. I francesi grandissimi consumatori di carni rosse - loro le
razze più pregiate, dalla Charolais alla Limousine - hanno bassissimi livelli di
colesterolo. E' il famoso “paradosso francese” scoperto (guarda caso) da uno
studioso americano...Poi certo abbiamo avuto la mucca pazza e anche questo non
ha invogliato il consumo. Ma resta, per chi si siede a tavola, l'eterno
problema: la carne e i salumi fanno bene o male? Il più grande studioso di
tumori in Italia, il professor Umberto Veronesi, è vegetariano e non smette mai
di ribadirlo. Ma, sottolinea sempre, per scelta personale non per decisione
ideologica o altro. Forse dovremmo fare come lui: mangiare o meno le carni
rosse, ma come scelta consapevole, quasi personale, non in virtù di mode o
ideologie. Bilanciando salute e piacere. E ricordando che solo gli anni
Cinquanta ci hanno liberato da malattie come il gozzo e la pellagra, provocate
da uno scarso apporto proteico. E' sempre meglio ricordarsi da dove siamo
venuti, prima di lanciare anatemi.
Salutismo Anti-salutismo: un dibattito
superato, scrive Filippo Ongaro il 14 marzo 2012 su
“Il Fatto Quotidiano”. Mi è capitato recentemente di partecipare ad un talk show
televisivo insieme a Pierangelo Dacrema, autore del libro “Fumo, bevo e mangio
molta carne”. Dacrema di mestiere fa l’economista ma in questo caso si avventura
in un nuovo territorio, con un libro dal titolo e dai contenuti provocatori che
è una sorta di ribellione istintiva a quello che lui percepisce come un
insopportabile e invadente attacco dei talebani della salute alle sue scelte di
vita. Pur non condividendone l’impostazione di base credo che il libro di
Dacrema possa essere uno spunto interessante per innalzare il livello della
discussione sulla salute che è senza dubbio un argomento più complesso di come
spesso viene descritto dal dibattito ormai superato tra salutismo e
anti-salutismo. Oltre ad invocare, maggiore tolleranza e atteggiamenti meno
dogmatici e giudicanti da parte di chi promuove una vita sana, Dacrema mette in
gioco giustamente il concetto di piacere che rimane il primum movens della
maggior parte delle nostre scelte. E’ senza dubbio vero che le scelte che non
portano ad un certo grado di piacere possono diventare sacrifici intollerabili
nel tempo ma allo stesso tempo è sbagliato supporre che vivere in modo più sano
possibile significhi non godersi la vita. Scegliere la salute non equivale a
rinunciare ad ogni piacere ma semplicemente a cambiare la scala delle proprie
priorità per passare da un piacere immediato ad uno a lungo termine, da una
veloce scarica di energia ad un’energia sostenibile sul piano individuale e
collettivo. Un pò come abbandonare fonti di energia inquinanti per abbracciare
la pulizia delle rinnovabili, senza per questo dover rinunciare all’energia
stessa. La tosse dopo aver fumato troppo il giorno prima, il mal di testa dopo
aver bevuto eccessivamente alla serata con gli amici o l’incidente in macchina
dopo aver goduto dell’ebbrezza della velocità sono esempi di piaceri immediati
seguiti da successivi dispiaceri di gravità variabile. L’elenco potrebbe essere
molto più lungo. Un altro argomento frequente di chi non vuole sentire parlare
di prevenzione è che non vale la pena fare alcun sacrificio perché tanto prima o
poi moriamo tutti. Meglio vivere come si vuole, ci dicono, e morire
prima. Peccato però che di mezzo ci sia la malattia non necessariamente la
morte. Una variabile non da poco che può farci entrare in una spirale di
sofferenze. La verità è che la nostra impotenza di fronte alla morte ci
obbliga ad accettarla ma non ci permette affatto di scegliere come morire e
tantomeno di cosa ammalarci. Non badare alla propria salute non equivale affatto
ad essere più liberi ma aumenta semplicemente il rischio di ammalarsi e un
malato è certamente meno libero di una persona sana di fare ciò che vuole. Il
menefreghismo e la leggerezza nei confronti della malattia tengono solo fino a
quando siamo sani. Poi franano e lasciano il posto in tutti alla paura e alla
disperazione. E a questo proposito viene da chiedersi se qualcuno dei
sostenitori della “non-salute” sia in grado di rinunciare alle cure nel momento
del bisogno per rimanere fedele al proprio ideale di una vita godereccia che
assomiglia al gioco d’azzardo. Se così fosse sarebbe per lo meno un modo
coerente di non incidere sui costi della sanità pagata da tutti, anche da coloro
che si sforzano di rimanere sani. Si certo, ci sono anche persone che fumano,
bevono e mangiano male per tutta la vita che non si ammalano e muoiono felici.
Così come ce ne sono altre attente e consapevoli che si ammalano. E’ un altro
argomento frequente di chi deride i tentativi di migliorare la salute degli
altri. Per rimanere all’esempio automobilistico, sarebbe come sostenere che le
cinture di sicurezza non servono perché alcuni guidano tutta la vita senza e non
si ammazzano o altri si ammazzano per avendo la cintura. Un argomento assurdo
che contrappone singoli casi fortunati o sfortunati a una mole impressionante di
dati statistici. Insomma il dibattito tra salutismo e anti-salutismo è
fondamentalmente inutile e fondato su argomenti piuttosto insensati. Meglio
sarebbe discutere di come rendere le scelte di vita sana più semplici, naturali
e soprattutto piacevoli per tutti puntando su una seria educazione alla salute a
partire dai giovani.
I TALEBANI DEL SALUTISMO.
Il progresso, si sa, porta sviluppo tecnologico e
sociale, ma produce anche inquinamento. Inquinamento prodotto dalle industrie,
prodotto dalla circolazione dei veicoli, prodotto dal riscaldamento domestico.
In inverno, spesso, si sente che le grandi città limitano la circolazione dei
veicoli e l’uso del riscaldamento domestico, connubio velenoso, per render più
respirabile l’aria. Proprio a Taranto l’ex sindaco Rossana Di Bello emise
un’ordinanza di divieto al transito in città alle corriere della Sud Est che
portavano i pendolari dalla provincia. Nei paesi sottosviluppati dove si muore
ancora di fame il problema dell’inquinamento non esiste: aria pura e panza
vuota. Ecco perché a nessuno verrebbe in mente di vietare i riscaldamenti o
impedire la circolazione dei veicoli per le strade urbane ed extraurbane, ne
tanto meno si proverebbe a chiudere qualsiasi attività economica, che
direttamente o indirettamente produce inquinamento. Certo è che vige un
principio: tutta quanto è dannoso deve stare lontano da noi, in casa d’altri!!
Purtroppo spesso gli altri siamo noi e dobbiamo farci una ragione. Ovviamente
non manca chi auspica la giunglalizzazione delle città, ma, per fortuna, ancora
sono in pochi. Inoltre, c’è da considerare un altro aspetto, a proposito di
inquinamento, non c’è solo l’Ilva e non c’è solo Taranto. Ma anche Gela, Priolo,
Bagnoli, Porto Torres, le miniere dell’Iglesiente, Marghera e decine di altri
siti industriali ancora in funzione o abbandonati. Quelli di interesse nazionale
sono 57. Da una stima approssimativa, per la bonifica servirebbero 30 miliardi
di euro, ma nel bilancio del ministero dell’Ambiente, alla voce “bonifiche” sono
disponibili 164 milioni. E la salute delle persone che lavorano negli impianti
ancora in funzione, quelle che vivono nelle vicinanze, cosa rischiano? Nessuno
osa negare, compresi i dirigenti e i proprietari delle aziende, che qualche
problema c’è. E il perenne ricatto è: bonificare vuol dire chiudere la fabbrica
e mandare a casa decine di migliaia di lavoratori. Ma cosa si è fatto nel
passato, cosa si fa oggi e quali sono i programmi futuri per sanare i siti? Una
cosa da non dimenticare: le persone coinvolte sono più di 6 milioni. In Italia
si calcola che i siti potenzialmente inquinati siano circa 13 mila e di questi
1.500 impianti minerari abbandonati, 6 mila e 500 ancora da indagare e 5 mila
sicuramente da bonificare. Poco meno di 13 mila siti sono di competenza
regionale (dai distributori di benzina alle piccole fabbriche che lavorano i
combustibili), mentre 57 sono sotto la giurisdizione statale. Questi ultimi sono
definiti dalla sigla SIN, vale a dire Siti di Interesse Nazionale. Allora ci si
chiede: perché si parla tanto e solo di Taranto e di ILVA? «Perché a Taranto ci
sono i “talebani”, ossia chi non sente ragioni contrarie alle proprie – spiega
il dr Antonio Giangrande, presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie”
e scrittore-editore dissidente, che proprio su Taranto ha scritto un libro. –
Quelli che nel privilegio dell’impiego pubblico si dedicano alla pseudo tutela
dell’ambiente. Questi, nel nome della tutela della salute, non chiedono la
sanificazione dell’Ilva, ma pretendono la sua chiusura. Non dell’Eni o della
Cementir, anch’esse gravemente inquinanti: no, dell’Ilva. Questi che vogliono la
chiusura dell’Ilva sono nati con l’Ilva o dopo che questa ha iniziato a
produrre. Sono cresciuti con essa ed anche grazie ad essa. Però, si sa, non c’è
gratitudine in questo mondo. E’ vero che sin da piccolo (ed i decenni son
passati) quando mi apprestavo ad entrare in Taranto, la città da lontano la
vedevo avvolta da una cappa di fumo, ma è anche vero che con l’Italsider
(odierna Ilva) la gente non emigrava più. Tutti lavoravano in Ilva e tutti
lavoravano per l’Ilva. Taranto senza l’Ilva e le altre grandi industrie sarebbe
solo una città di cozzari. Ripeto. Non c’è gratitudine. Per esempio, anche
Trieste ha la sua Ilva. Lì è stato perseguito per calunnia l’ambientalista che
denunciava l’esistenza dell’inquinamento. Paese che vai, usanza che trovi. A
Taranto affianco agli ambientalisti di maniera troviamo chi da operaio è stato
traviato dall’azienda e per gli effetti gli si ritorce contro. Troviamo ancora
il capo della procura con i suoi sostituti e l’ufficio del Gip-Gup che, in
generale dai dati elaborati in Italia, delle procure è la longa manus. Uomini
della Procura che nell’inerzia quarantennale ha deciso di essere deus ex machina
senza controllo alcuno e di decidere, da uomini soli, per un’intera nazione. A
proposito degli ambientalisti sprono della magistratura. Il presidente dei
Verdi, Angelo Bonelli, e il presidente di Peacelink Taranto, Alessandro
Marescotti hanno fornito i dati dello studio del progetto “Sentieri”. Nel
periodo 2003-2008 a Taranto è stato rilevato un aumento del 24% dei tumori del
fegato e dei polmoni, del 38% per i linfomi e del 38% per i mesoteliomi. Bonelli
e Marescotti hanno dichiarato “Il dato veramente preoccupante è quello dei
bambini, per i quali si registra un +35% di decessi sotto un anno di età e per
tutte le cause. Per quanto riguarda le morti nel periodo perinatale +71%. Questi
sono i dati dell’aggiornamento che il ministro Balduzzi non ha voluto comunicare
perché diceva che erano in fase di elaborazione. E’ falso perché questi dati
sono stati elaborati, stampati e comunicati alla procura della Repubblica il 30
marzo di quest’anno”. Corrado Clini sostiene che questi dati siano falsi. Per
questo motivo ha dato mandato all’avvocatura dello Stato di procedere nei
confronti di Bonelli, che ha ripetutamente accusato il ministro dell’Ambiente di
nascondere i dati sulla mortalità e di fornire informazioni false sullo stato
della salute degli abitanti di Taranto. Clini ha detto “Fra l’altro mi preoccupa
la diffusione di notizie false che generano allarme tra la popolazione e mirano
a intimidire le autorità competenti in materia di protezione ambiente e tutele
della salute”. Certo è che l’annunciata chiusura dell’Ilva di Taranto potrebbe
rappresentare uno dei più grandi disastri industriali e sociali del nostro Paese
degli ultimi anni, così come il suo funzionamento sembrerebbe esserlo stato per
le condizioni di salute della città. E’ questa la considerazione che viene più
spontaneo fare di fronte ai numeri sconvolgenti che lo stop degli altoforni di
Taranto potranno portarsi come conseguenza più immediata. D’altronde stiamo
parlando di un’azienda che rappresenta il 20esimo gruppo siderurgico del mondo,
e dunque non è difficile immaginare l’impatto che ci sia sull’economia
nazionale, sia in termini occupazionali che finanziari. E cominciamo allora
proprio da qui, dal mettere in fila le prime drammatiche cifre sugli effetti
umani e sociali di una sempre più probabile serrata dell’Ilva. Nella sola zona
di Taranto andrebbero in fumo circa 12mila posti di lavoro, che rappresentano
gli addetti diretti allo stabilimento, cifra che sale però a quota 20mila se si
considera l’indotto. Quello di Taranto infatti rappresenta il più grande sito
produttivo siderurgico d’Europa e allo stesso tempo lo stabilimento industriale
con più addetti in Italia. Un particolare non da poco se si pensa che sorge in
un contesto cittadino dove recenti statistiche parlano di un tasso di
disoccupazione che viaggia intorno al 30%. In pratica chiudere l’Ilva potrebbe
significare mettere in ginocchio l’economia di Taranto e a cascata di altre zone
della Provincia e della Regione Puglia, visto che dei citati 12mila addetti
diretti, solo 4mila sono tarantini, mentre gli altri vengono da fuori. Ma le
conseguenze negative non finiscono qui sul fronte occupazionale, perché lo stop
di Taranto si porta come conseguenza il blocco della produzione anche del sito
Ilva di Genova, dove altri 1.760 dipendenti sono in agitazione perché vedono a
rischio il proprio posto di lavoro. E il fatto che la chiusura dello
stabilimento di Taranto si porti dietro conseguenze occupazionali così pesanti,
si lega, come accennato, al rilievo che la sua produzione di acciaio riveste per
l’intera economia italiana. Secondo i dati forniti dalla Confindustria pugliese
infatti, la capacità produttiva di circa 10 milioni di tonnellate l’anno di
acciaio che arrivano da Taranto, rappresentano circa il 40% del fabbisogno
nazionale. Se l’Italia dovesse essere costretta a importare quantità di questo
rilievo, andrebbe incontro ad una spesa del valore di circa 9 miliardi di euro.
Una cifra che rappresenta circa un punto di Pil nazionale, e il 7-8% del Pil
regionale pugliese. Un vero e proprio disastro economico dunque per il nostro
Paese, che rischia, come accennato, di sfociare in dramma sociale a Taranto,
dove monta la rabbia degli operai rimasti senza lavoro dalla sera alla mattina.
Ma chi vive sulle spalle degli altri con la busta paga pubblica degli operai se
ne fotte (l’intercalare spiega bene l’idea). Gli operai, talebani anche loro.
Pronti a marciare su Taranto o a bloccare la circolazione dei veicoli, usando
violenza sui malcapitati che si son trovati a passar dalle loro parti. Spintoni
o gomme tagliate per chi non solidarizza con loro. L’esasperazione dirà
qualcuno. In Italia, infatti, lavorano solo 23 milioni di persone e il nostro è
il paese europeo col minor tasso di occupazione. In compenso, come è noto,
abbiamo 16 milioni di pensionati oltre a un bel po’ di disoccupati e un sacco di
altra gente che il lavoro manco lo cerca. E’ emergenza disoccupazione. Secondo
le ultime stime provvisorie dell’Istat il tasso generale si è attestato
all’11,1%. Per questo quando si dice che l’Italia lavora, non è vero. L’Italia
non lavora e se ne fotte degli altri, ma il punto è che non vota sfiduciata da
questa politica. Mai così tanti disoccupati, mai così tanti non votanti. C’è
difetto di rappresentanza e la contrapposizione tra interessi è l’effetto. Per
questo motivo, nel venire incontro a tutti gli interessi in campo il decreto
legge varato dal Consiglio dei ministri “stabilisce che la società Ilva abbia la
gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti e che sia
autorizzata a proseguire la produzione e la vendita per tutto il periodo di
validità dell’Aia”. Il rilascio a ottobre 2012 da parte del Ministero
dell’Ambiente dell’autorizzazione integrata ambientale ha anticipato gli
obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di BAT – best available
technologies (tecnologie più efficienti per raggiungere obiettivi di
compatibilità ambientale della produzione) di circa 4 anni. Con il provvedimento
– spiega il comunicato di Palazzo Chigi – all’Aia è stato conferito lo status di
legge, che obbliga l’azienda al rispetto inderogabile delle procedure e dei
tempi del risanamento. Qualora non venga rispettato il piano di investimenti
necessari alle operazioni di risanamento, il decreto introduce un meccanismo
sanzionatorio che si aggiunge al sistema di controllo già previsto dall’Aia. “I
provvedimenti di sequestro e confisca dell’autorità giudiziaria – spiega ancora
il comunicato stampa – non impediscono all’azienda di procedere agli adempimenti
ambientali e alla produzione e vendita secondo i termini dell’autorizzazione”.
“L’Ilva – spiega il comunicato stampa – è tenuta a rispettare pienamente le
prescrizioni dell’autorizzazione ambientale”. Palazzo Chigi definisce il decreto
legge “un cambio di passo importante verso la soluzione delle problematiche
ambientali, il rispetto del diritto alla salute dei lavoratori e delle comunità
locali interessate, e la tutela dell’occupazione”. “In questo modo – prosegue la
nota – vengono inoltre perseguite in maniera inderogabile le finalità espresse
dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria”. Il Cdm stabilisce che la
società “abbia la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti e
che sia autorizzata a proseguire la produzione e la vendita per tutto il periodo
di validità dell’Aia (sei anni). L’Ilva è tenuta a rispettare pienamente le
prescrizioni. Le bozze del decreto sono state continuamente limate e ritoccate
nel corso del Consiglio. Importante era evitare lo scontro frontale con la
magistratura. Confermata, l’introduzione di una ‘figura di garanzia’, una
‘figura terza’ che possa dare fiducia a tutte le parti coinvolte: non un
commissario ma un ‘garante’ che vigili sull’applicazione rigorosa ed efficace
delle prescrizioni Aia. “Il garante – ha spiegato il sottosegretario Antonio
Catricalà – deve essere persona di indiscussa indipendenza, competenza ed
esperienza e sarà proposto dal ministro dell’Ambiente, dal ministro
dell’Attività Produttive, e della Salute e sarà nominato dal presidente della
Repubblica”. Il Garante acquisirà dall’azienda, dalle amministrazioni e dagli
enti interessati le informazioni e gli atti ritenuti necessari, segnalando al
presidente del Consiglio e al ministro dell’Ambiente le eventuali criticità
riscontrate nell’attuazione delle disposizioni e potrà proporre le misure
idonee, tra le quali anche provvedimenti di amministrazione straordinaria.
“Qualora non venga rispettato il piano di investimenti necessari alle operazioni
di risanamento, il decreto introduce un meccanismo sanzionatorio che si aggiunge
al sistema di controllo già previsto dall’Aia”, si legge nella nota di Palazzo
Chigi. In caso di inadempienze per l’Ilva – ha spiegato a questo proposito il
ministro dell’Ambiente Corrado Clini – “restano tutte le sanzioni già previste e
in più introdotta la possibilità di una sanzione sino al 10% del fatturato annuo
dello stabilimento”. Non solo. “Abbiamo introdotto interventi possibili sulla
proprietà stessa – ha aggiunto il ministro dello Sviluppo Corrado Passera – che
potrebbero togliere enorme valore a quella proprietà: se non fa quello che la
legge prevede, vede il suo valore fino al punto di perderne il controllo di
fronte a comportamenti non coerenti. E’ possibile che variamo la procedura di
amministrazione controllata. Insomma, se non si fanno gli investimenti e gli
adempimenti di legge, viene messo qualcun altro a farlo”. “Non possiamo
ammettere – ha detto Monti in conferenza stampa – che ci siano contrapposizioni
drammatiche tra salute e lavoro, tra ambiente e lavoro e non è neppure
ammissibile che l’Italia possa dare di sé un’immagine, in un sito produttivo
così importante, di incoerenza. L’intervento del governo è stato necessario
perchè Taranto è un asset strategico regionale e nazionale”, ha aggiunto.
“Questo caso è la plastica dimostrazione per il passato degli errori reiterati
nel tempo e delle incoerenze di molte realtà, sia imprenditoriali che
pubblico-amministrative, che si sono sottratte, nel corso del tempo, alla regola
della responsabilità, dell’applicazione e del rispetto della legge”. La strada
del decreto è stata intrapresa per evitare – aveva spiegato Monti – “un impatto
negativo sull’economia stimato in otto miliardi di euro annui”. Il provvedimento
salva i 12mila dipendenti di Taranto e i lavoratori dell’indotto pugliese. Ma
anche Genova, Novi Ligure, Racconigi. La possibilità di togliere l’azienda alla
proprietà era stata prospettata anche da Clini intervenuto a Servizio Pubblico:
aveva fatto intendere che il governo sarebbe stato pronto a prendere in mano la
situazione nel caso in cui la famiglia Riva non voglia o non possa far fronte
alle prescrizioni. “Sappiamo – aveva spiegato – che per essere risanato quel
sito deve continuare ad essere gestito industrialmente. I Riva hanno detto che
sono ponti a farlo. Il piano degli interventi prevede parchi minerari,
altoforni, batterie delle cokerie. Se non fai questo, è la nostra posizione, non
puoi continuare a gestire gli impianti. Se non sono in grado dobbiamo farci
carico noi con un intervento che consenta di garantire la continuità produttiva
ed il risanamento”. Questo è il potere esecutivo, il cui operato sarà
convalidato dal potere legislativo. I magistrati, però hanno una loro ben
definita contrapposizione: «Prendiamo atto che il governo, di fronte ad una
situazione complessa e con gravi ripercussioni occupazionali, si è assunto la
grave responsabilità di vanificare le finalità preventive dei provvedimenti di
sequestro emessi dalla magistratura e volti a salvaguardare la salute di una
intera collettività dal pericolo attuale e concreto di gravi danni», dice il
segretario dell’Associazione magistrati (Anm), Maurizio Carbone, proprio a
Taranto sostituto procuratore. Per Carbone «resta tutta da verificare la
effettiva disponibilità dell’azienda ad investire i capitali necessari per
mettere a norma l’impianto e ad adempiere alle prescrizioni contenute nell’Aia»,
tenuto conto che «sino ad ora la proprietà ha dimostrato di volersi sottrarre
all’esecuzione di ogni provvedimento emesso dalla magistratura». Ed ancora non
ha lesinato critiche al provvedimento d’urgenza di Palazzo Chigi: «È
un’invasione di campo, dov’è finito il principio della separazione dei poteri?
Il decreto legge vanifica di colpo tutti gli effetti dei provvedimenti presi dai
magistrati per la tutela della salute dei cittadini. Il governo, così facendo,
si è preso una grossa responsabilità». Per il gip di Taranto Patrizia Todisco la
nuova Aia per l’Ilva «non si preoccupa affatto della attualità del pericolo e
della attualità delle gravi conseguenze dannose per la salute e l’ambiente».
L’attività produttiva dell’Ilva è «tuttora, allo stato attuale degli impianti e
delle aree in sequestro, altamente pericolosa». I tempi di realizzazione della
nuova Aia sono «incompatibili con le improcrastinabili esigenze di tutela della
salute della popolazione locale e dei lavoratori del Siderurgico», scrive il
gip. Tutela che «non può essere sospesa senza incorrere in una inammissibile
violazione dei principi costituzionali» (articoli 32 e 41). Come è possibile,
sulla base di quanto emerso dalle indagini, «autorizzare comunque l’Ilva alle
attuali condizioni e nell’attuale stato degli impianti in sequestro, a
continuare da subito l’attività produttiva», senza «prima pretendere» gli
interventi di risanamento? aggiunge il gip dicendo no al dissequestro degli
impianti. La partita con l’Ilva non è finita, «abbiamo ancora qualche cartuccia
da sparare», sorride amaro il procuratore capo di Taranto, Franco Sebastio, che
proprio non ci sta a passare per «il talebano», così come viene definito sui
giornali, «il pazzo nemico di 20 mila operai», «se solo avessi cinque minuti per
un caffè con il presidente Napolitano e con Mario Monti racconterei loro dei
bambini che qui nascono già malati di tumore…», si sfoga il vecchio magistrato.
La Procura solleva eccezioni di incostituzionalità del decreto legge di Palazzo
Chigi, chiedendo l’intervento della Corte Costituzionale. Il diritto
all’eguaglianza, ad esempio: la legge è uguale per tutti, no? Ma se la legge è
nata per l’Ilva, dove finiscono i principi di astrattezza e generalità? Intanto,
oltre al sindaco di Taranto, alcuni preti della città, alcuni giornalisti
tarantini, alcuni parlamentari locali, l’inchiesta coinvolge anche la provincia.
Così come per il delitto di Avetrana: nel dubbio, tutti dentro, avvocati
compresi. L’inchiesta afferra il Presidente della provincia di Taranto, Gianni
Florido, un passato importante da sindacalista quale ex segretario regionale
della Cisl e un presente da dirigente locale del Pd. Un’informativa di 182
pagine in parte mutilata da omissis e allegata all’ordinanza di custodia
cautelare che aveva già bussato al palazzo della Provincia, relegando agli
arresti domiciliari l’ex assessore all’ambiente Michele Conserva, lo fulmina in
poche righe. “Si evidenzia – scrivono i militari della Finanza – che alla luce
di quanto accertato, vanno ascritte al dottor Gianni Florido, Presidente della
Provincia di Taranto, specifiche responsabilità penali per il delitto di
concussione o, in subordine, di violenza privata”. Certo è che qualcuno dovrebbe
spiegare ai magistrati, che si lamentano quando la legge si stila senza la loro
dettatura, che non vi è scontro tra poteri, proprio perché la magistratura non è
un potere. Se l’articolo 1 della Costituzione detta che “La sovranità appartiene
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, ne
consegue che Potere è quello Legislativo che legifera in modo ordinario e quello
Esecutivo che legifera in modo straordinario. La Costituzione all’art. 104
afferma che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.” Ne conviene che il dettato vuol significare non equiparare
la Magistratura ad altro potere, ma differenziarne l’Ordine con il Potere che
spetta al popolo. Ordine costituzionalizzato, sì, non Potere. Ordine, non
potere, come invece il più delle volte si scrive, probabilmente ricordando
Montesquieu; il quale però aggiungeva che il potere giudiziario é “per così dire
invisibile e nullo”. Solo il popolo è depositario della sovranità: per questo
Togliatti alla Costituente avrebbe voluto addirittura che i magistrati fossero
eletti dal popolo, per questo sostenne le giurie popolari. Ordine o potere che
sia, in ogni caso è chiaro che di magistrati si parla. Per gli effetti l’art.
101 dichiara che “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.” Ergo: i magistrati devono applicare la legge,
rispettarla e farla rispettare, non formarla, né criticarla. Non devono sentirsi
portatori di una missione non loro. E nessuna risonanza mediatica può essere
ammessa, in special modo quando vi sono interessi più grandi che quelli castali.
E si deve ricordar loro, ai magistrati ed alla clache che li santifica, che c’è
anche quella legge ambientale che prevede il dogma “chi inquina paga”. Non
esiste il dettato tutto di stampo tarantino: “chi inquina, chiude i battenti e
tutti a casa”, specialmente se l’industria che viene chiusa, con le tasse che
paga, mantiene i suoi detrattori.»
LE BUGIE DEGLI AMBIENTALISTI.
"Le bugie degli ambientalisti" presentato da
Antonio Gaspari, giornalista e scrittore; coordinatore del Master in Scienze
Ambientali dell’Università Europea di Roma. «Il titolo del libro è provocatorio,
ma non era nostra intenzione, né mia né di Riccardo (Riccardo Cascioli, coautore
del libro), di giudicare qualcuno: abbiamo solo cercato di verificare fatti e
approfondire la verità su alcuni diffusissimi luoghi comuni. Abbiamo anche
analizzato l’approccio ai problemi ambientali, che ha cambiato la concezione
dell’uomo e ha operato un vero stravolgimento della concezione antropologica.
L’attenzione all’ambiente: ecologia o ecologismo?
L’accresciuta sensibilità nei confronti dei
problemi ambientali è un segno di civiltà. Investire denaro e risorse per
migliorare il nostro ambiente naturale, per ridurre l’impatto delle nostre
attività sull’ambiente, per arricchire l’ambiente e renderlo più bello, è un
fatto molto positivo. Dietro questa azione di miglioramento del creato da parte
dell’umanità, negli ultimi trenta anni abbiamo visto apparire un’ideologia che
chiameremo “ecologismo”: questa ideologia non si è preoccupata di agire e di
creare una cultura per migliorare il nostro rapporto con l’ambiente, ma si è
occupata esclusivamente di mettere in contrapposizione l’essere umano e la
natura. L’attenzione nei confronti di piante, animali o elementi inanimati,è
stata contrapposta ai diritti dell’uomo, indicato addirittura come il cancro del
pianeta. Nella storia dell’umanità ci sono state tante filosofie nichiliste di
contrapposizione alla natura umana, ma mai una ideologia era stata così diffusa
e così pervasiva. La contemplazione del creato genera grandi suggestioni:
guardare il cielo, le montagne o il mare, arricchisce la persona, sostiene la
speranza,fa pensare all’infinito. Ma, nell’immaginario culturale ambientalista,
ogni volta che si parla di ecologia si evocano catastrofi, inquinamento,
scomparsa di specie e di foreste, malattie, carestie, alluvioni,uragani. Per
questa ideologia il mondo naturale è in guerra con quello degli esseri umani.
Per i cristiani flora e fauna sono sorella e fratello, sono figli di uno stesso
creatore; per questa ideologia rappresentano invece i contendenti di un
conflitto selvaggio, in cui l’unico colpevole è sempre l’uomo con le sue
attività lavorative. L’ideologia è sostenuta da un massiccio apparato
propagandistico. Un esponente della compagnia petrolifera Shell mi raccontò che
Greenpeace ha un ufficio stampa dieci volte più grande della Shell: “Questi sono
bravissimi, sono capaci di inscenare un’aggressione a una nave, e finire su
tutti i giornali e le TV del mondo, e su questa base raccolgono denaro”. Azioni
dimostrative che utilizzano i mezzi di comunicazione e fanno pressione
sull’opinione pubblica e sul mondo politico:questo tipo di campagna ha avuto un
effetto significativo, tanto che oggi è quasi impossibile costruire un
parcheggio, un termovalorizzatore,un impianto industriale. Mi è capitato di
discutere in TV con un rappresentante di un’associazione ecologista, il quale si
vantava di avere impedito la costruzione di un auditorio e riceveva anche
approvazione dai personaggi presenti: la costruzione di un edificio in cui si
sviluppa la cultura musicale è ritenuta azione inquinante, e si ritiene un
merito l’averla impedita.
Difesa dell’ambiente e attacco all’uomo.
Questa ideologia ha influenzato anche l’aspetto
legislativo, facendo nascere paradossi spaventosi. Faccio un esempio: in Olanda
se andate a pescare col verme vivo rischiate fino a tre mesi di galera; c’è una
legge di protezione degli animali per cui è vietato pescare col verme
vivo,perché è un atto di crudeltà. Nella stessa Olanda il Parlamento ha votato
l’eutanasia attiva anche nei confronti dei bambini. Un altro esempio: l’anno
scorso c’è stata una grande campagna ambientalista per salvare gli alberi
ultracentenari; le stesse persone che portavano avanti questa campagna hanno
però proposto in Parlamento una legge per l’eutanasia. Se l’albero ha cento anni
va salvato, ma se il nonno è vecchio e malato va eliminato; questa purtroppo è
una logica molto diffusa nell’ideologia ambientalista. Un ultimo esempio: ci
sono state campagne contro i fitofarmaci, in cui si diceva di non mangiare la
mela “avvelenata”, trattata con antiparassitari;una campagna, quindi, contro
sostanze che avrebbero potuto danneggiare la salute dell’uomo; le stesse persone
però sostengono la diffusione massiccia e l’utilizzo della RU486, una pillola
tossica che uccide il concepito e strazia la mamma. Nessuno evidenzia la
contraddizione che esiste fra difendere in maniera radicale la flora e la fauna,
e poi contrapporsi alla vita umana. C’è addirittura una associazione
ambientalista negli Stati Uniti che si chiama Voluntary Human Extinction,
associazione per l’estinzione volontaria degli esseri umani; sostengono che
siamo troppi sulla terra e che la terra ha una sua dimensione spirituale: essa è
Gaia, è una dea, e chi sconvolge l’armonia di questo pianeta è l’uomo, per cui
ogni uomo in meno sulla terra è un beneficio per Gaia. Propongono di non fare
figli, propongono l’eutanasia volontaria, il suicidio. Siamo a livelli assurdi,
ma nessuno ride di questo, molte persone ci credono, praticano questo verbo, ne
discutono e lo diffondono.
Ideologia nichilista, neopagana, negatrice del Dio
creatore.
La questione più grave di questa ideologia è
l’aspetto nichilista, la sfiducia negli esseri umani,che crea notevoli conflitti
sociali. Non si vuole la pelliccia: contro la pelliccia si liberano gli animali
allevati, si rompono le vetrine alle pelliccerie, si butta la vernice addosso
alle donne che hanno la pelliccia; tutte azioni che creano un conflitto.
Avvengono anche attentati che vanno sotto la categoria di ecoterrorismo, per
impedire la costruzione del treno ad alta velocità, per far saltare tralicci: in
Italia basta dire “vogliamo costruire questa cosa, qui” e subito persone
scendono in piazza per impedirlo,utilizzando argomenti ambientalisti. Un altro
aspetto negativo è la divinizzazione della natura. Recentemente a Roma c’è stata
una manifestazione, con Greenpeace, CGIL, WWF, e diverse associazioni
ambientaliste: i manifestanti, per protestare contro gli organismi geneticamente
modificati (OGM), sono andati alla statua della dea Cerere, per una cerimonia
con offerta di semi. Fenomeni neopagani di questo tipo si stanno espandendo: la
divinizzazione della natura, minacciata dall’essere umano, si sta diffondendo in
maniera pervasiva. I fenomeni naturali catastrofi ci vengono indicati come “la
natura che si ribella all’uomo”,mentre in realtà si tratta di fenomeni che
preesistono all’uomo e che ci sono sempre stati;l’uomo viene considerato come
colui che ha offesola dea Gaia, e la dea Gaia si ribella rivoltandosi contro
l’uomo: un’idea precristiana, siamo tornati al panteismo. Altro fenomeno
preoccupante: questa ideologia, pur presentandosi in alcune forme“spirituali”,
presuppone la cancellazione del Dio creatore. Ci sono state diverse riunioni di
associazioni ambientaliste internazionali sulla questione spirituale: cercano
forme di spiritualità indiana,primitive, e forme di spiritualità nelle piante.
L’ideologia verde è pagana, ha uno spiritualismo che nega e si contrappone al
concetto di Dio creatore,soprattutto al concetto cristiano, perché i cristiani
vengono identificati come coloro che hanno portato avanti la cultura del fare,
la cultura che ha generatola scienza.
Bugia n. 1: “The population
bomb”.
Addentriamoci ora nelle bugie. A Stoccolma,nel
1972, si svolse la prima conferenza dell’ONU sull’ambiente, con una chiara
impostazione neomalthusiana. Il pastore anglicano Malthus [1766-1834] era un
economista e insegnava alla scuola che formava i quadri della Compagnia delle
Indie(in pratica i quadri dirigenti dell’Impero Britannico):sviluppò la teoria
secondo cui la crescita della popolazione non è coerente con la crescita della
produzione, ed è quindi causa di impoverimento,malattie, carestie. Nel 1968 le
teorie malthusiane vengono riprese dal libro di Paul R. Ehrlich “The population
bomb”: è il libro fondamentale che fa nascere il movimento ambientalista nel
mondo. Qual è la tesi?La popolazione cresce troppo e consuma troppo,quindi
inquina; dobbiamo ridurre la popolazione, altrimenti il pianeta sarà invivibile.
Viene messo sotto accusa l’uomo e il suo sviluppo, sia in termini5numerici sia
in termini economici e tecnologici. Tutte le previsioni contenute nel libro e in
libri successivi non si sono verificate, però l’ideologia è rimasta: la crescita
della popolazione è vista come cosa minacciosa, più di una bomba atomica.
Avevano previsto che nel 2000 saremmo stati ottomiliardi, mentre eravamo poco
più di sei miliardi;già un errore del 25% è grave, ma soprattutto noi oggi
abbiamo il problema contrario: le culle vuote. Nel pensiero neomalhtusiano, le
culle vuote avrebbe dovuto significare benessere, ricchezza, posti di lavoro, ma
si è visto che è vero il contrario: non avere fiducia, non far nascere bambini
significa rallentare i processi produttivi e sociali, creando gravi problemi
economici. Nel 2020 andrà in pensione il “baby boom”,cioè i nati negli anni ’50;
gran parte della società diventerà pensionata e saranno sempre meno le persone
giovani che lavorano: in termini sociali questo è il disastro tipico di una
società decadente. Siamo ricchi, materialmente non abbiamo mai avuto tante cose
come oggi, ma siamo poveri dentro, non abbiamo fiducia nella vita e non
investiamo sul futuro. Dicevano che non ci sarebbe stato cibo per tutti, invece
la produzione mondiale di cibo continua ad aumentare ovunque, e paesi come
Cina,India, Brasile sono diventati esportatori di cibo. Ci sono più di 800
milioni di persone denutrite, ma non a causa della crescita della popolazione:
la maggior parte di loro vivono in paesi sottosviluppati a bassa densità
demografica. Potremmo inoltre produrre molto più cibo: siamo nella situazione
paradossale e immorale per cui ci sono quote di produzione; c’è gente che muore
di fame, ma noi, per tenere alti i prezzi su alcuni prodotti, non produciamo
più.
Bugia n. 2: il calo delle foreste.
Hanno detto che le foreste stanno
scomparendo,hanno detto che ogni anno scompare una porzione grande come
l’Austria o la Svizzera solo nella foresta amazzonica. E’ vero, ma hanno
dimenticato di dire che la foresta amazzonica è grande 100 volte la Svizzera,
quindi è l’1%, e che il Brasile è uno dei paesi che pianta più alberi al mondo.
Hanno dimenticato di dire che, se c’è una minaccia di riduzione della flora, è
legata non allo sviluppo, ma al sottosviluppo: gli agricoltori poveri tagliano
le foreste, bruciano gli alberi, usano la cenere come fertilizzante, poi, quando
le piogge lavano le terre, passano avanti. La flora nel mondo è in crescita: lo
constatiamo non solo contandogli alberi o sommando i dati locali, ma anche
fotografandola situazione del mondo direttamente dai satelliti. C’è anche da
considerare il rapporto delle forme di vita sul pianeta. In termini numerici la
specie umana è lo 0,01% di tutte le specie viventi. In termini di massa i 6
miliardi e 800 milioni di persone hanno lo stesso peso delle formiche che vivono
sulla terra. Il 97% di questo pianeta è flora,il 2,5% è fauna. Un continente
gigantesco come l’Australia ha 19 milioni di persone; l’Argentina è sette volte
l’Italia, con 40 milioni di persone; la Cina con un miliardo e mezzo di persone
ha una densità demografica cinque volte inferiore all’Italia. La valutazione
quantitativa è necessaria, se davvero vogliamo capire.
Bugia n. 3: riscaldamento globale e protocollo di
Kyoto.
Hanno detto che i mari si sarebbero alzati:la
temperatura cresce, i ghiacci si sciolgono e i mari si sollevano. In realtà
l’unico dato certo è che stiamo vivendo un periodo relativamente caldo, mezzo
grado di temperatura in più: quasi certamente questo fatto non dipende dalle
attività umane, perché il clima è regolato da forze enormi varia secondo leggi
nelle quali l’uomo è una parte infinitesimale. Innanzitutto chiariamo i termini,
distinguendo tra “effetto serra” e “riscaldamento globale”. L’effetto serra è un
effetto benefico: il nostro pianeta,grazie all’atmosfera, rallenta i raggi del
sole che arrivano e li trattiene quando “rimbalzano” sulla terra, cosicché la
temperatura media rimane a+15°. Se l’effetto serra non ci fosse, la terra
avrebbe una temperatura media di -18°. Quello di cui si parla sempre è invece
la“teoria del riscaldamento globale”, secondo la quale l’uomo, bruciando
carburanti fossili, produce troppa anidride carbonica che va nell’atmosfera e
aumenta le temperature. Vediamo i dati: l’anidride carbonica rappresenta il 2%
di tutti i gas serra, più del 90% dei gas serra è rappresentato da vapore
acqueo. Di questo 2% di anidride carbonica, le attività umane ne producono il
4%, il 96% è prodotto naturalmente. L’eruzione di un vulcano produce più
anidride carbonica di tutta la produzione annuale delle industrie del mondo
occidentale. L’oceano e le foreste producono (e assorbono, ma producono)tanta di
quella anidride carbonica per cui verrebbe da dire: “Ma di cosa stiamo
discutendo?”. Il protocollo di Kyoto è una frode. Vi faccio un esempio: il
protocollo ambisce a ridurre le emissioni di anidride carbonica. L’Italia ha
sottoscritto l’accordo e ha continuato ad aumentare la sua quota di anidride
carbonica; adesso deve ridurla. In che modo? Sta comprando quote da paesi che
hanno crediti, paesi che ne producono meno della quota concordata: quindi non
c’è nessuna riduzione reale. Pagheremo 500 milioni di euro l’anno sulle nostre
bollette, ma non ridurremo di un grammo l’anidride carbonica: è solo un gioco e
una normativa ipocrita. Se fosse vera la teoria del protocollo di Kyoto,la
riduzione della produzione di anidride carbonica ridurrebbe la temperatura del
pianeta di 0,02° in50 anni con una spesa spaventosa: questo è il motivo per cui
Stati Uniti, Australia, Cina, India, non hanno aderito al protocollo. Però voi
provate a dire questo pubblicamente. Utilizzare i cambiamenti climatici per
sostenere una teoria è come usare la sfera di cristallo: se c’è una cosa che
varia ogni giorno e che non è mai stata uguale nella storia del pianeta è il
clima, e quanto l’uomo riesca a influenzare il clima è cosa molto incerta. Il
sole è un’esplosione termonucleare continua,una minima variazione del sole e il
nostro clima varia in una maniera spaventosa; ma anche le forze degli oceani, la
velocità di rotazione,l’inclinazione dell’asse terrestre, sono fenomeni in grado
di influenzare pesantemente il clima:dobbiamo studiare e capire queste cose, ma
dire che il cambiamento di clima è colpa dell’uomo è ridicolo.
Bugia n. 4: la scomparsa delle specie.
Hanno detto che le specie stanno scomparendo,e che
la crescita dell’attività urbana sta facendo scomparire le specie. Nelle nostre
città non abbiamo mai avuto una varietà tanto grande di specie, a Roma abbiamo i
gabbiani a Piazza Venezia, abbiamo tutti i tipi di uccelli, abbiamo gli
scoiattoli nei parchi. A livello mondiale noi conosciamo solo una parte della
fauna esistente. Tre anni fa è partito un grosso censimento della fauna marina
(400 scienziati di tutti i paesi con le tecnologie più avanzate): in tre anni
hanno scoperto 5.500nuove specie. Si pensava che nel mare a una certa altezza ci
fosse il massimo della fauna e poi sottonon ci fosse più niente, invece hanno
scoperto che sotto c’è più di sopra. Molte specie ritenute estinte sono state
ritrovate. Il caso più eclatante è quello del celacanto, un pesce esistente già
al tempo dei dinosauri e ritenuto estinto: una ricercatrice americana,in vacanza
alle isole Comore, lo ha “ritrovato”al mercato, dove veniva venduto e mangiato.
Per non parlare poi delle specie che si dicevano in via di estinzione: sullo
Stelvio adesso i cervi sono troppi e dovranno ucciderne; lo stesso accade nei
parchi africani con gli elefanti, lo stesso sta succedendo con le balene e gli
avvoltoi. Ci sono specie che probabilmente emergono e noi non le conosciamo,
perché sono in zone dove non ci sono uomini.
Altre bugie.
Abbiamo anche vissuto la demonizzazione
dell’energia nucleare. Sta di fatto che l’Italia oggi importa il 18% del suo
fabbisogno energetico da paesi che lo producono nuclearmente: noi non lo
produciamo, però lo compriamo. L’ENEL ha anche acquistato impianti nucleari in
Slovacchia: sono impianti più vecchi di quelli che avevamo, però lì non c’è
l’opposizione dei Verdi, quindi l’ENEL li ha comprati, ci investe, ha mandato lì
i nostri tecnici e da lì produrrà energia per l’Italia. Hanno detto che la
desertificazione sta avanzando mentre negli ultimi 10 anni il deserto sta
arretrando. Hanno detto che la società moderna è troppo inquinata, ma in realtà
la vita delle persone si allunga. E così via: nel libro abbiamo raccolto molte
bugie. Anche sugli OGM i Verdi ci hanno raccontato bugie e le accompagnano con
scenari catastrofici, una vera fabbrica delle paure.
La vera concezione dell’uomo.
La cosa più grave è che hanno voluto cancellare
l’ottimismo e la speranza e hanno stravoltola concezione dell’uomo. Guardiamo la
realtà: il nostro pianeta è un mistero grande e in tutto il sistema solare non
c’è vita. La terra non ha solo la vita, la flora, la fauna, i laghi, le piante,
gli animali,ma ha gli uomini e gli uomini sono una specie di vita straordinaria,
che supera tutti i limiti della fauna. L’uomo è un essere pensante, può
concepire l’infinito, studia le leggi che regolano l’universo e le utilizza per
svilupparsi: noi voliamo, navighiamo,andiamo nello spazio. L’umanità è qualcosa
di straordinario, altro che cancro del pianeta. La caratteristica antropologica
che definisce la specie umana è la sua capacità di produrre cultura, cultura che
va oltre le esigenze del mangiare,bere e costruire la casa. Parliamo di uomo
quando troviamo dipinti, immagini, culto dei morti, cioè quando troviamo
qualcosa che astrae, che va oltre l’aspetto materiale. L’uomo è un essere
intelligente e sociale che utilizza la socialità e il linguaggio per affrontare
con una nuova cultura i problemi che si trova di fronte. La comunità di fronte a
un problema, ad esempio la fame, sviluppa l’agricoltura: nell’agricoltura non
c’è niente di naturale, è produzione dell’uomo, è una riproduzione di ciò che
avviene in natura, però ordinata dall’uomo con l’utilizzo del seme, con la
crescita delle piante, con la selezione di piante. L’uomo osserva, studia,
produce una cultura, affronta e risolve il problema. Un’altra caratteristica
fondamentale dell’uomo è la socialità basata sulla famiglia. Il Creatore avrebbe
potuto creare un essere che si riproduce da sé, un ermafrodita, però sarebbe
stato l’essere più egoista del mondo; ha creato due esseri differenti, uomo e
donna, e la continuazione della specie passa attraverso l’atto d’amore di questi
due, un’unione non solo sessuale, ma d’amore,di donazione, di uscita dal proprio
egoismo. La famiglia è la più grande sfida all’egoismo: tante cose si fanno per
la famiglia, tanti sacrifici che, se uno vivesse da solo, non farebbe. Nella
società umana c’è anche la trasmissione della cultura, l’educazione, quella che
in economia viene chiamata “la formazione del capitale umano”: la ricchezza del
pianeta non sono le piante, gli animali, le materie prime, il denaro; la
ricchezza del pianeta è il capitale umano. I cristiani direbbero: la persona.
Perché rappresenta una ricchezza? Perché le persone riescono a definire, a
produrre, a pensare, a produrre amore, a produrre per il bene comune, perché
sono fatte per questo. C’è un disegno del Creatore, sono fatti per il bene,altro
che cancro per il pianeta. Questi piccoli spunti antropologici ci dicono che
dobbiamo superare il modo con cui l’ecologismo ha trattato il rapporto uomo -
ambiente; dobbiamo produrre una nuova cultura, più positiva,più ottimista, una
cultura che migliori l’ambiente utilizzando il meglio delle capacità umane, una
cultura che non criminalizzi gli uomini, ma che usi il meglio degli uomini per
migliorare il pianeta: ciò che Giovanni Paolo II chiamava “ecologia umana”. Il
nostro libro tenta di superare questa cultura catastrofista e nichilista, e di
dare un approccio culturale nuovo al rapporto con l’ambiente; la crescita
dell’umanità è ovvio che crea problemi di rapporto con la natura, ma non sono
rapporti conflittuali,sono rapporti che noi possiamo risolvere. Noi possiamo
risolverli, non la natura: non sarà la natura a salvare noi, come pensano gli
adoratori di Gaia, ma saremo noi a salvare la natura e a salvare noi stessi.»
DOMANDE e INTERVENTI
Nel libro ci sono moltissime parti che parlano
dell’ONU, mentre nel suo discorso non l’ha citato.
«L’ONU è un’istituzione internazionale che ha dei
compiti chiari, con molti fallimenti e grandi difficoltà, e riflette il modello
culturale dominante;l’ONU è condizionato dai poteri forti e i poteri forti hanno
sposato la cultura ecologista. Il WWF ha proprietà terriere più di un impero
coloniale, fra parchi, oasi, ecc. E’ diretta da persone molto legate ai poteri
forti, cominciando dal principe Filippo di Edimburgo, e nel suo consiglio di
amministrazione siedono presidenti di banche, di multinazionali, ecc.: non c’è
nessuno di quelli che voi immaginereste come ecologisti. L’ONU riflette la
stessa filosofia. C’è un ufficio dell’ONU che si occupa di ambiente, ed è stato
fondato dalle stesse persone che hanno fondato il WWF, in particolare da Julian
Huxley. La famiglia Huxley è una delle famiglie britanniche più potenti, il
primo Huxley di cui si parla veniva chiamato il mastino di Darwin ed è quello
che ha lanciato la teoria dell’evoluzionismo prima di Darwin, e alcuni dei
familiari sono diventati famosi (c’è anche il premio Nobel Huxley che ha scritto
il libro “Il mondo nuovo” in cui descrive la società che gli Huxley e i poteri
forti pensavano, cioè una società in cui non c’è più la famiglia, in cui tutte
le persone vengono prodotte da una grande incubatrice, in cui si decide le
categorie di persone che devono nascere alfa, beta, gamma: vi consiglio di
leggerlo perché è esattamente quello che stanno cercando di fare oggi).Ma la
cosa più incredibile di questo gruppo di potere è che erano anche i fondatori
delle società eugenetiche, che negli anni ‘20 e ‘30 hanno lanciato quel tipo di
programma, sempre legato a Malthus, per cui bisognava ridurre le nascite, che
dovevano essere selezionate, staccate dalla famiglia; teorie che poi Hitler, in
maniera molto teutonica, ha applicato alla lettera: nell’immediato dopoguerra
non si poteva parlare di eugenetica proprio per questo motivo. Oggi gli Stati
Uniti si sono opposti alla cultura malthusiana, sia perché sono pragmatici, sia
perché si sono resi conto che la cultura malthusiana significava la morte di una
civiltà, e per loro, che si considerano l’unica superpotenza,questo significava
la fine dell’impero. Dal 1972 ci sono state diverse riunioni internazionali
sulla questione dell’ambiente; l’ultima si è tenuta a Johannesburg nel 2002 e ha
ribaltato i parametri culturali che erano stati imposti nel 1972 a Stoccolma. A
Stoccolma si era detto: siamo troppi sulla terra, bisogna ridurre i consumi, lo
sviluppo è il problema, dobbiamo contenere e limitare i consumi, impedire le
attività produttive, limitare la scienza. A Johannesburg nel 2002 si è detto: il
vero problema dell’inquinamento non è lo sviluppo, ma il sottosviluppo. Quelli
che consumano più alberi non sono i paesi ricchi che vanno a tagliare gli alberi
nella foresta amazzonica (anche perché è molto antieconomico, è meglio piantarli
e poi tagliarli), ma sono i paesi poveri che non hanno carburante e tagliano
tutto il legno che trovano. Il 90% dei morti per le conseguenze
dell’inquinamento ambientali sono nei paesi poveri, non nei paesi ricchi. La
prima cosa da fare è dare casa e acqua potabile alle persone: questo è il più
grande contributo ambientale che possiamo dare. L’approccio neomalthusiano è
arrivato al capolinea, occorre cominciare a lavorare per un modello culturale
alternativo e propositivo.»
L’ostilità degli ambientalisti verso la
popolazione mondiale è dovuta a una causa semplicemente“spirituale” correlata
all’antica dea terra o è dovuta a un notevole introito economico per loro? Si sa
che molte persone agiscono quando ne hanno un guadagno: è il caso anche degli
ambientalisti?
«Vorrei distinguere tra “ideologia ambientalista”e
“ambientalisti”. Ci sono dirigenti ambientalistiche sono disonesti, ma la gran
parte delle persone che aderisce ad associazioni ambientaliste lo fa in buona
fede. Sul guadagno di denaro non ci sono dubbi: vendendo paure hanno creato un
impero. Associazioni come WWF, Greenpeace, Legambiente,hanno bilanci miliardari,
superiori in alcuni casi a quelli delle multinazionali; se andiamo a vedere da
dove vengono questi soldi, scoprirete che in parte vengono da gruppi e
fondazioni che hanno sostenuto la politica malthusiana del “siamo troppi sulla
terra”, finanziando enormi piani di riduzioni delle nascite. Sono state
sterilizzate 150 milioni di donne, in maggioranza povere e non scolarizzate, a
cui hanno fatto accettare la sterilizzazione9attraverso aiuti alimentari e
accesso al credito, e in alcuni casi con violazioni palesi dei diritti umani. In
Italia, durante la campagna sul nucleare, alcune compagnie petrolifere hanno
versato un’enorme quantità di denaro. Da una indagine fatta negli Stati Uniti è
venuto fuori che un’alta percentuale di dirigenti di associazioni ambientaliste
siede nei consigli di amministrazione delle 500 ditte più inquinanti del paese.
Il responsabile ambientale dell’Union Carbide, responsabile del disastro di
Bhopal in India, era uno dei fondatori del WWF. Nell’amministrazione del Parco
Nazionale d’Abruzzo, gestito da Fulco Pratesi, i dirigenti si sono aumentati gli
stipendi, hanno aperto uffici a New York, a Venezia, tutti con soldi dello
Stato, si sono affittati le case che loro abitavano; ci sono denunce, c’è una
sentenza: Fulco Pratesi deve riconsegnare il denaro [Si riferisce alla sentenza
1/2004 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione
Abruzzo, con condanna al pagamento per Franco Tassi, ex direttore, e Fulco
Pratesi, presidente, NdR]. Non si sa come, ma queste notizie non appaiono sui
giornali. Non c’è mai un rappresentante dei Verdi che parli tranquillo e sereno;
sono aggressivi,esprimono giudizi, accusano gli altri. Questo dà l’idea del poco
rispetto che hanno delle persone,come dimostra il recente caso di Mario Tozzi,
conduttore di Gaia, il quale in una trasmissione radio in cui si discuteva di
“unioni di fatto”, ha detto che il Cardinal Ruini è il peggior rifiuto da
eliminare ad ogni costo, che farà la fine di una porchetta con un pezzo di
limone in bocca, che lui conosce persone che per 500 euro sono in grado di
eliminare Ruini e i tabernacoli, che la Spagna degli anni ’30 ha avuto un enorme
progresso sociale da quando ha ucciso i sacerdoti e distrutto le chiese, ed è
assurdo che in Italia continuiamo a costruire chiese, e al posto di San Pietro
bisognerebbe fare come a New York…Le campagne catastrofiste hanno un
fine:aumentare la propria influenza, essere sempre sulle pagine dei giornali,
riuscire ad avere peso politico e costruirsi una vera e propria lobby. Tra
l’altro molte campagne ambientaliste consentono di favorire certi prodotti e
penalizzarne altri, senza essere accusati di concorrenza sleale. Una campagna
contro le pellicce naturali favorisce le pellicce sintetiche. Promuovi l’energia
solare e poi scopri che rappresentanti verdi sono nella dirigenza delle ditte
che producono il solare.»
Sono un iscritto Verde. Vorrei ricordare che
l’attuale Ministro dell’Agricoltura, che non è Verde, è convinto che gli OGM
siano un pericolo. Inoltre chiedo perché ritiene Kyoto una frode, visto che
tanti stati l’hanno sottoscritto, ultimamente anche la Russia. Poi due problemi
locali: foto dal satellite hanno evidenziato che l’Emilia Romagna ha un super
inquinamento dovuto a PM10 e ad altri fattori. La Regione sta cercando di
fermare una percentuale di traffico: lei cosa ne pensa? Inoltre,visto che lei è
favorevole al nucleare, può dirci quali benefici abbiamo ricavato in Italia
quando c’era il nucleare?
«Io non sto attaccando i Verdi per motivi
ideologici: dal punto di vista ideologico ci sono persone a destra molto vicine
all’estrema sinistra. L’ambientalismo storicamente è nato dalle società
eugenetiche che erano di estrema destra ed erano al potere. Uno dei fondatori
dell’ecologismo italiano si chiama Alessandro Ghigi (1875-1970): è stato rettore
dell’Università di Bologna e fu uno dei firmatari della carta utilizzata per la
promulgazione delle leggi razziali; poi nel dopoguerra è stato sostenuto da
organizzazioni di sinistra. Quindi a me non fa impressione che il ministro del
centro destra Alemanno sia, su certe questioni, molto vicino al Verde Pecoraro
Scanio. L’opposizione allo sviluppo e al progresso di una certa destra è uguale
a quello dell’estrema sinistra. Sugli OGM la questione è più articolata, anche
qui ci sono interessi specifici. Il mondo sta andando in quella direzione,
perché è ottimale dal punto di vista ambientale: sono l’unico modo per ridurre
l’utilizzo di fitofarmaci in agricoltura in zone dove i fitofarmaci non riescono
più a contenere i parassiti. Ho fatto una ricerca per la Santa Sede, durata due
anni: non c’è istituzione scientifica internazionale che non si sia pronunciata
su questo argomento e che non abbia fornito la stessa identica valutazione. Per
quanto riguarda Kyoto, bisogna ricordare che la maggior parte dei paesi l’ha
sottoscritto sulla base del fatto che il protocollo non comporta nessun impegno
per loro. La Russia prima della sottoscrizione ha presentato documenti
opponendosi alla teoria del riscaldamento globale, poi ha firmato il protocollo.
C’è una ragione: la Russia avanza crediti, la Russia adesso vuole essere pagata
per aver sottoscritto il protocollo; avendo dismesso moltissime attività di
vecchia tecnologia, eredità del regime comunista, adesso ha dei crediti a
livello di CO2 e aspetta il denaro. Per quanto riguarda l’inquinamento in Emilia
Romagna: la zona è particolare, ospita il 15% delle attività produttive della
pianura padana, assieme a molte vie di comunicazione. La presenza dei PM10 credo
sia dovuto soprattutto alle condizioni climatiche, all’umidità che schiaccia a
terra le particelle inquinanti. In Emilia Romagna ci sono problemi ambientali ma
è anche una regione con altissimi livelli di vita, quindi si deve trovare una
soluzione per migliorare le condizioni ambientali senza perdere questa capacità;
tante energie sono state spese per farne una regione produttiva e avanzata: se
le medesime energie si sposteranno anche sulla questione ambientale, le
soluzioni si possono trovare. Comunque, guardando i dati del passato, la
situazione ambientale è migliorata: mi riferisco soprattutto all’impatto degli
allevamenti di suini, agli scarichi nelle acque, ai valori sull’aria. Le leggi
sono diventate più rigorose e più applicate, mentre nel passato non c’erano
leggi o non venivano applicate. Gli alti livelli di vita implicano più attività
e più macchine, però non si può fermare il progresso, il progresso è anche un
miglioramento delle attività ambientali. Qui c’è un equivoco di fondo che
l’ecologismo ha creato. L’ideologia ecologista dice: c’è un luogo incontaminato;
vogliono fare un albergo; no, non si può fare l’albergo. Invece si dovrebbe
dire: sì, si fa l’albergo, ma si fa il miglior albergo del mondo, quello con il
minor impatto ambientale, quello che usa il solare come energia, eccetera. Per
quanto riguarda il nucleare, col petrolio a 70 dollari al barile, è evidente che
noi abbiamo sbagliato. Compriamo energia elettrica dalla Francia che la produce
nuclearmente, compriamo vecchie centrali nucleari in Slovacchia, perché è
energia più economica e meno inquinante. Siamo l’unico paese del mondo avanzato
che invece di ridurre la dipendenza dal petrolio l’ha aumentata: è ipocrita
firmare il protocollo di Kyoto e poi aumentare l’utilizzo delle fonti fossili.
Abbiamo impiegato 30 anni per far crescere tecnici capaci di fare il nucleare, e
quella ricchezza l’abbiamo spazzata via. Nella bolletta stiamo ancora pagando lo
smantellamento delle centrali: siamo l’unico paese al mondo che paga per non
produrre energia. Il bilancio sul nucleare è semplicissimo: avevamo tre impianti
nucleari che producevano energia, li abbiamo cancellati pagando lo
smantellamento senza avere benefici. Quindi è un bilancio assolutamente in
perdita.»
Faccio parte dell’Esecutivo provinciale dei Verdi.
La mia cultura d’origine è cattolica, lontana dall’excursus eugenetica –
catastrofismo - ambientalismo. Sono ottimista, credo nell’intelligenza
dell’uomo, credo che l’uomo debba preservare la terra dai pericoli che si creano
durante lo sviluppo. Credo che lei abbia preso solo argomenti che servono per
valorizzare la sua tesi, che è quella di denigrare l’ambientalismo in generale.
Premetto che c’è un problema di competenza: tutti noi dipendiamo da quello che
dicono gli scienziati. Io sono uno che approfondisce e che invita il mio
movimento a studiare, a essere competente, ma ugualmente non sono in grado di
valutare elementi così complessi che solo uno scienziato può argomentare. In
questa sala molti dipendono solo dalle sue parole; però penso che poi si
documenteranno, andranno a verificare se le cose che lei dice sono vere. Ho
raccolto un dossier di scienziati che dicono il contrario delle cose che lei
dice. Chi ha ragione? Bisogna verificare, cercare di prendere più elementi
possibili. E’ bene che ciascuno di noi cerchi di approfondire, di vedere i dati
interessanti e anche quelli negativi che ci sono sul libro.
«Sono contento di questo intervento: uno degli
obiettivi del libro era quello di cercare di argomentare, perché la verità è
complessa. La maggior parte delle cose che ho citato (con bibliografia)
sull’ideologia verde sono tratte da pubblicazioni e dichiarazioni fatte da
esponenti verdi. La discussione su questi temi è molto vasta, esattamente il
contrario di come viene presentata. Ad esempio, il protocollo di Kyoto fu votato
in prima istanza con l’Amministrazione Clinton e il Senato lo respinse 98 a 2;
inoltre c’è un manifesto firmato da 19.000 scienziati che si oppongono a Kyoto e
argomentano. Se il nostro libro non fosse stato scritto, queste argomentazioni
critiche non sarebbero apparse sulla stampa italiana. Sono d’accordo che non c’è
una verità assoluta su queste questioni: io sono in totale contrasto con coloro
che dicono che il clima funziona così perché lo diciamo noi. Il clima è una cosa
complicatissima. Dire che tagliando le produzioni di CO2 il clima si raffredda è
un’affermazione ideologica, non sappiamo nemmeno se l’aumento della CO2 riscalda
o raffredda: le stesse identiche persone che hanno portato avanti la teoria del
riscaldamento globale, 25 anni fa sostenevano che l’aumento della CO2 avrebbe
portato a un raffreddamento del clima. Anche l’approccio scientista non mi
convince. Un approccio scientifico che non tiene conto del bene degli uomini
chiaramente non è sufficiente: occorre ristabilire un principio più alto in cui
il rapporto uomo - ambiente sia visto non come conflitto, ma come una
possibilità di trovare soluzioni puntando sul bene degli esseri umani. Questo
per me è il principio di fondo. Per quanto riguarda i Verdi, mi dispiace se ho
suscitato la suscettibilità di qualcuno. Per me la persona è sacra, sono un
credente e rispetto ogni persona, ma non rispetto certe opinioni; e siccome
certe idee sono state portate avanti, scritte, documentate con odio contro
l’umanità, perché non dovrei dirlo? Qual è il fine di queste politiche, cosa ha
prodotto questo approccio culturale, quale è la concezione dell’uomo che sta
dietro a questa ideologia? Questo ho cercato di approfondire, ho anche fatto un
manifesto per i cristiani ambientalisti; stimo le persone che hanno una
sensibilità ambientale, però considero un certo approccio culturale come
deleterio, contrario al bene dell’umanità e quindi lo denuncio, lo scrivo in un
libro, mi pongo in una discussione pubblica, ma lungi da me, soprattutto sulla
questione scientifica, credere al pensiero unico. Purtroppo sulle questioni
ambientali c’è il pensiero unico. Ad esempio, sulla questione degli inceneritori
c’è il pensiero unico. Se lei va a Vienna, nel tour della città la portano anche
a vedere un inceneritore, fatto con una tecnologia molto vecchia, del1976.
Addirittura adesso lo triplicano, nel centro della città. Perché? Perché in
questo momento noi abbiamo un problema di rifiuti e lo avremo sempre più grande;
portare i rifiuti in discarica significa non trattare i rifiuti. L’Italia è un
paese piccolo, stretto,urbanizzato, ha le montagne, poche pianure, un po’ di
colline: se potenziamo le discariche, questo paese dal punto di vista ambientale
e umano peggiora. Il modo più efficiente che si conosce per affrontare questo
problema è il termovalorizzatore, la tecnologia attuale ci permette questo.
Ovviamente non c’è una sola soluzione, ci sono soluzioni articolate, ma la
quantità di rifiuti prodotti è enorme: o lei trova il modo di ridurli,
addirittura producendo energia, oppure il problema c’è. Lei può pensare al
compostaggio, alla riduzione, a ossidarli, ma la soluzione ottimale è quella.
Poi ci sono altre piccole e varie soluzioni, da studiare e verificare.
L’importante è impostare un metodo in cui non si contrappone un interesse a un
altro,ma si cerca di unificare gli interessi all’interno del bene comune.»
Non sono un verde, ma ho una preoccupazione.
Persone che hanno cominciato ad interessarsi di ambiente con uno spirito
positivo, sono finite nella ideologia ecologista, alleati di fatto con i vari
Rockfeller che sostengono le organizzazioni ambientaliste e contemporaneamente
promuovono le sterilizzazioni forzate, le pratiche eugenetiche e l’eutanasia di
massa. Non vorrei però che la controinformazione sull’ecologia venisse sfruttato
dall’altra faccia della medaglia. Non vorrei che uscissimo da questa sala, dopo
quello che lei ha smitizzato il movimento ecologista, dicendo “si può tornare a
far tutto”. Una cosa del genere rischia di diventare funzionale a un sistema di
tipo diverso che comunque non è in armonia con l’antropologia cristiana. Ho
votato contro l’energia nucleare e me ne sono pentito; magari mi ripentirò anche
sugli OGM, però al momento sto col ministro Alemanno, che non sarebbe contento
dell’accoppiamento che lei ha fatto con l’estrema sinistra, perché per esempio
l’organizzazione Fare Verde, legata a quella parte politica, diverge
dall’estrema sinistra sui problemi della vita umana.
«Quello che lei ha detto è vero. Le soluzioni che
puntano solo al materialismo o all’efficienza economica o al benessere non sono
le soluzioni migliori; la tecnologia e la scienza non sono l’essenza della vita,
sono qualcosa che aiuta la vita, ma non sono cose che danno senso alla vita.
Così come la materia, il possesso, non dà senso alla vita. Il senso della vita è
qualcosa di più profondo, di più grande, e va oltre l’aspetto materiale, quindi
non è che noi risolveremo i problemi ambientali solo costruendo i
termovalorizzatori, che sono una soluzione intermedia e parziale come tutte le
tecnologie che noi sviluppiamo. Le nostre conoscenze sono ancora molto limitate,
perché il mondo è più grande di quanto noi immaginiamo; è paradossale che molte
delle ideologie verdi si oppongano all’utilizzo della scienza e della
tecnologia, poi però identificano l’uomo come onnipotente, capace di cambiare il
clima, di stravolgere la società Le catastrofi naturali ci dimostrano che noi
siamo piccoli, che c’è ancora molta strada da fare. Noi per esempio non sappiamo
difenderci dalle catastrofi naturali, un terremoto uccide migliaia di persone,
in Giappone ne uccide un po’ meno; l’uragano è ancora una cosa disastrosa che
uccide tante persone, è un fenomeno che c’è da sempre, e noi dobbiamo crescere
per difendere l’umanità dalle catastrofi naturali. Il problema è che, per
motivazioni ideologiche e politiche, e per i propri interessi, molte persone
impediscono di alzare il livello della discussione: questo è totalmente
sbagliato. C’è un interesse comune che è la crescita, lo sviluppo dell’umanità
su questo pianeta, su cui noi sappiamo pochissimo; siamo l’unica specie vivente
fatta in questo modo e su questo noi dobbiamo lavorare per cercare di capire
qual è il senso della nostra vita e come migliorare per il bene comune. Per noi
credenti questo è evidente, il Signore ci ha creato per il bene, ci ha creato
con questa tensione, però dobbiamo cercare in qualche modo di migliorare questa
capacità scientifica, tecnologica, ma anche umana di lavorare insieme per
risolvere i problemi. Non dobbiamo discutere ai livelli più bassi per
contrastarci l’un l’altro. Viviamo in un mondo di fortissime contraddizioni,
l’umanità non ha mai avuto uno sviluppo materiale come oggi, produciamo una
quantità di merci immensa, siamo enormemente ricchi. Nello stesso tempo però
vediamo che una parte degli uomini ha perso il senso dell’umanità. Il Papa la
definiva una crisi epocale: siamo progrediti nella scienza, ma nello sviluppo
morale non abbiamo fatto i salti necessari;c’è un tentativo di ridurre i
rapporti umani, di ridurre le persone a cose; abbiamo timore di mettere al mondo
bambini, però cerchiamo il modo di farlo in maniera tecnologica, come in una
fabbrica, e parliamo di libertà quando sopprimiamo i bambini. Che libertà è, se
nega la vita? E poi, libertà di chi? Sicuramente non di quello che viene
soppresso;siamo tornati al tempo del diritto di vita o di morte sul nascituro.
Torniamo con la mente a San Benedetto: i benedettini da un punto di vista
ambientale hanno fatto moltissimo, perché per primi hanno sviluppatole tecniche
di rimboschimento quando il legno era la cosa più preziosa. E soprattutto “ora
et labora” e sii lieto, questa era l’atteggiamento. Io credo che se riuscissimo
a riprendere quei principi, soprattutto il “sii lieto”, andremmo molto meglio.»
PORTA IL NIPOTE IN CAMPAGNA: MULTATO!!!
«In una nazione dove tutto va a catafascio, o come
dicono alcuni a scatafascio, ossia alla deriva morale e materiale, il sistema di
parassiti le pensa tutte per potersi mantenere vessando in tutti modi i
cittadini, sudditi di una classe dirigente (politica ed istituzionale) corrotta
ed incapace. Classe dirigente che con i media genuflessi alle cricche induce il
paese ad essere governato da nani, ballerine ed oggi anche da comici. Questo da
aggiungersi al sistema di potere cristallizzato di mafie, lobbies, caste e
massonerie. Si sorvola sul fatto che a riformare l’ordinamento forense ci sono
gli stessi avvocati in Parlamento a tutela dei loro privilegi ed a chiusura
della concorrenza (salvo che per amici e parenti), i medesimi che, oltretutto,
sono periodicamente in sciopero per le riforme da loro stessi predisposte. Ma
passiamo oltre. In una Italia dove si sottace l’usura e l’estorsione di Stato,
ovvero la nomina e la retribuzione amicale dei consulenti dei magistrati. Una
nazione, dove il più onesto merita l’Asinara, ci dimostra che né toghe, né
divise possono pretendere l’esclusiva della legalità, né possono permettersi il
monopolio del parlarne agli studenti in incontri nelle scuole e nei convegni
organizzati dalla sinistra – dice il dr Antonio Giangrande, presidente della
“Associazione Contro Tutte le Mafie” www.controtuttelemafie.it, e
scrittore-editore dissidente che ha scritto e pubblicato la collana editoriale
“L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo” pubblicata sui propri siti web, su
Amazon in E-Book e su Lulu in cartaceo. 40 libri scritti dallo stesso autore e
pertinenti questioni che nessuno osa affrontare. Opere che i media si astengono
a dare la dovuta visibilità e le rassegne culturali ad ignorare. - Bene. Detto
questo, un fatto merita di essere conosciuto.
Quando tutto è perduto, e quel tutto ti accorgi di
essere vacuo, non rimane altro che tornare a fare i contadini. Ma ecco qui. Ci
impediscono anche di fare questo. Si passa oltre sul fatto che il duro lavoro
dei nostri antenati di sanificazione dei terreni da sterpaglie e pietre o di
bonifica dalle paludi, al fine di renderli terreni fertili da coltivare, sia
stato reso vano dall’invasione su quelle stesse terre di pannelli fotovoltaici e
del ritorno delle sterpaglie. Truffaldini intenti ambientalisti di falsa tutela
della natura, ma che nasconde l’odio verso gli umani od addirittura speculazioni
mafiose, ci impongono l’invasione di alternative fonti di energia e ci
impediscono di tagliare le sterpaglie, che oggi sono protette. Oggi tu tagli e
pulisci le strade o il podere dai rovi? Giù multe perché tagli piante protette.
Ed ancora. Da sempre i contadini hanno bruciato nello stesso campo gli avanzi
delle potature degli alberi o le foglie cadute. Oggi tu li bruci? Giù multe
perché inquini. Ma il colmo di questa Italia e che in campagna non ci puoi più
proprio andare, salvo che accompagnato dal commercialista o dal consulente del
lavoro, se no giù multe per violazione di norme sul lavoro.
“Vendemmia amara: 5mila euro per aver portato il
nipote in campagna” è il titolo del fatto avvenuto e pubblicato su “La Voce di
Manduria”. Un fatto che merita di essere conosciuto in tutta Italia, perché
fatti analoghi succedono in tutto il “Mal Paese”, ma nessuno si degna di
parlarne. “Una multa di cinquemila euro per lo zio e una denuncia penale per i
genitori di un quindicenne che prima dell’inizio dell’anno scolastico si era
recato nella campagna dei parenti per assistere al taglio dell’uva.
Quell’esperienza costerà cara alle due famiglie di agricoltori manduriani che
durante la passata vendemmia in uno dei propri poderi hanno avuto la visita
degli ispettori dell’Ufficio provinciale del lavoro di Taranto. La sanzione
pecuniaria riconosciuta allo zio è per impiego di minore e lavoro irregolare
mentre il papà del ragazzo è in attesa di una contestazione di reato penale per
sfruttamento di lavoro minorile. L’episodio risale al 6 settembre 2012, ma solo
ora è stata notificata l’intimazione a pagare. I protagonisti della vicenda sono
due cugini manduriani che per la campagna dell’uva avevano organizzato il
cantiere di vendemmia, assumendo regolarmente cinque operai che impiegavano
alternativamente nei rispettivamente vigneti. Il 6 settembre si vendemmia dal
cugino e il signor M. oltre alla moglie, componente del nucleo lavorativo
familiare, porta con sé anche il figlio P. Il giovane oltre a frequentare lo
Scientifico di Manduria, studia pianoforte (quinto anno) presso il conservatorio
musicale “Paisiello” di Taranto (scuola privata). P. non ha iniziato ancora le
lezioni in quanto le scuole non erano aperte alla data del 6 settembre. Decide
allora di assistere alla vendemmia. Si mette affianco alla madre senza prendere
parte ai lavori. Lo studente di fatto non vendemmia e questo perché il padre è
un agricoltore che rispetta la legge. Quel giorno però arrivano in campagna gli
ispettori del lavoro (un uomo e una donna), fanno i dovuti controlli e trovano
tutto in regola salvo, per loro, la presenza di P. che viene considerato come un
lavoratore, in quanto ha in mano delle forbici antinfortunistiche. Il tutto
viene contestato dagli ispettori e a domanda al ragazzo se stesse lavorando
Piero risponde di no, dice che si trovava affianco alla madre e non su un filare
di vite e senza un secchio per la raccolta. A non convincere gli ispettori circa
quella casualità è stato l’arnese che aveva tra le mani: le forbici
antinfortunistiche che seppure non adatte al taglio dei grappoli sono state
comunque considerate come un utensile da lavoro.”
Il fatto è successo a Manduria, comune sciolto ed
in odor di infiltrazione mafiosa. Eppure, quando una denuncia partì dal Dr
Antonio Giangrande, anche in occasione di concorsi pubblici truccati svolti in
quel comune, i carabinieri delegati alle indagini scrissero nel rapporto che
tutto quanto denunciato non era vero, anzi, erano propalazioni del Giangrande ed
il magistrato archiviò. Del fatto si occupò la Gazzetta del Sud Africa e il
magistrato per ritorsione denunciò a Potenza il Giangrande per diffamazione. I
magistrati a Potenza furono pronti ad incriminare. Vuol dire che è più importate
multare i campagnoli che lottare contro i mafiosi.
In questa Italia c’è solo da vergognarsi di farne
parte. Non sanno più da dove prendere i soldi. Se una famiglia ha un piccolo
appezzamento di terreno ereditato dagli avi, coltivato ad uliveto o vigneto o
altro tipo di coltura, ed il capo famiglia portasse con sé moglie e figli, per
raccoglierne i miseri frutti per i bisogni familiari, e vorrebbe farsi aiutare
dai parenti il sabato o la domenica per sbrigarsi prima perché affaccendato in
altre mansioni durante la settimana? Non può. Deve passare prima dai burocrati
che devono stampargli in fronte il timbro della validazione e pagare tributi e
contributi. Aprire la partita iva ed assumere i parenti con tanto di sfilza di
norme da rispettare. Se non lo fa: giù multe e processi per caporalato. Ma qui
ci impediscono addirittura le salutari scampagnate di una volta. Qui più che non
ci sono più le tradizioni di una volta, mi sa che non c’è più religione. Ed
allora sì che la campagna viene abbandonata, l’unica vera e certa fonte di
sostentamento. Che ci invoglino a rubare e finire in carcere? Almeno lì si
mangia e si beve a sgrascio…e multe non te ne fanno. Ben venga allora quel
sonoro vaff… di quel comico che, a quanto pare, fa ridere meno dei nostri
governanti ed aspira a governare un paese abitato da macchiette colluse e
codarde.»
PARLIAMO DEI POZZI ABUSIVI.
Prendendo spunto dall’inchiesta di Margherita
D’Amico su “La Repubblica”. Un paese groviera: 10 milioni di pozzi. Troppi scavi
abusivi per trovare l'acqua. Poca pioggia e tanti sprechi, l'Italia ai tempi
della siccità. Nel nostro Paese si utilizzano più di cinquanta miliardi di metri
cubi l'anno, ma una grossa parte viene sperperata. Nel bacino del Tevere negli
ultimi 50 anni si sono persi più di due miliardi cubi d'acqua. Solo a Torino
sono stati censiti più di trentamila pozzi.
50.700 I pozzi denunciati nella sola provincia di
Torino
31.000 i pozzi destinati all'uso domestico
50 milardi di metri cubi annui l'utilizzo
dell'acqua in Italia
70% per l'allevamento e l'agricoltura
15% all'industria
15% per uso potabile
2 miliardi i metri cubi d'acqua che si sono persi
nel bacino del Tevere negli ultimi 50 anni
- 47% di precipitazioni nel grossetano
Secondo l'Autorità di bacino del fiume Po, fra
censiti, abusivi, attivi e abbandonati, sono una quantità enorme. Molti
attingono per bere o irrigare un orto, ma anche per riempire una piscina, in
modo incontrollato e pericoloso. Un bene prezioso che non è infinito. Mentre il
caldo anomalo e protratto raddoppia i consumi idrici e la siccità affligge
severamente quasi tutte le nostre regioni. Mancano norme chiare e limiti
uniformi. Si perde in un pozzo la storia dell'uomo, che affonda la mano nel buio
per dissetarsi: presso un pozzo, a Lacai-Roi, Isacco va dopo la morte di Abramo,
è al pozzo di Sicar che la samaritana riconosce il Messia, mentre in un pozzo
artesiano, nel giugno 1980, il bambino Alfredo Rampi perde la vita e l'Italia
alla tv varca per sempre un limite. In silenzio oggi, nel nostro Paese, milioni
di pozzi attingono incontrollabili a un bene che si esaurisce: l'acqua. Il caldo
anomalo e protratto raddoppia i consumi idrici, niente affatto compensati dalle
precipitazioni scarse, oppure da temporali inadatti a ricaricare le falde, così
la siccità affligge severamente quasi tutte le nostre regioni. Intanto però,
grazie a economiche tecnologie di perforazione profonda diffuse fin dagli anni
70, per realizzare un pozzo si arriva a scavare fino a baratri inauditi, anche
300-400 metri. Non solo per l'orto, ma per prato all'inglese o piscina, si vanno
ormai a raggiungere falde preziosissime, che dovrebbero rimanere inviolabili,
non di rado unendole a quelle più superficiali e contaminandole per sempre. Il
fatto è che da noi le concessioni di acque pubbliche sono ancora regolamentate
da una legge degli anni Trenta, il Regio Decreto dell'11 Dicembre 1933, n.1775,
redatto quando ancora si scavava a mano: benché modificato e integrato nel
tempo, il testo unico rimane il corpo normativo in vigore. "Dieci milioni fra
censiti, abusivi, attivi e abbandonati è la stima ragionevole dei pozzi in
Italia, ma il numero esatto non lo conosce nessuno" dice Francesco Puma
segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po. "Sarebbe già
importante incominciare a mettere il contatore, valutare l'entità dei prelievi.
Non si può sperare di gestire ciò che non si conosce in un clima di risorse
all'osso. Noi qui ci ritroviamo a controllare in 30 un bacino di 70mila kmq."
Qua e là, si possono scorrere i dati di qualche catasto. La Provincia di Torino
per esempio elenca 50.700 pozzi denunciati, di cui 31.000 a uso domestico. Ma
ogni regione ha i propri regolamenti, ciascun territorio le sue caratteristiche.
In Piemonte, Lombardia, Liguria, è la regione a rilasciare le concessioni, che
per i vari usi richiedono il pagamento di oneri, in Emilia Romagna sono le
province, in Umbra il permesso viene direttamente dai comuni. Nelle aree padane
e non solo la prevalenza dei pozzi è irrigua (ortofrutta e allevamento) e
industriale, la Toscana invece dichiara un 50% di pozzi a uso idropotabile, 27%
per usi irrigui e 23% per usi industriali. Ma il piccolo, innocente pozzo
domestico, quasi ovunque non richiede alcun permesso, se non
l'autocertificazione. "Nasce per lavarsi la faccia e annaffiare l'orto, in
realtà è concettualmente legato a un unico nucleo familiare," spiega Roberto
Mazza, docente di Idrogeologia e Geologia Applicata all'Università di Roma3.
"Per chi non è raggiunto dall'acquedotto il discorso cambia, certo, ma quanti
millantano l'uso personale e poi fanno altro? Si scava a centinaia di metri, si
mettono in comunicazione falde di superficie con quelle più protette,
corrompendo e inquinando." Acque carbonatiche, alluvionali, pregiatissime
vulcaniti, a causa delle maxi trivelle possono entrare in promiscuità e pure
ricevere detriti, concimi, pesticidi. "Inoltre, si usano sistemi di pompaggio
incredibili. E poi non piove. C'è l'emergenza idrica, i privati si lamentano, i
comuni sono strozzati e nelle more si approfondiscono i pozzi, creando disastri.
Una seria politica sull'acqua per gli amministratori è scomoda, andrebbe fatta
anche quando la sorgente non è secca." Ci si misura con l'impresa di raggiungere
i parametri stabiliti dalla Direttiva quadro UE 2000/60/CE, che impone a tutti
gli stati membri il conseguimento di buoni standard qualitativi del corpo idrico
e recupero dei costi, ma "persino l'ultima programmazione finanziaria ha
completamente ignorato la risorsa idrica: sembra che ci si stia muovendo adesso,
forse. Ma la situazione è molto grave," avverte Vera Corbelli, segretario
generale dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno, che abbraccia tutto
l'Appennino centro meridionale. "Da noi i pozzi rappresentano una questione
critica in uno scenario ancora più critico. Nella realtà del Mezzogiorno
permettono di attingere e trasferire a agricoltura e industria anche acqua di
altissima qualità. Scarsissimi controlli: obblighiamo gli enti locali al
monitoraggio e richiediamo i risultati; alcune amministrazioni li mandano, altre
no. La maggior parte degli scavi qui non è conforme," prosegue. "Come in altre
zone d'Italia, a causa di forti pompaggi si sono verificati cunei salini, acqua
di mare che ha corrotto le falde dolci, sia nel Salento che a Reggio Calabria,
nell'area del Fucino e nella piana del Volturno." Sulla base di emergenze
passate, c'è chi ha posto dei limiti: "Con la crisi idrica del 2002 la Regione
Umbria, salvo problemi igienico-sanitari, ha vietato di perforare a uso
domestico oltre i 30 metri" dicono dal Servizio Difesa e Gestione Idraulica
Provincia di Perugia. "Da allora vediamo autodichiarazioni a 29 metri e mezzo,
magari poi arrivano a 100. I lavori andrebbero fatti a norma, il direttore è un
geologo, emette una certificazione. Gli organi di controllo sono polizia
comunale e provinciale, carabinieri, corpo forestale: fanno quello che possono."
"Esistono ditte serie, ma quanti preferiscono risparmiare, rivolgendosi ai
pozzaroli che promettono: 'se non trovo l'acqua non mi paghi'," racconta Manuela
Ruisi, dell'Ordine Geologi del Lazio. "Non solo puoi distruggere una falda
incontaminata, ma con una pompa più forte rubi pure l'acqua al pozzo del vicino.
Ed è ben difficile che la polizia provinciale misuri le profondità calando il
freatimetro." Ligi o scorretti, i trivellatori non hanno albo professionale,
eppure manovrano un bene primario. "In Italia i parametri di riferimento per
l'utilizzo d'acqua sono di 50 miliardi di metri cubi l'anno: 30 miliardi vanno a
allevamento e agricoltura, 10 all'industria, 10 al potabile, per una superficie
di 300mila km quadrati," spiega Giorgio Cesari, segretario dell'Autorità di
Bacino del Fiume Tevere. " Nel bacino del Tevere negli ultimi 50 anni si sono
persi 2 miliardi di metri cubi d'acqua. Albano, Nemi, il Trasimeno, i bacini a
debole ricarica si sono ridotti, anche di alcuni metri, con pesanti conseguenze
sulla biodiversità. Qui siamo viziati, Roma è l'unica capitale al mondo
alimentata integralmente da acqua di sorgente prelevata in quota. L'incidenza
dei pozzi è difficile da valutare, ma indubbia. In teoria il privato emunge
circa 0.2-0,5 litri al secondo, 1,500-2000 metri cubi l'anno." Ma pozzi per
raffreddamento degli impianti arrivano a 50-100mila metri cubi l'anno. Il
fenomeno del cuneo salino ha toccato quasi tutte le aree costiere italiane, da
Castel Porziano all'Adriatico: "Già negli anni 80 a San Benedetto del Tronto
abbiamo avuto un importante problema di questo tipo, a causa di congelamento
ortofrutticolo e del pesce. E' stato contenuto realizzando acquedotti
industriali che prelevano dall'interno," racconta Giancarlo Casini segretario
dell'Autorità del bacino Interregionale del Tronto. La Regione Toscana intanto,
al pari dell'Umbria, porta avanti un progetto di monitoraggio delle falde
sotterranee (www. sir. toscana. it) e a breve si studieranno anche le sorgenti,
allo scopo di analizzare in tempo reale l'andamento delle risorse. Niente di
allegro nei dati recenti: quasi tutti i fiumi sono in grande sofferenza e sotto
il cosiddetto dmv-deflusso minimo vitale; se nel grossetano si è registrato un
deficit di precipitazioni del 47%, il Cecina è al di sotto dei valori storici di
riferimento. Gaia Checcucci, segretario generale dell'Autorità di Bacino del
fiume Arno, annuncia rispetto alla scorsa estate l'abbassamento del 10% di tutti
i bacini, con picchi del 40% in Val di Chiana e nel Casentino. Il futuro non
promette precipitazioni, se finora ci siamo creduti ricchi di pioggia, è tempo
di cambiare registro: "Adesso non va più sprecata nemmeno una goccia d'acqua."
PARLIAMO DELLA CACCIA. DOPPIETTA ASSASSINA.
La lunga lista di vittime.
Negli ultimi quattro anni oltre cento persone
hanno perso la vita e i feriti sono stati più di trecento. In mancanza di dati
ufficiali mese dopo mese l'Associazione Vittime della caccia mette insieme una
parziale lista di caduti.
42 morti e 94 feriti nel 2008/2009
31 morti e 86 feriti nel 2009/2010
25 morti e 75 feriti nel 2010-2011
16 morti e 48 feriti nel 2011-2012
La caccia uccide anche gli uomini. Vittime
innocenti di troppi fucili, scrive Margherita D’amico su “La Repubblica”. Pochi
ne parlano ma di pratica venatoria non muoiono soltanto gli animali. Negli
ultimi quattro anni, 114 morti e 303 feriti provocati dai pallini dei
cacciatori. Non più una faccenda legata alla difesa della fauna e del territorio
bensì qualcosa che tocca le persone e la loro incolumità. L'Italia è il primo
produttore europeo di armi sportivo-venatorie. E' la mattina del 13 ottobre e
Vincenzo Pulicicchio, settant'anni, è stato a raccogliere funghi. Torna all'auto
con il paniere pieno; cammina lungo la strada sterrata, frequentata da pedoni e
veicoli, che divide la provincia di Catanzaro da quella di Cosenza, quando
scorge un paio di esemplari irrinunciabili. Si sporge appena verso il cespuglio
e dall'alto un colpo di carabina gli trapassa la spalla, spezzandogli l'aorta.
Dissanguato, secondo l'Associazione Vittime della Caccia, è il nono dei 16 morti
e 48 feriti provocati dalle armi venatorie dalla pre-apertura di questa stagione
- 1 settembre - a oggi. Seguono di pochi giorni un ragazzo di sedici anni,
ucciso per errore vicino Pavia dall'amico di diciassette, e Onorio Dentella,
raggiunto nel Bergamasco dal proiettile del nipote inciampato durante una
battuta. I cacciatori hanno fatto strage fra i loro colleghi (12 morti e 34
feriti), ma anche tra persone che avevano il solo torto di passare davanti alla
canna dei loro fucili: 4 morti (2 bambini) e 14 feriti (3 bambini). Di caccia
allora non muoiono solo gli animali, ma non se ne parla mai: perché? A sentire i
parenti di molte vittime, gli scampati, diverse associazioni che si occupano di
diritti umani, un fitto velo di omertà copre questi fatti, che spostano l'asse
rispetto alla questione venatoria. Non più una faccenda legata alla difesa della
fauna e del territorio, roba da animalisti e ambientalisti, bensì qualcosa che
tocca le persone e la loro incolumità, e ha al centro gli strumenti con cui il
pericoloso hobby è praticato: le armi. Quanti cittadini italiani finiscono
dunque nei bersagli destinati agli animali? Quante armi, in virtù della caccia,
circolano fra la popolazione civile? In mancanza di dati ufficiali, richiesti
con insistenza alle istituzioni, ogni anno l'Associazione Vittime della Caccia
mette insieme una parziale lista dei caduti, dedotta da notizie di stampa locale
poi verificate. Se la stagione 2010-2011 risulta particolarmente tranquilla, 25
morti di cui uno solo non cacciatore e 75 feriti (subito prima del periodo
venatorio peraltro, vicino Altamura in provincia di Bari viene abbattuto da un
bracconiere don Francesco Cassol, addormentato nel sacco a pelo durante un
ritiro spirituale), il 2009/2010 registra 31 decessi e 86 feriti, e nel
2008/2009 i morti sono 42, di cui 27 estranei alla caccia, e i feriti globali
94. Negli ultimi quattro anni, (pur con una tendenza in calo) è una strage: 114
morti e 303 feriti. "Il nostro elenco si limita alle vittime dei fucili da
caccia, sia in ambito venatorio che, quando riusciamo a saperlo, extra
venatorio," spiega Daniela Casprini, presidente dell'associazione. "Escludiamo
incidenti come cadute, infarti, e pure i suicidi ameno che questi ultimi non
siano stati commessi da minorenni" Ciò nonostante la nota che si scorre sul sito
dedicato alle vittime della caccia è assai nutrita: il bambino di Lucca
impallinato al volto mentre gioca nel cortile di casa, le sorelline colpite
dalle schegge del fucile dello zio, l'automobilista incolonnato e raggiunto da
proiettile vagante, la segretaria comunale di Venosa colpita in giardino, il
giovane che a Siena stramazza in campo mentre gioca a pallone, quando a Palermo,
sempre con un fucile da caccia, un uomo spara dal balcone e uccide l'ex genero.
Oltre a essere, infatti, grazie all'articolo 842 del codice civile, gli unici
depositari del diritto a entrare nelle proprietà altrui a meno che non siano
recintate a norma (chiudere quattro ettari costa 15-20mila euro) potendo sparare
fino a 150 metri dalle abitazioni e a 50 dalle strade, i cacciatori sono anche
autorizzati a possedere un numero illimitato di fucili e carabine, con cui, al
contrario di chi ha un revolver per la difesa personale, possono esplodere colpi
anche in luoghi pubblici. In base alla direttiva 91/477/CEE e ss. mm. ii. a loro
è inoltre consentito di viaggiare con i fucili al seguito per tutti gli stati
membri con la carta europea armi da fuoco, e anche fuori dalla UE, grazie a
permessi rilasciati senza grandi difficoltà dalle questure. Come mai tanti
favori a una minoranza - si stima che i cacciatori siano poco più di 700mila -
non così amata dall'opinione pubblica, che oggi sembra più a favore di animali,
ambiente e vita pacifica? L'Italia è il primo produttore europeo di armi
sportivo-venatorie, copre circa il 60% dell'intera offerta comunitaria,
arrivando al 70% se si considerano solo le armi lunghe da caccia e tiro, ed è il
più importante paese esportatore nel mondo di armi sportive, commerciali e
munizioni, con aziende leader nel settore come Beretta e Fiocchi. "Secondo dati
Eurispes 2008 il comparto ha un giro d'affari valutato poco meno di 2 miliardi
di euro, invece per il Consorzio Armaioli Italiani nel 2010 l'indotto delle armi
civili realizzava più di 3 miliardi" dice Maurizio Simoncelli, vicepresidente
dell'Archivio Disarmo. "La Rete Italiana Disarmo indica oggi in Italia 10
milioni di armi detenute ufficialmente, di cui la metà presso civili. Tra le
categorie in possesso di licenza ci sono 50.000 guardie giurate, 178.000
sportivi del tiro a segno e circa 720.000 cacciatori." Spiegano dall'ANPAM,
Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili: "Non
sappiamo il numero esatto di armi da caccia vendute in Italia. Ma tutte le armi
sportive e civili prodotte qui o importate devono essere testate, approvate,
immatricolate e punzonate presso il Banco Nazionale di Prova. Conoscendo quindi
la nostra produzione totale, esportata per il 90%, e quante armi lunghe vengono
importate, stimiamo che ogni anno da noi ne vengano vendute intorno alle 50
mila, fra caccia e tiro sportivo." Ma quante e quali armi può avere un
cacciatore? Quali esami psicofisici occorre superare per utilizzarle? "Un
cacciatore possiede tutte le armi che vuole, ma fuori può portarne una sola, e
se la lascia incustodita è reato penale" dice Gianluca Dall'Olio presidente di
Federcaccia. A parte le carabine a canna rigata impiegate nella caccia agli
ungulati, cervidi, mufloni e cinghiali, potenti quanto armi da guerra e capaci
di raggiungere gittate di migliaia di metri "di regola si usano fucili ad anima
liscia, principalmente calibro 20 e calibro 16, e ai nostri 450mila tesserati
distribuiamo precisi vademecum." C'è chi dubita però che sia opportuno favorire
ancora la massiccia presenza di questi utensili fra la gente. Nel 2005 Christian
Maggi ha 19 anni, vive a Sori in provincia di Genova e una sera, rientrando in
motorino, si sente apostrofare dal terrazzo sopra il garage. "Vi siete
divertiti?" chiede il vicino, 81 anni. Christian alza gli occhi e l'ex
cacciatore gli scarica addosso 150 pallini. "Era in cura alla Asl, prendeva
farmaci antimaniacali, ma gli lasciavano in casa due fucili" racconta il
fratello Daniele. "Il processo penale si è chiuso subito, il gip non lo imputò
di tentato omicidio ma di lesioni personali aggravate. Ha sparato nella schiena
di Christian, inoperabile e costretto a convivere con tutto quel piombo in
corpo, e non si è fatto un giorno di fermo." Ed è ancora in una frazione di
Sori, a Sussisa, che nel 2010 incontrano la morte le guardie zoofile Elvio
Fichera e Paola Quartini, lei della LIPU, per mano di un cacciatore a cui stanno
notificando una sanzione per le pessime condizioni di detenzione dei suoi cani.
Renzo Castagnola uccide entrambi, quindi si toglie la vita. "Parliamo di
tragedie, ma non sottovalutiamo il disagio di dover tollerare estranei armati in
casa propria" commenta Danilo Selvaggi, responsabile dei rapporti istituzionali
della LIPU-Birdlife Italia. "Esiste inoltre una zona grigia fra caccia legale e
bracconaggio, popolata di cacciatori che commettono piccole ma continue
infrazioni." Tanti sicuramente sono ligi, ma c'è pure chi s'impone tagliando
reti, uccidendo per rappresaglia animali d'affezione; conversazioni sui blog
rivelano disinvoltura nell'ammettere frodi e abusi. Il clima è teso anche
altrove, lo raccontano gli otto volontari italiani e tedeschi del CABS-Committee
Against Bird Slaughter che nei Pirenei sono stati inseguiti dalle pallottole dei
bracconieri a cui avevano disattivato quasi 700 trappole illecite. Per le
guardie zoofile delle nostre associazioni più impegnate, fra cui Lipu, Lac, WWF,
non è mai una passeggiata. Il 18 ottobre a Lumezzane, Brescia, finito un
sequestro tre guardie del WWF tornano all'automobile, incustodita. Ripartiti,
scoprono che qualcuno ha provveduto a tagliare i tubi del liquido dei freni, e
solo un testacoda li salva da un burrone. Possibile che le istituzioni al
servizio del cittadino siano così evasive? A quanto pare il Ministero degli
Interni non è disponibile a trattare il tema, né sui guai combinati dalle armi
da caccia la Polizia di Stato sa fornire alcun dato, informazione, commento. E
dire che varie cronache riferiscono persino fenomeni di ricettazione di questi
strumenti. "Papà è morto alle 10.40, noi però siamo stati avvisati dai
carabinieri alle 14.10, quando la notizia già circolava su internet; non abbiamo
visto nemmeno un verbale" racconta Antonio Pulicicchio, figlio del cercatore di
funghi ucciso a Soveria Mannelli. "A chi ha sparato pare fosse stato sospeso il
patentino, si era unito lo stesso a una battuta al cinghiale e un amico medico
gli ha prestato la carabina. Ha centrato mio padre da dieci metri. A causa dei
cinghialai, squadre di rambo che si muovono anche in cinquanta, da queste parti
la gente ha paura a uscire di casa." Luciano Cerutti invece viene stroncato a 56
anni in Val di Cadore, novembre 2005, da un selecacciatore, autorizzato ai
cosiddetti abbattimenti di selezione fuori stagione. Femmine sterili, esemplari
malati che verrebbero individuati a colpo sicuro, anche se per i requisiti
minimi stabiliti dal Ministero della Salute con decreto 28/IV/1998 può rinnovare
il porto d'armi chi veda con un solo occhio e abbia 8/10 di acutezza corretti da
lenti e occhiali, chi decifri fonemi a non meno di sei metri di distanza pure
per mezzo di impianti acustici (sotto questa soglia, ci si può consolare con la
caccia in appostamento); nessuna prescrizione contro l'impossibilità di
deambulare, mentre in caso di minorazioni agli arti superiori si può ricorrere
alle protesi. "Mio marito era salito alla sua piccola baita, bruciava ramaglie,
l'uomo gli ha sparato da 55 metri. Non c'era nebbia, il fucile era dotato di
binocolo; cercava un cervo e ha centrato Luciano al cuore" racconta la vedova
Marcella Del Longo. "Non ha mai detto nemmeno 'mi dispiace'. Ho due figli, il
più piccolo ha perso il padre che adorava a tredici anni. Oggi a quell'uomo
vorrei chiedere: cos'ha visto, quella mattina? Non mi risulta che mio marito
avesse orecchie a punta, lunghe corna . Alcuni cacciatori hanno avuto il
coraggio di chiedermi com'era vestito, come se bisognasse andare in giro a palle
e strisce per non finire ammazzati." "Le vittime vanno contate nel modo giusto.
Ma per la sicurezza si può fare di più". Parla Osvaldo Veneziano, Presidente
Nazionale Arcicaccia, associazione venatoria con 51 mila iscritti in
un’intervista rilasciata a Gregorio Romeo su “La Repubblica”. Ammette che il
problema esiste, ma aggiunge: "Noi da sempre promuoviamo comportamenti che
riducano al minimo i rischi". Le regole sulla custodia delle armi. Evitare che
con la licenza di caccia si possano detenere armi da difesa personale. Ad un
certo punto, esasperato, ha fissato un cartellone fuori dal cancello di casa:
"Vendesi villa causa bracconieri". Dopodiché Cesare Scuderi, proprietario di un
baglio ai piedi dell'Etna, ha attaccato: "Non ne posso più, i cacciatori sparano
fin dentro la mia proprietà, senza rispettare la distanza minima dalle
abitazioni. Hanno già ucciso a fucilate 4 gatti di famiglia, e sicuramente non
per errore". Erano i primi di settembre e da allora, in Italia, 13 persone (fra
cui 4 "civili" che niente avevano a che fare con la caccia) sono state uccise
dal fuoco delle doppiette. I feriti hanno raggiunto quota 33. "Ma bisogna
contare le vittime nel modo opportuno - replica Osvaldo Veneziano, Presidente
Nazionale Arcicaccia, associazione venatoria con 51 mila iscritti -. A volte,
nei bilanci vengono inseriti anche i morti per altre cause, come infarti o
cadute mortali".
Non in questa lista, Presidente, che tiene conto
solo le vittime dei fucili. In quattro anni 111 persone sono state uccise dalle
doppiette. Come giudica questi numeri?
"Il tema della sicurezza va affrontato senza
pregiudizi. Il fatto che andando a 180 chilometri orari in autostrada si rischi
di fare un incidente mortale non può impedire che si vendano auto. Ma è vero:
sulla sicurezza si può fare di più. Infatti, Arcicaccia promuove da sempre
comportamenti in grado di ridurre al minimo ogni rischio".
Ad esempio?
"In casa si dovrebbe sempre custodire il fucile in
un armadio blindato, per evitare che l'arma venga utilizzata da mani inesperte.
Inoltre, il grilletto va tenuto bloccato con un'apposita sicura. In campagna,
invece, per i cacciatori si potrebbe rendere obbligatorio l'abbigliamento ad
alta visibilità, in modo da essere facilmente riconosciuti dagli escursionisti.
In Italia, inoltre, le doppiette devono rispettare delle distanze di sicurezza
dalle case e dalle strade. Il problema, però, è che la presenza di questi luoghi
non è mai segnalata. Andrebbero, dunque, aggiunti dei cartelloni che indichino
la prossimità di aree sensibili. Certo, non tutti i problemi si risolverebbero
così, ma almeno i rischi diminuirebbero".
Facciamo un passo indietro e parliamo delle
licenza di caccia. Lei non pensa che andrebbero rivisti i criteri per ottenerla?
"Partiamo dal presupposto che, prima di ricevere
la licenza di caccia, il candidato deve sottoporsi ad approfonditi esami
psicofisici e deve superare un test a risposta multipla sulle specie cacciabili
e sull'uso dell'arma. Tuttavia, io cambierei alcune cose. Ad esempio, non trovo
necessario che la licenza di caccia autorizzi anche la detenzione di armi corte,
palesemente inutili per l'attività venatoria. Bisogna riconoscere che,
soprattutto in passato, molti hanno utilizzato la licenza di caccia - più facile
da ottenere rispetto a quella per la difesa personale - per detenere armi con lo
scopo di proteggere i propri beni privati. Infine, sarebbe giusto rendere
obbligatorio un serio corso di tiro da svolgere al poligono, prima del rilascio
della licenza. Avere cacciatori più abili a maneggiare i fucili aumenterebbe di
certo la sicurezza".
Non pensa che anche le associazioni venatorie
potrebbero lavorare di più per sensibilizzare i cacciatori?
"La maggior parte dei cacciatori è molto educata.
Ma è chiaro, si può sempre fare di più. L'importante è non affrontare il
problema in chiave ideologica. Arcicaccia, diversamente dalle altre associazioni
venatorie, cerca di cooperare con gli animalisti. Con Legambiente, ad esempio,
abbiamo attivato diversi progetti di collaborazione in varie parti d'Italia. In
generale, apprezziamo le persone in buona fede. Tuttavia, capita che
l'ambientalismo diventi radicale o, molto peggio, strumentale. Magari cavalcato
da certi politici solo a fini elettoralistici...".
Ha in mente qualche nome in particolare?
"Certo, quello dell'ex ministro Michela Vittoria
Brambilla. Oggi dalla parte degli animali ma silente quando - tanto per fare un
esempio - il Presidente del Consiglio Berlusconi regalò un pregiato fucile da
caccia al presidente russo Vladimir Putin".
PARLIAMO DI SCIENZIATI CON LA TOGA.
Una barbarie le toghe che fanno gli scienziati.
"Grazie a magistrati senza responsabilità e irresponsabili stiamo diventando un
Paese di barbari", scrive Franco Battaglia su “Il Giornale”. Grazie a magistrati
senza responsabilità e irresponsabili stiamo diventando un Paese di barbari.
Barbarie è stato l'arresto di un imprenditore di 86 anni accusato di aver ucciso
adulti e bambini con le emissioni della sua acciaieria. Abbiamo già scritto che
il rapporto epidemiologico di cui s'è servita la magistrata è scientificamente
carente e redatto da signori che già in passato si erano distinti per puntare il
dito contro l'inesistente inquinamento elettromagnetico. Questi signori, anziché
essere oggetti di una indagine che valuti i presupposti del procurato allarme,
sono i consulenti della nostra magistratura. I dati ci dicono che a Taranto non
si muore né si contrae tumore più che altrove in Italia, eppure è da due giorni
che tutte le agenzie di stampa strillano perché un rapporto, chiamato «shock»,
rivelerebbe che a Taranto si sarebbe riscontrato un «eccesso del 419% di
mortalità maschile per mesiotelioma pleurico». Soltanto chi conosce solo la
statistica di Trilussa si allarma. In tutta la Puglia, negli 8 anni 1993-2001,
vi furono 197 maschi con mesiotelioma pleurico certo, di cui 13 nel 1993, 32 nel
1996, e 20 nel 2001. Diremmo che nel 1996, in Puglia, ve ne fu il 146% in più
che nel 1993? Lo diremmo se fossimo Trilussa o abituati a procurare, impuniti,
allarme, anziché riconoscere che sono numeri troppo piccoli per fare quella
statistica. (Peraltro, i Trilussa avrebbero anche dovuto dire che nel 2001 ve ne
furono il 38% in meno che nel 1996, ma questo non fa notizia). Dicono che il
colpevole sarebbe il benzopirene misurato con concentrazioni di 1.8 nanogrammi
per metro cubo, ma sembra che ignorino che chi fuma una sola sigaretta al giorno
di benzopirene ne aspira 20 di nanogrammi. Ora, siccome ci sono gli elementi per
rassicurare (cioè, a dispetto delle frottole di questi giorni, non è vero che a
Taranto si muore o ci si ammala di più che altrove in Italia) è nostro dovere
rassicurare. Rischiando così di essere sbattuti in galera da chi ha il potere -
impunibile se sbaglia - di sbatterci in galera. E questa è barbarie. Come quella
che ha fatto condannare a 6 anni di galera alcuni stimati uomini di scienza -
uomini che dovremmo tenere in conto come nostro fiore all'occhiello - per
omicidio colposo plurimo. Su questo dobbiamo però essere precisi, perché a
ridere del fatto che siano stati condannati per non aver previsto il terremoto,
non si rende giustizia della barbarie in atto. E, soprattutto, si
giustificherebbe la barbarica condanna nel momento stesso in cui essa dovesse
rivelare motivazioni diverse da quelle per le quali oggi si ride sgomenti. Non è
per non aver previsto il terremoto che sono stati condannati, né di questo erano
accusati, ma - hanno dichiarato i pubblici ministeri - «per una carente
valutazione degli indicatori di rischio e una errata informazione». Insomma, i
condannati sono colpevoli di avere rassicurato la gente. Siccome le
dichiarazioni del professor De Bernardinis sono ascoltabili in rete, le riporto
testuali: «Dobbiamo mantenere uno stato d'attenzione senza avere uno stato
d'ansia, capendo che abbiamo da affrontare situazioni per le quali dobbiamo
essere sì, pronti, ma anche sereni di poter vivere la nostra vita quotidiana».
Per la magistratura italiana questo sarebbe omicidio colposo plurimo. De
Bernardinis, invece, non ha fatto altro che il proprio dovere: rassicurare. Non
per minimizzare il terremoto (che è stato sì devastante, ma solo col senno di
poi) ma perché di fronte all'ignoranza (nessuno può prevedere né tempi né
intensità dei sismi) il primo dovere è non creare i presupposti per un panico
destinato ad avere, quello sì con certezza, conseguenze devastanti. Nel momento
in cui scrivo un terremoto di magnitudo 3 è stato registrato sul Pollino:
evacuerà la magistratura Castrovillari? La magistratura o, più precisamente,
alcuni magistrati sono il nostro problema: ignoranti di statistica, di gestione
dei rischi, di scienza, malati di protagonismo, imbevuti di preconcetti
ideologici, sono liberi di muoversi senza freno e senza responsabilità. A
cominciare dal fatto che possano far conoscere le motivazioni di una sentenza
non contestualmente alla stessa, lasciando così il dubbio che possa essere
aggiustata a seconda delle reazioni conseguenti. Una barbarie. Che non giova né
al Paese né alla Magistratura stessa.
Travaglio. C'è un solo uomo in Italia che difende
il giudice dell'Aquila. Indovinate chi? Il vicedirettore del Fatto Quotidiano
sulla sentenza di condanna alla Grandi Rischi per il sisma del 2009: la colpa è
dei giornali pecoroni e degli scienziati che non fecero gli scienziati, scrive
“Libero Quotidiano”. Tutti contro pm e giudice dell'Aquila che ha condannato a
sei anni i sismologi colpevoli di non aver dato l'allarme per il terremoto
dell'aprile 2009. Politici, giornali, comunità scientifica italiana ed
internazionale. I membri della commissione Grandi Rischi, falcidiata dalla
sentenza di primo grado, si è dimessa in blocco. C'è una sola persona, giudici a
parte, fuori dal coro. Secondo questa persona la colpa delle polemiche e dello
scandalo non è della sentenza, appunto, ma dei politici e dei giornali. E magari
pure degli scienziati che, sottinteso, si fanno traviare da politici e giornali.
Questa persona, manco a dirlo, è Marco Travaglio, vicedirettore del Fatto
Quotidiano. Stampa pecorona - Nel suo editoriale sul numero di mercoledì 24
ottobre, l'editorialista più manettaro che c'è si scatena. Sotto il titolo
Rischi per fiaschi mette alla berlina la stampa pecorona non in grado di leggere
le motivazioni della sentenza, che ancora non sono state depositate
(naturalmente non le può avere lette nemmeno lui, ma questo non ha importanza),
e in balia dei sentimenti di pancia. Po via alla filippica: "A nessun magistrato
è mai saltato in mente di accusarli (i sismologi) di non aver previsto il
terremoto: semmai di aver previsto che il terremoto non ci sarebbe stato, dopo
una finta riunione tecnica (durata 45 minuti) a L'Aquila, 'approssimativa,
generica e inefficace', in cui non si valutarono affatto i rischi delle 400
scosse in quattro mesi di sciame sismico. E alla fine, di aver fornito
'informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, le cause, la
pericolosità e i futuri sviluppi dell'attività sismica in esame'". Travaglio
ricorda che per questa sottovalutazione del rischio almeno 29 aquilani non
uscirono di casa, come in genere facevano negli ultimi mesi, la sera del 6
aprile e finirono sepolti vivi. Attacchi a Bertolaso - Quindi il vicedirettore
va all'attacco di Franco Bertolaso, ex capo della Protezione civile: "Che lo
scopo della riunione fosse tutto politico e per nulla scientifico, l'aveva
confidato a una funzionaria Bertolaso alla vigilia: 'Vengono i luminari, è più
un'operazione mediatica, loro diranno: è una situazione normale, non ci sarà mai
la scossa che fa male'. E, prim'ancora che i tecnici si riunissero, dichiarò:
'Non c'è nessun allarme in corso'". E ricorda come "nessuno verbalizzò nulla (il
verbale, debitamente ritoccato, fu firmato in fretta e furia sei giorni dopo, a
sisma avvenuto)". Conclusione consequenziale: gli scienziati, allora, non hanno
fatto gli scienziati, proprio come in Italia i politici non fanno i politici e i
giornalisti i giornalisti. Mentre i giudici, questo lo diciamo noi, non
sbagliano mai.
TERREMOTO DELL’AQUILA: CONDANNATI I MEMBRI
DELLA “COMMISSIONE GRANDI RISCHI”.
Il resoconto su una sentenza epocale raccontato da
tanti punti di vista. Terremoto dell'Aquila, condannati membri commissione
Grandi rischi. Ricordate il terremoto che rase al suolo L'Aquila nel 2009?
Secondo la giustizia italiana poteva essere previsto. Condannati a sei anni
tutti i membri della commissione Grandi rischi. Così scrive Raffaello Binelli su
“Il Giornale” Dopo trenta udienze il giudice del tribunale dell’Aquila ha
condannato a sei anni di reclusione i membri della Commissione Grandi rischi che
parteciparono alla riunione del 31 marzo 2009 sugli eventi sismici all’Aquila,
rassicurando i cittadini. L’accusa aveva chiesto la condanna a quattro anni. La
difesa aveva puntato, invece, sulla impossibilità di prevedere i terremoti,
posizione sostenuta da diversi ricercatori internazionali. Nella sentenza di
condanna il giudice ha disposto, a titolo risarcitorio, una provvisionale che
sfiora i sei milioni di euro per le parti civili di cui oltre due milioni di
euro immediatamente esecutiva. Il giudice Marco Billi ha ritenuto i sette membri
della commissione - l’organo tecnico-consultivo della presidenza del Consiglio,
nella sua composizione del 2009 - tutti colpevoli di omicidio colposo plurimo e
lesioni colpose. Ecco chi sono i condannati: Franco Barberi, presidente vicario
della Commissione Grandi rischi; Bernardo De Bernardinis, già vicecapo del
settore tecnico del Dipartimento della protezione civile; Enzo Boschi, all’epoca
presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; Giulio Selvaggi,
direttore del Centro nazionale terremoti; Gianmichele Calvi, direttore Eucentre;
Claudio Eva, ordinario di Fisica all’Università di Genova; Mauro Dolce,
direttore Ufficio rischio sismico della protezione civile. I pm: volevamo solo
capire i fatti. "Non ci sono commenti da fare - dice il pm Fabio Picuti - se non
quelli del giudice che ha letto la sentenza: tutto il filo conduttore del
processo non era la ricerca di colpevoli, ma quella di capire i fatti, perché
noi con il compianto procuratore capo, Alfredo Rossini, volevamo solo capire i
fatti. L’Aquila - ha spiegato - ha consentito che si tenesse questo processo
delicato e si arrivasse a sentenza". Gli avvocati: ci saranno grosse
ripercussioni. "Una sentenza sbalorditiva e incomprensibile, in diritto e nella
valutazione dei fatti", ha detto l’avvocato Marcello Petrelli, difensore del
professor Franco Barberi. "Una sentenza che non potrà che essere oggetto di
profonda valutazione in appello". "Questa sentenza avrà grosse ripercussioni
sull’apparato della pubblica amministrazione. Nessuno farà più niente", ha
evidenziato l’avvocato Filippo Dinacci, difensore dell’ex vicecapo della
Protezione civile e attuale presidente dell’Ispra, Bernardo De Bernardinis, e
del direttore del servizio sismico del dipartimento della Protezione civile,
Mauro Dolce. De Bernardinis: innocente davanti a Dio e agli uomini. Uno dei
condannati, il professor De Bernardinis, commenta così la sentenza: "Mi ritengo
innocente di fronte a Dio e agli uomini. La mia vita da domani cambierà, ma se
saranno dimostrate le mie responsabilità in tutti i gradi di giudizio - ha
aggiunto - le accetterò fino in fondo". "Il processo ha sviscerato molte cose
che dovranno trovare conferma negli altri gradi di giudizio". Poi ha aggiunto:
"Non c’erano le condizioni per fare scelte diverse, quelle erano le scelte che
potevo fare. Io avrei voluto evitare non solo questi morti, ma anche quelli del
’94 in Piemonte e in Irpinia". Boschi: sono avvilito e disperato. L'ex
presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Enzo
Boschi: "Sono avvilito, disperato. Pensavo di essere assolto. Ancora non capisco
di cosa sono accusato". I geologi: ingiuste accuse al mondo scientifico. Se la
sentenza "dovesse riguardare la mancata previsione del sisma, ciò
significherebbe mettere sotto accusa l’intera comunità scientifica che, ad oggi,
in Italia e nel mondo, non ha i mezzi per poter prevedere i terremoti", ha detto
il presidente del Consiglio dei geologi, Gianvito Graziano. "Tuttavia - precisa
- penso che l’accusa non vertesse sulla mancata previsione del terremoto, bensì
su un comportamento omissivo della commissione rispetto ad una situazione di
rischio, sottolineando comportamenti non diligenti. Se di ciò si tratta -
conclude il presidente dei geologi - è necessario leggere attentamente la
sentenza per capire in cosa, esattamente, i membri della Commissione Grandi
rischi abbiano peccato". Il sindaco dell'Aquila: vogliamo giustizia per il dopo.
Quando nell’assemblea a piazza Duomo all’Aquila, convocata dal sindaco Massimo
Cialente per parlare della restituzione delle tasse, è arrivata la notizia della
sentenza è partito un lungo applauso. Cialente ha spiegato che "volevamo questa
sentenza per capire, ma il dramma non si cancella. Il comune si era costituito
parte civile per chiedere giustizia: ma ora la giustizia la vogliamo anche per
tutto quello che è successo dopo il 6 aprile". Pezzopane: finalmente giustizia.
Stefania Pezzopane, che il 6 aprile del 2009 ricopriva la carica di Presidente
della Provincia dell’Aquila, è soddisfatta: "Ci voleva coraggio e i giudici ne
hanno avuto. Finalmente un po' di giustizia per L’Aquila. Avevo già denunciato
l’inganno e la superficialità dei quali si era resa colpevole la Commissione
Grandi Rischi. Oggi più che mai sento tutto il dolore per l’inganno che abbiamo
subìto". Schifani: sentenza imbarazzante. "È una sentenza un po' strana e un po'
imbarazzante" per cui "chi sarà chiamato in futuro a coprire questi ruoli si
tirerà indietro". Lo ha detto il presidente del Senato, Renato Schifani a Porta
a Porta la sentenza. "Bisogna vedere le motivazioni", ha aggiunto, sottolineando
di augurarsi che da lì "emergano scelte inoppugnabili da parte dei magistrati in
questa sentenza".
Storica condanna per i membri della commissione
Grandi rischi: sei anni di reclusione per tutti gli imputati, sei esperti e il
vice direttore della protezione civile, Bernardo De Bernardinis. Così scrive “Il
Corriere della Sera”. È questa la decisione del giudice unico Marco Billi che ha
condannato i componenti della commissione Grandi rischi, in carica nel 2009. I
sette avevano rassicurato gli aquilani circa l'improbabilità di una forte scossa
sismica che invece si verificò alle 3.32 del 6 aprile 2009. L'accusa nei loro
confronti era di omicidio colposo, disastro e lesioni gravi, per aver fornito
rassicurazioni alla popolazione aquilana, in una riunione avvenuta solo una
settimana prima del sisma. I pm hanno chiesto per loro la condanna a quattro
anni di carcere, mentre i legali degli imputati hanno chiesto per tutti la piena
assoluzione. Grande era l'attesa all'Aquila sulle sorti degli imputati. La
sentenza è stata letta dal giudice unico Marco Billi alle 17 circa, dopo quattro
ore di camera di consiglio. A intervenire per ultimo l'avvocato difensore
Antonio Pallotta, legale di Giulio Selvaggi. Sette gli esperti e scienziati
imputati, accusati di aver dato ai residenti avvertimenti insufficienti del
rischio sismico. Precisamente si contesta loro di aver dato «informazioni
inesatte, incomplete e contraddittorie» sulla pericolosità delle scosse
registrate nei sei mesi precedenti al 6 aprile 2009. La difesa ha puntato sulla
impossibilità di prevedere i terremoti, posizione sostenuta da ricercatori
internazionali. Tutta la comunità scientifica si interroga ora su un punto: le
rassicurazioni eccessive possono indurre la gente ad adottare comportamenti
rischiosi, ma può un errore di comunicazione valere una condanna per omicidio
colposo? Il giudice ha ritenuto i sette membri della commissione tutti
colpevoli di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. A Franco Barberi, Enzo
Boschi, Mauro Dolce, Bernardo De Bernardinis, Giulio Selvaggi, Claudio Eva e
Gianmichele Calvi sono state concesse le attenuanti generiche. Oltre alla
condanna a sei anni, sono stati condannati anche all'interdizione perpetua dai
pubblici uffici. È «una sentenza sbalorditiva e incomprensibile in diritto e
nella valutazione dei fatti» ha commentato l'avvocato Marcello Petrelli,
difensore di Franco Barberi. «Una sentenza che - ha aggiunto - non potrà che
essere oggetto di profonda valutazione in appello». Si è detto «avvilito,
disperato» Enzo Boschi, ex presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv). «Pensavo di essere assolto - ha aggiunto - ancora non
capisco di cosa sono accusato». «Mi ritengo innocente di fronte a Dio e agli
uomini» ha aggiunto Bernardo De Bernardinis, ex vicecapo della Protezione civile
e attuale presidente dell'Ispra. «La mia vita da domani cambierà, ma se saranno
dimostrate le mie responsabilità in tutti i gradi di giudizio - ha aggiunto - le
accetterò fino in fondo». Levata di scudi, sulla sentenza, da parte dei
professori del mondo scientifico: «È la morte del servizio prestato dai
professori e dai professionisti allo Stato - ha detto il fisico Luciano Maiani,
attuale presidente della commissione Grandi rischi - non è possibile fornire una
consulenza in termini sereni, professionali e disinteressati sotto questa folle
pressione giudiziaria e mediatica. Questo non accade in nessun altro Paese al
mondo». Sorpreso e amareggiato anche il mondo politico. «È una sentenza un po'
strana e un po' imbarazzante: chi sarà chiamato in futuro a coprire questi ruoli
si tirerà indietro» ha detto il presidente del Senato, Renato Schifani. «Questa
sentenza è la morte dello stato di diritto e una follia allo stato puro - ha
commentato il leader Udc, Pier Ferdinando Casini - . L'obbligo previsionale in
ordine a eventi tellurici è sancito». «Le sentenze vanno sempre rispettate - ha
puntualizzato Pierluigi Bersani - ma l'importante è che prosegua la solidarietà.
La giustizia deve fare il suo corso ma anche la ricostruzione deve farlo».
Gli scienziati su “Il Corriere della Sera”: «ora
avremo paura di esprimere opinioni». Dal mondo accademico è una levata di scudi,
appresa la notizia della condanna dei sette scienziati per le omissioni e la
sottovalutazione del rischio per il terremoto dell'Aquila. Se i sei condannati
ondeggiano tra sbigottimento e stupore, è netto il commento del fisico Luciano
Maiani, attuale presidente della commissione Grandi rischi, quella appunto messa
all'indice dalla sentenza del tribunale «È la morte del servizio prestato dai
professori e dai professionisti allo Stato: non è possibile fornire una
consulenza in termini sereni, professionali e disinteressati sotto questa folle
pressione giudiziaria e mediatica. Questo non accade in nessun altro Paese al
mondo»»
GLI SCIENZIATI NON VORRANNO ESPRIMERE PIU' LA LORO
OPINIONE? E pure l'INGV (L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)
esprime tutta la sua preoccupazione per la sentenza: dell'istituto faceva
infatti parte l'ex presidente Enzo Boschi. Secondo l'Istituto: «La sentenza di
condanna di L’Aquila rischia, infatti, di compromettere il diritto/dovere degli
scienziati di partecipare al dialogo pubblico tramite la comunicazione dei
risultati delle proprie ricerche al di fuori delle sedi scientifiche, nel timore
di subire una condanna penale. Quale scienziato vorrà esprimere la propria
opinione sapendo di poter finire in carcere?»
«IMPOSSIBILE PREVEDERE UN TERREMOTO» - Secondo
quanto affermato dalla letteratura scientifica internazionale, prosegue la nota
dell'Ingv: «allo stato attuale è impossibile prevedere in maniera deterministica
un terremoto. Di conseguenza, chiedere all’INGV di indicare come, quando e dove
colpirà il prossimo terremoto non solo è inutile, ma è anche dannoso perché
alimenta in modo ingiustificato le aspettative delle popolazioni interessate da
una eventuale sequenza sismica in atto. L’unica efficace opera di mitigazione
del rischio sismico è quella legata alla prevenzione, all’informazione e
all’educazione della popolazione in cui istituzioni scientifiche, Protezione
Civile e amministrazioni locali devono svolgere, in modo coordinato, ognuna il
proprio ruolo».
TERREMOTO. L'Aquila, Grandi rischi: 6 anni agli
imputati. Maiani: "Nella sentenza profondo errore". Così scrive “La Repubblica”.
Il verdetto, compresa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, colpisce i
sette membri della Commissione all'epoca in carica, che avrebbe fornito false
informazioni circa l'improbabilità della forte scossa che la notte del 6 aprile
2009 causò la morte di 309 persone. L'accusa aveva chiesto quattro anni di
reclusione. Condannati a sei anni per aver dato ai residenti avvertimenti
insufficienti sul rischio sismico. Questa la sentenza per i sette componenti
della commissione Grandi rischi, in carica nel 2009, che avevano rassicurato gli
aquilani circa l'improbabilità di una forte scossa sismica, che invece si
verificò alle 3,32 del 6 aprile 2009. L'accusa aveva chiesto quattro anni, ma
Franco Barberi, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Bernardo De Bernardinis, Giulio
Selvaggi, Claudio Eva e Gianmichele Calvi, sono stati giudicati colpevoli di
omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Nonostante la concessione delle
attenuanti generiche, sono stati condannati anche all'interdizione perpetua dai
pubblici uffici. "È la morte del servizio prestato dai professori e dai
professionisti allo Stato" è stato il commento senza mezzi termini da parte del
fisico Luciano Maiani, attuale presidente della commissione Grandi rischi, che
ha aggiunto: "Non è possibile fornire allo Stato una consulenza in termini
sereni, professionali e disinteressati sotto questa folle pressione giudiziaria
e mediatica. Questo non accade in nessun altro Paese al mondo''. C'è "un
profondo errore" nella sentenza che oggi ha condannato a sei anni i membri della
commissione Grandi rischi, ha sottolineato Maiani. Le persone condannate oggi
"sono professionisti che hanno parlato in buona fede e non spinte da interessi
personali. Sono persone - aggiunge - che hanno sempre detto che i terremoti non
sono prevedibili". A fronte della loro condanna, prosegue, "non c'è nessuna
indagine su chi ha costruito in maniera non adeguata ad una zona antisismica.
Questo è un profondo sbaglio". Il mondo politico non esprime un giudizio unanime
sulla sentenza: per il presidente del Senato, Renato Schifani, si tratta di "una
sentenza un po' strana e imbarazzante. Pone un problema serio e grave in
relazione al quale chi sarà chiamato in futuro a ricoprire questi ruoli si farà
da parte", ha dichiarato a Porta a Porta. "Le sentenze vanno sempre rispettate e
la giustizia deve fare il suo corso. Ma è importante anche dare solidarietà a
queste terre ed è per questo che tornerò ancora a visitarle'', ha detto il
segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. Non è d'accordo con il verdetto l'ex
ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi: ''Ulteriore sentenza angosciante
destinata a inibire assunzioni di responsabilità da parte di tecnici e
scienziati e a determinare ingiustificati allarmismi e impraticabili proposte di
ricorrente evacuazione''. Anche per il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini,
la sentenza è ''una follia allo stato puro''. ''Credo che qualsiasi
professionista - ha aggiunto Casini - di fronte a una sentenza di questo genere
si tirerà indietro. Così è sancito l'obbligo professionale a non sbagliare''. Il
giudice unico Marco Billi si è ritirato in Camera di consiglio alle 12,30 dopo
l'ultimo intervento dell'avvocato difensore Antonio Pallotta, legale di Giulio
Selvaggi. Gli imputati hanno aspettato quattro ore prima di avere il verdetto.
Precisamente si contestava loro di aver dato "informazioni inesatte, incomplete
e contraddittorie" sulla pericolosità delle scosse registrate nei sei mesi
precedenti al 6 aprile 2009. La difesa ha puntato sulla impossibilità di
prevedere i terremoti, posizione sostenuta da ricercatori internazionali. "Una
sentenza sbalorditiva e incomprensibile, in diritto e nella valutazione dei
fatti", ha commentato l'avvocato Marcello Petrelli, difensore del professor
Franco Barberi, "non potrà che essere oggetto di profonda valutazione in
appello". Ammonta a 7,8 milioni di euro il risarcimento disposto dal giudice. A
questa cifra vanno sommate le spese giudiziarie delle parti civili che ammontano
a oltre 100 mila euro. Si dice "avvilito e disperato" Enzo Boschi, ex presidente
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), nella prima reazione
a caldo dopo la sentenza. "Sono frastornato, devastato, ero convintissimo che
sarei stato assolto perché non ho mai rassicurato nessuno. Sfido chiunque a
trovare scritta, detta a voce, su tv o da qualsiasi parte una mia rassicurazione
concernente il terremoto dell'Aquila", ha sottolineato Boschi. "E questo perché
- aggiunge - nessuno è in grado di prevedere terremoti quindi io non rassicuro
nessuno. La qualità degli edifici in Italia è tale che anche una piccola scossa
può causare un disastro". "Mi ritengo innocente di fronte a Dio e agli uomini",
ha detto il professor Bernardo De Bernardinis, ex vicecapo della Protezione
civile e attuale presidente dell'Ispra. "La mia vita da domani cambierà, ma se
saranno dimostrate le mie responsabilità in tutti i gradi di giudizio - ha
aggiunto - le accetterò fino in fondo". ''Non mi aspettavo sei anni, pensavo che
la condanna sarebbe stata inferiore. Non provo nessun godimento, nessuna
sentenza ci ripaga di quanto accaduto'' ha detto Giampaolo Giuliani, il tecnico
di ricerca che studia il radon come precursore sismico e che nei giorni
precedenti alla tragedia aveva lanciato l'allarme. Nella sua replica il pm,
prima che il giudice Marco Billi si chiudesse in Camera di consiglio, ha
ricordato Guido Fioravanti, figlio di Claudio, avvocato e giudice tributario,
oltre che una delle 309 vittime del sisma del 6 aprile. Morto nella sua casa in
via Campo di Fossa, dietro alla Villa Comunale, crollata insieme a molte altre.
"Noi crediamo alle persone offese - ha detto il titolare dell'accusa in aula -.
Questo processo nasce perché è venuto da me Guido Fioravanti e mi ha detto: 'mio
padre è morto perché ha creduto allo Stato'. Questo è stato il punto di
partenza". Per Guido Fioravanti quello di oggi "non è stato un processo alla
scienza", ma a "ciò che ha detto la scienza e che ha mutato in noi aquilani
l'approccio al terremoto". Quella notte, Guido si era sentito con la madre verso
le 23, subito dopo la prima scossa. "Mi ricordo la paura che usciva dalle sue
parole. In altri tempi sarebbero scappati ma quella notte, assieme a mio padre,
si sono ripetuti quello che avevano sentito dalla commissione Grandi rischi. E
sono rimasti lì". È preoccupato per le conseguenze che la condanna può avere il
direttore dell'Istituto di geoingegneria del Cnr, Paolo Messina: "Una condanna
durissima, e ciò che preoccupa sono le conseguenze che tale pronunciamento potrà
avere: non vorrei passasse il messaggio che i terremoti si possono prevedere,
perché ciò è impossibile. In linea di principio, allora, bisognerebbe evacuare
l'intera popolazione ad ogni scossa?". La sentenza con la quale sono stati
condannati i componenti della Commissione Grandi Rischi, "costituisce un
precedente, in grado di condizionare in modo determinante il rapporto tra
esperti scientifici e decisori,non solo nel nostro Paese", è scritto in una nota
dello stesso istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che esprime "tutto
il suo rammarico e la sua preoccupazione" per la sentenza di primo grado. ''Ci
voleva coraggio e i giudici ne hanno avuto. Finalmente un po' di giustizia per
L'Aquila''. È soddisfatta Stefania Pezzopane che il 6 aprile del 2009 ricopriva
la carica di Presidente della Provincia dell'Aquila, dopo aver appreso l'esito
della sentenza. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha spiegato che
''volevamo questa sentenza per capire, ma il dramma non si cancella. Il comune
si era costituito parte civile per chiedere giustizia: ma ora la giustizia la
vogliamo anche per tutto quello che è successo dopo il 6 aprile''. ''Sono pochi,
hanno fatto bene, benissimo''. In piazza Duomo a L'Aquila i cittadini aquilani
riuniti sotto al tendone per ascoltare il sindaco Cialente su tasse e tributi
hanno così commentato a caldo le notizie sulla sentenza.
Le intercettazioni riportate da Giuseppe Caporale
su “La Repubblica”. L'Aquila, esperti a consulto sul terremoto: "Ma è soltanto
un'operazione mediatica". E' la fine di marzo 2009, la città abruzzese da
quattro mesi è ostaggio di uno sciame sismico e una nuova scossa di magnitudo
4.1 Richter ha appena fatto crescere la paura. Bertolaso racconta al telefono
che sta organizzando una riunione di tecnici al solo scopo di tranquillizzare la
popolazione. E sette giorni dopo, la tragedia. La riunione straordinaria della
Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile, che si svolse all'Aquila
durante lo sciame sismico sette giorni prima della scossa fatale, fu soltanto
uno show. Una "operazione mediatica". I più importanti scienziati italiani
furono inviati dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio (dell'allora
governo Berlusconi) nella città sotto shock per le quattrocento scosse di
terremoto in quattro mesi solo per "tranquillizzare la popolazione", per
comunicare alla pubblica opinione che si era di fronte a un "fenomeno normale".
Lo rivela proprio Guido Bertolaso in un'intercettazione. Un'intercettazione
contenuta tra le duemila e duecento conversazioni registrate dai carabinieri del
Ros di Firenze, formalmente inserita negli atti del processo sullo scandalo G8
alla Maddalena, ma che non fu mai trascritta. E che adesso Repubblica è in grado
di documentare e di farvi ascoltare. E' il pomeriggio del 30 marzo 2009. Da
quattro mesi la città dell'Aquila balla sotto i colpi dello sciame sismico. Alle
15.38 arriva un'altra forte scossa (magnitudo 4.1 della scala Richter). In città
scoppia di nuovo il panico e scatta ancora una volta l'allerta per la Protezione
Civile. La sera stessa, Bertolaso chiama Daniela Stati, assessore regionale alla
Protezione Civile dell'Abruzzo. "Sono Guido Bertolaso...". La Stati: "Che
onore...". Bertolaso: "Ti chiamerà De Bernardinis il mio vice, perché gli ho
detto di fare una riunione lì all'Aquila domani, su questa vicenda di questo
sciame sismico che continua, in modo da zittire subito qualsiasi imbecille,
placare illazioni, preoccupazioni... Eccetera...". Ancora Bertolaso: "La cosa
importante è che domani... Adesso De Bernardinis ti chiama per dirti dove volete
fare la riunione. Io non vengo... ma vengono Zamberletti (l'unico che poi non
parteciperà, ndr), Barberi, Boschi, quindi i luminari del terremoto in Italia.
Li faccio venire all'Aquila o da te o in prefettura... Decidete voi, a me non me
ne frega niente... In modo che è più un'operazione mediatica, hai capito? Così
loro, che sono i massimi esperti di terremoti, diranno: è una situazione
normale... sono fenomeni che si verificano... meglio che ci siano cento scosse
di quattro scala Richter piuttosto che il silenzio, perché cento scosse servono
a liberare energia e non ci sarà mai la scossa quella che fa male... Hai capito?
(...) Tu parla con De Bernardinis e decidete dove fare questa riunione domani,
poi fatelo sapere (alla stampa, ndr) che ci sarà questa riunione. E che non è
perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la
gente. E invece di parlare io e te... facciamo parlare i massimi scienziati nel
campo della sismologia". La Stati: "Va benissimo...". E, in effetti, il giorno
dopo gli esperti andranno all'Aquila e ripeteranno esattamente le parole dette
da Bertolaso alla Stati al telefono. La riunione durerà appena sessanta minuti e
al termine si terrà una conferenza stampa. De Bernardinis parlerà ai microfoni
di una situazione "normale...". "... La comunità scientifica conferma che non
c'è pericolo, perché c'è uno scarico continuo di energia. La situazione è
favorevole..." ."Si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale". A
leggerla e ad ascoltarla ora, questa intercettazione, quasi tre anni dopo la
tragedia, mentre è in corso all'Aquila un processo nei confronti proprio della
Commissione Grandi Rischi, accusata di omicidio colposo plurimo e disastro
colposo - per non aver correttamente valutato in quella riunione lo sciame
sismico in atto - quella di Bertolaso suona come un'ammissione. Una confessione.
Questa intercettazione - fino ad oggi sconosciuta alla Procura dell'Aquila -
verosimilmente cadrà come un macigno sul processo, sul suo esito e sul ruolo che
ebbe Bertolaso in quella vicenda. L'ex capo della Protezione Civile non fu
iscritto nel registro degli indagati perché non era presente alla riunione. Ora
si scopre che la convocò (senza andarci) al solo scopo di tranquillizzare (e
tacitare la popolazione). Si adoperò affinché una riunione di importanti
scienziati, formalmente chiamati a valutare uno sciame sismico su una zona ad
alto rischio terremoto, fosse solo "un'operazione mediatica". Sette giorni dopo
la catastrofe: 309 morti, 1500 feriti, e una città che, probabilmente, non
tornerà mai più come prima.
INQUINAMENTO AMBIENTALE: NON SOLO ILVA. C’E’
PIOMBO PURE NEL BIBERON.
Piombo, mercurio, PBC, diossina, polveri sottili.
Sono le sostanze in esame nei grandi scandali ambientali, dall'Ilva di Taranto
alla Caffaro di Brescia, ma anche quelle che inquinano le nostre città. Nel
libro 'Biberon al piombo' la ricercatrice Maria Cristina Saccuman spiega come,
oltre a provocare il cancro e altre patologie, danneggiano lo sviluppo neuronale
dei più piccoli. L’ha intervistata Lara Crinò su “L’Espresso”. I ricercatori
francesi Philippe Grandjean e Philip Landrigan la chiamano "pandemia
silenziosa". Perché spesso non ha effetti eclatanti ma subdoli e protratti nel
tempo. E perché, rispetto ad altri pericoli per la salute nostra e dei nostri
figli, su questo argomento l'informazione dei media è frammentaria. E' l'effetto
dei neurotossici (una lunga serie di sostanze chimiche, dal piombo al mercurio
alle polveri sottili) hanno sulle funzioni neurologiche dei più piccoli, dalla
fase embrionale dello sviluppo umano alla soglia dell'età adulta. Ora su questo
argomento una ricercatrice italiana, Maria Cristina Saccuman, ha pubblicato
Biberon al piombo (Sironi editore, pp. 192, euro 17), un saggio molto
documentato sugli studi più recenti che riguardano patologie, fattori di rischio
e possibili precauzioni. Senza allarmismi ma con un invito ai genitori: essere
attenti ai propri figli vuol dire essere attenti alla propria comunità, alle
politiche ambientali e ai fattori di inquinamento. Perché, se non possiamo
proteggerli facendoli crescere sotto una campana di vetro, possiamo preparare
per loro un mondo migliore.
Dottoressa Saccuman, lei spiega che molte sostanze
inquinanti, dal mercurio al piombo, provocano non solo neoplasie, asma e
malformazioni, ma modiche nello sviluppo del cervello. Perché di questo tipo di
danno alla salute dei più piccoli si parla poco? I neurotossici sono una classe
molto ampia di sostanze chimiche e i ricercatori e i medici le studiano da molti
anni. Ad esempio il piombo è una sostanza che ha fin dall'antichità moltissimi
utilizzi e di cui si è sempre conosciuta la tossicità. Ma quello che si è
capito, grazie a studi che hanno cambiato il modo stesso di concepire
l'epidemiologia, è che non è necessario arrivare al saturnismo, la patologia più
grave, perché il piombo sia tossico. Già a dosi bassissime l'esposizione al
piombo ha effetto sulla madre in gravidanza, sul feto e sul bambino. E si
correla a una serie di patologie: dal ritardo mentale ai disturbi
dell'apprendimento fino alla sindrome DHD (deficit di attenzione e
iperattività). Negli ultimi anni la situazione è migliorata perché il piombo è
stato eliminato dai carburanti delle auto e dalle vernici, ma permane in molti
ambienti. Si calcola che tuttora rubi un paio di punti di QI ai bambini europei.
Lo stesso discorso vale per gli effetti dei PBC, emessi per anni da industrie
come la Caffaro di Brescia, e per le polveri sottili che inquinano l'aria nelle
aree urbane. Purtroppo si parla poco di questo tipo di danno perché, rispetto ad
esempio alle neoplasie, è più difficile fare studi epidemiologici sulle
neuropatie che coinvolgano i bambini e i neonati.
Perché i bambini sono più sensibili ai
neurotossici? In primo luogo perché il loro cervello è in formazione, plastico e
duttile. E poi perché i bambini rispetto al loro peso corporeo, interagiscono
molto di più con l'ambiente: mangiano più cibo, consumano più aria, hanno più
contatti fisici con l'ambiente. Un bambino che gattona o gioca in un cortile
entra in contatto con la terra o la polvere moltissime volte in più di un
adulto.
Lei parla dei grandi scandali ambientali ma anche
della battaglia contro i gas di scarico che si combatte nelle nostre città.
Qual'è la situazione italiana rispetto alle altre nazioni dell'Occidente? In
Italia ci sono alcune situazioni assolutamente critiche: oltre a quelle create
dall'Ilva di Taranto o dalla Caffaro di Brescia, ovviamente la situazione della
diossina in Campania. Il problema è che spesso le zone inquinate sono anche
quelle a più basso sviluppo socioeconomico. Ed è stato dimostrato da molti studi
che la povertà aumenta i fattori di rischio per i danni neurologici. A livello
internazionale, invece, l'Italia non ha ratificato l'accordo di Stoccolma sugli
inquinanti organici. Le leggi sono fondamentali perché fanno sì che vengano
fissati limiti alle emissioni.
Che cosa può fare un genitore per proteggere i
propri figli? Ci sono delle raccomandazioni valide sempre? La prima
raccomandazione che mi sento di dare è: siate attivi nella società. Il che
significa informarsi, anche se non è sempre facile avere accesso a informazioni
corrette, e partecipare alla politica. Votare per chi è attento all'ambiente,
per chi vuole limitare il traffico delle auto. Non possiamo tenere i piccoli
sotto la campana di vetro, ma possiamo migliorare il loro mondo. E' inutile
fissarsi con il cibo biologico e pensare di poter dare ai piccoli una casa
'pura'. Ma ci sono alcuni accorgimenti che nel libro elenco. Ad esempio stare
attenti ai giocattoli vecchi o 'vintage' che potrebbero contenere piombo,
eliminare nelle case le vecchie tinteggiature, i vecchi infissi e rinnovare le
tubature. E altre cose: meglio non scaldare i cibi nel microonde con contenitori
di plastica, meglio non dare ai ragazzi pesci di grossa taglia come tonno o
pesce spada. E questo vale anche per le donne in gravidanza, che allattano o che
sono in età fertile.
CHI INQUINA PAGA? DIPENDE!
L'obbligo di bonificare i siti altamente a rischio
sanitario deve avvenire "ove possibile e economicamente sostenibile". Insomma,
si deve disinquinare solo se non costa troppo. E così, stando alla bozza del
prossimo dl Semplificazione, lo stabilimento di Taranto può continuare a
lavorare, scrive Paolo Fantauzzi su “L’Espresso”. Ilva salva e inquinatori al
sicuro. Sono questi due dei principali effetti che potrebbe produrre il dl
Semplificazioni che il governo approverà nei prossimi giorni. La bozza, entrata
nel Consiglio dei ministri della settimana scorsa ma poi non licenziata, non
sembra infatti lasciare molto spazio all'immaginazione in materia ambientale. A
cominciare proprio dal caso di Taranto che tiene banco in questi giorni. "Nei
siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del
danno ambientale - recita il provvedimento all'articolo 22 - possono essere
effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla
necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri
interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili
all'operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione".
Tradotto: lo stabilimento di Taranto può continuare a lavorare, nonostante il
blocco della produzione disposto dalla magistratura. E poco importa che
movimentando acque e terreni contaminati si rischi di peggiorare la situazione e
di vanificare gli effetti del risanamento già effettuato, come denunciano i
Verdi, che parlano apertamente di una norma "ad aziendam". Ma è l'articolo
precedente (il 21) a dare il colpo di grazia al principio su cui si fonda la
politica ambientale dell'Unione europea, ovvero "chi inquina, paga". Di fatto le
nuove norme sostituiscono con procedure più "snelle" l'articolo 243 ("Acque di
falda") del Codice dell'Ambiente, approvato nel 2006. Questo il risultato: nei
casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio
sanitario, "l'eliminazione della fonte di contaminazione" deve avvenire "ove
possibile e economicamente sostenibile". «L'obbligo di disinquinare, insomma,
sussiste solo se non costa troppo» attacca il presidente dei Verdi Angelo
Bonelli. «In pratica da Porto Torres a Priolo, da Milazzo a Piombino passando
per Taranto chi ha inquinato sarà di fatto esentato dalla bonifica».
Potenzialmente, un regalo da miliardi di euro. Senza considerare gli effetti
sanitari che potrebbe comportare il blocco degli interventi di risanamento. In
Italia sono 57 i siti del Programma nazionale di bonifica: raffinerie, poli
petrolchimici, impianti metallurgici, aree industriali in attività, dismesse, in
corso di riconversione o oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti
pericolosi. A novembre 2011 il rapporto Sentieri (Studio epidemiologico
nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento),
coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e condotto su 44 di questi 57 siti,
ha stimato in 3.500-10.000 le morti "aggiuntive" rispetto alla media a causa
dell'inquinamento diretto o indiretto nel periodo compreso tra il 1995 e il
2002. Con una casistica differenziata in base alle lavorazioni effettuate:
tumore polmonare e malattie respiratorie a Gela, Porto Torres, Taranto e nel
Sulcis per effetto delle emissioni delle raffinerie e degli stabilimenti
metallurgici. Malformazioni congenite a Massa Carrara, Falconara e Milazzo e
insufficienze renali a Massa Carrara, Piombino e Orbetello a causa dei metalli
pesanti. Malattie neurologiche a Trento Nord, Grado e Marano a causa del piombo
e del mercurio e linfomi a Brescia per effetto della contaminazione da
policlorobifenili. Un autentico bollettino da guerra, che fra l'altro non tiene
conto di quanti si ammalano di simili patologie in forma non letale. E sul quale
adesso pende il rischio di un colpo di spugna del governo.
PUGLIA, UNA REGIONE AVVELENATA.
Non c'è solo l'Ilva: i siti considerati pericolosi
sono quasi 500. E tre sono nella lista nera d'Europa. Un disastro che uccide
l'economia, ma soprattutto le persone scrive Emiliano Fittipaldi su
“L’Espresso”. Se Taranto è il centro dell'inferno e l'Ilva la bocca di Satana,
anche il resto della Puglia non se la passa bene. Inquinamento alle stelle,
emissioni di CO2 da record, tracce di diossina nel latte materno, incidenza di
tumori troppo alta vicino ai poli industriali: la regione dei trulli è il tacco
nero d'Italia, il luogo dove sorgono le fabbriche più inquinanti del Belpaese.
L'Agenzia europea dell'Ambiente lo scorso anno ha stilato una classifica delle
industrie più "sporche" del Vecchio Continente. Nelle prime cento posizioni ci
sono cinque fabbriche italiane. Tre sono in Puglia e due in Sardegna. Se l'Ilva
di Taranto è cinquantaduesima, la centrale termoelettrica dell'Enel di Brindisi
è piazzata addirittura al diciottesimo posto, mentre l'altra centrale di Taranto
(sempre dell'Enel) è all'ottantesimo posto. Non è tutto: secondo gli studi
dell'Arpa tra Foggia e Santa Maria di Leuca si contano centinaia di altri siti
potenzialmente pericolosi. In tutto sono 498, di cui 70 di origine industriale,
145 discariche, 11 luoghi a rischio contaminazioni da amianto. «Non stupisce»,
chiosa Annibale Biggeri, epidemiologo, professore ordinario a Firenze e perito
del gip di Taranto che ha ordinato il sequestro dell'Ilva, «che in alcune zone
della Puglia i dati epidemiologici siano così allarmanti». Taranto è il caso più
devastante. Lo studio "Sentieri" ha definito la zona vicino l'Ilva«area
insalubre», e la procura ha deciso - dopo anni di inedia da parte di istituzioni
locali e nazionali - di intervenire bloccando la produzione. Il Gruppo Riva,
oggi nel mirino dei magistrati, ha comprato il sito alla fine degli anni '90 e
ha inquinato allegramente per quindici anni l'aria e il mare della città, ma
sono almeno tre decadi che gli esperti degli istituti di ricerca andavano
spiegando dei pericoli mortali dell'acciaieria più grande d'Italia. «A Taranto
in 13 anni di osservazioni, che vanno dal 1998 al 2010», ricorda Biggieri, «sono
attribuibili alle emissioni industriali (misurate come polveri sottili) ben 386
decessi. Circa 30 l'anno. Un eccidio».
A settanta chilometri dall'Ilva, a Brindisi, c'è
un altro dei siti d'interesse nazionale (Sin) che fa tremare gli esperti.
Comprende la zona industriale della città, il porto e una fascia costiera che si
estende per oltre 30 chilometri quadri. Qui sorge la Syndial, la Polimeri
Europa, l'Enipower, la Powerco, senza dimenticare le due enormi centrali
dell'Enel, campioni nazionali nell'emissione di CO2. Gli studi in mano agli
scienziati sono scioccanti. La mortalità per l'area di Brindisi è stata
analizzata nel periodo 1990-1994, quando vennero segnalati eccessi di mortalità
per tutte le cause e per tutti i tipi di tumore. Un report più recente,
pubblicato nel 2004, riguardò l'area residenziale vicino al petrolchimico: i
risultati evidenziarono un incremento «moderato» nel rischio di mortalità per
tumore del polmone, della vescica e del sistema linfoematopoietico per chi
risiedeva in un raggio di due chilometri dalle industrie inquinanti. L'Arpa
recentemente ha effettuato nuovi rilievi del suolo e delle falde acquifere,
trovando di tutto: l'arsenico supera i limiti del 63 per cento, lo stagno del
42, il mercurio del 14, ci sono troppi idrocarburi, composti cancerogeni di
vario tipo, clorobenzeni. Nello studio "Sentieri" gli esperti ricordano pure la
presenza massiccia di amianto, che potrebbe aver causato«l'eccesso di mortalità
per tumore alla pleura», e le troppe malformazioni congenite presenti a
Brindisi. Il ministero dell'Ambiente, nella conferenza di servizi del marzo
2011, ha chiesto al Comune di presentare un progetto di bonifica della zona, e
di fare rapidamente gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle acque
di falda. Chissà a che punto stanno i lavori. Di sicuro la commissione
bicamerale d'inchiesta, che ha pubblicato lo scorso giugno una relazione sulla
situazione pugliese in tema di illeciti e criminalità ambientale, sul tema delle
bonifiche ha bacchettato l'amministrazione guidata da Nichi Vendola, rea di
essere troppo lenta negli interventi di pulizia. «Il piano di stralcio delle
bonifiche (pubblicato nel bollettino ufficiale del 9 agosto 2011, ndr) non
riporta né una definizione degli interventi prioritari né un quadro chiaro dei
meccanismi di finanziamento degli stessi». L'unica eccezione positiva, nota il
Parlamento, è il sito inquinato di Manfredonia. Qui, grazie alla «spinta
propulsiva» di una procedura d'infrazione della Comunità europea (che avrebbe
portato a pagare multe da centinaia di migliaia di euro al giorno) la Regione ha
investito una quarantina di milioni ed ha bonificato tre discariche pubbliche
che aspettavano di essere pulite da 13 anni. La situazione in città è
migliorata, ma c'è ancora molto da fare. Innanzitutto nell'area della Syndial
(Ex Enichem), che nel 1976 finì sulle prime pagine dei giornali per
un'esplosione che provocò una nube tossica di arsenico. Dieci tonnellate di
veleni caddero sotto forma di polveri, come ricorda la commissione bicamerale,
«nei pressi dello stabilimento e fino all'estrema periferia» di Manfredonia,
ricoprendo i tetti delle case, le strade, i campi e i giardini. Uno studio ha
segnalato per la città - per quanto riguarda la mortalità- trend temporali in
crescita per tutti i tumori. «Su quell'evento bisognerebbe indagare meglio: è un
incidente tipo Seveso, non si sa cosa sia davvero successo alla salute delle
persone, i possibili danni di chi fu esposto dovrebbero essere studiati con
maggiore cura», ragiona Biggeri. Il quarto sito di interesse nazionale è quello
di Bari, area Fibronit. Qui l'assassino è l'amianto, che ha ucciso negli anni
(per asbestosi, tumori e malattie dell'apparato respiratorio) centinaia di
persone, gli operai che andavano al lavoro, le mogli che venivano in contatto
con le polveri nascoste nelle tute da lavoro, i figli che le respiravano. Nella
zona, sostengono gli scienziati, c'è ancora un eccesso di malattie. La fabbrica
ha chiuso da lustri, ma incredibilmente ci sono ancora migliaia di metri quadri
da bonificare, con residui di eternit che rischiano di far ammalare, oggi, gli
abitanti dei quartieri vicini: solo a Japigia vivono oltre 50 mila persone. Lo
studio "Sentieri" dà alcuni suggerimenti: «Considerata la particolare
complessità della città di Bari (ambiente urbano, area portuale, altri
insiedamenti produttivi) si ritiene opportuna una caratterizzazione ambientale
più ampia, e un approfondimento del quadro di salute della popolazione». I
biomonitoraggi, però, costano caro, e i loro risultati non sempre piacciono ai
politici. Le bonifiche sono operazioni complesse e richiedono enormi sforzi
economici: è impossibile fare una stima precisa, ma di sicuro mettere in
sicurezza i quattro Sin pugliesi non costerebbe meno di una decina di miliardi
di euro. Soldi che nessuno (né il pubblico né tantomeno i privati) ha mai voluto
investire. La commissione bicamerale alza il dito anche contro la gestione
commissariale in tema di rifiuti e bonifiche. «In Puglia come in altre regioni
ha prodotto scarsi risultati, dal momento che il primo censimento dei siti
contaminati è stato pubblicato nel 1994 dall'Enea, e quindi da allora si aveva
contezza dello stato di degrado ambientale del territorio». Un disastro che
ammazza anche l'economia: se i mancati investimenti dovuti all'inquinamento
pesano sul Pil regionale per centinaia di milioni di euro l'anno (nel 2006 uno
studio della Ue quantificò un costo annuale per le mancate bonifiche in un range
che andava, per quanto riguarda l'Italia, tra i 2,4 e i 17,3 miliardi di euro),
i veleni hanno penalizzato anche l'agricoltura, «martoriata», scrive la
Commissione, «dalle emissioni industriali degli insediamenti di Brindisi e
Taranto e dallo sversamento illegale di rifiuti». La commissione non risparmia
nessuno, e se la prende anche con il ministero dell'Ambiente, che non avrebbe
mai emanato il regolamento relativo agli interventi di bonifica. In assenza di
norme precise, ogni situazione viene gestita «caso per caso, rendendo di fatto
inefficaci le richieste di intervento». Senza un quadro normativo di
riferimento, in pratica, tutto è demandato ai Tar. Che, in caso di ricorso,
possono bloccare il lavoro di bonifica. Come è capitato alla Fibronit di Bari:
il Comune voleva trasformare l'area in un parco cittadino dedicato alle vittime
dell'amianto, il Tar ha bocciato il progetto, i lavori sono stati bloccati e i
veleni sono rimasti a terra.
PARLIAMO DELL’ITALIA DEI VELENI: MORIRE DI FAME
O DI INQUINAMENTO?
SCEGLIERE TRA LAVORO E SALUTE.
Il caso Ilva ha riportato agli onori della cronaca
una questione annosa nel nostro paese: l’industrializzazione selvaggia e
sregolata. Un capitalismo senza freni che spesso non ha guardato in faccia né
alla gente né al territorio, sacrificati all’altare della produttività e del
risparmio. L’Ilva è stata sequestrata e sarà giustamente costretta a bonificare
i propri impianti a causa dei quali tutta Taranto è coperta da una patina
rossastra, invasa dagli scarafaggi e dove i tumori negli ultimi anni sono
aumentati del 600%. Il diritto al lavoro è sacro, ma quello alla vita di più e
purtroppo solo gli interventi eclatanti della magistratura possono costringere
gli imprenditori a rimettersi in regola. Il caso Ilva è solo l’ultimo del
decennale scontro tra industria e ambiente. La popolazione è una variabile a
parte: a volte si schiera compatta a favore della fabbrica, a volte in difesa
della propria salute e della propria terra. Nel luglio del 2005 le proteste
battendo sulle casseruole delle mamme di Cornigliano convinse l’industriale
Emilio Riva ad abbattere l’altoforno dell’Italsider: ora si occupa solo di
laminati a freddo. Sono stati invece i sindaci, con Massimo Cacciari in testa, a
spingere e a finanziare, con 5 miliardi pubblici e privati, la riconversione
dell’immensa area industriale di Porto Marghera. È sotto accusa lo storico
petrolchimico di Gela voluto da Enrico Mattei in cui lavorano duemila persone.
Venti persone su settantacinque del reparto Clorosoda, chiuso nel 1994, sono
morti per timore, altrettanti hanno il sistema immunitario distrutto dal
mercurio. Nel 2006 ci sono state denunce da parte di 100 famiglie contro l’Eni e
nel 2008 è stata aperta un’inchiesta. A Brindisi sono stati rinviati a giudizio
tredici dirigenti della centrale a carbone dell’Enel: secondo il GIP le polveri
del nastro trasportatore hanno avvelenato 400 ettari di terreni agricoli.
Centrale a carbone chiacchierata anche a Civitavecchia: il sindaco PD Pietro
Tidei la vuole chiudere perché i fanghi vengono essiccati senza essere depurati
e la città è avvolta da una costante nebbia gialla, a causa delle polveri.
L’Enel però fa orecchie da mercante. Polveroni rossi hanno investito anche
l’isola di Carloforte, in Sardegna, a causa dei fanghi prodotti dall’Alcoa di
Portovesme. Sempre sulla costa nel Sulcis il GIP ha contestato all’Eurallumina
il reato di disastro ambientale doloso con inquinamento delle acque di falda.
Fluoruri, boro e arsenico nelle acque e nell’aria hanno portato al rinvio a
giudizio degli ultimi tre amministratori delegati della centrale Enel di Porto
Tolle in provincia di Rovigo. Seimila operai della Carnia si sono invece opposti
alla chiusura delle cartiere di Burgo di Tolmezzo a causa degli scarichi
irregolari. La gente si è invece comportata in modo opposto altrove. Nel
processo contro l’Acciaieria Valsugana di Borgo per l’emissione di diossine e
monossidi si sono costituite parte civile 554 persone i cui terreni erano stati
distrutti e il valore delle case crollato. A Bottegone-Badia-Agliana nel
Pistoiese, i cittadini hanno sottoposto i candidati sindaci a un pre-referendum
contro il progetto Repower, un turbogas. Tutti tranne uno si sono espressi come
voleva la gente: niente centrale. Industrializzazione e ambiente, un rapporto di
rose e spine, con la gente a fare da giudice.
Non solo Ilva. Il ricatto dei colossi che ci
avvelenano: pane o salute? La domanda di Simona Martini su “Oggi 24". Salute o
lavoro? Impossibile scegliere. Anzi non si dovrebbe. Eppure le recenti vicende
dell’Ilva di Taranto il più grande polo siderurgico d’Europa hanno evidenziato
l’esatto contrario. Il problema esiste: non si può chiudere ma non si può
neanche andare avanti così. “Occorre evitare la chiusura, se si chiudono quegli
impianti non si riaprono più”. E’ la posizione del Ministro Passera. Il problema
occupazionale è forte e più immediato. La paura per la salute c’è ma non la
certezza di essere colpiti dalle malattie causate dall’inquinamento. Il ‘forse
non succede a me’ contro la paura molto più sentita di perdere il posto di
lavoro anche se la decisioni della procura di Taranto parlano chiaro: il
sequestro, confermato dal riesame, di sei impianti dell’area a caldo con
utilizzo finalizzato alla messa in sicurezza e al risanamento in aggiunta ai
reati di disastro ambientale, getto di sostanze pericolose, inquinamento
atmosferico contestati ai vertici dell’azienda. La situazione è grave e i
cittadini di Taranto lo sanno e lo sapevano: senza bisogno di studi o analisi,
quelle colonne di fumo che si alzavano dall’Ilva non promettevano nulla di
buono. Adesso il polo è sotto i riflettori. Giornali e giustizia se ne stanno
occupando ma l’Italia è piena siti industriali ed energetici pronti ad esplodere
come altri casi ‘Ilva’. A Gela il gigante industriale è la raffineria Eni, con
una capacità di 100 mila barili al giorno per la produzione di greggi pesanti e
impianti petrolchimici. Secondo Legambiente il pet coke, che viene utilizzato
nella raffineria è di fatto tossico o meglio lo sono i fumi derivati dal suo
utilizzo. Lo scarto della lavorazione del petrolio ‘riabilitato’ a combustibile
rilascerebbe nell’aria sostanze come mercurio, cadmio, nichel e cromo. Agenti
cancerogeni! Teoria sostenuta anche da una ricerca del Dipartimento di Chimica e
Fisica della Terra dell’Università degli Studi di Palermo, ‘Inorganic pollutants
associated with particulate matter from an area near a petrochemical plant’,
dedicata all’area di Gela dove avevano appunto riscontrato la presenza di
diversi metalli. I pericoli per la salute vengono confermati dall’Istituto
Superiore di Sanità: “Per gli incrementi di mortalità per tumore polmonare e
malattie respiratorie non tumorali è stato suggerito un ruolo delle emissioni di
raffinerie e poli petrolchimici” perché da quelle parti l’incidenza di patologie
del genere è superiore alla media regionale di un inquietante 15%. Sul banco
degli imputati c’è anche l’Enel e le centrali a carbone di ultima generazione. A
Brindisi in concomitanza con il caso Ilva la magistratura ha citato in giudizio
per inquinamento ambientale 15 dirigenti della centrale termoelettrica di
Cerano. L’accusa: aver disperso polveri di carbone sui terreni circostanti
provocando seri danni all’agricoltura e ai contadini che si sono visti togliere
gli appezzamenti perché non più coltivabili. Le polveri avevano avvelenato la
terra e forse non solo: alcuni agricoltori si sono ammalati e sono morti di
cancro. Coincidenza? Intanto a fine 2011 il rapporto “Revealing the costs of air
pollution from industrial facilities in Europe” dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente catalogava i 20 impianti industriali più inquinanti, per emissioni
atmosferiche: al 18esimo posto la centrale di Brindisi. Greenpeace fa di più:
punta il dito accusando apertamente l’Enel di ‘omicidio colposo’. Secondo i dati
diffusi dall’associazione ambientalista il carbone provocherebbe una morte al
giorno: nel 2009 366 decessi prematuri e 1,8 miliardi di euro di danni
economici, principalmente in capo agricolo. Ma Brindisi, che pure ha la maglia
nera, non è l’unica e a Civitavecchia il sindaco Tidei tuona contro la centrale:
“Mi auguro di poter firmare un’ordinanza e di disporre la chiusura di
Torrevaldaliga nord entro agosto”. Il motivo: il troppo inquinamento. Ma la
centrale a carbone è stata decisa da un accordo fra l’allora Ministero delle
attività produttive, Comune e Regione perché si riconosceva nella riconversione
un’occasione di “sviluppo occupazionale e di crescita economica e professionale
per le maestranze, le imprese e le professionalità locali”. E ancora a tutela
dell’ambiente un Osservatorio ad hoc, limite di emissioni stabilite
preventivamente. Questo almeno sulla carta dove si trova la prima anomalia: il
medesimo accordo stabilisce che l’Enel dovrà “contribuire alla gestione
dell’Osservatorio attraverso l’erogazione di un contributo annuo pari alla somma
di 1 milione di euro”. Il controllato paga i controllori. Non solo: gli fornisce
anche gli strumenti! Cede infatti al Comune le centraline per il monitoraggio
della qualità dell’aria. Il primo cittadino sembrerebbe voler prendere comunque
una drastica decisione ma sul piatto della bilancia, come al solito, si trovano
salute o lavoro. A Civitavecchia, come negli altri siti, l’industria incriminata
ha creato occupazione sia per il suo funzionamento che l’indotto senza contare
le interconnessioni che il colosso dell’energia ha creato nel tessuto economico
e sociale. Difficile rinunciarci, impensabile quasi in tempo di crisi nonostante
i dati epidemiologici della zona riportino un aumento di tumori polmonari così
come i ricoveri ospedalieri per asma bronchiale. “La chiusura dell’Enel
creerebbe sicuramente un problema. Ci sono più di 300 dipendenti e 6-700 persone
che lavorano nell’indotto ma se le istituzioni avessero la schiena dritta
potrebbero pretendere da Enel una riconversione in fonti energetiche rinnovabili
o attività accessorie come la formazione di personale o centri di ricerca”.
Questa l’opinione di Simona Ricotti, esponente dei No coke Alto Lazio e
rappresentante del Forum Ambientalista. “Quando si stava decidendo sulla
riconversione a carbone di Torrevaldaliga il tessuto sociale si è spaccato in
due, si sono rotte amicizie, spezzate famiglie . Nei pro c’erano solo ed
esclusivamente i lavoratori dell’Enel e dell’indotto e coloro che vivevano nel
sottobosco dei finanziamenti Enel. Esiste una consapevolezza della classe
politica che però non produce gli atti conseguenti perché c’è una sorta di
collusione con l’azienda. L’Enel a Civitavecchia finanzia tutto: non c’è società
sportiva o culturale che non prenda soldi dal colosso dell’energia, tutti in
qualche maniera sono complici”. Anche se Simona Ricotti spera che dopo le
dichiarazioni del sindaco Tidei “si vada fino in fondo e non si utilizzi questo
disagio della popolazione per alzare il prezzo con l’Enel”. Delle vicende
dell’Ilva non si stupisce: “Noi non ci siamo spaventati perché eravamo
consapevoli di quello che succedeva a Taranto così come eravamo consapevoli di
quello che stava accadendo a Brindisi. Noi avevamo consapevolezza che c’erano, a
essere buoni, delle omissioni se non delle vere e proprie falsificazioni e siamo
convinti che la stessa cosa stia succedendo a Civitavecchia. I dati
epidemiologici già parlando di danni profondi nella salute della popolazione. A
breve ci attendiamo i danni economici che già ci sono stati a Brindisi e a
Taranto. Danni per esempio al patrimonio ittico di Civitavecchia dove sono stati
trovati altissimi livelli di mercurio. Siamo consapevoli ed è questa la cosa che
ci manda avanti da 10 anni a combattere contro questa centrale”.
Non solo Taranto. Le "altre" Ilva in Italia.
Almeno 60 siti italiani nella lista dei 622 più “tossici” del continente. Il
primato va alla centrale Enel di Brindisi. Queste sono le risultanze di
un’inchiesta di Marino Petrelli pubblicata su “Panorama”. Taranto, ma non solo.
Ci sono oltre 60 fabbriche italiane dove ci si ammala per l'inquinamento
prodotto dagli stabilimenti industriali. Per un costo complessivo, per i
cittadini europei, di quasi 169 miliardi annui. Lo stabilisce il rapporto 2011
dell’Agenzia europea per l’ambiente (Eea) sull'inquinamento prodotto dagli
stabilimenti industriali in Europa, secondo il quale nella lista dei 622 siti
più “tossici” del continente, almeno 60 sono del nostro paese. Il triste primato
non spetta all'Ilva di Taranto, ma alla centrale Enel termoelettrica a carbone
“Federico II” a Cerano, pochi chilometri a sud di Brindisi, la seconda più
grande del paese dopo quella di Civitavecchia. Come ha testimoniato Panorama.it,
una lunga storia accompagna questa centrale che dista da Taranto non più di 70
chilometri. Dal 2007 ha emesso 14,2 tonnellate di Co2, almeno 3 volte tanto
quello delle altre fabbriche, aggiudicandosi il ben poco invidiabile titolo di
centrale più inquinante d'Italia. Secondo il rapporto dell'Agenzia europea per
l'ambiente, da sola genera costi connessi ad inquinamento tra i 536 e i 707
milioni di euro l'anno. Nello stesso anno, l'allora sindaco Domenico Mennitti
firmò un'ordinanza che vietava la coltivazione dei 400 ettari di terreno che
circondano la centrale. Da allora i contadini chiedono a gran voce cosa abbia
avvelenato i loro campi. E, forse, anche i loro polmoni. Alla fine hanno
presentato un esposto, a partire dal quale la procura di Brindisi ha aperto
un'inchiesta. Tra i quindici indagati, ci sono dirigenti Enel e imprenditori
addetti al trasporto del carbone che alimenta la centrale, accusati di gettito
pericoloso di cose, danneggiamento delle colture e insudiciamento delle
abitazioni. Il processo partirà il prossimo 12 dicembre. La provincia di
Brindisi ha annunciato che si costituirà parte civile e chiederà, secondo quanto
apprende Panorama.it, un risarcimento di 500 milioni di euro relativamente ai
danni di immagine, ambientali, alla salute, alla perdita di chance per il
territorio e per altri eventuali e potenziali voci di danno patrimoniali e non
subiti dalla provincia e dai cittadini. Una notizia che, da indiscrezioni
raccolte in città, avrebbe lasciato stupiti i vertici di Enel che reputano la
richiesta "infondata e inammissibile". In Italia ci sono 57 aree tossiche, pari
a 298 comuni, i cosiddetti Sin (Siti di interesse nazionale) compresi nel
“Programma nazionale di bonifica” e coincidenti con i maggiori agglomerati
industriali nazionali. Siti “a rischio” come Taranto, sono da anni sotto la
lente d'ingrandimento del ministero della Salute, per i problemi causati alla
popolazione che vive nella zona. Ad esempio, in Sicilia, le aree intorno al
petrolchimico di Gela, quello di Augusta e le raffinerie a Milazzo. Queste aree
sono state dichiarate “a elevato rischio ambientale” da uno studio dell’Istituto
superiore di sanità, che ha osservato un’alta incidenza di patologie tumorali
sia negli uomini che nelle donne. I siciliani che lavorano o abitano attorno a
questi stabilimenti industriali, secondo l'Iss, si ammalano soprattutto di
“tumore maligno del colon retto, della laringe, della trachea, bronchi e
polmoni”. È quello che denuncia anche il sindaco di Civitavecchia Pietro Tidei,
che ha minacciato di far chiudere la centrale Enel a carbone di Torrevaldaliga
Nord per l’inquinamento prodotto dai fumi. Bisogna scendere al 52 esimo posto
per trovare gli stabilimenti dell’Ilva di Taranto, con l’emissione di 5.160.000
tonnellate di anidride carbonica all’anno e che ci costa dai 283 ai 463 milioni,
circondati dalle raffinerie e dalle centrali termoelettriche di Eni, all’80esimo
posto della lista Eea. Un po' più giù, al 69esimo posto a livello europeo, ma
tra le prime in Italia, le “Raffinerie Sarde Saras” di Sarroch, in provincia di
Cagliari, di proprietà della famiglia Moratti. La raffineria più grande
d’Italia, con oltre 2200 lavoratori e una capacità di produzione di 15 milioni
di tonnellate annue di petrolio, pari al 15% dell'intera capacità italiana di
raffinazione. Anche qui la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sulla
attività della Saras e sulle presunte conseguenze per la salute degli operai e
degli abitanti di Sarroch. Nella raffineria nel maggio 2009 tre operai sono
morti intossicati dall’azoto nel corso di una operazione di lavaggio di una
cisterna, e quattro dirigenti sono stati rinviati a giudizio per non aver
garantito agli operai le condizioni di sicurezza necessarie sul posto di lavoro.
Nella nefasta classifica, seguono la centrale termoelettrica E.on di Fiume
Santo, a Sassari, all'87esimo posto; l'impianto termoelettrico Enel di Fusina al
108esimo posto; la centrale di Vado Ligure di Tirreno Power al 118esimo posto. E
ancora: la centrale di San Filippo del Mela al 128esimo posto, la raffineria
Esso di Augusta, in Sicilia, al 145esimo posto, quella Eni di Sannazzaro de'
Burgondi, Pavia, al 148esimo. Come detto, il costo complessivo a livello europeo
si aggira sui 169 miliardi di euro. Per la precisione, a seconda delle
metodologie adoperate per calcolare gli oneri che vengono esternalizzati dalle
imprese sull'ambiente circostante, le emissioni di agenti inquinanti nel 2009,
ultimo dato disponibile nella ricerca, pesavano tra i 102 e i 169 miliardi
l'anno, ovvero dai 200 ai 330 euro a persona. Colpisce di più che ben il 50 per
cento dei costi aggiuntivi, tra 51 e 85 miliardi, sono generati da soltanto 191
impianti. Si tratta del 2% del totale di quelli censiti, quelli più “sporchi” in
assoluto. Il 75% del totale delle emissioni è prodotto invece da soli 622 siti
industriali. A guidare la classifica sono le centrali termoelettriche, in
particolare a carbone o a olio combustibile. Il discutibile primato di industria
più inquinante in assoluto d'Europa se lo aggiudica la famigerata centrale
elettrica di Belchatow, nei pressi di Lodz, in Polonia, un “mostro” alimentato a
lignite da 5.000 Megawatt. Tra le prime venti troviamo anche la centrale di
Brindisi. Il rapporto dell'Aea utilizza gli ufficialissimi dati del registro
europeo delle emissioni (E-PRTR) che registra 10 mila impianti industriali e si
basa su strumenti e metodi certificati. Le emissioni delle grandi centrali
elettriche sono quelle più costose, tra 66 e 112 miliardi. In secondo luogo, i
paesi dove i costi ambientali “nascosti” sono in assoluto più elevati sono
quelli a storica vocazione industrializzata: Germania, Polonia, Gran Bretagna,
Francia e Italia. Per l'Italia si stimano costi aggiuntivi tra gli 8 e i 12,2
miliardi. Rispetto alla grandezza delle economie, però, in testa ci sono i paesi
dell'ex Europa socialista: Bulgaria, Romania, Estonia, Polonia e Repubblica
Ceca. Il paese più virtuoso in assoluto è invece la Lettonia.
Non solo Taranto, ecco tutte le Ilva d’Italia,
questa, invece è il reportage di Lidia Baratta su “L’Inkiesta”. Non solo
Taranto, anche in altre zone d’Italia ci si ammala per l’inquinamento prodotto
dagli stabilimenti industriali. In base al rapporto 2011 dell’Agenzia europea
per l’ambiente (Eea) sull'inquinamento degli stabilimenti industriali in Europa,
più di 60 fabbriche italiane compaiono nella lista dei 622 siti più "tossici"
del continente. E, a sorpresa, l’Ilva di Taranto del Gruppo Riva non è al primo
posto tra le italiane. La maglia nera del sito più inquinante d’Italia (al
18esimo posto della lista Eea) se la aggiudica la centrale Enel termoelettrica a
carbone Federico II di Cerano, in provincia di Brindisi. Non solo Taranto, anche
in altre zone d’Italia ci si ammala per l’inquinamento prodotto dagli
stabilimenti industriali. In base al rapporto 2011 dell’Agenzia europea per
l’ambiente (Eea) sull'inquinamento prodotto dagli stabilimenti industriali in
Europa, più di 60 fabbriche italiane compaiono nella lista dei 622 siti più
"tossici" del continente. E, a sorpresa, l’Ilva di Taranto del Gruppo Riva non è
al primo posto tra le italiane. La maglia nera del sito più inquinante d’Italia
(al 18esimo posto della lista Eea) se la aggiudica la centrale Enel
termoelettrica a carbone Federico II di Cerano, in provincia di Brindisi, la
seconda più grande del Paese dopo Civitavecchia. Qui, al confine con il Salento,
dal 2007 il sindaco ha indetto una ordinanza che vieta la coltivazione dei 400
ettari di terreno che circondano la centrale. Da molti anni i contadini chiedono
a gran voce cosa abbia avvelenato i loro campi. E forse, anche i loro polmoni.
Alla fine hanno presentato un esposto, a partire dal quale la procura di
Brindisi ha aperto una inchiesta. Tra i quindici indagati, ci sono dirigenti
Enel e imprenditori addetti al trasporto del carbone che alimenta la centrale,
accusati di gettito pericoloso di cose, danneggiamento delle colture e
insudiciamento delle abitazioni. A contaminare i terreni, le colture, l’acqua e
l’atmosfera, secondo la perizia affidata a Claudio Minoia, direttore del
laboratorio di misure ambientali e tossicologiche della Fondazione Maugeri di
Pavia, sarebbe la polvere del combustibile usato nella centrale. Stessa
conclusione a cui è arrivato uno studio della Università del Salento e Arpa
Puglia, che individua «la centrale Enel Federico II, con particolare riferimento
alla gestione del carbonile» come «fonte potenziale più probabile delle
emissioni». Il processo partirà il prossimo 12 dicembre e la provincia di
Brindisi ha annunciato che si costituirà parte civile. Dopo Cerano, bisogna
aspettare il 52esimo posto per trovare gli stabilimenti a rischio chiusura
dell’Ilva di Taranto, con l’emissione di 5.160.000 tonnellate di anidride
carbonica all’anno, circondati dalle raffinerie e dalle centrali termoelettriche
di Eni (all’80esimo posto della lista Eea). Alla 69esima posizione compaiono le
Raffinerie Sarde Saras di Sarroch, in provincia di Cagliari, di proprietà della
famiglia Moratti. Si tratta della raffineria più grande d’Italia, con una
capacità di produzione di 15 milioni di tonnellate annue di petrolio, ossia il
15% della capacità italiana di raffinazione. Una vera e propria città del
petrolio addossata al paese di Sarroch, in cui molte case sono state costruite
quasi a ridosso dei serbatoi. Anche qui la procura della Repubblica ha aperto un
fascicolo sulla attività della Saras e sulle presunte conseguenze per la salute
degli operai e degli abitanti di Sarroch. Nella raffineria nel maggio 2009 tre
operai sono morti intossicati dall’azoto nel corso di una operazione di lavaggio
di una cisterna, e quattro dirigenti sono stati rinviati a giudizio per non aver
garantito agli operai le condizioni di sicurezza necessarie sul posto di lavoro.
Non solo Saras. L'aria della Sardegna risulta altamente inquinata anche a causa
della presenza della centrale termoelettrica E.on di Fiume Santo (Sassari),
nell’area industriale di Porto Torres, e della centrale “Grazie Deledda” di
Portoscuso, nel Sulcis. Rispettivamente all’87esimo e al 186esimo posto della
classifica Eea. Il Sulcis, nell’area di Portovesme, è un bacino che accoglie
aziende diverse, dalla produzione di alluminio (Alcoa, Eurallumina), bitume e
polistirolo, al trattamento dei gas e alla gestione di rifiuti speciali e
mercantili. E, ciliegina sulla torta, c'è anche una miniera di carbone
(Carbosulcis spa). «Non ci possono essere corsie preferenziali per le bonifiche
ambientali: Porto Torres e il Sulcis sono nelle stesse condizioni dell’Ilva di
Taranto e devono essere immediatamente avviate», ha dichiarato il deputato Pdl
Mauro Pili nei giorni scorsi. «Bisogna ricorrere anche qui alla magistratura,
rischiando di far crollare tutto il sistema industriale sardo?», si chiedono in
tanti sull’isola. Secondo il Wwf, nell’area industriale di Porto Torres «sono
state scaricate acque reflue industriali in violazione dei limiti fissati dalla
legge con conseguente inquinamento del suolo e immissione di sostanze
cancerogene e altamente tossiche per l’ambiente e la fauna marini», generando
«un gravissimo pericolo per la pubblica incolumità», con «l’incremento della
mortalità per tumore polmonare, altre malattie respiratorie non tumorali,
malformazioni alla nascita». In particolare, «nei pressi dell’insediamento
petrolchimico è stata rinvenuta una lunga serie di contaminanti tra cui sostanze
organiche clorurate, mercurio, solventi, diossine e pesticidi». E anche la
salute del Sulcis sarebbe malata: secondo un dossier realizzato da TzdE “Energia
e Ambiente”, solo nell’area di Portoscuso tra il 1997 e il 2003 siu sarebbe
registrata un0incidenza del tumore ai polmoni superiore al 30% rispetto alla
media regionale. Non si salva neanche l’altra isola, la Sicilia, con il polo
petrolchimico di Gela, quello siracusano (Augusta-Priolo) e le raffinerie di
Milazzo (Messina). Queste aree sono state dichiarate «a elevato rischio
ambientale» da uno studio dell’Istituo superiore di sanità, che ha osservato
un’alta incidenza di patologie tumorali sia negli uomini che nelle donne. I
siciliani che lavorano o abitano attorno a questi stabilimenti industriali,
secondo l'Iss, si ammalano soprattutto di «tumore maligno del colon retto, della
laringe, della trachea, bronchi e polmoni». È quello che denuncia anche il
sindaco di Civitavecchia Pietro Tidei, che ha minacciato di far chiudere la
centrale Enel a carbone di Torrevaldaliga Nord per via dell’inquinamento
prodotto dai fumi. «Questa mattina Civitavecchia sembrava la pianura padana e
non per colpa della nebbia», ha dichiarato il primo cittadino nel corso della
conferenza dei sindaci della Asl Rmf il 31 luglio scorso. «Quella polvere gialla
che proviene dalla centrale Enel non possiamo più sopportarla». Ma Enel risponde
che «tutti i controlli sulla funzionalità dei sistemi di monitoraggio delle
emissioni sono stati effettuati da ditte specializzate, secondo le scadenze
previste dall’autorizzazione integrata ambientale e sono state costantemente
verificate dagli organi di controllo competenti». Altra regione in cui sono
state individuate numerose aree ad alto rischio ambientale è il Veneto.
L’impianto termoelettrico Enel di Fusina è alla posizione 108 delle fabbriche
pericolose segnalate dalla Eea, mentre la raffineria di Venezia-Porto Marghera
dell’Eni è al posto 403. Senza dimenticare che nell’area industriale c’è un
piccolo impianto dell’Ilva con un centinaio di dipendenti che rischiano di stare
a casa se gli impianti di Taranto venissero chiusi. Nel 1994 la magistratura
avviò un'indagine per il disastro del polo industriale: 157 morti, 120
discariche abusive, 5 milioni di metri cubi rifiuti tossici. E anche qui ora i
politici locali alzano la mano e chiedono che non si pensi solo a Taranto e
all’Ilva. La differenza è che a Venezia ci sono stati i «risarcimenti» delle
aziende che hanno versato quasi 500 milioni di euro per l'inquinamento prodotto,
a Taranto invece per l'Ilva lo Stato stanzia direttamente quasi 360 milioni per
bonificare e ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento.
Ecco la mappa delle aree industriali inquinanti
italiane segnalate dalla Agenzia europea per l'ambiente.
ECOLOGISMO ED AMBIENTALISMO: LA TRUFFA IN DANNO
DELL’UMANITA’.
Un mondo pulito ma di morti di fame, scrive Franco
Battaglia su “Il Giornale”. Mi ritrovai a dibattere con Pecoraro Scanio nel
programma televisivo Otto-e-mezzo condotto su La7 da Giuliano Ferrara e Ritanna
Armeni. Non appena aprii bocca, il ministro, immemore di essere sventolatore di
bandiere della pace e a dispetto della presenza in studio di una signora, andò
in escandescenze, urlando come un forsennato e augurandomi, più o meno, di
marcire tra le scorie radioattive. Avevo appena affermato che tra i grandi mali
che ha dovuto subire l'umanità a causa di sè stessa - la schiavitù, il nazismo,
il comunismo, il terrorismo - l'ambientalismo li superava tutti: più
precisamente, dissi che l'ambientalismo è più pericoloso di comunismo + nazismo
+ terrorismo messi insieme. L'affermazione mi era (e mi è) talmente evidente che
provai enorme meraviglia nell'apprendere che essa fu disapprovata da quasi tutti
i miei amici e conoscenti che mi avevano seguito in trasmissione: «è stata una
inopportuna provocazione», fu il commento più benevolo; ma mi è rimasto il
dubbio se fu considerata «provocazione» perchè ritenuta falsa o perchè ritenuta
vera, una di quelle verità che non sta bene dire, insomma. Pensate che un mio
collega e amico mi invitò a tenere una conferenza pubblica all'università di
Bologna - moderata dal grande Piero Angela - ma si fece promettere solennemente
che non avrei ripetuto quella evidentemente indicibile frase. Io continuo a non
capire come agli esperti di fotochimica dell'ateneo più antico del mondo si
consenta di affermare pubblicamente che l'efficienza della trasformazione
dell'energia solare in biomassa è «quasi del 100%», una palese menzogna visto
che quell'efficienza è inferiore all'1%, mentre si vieti di affermare una palese
verità come quella da me enunciata. Pur non capendo, mi adeguai e mantenni la
promessa. L'occasione di tornare sull'argomento tabù me la fornisce niente meno
che Vaclav Klaus, già primo ministro e poi presidente della Repubblica Ceca,
valente economista, ottimo conoscitore della lingua italiana e ospite del
presidente Napolitano. Orbene, nel presentare il suo ultimo libro - Modrà,
nikoli zelenà planeta, di cui attendo con ansia un'edizione in una lingua a me
nota (in italiano dovrebbe fare "Un pianeta blu, non verde") - il presidente
Klaus ha dichiarato: «Il pericolo che sta correndo il nostro pianeta non è
quello che viene dall'effetto serra, che è una colossale menzogna; il vero
pericolo, e che ci viene dai Verdi e dalle loro menzogne, è la perdita della
libertà. L'ambientalismo è potenzialmente più pericoloso del comunismo». La
preoccupazione principale di Klaus è l'ineluttabile perdita di libertà che
seguirebbe dall'affermazione delle tesi ambientaliste: ne leggeremo le
argomentazioni nel suo libro, non appena disponibile. Per il momento, forte di
questa illustre consonanza di pareri, consentitemi di condividere con voi le mie
semplicistiche argomentazioni per ribattere a Pecoraro Scanio con quella frase
tabù. Il ministro aveva affermato che, se dipendesse dai Verdi, le emissioni di
anidride carbonica del mondo sarebbero, oggi, del 70% di meno. Vediamone le
conseguenze. Siccome il 90% dell'energia che usiamo proviene dai combustibili
fossili, e siccome l'80% dei costi di ciò che mangiamo sono, direttamente o
indirettamente, costi energetici, allora, se dipendesse dai Verdi, la
disponibilità di cibo del mondo sarebbe ridotta del 50%, come si calcola
moltiplicando 70x90x80. Circostanza che, per noi, significherebbe saltare il
pranzo e limitarsi alla colazione e alla cena; ma per un paio di miliardi della
popolazione mondiale significherebbe passare dalla condizione di limite di
sopravvivenza alla condizione di estinzione per fame. Che le cose stiano così, e
a dispetto del fatto che vorrebbero farci credere di poter colmare con l'energia
dal sole quel 70% (per ragioni tecniche l'energia dal sole non può colmare
neanche il 10%), ne sono consapevoli anche i Verdi: fateci caso, ma sta infatti
diffondendosi l'idea della «decrescita felice». Immagino che la felicità stia
nel fatto di non essere tra quei 2 miliardi destinati a morire di fame.
E sempre Franco Battaglia su “Il Giornale” parla
del grande bluff dell’energia solare. Credo di aver capito perchè Prodi e
Padoa-Schioppa sono stati obbligati ad aumentare vieppiù le tasse: Alfonso
Pecoraro Scanio si sarebbe messo in affari. Promuove egli la vendita di pannelli
fotovoltaici (FV), che naturalmente - nonostante gli aiuti che, da quando ha in
mano il potere di amministrare il nostro denaro, il ministro intende elargire -
nessuno compra perchè, anche se fossero gratis, continuano a essere proibitivi:
i soli costi di installazione e manutenzione non valgono, neanche
impercettibilmente, il risparmio energetico che ne consegue. Il ministro s'è
allora industriato e ha scritto a 8000 sindaci, suggerendo loro di installare i
pannelli FV sugli edifici pubblici e avvertendo che se non lo fanno
«spontaneamente» sarà il governo a imporre questa pazzia. Ed è una pazzia:
installare tanti pannelli FV quanti ne occorrono per erogare 1 GW elettrico (il
2% del nostro fabbisogno) richiede una spesa di 50 miliardi, cui bisogna
aggiungere, pronto ad avviarsi quando il sole non brilla, un impianto
convenzionale di pari potenza (che costa mezzo miliardo se a gas, 1 miliardo se
a carbone e 2 miliardi se nucleare). Se assumiamo che i pannelli FV mantengano
immutata la loro efficienza per 30 generosi anni, il combustibile nucleare che
si consumerebbe dopo 30 anni di esercizio di un reattore da 1 GW comporterebbe
una spesa di meno di 1 miliardo. Insomma, per non spendere 3 miliardi Pecoraro
Scanio e il governo tutto si apprestano a spenderne 52. Capiamo ora tutti perchè
Prodi e Padoa-Schioppa ci obbligano a queste elevate tasse: dobbiamo tutti
pagare molto affinchè i pochi amici di Pecoraro Scanio facciano i loro affari.
Se uno - sfidando tutte le figure retoriche - provasse a chiedere ragione della
pazzia, il ministro risponde candidamente che «quello del combustibile spento è
un problema non risolto, le scorie nucleari sono pericolose per 100.000 anni, e
sono minaccia di proliferazione e un obbiettivo dei terroristi». Almeno così ha
dichiarato in un'intervista televisiva ad un giornalista di Repubblica, il quale
palesemente non capiva un'acca ma si adeguava in tutto. Innanzitutto, cominciamo
col dire che il combustibile nucleare spento non è un rifiuto: esso consiste per
il 95% di uranio (l'elemento naturale di partenza) e per l'1% da plutonio, ed
entrambi, se opportunamente riciclati, sono perfettamente utilizzabili come
combustibile in reattori a ciclo chiuso. Il restante 4% è la componente
energeticamente inutilizzabile: ma 3.5% contiene nuclidi che o sono stabili o
dimezzano la loro attività ogni 24 ore, mentre 0.4% contiene nuclidi che
dimezzano la propria attività in meno di 10 anni. Alla fine, del combustibile
spento meno dello 0.1% (principalmente stronzio-90 e cesio 137) dimezza la
propria attività in circa 30 anni. In definitiva, è solo la componente
energeticamente inutilizzabile del combustibile nucleare che va trattata come
rifiuto e tenuta sotto controllo come già si fa ora, e per soli 100 anni circa e
non per i 100.000 fantasticati da Pecoraro Scanio: se l'energia elettrica che
ciascuno di noi consuma fosse tutta da fonte nucleare, le scorie annualmente
prodotte da ciascuno di noi occuperebbero il volume di una tazzina di caffè,
sono perfettamente gestibili, e quelle esistenti in 60 anni di nucleare non
hanno mai fatto male a nessuno. Secondo Pecoraro Scanio «i francesi usano il
nucleare perchè hanno la bomba atomica». Già, e usano i coltelli perchè avevano
la ghigliottina. Come le recenti cronache sull'Iran ci hanno informato, la
verità è che è infinitamente più semplice ottenere il materiale esplosivo per
una bomba da un impianto di arricchimento dell'uranio che non dal combustibile
spento di un reattore commerciale. Nè è pensabile che i terroristi possano avere
il minimo interesse verso il combustibile spento: hanno obiettivi ben più facili
da colpire, come il triste 11 settembre ci ha insegnato. Piuttosto, potessimo
mai persuaderli a sottrarlo dai luoghi ove è conservato, avremmo trovato il modo
per sbarazzarci di costoro. Non c'è nulla di non risolto nel problema della
gestione del combustibile spento. L'unico problema è avere dei politici che,
magari a prezzo di una manciata di voti, acconsentano che gli ingegneri facciano
il lavoro necessario per curarsi responsabilmente di quelli che impropriamente
vengono chiamati rifiuti nucleari. Il precedente governo, con grande e non
apprezzato senso di responsabilità, ci aveva provato. Questo governo, però,
incapace di affrontare il problema anche dei rifiuti ordinari in Campania, può
almeno vantarsi che nel paese di Pecoraro Scanio, in Campania, sono installati
più tetti FV che in qualunque altra parte d'Italia.
L'ecologia, un disastro nato per colpa di una
favoletta. L’inchiesta de “Il Giornale” apre nuovi scenari. Compie 50 anni la
"bibbia" ambientalista. Raccontava di una città morta per colpa del Ddt. Ma era
tutto inventato. Mentre i grandi leader del mondo si riuniscono invano a Rio per
l’inutile ecosummit, ricorre il 50mo anniversario della Primavera Silenziosa, la
Bibbia degli ambientalisti. Chi mi legge sa che io ritengo che l'ambientalismo -
assieme a schiavitù, nazismo, comunismo, terrorismo - sia uno dei grandi mali
che hanno afflitto l’umanità. Qualcuno dice che sono severo, qualcun altro
taglia corto e dice che sono provocatore e bugiardo. Facciamo così: giudicate
voi. È indubbio che l'ambientalismo è animato da, apparentemente e a parole,
ottime intenzioni, come peraltro ottime furono, almeno a parole, le intenzioni
di nazismo e comunismo. L'ottima intenzione dell'ambientalismo - di cui,
peraltro, proprio i gerarchi nazisti furono ardenti seguaci - è salvare il
pianeta. Da chi e/o da cosa? Da chi, dall'uomo stesso: siamo noi il cancro del
pianeta e come ogni cancro va estirpato con la forza. Da cosa, da una pletora di
pericoli che, però, sono per lo più fasulli. Porre in essere azioni per
alleviare rischi inesistenti o, peggio, per ignorare, non affrontare (o, sempre
peggio, aggravare) rischi reali, può avere conseguenze fatali e pandemiche.
Rachel Carson aveva iniziato gli studi universitari di biologia e, coerente con
una pratica che sarebbe diventata ricorrente tra gli ambientalisti, non riuscì a
completarli fino al dottorato: conseguì solo un bachelor (l'equivalente della
nostra odierna laurea triennale) e con diversi anni di ritardo rispetto ai
coetanei. Fallita come scienziata, si dette alla divulgazione contro la scienza.
Nel 1948 Paul Muller era stato premiato col Nobel per aver inventato la molecola
del Ddt, cruciale per la lotta contro il tifo e la malaria. Nel 1948, nella sola
isola di Ceylon (odierno Sri Lanka), si contarono 2 milioni di casi di malaria
che, grazie al Ddt, poi benedetto da Winston Churchill come «polvere
miracolosa», si ridussero a 31 casi nel 1962. E nel 1962 uscì Primavera
Silenziosa. Nel cui primo capitolo la Carson si inventò di sana pianta una città
così avvelenata dal Ddt che le primavere sarebbero appunto silenziose, a causa
della morte di tutte le specie di insetti e uccelli che altrimenti allietano le
orecchie di chi va per prati. La città naturalmente non esiste, ma lo stesso il
Ddt fu bollato nel libro come «l'elisir della morte», mentre invece stava
salvando milioni di vite umane. Cosa che continuò a fare fino a quando la
campagna lanciata dalla Carson e urlata dai movimenti ambientalisti (che stavano
al tempo nascendo) lo mise al bando, proibendone l'uso in tutto il mondo. La
conseguenza fu (è) che milioni di persone hanno ripreso (stanno continuando) a
morire per la malaria: da 650mila fino a due milioni l’anno. Il che dovrebbe già
rendere giustizia del paragone con nazismo e comunismo. Nel caso non ne foste
ancora convinti, continuate a leggere. Non contenti della strage della malaria,
i Verdi del mondo sono impegnati in altre non meno imponenti. La lotta
all'agricoltura con organismi geneticamente migliorati (Ogm) è una di queste. Vi
sono nel mondo oltre un miliardo di persone che, essendo la loro unica fonte di
nutrizione il riso (vegetale di propria natura privo di vitamina A), soffrono di
un grave deficit alimentare, che nei casi più severi causa cecità o anche morte
prematura. Se solo quelle persone potessero coltivare golden rice che,
geneticamente migliorato, è ricco di beta-carotene (un precursore della vitamina
A), il loro destino sarebbe meno miserabile. Ma non possono perché gli
ambientalisti del mondo hanno dichiarato la guerra agli Ogm. Un'altra tanto
tragica quanto ignorante lotta dei Verdi del mondo è quella per la riduzione
delle emissioni di CO2. Dovete sapere che l'85% delle azioni che facciamo
sfruttano energia prodotta con emissioni di CO2 (il restante 15% no, grazie a
nucleare e idroelettrico) e che l'80% dei costi del cibo nel nostro piatto sono
costi energetici: in pratica, la moderna agricoltura altro non è che la
trasformazione di petrolio in cibo. Orbene, ridurre le emissioni di CO2 del 50%
come prefigurano i Verdi (tra i quali brillano personaggi come Al Gore o il
Principe Carlo d'Inghilterra), a noi farebbe saltare la cena, ma porterebbe
centinaia di milioni di persone dalla condizione di morti-di-fame a quella di
morti per fame. E ora il vostro severo verdetto: ditemi se è vero o no che
l'ambientalismo ha o non ha fatto danni enormi, tali da farlo di diritto entrare
nella classifica dei grandi mali del mondo. E ancora più danni potrebbe fare se
i suoi insani propositi non saranno fermati.
Ma ci sono ecologisti ed ecologisti, ambientalisti
ed ambientalisti. Lì dove la sinistra non impone la sua ideologia e religione.
Di Paolo Bracalini su “Il Giornale” una dettagliata analisi. Bianchi, azzurri e
neri: ecco gli "altri" verdi. Nucleare, biotecnologie, infrastrutture: il
dibattito è aperto. Il punto di partenza è comune: non demonizzare lo sviluppo.
Interpreti delle varie anime del centrodestra rifiutano il catastrofismo di
sinistra. Sono isolati, spesso quasi invisibili all’opinione pubblica,
politicamente inesistenti oppure subalterni a un partito. Ma c’è una vera
galassia di associazioni, volontari, movimenti di verdi non-verdi, una
variopinta gamma di ambientalisti-ecologisti che però con il catastrofismo delle
organizzazioni ambientaliste classiche, ben più potenti, non hanno nulla a che
spartire. Eccoli qui, dunque, gli ambientalisti di destra. In realtà, appunto,
più che di un movimento organizzato si tratta di una galassia che al suo interno
mostra spaccature, differenze, e un’incapacità cronica di darsi un indirizzo
comune. Per dire, non c’è a destra niente di lontanamente paragonabile a una
corazzata come Legambiente, o tantomeno un’associazione planetaria come il Wwf.
Le riviste sono di ultranicchia, circoscritte ai volontari stessi. È un
ambientalismo spesso legato a iniziative territoriali, ad azioni concrete, che
in qualche modo paga il fatto di non avere un messaggio apocalittico da
diffondere, nessun allarme per l’innalzamento dei mari, nessuna spettacolare
sparizione di città sotto giganteschi tsunami, nessun ghiacciaio artico che si
squaglia, nessun Al Gore come testimonial. Ma chi sono gli ambientalisti di
destra? Si va dagli ex rautiani agli ecologisti nazionalisti, dagli
ambientalisti legati ad An alle associazioni cattoliche (anche qui
differenziate: cattolici di tradizione dc, Comunione e liberazione, francescani)
alle organizzazioni verdi padane, agli ambientalisti liberisti, agli esperimenti
di cooperative di agricoltori-ecologisti che contestano l’ecologia alla Pecoraro
Scanio. Partendo idealmente dalla destra di questa galassia, troviamo il mensile
di destra Area che ultimamente ha lanciato un manifesto per un nuovo
«patriottismo ambientale». «Ha ancora senso oggi - scrive su Area Salvatore
Santangelo - parlare di un nazionalismo verde inteso come amore per la propria
terra e come determinazione a difenderla dall’inquinamento, dalla speculazione,
dall’usura, dallo scatenamento delle logiche dell’utile». È un modo di guardare
al rapporto uomo-ambiente che richiama la tradizione del Msi e che si ritrova
infatti in «Fare verde», l’associazione ecologista nata nel 1987 in seno al
Fronte della gioventù e che oggi conta sedi in tutta Italia. Nel retroterra
culturale di questo ecologismo comunitario, antiprogressista e antiutilitarista,
si mescolano la critica al denaro di Ezra Pound, una visione mitico-pagana della
natura alla Tolkien, la lotta alla globalizzazione e alla tecnologia come
strumenti di alienazione dell’uomo, la contestazione del modello capitalistico
di sfruttamento delle risorse. Qualcosa che evidentemente li porta a convergere
spesso con l’ambientalismo di estrema sinistra. «Ma non vogliamo essere definiti
di destra - spiega Massimo De Maio, presidente di “Fare verde” -, perché sia la
destra che la sinistra italiane ormai sono subordinate al consumismo e all’idea
che la crescita della produzione e dei consumi sia la strada per il benessere.
Questo è falso. Anche il nucleare è un errore». Diverso l’approccio di
un’associazione ecologista espressione di Alleanza nazionale come «Ambiente e
vita» il cui presidente è Altero Matteoli, ex ministro dell’Ambiente dal celebre
motto: «Con me è nata l’ecologia di destra». Sempre nell’area di centrodestra si
colloca «Fare ambiente», movimento ambientalista con 20mila iscritti nato nel
2006 nell’ambito universitario, il cui manifesto contesta «una metodologia
anacronistica per tutelare l’ambiente e l’ecosistema». Ancora in questo spazio
si trova «Viva», l’associazione di Paolo Togni, ex capo di gabinetto di
Matteoli. Viva è impegnata soprattutto sul fronte educativo, con convegni,
seminari e pubblicazioni per combattere quello che nel programma della Onlus
viene definita «la micidiale combinazione tra conformismo e interessi dei poteri
forti di settore» che impedisce un’informazione completa e corretta in campo
ambientale. Condivide questa impostazione «Ambiente azzurro», associazione che
propugna «una politica propositiva e non di veto per la tutela ambientale e lo
sviluppo compatibile». Da non confondere con «Movimento azzurro», sempre di area
centrodestra ma di tradizione cattolica, o meglio democristiana. «Associazione
ambientalista d’ispirazione cristiana» nata nel 1987, «Movimento azzurro» è
impegnata nella ricerca e nella diffusione di «una cultura dell’equilibrio tra
natura e sviluppo». È esattamente questa parola, «sviluppo», la linea di
frattura a destra fra ecologisti progressisti ed ecologisti antiprogressisti.
L’area cattolica appartiene alla prima categoria, a partire da «Movimento
azzurro» fino ai più combattivi «Cristiani per l’ambiente» (sigla che comprende
17 associazioni) fondata da Antonio Gaspari, giornalista, scrittore e direttore
del Master in Scienze ambientali dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Qui
c’è una visione completamente diversa della natura rispetto all’ambientalismo
«pagano» della destra sociale. «Noi mettiamo al centro l’uomo, che non è in
conflitto con l’ambiente, ma anzi è in grado di salvarlo. E lo sviluppo non è un
male, ma la chiave del miglioramento perché è in grado di rendere più efficiente
tutto il sistema». Quindi sì al nucleare, alle nuove infrastrutture, alle
biotecnologie. «È una nuova ecologia umana», riassume Gaspari. Ancora in ambito
cattolico c’è da segnalare Svipop (Sviluppo e popolazione), agenzia on line
guidata da Roberto Cascioli; Sorella natura, fondazione ambientalista ispirata a
San Francesco d’Assisi; e Umana dimora, associazione ecologista appartenente
alla Compagnia delle opere (ovvero Cl); Forza verde, associazione
cattolico-moderata. Ma al di là degli ambientalisti cattolici, di quelli della
destra ex missina o di An, ci sono altre espressioni di una cultura ecologista
alternativa. Una è l’Istituto Bruno Leoni che promuove il pensiero libertario e
con il dipartimento Ambiente guidato da Carlo Stagnaro è impegnato su due
fronti: la critica del catastrofismo verde e la promozione di un approccio
realistico che vede nello sviluppo la chiave del rapporto con l’ambiente. O
ancora la rivista XXI Secolo, nata negli anni ’90 «per contrastare l’ideologia
ambientalista che ha chiuso il nucleare in Italia», spiega il fondatore Massimo
Martelli, «ma non si può prescindere dalla questione energetica per lo sviluppo
del Paese». Un’altra linea è quelle aperta dalla Federazione ambiente e
agricoltura (Faa), associazione nata da un gruppo di rappresentanti del mondo
rurale italiano nel 2007. Dopo oltre vent’anni, la politica ambientalista in
Italia ha mostrato tutti i suoi possibili limiti. «L’ambientalismo in Italia -
si legge nel programma della Faa - ha dimostrato di non comprendere innanzitutto
le ragioni di agricoltori, allevatori, pescatori, cacciatori. Il nostro
obiettivo è ridare all’ambiente e all’agricoltura il giusto valore all’interno
della società, favorendo l’integrazione tra la civiltà rurale e quella urbana».
I piccoli imprenditori legati alla Faa rappresentano la parte del mondo agricolo
e produttivo, in particolare del Nord, che ha trovato una rappresentanza nel
ministro leghista dell’Agricoltura Luca Zaia, come anche nel movimento
Padaniambiente, sempre della Lega nord. L’ambientalismo leghista però, pur
distanziandosi dall’ecologia alla maniera dei verdi, non ha contorni del tutto
precisi e comprende una forte componente di rivendicazione identitaria e
localistica che guarda con sospetto, per esempio, alle biotecnologie, alle
tecnologie, e anche all’energia nucleare. Insomma una galassia turbolenta:
ambientalisti padani d’accordo con l’ecologismo anti antropocentrico della
destra sociale su nucleare e ogm, ma all’antitesi dei cattolici che invece
mettono l’uomo e i suoi bisogni al centro della natura, come fanno gli
ecologisti liberali, ma da un’angolazione laica. Come si diceva, nell’area
culturale del centrodestra c’è una sensibilità ecologica che non ha una
direzione precisa, unitaria, che è divisa - o profondamente contrapposta - tra
nostalgie romantiche e ottimismo tecnologico, tra tradizionalismo bucolico e
fiducia nella tecnica come mezzo per il miglioramento dell’uomo e del suo
ambiente.
Da sempre gli ambientalisti e gli ecologisti ci
propinano eventi catastrofici dovuta alla cattiva gestione del patrimonio
naturale. Per loro la cementificazione, la deforestazione, ecc. ecc.. sono la
causa dell’ “effetto serra”. Spesso una pianta, secondo la loro ideologia
politica, che è anche confessione religiosa, ha più diritto di un essere umano.
Questa diatriba ha fatto si che le posizioni fossero inconciliabili: da una
parte gli speculatori edilizi hanno distrutto ambienti unici e da salvaguardare,
dall’altra parte si è impedito il progresso sociale ed economico in territori
arretrati, ovvero hanno divelto le fonti di ricchezza e di sostentamento. La
mancanza di buon senso ha impedito la regolarizzazione dello sviluppo. Quindi in
virtù degli estremismi e dei fondamentalismi siamo in presenza di luoghi
deturpati ovvero sotto fruttati. Tralasciando l’invasione dei sistemi
eco-mafiosi di energia alternativa (solare, fotovoltaica, eolica) che hanno
soppiantato, sui terreni occupati, le culture autoctone su cui era poggiata
l’economia locale.
Bene in risposta alle tante bugie che inondano i
media ecco la sorpresa.
Il patrimonio forestale italiano è aumentato di
circa 1,7 milioni di ettari negli ultimi 20 anni raggiungendo oltre 10 milioni e
400 mila ettari di superficie, con 12 miliardi di alberi che ricoprono oltre un
terzo dell'intero territorio nazionale. A questi importanti dati si affiancano
oggi i risultati dell'indagine sulla quantità di carbonio contenuto nei suoli
forestali italiani. Tale attività, unica in Europa su così vasta scala, mette in
evidenza come il suolo forestale svolga un ruolo fondamentale nello
''stoccaggio'' di carbonio organico, addirittura superiore a quello della parte
epigea del bosco. La quantità di carbonio trattenuta nei tessuti, nei residui
vegetali e nei suoli delle foreste, infatti, è pari a circa 1,2 miliardi di
tonnellate di carbonio, corrispondenti a 4 miliardi di tonnellate di CO2. Il 58
per cento di tutto il carbonio forestale è contenuto nel suolo, mentre quello
accumulato nella vegetazione arborea e arbustiva è il 38 per cento. Il restante
4 per cento è presente nella lettiera, nei residui vegetali e nel legno morto.
In particolare, il carbonio contenuto nel suolo è di oltre 700 milioni di
tonnellate. Tali risultati sottolineano l'importanza dei suoli forestali, non
solo per la loro funzione di difesa idrogeologica, di conservazione e tutela
della biodiversità e di base per la produzione di legname, ma anche per la
mitigazione dei cambiamenti climatici in atto. Questi i principali risultati
emersi dall'ultimo Inventario Nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali
di Carbonio (INFC) del Corpo forestale dello Stato, realizzato con la consulenza
scientifica del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura -
Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale CRA-MPF di
Trento e contenuti in un nuovo volume tematico. I dati sono stati presentati il
19 aprile 2012 a Roma alla presenza di Mario Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, Corrado Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello
Stato e Giuseppe Alonzo, Presidente del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura.
Le foreste italiane, come contenitori naturali di
carbonio, svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento dell'obiettivo
fissato dal Protocollo di Kyoto, strumento operativo vincolante della
Convenzione quadro sui cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (Unfccc),
frutto della Conferenza sull'Ambiente di Rio de Janeiro del 1992. Lo scopo del
Protocollo è quello di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra su scala
globale al fine di contenere l'innalzamento della temperatura del pianeta e i
relativi cambiamenti climatici in corso, determinati dall'aumento della
concentrazione di tali gas. I boschi ricoprono un ruolo centrale come
assorbitori e contenitori di anidride carbonica, che e' il principale gas ad
effetto serra, e sono fondamentali nella mitigazione e nell'adattamento ai
cambiamenti climatici in corso. Il Protocollo di Kyoto ha iniziato la sua
attività operativa il 1 gennaio 2008 e terminerà il primo periodo d'impegno il
31 dicembre 2012. Attualmente l'Italia è vicina al raggiungimento dell'obiettivo
fissato dagli accordi internazionali, in quanto si è avuta una riduzione delle
emissioni totali dei gas serra del 5,4 per cento, a fronte di un impegno pari al
6,5 per cento. Un obiettivo che sarà possibile raggiungere anche grazie alle
foreste che assumono in questo contesto un'importanza non solo ecologica ma
anche economica. La componente di carbonio forestale calcolata dal Protocollo di
Kyoto, infatti, è quantificata in circa 1-1,5 miliardi di euro per il periodo
2008-2012, che l'Italia risparmierà evitando le possibili sanzioni dovute al
mancato raggiungimento dell'obiettivo fissato.
Ma la tutela del patrimonio ambientale non è "Cosa
ambientalista".
''Nel nostro Paese le foreste descrivono una
grande ricchezza di diversità biologica e con 12 miliardi di alberi oggi
occupano quasi il 35 per cento della superficie territoriale. Ma questo non
basta - spiega la Cia - Solamente attraverso una corretta gestione delle foreste
è possibile garantire tutte le funzioni che queste svolgono. C'è necessità,
insomma, di recuperare e di rafforzare la gestione e la manutenzione delle
foreste, anche perché rappresentano una delle principali risorse per lo sviluppo
delle aree rurali e montane e sono fonti straordinarie non solo di ossigeno, ma
di occupazione, reddito e materie prime rinnovabili''. ''Un compito che sembra
cucito addosso agli agricoltori, non solo perché circa il 40 per cento delle
aziende del settore è interessato dai boschi, ma anche perché già oggi gli
agricoltori sono in prima linea nella salvaguardia del patrimonio forestale del
Paese, fungendo da 'guardiani' del territorio contro gli incendi e il degrado
dei versanti e da 'custodi' delle tradizioni del mondo rurale - conclude - Di
conseguenza si candidano naturalmente a essere parte attiva nella manutenzione
delle foreste, e quindi del 'polmone verde' d'Italia''.
UNO STUDIO RIDIMENSIONA IL BENEFICO CONTRIBUTO
DEGLI ALBERI NELLA RIDUZIONE DEI GAS SERRA
Chiamando in causa i microscopici organismi che
popolano il suolo e la loro pericolosa produzione di gas. La capacità delle
piante di catturare anidride carbonica dall’atmosfera è sempre stata considerata
un’arma efficace contro il pericoloso aumento dei gas serra. Tuttavia lo studio
pubblicato su Nature da Kees Jan van Groenigen (Trinity College di Dublino),
Craig Osenberg (University of Florida) e Bruce Hungate (Northern Arizona
University), sottolinea come si sia trascurata un’importante conseguenza. Una
più intensa attività degli alberi e la conseguente maggiore crescita, infatti,
sfociano inevitabilmente in una maggiore disponibilità di nutrienti per i
microorganismi che popolano il suolo. Peccato che il metabolismo di questi
ultimi produca metano e protossido d’azoto, due gas serra ben più dannosi
dell’anidride carbonica. I dati raccolti dai ricercatori in 49 esperimenti
condotti in Europa, Nord America e Asia su foreste, zone umide, praterie e campi
coltivati – comprese le risaie – hanno mostrato che questa produzione
supplementare di gas serra finisce col ridurre di almeno il 16% la mitigazione
del riscaldamento globale esercitata dalle piante. Un risvolto inaspettato del
quale i climatologi dovranno necessariamente tener conto nel rifinire i loro
scenari.
ECOLOGIA, AMBIENTE E MEDIA: LOTTA DI PARTE E DI
FACCIATA.
Gli allarmi pretestuosi pubblicizzati con
l'ausilio del megafono della stampa di sinistra.
Proponiamo come esempio il filmato, trasmesso da
Matrix diretto da Enrico Mentana. Il video è stato prodotto dall'emittente
britannica Channel Four. L'impianto non ammette repliche, davanti alla
telecamera sfilano una decina di esperti che dimostrano, dati alla mano,
l'infondatezza dell'effetto serra. Il riscaldamento globale viene presentato
come l'effetto dell'attività solare, gli ambientalisti come una lobby che affama
le popolazioni africane in nome delle fonti rinnovabili e la CO2 (anidride
carbonica) una conseguenza della temperatura che periodicamente si innalza nei
secoli e nei millenni. Il fatto curioso è che mentre in Inghilterra la
trasmissione del servizio ha provocato enormi polemiche, in Italia la cosa è
passata del tutto inosservata, tanto quanto il fiasco del mega concerto mondiale
Live Earth. Tutto questo lascia molte domande aperte.
E’ un curioso paradosso quello per cui la
sinistra, nel corso degli ultimi decenni, è riuscita a impossessarsi della
“questione ambientale”, e ha finito con l’incarnarne la sensibilità e i
contenuti. Le istituzioni e le organizzazioni che si occupano di ambiente sono
invariabilmente affiliate alla sinistra. Non v’è manifestazione, commemorazione,
fiera, festa o evento di sinistra che non ospiti stand di ambientalisti,
conservazionisti, ecologisti. La parola ambiente, in breve, ha finito col far
rima con sinistra. E quando è invece accostata alla destra, produce uno iato
assordante. Ciò ha prodotto due conseguenze. La prima è che l’ambientalismo è
divenuto ostaggio dell’opposizione ideologica al capitalismo, allo sviluppo, e
all’Occidente. Si è trasformato esso stesso in ideologia radicale, nel perenne
tema di tutti i “movimenti” che contestano l’ordine globale, il capitalismo, la
società occidentale - e come sempre in questi casi, l’America. Per un
presupposto ideologico tout court: l’America è il simbolo del capitalismo; il
capitalismo è contro la natura, ed è di destra; l’ambientalismo è soltanto di
sinistra, e pertanto non può che essere anti-capitalista e anti-occidentale. Ma
più stupefacente è la seconda conseguenza - che in realtà è al contempo causa.
E’ stata la destra a legittimare una simile “appropriazione indebita”
dell’ambientalismo da parte della sinistra.
Come? Disinteressandosi dell’ambiente, ostinandosi
a difendere posizioni indifendibili - come il supporto senza se e senza ma
per qualsiasi tipo di capitalismo, o la negazione testarda e incomprensibile
della minaccia che i cambiamenti climatici rappresentano per il futuro del
pianeta. Scegliendo, in sostanza, di accettare la vulgata per cui l’ambiente è
davvero roba di sinistra. E iniziando a parlare il linguaggio che i suoi
detrattori - fautori dell’ambientalismo esclusivamente di sinistra e
anti-occidentale - le hanno attribuito, senza alcuna reale motivazione o
giustificazione se non un’opposizione ideologica e una strategia politica: il
linguaggio della derisione delle ragioni dell’ambientalismo. Così facendo, la
destra ha però non soltanto rinnegato alcune tra le più importanti e ricorrenti
radici della propria identità – che storicamente si è nutrita della passione per
l’ambiente e della riscoperta della natura come fonte di un’idea sana e vigorosa
del popolo e della “nazione” (persino troppa passione, divenuta estrema,
talvolta). Ha anche commesso un imperdonabile errore politico, lasciandosi
scippare l’ambiente e l’immenso capitale elettorale che esso, oggi più che mai,
rappresenta. L’abbandono dell’ambiente è uno dei peccati capitali della destra
contemporanea. Perché la obbliga a recitare - ovunque siano in gioco tematiche
ambientali anche cruciali come i cambiamenti climatici - la parte arcigna e
impopolare dello sviluppo a tutti i costi e della derisione dell’ambientalismo.
E siccome oggi la sensibilità ambientalista è diffusa ed è divenuta un capitale
politico, elettorale e sociale gigantesco, la sinistra continua, per inerzia, a
mietere consensi e a perpetuare l’immagine negativa di una destra distruttiva e
priva di scrupoli ecologisti. Ma invece di riconoscere il problema, e cercarvi
una soluzione che sfrutti il capitale umano, sociale, finanziario ed economico
che lo stesso capitalismo è in grado di creare - a dispetto della retorica no
global e anti-occidentale - la destra si arrampica sugli specchi. Per negare
legittimità alla scienza, che ormai unanimemente concorda sulla minaccia dei
cambiamenti climatici, e per ignorarne le ripercussioni, che pure sono già sotto
gli occhi di tutti i cittadini - dalle conseguenze profetiche dell’uragano
Katrina all’emergenza idrica in mezzo mondo. Continua ad accusare gli esperti e
gli scienziati di allarmismo, insincerità, propaganda. Si arrocca su posizioni
insostenibili, e soprattutto non giustificate. Non giustificate, semplicemente
perchè è un’illusione ottica e un vizio mentale quello per cui l’ambientalismo
debba essere appannaggio della sinistra.
Deforestazione, crisi dell'acqua, esplosione
demografica, inquinamento atmosferico, buco dell'ozono, esaurimento delle
risorse, effetto serra... Gli SOS lanciati dalle organizzazioni ambientaliste
profetizzano la fine prossima del pianeta. In questo libro gli autori intendono
dimostrare, attraverso dati e casi concreti, che il solo scopo di queste
organizzazioni è raccogliere fondi per operazioni demagogiche, ideologiche e
politiche che nulla hanno a che fare con la salvaguardia della Terra. Tutte le
bugie della religione ambientalista secondo Benedetta Bellin. Il novecento
potrebbe essere descritto dagli storici del futuro come il secolo dei sacrifici
umani. Questi non si sarebbero verificati soltanto per l’avvicendarsi di due
guerre mondiali, ma anche per l’affermarsi di una ideologia che affondando le
proprie radici nell’illuminismo e nel darwinismo, si impone a tutto l’Occidente,
identificandosi nel sogno di una umanità sempre più perfetta e autodeterminata,
libera dal bisogno di Dio.
L’ideologia in questione è quella che gli
scienziati chiamano ecologia. Le bugie degli ambientalisti di Riccardo Cascioli
e Antonio Gaspari, è un’opera che mina alla radice il pensiero ‘Eco’ svelando,
attraverso delle attente analisi, le reali intenzioni dei movimenti
ambientalisti celate dalla loro solo apparente innocenza. L’ecologismo ha la sua
“Bibbia” in numerosi saggi: in particolare, gli autori ricordano "Primavera
Silenziosa" del 1962, scritto da Rachel Carson, la biologa statunitense che in
un’intervista alla CBS denunciava la grave situazione dei suoli agricoli
infestati dai pesticidi con queste parole:“Man is a part of nature, and his war
against nature is inevitably a war againgst himself” (L’uomo è parte della
natura e combattere contro la natura è inevitabilmente una lotta contro se
stesso). L’allarme della questione ambientale è stato fatto risuonare al mondo
da una rapporto del Massachusset Institute of Technology (MIT) con il titolo di
“Limits to growth” (Limiti alla crescita) nel 1972. Il principale pericolo
secondo il pensiero ecologista è da rintracciare nella crescita demografica: il
pianeta secondo le stime del MIT dovrà sopportare un carico demografico
raddoppiato nel prossimo secolo con la conseguente sovrappopolazione e l’aumento
di domanda di risorse alimentari e naturali. La crescita demografica e l’uso
eccessivo di risorse accelerano il degrado delle risorse: la desertificazione,
l’erosione dei suoli, il prosciugamento delle falde, sono dei funesti esempi. Il
politologo Giovanni Sartori ne “La Terra scoppia: sovrappopolazione e sviluppo”
(Rizzoli 2003), scrive:“Se la follia umana non troverà una pillola che possa
curare, e se questa pillola non sarà vietata dai folli che ci vogliono in
incessante moltiplicazione, il regno dell’uomo arriverà a malapena al 2100. Tra
un secolo di questo passo, il pianeta Terra sarà mezzo morto e gli esseri umani
anche”. Tuttavia, i sacrifici umani invocati dagli illustri campanelli
d’allarme, possono essere facilmente raggiunti: l’eugenetica, la pratica
dell’aborto e il movimento di estinzione umana volontaria, notano Cascioli e
Gaspari, sono i cavalli di Troia dell’ideologia ecologista.
L’ipotesi ‘Gaia’ di James Lovelock ("Gaia: nuove
idee sull’ecologia", Boringhieri, 1981) è poi l’emblema dell’ecologismo come
ideologia che denigra l’uomo quale cancro del pianeta:“Gli uomini sulla terra si
comportano come un organismo patogeno o cellule di un tumore o di una neoplasia.
La specie umana è oggi talmente numerosa da costituire una grave malattia
planetaria”. L’ecologismo, pertanto, spiegano i due autori, si pone come un
ritorno al paganesimo che tende a idolatrare la Madre Terra, Gaia o Demetra e a
sostituirla al Dio della tradizione giudaico-cristiana e alla visione
antropocentrica della Bibbia, dove gli esseri umani sono al centro del mondo
poiché considerati qualitativamente superiori ad altre forme naturali. Questa
forma di religiosità primitiva ha un unico obiettivo di fondo: attaccare il
cristianesimo e con esso il Vaticano. A coloro che sostengono siffatta ideologia
e religiosità pagana, a coloro che ricercano un mondo nuovo à la Aldus Huxlev
(1932), dove regna il controllo mondiale e la libertà è sostituita dalla
stabilità, possiamo rispondere con le parole di G. K. Chesterton (1935):“Nei
tempi in cui Huxley, Herbert, Spencer e gli agnostici vittoriani strombazzavano
sulla famosa idea di Darwin quasi fosse una verità definitiva, sembrò a migliaia
di persone semplici, praticamente impossibile che la religione potesse
sopravvivere. Ironia della sorte fu che è sopravvissuta non solo a tutti
costoro, ma che è la dimostrazione ideale (forse l’unica dimostrazione concreta)
di ciò che chiamavano la sopravvivenza del più forte”.
Le bugie degli ambientalisti. Il catastrofismo è
ormai il gusto corrente. Lo scienziato americano Gregory D. Foster in un
articolo pubblicato sul World Watch Institute Magazine, rivista edita
dall’omonima “multinazionale” ambientalista, dichiara che «i disastri
ambientali provocati dai cambiamenti climatici minacciano il futuro dell’
umanità in misura enormemente più grave rispetto al terrorismo. Dal 1968 i
gruppi eversivi hanno ucciso 24 mila persone, ogni anno invece ne muoiono 240
mila per i danni del clima». E la catastrofe è dietro l’angolo. Secondo Foster,
l’attuale surriscaldamento del nostro pianeta sta provocando dei cambiamenti
climatici che provocheranno, in una sorta di tragico effetto domino, «un mondo
futuro di Stati in guerra tra loro per la sopravvivenza», una sorta di guerra
planetaria che vedrà l’umanità scontrarsi militarmente per aver accesso alle
derrate alimentari. E non finisce qui, se proprio qualcuno fosse sopravvissuto a
tale babele, dovrà fare i conti con il riscaldamento della massa terrestre, che
darà luogo a catastrofi ambientali sempre più frequenti e che saranno
l’anticamera di una nuova era glaciale.
Chi inizia ad aver dubbi sulla fondatezza degli
allarmi lanciati dalle major ambientaliste, può leggere un libro molto
interessante, fuori dal coro, che parla di eco-ottimismo: “Le bugie degli
ambientalisti 2”. I due autori, Riccardo Cascioli e Antonio Gaspari, smontano,
pezzo per pezzo, tutti i falsi allarmi a cui abbiamo dovuto dar ascolto in
questi ultimi decenni. Tanto per gradire: è stato detto che la popolazione
mondiale sta per raddoppiare e questo condurrà gran parte di noi ad una morte
sicura per fame. In realtà non è possibile prevedere un contemporaneo aumento
della popolazione e della mortalità. Tale concetto nasce da due processi
contrari che non possono coesistere: aumento della popolazione non significa
aumento della mortalità. La popolazione riesce a svilupparsi solo se le
condizioni di vita e l’alimentazione lo permettono. E’ stato detto che ogni
giorni scompaiono dalla faccia della terra 30 km di boschi, ma nel libro si
legge che le rilevazioni satellitari hanno mostrato che dal 1982 al 1999 le aree
boschive sono aumentate del 6%. E’ stato detto che questo benedetto
riscaldamento della terra è causato dalle crescenti emissioni di CO2 prodotte
dalle industrie, mentre è stato scientificamente dimostrato che l’uomo incide
solo per il 4% sul totale delle emissioni. Il dato più importante che emerge
dalla lettura del libro è quello rappresentato dallo stretto collegamento fra
alcune associazioni ambientaliste e le società di eugenetica inglesi ed
americane, finanziate da ricchi magnati, che cercano, in sostanza, di combattere
la povertà eliminando (fisicamente) i poveri. A conferma di quanto detto ci sono
tutte le battaglie finora promosse dalle più potenti associazioni ambientaliste
del pianeta. L’opposizione agli OGM, i messaggi terroristici sul riscaldamento
globale, la presunta sparizione delle foreste, la promozione delle “domeniche
ecologiche” e delle targhe alterne, hanno come denominatore comune il voler
dimostrare che la sovrappopolazione della terra mette a rischio la natura e
quindi è necessario ricorrere a tecniche di riduzione delle nascite (da attuare,
naturalmente, nei paesi poveri). L’ecologismo dunque diventa esso stesso una
religione in cui viene eliminata ogni differenza ontologica tra uomini e altri
esseri viventi. La stessa natura diventa una divinità: Gaia. Ed in nome di Gaia
sacrificheremo l’uomo celebrando il trionfo del matrimonio di interessi fra
Eugenetica ed Ecologismo sul modello di Sparta: loro rincorrevano la perfezione
della razza eliminando i più deboli, noi proteggiamo la nostra terra eliminando
le popolazioni povere.
“Le bugie degli ambientalisti” di Riccardo
Cascioli, Antonio Gaspari. I falsi allarmismi dei movimenti ecologisti. Le bugie
degli ambientalisti sono tali e tante che un libro non è bastato per
smascherarle tutte. Si trova nelle librerie dopo il primo volume "Le bugie degli
ambientalisti" 2. I falsi allarmismi dei movimenti ecologisti, il seguito del
testo di Riccardo Cascioli e Antonio Gaspari pubblicato dalla casa editrice
Piemme dedicato all'ideologia ecocatastrofista nelle sue varie espressioni.
Molti sono gli spunti di riflessione contenuti in questo secondo volume, che
esce proprio mentre a Nairobi un vertice mondiale discute di cambiamenti
climatici e problemi ambientali e in concomitanza con la presentazione del
rapporto 2006 dell'Undp, il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite,
intitolato «Oltre la scarsità: potere, povertà e crisi globale dell'acqua».
È da segnalare in particolare la prima parte del
saggio («Tutto ciò che dovreste sapere sulla natura»), in cui molto giustamente
gli autori documentano e quantificano ciò che gli ecologisti, tesi soltanto a
contenere l'impatto della presenza umana sul pianeta, di rado prendono in
considerazione: vale a dire che la natura stessa, il pianeta e le specie animali
e vegetali che ospita, consuma e inquina incidendo a sua volta sui tanto
temibili cambiamenti climatici. Sul fronte dei consumi di energia e di risorse
naturali, un singolo fulmine consuma energia elettrica quanto migliaia di
famiglie e, secondo i calcoli degli scienziati, sulla terra ne cadono in media
almeno 100 al secondo. Nel regno animale, poi, le formiche contendono il primato
dei consumi alimentari all'elefante e alla balenottera azzurra, il più grande
dei mammiferi, che divora quattro tonnellate di crostacei al giorno per tutti i
90 anni della sua vita. Le formiche Rufe, che vivono esclusivamente sulle Alpi,
sono circa 300 miliardi sparse in un milione di nidi. L'entomologo italiano
Mario Pavan, dell'Università degli Studi di Pavia, ha calcolato che ogni Rufa
operaia mangia ogni giorno una quantità di cibo pari a un ventesimo del proprio
peso, il che porta il consumo totale della popolazione di formiche Rufe alpine a
circa 24.000 tonnellate di cibo all'anno.
A inquinare irreparabilmente l'atmosfera, invece,
sono prima di tutto i vulcani; una eruzione di grandi dimensioni emette circa 17
miliardi di tonnellate di biossido di carbonio (uno dei gas responsabili
dell'effetto serra), pari a due volte e mezza l'emissione annua mondiale
derivante dalle attività umane; da solo il Monte Pinatubo, nelle Filippine, nel
1991 ha inoltre emesso circa 30 milioni di tonnellate di biossido di zolfo, il
gas principale responsabile del fenomeno delle piogge acide. Inquinano anche,
soprattutto nei maggiori centri urbani, le piante, rilasciando dei composti
volatili organici che causano, ad esempio, il 15% delle polveri sottili di Los
Angeles e il 6% di quelle di Milano. I bovini addomesticati, da parte loro,
emettono metano e protossido di azoto producendo con le loro «fermentazioni
enteriche» quantità di gas serra che in Francia ammontano ogni anno a 26 milioni
di tonnellate, mentre lo stoccaggio delle loro deiezioni ne libera altre 12
tonnellate. Per questo in Nuova Zelanda tre anni fa si erano proposte variazioni
nella dieta delle mucche, al fine di ridurre i danni ambientali arrecati dai
loro processi digestivi: un'idea abbandonata perché comportava l'assunzione di
olio di fegato di merluzzo, che avrebbe dato alle bistecche e agli arrosti gusto
di pesce. Nel 2000, invece, l'Unione Europea aveva preso in considerazione
l'idea di introdurre una «tassa sulle mucche» per i Paesi prevalentemente
agricoli, come ad esempio l'Irlanda; un progetto per ora accantonato.
Non stupirebbe allora se, prima o poi, in
controtendenza con le strategie ambientaliste finora adottate, qualcuno
proponesse di abbattere le piante urbane o, in alternativa, di tassare le
amministrazioni comunali e i privati cittadini in ragione del verde di cui sono
responsabili. Nella stessa logica, l'Italia potrebbe subire sanzioni e imposte
per i suoi troppi vulcani attivi?
Dalle auto ibride alle foreste: i falsi miti degli
ambientalisti. Inchiesta provocatoria dell'Indipendent che smonta molti dei
dogmi degli ecologisti a cura di Valerio Gualerzi su “La Repubblica”. Per
qualche ambientalista potrà avere lo stesso effetto che le celebri vignette
danesi hanno scatenato tra i musulmani più intransigenti. L'Independent,
quotidiano inglese di certo non sospettabile di antipatie ecologiste, ha
pubblicato infatti uno speciale per smontare molti dogmi verdi. Le conclusioni
sono tutto sommato opinabili e destinate a far discutere all'infinito, ma
decisamente sorprendenti. Nel bene come nel male. Nella prima categoria rientra
ad esempio il giudizio sulla Cina, vista da molti ambientalisti (sempre meno in
realtà), come il "Grande Satana" dell'inquinamento. In realtà, sottolinea
l'inchiesta del giornale britannico, Pechino sta infilando una lunga serie di
mosse positive ed è in pole position per diventare il vero leader della
rivoluzione energetica verde. ''La Cina - scrive l'Independent - è sulla via per
divenire un'economia a bassa produzione di CO2'' e ormai le sue industrie non
producono solo giocattoli e paccottaglia a basso prezzo, ma anche pannelli
solari, turbine eoliche e batterie ricaricabili. Nella seconda categoria, ovvero
tra i miti "salvifici" che gli ambientalisti farebbero bene a mettere in
soffitta, secondo il quotidiano c'è invece l'auto ibrida. Protagonista degli
ultimi saloni motoristici internazionali e grande speranza di un'industria alla
disperata ricerca di una via d'uscita verde dalla crisi, le vetture a doppia
alimentazione benzina/elettricità per il giornale britannico possono inquinare
in realtà più di un vecchio diesel. Tra i miti da dissacrare il giornale segnala
anche la tutela delle antiche foreste. Non che siano dannose ovviamente, ma il
loro contributo nella lotta al riscaldamento globale va drasticamente
ridimensionato. Gli alberi vecchi, sostiene l'Independent in uno dei passaggi
più discutibili dell'inchiesta, non assorbono infatti CO2 come quelli giovani e
quando muoiono liberano tutta l'anidride carbonica che hanno utilizzato. Per
questo - è la provocatoria tesi del giornale - meglio abbatterli e farci sedie,
scrivanie, costruzioni, risparmiando in materiali chimici equivalenti. Purché
naturalmente si proceda a sostituirli con alberi nuovi che nei primi 55 ani di
vita assorbiranno il maggior quantitativo di anidride carbonica.
Altro dogma messo a dura prova dall'inchiesta è
quello del "buy local", ovvero della spesa a chilometri zero. Il conteggio delle
emissioni prodotte per ogni chilo di alimenti, si sottolinea, non dipende
infatti necessariamente dalla distanza rispetto a chi li consuma, ma
dall'efficienza energetica con cui vengono prodotti e distribuiti. L'Independent
sposa infine due soluzioni che per gli ambientalisti sono vere e proprie bestie
nere: utilizzo degli ogm in agricoltura e ritorno al nucleare. I primi, afferma
il giornale, possono dare un importante contributo nella lotta alla fame nel
mondo, mentre l'energia dell'atomo produce solo il 5% delle emissioni di CO2
rispetto al gas e rappresenta una fonte alla quale non si può rinunciare.
I crediti da anidride carbonica renderebbero il
WWF ed i suoi partner molto più ricchi, senza nessuna effettiva riduzione della
CO2, afferma Christopher Booker del The Telegraph Se il più grande e ricco
gruppo ambientalista, il WWF, annuncia di giocare un ruolo cardine nell'ambito
della preservazione di un'area della foresta amazzonica grande il doppio della
Svizzera, molti applaudono, pensando che ciò sia semplicemente una delle cause
per le quali il WWF è stato fondato. Da molto tempo l'Amazzonia è in testa alla
lista delle preoccupazioni ambientali mondiali, non solo perchè ovviamente
ospita la foresta pluviale più vasta e ricca di biodiversità del mondo, ma anche
perchè i suoi miliardi di alberi rappresentano il più grande deposito naturale
di CO2. Quindi ogni minaccia alla foresta rappresenterebbe anche un contributo
all'aumento del riscaldamento globale. E' emersa però un'agenda nascosta circa
la preservazione di questa parte di foresta che consiste nel permettere al WWF
ed ai suoi partners di condividere la vendita di crediti di emissione di
anidride carbonica per un valore di 60 miliardi di dollari, per permettere alle
compagnie industriali di continuare ad emettere CO2 esattamente come nel
passato. L'idea alla base di ciò è che i crediti connessi alla CO2 immagazzinata
in questa specifica parte di giungla - così fuori mano da non temere minacce
immediate - potrebbero essere venduti sul mercato internazionale, in modo da
permettere a migliaia di compagnie nel mondo sviluppato di compensare la
restrizione all'emissione di anidride carbonica. L'effetto pratico sarebbe
semplicemente quello di rendere il WWF ed i suoi partner molto più ricchi senza
minimamente contribuire ad abbassare il livello globale delle emissioni di CO2.
Il WWF, che già guadagna 400 miliardi di Sterline
annualmente, la maggior parte dei quali provenienti dai governi e dai
contribuenti, è da molto tempo il cardine del dibattito sulle minacce alla
foresta amazzonica, come si evince anche dall'entusiasmo ricevuto da un ben
pubblicizzato passaggio nel rapporto del 2007 dell'IPCC. Comunque la
dichiarazione, da parte dell'IPCC, che il 40% della foresta è minacciata dal
riscaldamento globale, si è scoperto che non è basata su nessuna evidenza
scientifica, ma semplicemente sulla propaganda del WWF, che ha pienamente
distorto i risultati di uno studio preliminare sulle minacce poste alla foresta,
non dai cambiamenti climatici bensì dal taglio del legname. Questa curiosa saga
risale al 1997, quando il protocollo di Kyoto allestì quello che è noto come
CDM, vale a dire il Meccanismo sullo Sviluppo Pulito. Questa misura permette
alle compagnie basate nei paesi in via di sviluppo che dichiarino di aver
ridotto le proprie emissioni di gas serra, di guadagnare miliardi di sterline
vendendo le loro quote di emissioni nei paesi sviluppati che siano obbligati dal
protocollo di Kyoto a tagliare le proprie emissioni. Nel 2001 i paesi aderenti
al procollo hanno raggiunto un accordo in base al quale gli alberi nell'emisfero
meridionale possono essere considerati come "depositi di anidride carbonica" a
beneficio delle compagnie che emettono CO2 nell'emisfero settentrionale. Nel
2002, dopo una lunga negoziazione col WWF ed altre organizzazioni non
governative, il governo brasiliano approntò il progetto Arpa (Aree protette
della regione amazzonica), sostenuto da circa 80 miliardi di dollari di
finanziamento. Di questi, 18 miliardi furono dati al WWF dalla fondazione
americana Gordon & Betty Moore, 18 miliardi forniti dal governo brasiliano al
partner locale del WWF e 30 miliardi dalla Banca Mondiale. Lo scopo era di far
amministrare aree della foresta pluviale brasiliana dalle organizzazioni non
governative, capeggiate dal WWF, per assicurare sia che fossero lasciate intatte
oppure gestite in modo "sostenibile". Fra queste la parte più vasta era
costituita da 31.000 miglia quadrate situate presso l'inaccessibile frontiera
settentrionale del Brasile, metà della quale designata come Parco Nazionale di
Tumucumaque, la più vasta riserva naturale del mondo, mentre l'altra metà da
sottoporre a sviluppo sostenibile lasciandola fondamentalmente intatta. La zona
interessata è talmente fuori mano da non temere minacce da parte di taglialegna,
minatori o agricoltori. Giunti a questo punto, tutto ciò può apparire come
appartenente al mono degli ideali. A dispetto dell'accordo internazionale circa
il considerare le foreste come "depositi" naturali di anidride carbonica, non
esisteva ancora un sistema per tramutare questa CO2 "risparmiata" in merce
scambiabile. Nel 2007, comunque, il WWF ed i suoi alleati presso la Banca
Mondiale lanciarono la Alleanza Globale sulle Foreste, con un finanziamento
iniziale di 250 milioni di dollari da parte della Banca, per lavorare con quella
che fu battezzata "deforestazione evitata". Ad una conferenza a Bali, sotto gli
auspici della Convenzione sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite
(UNFCCC), che amministra il CDM (Meccanismo sullo Sviluppo Pulito), fu raggiunto
un accordo su uno schema chiamato REDD (Riduzione delle emissioni da
deforestazione nei paesi in via di sviluppo). Lanciata in grande stile come "la
nuova grande idea per salvare il pianeta da un cambiamento climatico oramai
fuori controllo", questa iniziativa istituì un fondo globale per salvare vaste
aree di foresta pluviale dalla deforestazione che rappresenta circa un quinto
delle emissioni di CO2 di origine antropica. Ma ancora non esisteva un
meccanismo per tramutare tutta questa CO2 "risparmiata" in merce vendibile.
Allora il WWF trovò un alleato chiave nel Centro di Ricerca Woods Hole,
Massachusetts, da non confondere con il vicino Istituto Oceanografico Woods
Hole, un ente scientifico in buona fede. Nel 2008, con un finanziamento di 7
milioni di dollari da parte della Fondazione Moore e lavorando in partenariato
col Progetto Tumucumaque, il Woods Hole se ne uscì con l'idea che mancava: un
modo cioè di valutare l'anidride carbonica immagazzinata nelle foreste pluviali
protette del Brasile, per fare in modo che questa potesse essere scambiata sotto
il meccanismo CDM. Il programma Arpa quindi calcolò in 5.1 miliardi di
tonnellate questa anidride carbonica "risparmiata". Basato su una valutazione da
parte dell'UNFCCC di 12,50 dollari a tonnellata di CO2, questo permetteva di
considerare gli alberi delle aree protette brasiliane aventi un valore di oltre
60 miliardi di dollari. Sostenuto dalla Banca Mondiale, questo progetto fu
presentato all'UNFCCC. Ma vi erano ancora due ostacoli da superare. Il primo era
che lo schema doveva essere adottato come parte del REDD dalla Conferenza di
Copenhagen 2009, che avrebbe dovuto dare vita ad un nuovo trattato in
sostituzione di quello di Kyoto. Questo avrebbe permesso di monetizzare la CO2
brasiliana sotto lo schema CDM. Il secondo era che gli USA avrebbero dovuto
adottare lo schema "cap and trade" per imporre un severo limite alle emissioni
di CO2 da parte delle industrie americane. Questo avrebbe incrementato il
mercato internazionale della CO2, facendo schizzare alle stelle i prezzi non
appena le industrie americane si fossero accalcate per comprare i crediti che
avrebbero permesso loro di continuare ad emettere la quantità di CO2 necessaria
alla loro sopravvivenza. Per quel che è dato di sapere, però, la storia non è
andata secondo quanto previsto. Nella baraonda di Copenhagen a dicembre 2009,
tutto ciò che si è potuto salvare delle proposte del REDD è stata una
dichiarazione di principio, con l'auspicio di raggiungere un consenso più ampio
in Messico a fine 2010. Nella confusione di Copenhagen è andato anche perso il
minuscolo intento che avrebbe garantiti i diritti delle popolazioni che vivono
nelle foreste pluviali, il cui tenore di vita - con le preoccupazioni di gruppi
come Survival International e il Forest Peoples Programme - è stato altrove già
seriamente compromesso dagli schemi ispirati dal REDD, come ad esempio in Kenya
e Papua Nuova Guinea. Un'altro evento che ha allarmato il WWF ed i suoi alleati,
che stavano sperando di ricavare miliardi di dollari dalle foreste brasiliane, è
stata la mancata approvazione del progetto di legge del Senato Usa sul "cap and
trade", sponsorizzato dal presidente Obama. Poichè l'Unione Europea ha escluso
dal proprio schema di "cap and trade" le foreste pluviali, prendere nella rete
gli USA è vitale per le speranze del WWF di trovare "soldi che crescono sugli
alberi". Intanto il prezzo dell'anidride carbonica presso la Chicago Climate
Exchange è appena piombato al suo minimo storico dio sempre, vale a dire 10
centesimi di dollaro a tonnellata. Il sogno del WWF è stato ostacolato - ma
anche la sola rivelazione che sia parte di una tale disegno può avere una
influenza considerevole sulla percezione che il pubblico ha di quella che è la
più ricca fra le organizzazioni ambientaliste.
PARLIAMO DELL’ITALIA DEI VELENI
Tutta la stampa e la tv ne parla..finalmente! A
Taranto, per colpa dell'inquinamento, ci si ammala più di tumore di quanto su
dovrebbe. Salgono il numero di malattie cardiovascolari per via del
benzoapirene, prodotto quasi esclusivamente dall'Ilva. E sono segnalate anche
anomalie nei tumori che colpiscono i bambini. Questi i risultati della perizia
epidemiologica depositata dai tecnici esperti nominati dal gip di Taranto,
Patrizia Todisco, davanti alla quale si è svolto l’incidente probatorio
nell´inchiesta per disastro ambientale ai cinque vertici Ilva. L'indagine,
affidata a tre specialisti, ha accertato l'esistenza di una possibile
connessione tra le malattie, le morti causate da tumori e l'inquinamento
prodotto dalle emissioni dagli impianti industriali dell'Ilva. E' la seconda
parte della maxi-indagine: la prima, svolta dai chimici, ha già accertato la
pericolosità delle sostanze inquinanti per la salute di lavoratori e cittadini
di Taranto. Oltre 500 pagine per mettere nero su bianco che dall'Ilva di Taranto
vengono emesse in atmosfera sostanze come diossine e Pcb, pericolose per i
lavoratori e la popolazione. E' la prima verità sull'inquinamento a Taranto,
dove è stata depositata la relazione dei periti chimici che costituisce la prima
parte della maxi perizia sull'Ilva, disposta nell'ambito di un incidente
probatorio, che dovrà accertare se le emissioni di fumi e polveri dallo
stabilimento siderurgico siano nocive alla salute umana nell'inchiesta al maxi
colosso. I documenti sono ora al vaglio del gip Patrizia Todisco, che ha
nominato gli esperti e disposto l'accertamento peritale durato oltre un anno. Ad
essere indagati sono Emilio Riva, presidente dell'Ilva spa sino al 19 maggio
2010, Nicola Riva presidente dell'Ilva dal 20 maggio 2010, Luigi Capogrosso,
direttore dello stabilimento Ilva, Ivan Di Maggio, dirigente capo area del
reparto cokerie, Angelo Cavallo, capo area del reparto Agglomerato. Le accuse
sono disastro colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione
dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di
beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose, inquinamento
atmosferico. "L'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi
dall'impianto siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni
degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi
di malattia e di morte". E' quanto sostengono i periti Annibale Biggeri, docente
ordinario all'università di Firenze e direttore del centro per lo studio e la
prevenzione oncologica, Maria Triassi, direttore di struttura complessa
dell'area funzionale di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed
epidemiologia applicata dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di
Napoli, e Francesco Forastiere, direttore del dipartimento di Epidemiologia
dell'Asl di Roma. I periti sono stati incaricati dal gip Todisco nell'ambito
dell'incidente probatorio sull'llva chiesto dal procuratore capo Franco
Sebastio, dall'aggiunto Pietro Argentino e dal sostituto Mariano Buccoliero.
"Nei sette anni considerati, per Taranto nel suo complesso, si stimano 83
decessi attribuibili ai superamenti del limite Oms di 20 microgrammi al metro
cubo per la concentrazione annuale media di Pm10. Nei sette anni considerati per
i quartieri Borgo e Tamburi - rilevano ancora i periti - si stimano 91 decessi
attribuibili ai superamenti Oms di 20 microgrammi al metro cubo per la
concentrazione annuale media di PM10". E ancora nei sette anni considerati per
Taranto "si stimano - sempre secondo la perizia - 193 ricoveri per malattie
cardiache attribuibili ai superamenti del limite Oms di 20 microgrammi al metro
cubo per la media annuale delle concentrazioni di Pm10 e 455 ricoveri per
malattie respiratorie". Le emissioni dello stabilimento Ilva causano malattie e
90 morti l’anno nella popolazione di Taranto. È quanto hanno stabilito i medici
nominati dal gip Patrizia Todisco nella perizia epidemiologica per comprendere
lo stato di salute dei tarantini in relazione agli inquinanti emessi dallo
stabilimento siderurgico. Nelle 282 pagine che compongono il documento
depositato, Annibale Biggeri, Maria Triassi e Francesco Forastiere, hanno
risposto ai tre quesiti posti dal giudice. Su richiesta del pool di inquirenti,
il gip ha infatti chiesto ai tre esperti di individuare le patologie derivanti
dall’esposizione agli inquinati emessi dallo stabilimento industriale, il numero
dei morti e degli ammalati attribuibili all’inquinamento prodotto dagli impianti
di proprietà del gruppo Riva. A Taranto, secondo i periti, tra il 2004 e il 2010
vi sarebbero stati mediamente 83 morti all’anno attribuibili ai superamenti di
polveri sottili nell’aria, mentre i ricoveri per cause cardio-respiratorie
ammonterebbero a 648 all’anno. La media dei decessi sale però fino a 91 se si
prendono in considerazione i quartieri Tamburi e Borgo, geograficamente più
vicini alla fabbrica. “L’analisi per i quartieri Borgo e Tamburi – scrivono i
periti – mostra che, nonostante la ridotta numerosità, una forte associazione
tra inquinamento dell’aria ed eventi sanitari è osservabile e documentabile solo
per questa popolazione”. Ironia della sorte però, il record per i decessi e
ricoveri per malattie croniche spetta al quartiere Paolo VI, il rione costruito
proprio per ospitare, dopo la nascita del polo siderurgico negli anni ’60, i
nuovi cittadini di Taranto: coloro cioè che dalle campagne della provincia si
trasferirono in città per diventare operai. A Paolo VI, infatti, vi è una
percentuale maggiore rispetto alla media complessiva della città e i decessi
dovuti a malattie dell’apparato respiratorio sono addirittura superiori del 64%.
Ma non è solo la lunga esposizione a creare danni secondo i periti. Nei bambini
e negli adolescenti fino a 14 anni, i periti hanno infatti accertato “un effetto
statisticamente significativo per i ricoveri ospedalieri per cause respiratorie”
e un’elevata presenza di tumori in età pediatrica. La situazione peggiore è
quella che riguarda gli ex operai dello stabilimento siderurgico. L’analisi “dei
lavoratori che hanno prestato servizio presso l’impianto siderurgico negli anni
’70-’90 – allora Italsider acquisita Gruppo Riva nel 1995 e denominata Ilva, ndr
– con la qualifica di operaio ha mostrato un eccesso di mortalità per patologia
tumorale (+11%), in particolare per tumore dello stomaco (+107), della pleura
(+71%), della prostata (+50) e della vescica (+69%). Tra le malattie non
tumorali sono risultate in eccesso le malattie neurologiche (+64%) e le malattie
cardiache (+14%). I lavoratori con la qualifica di impiegato hanno presentato
eccessi di mortalità per tumore della pleura (+135%) e dell’encefalo (+111%). Il
quadro di compromissione dello stato di salute degli operai della industria
siderurgica è confermato dall’analisi dei ricoveri ospedalieri con eccessi di
ricoveri per cause tumorali, cardiovascolari e respiratorie”. Dopo la prima
relazione sulle condizioni ambientali della città, questo nuovo documento,
contribuisce a fare chiarezza sui danni causati dalle emissioni inquinanti.
Gli esiliati di Cerano. Da cinque anni non possono
più coltivare le loro terre che si trovano ridosso della più grande centrale
termoelettrica a carbone d'Italia, in provincia di Brindisi. L'Enel,
proprietaria del sito, si difende: 'nessuna violazione di legge'. Intanto offre
sei milioni di euro come contributo agli agricoltori. Ne parla l’inchiesta di
“La Repubblica”. Il Reportage di Sonia Gioia. Coltivazioni proibite vicino alla
centrale. L'ombra del carbone sui terreni contaminati. Quattrocento ettari
avvelenati da arsenico, berillio e altri metalli pesanti. Sono le aree agricole
a ridosso della grande centrale termoelettrica Federico II di Cerano, a pochi
chilometri da Brindisi. Ora un'inchiesta della procura salentina cerca di
accertare la responsabilità dell'impianto nell'inquinamento delle terre. La
perizia disposta dai pm non lascia dubbi: "E' la principale via di
contaminazione". Ma uno studio commissionato dall'Enel, proprietaria del sito,
parla di "origine naturale". Polvere di carbone sui campi di Cerano. Polvere
nera sulle mani, nelle case, sui panni stesi ad asciugare. Polvere nera sui
campi fertili, coltivati un tempo a vite, carciofi, ulivi, che una volta davano
da mangiare ai contadini e ai loro padri. Carbone forse anche nel sangue. Negli
oltre quattrocento ettari di terre all'ombra della centrale Federico II di
Cerano non si può più coltivare ormai da cinque anni per effetto di una
ordinanza che ha intimato la distruzione dei frutti dei quali è disposto il
divieto assoluto di commercializzazione. Ma anche l'esilio coatto degli oltre
sessanta agricoltori che su quei campi non possono lavorare più di 180 giorni
all'anno, pena il rischio di contaminazione da arsenico, berillio, vanadio,
metalli pesanti dall'alto potenziale tossico rilevati in quantità superiori alle
soglie considerate non pericolose per la salute. Come se per tenere in vita la
terra bastassero cure a intermittenza. Da un lustro i contadini di Cerano
chiedono di sapere cosa abbia avvelenato i campi e forse loro stessi. Lo hanno
chiesto tramite un esposto indirizzato alla procura di Brindisi dalla quale è
scaturita una inchiesta che solo oggi giunge al capolinea. Il pubblico ministero
Giuseppe De Nozza ha notificato di recente l'avviso di conclusione delle
indagini a carico dei quindici indagati, fra dirigenti Enel e imprenditori
addetti al trasporto del carbone che alimenta la centrale, accusati di getto
pericoloso di cose, danneggiamento delle colture e insudiciamento delle
abitazioni. Sono le accuse che gravano tra gli altri sul direttore della
centrale, i responsabili dell'area Ambiente e dell'impianto trasportatore.
L'azienda, contattata da Repubblica, non rilascia dichiarazioni, ma in una nota
si dice fiduciosa: "In merito alla decisione della Procura di Brindisi, Enel -
si legge - nella piena convinzione di aver sempre operato nel rispetto delle
leggi e nell'interesse della collettività, attende con fiducia i successivi
sviluppi". Le conclusioni del pubblico ministero poggiano su quelle del perito
al quale è stato chiesto di verificare se è vero oppure no che quella polvere
nera sia polvere di carbone. Nessun dubbio per il consulente tecnico della
procura Claudio Minoia, direttore del laboratorio di misure ambientali e
tossicologiche della Fondazione Maugeri di Pavia, nonché responsabile della
scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell'ateneo pavese: la fonte
di contaminazione di terreni, colture, falda acquifera e atmosfera è la centrale
termoelettrica, non i camini delle villette come pure qualcuno ha sostenuto, né
il traffico automobilistico. E' il vento che solleva il pulviscolo dal deposito
(scoperto) del combustibile, ammantando le colture: "Il consulente tecnico
ritiene - scrive Minoia - che in aree prospicienti la centrale Federico II
ubicata a Cerano si siano determinate, anche se non con carattere di continuità
ma piuttosto come diretta conseguenza di fenomeni eolici, dispersioni
significative di polveri di carbone dal deposito carbonile. Questa ha
sicuramente rappresentato la principale via di contaminazione delle aree
prospicienti". E' esattamente quello che aveva sostenuto la Asl di Brindisi nel
2007, in una nota propedeutica al divieto di coltivazione emanato dal sindaco,
avvertendo dei pericoli per la salute se ortaggi, frutta e polveri fossero
arrivati dai campi alle tavole dei brindisini: "...è più che ragionevole
sospettare la possibilità che le sostanze chimiche riscontrate possono entrare
nel ciclo biologico di produzione sia vegetale che animale e, conseguentemente,
passare nella catena alimentare con grave rischio per la salute dei
consumatori". Le stesse conclusioni a cui giunge l'equipe di ricercatori ai
quali nel 2009 il Comune di Brindisi aveva commissionato un'analisi di rischio,
effettuata dall'Università del Salento e Arpa Puglia. Le analisi su prelievi e
campionamenti rilevano la presenza di metalli pesanti nell'area, stigmatizzando
come pericolosa per la salute dei coltivatori l'esposizione superiore ai sei
mesi all'anno. Lo studio conclude individuando come "fonte potenziale più
probabile" delle emissioni "la centrale Enel Federico II, con particolare
riferimento alla gestione del carbonile". Nello stesso anno, un dossier
divulgato da Medicina democratica avverte: "L'emissione di anidride carbonica è
quindici volte superiore alla soglia nella centrale di Cerano. L'arsenico, il
cadmio, il cromo, gli idrocarburi policiclici aromatici e il benzene, tutti
cancerogeni in grado di provocare diversi tipi di tumori, superano
abbondantemente la soglia". A tutt'altre deduzioni giunge invece uno studio
commissionato da Enel all'istituto di ricerca Erm (Environmental resources
management spa), sempre nel 2009, secondo cui "le concentrazioni rilevate sono
di origine naturale". "Lo studio ha dimostrato - scrivono i ricercatori Erm -
che la concentrazione dei metalli nei terreni non è riconducibile ad alcuna
sorgente puntuale e/o specifica attiva, nel presente e/o nel passato, sull'area
di interesse. Tale concentrazione è invece riconducibile a quanto viene
universalmente riconosciuto, anche da Apat, come valore di fondo o fondo
naturale". Nessuna relazione, dunque, fra la mole della centrale elettrica, il
deposito-carbonile scoperto e la dispersione di polveri di carbone su carciofeti
e vigneti andati distrutti. Le conclusioni di Erm vengono supportate e
avvalorate da tre docenti di altrettanti atenei italiani, Giacomo Lorenzini
dell'Università di Pisa, Pierluigi Giacomello dell'Università di Roma e Luigi De
Bellis, a capo del dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali
dell'Università del Salento. Strano caso: l'università del Salento giunge dunque
sul tema a esiti del tutto in antitesi. Anzi, è dalla stessa cattedra di
Fisiologia vegetale dell'ateneo leccese che arrivano conclusioni opposte. Nello
studio Erm-Enel il professore titolare del corso, Luigi De Bellis, dice che no,
il livello di contaminazione da arsenico è del tutto nella norma. Nell'analisi
di rischio condotta insieme ad Arpa, la stessa cattedra (sulla carta, altro
ricercatore) dice che la quantità di arsenico è al limite del livello di guardia
e che prudente per la salute dei lavoratori agricoli sarebbe non esporsi più di
sei mesi all'anno. Una delle incognite alle quali dovrà rispondere il processo
che verrà. Quel che è certo è che, nel frattempo, al danno si è aggiunta la
beffa. Nel giugno del 2009 Enel ricorre al Tar, per scongiurare la pioggia di
richieste risarcitorie provenienti dagli agricoltori, sostenendo la
illegittimità della ordinanza, fondata su termini "possibilistici ed eventuali"
di nessuna evidenza scientifica. La magistratura amministrativa dà ragione al
colosso energetico per una ragione su tutte: l'analisi di rischio commissionata
ad Arpa e Università del Salento è stata condotta in ritardo, due anni dopo
l'emanazione della ordinanza sindacale, il percorso avrebbe dovuto essere
esattamente contrario. Potenzialmente insomma, nei terreni di Cerano oggi si
potrebbe coltivare, ma se lo fai la Asl ti trascina in tribunale, come è
successo a uno degli agricoltori. Uno di quelli che si sono rifiutati di
accettare soldi dal colosso energetico in cambio della rinuncia all'azione
penale. Il punto resta un altro. I prodotti della terra maledetta non li vuole
più nessuno, e i contadini stessi su quei campi hanno paura di lavorare, per
timore di morire avvelenati dal cancro. Psicosi. Forse. L'ateneo del Salento,
chiamato in causa da entrambe le parti, giunge attraverso due studi a
conclusioni diverse. Il responsabile della relazione commissionata dall'Enel,
Luigi De Bellis: "Valutazioni effettuate in tempi e con scopi differenti". Uno
l'ateneo, due le conclusioni, sebbene il quesito a monte fosse lo stesso, ossia
se i terreni di Cerano siano inquinati oppure no. La cattedra di Fisiologia
vegetale dell'Università del Salento giunge sul medesimo tema a conclusioni in
antitesi: nello studio commissionato ad Erm (l' Environmental Resources
Management) da Enel il professore titolare del corso, Luigi De Bellis, dice che
no, il livello di contaminazione da arsenico è del tutto nella norma.
Nell'analisi di rischio condotta insieme ad Arpa, la stessa cattedra dice che la
quantità di arsenico è al limite del livello di guardia e che prudente per la
salute dei lavoratori agricoli sarebbe non esporsi più di sei mesi all'anno. "La
contraddizione è solo apparente", spiega De Bellis, "allo studio dell'Università
del Salento essendo in quel periodo consulente Enel, non ho partecipato, come
facilmente verificabile da frontespizio del documento". Le conclusioni
discordanti insomma, sarebbero secondo il docente "relative a due studi che non
solo sono stati realizzati in tempi diversi e con presupposti e scopi differenti
ma che, in particolare quello dell'Università del Salento, per ragioni varie,
non hanno incluso o considerato il quadro di insieme costituito dai molti dati
raccolti negli anni precedenti da altre fonti, ovvero studi realizzati da gruppi
indipendenti e indipendentemente dall'esistenza e dalla attività della Centrale
di Cerano". De Bellis rivendica la attendibilità delle conclusioni dello studio
Erm che "erano e sono in perfetto accordo con le analisi effettuate da Sviluppo
Italia nel 2005-2006, le quali hanno rivelato che metalli pesanti (in
particolare arsenico) sono presenti a concentrazioni superiori ai valori soglia
per i Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (mentre non sono ancora
stati definiti i valori soglia per i terreni agricoli) nei terreni limitrofi al
nastro trasportatore di Cerano. Da notare che l'uso dei valori soglia relativi a
siti ad uso verde pubblico è inappropriato per i terreni agricoli. Questo
problema è ben noto nel mondo scientifico tanto che presso il Ministero delle
Risorse Agricole è al lavoro, da anni, una commissione che ha il compito di
definire una tabella specifica per i terreni agricoli". La cartina al tornasole
dell'attendibilità delle conclusioni di Erm, secondo De Bellis sta anche nel
fatto che le stesse analisi "rilevano generalmente concentrazioni di metalli
pesanti più elevate in profondità (come indicato nella relazione di Sviluppo
Italia un "incremento della diffusione della contaminazione da arsenico con
l'aumentare della Profondità") cosa ben difficile da spiegare ipotizzando che la
fonte di inquinamento sia polvere di carbone proveniente dal carbonile; se la
fonte fosse il carbonile avremmo necessariamente maggiori concentrazioni in
superficie". Le varie tipologie di carbone utilizzato da Enel secondo Erm ma
anche secondo Luigi De Bellis mostrano un contenuto percentuale in metalli
pesanti inferiore ai valori riscontrati nel terreno, "gli altri contaminanti
organici presenti (pesticidi ed idrocarburi) nei terreni dell'area Cerano non
hanno alcuna relazione con il carbone e, con la loro presenza, indicano che
esiste (o è esistita) una diversa fonte inquinante". Per concludere il
professore rivendica il diritto alle divergenze nel mondo accademico e
scientifico, e arriva a scomodare Galileo: "Almeno nell'Università non esistono
posizioni "uniche" ed ancora rimane la possibilità di dissentire. Infatti, nel
mondo scientifico le varie tesi vengono messe in discussione in funzione di
argomenti logici e scientifici con arbitri indipendenti che stabiliscono quale
sia la migliore. Ma l'ipotesi che raccoglie la maggioranza dei pareri positivi
non sempre è quella giusta (Galileo insegna), perché a volte gli arbitri non
sono indipendenti o perché per ragioni varie omettono di considerare alcuni
degli aspetti della questione". Sei milioni di euro dividono i contadini. E
arriva Zamparini con i pannelli solari. Per scongiurare eventuali azioni penali
degli agricoltori l'Enel ha offerto una somma per la riconversione produttiva
dell'area. Ma le associazioni sono divise sulla firma dell'accordo. Intanto si è
fatto avanti il patron del Palermo che punta a utilizzare i campi 'contestati'
per installare un grande impianto fotovoltaico. "Nessuna responsabilità sulla
presunta contaminazione dei terreni a Cerano", sul punto l'Enel non ammette
repliche. E' dunque per "puro spirito di liberalità" che la società offre agli
agricoltori (ma soprattutto a sindacati, associazioni di rappresentanza degli
stessi oltre che al Comune di Brindisi), una somma pari a 6.100.000 euro per la
riconversione produttiva dell'area. Riconversione produttiva che non sta per
"risarcimento", attenzione. La parola va considerata tra quelle proibite. La
cifra vale come un cadeux milionario che servirà in buona parte per la
piantumazione di una barriera arborea, una muraglia verde che intrappoli il
pulviscolo nero di carbone, dietro la quale eclissare centrale termoelettrica,
carbonile e nastro trasportatore. Almeno alla vista. C'è un dettaglio, però, che
ha fatto la differenza fra chi si è immediatamente dichiarato disponibile a
sottoscrivere l'accordo e chi no. Il patto di sangue con Enel prevede infatti
che con quei soldi i contadini continuino a rimanere proprietari delle loro
terre, dalle quali dovranno sradicare filari di malvasia e carciofi che un tempo
crescevano rigogliosi per piantare (a casa loro e con le loro braccia)
eucalipti, falso pepe e oleandri. L'offerta, si capisce, ha avuto come
conseguenza diretta quella di spaccare il fronte dei piccoli imprenditori
agricoli, molti dei quali hanno sottoscritto l'accordo con il colosso energetico
che in cambio ha chiesto la rinuncia all'azione penale. Nero su bianco,
naturalmente. L'accordo-quadro è stato sottoscritto il 21 giugno 2011 dopo una
trattativa durata anni. Le firme in calce sono quelle dell'ex sindaco Pdl
Domenico Mennitti, che nel 2007 firmò il divieto di coltivazione, di
Confcooperative, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Ugc-Cisl. Fra i firmatari
figura anche l'associazione Agricoltura ambiente e natura, giunta alla
sottoscrizione tramite un percorso tortuoso, a dir poco. A un certo punto della
storia infatti, l'associazione sbatte la porta e si ritira dal tavolo insieme al
Codiamsa, un altro degli organismi di rappresentanza dei contadini esiliati. Per
entrambe le sigle l'accordo è un patto capestro a tutto danno di quelli che si
pretende di beneficiare: con i soldi intascati i contadini devono acquistare gli
alberi, le macchine agricole per piantumarli e provvedere alla manutenzione.
Come dovranno fare dopo di loro i loro figli, e poi i nipoti, e i pronipoti:
tanto per 15mila euro ad ettaro, una tantum. In sostanza, di questi sei milioni,
alle sessanta famiglie arriverà solo una parte. Detratte le spese per gli alberi
e le quote spettanti alle associazioni, ai sindacati e al Comune di Brindisi, a
loro non resterà molto. Dopo avere ratificato la propria uscita di scena insieme
a Codiamsa, l'associazione Agricoltura ambiente e natura rientra in extremis
nella trattativa, suggellando l'accordo finale. Cosa è successo, nel frattempo?
Che sui terreni di Cerano ci ha messo gli occhi Maurizio Zamparini. Il patron
del Palermo calcio vuole costruire nell'area una distesa da 200 megawatt di
pannelli fotovoltaici, l'impresa che si propone a nome del Zamparini nazionale è
la Tre emme energia. A sorpresa però, l'iniziativa incassa la sonora bocciatura
della Provincia di Brindisi che non concede le autorizzazioni. Il progetto, dice
l'ente, fa acqua da tutte le parti e la documentazione per la richiesta di Via è
piena di falle. Naturalmente, Zamparini & co non demordono. "Il progetto sarà
rilanciato", lo giura l'avvocato Giovanni Brigante che per conto della Tre emme
energia si è occupato dell'attività immobiliare, l'acquisto dei terreni o del
diritto di superficie. Chi è Brigante? Personaggio uno e trino, consulente di
Zamparini ma anche segretario dell'associazione Agricoltura ambiente e natura,
rientrata in corsa nella ratifica dell'accordo di programma con Enel. Un
repentino cambio di programma, che Brigante spiega in questi termini: "La
premessa è che la cifra offerta da Enel non è un risarcimento, ma un contributo
per la riconversione, che fa salva la possibilità di richiedere la liquidazione
del danno ambientale in via amministrativa, così come previsto dal testo unico
in materia. Enel ha, fra l'altro, già versato al ministero una somma a titolo di
risarcimento del danno ambientale, noi chiederemo al dicastero stesso
l'indennizzo per equivalente in favore degli agricoltori. Con le somme già
incassate ci siamo costituiti inoltre in consorzio, e stiamo mettendo a punto
dei progetti di riconversione, che vadano naturalmente oltre la piantumazione
della barriera arborea consentendo un reddito sostitutivo". In cosa consistano
questi progetti, Brigante non lo dice, tutto top secret per il momento. In
realtà molti elementi fanno pensare che il progetto fotovoltaico di Zamparini
possa effettivamente andare in porto. Basta che la Tre emme energia lo
ripresenti adeguandolo alle prescrizioni della Provincia e adeguandolo alle
nuove indicazioni della legge che vieta l'impianto di pannelli a terra. Ma
aggiunge: "Molti degli agricoltori della nostra associazione sono alle prese con
decreti ingiuntivi per i quali rischiano persino di rimanere senza casa, abbiamo
fatto di necessità virtù percorrendo la via che ci sembrava più breve per
consentire loro di garantirsi un'altra prospettiva, un'altra fonte di reddito".
Una tesi che non convince il Codiamsa, assistito dall'avvocato Vincenzo Farina.
L'agronomo Antonio Nigro, referente dell'associazione spiega perché: "Vorrei
precisare intanto che non si tratta di una questione esclusivamente economica.
L'Enel offre soldi per la riconversione produttiva, ma non a titolo di
indennizzo o acquisto dei terreni. In sostanza gli imprenditori agricoli
dovrebbero accettare di lavorare sui propri campi, quelli che fino a qualche
anno fa producevano frutti che davano da mangiare a loro e alle loro famiglie,
per l'impianto di una barriera arborea. La cifra insomma non tiene minimamente
in conto dei redditi che le famiglie percepivano grazie alla coltivazione dei
prodotti dell'agricoltura destinati al commercio. Il vantaggio è tutto del
colosso elettrico, al quale occuparsi della barriera in proprio costerebbe
enormemente di più di quello che propone ai contadini, piegati dal comprensibile
terrore di lavorare in un'area che mette a rischio la loro salute. Val la pena
di precisare inoltre che la somma proposta verrebbe versata a rate diluite in
dieci anni esatti, alla scadenza dei quali la barriera non si potrebbe più
espiantare per legge. Dopo quella data insomma, tutto ricadrebbe sulle spalle
dei contadini e dei loro figli, sempre a favore dell'Enel. Un'ipoteca, di
generazione in generazione".
L'ITALIA DEI VELENI
Sul tema dell’amianto e su altri veleni Emiliano
Fittipaldi ed altri autori hanno scritto varie inchieste pubblicate da
“L’Espresso”.
L'Italia dei veleni di Emiliano Fittipaldi.
Amianto. Piombo. Diossine. Idrocarburi. Il rischio sostanze tossiche colpisce un
quarto della popolazione. Spese negli anni cifre da capogiro. Ma spesso le
bonifiche non sono neanche partite. Dici Orbetello e pensi alle spiagge bianche,
alla Maremma incontaminata e agli allevamenti di spigole. A nessuno verrebbe in
mente che il cuore dell'Argentario è inserito dal 2002 nella lista dei siti più
inquinati d'Italia. La laguna è così compromessa che Altero Matteoli, sindaco
del paesino durante i week-end e ministro delle Infrastrutture il resto della
settimana, è riuscito ad inserirla per intero nell'area da bonificare per legge,
che inizialmente prevedeva la pulizia solo della fabbrica di fertilizzanti della
Sitoco. "La Sitoco? E chi la dimentica... Noi da ragazzi si andava a giocare
nel bosco dietro le ciminiere", ricorda un ristoratore, "quando s'alzava il
maestrale era uno spettacolo, la mia R4 bianca si ricopriva di una polverina
arancione che non veniva più via. Con la fabbrica mangiavano duecento famiglie,
ma devo ammettere che quella polverina dava noia alla gola. Pizzicava pure gli
occhi". La polverina era in realtà anidride solforosa, che il vento ha portato a
spasso da inizio Novecento fino al 1991, quando lo stabilimento ha chiuso
definitivamente. Se eventuali danni alla salute non sono mai stati registrati,
di sicuro terreni e acque portano ancora le ferite inferte dalle ciminiere:
metalli, Pcb, diossine e idrocarburi pesanti sono sparsi per i 54 ettari del
sito industriale. La fabbrica cade a pezzi, ma lo scheletro fatiscente accoglie
ancora i villeggianti che scendono alla stazione. Il guardiano non fa entrare
nessuno, "non per cattiveria ma per sicurezza: nei capannoni sono conservati le
ceneri di pirite, amianto e altre schifezze. Io pure giro con la mascherina. Ma
presto qui sarà tutto rinnovato, vogliono costruire un grande centro congressi".
Sarà. A oggi sono stati messi sul tavolo oltre 8 milioni di euro, qualcosa è
stata messa in sicurezza, ma dopo 18 anni di attesa la riqualificazione resta un
miraggio. Così come la bonifica della parte di levante della laguna e del bacino
di Ansedonia, dove nelle reti dei pescatori finiscono da mesi impigliate spigole
piene di mercurio. In questa zona il problema non sono i residui chimici, ma le
ex miniere della Ferromin del Monte Argentario. "Il metallo è rilasciato dai
sedimenti del fondale, poi viene inghiottito dai pesci" spiega il Commissario al
risanamento ambientale della laguna Rolando di Vincenzo, già assessore
all'urbanistica per An. Nonostante i dati Arpat siano negativi, non c'è un
esplicito divieto di pesca: il consorzio 'Orbetello pesca lagunare', che vanta
l'esclusiva del Comune, semplicemente 'evita' di gettare le reti nelle zone
compromesse. Ripulire la zona non sarà uno scherzetto: l'idea è quella di
strappare i primi 70 centimetri del fondale, e spostare altrove terra e
mercurio. Ma servono soldi a palate, e un sito ad hoc dove stoccare migliaia di
tonnellate di rifiuti speciali.
La valle dei tumori. I veleni 'per sempre' di
Orbetello sono in buona compagnia. Anche Trento aspetta la bonifica di una vasta
area alla periferia nord. A fine anni '70 l'incendio a un deposito di sodio
obbligò il sindaco a chiudere la Sloi, che produceva dai tempi del fascismo
piombo tetraetile. A pochi chilometri dal centro cittadino nell'anno di grazia
2009 circa 150 mila metri cubi di terreno conservano gelosamente un cocktail di
mercurio, piombo, fenoli, policiclici aromatici e solventi. Del recupero si
discute da tre decenni. Costo stimato 50 milioni, qualcuno favoleggiava di un
parco con le altalene, ma in città nessuno ci crede più. La storia dell'impianto
e della bonifica mancata sarà protagonista persino di un film-documentario
finito di girare un mesetto fa, 'La fabbrica degli invisibili'. Come invisibile
è stato per settimane un dossier di settembre dell'Asl due di Roma e
dell'Istituto superiore della sanità, che racconta la devastazione della Valle
del Sacco. Dopo tre mesi di silenzi da parte di sindaci e istituzioni, centinaia
di persone che vivono a Colleferro, Segni e Gavignano, paesoni vicino la
capitale, hanno scoperto dai giornali locali di essere contaminati "in maniera
irreversibile" dal beta-esaclorocicloesano, una sostanza cancerogena rilasciata
da una fabbrica di pesticidi chiusa anni fa. Già nel 2005 la zona fu messa sotto
osservazione dopo che decine di mucche morirono per aver bevuto l'acqua di un
torrente. I veleni del distretto industriale sono rimasti in circolo: secondo
gli esperti i pazzeschi livelli di contaminazione sono legati "all'uso
dell'acqua dei pozzi locali e al consumo di alimenti prodotti in loco".
Business gigantesco. Materiali pericolosi di ogni
genere sono sparsi in tutte le regioni d'Italia, senza eccezione alcuna, e
contaminano suolo, falde acquifere e polmoni anche dopo decenni dalla chiusura
delle ciminiere. Nonostante le cifre da capogiro spese (stimabili intorno ai
5-10 miliardi di euro) o solo annunciate, l'Italia resta uno dei paesi più
inquinati del mondo occidentale. Gli inquinanti, quando va bene, vengono
nascosti sotto il tappeto nemmeno fossero polvere, o separati dalle zone
circostanti con muri speciali, come si progettava per Portoscuso, in Sardegna. A
parte le 15 aree ad 'alto rischio di crisi ambientale' censite nel lontano 1986,
il Cnr elenca a tutt'oggi 54 siti di interesse nazionale, i cosiddetti Sin, e
ben 6 mila siti regionali da tenere sotto controllo. I ricercatori mettono le
bandierine su altri 58 luoghi con elevata contaminazione da amianto e 1.120
stabilimenti industriali e chimici a rischio di incidente rilevante. In tutto, i
siti inquinati sarebbero 10 mila, compresi i depositi di materiale radioattivo
eredità della stagione nucleare. "Per avere una dimensione del problema",
spiegano gli esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, "segnaliamo che gli
abitanti nei 311 comuni inclusi nei Sin sono tra i 6,4 e gli 8,6 milioni,
escludendo o includendo i comuni di Milano e Torino". Se si considerano le altri
fonti di inquinamento, il numero supera i 15 milioni, un quarto dell'intera
popolazione. Gli allarmi degli scienziati e le leggi ad hoc non si contano, ma a
parte le perimetrazioni e le analisi delle sostanze, gran parte delle bonifiche
non sono neanche iniziate. "Non solo abbiamo cominciato a pulire dieci anni dopo
la Germania e la Francia, ma il sistematico scarico di responsabilità tra
aziende private e amministrazioni pubbliche blocca tutto, visti i tempi biblici
della giustizia italiana", ragiona il vicepresidente del Wwf Stefano Leoni: "Il
business è gigantesco. Non solo per le opere di messa in sicurezza, ma anche per
l'affare della riconversione industriale". Impossibile, secondo l'esperto,
calcolare un dato preciso delle spese sostenute finora: "Do solo due indicatori
che definiscono la misura degli interventi: la bonifica del sito di Cengio, in
Liguria, è costata 450 milioni di euro, e parliamo di un sito piccolo rispetto a
quello di Gela o Porto Marghera. Il governo Berlusconi, poi, riprendendo un
decreto voluto dall'ex ministro Bersani stanzierà la bellezza di tre miliardi di
euro per il recupero dei Sin, che si aggiungono alla montagna di denaro spesa
dagli anni '70 in poi". Nonostante gli sforzi economici, tranne poche eccezioni
i risultati non si vedono. Secondo uno studio della Corte dei conti la lotta ai
veleni combattuta con il programma nazionale di bonifica ha prodotto "risultati
del tutto modesti". La stroncatura è del 2003, ma a tutt'oggi non esistono altre
analisi dei progressi compiuti. Eppure il tema resta devastante. Per l'impatto
ambientale e per le ripercussioni sulla salute. Nel 2002 l'Oms ha dimostrato che
ad Augusta-Priolo, a Crotone, in Puglia, nel napoletano, nella parte della
Pianura Padana più inquinata, in Val Bormida e nella zona del Lambro in
Lombardia, in un quinquennio si sono registrati (rispetto alle medie regionali)
oltre 4 mila morti in eccesso, di cui 660 per tumori. Una ricerca della Regione
Sicilia ha stimato recentemente eccessi di mortalità e di tumori al polmone e
colon retto anche a Biancavilla e Milazzo, mentre in Sardegna rapporti
allarmanti sono stati stilati sulla zona di Portoscuso e Porto Torres. Per non
parlare del cosiddetto 'triangolo della morte' del napoletano, dove secondo la
Protezione civile in alcuni comuni si registrano aumenti significativi del
rischio di malformazioni del sistema nervoso centrale e dell'apparato urinario e
un incremento del 2 per cento della mortalità.
Scandalo Toscana. Se in qualche caso le analisi
sono datate, in pochi credono che di recente la situazione sia migliorata. Anche
perché il ripristino delle aree resta inchiodato, in pratica, all'anno zero. Il
caso Toscana è emblematico: a parte Orbetello, nella black-list dei Sin la
regione è ben rappresentata anche da Livorno, Massa Carrara, la discarica delle
Strillaie e Piombino. Per mettere in sicurezza le aree servirebbero 500 milioni,
in vent'anni ne sono stati spesi una trentina. Un fiume di soldi finito quasi
tutto in analisi preliminari e nella perimetrazione. "A Piombino c'è
inquinamento atmosferico da polveri, benzene, accumulo di residui di lavorazioni
in attuali situazioni di rischio, la falda artificiale è contaminata, ci sono
discariche di rifiuti pericolosi", recitava un decreto del 2001 voluto
dall'allora ministro dell'Ambiente Matteoli. Finora è stata ripulita solo la
banchina 'dei Marinai'. Anche a Massa Carrara, nella zona del vecchio polo
chimico dove insistevano l'Enichem, l'Italiana Coke, la Dalmine, l'inceneritore
Cermec e la Farmoplant, l'elenco degli inquinanti a terra è impressionante.
Metalli, pesticidi, solventi e fenoli, idrocarburi, polveri derivanti dalla
lavorazione del marmo. Il materiale da riporto ha creato una crosta di due
metri. "E' uno degli scandali italiani", dice Erasmo D'Angelis, presidente della
commissione ambiente del Consiglio regionale: "Si resta alle parole e alle
promesse. Gli impegni presi dai governi sembrano firmati con l'inchiostro
simpatico. Si bruciano miliardi per difendere l'italianità dell'Alitalia ma non
c'è un euro per garantire i territori della Toscana, brand di successo per
l'industria culturale e turistica nazionale".
Aspettando la bonifica. I tempi lunghi per le
operazioni di bonifica riguardano anche esempi virtuosi. In Piemonte Casal
Monferrato e una cinquantina di piccoli comuni limitrofi sono stati riconosciuti
'area critica' per l'amianto ben 12 anni fa. Le amministrazioni sono riuscite a
sostituire oltre un milione di metri quadri di coperture pericolose, ma prima di
altri quattro anni è difficile che i lavori vengano terminati. Persino a
Fidenza, in Emilia Romagna, i cantieri per ripulire le aree dell'ex Cip
(un'azienda fallita nel 1971, produceva piombo) e dell'ex Carbochimica sono
ancora aperti: spesi finora una ventina di milioni, ad aprile ne sono arrivati
altri 12. I più speranzosi puntano a chiudere nel 2011. Al Sud, dove dovrebbe
finire l'83 per cento del denaro stanziato, la situazione è di stallo totale. In
Campania i siti nazionali interessano una cinquantina di comuni, ma secondo il
censimento dell'Arpac le aree compromesse sono in totale 3.972, tre volte il
dato, già alto, della Lombardia. Nel napoletano e nel casertano il rischio viene
in primis dalle discariche abusive. Il commissariato alle bonifiche, che fino
allo scorso 31 gennaio era guidato dal governatore Antonio Bassolino, ha
bruciato circa 400 milioni di euro. In sette anni tra i cantieri portati a
termine ci sono quelli di Pirucchi, Paenzano e Schiavi, a Giugliano. Per il
resto, ci si è limitati alle analisi e alla perimetrazione. Secondo la Procura
di Napoli la società Jacorossi, vincitrice dell'appalto per eliminare i rifiuti
tossici, avrebbe addirittura smaltito parte delle sostanze in varie cave
spacciandoli per scarti edilizi: dei 60 milioni versati all'azienda, 46
sarebbero frutto, secondo i carabinieri del Noe, di una "gestione illecita".
Sperperi monstre anche per risanare il Sarno, il fiume più inquinato d'Europa:
tra il 1973 e il 2003 il commissariato preposto ha speso circa un miliardo,
senza risultati di rilievo. Negli ultimi cinque anni sotto la guida del generale
Roberto Jucci la situazione è migliorata, sono stati costruiti depuratori e
fogne, ma secondo i dati Arpac le acque restano sporche. Anche a Bagnoli i
lavori per risanare l'area Italsider (chiusa 18 anni fa) vanno a rilento. E i
turisti al posto del lungomare con porticciolo ammirano ancora la colata a mare
dell'ex acciaieria Ilva, in attesa che venga smontata e spedita a Piombino.
Chi inquina non paga. In Puglia è stato fatto
ancora meno. Nella zona della vecchia Enichem, a Manfredonia, sono state messe
in sicurezza alcune aree, ma secondo Legambiente attorno alla fabbrica restano
accumulati 250 mila metri cubi di acidi, ammoniaca, arsenico, fanghi e altro. A
Brindisi e Taranto di come fare piazza pulita si dibatte dalla notte dei tempi.
L'ultimo accordo di programma è di un anno fa: 170 milioni, da aggiungere ai 150
già messi sul piatto per la bonifica. A oggi non è arrivato nemmeno un euro,
tanto che il governatore Nichi Vendola ha protestato col governo. Il problema
non è solo ambientale: il blocco dei finanziamenti impedisce anche l'apertura di
nuove aziende (solo a Brindisi potrebbero svanire investimenti per 165 milioni)
nelle aree "ad alto rischio". Anche a Gela, Priolo e Augusta, in Sicilia, i poli
industriali che minacciano da decenni la salute di centinaia di migliaia di
persone definiscono, immutabile, il panorama della costa. Finora, nonostante gli
studi sull'aumento di tumori e malformazioni, nessuno ha mosso una foglia. A
Gela sono stati spesi 15 milioni di soldi pubblici, messi a disposizione nei
primi anni '90. Con il gruzzolo è stata portata a norma qualche discarica ed è
stata restaurata la caserma dei pompieri. "Peccato che per bonificare la mia
città serva un miliardo", spiega il sindaco Rosario Crocetta: "Il petrolchimico
ha invece investito 150 milioni di tasca propria per riciclare l'acqua di falda,
grazie a un accordo con noi. E' inutile aspettare lo Stato, bisogna applicare il
principio che chi inquina, paga". Il caso della vicina Priolo fa da monito: in
vent'anni, nonostante gli accordi quadro del 1990 che stanziavano ben 100
miliardi di lire, sono stati effettuati interventi tampone per 5 milioni di
euro, circa il 10 per cento del totale. Restano i veleni degli impianti
dismessi, mentre le fabbriche funzionanti continuano ad inquinare. "Quelle zone
sono state usate anche come pattumiera illegale di rifiuti tossici" chiosa
l'assessore regionale all'Industria Pippo Gianni: "C'è il sospetto che la
criminalità abbia interrato centinaia di fusti di materiale radioattivo scarto
della sanità lombarda. Tra Lentini, Carlentini e Francofonte è lievitato il
tasso di leucemie infantili". Se finora non è stato rimosso un solo bidone,
Gianni punta sull'ennesimo accordo di programma firmato a novembre. I
finanziamenti come sempre sono faraonici: 776 milioni di euro, di cui 200 a
carico dei privati. Molti gli scettici, ma qualche inguaribile ottimista giura
che questa è la volta buona. Come recita il proverbio, chi vivrà, vedrà.
Sos bambini di Emiliano Fittipaldi. Crescono del 2
per cento l'anno le neoplasie infantili in Italia. Con picchi spaventosi in
prossimità di aree industriali o inquinate. Colpa di smog e pesticidi. E della
contaminazione della catena alimentare. Nelle Marche tra il 1988 e il 1992 il
Registro tumori ha segnalato 93 bambini malati. Dieci anni dopo, sono diventati
171. Un raddoppio secco. A Parma i casi sono passati da 27 a 53. A Sassari,
nello stesso arco di tempo, gli under 14 ammalati di tumore sono triplicati. Il
bollettino è agghiacciante, la fonte autorevole: i numeri che nessuno vorrebbe
leggere li sciorina il rapporto Airtum 2008, il primo del suo genere, cofirmato
dal Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, dall'Associazione
di ematologia e oncologia pediatrica e dall'Istituto superiore di sanità. Lo
studio evidenzia che nel nostro Paese, tra il 1988 e il 2002, c'è stato un
aumento medio dei tumori infantili del 2 per cento l'anno. I tumori sono
bastardi, nessuno sa esattamente quale sia la causa. Per ogni cancro ci sono
diversi fattori di rischio possibili, e tutti lavorano insieme ad avvelenare
l'organismo. Così davanti al trend gli epidemiologi intervistati invitano a non
trarre conclusioni affrettate, ma quasi nessuno nega che tra i maggiori
sospettati ci siano l'inquinamento, i pesticidi e la contaminazione della catena
alimentare. Basta pensare alla diossina che, attraverso le carni, il latte e
l'acqua, arriva direttamente sulle tavole: se da giorni l'Europa dà la caccia ai
maiali e bovini irlandesi avvelenati, nei mesi scorsi la sostanza cancerogena ha
già compromesso interi greggi di pecore che pascolavano a ridosso dell'Ilva di
Taranto e migliaia di bufale vicino Caserta. Il dottor Gianfranco Scoppa il
rapporto sui tumori infantili non l'ha letto. Ma la sua percezione
sull'andamento delle malattie è addirittura peggiore dei dati pubblicati
dall'Airtum. Il radioterapista, ex oncologo del Pascale, oggi dirige l'Aktis di
Marano, uno dei più grandi centri di radioterapia della Campania. "Crescono
sarcomi, linfomi, leucemie. Vedo entrare troppi bambini, stiamo diventando una
struttura pediatrica", spiega. A 800 chilometri di distanza, a Mantova, pochi
giorni fa uno studio di una società privata ha messo in allarme la città e la
vicina Cremona: nelle due province la frequenza di leucemie infantili sarebbe
rispettivamente 20 e dieci volte superiore a quella registrata mediamente in
Lombardia. "I numeri sono abnormi, credo abbiano confuso i singoli casi con il
numero, più alto, dei ricoveri", spiega Paolo Ricci, epidemiologo dell'Asl
mantovana. "Ma in provincia un dato da approfondire c'è davvero". A Castiglione
delle Stiviere, meno di 20 mila abitanti, negli ultimi anni sono stati accertati
sette casi di leucemie infantili. "Un fatto anomalo, l'incidenza è rilevante.
Ricordiamoci che si tratta della zona più industrializzata della provincia, un
distretto dove la mortalità rincorre quella di Brescia". Anche a Lentini, in
Sicilia, i bambini si ammalano con frequenza eccessiva: i tassi del periodo
1999-2003 del registro territoriale di patologia segnano una media dieci volte
superiore rispetto a quella della provincia di Siracusa. Picchi anomali che
hanno convinto la Procura ad aprire un'indagine per tentare di capirne le
origini. Di sicuro in Italia il trend è anomalo rispetto al resto dei paesi
industrializzati: doppio rispetto a quello europeo, addirittura cinque volte più
alto rispetto ai tassi americani. Molti si affrettano a spiegare la tendenza con
la diagnosi precoce e le nuove tecniche che permettono di cercare le malattie
con strumenti più raffinati rispetto al passato. Ma la risposta, per gli esperti
più attenti, è insoddisfacente: equivarrebbe a sostenere che tedeschi, francesi
e svizzeri (dove l'incidenza è più bassa) sarebbero meno bravi di noi a
individuare il male. Non solo: l'incremento è troppo rilevante. Entrando nello
specifico, se nel Vecchio Continente i linfomi infantili aumentano con una media
dello 0,9 per cento annuo, in Italia la percentuale sale al 4,6 per cento. Anche
le leucemie viaggiano a tasso quasi triplo, mentre i tumori del sistema nervoso
centrale crescono del 2 per cento, contro la riduzione dello 0,1 registrata in
Usa. "I dati dei nostri registri trovano un utile complemento in quelli raccolti
da registri ospedalieri e di mortalità", commenta secco Corrado Magnani del
Centro di prevenzione oncologica del Piemonte: "I risultati concordano con le
indicazioni di tassi di incidenza relativamente elevati nel panorama
internazionale e indicano un incremento statisticamente significativo
dell'incidenza". In Italia ogni anno si ammalano circa 1.500 bambini e 800
adolescenti dai 15 ai 19 anni. Soprattutto di leucemia (un terzo del totale),
linfomi, neuroblastomi, sarcomi dei tessuti molli, tumori ossei e renali. I
numeri assoluti sono bassi, e fortunatamente i tassi di mortalità diminuiscono
grazie all'efficacia delle cure. L'incidenza, però, sembra destinata a crescere.
"Per i bambini le previsioni non sono rosee", dice l'Airtum: "Le stime,
calcolate utilizzando le informazioni raccolte nelle aree coperte dai registri e
i dati di popolazione Istat, indicano che ci sarà un aumento dei casi". Se la
tendenza resterà costante, nel periodo 2011-2015 si ammalerà il 18 per cento di
under 14 in più rispetto al quinquennio 2001-2005. Il fenomeno riguarda sia il
Nord che il Sud. Gli epidemiologi hanno preso in considerazione solo i registri
che rilevavano i tre periodi presi in esame: quello che va dal 1988 al 1992, il
periodo 1993-1997 e quello 1998-2002. A Sassari i bimbi ammalati passano da 12 a
40, a Napoli da 33 a 114. A Latina si passa da 38 a 52, a Modena, Parma, Ferrara
e Reggio Emilia stesso rialzo, il registro della Romagna ha raddoppiato i suoi
iscritti. Identico trend per l'Alto Adige, mentre l'aumento è meno preoccupante
per il Friuli. In Liguria e in Piemonte, che può vantare il registro più antico,
l'incidenza è invece stabile, come a Salerno e Ragusa.
Ma cosa sta succedendo? I medici dell'ambiente
dell'Isde non hanno dubbi, e considerano l'aumento delle neoplasie dei bambini
un indicatore assai preoccupante. Puntano il dito sull'inquinamento selvaggio,
sui danni provocati dai rifiuti tossici e dall'uso dissennato di sostanze nocive
in agricoltura e nella produzione dei beni di massa. Gli epidemiologi puri - in
mancanza di evidenze dimostrate da studi scientifici definitivi -sono
tradizionalmente più cauti su cause e fattori di rischio. Stavolta, però, anche
loro non escludono che l'inquinamento ambientale e lo stile di vita di bambini e
genitori possano avere responsabilità rilevanti sul fenomeno. Benedetto
Terracini è uno dei luminari dell'epidemiologia dei tumori, e da qualche
settimana ha iniziato un carteggio con alcuni colleghi per cercare di dare
un'interpretazione al rapporto, insieme a indicazioni operative per possibili
misure di salute pubblica. "Non si può affermare con certezza che l'aumento sia
dovuto all'inquinamento", chiosa, "ma è plausibile che influiscano fattori
esterni a quelli genetici: sono decenni che sappiamo che le frequenze tumorali
sono correlate all'ambiente. I cinesi che emigrarono in Usa si ammalano oggi
esattamente quanto e come gli americani, proprio come accade ai pugliesi a
Milano e agli italiani partiti per l'Australia. Il lavoro dell'Airtum è il
massimo che si può fare in termini statistici, ma ora bisogna agire". Terracini
dubita che in tempi brevi gli scienziati potranno dimostrare definitivamente il
coinvolgimento di fattori legati all'inquinamento. "Ma anche se non si può dire
che benzene e smog fanno venire il cancro agli under 14, si possono applicare
rapidamente politiche precauzionali: non servono certo altri studi per sostenere
che vivere vicino a una strada a grande traffico non fa bene alla salute.
Bisogna difendere i bambini a priori, senza fare allarmismo usando un tema
delicatissimo come le neoplasie infantili". Se i 'ragionevoli dubbi' sul
rapporto tra inquinanti e tumori non sono ancora diventati legge scientifica,
serpeggiano con sempre maggior insistenza nelle conclusioni di autorevoli
ricerche internazionali. Nel 2005 un report dell'ateneo di Birmingham ha
evidenziato che i piccoli che abitano nel raggio di un chilometro da uno snodo
di traffico 'importante' hanno un rischio 12 volte più alto di ammalarsi, mentre
due anni fa ricercatori delle università di Milano e Padova mostrarono un legame
tra inquinamento da diossina prodotto da inceneritori per rifiuti industriali e
urbani e l'insorgenza di sarcomi nella provincia di Venezia. Anche a Mantova un
rapporto dell'Asl (che a breve verrà pubblicato dall'Istituto superiore di
sanità) ha ufficializzato un nesso tra sarcomi dei tessuti molli e le sostanze
diossino-simili osservate intorno al polo industriale di Mantova, dove insistono
il petrolchimico dell'Enichem, le Cartiere Burgo, tre centrali termoelettriche,
tre discariche per rifiuti tossici e un inceneritore per rifiuti industriali e
sanitari. Basata sul contributo di esperti di rilievo come Pieralberto Bertazzi,
Pietro Comba, Paolo Crosignani e il compianto Lorenzo Tomatis, la ricerca spiega
che il rischio più alto che ha la popolazione residente vicino all'area
industriale di ammalarsi (bambini compresi) è legata probabilmente non solo alla
diossina e ai Pcb, ma anche ad altri inquinanti: "Sempre comunque di origine
industriale". Altre analisi hanno evidenziato i nessi tra leucemie e campi
magnetici. La faccenda è molto discussa, ma a tutt'oggi, spiega Magnani, "il
dato scientifico non è stato ancora confutato". Se il rapporto Airtum ha avuto
scarsa pubblicità, gli scienziati non mancano di mettere insieme le indicazioni
che arrivano da questi studi scientifici con le cifre delle neoplasie infantili
in Italia. E non nascondono la loro preoccupazione. Tutti, dal decano Terracini
a Franco Berrino dell'Istituto dei tumori di Milano, concordano sul fatto che
occorre studiare le sostanze sospettate sia sul piano epidemiologico (ovvero
andare a vedere come e quando si correlano agli aumenti di incidenza), sia su
quello tossicologico e genetico, per capire in che modo possono indurre il male.
All'indomani del rapporto Airtum, qualcuno si spinge anche più in là, e comincia
a comporre il puzzle. Come Gemma Gatta, ricercatrice all'Istituto dei tumori di
Milano: "L'aumento generale c'è di certo. E i fattori di rischio sono numerosi:
radiazioni, farmaci antinfiammatori usati in passato in Europa, ormoni per
l'interruzione della gravidanza. Poi, il consumo di tabacco e alcol da parte
della madre in gravidanza, il traffico veicolare, le infezioni e la professione
dei genitori". In particolare, l'esperta sottolinea il rischio di chi vive parte
della giornata a stretto contatto con sostanze cancerogene come benzene e
pesticidi. Ma non è tutto. "Negli ultimi anni le madri allattano meno al seno,
fumano di più, i giovani si alimentano peggio: bisognerebbe, anche in assenza di
studi definitivi, modificare stili di vita insalubri", chiosa la studiosa. Pure
Luigia Miligi, dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica della
Toscana, è cauta su cause e concause, e preferisce andare al sodo. "Ho mandato
delle mail ai colleghi mettendo l'accento sulla gestione del rischio. Ci sono
cose che possono essere fatte subito, quasi a costo zero. Si potrebbe diminuire
l'inquinamento indoor delle scuole evitando l'uso di detersivi con solventi
aromatici, ed eliminando i materiali che rilasciano formaldeide". Anche il
controllo dei residui antiparassitari in agricoltura, dice la Miligi, dovrebbe
essere sistematico: il principio di precauzione e il diritto alla salute deve
essere prioritario rispetto a qualsiasi altro interesse. "Ma gli allarmi devono
essere gestiti bene. Tre anni fa a Firenze ci fu un picco di leucemie in una
scuola materna: le istituzioni si mossero all'unisono, in silenzio, per
garantire la sicurezza dei piccoli. Analizzammo ogni rischio, misurammo persino
l'eventuale presenza di radon, un gas radioattivo. Non trovammo nulla: a volte
certi fenomeni sono del tutto casuali".
L'Italia è piena di amianto. di Chiara Organtini
su “L’Espresso”. Negli anni '60 - '70 giocavano con la "neve", una polvere
bianca che usciva dai sacchi in stazione. Gli abitanti di Casale Monferrato,
l'amianto, quella "polverina magica", l'hanno conosciuta bene e non solo per
gioco, purtroppo. Lunedì, 13 febbraio, si attende la sentenza del processo
contro l'Eternit AG, l'azienda - dal 1906 a Casale - che ha mandato a morire
1.800 tra lavoratori, familiari e casalesi. A giudizio i proprietari della
multinazionale: lo svizzero Stephan Schmideiny e il belga Jean-Louis de Cartier
de Marchienne per disastro doloso e omissione volontaria di cautele
infortunistiche. In un processo che ha visto 65 udienze, 6.000 parti civili in
26 mesi di istruttoria, il procuratore di Torino Raffaele Guariniello ha chiesto
venti anni di reclusione per entrambi gli imputati. Schmideiny, propose mesi fa
al Comune di Casale un'offerta di transazione di 18 milioni di euro, purché si
ritirasse dalle parti civili. Dopo giorni di lotta e polemiche da parte degli
abitanti, il sindaco di Casale ha rinunciato. E ora si chiude il procedimento
penale più grande d'Italia, ma non l'unico. Dove si indaga per amianto in
Italia. C'è il processo di Praia a mare (Cosenza) contro Lomonaco ex sindaco e
responsabile all'interno della fabbrica tessile Marlane (24 febbraio, prossima
udienza), quello diPadova contro alcuni ex capi di Stato Maggiore della Marina
Militare (la sentenza 22 marzo); il processo contro l'Isochimica di Avellino di
Elio Graziano che sta per partire e che ha visto 108 lavoratori ammalarsi in 20
anni; l'istruttoria, appena partita, contro Filippo Russo che ha abbattuto l'Ex
Velodromo a Roma per conto dell'Eur Spa. Quest'ultimo, è l'unico processo dove
non ci sono vittime, per quanto dopo l'esplosione della struttura che ha
inondato di polveri il quartiere Eur, si siano contati 4500 chili di detriti con
amianto, tanto che il pubblico Ministero è passato dall'imputazione di "getto di
cose pericolose" a "disastro colposo". In realtà, i casi aperti su cui si indaga
in Italia sono molti di più: l'ex stabilimento Fibronit Bronie di Bari
(Lombardia e Puglia); l'ex stabilimento Michelin diCuneo; la Caserma di Prati di
Caprara aBologna dove nonostante il tetto in eternit sgretolante sono stati
accolti i profughi dal Nord Africa la scorsa primavera; l'ex opificio
industriale di Mongrassano Scalo a Cosenza; e ancora l'Eternit, la Cementir e
l'Italsider diBagnoli, dove si devono ancora smaltire 100mila tonnellate di
amianto, accanto alle quali centinaia di ragazzi si raccolgono nelle discoteche
contigue tutti i fine settimana. L'Italia, a venti anni dalla legge che lo ho
bandito, è piena d'amianto: 32 milioni di tonnellate, 1 miliardo di manufatti
per 4mila morti l'anno. Secondo i dati dello studio SENTIERI (Studio
Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio
Inquinamento) dell'Istituto Superiore di Sanità, sono almeno 31 i luoghi di
interesse per una bonifica da amianto. Ma in tutti questi anni cosa ha fatto lo
stato, la politica?
Amianto, male di Stato e di politica. La giustizia
in Italia tenta sempre di fare il suo corso, anche quando è lo stesso Stato a
mettergli i bastoni tra le ruote.Sergio Dini, Pubblico Ministero a Padova nel
processo contro gli otto ex capi di Stato Maggiore della Marina Militare, nel
bel mezzo dell'istruttoria ha dovuto vedersela con la legge 132/2010, introdotta
dall'ultimo governo Berlusconi. Il processo aveva chiamato in causa per omicidio
colposo alcuni ammiragli, responsabili di non aver segnalato la presenza di
amianto ai marittimi delle navi. Le parti offese, un capitano di vascello e un
meccanico (deceduti). In realtà i militari marittimi morti per cause d'amianto
sono circa 700 a tutt'oggi. La legge 132, ridenominata "salva-ammiragli",
solleverebbe dalla responsabilità penale gli ufficiali dei navigli militari,
secondo il grimaldello di una legge del 1955 che ne permette solo l'imputazione
ai fini civili. "E' chiaro che la legge 132 - spiega Dini - è il prodotto di una
mentalità politica ad personam. E' incostituzionale." Ma i problemi non
finiscono qui. C'è la questione delle certificazioni dell'INAIL per il
prepensionamento dei lavoratori ex esposti all'amianto. L'ente previdenziale,
infatti, grazie ad un altro decreto del marzo 2008 ha escluso i lavoratori delle
aree portuali dalla possibilità di farne richiesta e nonostante un ricorso del
TAR che ha dato loro ragione, ritarda ancora le procedure.
Chi paga allora per le vittime d'amianto? Esiste
un Fondo per le vittime dell'amianto, istituito nel 2007 (legge 244) durante
l'ultimo governo Prodi. Per renderlo operativo occorreva un decreto entro 90
giorni. E invece il decreto è arrivato solo il 12 gennaio 2011, come denuncia
Felice Casson, vice presidente del Partito Democratico al Senato ed ex
magistrato, il quale sulla questione ha presentato anche una Risoluzione in
discussione a Palazzo Madama. Arrivato il decreto con il ministro del Lavoro
Sacconi, sono stati però esclusi dall'accesso al Fondo le vittime per amianto
non lavoratori! Il problema, tuttavia, non è solo a livello di politica
nazionale. C'è, infatti, il caso del Comune di Roma che sull'ex velodromo, la
struttura abbattuta nel 2008, ricca di amianto e mal bonificata, vorrebbe far
costruire un complesso di torri ed abitazioni di pregio, accanto a qualche
servizio pubblico per il quartiere, non curante del processo che è appena
partito contro l'Eur Spa, la società mista tra Comune e Ministero del Tesoro.
Una colata di cemento, il progetto comunale, che la Provincia sta tentando di
bloccare nonostante la delibera del Comune possa essere votata in qualsiasi
momento.
Responsabilità di Stato. La sete di giustizia che
ha portato i cittadini di Casale Monferrato a rifiutare l'offerta di indennizzo
della Eternit al Comune ed il Comune stesso a rimanere quindi parte civile nel
processo, è un segno evidente che le vittime dell'amianto, sia malati che non,
vogliono la partecipazione dello Stato. Le bonifiche per tutta Italia avranno
dei costi proibitivi e non saranno risolutivi nemmeno i 750mila euro promessi
dal Ministro della Salute Balduzzi a Casale. "Quel che è certo, però - sostiene
l'avvocato Ezio Bonanni che segue l'inchiesta dell'Isochimica di Avellino ed è
Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto - è che un reato commesso non può
rimanere senza responsabili. Presenterò l'esposto, già inoltrato alla Procura di
Firenze per la vicenda dell'ex fabbrica Isochimica, anche all'Antimafia". Come a
dire: L'Italia dell'amianto, per avere giustizia, deve lottare anche contro se
stessa.
Nel paese che muore d'amianto di Andrea Milluzzi
su “L’Espresso”. A Ferrandina, Basilicata, una discarica di Eternit sta facendo
una strage. Qualcuno vuole intervenire? "Ma che cosa sta succedendo a
Ferrandina?" Questa è la domanda che Nunzia si sente rivolgere all'ospedale di
Matera, dove le hanno appena diagnosticato un tumore. Una sentenza ultimamente
troppo ricorrente fra gli abitanti di questo paesino a una trentina di
chilometri dalla città dei sassi. Ma una risposta i ferrandinesi se la sono
data: sta succedendo che la pattumiera d'Italia ha iniziato a generare i suoi
morti. All'ingresso del paese un corteo funebre sta salutando una donna di 57
anni portata via in un mese da un cancro. Sotto si estende la valle con i suoi
calanchi, che nelle intenzioni di una volta doveva diventare un parco nazionale.
Invece adesso ospita cinque discariche e il ministero dell'Ambiente progetta di
costruirci pure un inceneritore e un'ennesima mega discarica di rifiuti tossici
e nocivi. Ferrandina ha quasi diecimila abitanti e una grande storia alle
spalle: è stata fondata ai tempi della Magna Grecia ed è stata un centro
culturale anche in epoca bizantina. Nell'Ottocento i suoi abitanti si
ribellarono più volte e anche durante la Seconda Guerra mondiale ci fu
un'insurrezione contro i gerarchi e i latifondisti fascisti. Il paese è in cima
a una collina e nel 1978 fu usato come location per il film 'Cristo si è fermato
a Eboli', di Francesco Rosi. Ma molto tempo è passato da allora. Domenico La
Carpia è un imprenditore locale che si occupa di trivellazioni, smaltimento
rifiuti e bonifica del territorio. Il nome della sua ditta è uno dei tanti che
campeggiano sui cartelli di divieto d'accesso per presenza di sostanze
pericolose. Sta mettendo in sicurezza la discarica comunale di Casaleni, ha una
discarica di amianto e ha in carico la bonifica dell'ex Materit, azienda della
vecchia e famigerata Eternit che fra il 1973 e il 1989 ha fatto tutti i danni
che poteva fare al paese e ai paesani. "I lavori di bonifica sono iniziati ma
per mettere completamente in sicurezza la zona servono, direi, 2 milioni di euro
e il Comune non ha più una lira", spiega La Carpia. Nel frattempo 10 operai
degli 86 che ci lavoravano sono morti, 16 si sono ammalati e tutti gli altri
vivono un'esistenza sospesa fra controlli medici e il sospetto di essere già
condannati. Eppure che l'amianto fosse cancerogeno si sa da tempo. Non è più
come 30 anni fa quando pur di lavorare i ferrandinesi accettarono di maneggiare
quella strana polvere sconosciuta. Una relazione tecnica del 2005 ha rilevato
amianto e manganese in quantità superiori alla norma nei terreni e nelle acque
vicini alla ex Materit. Cinque anni dopo la fabbrica è sigillata alla meno
peggio, con finestre infrante, un portone aperto e polvere per terra che si alza
al minimo venticello stagionale. Dentro ci sono ancora 500-600 sacconi da mille
chili di amianto ciascuno che aspettano di essere seppelliti e definitivamente
dimenticati. Ma sono ancora là. E in paese si conta un malato a famiglia. A
pochi metri dallo stabilimento passa la superstrada Basentana che collega tutta
la valle. Un altro centinaio di sacchi di amianto e un altro telone - rotto -
danno il benvenuto. Nessuna recinzione, un solo cartello che però capre e mucche
non possono leggere e quindi brulicano tranquillamente l'erbetta accanto alla
sostanza maledetta. Dal produttore al consumatore il passo è breve e a volte
mortale. "Mio marito diceva sempre che mangiando i prodotti locali sapevamo bene
cosa mangiavamo. No, lo sappiamo adesso". Nunzia ha 53 anni, da uno è rimasta
vedova dopo che il marito è stato ucciso da un tumore. Adesso è lei a combattere
con lo stesso male: "Mi sentivo stanca, pensavo fosse per quello che ho dovuto
passare negli ultimi tempi. Invece ho fatto gli esami ed è venuto fuori che
avevo un tumore al seno. Ma non ero preoccupata, so che si può guarire e ho
fiducia nella scienza. Poi invece la Tac ha trovato metastasi ovunque e mi hanno
detto che era inutile pure l'operazione". C'è un documentario della Ola
(Organizzazione lucana ambientalista), dall'associazione Ambiente e legalità e
da Pensiero Attivo, un'associazione giovanile di Ferrandina in cui il free lance
Andrea Spartaco filma i sacchi di amianto e il percolato che defluisce dalla
discarica di Casaleni. "Nemmeno far vedere il video in piazza è servito a
smuovere le coscienze. La conseguenza più devastante di essere diventati la
pattumiera d'Italia è che tutti si sentono legittimati a fare quello che
vogliono", dice Spartaco. Se dici amianto e Eternit, la prima assonanza che
viene in mente è Casale Monferrato, ma le pattumiere d'Italia sono di più, e tra
queste Ferrandina. Gli effetti sono gli stessi, la consapevolezza, molto spesso,
no. I morti d'amianto sono migliaia, ogni anno. In Italia, vaticinano gli
scienziati, l'anno del picco sarà il 2025. Non è una profezia, ma un dato di
fatto. Durante quei dodici mesi che verranno i morti d'amianto mangiati dal
mesotelioma saranno centinaia, per un conto macabro che porterà a 30mila i
caduti complessivi dall'inizio della carneficina. Uccisi dal mesotelioma
pleurico, il più bastardo dei tumori. Trentamila morti. Non sono dati buttati a
caso da qualche ecologista furente, sono stime scientifiche. Il massacro che
verrà è una certezza matematica. A Casale Monferrato, a Sesto San Giovanni, a
Napoli, a Siracusa, a Monfalcone. Toccherà agli operai, ma anche a chi con
l'amianto non ci ha mai lavorato. Ai familiari intossicati dalle polveri portate
a casa da padri e mariti, a chi vicino l'amianto ci ha abitato troppo a lungo.
Ma per capire se esiste giustizia terrena, o se bisogna aspettare solo quella
divina, aspetteremo meno tempo. Perché per questa tragedia, incredibilmente, un
processo è stato aperto. Il processo del secolo si fa a Torino, e le parti in
battaglia sono due: da una parte l'esercito dei morituri e dei parenti dei già
morti, capitanati dal pm Raffaele Guariniello, dall'altra due miliardari.
Chiamati da tutti, in Piemonte, semplicemente «lo svizzero e il belga». La loro
storia si intreccia con quella dell'amianto italiano, uno dei veleni più
pericolosi che esistano in circolazione. Nel 1941 il giovane Louis, oggi
"l'imputato numero due", aveva vent'anni, e stava bruciando i suoi giorni in un
lager nazista per prigionieri di guerra. Questa storia la racconta spesso, anche
oggi che di anni ne ha 88 suonati. Nato bene, il barone de Cartier de Marchienne
s'era arruolato quando Hitler aveva invaso il Belgio, ed era stato catturato
dopo i primi combattimenti. Deportato in un campo, circondato da filo spinato e
mine antiuomo, a centinaia. Capì che la fuga era cosa praticamente impossibile.
Louis, che era ufficiale, ci provò lo stesso. Stremato dalla fame e da
condizioni di vita disumane, tentò il tutto per tutto. Provando a correre dritto
sul campo, come un pazzo. O la và, o pazienza. Chiuse gli occhi e cominciò a
ruotare le gambe. Veloce era veloce: i tedeschi non lo videro, le bombe non
esplosero, invisibile. La sorte gli fu amica, un miracolo, riuscì a fuggire.
Nemmeno un graffio. Sfortuna volle che scappò dalla parte sbagliata, e incocciò
le linee dei russi che arrivavano da est. «O ti arruoli con noi, o finisci nei
gulag». Il barone non ci pensò su molto: si arruola con i comunisti, combatte in
compagnie miste destinate al macello, sopravvive, ed entra a Berlino insieme
all'Armata Rossa. La seconda guerra mondiale è finita. Tenta subito riparo dagli
americani, che dopo qualche giorno di galera per gli accertamenti, lo lasciano
libero. Negli anni a venire Louis diventerà ricco. Il barone dell'Eternit. Pare
che il 22 luglio del 2009, cinquantaquattro anni dopo la grande fuga, quando ha
saputo che la procura di Torino lo processerà per la morte di due migliaia di
persone, non abbia fiatato. Stephan Ernest Schmidheiny, l'imputato "numero uno",
la guerra non l'ha mai nemmeno vista. E' nato nel 1947 a Heerbrugg, cittadina
verdissima della Svizzera, e oggi è uno degli uomini più ricchi del mondo. Per
la precisione, il 288esimo. Secondo Forbes nel 2008 la sua fortuna toccava i 3,7
miliardi di dollari, un po' meno dei i cinque miliardi incamerati dal fratello
Thomas e i 10 che rimpinguano il conto in banca del finanziere appassionato di
Coppa America, Ernesto Bertarelli, l'uomo più liquido della patria del
cioccolato, ma abbastanza per farne il quarto svizzero più ricco del mondo.
Sthefan e Thomas sono figli di papà. Di papà Max, che grazie all'amianto ha
fatto la fortuna della famiglia per le prossime venti generazioni. L'Eternit,
l'impasto di cemento e asbesto, l'hanno brevettato gli austriaci, è vero, ma
sono gli svizzeri ad averlo diffuso in mezzo mondo, Italia compresa. L'imputato
numero uno era il successore designato dell'impero. Nel 1968 studia
giurisprudenza a Roma, e partecipa al '68. Proprio allora diventa un
ambientalista convinto. Sette anni dopo sale nella sala dei bottoni, prendendo
la guida di una delle tante società del padre, e nel 1976 fa il balzo sulla
poltrona di presidente, divenendo proprietario del gruppo nel 1984. Guariniello,
che dopo un lavoro titanico e certosino ha raggruppato in un unico fascicolo
tutti i morti e i malati d'amianto certificati in Italia, lo ha messo sotto
accusa «nella qualità di effettivo responsabile della gestione delle società
esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale
Monferrato, Bagnoli e Rubiera». Le sue colpe presunte: disastro e omissione di
misure di sicurezza. I 2191 morti finora calcolati sono sul suo groppone, come
la fine certa di altre migliaia di malati, secondo il giudice. E' lui il mostro,
secondo la stampa.«E' semplicemente l'ultimo rimasto con il cerino in mano»,
secondo il suo avvocato.
Casale Monferrato. La città da cento anni respira
amianto, mangia amianto, cammina sull'amianto. E' d'amianto. Amianto, dal greco
"incorruttibile". L'altro nome del veleno, absteso, significa "inestinguibile".
Come la paura di chi ne è stato contaminato. Qui lo stabilimento piemontese,
94mila metri quadrati di cui la metà coperti (da amianto) è stato un totem per
ottant'anni. La cattedrale operaia della città, dal 1906. Le tute blu che ci
hanno passato una vita sono migliaia, decine di migliaia le persone che
costruiranno tetti, aie per i polli, muretti e strade con il polverino, gli
scarti di lavorazione regalati dalla fabbrica per decenni. Fino al 1952 la
proprietà è italiana, della famiglia Mazza. Poi il gruppo belga compra l'intera
attività. Un affare: l'Eternit è il materiale perfetto per la ricostruzione del
dopoguerra. Ha un costo basso, capacità costruttive elevata, è pubblicizzato
come il materiale eterno. "I mille usi dell'amianto", strizzava l'occhio un
volantino dell'epoca. Nessuno al tempo immaginava gli effetti devastanti delle
fibre d'amianto e delle sue polveri sottili. Solo negli anni '60 la comunità
scientifica lancia l'allarme. Peccato che la distribuzione di polverino vada
avanti, di sicuro, fino al 1976. Mentre molti testimoni ricordano che proseguì
anche più tardi. La Città e la campagna si sono riempite di asbesto, che non è
stato ancora bonificato. I belgi, una volta assunto il controllo, si espandono,
ed aprono altri capannoni a Bagnoli e in Sicilia. Le vendite vanno forte fino
agli inizi del 1970, l'amianto si diffonde peggio della plastica. Ferri da
stiro, tetti, guanti da forno, schermi cinematografici, filtri per pipe e
sigarette mentolate, phon per capelli, carrozze ferroviarie, assorbenti interni,
scuole coibentate con l'asbesto spruzzato. Tubature, tubi di scappamento,
linoleum, freni per auto, canne fumarie, il veleno si annida ovunque. Poi la
crisi del settore, nerissima. I belgi non vogliono investire, non ci credono
più. Nel 1972 arrivano gli Schmidheiny, che sono i capitalisti dominanti del
mercato. Comprano tutto il pacchetto di quote. «E dal 1975 al 1986, anno del
fallimento e della chiusura definitiva, investono un fiume di denaro, una roba
enorme, circa 46 miliardi di lire totali. Buona parte serviranno a ristrutturare
gli impianti, che passano dalla produzione a secco, dove le polveri galleggiano
nell'aria, a quella a umido, in cui la sostanza bagnata è più contenuta»spiega
l'avvocato dell'imputato numero uno, il romano Astolfo Di Amato. Guariniello la
pensa diversamente. Il processo messo in piedi a Torino contro i due imputati
non ha precedenti sul pianeta. E' il più grande processo penale della storia.
Due imputati, 2191 vittime accertate fra il 1952 e il 2008, 2889 tra
organizzazioni e persone singole costituitesi parte civile, 557 test, ex
dipendenti degli stabilimenti Eternit sentiti dal pm, 220mila pagine di atti
giudiziari, 1200 posti a disposizione di chi vorrà assistere alle udienze. Da
aprile 2008 i pullman da Casale pieni di testimoni fanno spola con la procura di
Torino. Portano un carico di dolore, di dad man walking. Che vogliono esserci
ancora, che chiedono giustizia. Stephan ha promesso indennizzi importanti, ma
loro non vogliono quella che chiamano carità: 36mila abitanti, 2mila morti, il
rapporto proporzionale è assurdo. «Un'ecatombe non si perdona, non si compra».
Davanti alla procura, con striscioni e cartelli, i giorni delle udienze si
possono incontrare anche francesi, svizzeri, belgi e tedeschi, che guardano al
processo con interesse enorme: all'estero chi si è ammalato di cancro, asbestosi
o mesotelioma riesce a prendere senza troppe difficoltà risarcimenti economici
nei tribunali civili, ma non esistono processi penali come quello messo in piedi
in Italia. Guariniello ce l'ha messa tutta. Ha trovato gli indirizzi di quasi
tremila persone, per notificare gli atti. Ha ipotizzato, per la prima volta in
assoluto, il reato di disastro non solo "interno" (che colpisce, dunque, i
lavoratori) ma anche "esterno", con il coinvolgimento dei cittadini che hanno
vissuto vicino la fabbrica. Ha portato alla sbarra non solo quadri e dirigenti
secondari, ma i vertici massimi di una multinazionale. Davide contro Golia. Le
responsabilità sono dei capi, questo il principio. Dovrebbe essere ovvio, ma è
cosa rara nei processi di questo genere. Guariniello, soprattutto, ha messo
insieme migliaia di carte, documenti, fotografie e testimonianze che hanno
indotto il giudice per le indagini preliminari a disporre il giudizio.Una delle
prove chiave della negligenza dei due imputati è una relazione tecnica del 23
febbraio del 1976. Da anni gli scienziati hanno già spiegato i gravi rischi per
la salute collegati all'amianto. La lettera è firmata dal dottor K. Robock, il
responsabile sulla sicurezza sul lavoro e tutela ambientale della
Wirtshaftsverband Asbesrzement E.V., l'Associazione commerciale cemento-amianto
a cui appartenevano i produttori più importanti. Destinatario: Luigi Reposo,
direttore della fabbrica di Casale. Dieci paginette da leggere piano,
pianissimo. Lasciano senza fiato.«La pulizia delle macchine non è da
considerarsi soddisfacente. Per questa attività vengono impiegate esclusivamente
scope. In tal modo le macchine e i pavimenti del capannone vengono certamente
puliti in maniera irreprensibile, ma allo stesso tempo vengono sollevati dei
vortici di polvere sottile che portano ad un innalzamento del livello di polvere
complessivo...Come protezione contro la polvere sono state indossate quasi
esclusivamente maschere protettive contro polvere grossa. L'effetto barriera di
queste maschere contro le polveri sottili è decisamente limitato. Indossare
queste maschere ha più che altro un valore psicologico. Qualora in Italia non
venga subito prescritto da parte delle autorità l'utilizzo di maschere adeguate,
consigliamo l'impiego delle maschere protettive contro polvere sottile».
"Consigliamo". «Punti di misura 10 e 11: E' stato osservato che gli operai
tolgono i blocchi di amianto pressato dai sacchi anche molto tempo prima
dell'inserimento, non è da escludere che la circolazione d'aria possa in questo
modo trasportare fibre...Punto di misura 13: al momento della misurazione il
sistema di aspirazione era otturato. Il risultato mostra che, a causa di ciò,
non solo viene liberato cemento, come già sappiamo, ma anche una considerevole
quantità di fibre... Punto di misura 16: i sacchi di plastica utilizzati sono in
parte danneggiati e vengono fatti arrivare al bocchettone di riempimento
allentati. Durante il riempimento vi è quindi un notevole sviluppo di
polvere...Punto di misura 22: qui l'aspirazione non è ottimale...Punto 23: Qui
sussiste il rischio legato all'alta concentrazione di polveri sottili...è
possibile che di tanto in tanto l'aria carica di polvere venga deviata
dall'aspirazione. Sarebbe opportuno...Punto 31: Al termine del processo di
taglio, quando dalla lastra viene rimosso del materiale, si alza una visibile
nuvola di polvere. A mio avviso, questo inconveniente può essere evitato
allungando la cappa». Negli altri appunti si parla di aspirazioni «non ottimali»
e di tubi «difettosi», poi si chiude con il punto di misura 40. «Se si considera
l'effetto a breve termine, l'impatto ambientale è minore di quanto non ci si
aspetti. Il conducente del camion, che durante lo scaricamento si trova in mezzo
ad una fittissima nuvola di polvere, è però fortemente a rischio». Il consiglio:
indossi una maschera protettiva adeguata. Ergo: quando gli ispettori hanno fatto
visita a Casale, non la usavano. Alla fine il dottor Robock è comunque più che
soddisfatto. Addirittura «molto sorpreso»per la quantità bassa di polveri di
amianto. L'impianto è promosso a pieni voti, tanto che «la priorità non è più
quella di puntare sugli investimenti, ma su misure formative e preventive, in
questo caso specialmente per quanto riguarda le attività di pulizia». Stephan
Schmidheiny si è ripulito alla grande. L'Eternit italiana è fallita oltre venti
anni fa, non ha più cariche formali nell'azienda di famiglia, ma i suoi
investimenti hanno continuato ad andare a gonfie vele. E' tra i fondatori della
Swatch, gli orologi di plastica a basso prezzo più venduti del mondo, ed è o è
stato membro dei consigli di amministrazione di colossi aziendali, da Asea Brown
Boveri alla Nestè, passando per l'Ubs. Ma oggi ama definirsi, più di ogni altra
cosa, un filantropo. Già: per gli scherzi del destino, quello che qualcuno
accusa di essere una sorta di avvelenatore seriale, dagli anni '90 promuove con
la fondazione Fundes lo sviluppo di aziende ecosostenibili in Sud America;
finanzia associazioni ambientaliste come Avina, che si occupa di cooperazione e
assistenza sociale; diventa consulente di Bill Clinton e parla all'Onu e al
Vaticano; scrive libri sullo sviluppo sostenibile; prende svariati premi e
persino lauree honoris causa. Come quella, prestigiosa, assegnata dalla Yale
University. «Sono cresciuto in una fattoria piena di vigneti, e con i miei
parenti ero solito compiere escursioni in montagna» racconta «Le vacanze le
passavamo nelle isole del mediterraneo, e lì ho iniziato a occuparmi della
difesa dell'ambiente». Una conversione quasi religiosa, quella dell' ex Mister
Eternit. Frasi quasi paradossali, da chi è accusato di non aver messo impianti e
apparecchi per prevenire malattie e patologie da amianto, omesso di «sottoporre
i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da
amianto», di aver determinato, a Cavagnolo, Casale, Bagnoli e Rubiera
«un'esposizione incontrollata continuativa e a tutt'oggi perdurante» scrive dura
il gip nel decreto «senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei
predetti materiali e per giunta indicendo un'esposizione di fanciulli e
adolescenti anche durante attività ludiche». Un criminale, in pratica, nemmeno
lontano parente dell'ecologista stimato nei consessi internazionali. Stephan si
difende così: «Io stesso ho respirato fibre di aminato quando ero in Brasile, a
fare formazione. Mi è capitato spesso di aver caricato sacchi di amianto... I
nostri consulenti credevano che negli studi scientifici che evidenziavano gli
effetti nocivi dell'asbesto c'erano delle contraddizioni. Io ho immediatamente
installato nuove apparecchiature e filtri per ridurre al minimo la
concentrazione di fibre nell'aria delle nostre fabriche. Abbiamo anche attuato
programmi di formazione del personale per ridurre al minimo i rischi. Allo
stesso tempo, ho annunciato pubblicamente che il gruppo avrebbe smesso di
produrre prodotti contenenti amianto, molto prima che l'Unione europea imponesse
il divieto. Mi ricorda ancora le parole di uno dei responsabili tecnici dopo il
mio annuncio: "Il giovane Schmidheiny è pazzo!"». Sarà. Il destino di Sthepan il
filantropo è ora in mano ai giudici, che dovranno decidere se lui sapeva davvero
dei rischi e nulla ha fatto per salvare la vita ai suoi operai o se, al
contrario, nulla poteva contro gli effetti del veleno. Ma una cosa è certa: al
processo di Torino c'è un altro imputato di pietra, lo Stato italiano. Uno degli
ultimi a bloccare ufficialmente le produzioni in amianto: se la marina inglese
vieta la coibentazione a spruzzo già nel 1963, e l'Australia bandisce il veleno
nel 1970, prima ancora che gli svizzeri scendessero dalle Alpi, nel Belpaese la
prima direttiva che mette limiti alla quantità di polveri è del 1982, ma il
divieto definitivo arriva nel 1992. La pubblicazione di ricerche scientifiche
che inequivocabilmente dimostravano la pericolosità della sostanza avviene
trent'anni prima, mentre nel 1976 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul
cancro avverte che ogni tipo di asbesto è altamente cancerogeno. Se ne fregano
tutti. I governi che si sono succeduti hanno consentito non solo la produzione
massiccia, ma la diffusione selvaggia di amianto in tutto il Paese. Noi eravamo
uno dei maggiori player del mondo. Solo negli anni che vanno dal 1984 al 1988,
quando la Ue raccomandava la messa in mora e tutti i paesi scandinavi
smantellavano le fabbriche e bonificavano il bonificabile, in Italia sono state
piazzate tre milioni di tonnellate. Oggi si stima che esistano ancora 2,5
miliardi di lastre di cemento-amianto da rimuovere, pari a circa 32 milioni di
tonnellate, in gran parte materiale friabile tossico. Sono dati del Cnr.
Ripostigli, garage, condutture idriche, scuole e ospedali sono ancora foderati
di Eternit. Interi quartieri galleggiano nelle invisibili polveri, almeno mille
italiani ogni anno vengono uccisi dalla morte bianca. La dimensione sociale del
fenomeno è enorme: basta dare un'occhiata ai dati Inail, che riceve 1400 denunce
di malattie da amianto ogni 12 mesi. La legge prevede una pensione privilegiata
per chi abbia lavorato a contatto con il veleno, e, visto che il periodo di
latenza del mesotelioma può durare 40 anni, gli esperti sanno che i numeri
andranno ad aumentare esponenzialmente negli anni a venire. Secondo
l'Associazione italiana esposti amianto sono 210mila i cittadini ancora a
rischio. Il killer invisibile è annidato dappertutto. La Spezia e Genova, si sa,
ha uno dei tassi di asbestosi più alti del mondo: la sostanza arrivava nascosta
nelle navi militari ed era conservata a decine di tonnellate nei depositi per il
crisotilo, l'amianto blu. I porti sono zone franche. Altri punti sensibili,
secondo i dati nazionali dell'Apat, sono le ex miniere di Balangero, in
Piemonte, alcune fabbriche di Marghera a Venezia, la vecchia base aeronautica di
Monte Venda, sui Colli Euganei, la solita, sfortunata Seveso, la Breda di Sesto
e di Pistoia, dove si sono costruiti per lustri i convogli dei treni imbottiti
di asbesto. Ancora. L'amianto è stato padrone ai cantieri navali di Trieste e
alla Fincantieri di Monfalcone, nel paese di Biancavilla, in Sicilia, dove fino
alla metà degli anni '90 lo sfruttamento di una cava ha diffuso polveri
d'amianto in ogni angolo. Come alla ex fabbrica Fibronit di Bari, i cui residui
di amianto sono stati per anni scaricati in mare, cosicché a poco a poco le
fibre si sono depositate su una spiaggia. L'ecatombe è quotidiana: i ricercatori
del Monaldi di Napoli, un polo di eccellenza per la diagnosi e la cura delle
malattie respiratorie, ha redatto nel 2009 un rapporto-choc, studiando le
cartelle cliniche di chi è morto nell'ultimo decennio in Campania per
mesotelioma pleurico. Ebbene, tra il 2006 e il 2002 c'è stato un l'aumento di
casi del 50 per cento rispetto al cinquennio precedente. E su 213 casi censiti,
198 hanno riguardato persone che non hanno mai lavorato in mezzo al veleno. Come
mai un fenomeno così massiccio? «La rimozione e il deposito in discariche
speciali dell'amianto, come previsto dalla legge, non è semplice»scrivono i
ricercatori «per cui spesso l'amianto è gettato in discariche comuni e/o
abusive, e quando gli agenti atmosferici penetrano nelle discariche ne possono
derivare percolati che diffondono le fibre nocive nell'ambiente e nelle acque».
Il rapporto ha una dedica speciale, «in ricordo di due cari amici morti di
recente per il mesotelioma». Ancora oggi nessuno ha pubblicato una mappatura
degli edifici pubblici contaminati, ma è sicuro che alcune Regioni, una volta
venuti a conoscenza della quantità di veleno ancora in circolo, hanno preferito
secretare la documentazione. Scelta che ha fatto la Toscana. Peccato, perchè la
legge del marzo del 2001 ha stanziato per la mappatura nazionale ben 9 milioni
di euro. Calabria, Lazio e Sicilia non hanno consegnato ancora nessuna tabella,
mentre Campania, Puglia, Umbria, Veneto e Valle d'Aosta hanno inviato al
ministero dell'Ambiente dati parziali e statistiche poco significative. Nessuno,
in Italia, ha investito massicciamente sulla bonifica del territorio. Nemmeno
per le condutture: quasi tutte le grandi città vengono usate migliaia di
condutture in cemento-amianto per trasportare l'acqua nelle nostre case. «Non è
un problema» dicono gli scienziati dell'Oms «Non è sicuro che l'amianto bevuto
faccia male come quello che si respira». Allora sì, siamo tranquilli.
Acque velenose di Emiliano Fittipaldi. Nichel.
Arsenico. Fosforo. Sostanze pericolose dai nostri rubinetti. E le Regioni lo
nascondono alzando i limiti di legge. Un libro racconta i disastri d'Italia. I
veleni sono in agguato. Nell'acqua che beviamo, nel cibo, nell'aria che
respiriamo, nei cosmetici. Esce mercoledì prossimo 'Così ci uccidono' (Rizzoli),
l'inchiesta di Emiliano Fittipaldi, giornalista de 'L'espresso' che racconta
storie e segreti di avvelenatori e avvelenati, protagonisti di un disastro
nazionale di cui nessuno vuole parlare. Anticipiamo un brano dal primo capitolo.
Lo stato delle acque pubbliche italiane e la possibilità, accettata per legge,
che si possano ingurgitare sorsi di sostanze tossiche al di sopra delle soglie
massime è un fenomeno nascosto, che coinvolge centinaia di comuni in tutto il
Paese. Città e piccoli centri dove ogni giorno dai rubinetti della cucina e
dalla doccia sgorgano, mischiate alle molecole d'acqua, anche quelle
dell'arsenico, dell'alluminio, del cromo, del nichel. Con l'aggiunta di un po'
di piombo, vanadio, fluoro, selenio, trialometanio, atrazina. E spesso in quelle
zone i tassi di mortalità sono più alti rispetto a quanto dovrebbero essere.
"Atra... che?". "Atrazina, signora.". "E quindi?". "E quindi non la deve più
bere né bollirci le patate". Così la signora Maria Rosa di Dossobuono da
Villafranca di Verona, profondo Nord-Est, ha scoperto che l'acqua del suo comune
era una schifezza. Il 30 settembre 2009 il sindaco Mario Faccioli ha stabilito
con un'ordinanza "l'interdizione del consumo dell'acqua da parte della
popolazione, fino all'avvenuto ripristino della qualità-idoneità dell'acqua
erogata". Maria e 11 mila compaesani dalla sera alla mattina hanno imbracciato
taniche e bottiglie vuote e fatto la fila per riempirle alle cisterne. L'acqua
era un pericolo. Atrazina e desetilatrazina vogliono dire tracce di concimi
azotati usati in agricoltura e di un diserbante vietato dal 1992. Ma quanta ne
hanno bevuta prima di esserne informati? Una disposizione simile è in vigore
anche a Civitavecchia, nel Lazio, dove nei bagni di certe aziende c'è scritto
sopra i lavandini: 'Non bevete'... Qui a rendere torbida l'acqua sono gli
organoalogenati, composti nocivi anche per semplice inalazione. Purtroppo non si
tratta affatto di casi limite. Nell'ultimo anno, solo per fare qualche esempio,
divieti assoluti sono scattati a Campomarino (Molise), Agrate Brianza
(Lombardia), Satriano (Calabria), Mussomeli e Campobello di Licata (Sicilia). A
Talamone, in Toscana, il sindaco ha invece ordinato di "far bollire l'acqua per
almeno quindici minuti, se la si vuole utilizzare per usi alimentari".
Tranquillizzante. Che cosa contamina le nostre acque e perché? Ci sono diverse
spiegazioni: la morfologia del territorio, gli scarichi industriali, la carenza
delle condutture. Talvolta in un solo territorio concorrono all'inquinamento
tutte e tre le situazioni: nella zona dei Colli Albani, nel Lazio, in un'area
che interessa 1.500 chilometri quadrati e quasi 600 mila persone, le acque sono
intossicate dalle emissioni gassose sotterranee del Vulcano Laziale, ricche di
anidride carbonica, che entrano in contatto con le rocce portando nelle tubature
metalli pesanti. Il mix è inoltre arricchito dai liquami privati, che vengono
scaricati nel terreno. Ne risulta una massiccia presenza di elementi cancerogeni
o fortemente tossici come il fluoro, l'arsenico, l'uranio nelle falde
sottostanti. A Crotone, in Calabria, se possibile va ancora peggio. Si sospetta
che l'acqua sia contaminata e avvelenata da arsenico, cadmio e altri minerali
tossici... Un altro disastro si è verificato nei pressi di Pescara, in una valle
a 50 chilometri dalla città... Abruzzo, Colli Albani, Civitavecchia, Veneto sono
solo esempi probabilmente abbastanza noti della devastazione massiccia del
nostro territorio. Pochi sanno però che le nostre istituzioni ce la danno a
bere, letteralmente, l'acqua avvelenata che ha invaso acquedotti e condutture.
Non possono evitarlo, l'unico modo è lasciare a secco qualche milione di
persone. Ma come ci riescono senza farsi notare troppo? Attraverso le cosiddette
"deroghe". La questione risale ai primi anni Duemila, quando entra in vigore il
decreto legislativo 31/2001, che disciplina le acque destinate al consumo umano.
Le norme stabiliscono i valori limite dei parametri microbiologici e chimici che
possono essere presenti nell'acqua per definirla "potabile". Ma, in particolari
circostanze di degrado della risorsa idrica, l'articolo 13 del decreto concede
alle amministrazioni "interessate" la possibilità di accordare deroghe ai valori
prescritti, purché non comportino "potenziale pericolo per la salute umana e
sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo non possa esser
assicurato con altro mezzo". In pratica, se l'acqua comune presenta elementi
potenzialmente nocivi, l'ente locale lascia aperti i rubinetti e fissa dei
termini entro i quali dovrà provvedere a riportare i parametri a norma. Peccato
che in genere le deroghe non durino pochi mesi, ma vengano rinnovate di anno in
anno. Un controsenso anche per l'Unione europea: dal 2012, non sarà più
possibile far ricorso ai regimi in deroga. Senza trucchetto, però, c'è il
rischio concreto che milioni di famiglie possano rimanere senz'acqua. Dal 2002
almeno 13 regioni italiane hanno fatto uso massiccio di deroghe. La prima è
stata la Campania, proprio quell'anno, per eccesso di fluoro nelle acque... Le
deroghe accordate per 14 comuni della provincia di Napoli erano ancora in vigore
nel 2009. Nel 2003 si sono aggiunte Sicilia e Toscana. Nell'acquedotto di
Palermo e di altri comuni della fascia costiera ci sono troppi cloriti: i
cittadini hanno bevuto livelli 'fuorilegge' fino al 2007. Stessa sorte per le
deroghe nei comuni del massiccio etneo, in provincia di Catania, accordate anche
per vanadio e boro; mentre nel 2008 a un comune della provincia di Trapani è
stata concessa deroga per i nitrati, legati all'allevamento e all'uso di
fertilizzanti. Per quanto riguarda la Toscana, dal 2003 si sono bevuti veleni in
eccesso in ben 137 comuni... Gli elementi oggetto delle deroghe sono arsenico,
boro, cloriti, trialometani... In genere le lievi contaminazioni da arsenico
comportano lesioni, arti gonfi e perdita di sensibilità, mentre quelle più gravi
possono portare fino al cancro alla vescica, ai polmoni e ai reni... Marco
Betti, assessore della regione Toscana alla Difesa del suolo, si è detto sicuro
che l'emergenza rientrerà presto... Nel 2004 le regioni che hanno adottato
deroghe raddoppiano. Oltre a Campania, Sicilia e Toscana si sono aggiunte
Lombardia, Piemonte, Trentino, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Sardegna. In
Emilia e nelle Marche si è disposta per due anni la deroga in alcuni comuni dove
erano presenti cloriti. Invece Lombardia e Piemonte fanno eccezioni per le
località dove le acque sono ricche di arsenico... In Puglia sono state disposte
deroghe (attive tuttora) per cloriti e trialometani... Pure la regione Sardegna
ha dispensato alcuni comuni dai parametri legali di cloriti, trialometani e
vanadio... Il Lazio è una delle aree italiane dove il problema delle
contaminazioni delle risorse idriche è più forte. Come descritto in un rapporto
di Cittadinanzattiva, se nel 2006 le deroghe riguardavano complessivamente 37
comuni, di cui 15 per tre parametri contemporaneamente, nel 2009 il totale dei
comuni ammonta a 84 e in 59 tra questi le dispense riguardano quattro parametri:
arsenico, fluoro, selenio e vanadio... Nel 2006 tocca al Veneto derogare le
acque di un paesino della provincia di Verona, dati gli alti tassi di
tricloroetilene e tetracloroetilene, contaminanti organici molto utilizzati
nelle lavanderie e nelle industrie metalmeccaniche... Qui il caso è virtuoso:
dopo un anno il Veneto ha deciso di non prorogare. L'ultima regione ad adottare
dispense normative è stata l'Umbria, nel 2008: deroghe sull'arsenico attive
ancora oggi, sebbene l'assessorato regionale assicuri: "Sono problemi di origine
geologica, ci sono da sempre e si sostanziano in 14 microgrammi di arsenico a
litro d'acqua". Ovvero poco al di sopra di quanto consentito dalla legge. Ora
avete il petrolio, disse l'ingegnere. "Il petrolio? Mi creda, se lo succhiano -
disse il professore - se lo succhiano. E così finisce col petrolio: una canna
lunga da Milano a Gela, e se lo succhiano". Leonardo Sciascia aveva capito.
Aveva scritto in un racconto del 1966, 'Il mare colore del vino', che il
petrolchimico della città siciliana non avrebbe portato una lira nelle tasche
dei suoi abitanti. Mai, però, avrebbe potuto immaginare che, dopo 40 anni, la
città sarebbe diventata famosa in tutto il mondo per i tassi mostruosi di
malformazioni e tumori. L'area di Gela è una delle più inquinate del mondo, ed è
cosa nota. Ma ora l'Oms ha scoperto che nelle vene degli abitanti scorre anche
arsenico. Il biomonitoraggio effettuato dal Cnr è durato mesi, e ha dato
risultati choccanti: il sangue del 20 per cento del campione, composto in tutto
da 262 persone, è pieno di veleno. Oltre all'arsenico ci sono tracce di rame,
piombo, cadmio e mercurio. Non si tratta di operai esposti sul lavoro, ma di
casalinghe, impiegati, giovani sotto i 44 anni. Residenti a Gela, Niscemi e
Butera. Nelle loro urine sono stati trovati livelli di arsenico superiori del
1.600 per cento al tasso-limite. Facendo una proporzione sul totale dei
residenti, a rischio avvelenamento potrebbero trovarsi più di 20 mila persone.
Non stupiscono, visti i risultati delle analisi, i nuovi dati sulla mortalità e
le malattie, statistiche che arrivano fino al 2007: "Nell'area in studio", si
legge nel rapporto pubblicato su 'Epidemiologia&Prevenzione', si osserva una
mortalità generale per tutti i tumori significativamente più elevata, sia negli
uomini sia nelle donne". Il boom riguarda il cancro alla pleura, ai bronchi e ai
polmoni, con eccessi di patologie per lo stomaco, la laringe, il colon e il
retto. Un disastro sanitario che è evidente anche nelle tabelle sulle malattie
generiche, con troppi ricoveri per malattie psichiatriche e avvelenamenti. Che a
Gela si muore d'ambiente sembra provarlo anche un'altro report firmato
dall'Istituto superiore di sanità: tra i lavoratori del petrolchimico, i più a
rischio sono quelli che, finito il turno, tornano a casa in città. I pendolari
non residenti hanno tassi di mortalità per cancro polmonare molto più bassi Lo
studio è uno spartiacque. Per la prima volta gli scienziati hanno in mano un
potenziale nesso tra inquinamento del territorio e mortalità in eccesso. Un
legame che dovrebbe indurre le istituzioni a darsi una mossa, mettendo in campo
politiche di prevenzione più efficaci: anche se non sappiamo ancora il tipo di
arsenico che circola nel corpo dei gelesi (quello inorganico è cancerogeno,
quello organico è tossico, ma assai meno pericoloso) gli scienziati chiedono
subito maggiori controlli sugli alimenti, in particolare su verdure, pesci e
crostacei. Fabrizio Bianchi, epidemiologo del Cnr, ha coordinato la ricerca e
non nasconde la sua preoccupazione: "L'impatto ambientale è indubitabile. In
mare, nelle acque, sulla terra ci sono concentrazione di metalli superiori fino
a un milione di volte i livelli accettabili. L'arsenico non era già presente in
forme naturali, come dice qualcuno, ma è stato immesso dall'uomo. La 'pistola
fumante'? Diciamo che abbiamo trovato i proiettili, ora dobbiamo capire chi ha
sparato". La procura indaga, ma il compito dei pm non è facile. Oggi a Gela è
attiva la grande raffineria dell'Eni, ma nell'area per decenni hanno fabbricato
clorosoda, acido cloridico e altri prodotti chimici. Le bonifiche già partite
sono poche, la stragrande maggioranza dei veleni resta a terra. "Siamo ancora
alle conferenze istruttorie", chiosa Bianchi: "Bisognerebbe accelerare l'iter,
anche perché l'arsenico è un composto che non rimane a lungo nel corpo. Le
grandi quantità che abbiamo trovato dimostrano che l'esposizione è tutt'ora in
corso".
Acqua velenosa di Emiliano Fittipaldi. Nel fiume
Ticino è allarme cadmio, cromo, ammoniaca, azoto. In dosi fuori limite. E altri
inquinanti nei bacini idrici in provincia di Milano e Pavia. Scoperti dal Corpo
forestale. Nel 1997 i Mondiali di Pesca all'oro hanno fatto tappa nel Ticino.
Gli organizzatori sono andati a colpo sicuro: le preziose pagliuzze scendono
dalle Alpi dalla notte dei tempi, e le gesta dei cercatori (migliaia di schiavi
assoldati dall'Impero romano, in verità) le ha già raccontate Plinio il Vecchio.
Oggi una nuova corsa è inimmaginabile: si calcola che il fiume trasporti ogni
giorno micro-pepite per un valore oscillante tra i 5 mila e i 10 mila euro, poca
cosa. Ma di sicuro, se si organizzasse una nuova tappa del campionato, oggi
nelle padelle non finirebbe il nobile metallo giallo, ma perniciosissimi (e
invisibili) metalli pesanti. Che, in aggiunta a decine di altre sostanze
tossiche, formano un menù killer per la flora e la fauna dell'ecosistema.
Cadmio, azoto ammoniacale e cromo esavalente sono solo alcuni degli inquinanti
ritrovati in quantità superiori ai limiti dai tecnici del Corpo forestale dello
Stato, che hanno messo sotto osservazione la parte di fiume vicino Morimondo. Un
comune ridente, al di là del nome, e famoso per i suoi prodotti biologici: siamo
all'interno del Parco della Valle del Ticino, annoverata dall'Unesco tra i
patrimoni dell'umanità. "Mancanza di depuratori, scarichi urbani, agricoli e
industriali hanno messo in serio pericolo la salute delle acque. E chi si fa il
bagno nel fiume lo fa a suo rischio e pericolo", dice Elisabetta Morgante,
vice-questore aggiunto della polizia scientifica ambientale. Non solo ignari
canoisti e pescatori e altri habitué del Ticino, ma anche chi va nelle toilette
di alcune fabbriche di Abbiategrasso, senza saperlo, mette a rischio la propria
incolumità. A pochi chilometri da Milano, infatti, gli agenti del Corpo hanno
scoperto che l'acqua che esce dai rubinetti di alcune fabbriche di un grosso
insediamento industriale (circa 20 fabbricati in periferia) è avvelenata.
Dipendenti, operai e dirigenti si lavano con il cadmio, il nichel e il piombo,
metalli trovati sia nelle condutture dei bagni sia nelle fognature del
quartiere. Anche in provincia di Pavia, ad Albuzzano, le indagini del
laboratorio mobile hanno scoperto situazioni al limite. Le acque nere di un
nuovo complesso residenziale del paese finiscono dritte dritte nei canali di
irrigazione dei campi. A parte il tanfo, fastidioso ma innocuo, l'acqua corretta
a fenolo e nichel penetra nel terreno dove si coltivano foraggio e cereali. Mais
e grano che si trasformano in pane e pasta. Chi crede che la Lombardia, la zona
più ricca e sviluppata d'Italia, sia immune dagli effetti dell'inquinamento
selvaggio e dell'antropizzazione sbaglia di grosso. I fiumi della regione sono
molto sporchi: secondo gli ultimi dati resi noti dell'Agenzia di protezione
dell'ambiente il 32 per cento dei corsi d'acqua è 'scarso' o 'pessimo', e le
falde primarie, quelle più in superficie, sono praticamente compromesse. Come la
Lombardia, anche il resto della Pianura Padana conserva nel sottosuolo nitrati,
metalli e pesticidi in quantità massicce. "Si pensa agli effetti della diossina
a Napoli e alle falde acquifere del Sud, ma anche qui abbiamo seri problemi",
spiega Damiano Di Simine, presidente regionale di Legambiente: "Dieci milioni di
abitanti, sette milioni tra suini e bovini, insediamenti zootecnici e
industriali hanno un impatto pesante. Se il Seveso e l'Olona non viaggiano
dentro zone agricole, l'inquinatissimo Lambro viene usato tuttora per irrigare i
campi. Una bomba biologica". Nel Bresciano le industrie di fucili e chiodi della
Val Trompia scaricano nel fiume Mella, che bagna filari di ortaggi e frumento.
Un corso che ha sparpagliato la diossina prodotta dalla Caffaro di Brescia per
mezza provincia. La Lombardia è in ottima compagnia. I dati Apat disegnano un
quadro a tinte fosche di tutte le acque tricolori. Quella potabile è in genere
di ottima qualità, ma le riserve blu del sottosuolo e i corsi in superficie
sono, in parte, contaminati, come mostrano la tabellla qui a fianco, e come
spieghiamo nel dettaglio nell'articolo di pagina 53. Con un trend decisamente
negativo: rispetto al 2003, l'acqua delle falde inquinata per mano dell'uomo
passa dal 21,5 al 28 per cento, mentre il liquido di classe 1 e 2, il più
pregiato, diminuisce di tre punti. Ticino al cadmio Morimondo è in provincia di
Milano ed è nelle acque in cui si specchia il paesino (1.131 anime secondo
l'ultimo censimento Istat) che la Forestale ha fatto le prime analisi. La
diagnosi è sconfortante: quello che molti considerano uno dei fiumi più puliti
d'Italia è gravemente ammalato. "Abbiamo trovato presenza massiccia di schiuma,
dovuta a presenza di tensioattivi", spiega Elisabeta Morgante, "ma soprattutto
valori alti di cadmio, fenoli, azoto ammoniacale, piombo. Sostanze rilevate sia
vicino lo scarico sia nell'ansa. Un fatto gravissimo per un'area di elevato
pregio naturalistico. Bisogna che le autorità gestiscano gli scarichi in modo
adeguato. Sono troppi i comuni della zona senza depuratore o con sistemi non
funzionanti, e troppe le aziende di zootecnia e del secondario che buttano tutto
in canali collegati al Ticino". L'inquinamento-choc è provocato anche dallo
sfruttamento serrato da parte dell'agricoltura: il fiume, saccheggiato durante
sei mesi l'anno, a bassa portata perde la capacità di autodepurazione. I
campanelli d'allarme ci sono tutti, compresa l'assenza dei microrganismi che
vivono solo in acque pulite: la minaccia all'ecosistema è reale. "Non solo.
Ricordo che qui si coltivano riso e prodotti biologici, cibo che finisce sulle
nostre tavole", chiosa la scienziata. Che fa un breve, terrificante elenco degli
effetti dei metalli pesanti sulla salute e l'ambiente. "Il cadmio è un metallo
raro, e insieme al mercurio è il più pericoloso. E' tossico per l'uomo anche a
concentrazioni minime, e tende ad accumularsi negli esseri e negli ecosistemi.
L'assorbimento avviene attraverso gli alimenti, come fegato, funghi, crostacei,
polvere di cacao, alghe. I fenoli hanno effetti pericolosi se ingeriti o messi a
contato con gli occhi, il piombo viene trattenuto nel sistema nervoso centrale e
nelle ossa". Anche il cromo esavalente, usato per la concia delle pelli o la
produzione di vernici, può provocare reazioni allergiche, problemi di stomaco e
respiratori, persino alterazione del materiale genetico e cancro ai polmoni.
"Solo una piccola parte di questa sostanza si dissolve in acqua:
l'acidificazione del terreno può facilitare l'assorbimento del cromo da parte
dei raccolti". Nichel ad Abbiategrasso La vicenda di Abbiategrasso, paesone a 20
chilometri dal capoluogo, ha dell'incredibile. La Forestale ha trovato nichel,
piombo e cadmio direttamente nell'acqua che usciva dai rubinetti di un intero
supercondominio industriale alla periferia della città. Un distretto in cui sono
localizzate varie ditte: dalle carrozzerie per auto ad aziende di materie
plastiche, dalla verniciatura di accessori da bagno alla produzione di sacchetti
e borse in polietilene, fino alla costruzione di motori elettrici e alla
lavorazione del cemento. Circa 20 insediamenti in cui lavorano centinaia di
persone. La gestione della lottizzazione, dice la Forestale, non è mai passata
al Comune, e la zona non è servita da un acquedotto: le aziende scaricano i
liquidi in una fognatura privata, e l'acqua che alimenta il quartiere proviene
da un pozzo. Tutto gestito da una società che, dopo le indagini, è finita nel
mirino della Procura di Milano. Dopo l'intervento della Forestale
l'amministrazione ha firmato un'ordinanza urgente, che ha vietato alle aziende
di aprire i rubinetti venefici. "La problematica degli scarichi e della gestione
della risorsa idrica in Italia anche nei contesti apparentemente più sviluppati
è risultata quanto mai irrisolta e confusa: in provincia di Milano le analisi
portano ad ipotizzare un rischio concreto di contaminazione diffusa", chiosano
dal Corpo. L'acqua destinata ai bagni delle aziende, usata per fini igienici, ma
che chiunque poteva bere, era di fatto non potabile, così sporca da poter
determinare "danni ambientali anche a lungo termine e forme di tossicità acuta e
cronica". Pavia a cielo aperto Il mirino dei biologi della Forestale si è infine
fermato su Albuzzano, in provincia di Pavia. Il regno dei cereali e del riso: i
chicchi della zona finiscono nei piatti di tutti gli italiani, e si stagliano in
bella evidenza persino nello stemma del Comune. Ebbene, nella ricca Padania può
accadere che un insediamento residenziale nuovo di zecca scarichi le sue acque
nere direttamente nel reticolo idrico superficiale. Fuor di tecnicismi, lo scolo
dei bagni di una ventina di villette finisce nei canali a cielo aperto usati per
l'irrigazione dei campi coltivati. "Abbiamo visto a occhio nudo chiazze oleose e
idrocarburanti, oltre a sentire un puzzo nauseante", ragiona Alberto Guzzi,
comandante provinciale del Corpo: "L'inquinamento, paradossalmente, in questo
caso potrebbe essere legalizzato: non è raro che la Provincia autorizzi
temporaneamente il convoglio degli scarichi nelle acque superficiali. Basti
pensare che fino a pochi anni fa intere zone di Milano est usavano il Lambro
come fognatura". Dai risultati dei campioni prelevati risultano anche valori
alti di fenoli, presenza di piombo e nichel, formazione di solidi sospesi a
rischio tossicità. A dimostrazione che i veleni non sono un'esclusiva della
Campania e delle sue discariche, ma galleggiano anche nelle acque poco
trasparenti dell'Italia del Nord.
Così ho avvelenato Napoli di Gianluca Di Feo e
Emiliano Fittipaldi. Le confessioni di Gaetano Vassallo, il boss che per 20 anni
ha nascosto rifiuti tossici in Campania pagando politici e funzionari. Temo per
la mia vita e per questo ho deciso di collaborare con la giustizia e dire tutto
quello che mi riguarda, anche reati da me commessi. In particolare, intendo
riferire sullo smaltimento illegale dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, a
partire dal 1987-88 fino all'anno 2005. Smaltimenti realizzati in cave, in
terreni vergini, in discariche non autorizzate e in siti che posso materialmente
indicare, avendo anche io contribuito...Comincia così il più sconvolgente
racconto della devastazione di una regione: venti anni di veleni nascosti
ovunque, che hanno contaminato il suolo, l'acqua e l'aria della Campania. Venti
anni di denaro facile che hanno consolidato il potere dei casalesi, diventati
praticamente i monopolisti di questo business sporco e redditizio. La
testimonianza choc di una follia collettiva, che dalla fine degli anni Ottanta
ha spinto sindaci, boss e contadini a seminare scorie tossiche nelle campagne
tra Napoli e Caserta. Con il Commissariato di governo che in nome dell'emergenza
ha poi legalizzato questo inferno. Gaetano Vassallo è stato l'inventore del
traffico: l'imprenditore che ha aperto la rotta dei rifiuti tossici alle aziende
del Nord. E ha amministrato il grande affare per conto della famiglia
Bidognetti, seguendone ascesa e declino nell'impero di Gomorra. I primi clienti
li ha raccolti in Toscana, in quelle aziende fiorentine dove la massoneria di
Licio Gelli continua ad avere un peso. I controlli non sono mai stati un
problema: dichiara di avere avuto a libro paga i responsabili. Anche con la
politica ha curato rapporti e investimenti, prendendo la tessera di Forza Italia
e puntando sul partito di Berlusconi.
La rete di protezione. Quando Vassallo si presenta
ai magistrati dell'Antimafia di Napoli è il primo aprile. Mancano due settimane
alle elezioni, tante cose dovevano ancora accadere. Due mesi esatti dopo,
Michele Orsi, uno dei protagonisti delle sue rivelazioni è stato assassinato da
un commando di killer casalesi. E 42 giorni dopo Nicola Cosentino, il più
importante parlamentare da lui chiamato in causa, è diventato sottosegretario
del governo Berlusconi. Vassallo non si è preoccupato. Ha continuato a riempire
decine di verbali di accuse, che vengono vagliati da un pool di pm della
direzione distrettuale antimafia napoletana e da squadre specializzate delle
forze dell'ordine: poliziotti, finanzieri, carabinieri e Dia. Finora i riscontri
alle sue testimonianze sono stati numerosi: per gli inquirenti è altamente
attendibile. Anche perché ha conservato pacchi di documenti per dare forza alle
sue parole. Che aprono un abisso sulla devastazione dei suoli campani e poi,
attraverso i roghi e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, sulla
minaccia alla salute di tutti i cittadini. Come è stato possibile? "Nel corso
degli anni, quanto meno fino al 2002, ho proseguito nella sfruttamento della ex
discarica di Giugliano, insieme ai miei fratelli, corrompendo l'architetto
Bovier del Commissariato di governo e l'ingegner Avallone dell'Arpac (l'agenzia
regionale dell'ambiente). Il primo è stato remunerato continuativamente perché
consentiva, falsificando i certificati o i verbali di accertamento, di far
apparire conforme al materiale di bonifica i rifiuti che venivano smaltiti
illecitamente. Ha ricevuto in tutto somme prossime ai 70 milioni di lire.
L'ingegner Avallone era praticamente 'stipendiato' con tre milioni di lire al
mese, essendo lo stesso incaricato anche di predisporre il progetto di bonifica
della nostra discarica, progetto che ci consentiva la copertura formale per
poter smaltire illecitamente i rifiuti". Il gran pentito dei veleni parla anche
di uomini delle forze dell'ordine 'a disposizione' e di decine di sindaci
prezzolati. Ci sono persino funzionari della provincia di Caserta che firmano
licenze per siti che sono fuori dai loro territori. Una lista sterminata di
tangenti, versate attraverso i canali più diversi: si parte dalle fidejussioni
affidate negli anni Ottanta alla moglie di Rosario Gava, fratello del patriarca
dc, fino alla partecipazione occulta dell'ultima leva politica alle società
dell'immondizia.
L'età dell'oro. Vassallo sa tutto. Perché per
venti anni è stato il ministro dei rifiuti di Francesco Bidognetti, l'uomo che
assieme a Francesco 'Sandokan' Schiavone domina il clan dei casalesi. All'inizio
i veleni finivano in una discarica autorizzata, quella di Giugliano, legalmente
gestita. Le scorie arrivavano soprattutto dalle concerie della Toscana, sui
camion della ditta di Elio e Generoso Roma. C'era poi un giro campano con tutti
i rifiuti speciali provenienti dalla rottamazione di veicoli: fiumi di olii
nocivi. I protagonisti sono colletti bianchi, che fanno da prestanome per i
padrini latitanti, li nascondono nelle loro ville e trasmettono gli ordini dal
carcere dei boss detenuti. In pratica, accusa tutte le aziende campane che hanno
operato nel settore, citando minuziosamente coperture e referenti. C'è
l'avvocato Cipriano Chianese. C'è Gaetano Cerci "che peraltro è in contatto con
Licio Gelli e con il suo vice così come mi ha riferito dieci giorni fa". Il
racconto è agghiacciante. Sembra che la zona tra Napoli e Caserta venga colpita
dalla nuova febbre dell'oro. Tutti corrono a sversare liquidi tossici,
improvvisandosi riciclatori. "Verso la fine degli Ottanta ogni clan si era
organizzato autonomamente per interrare i carichi in discariche abusive. Finora
è stato scoperto solo uno dei gruppi, ma vi erano sistemi paralleli gestiti
anche da altre famiglie". Ci sono trafficanti fai-dai-te che buttano liquidi
fetidi nei campi coltivati in pieno giorno. Contadini che offrono i loro
frutteti alle autobotti della morte. E se qualcuno protesta, intervengono i
camorristi con la mitraglietta in pugno.
La banalità del male. Chi, come Vassallo, possiede
una discarica lecita, la sfrutta all'infinito. Il sistema è terribilmente
banale: nei permessi non viene indicata l'esatta posizione dell'invaso, né il
suo perimetro. Così le voragini vengono triplicate. "Tutte le discariche campane
con tale espediente hanno continuato a smaltire in modo abusivo, sfruttando
autorizzazioni meramente cartolari. Ovviamente, nel creare nuovi invasi mi sono
disinteressato di attrezzare quegli spazi in modo da impermeabilizzare i
terreni; non fu realizzato nessun sistema di controllo del percolato e nessuna
vasca di raccolta, sicché mai si è provveduto a controllare quella discarica ed
a sanarla". In uno di questi 'buchi' semilegali Vassallo fa seppellire un
milione di metri cubi di detriti pericolosi. L'aspetto più assurdo è che durante
le emergenze che si sono accavallate, tutte queste discariche - quelle lecite e
i satelliti abusivi - vengono espropriate dal Commissariato di governo per fare
spazio all'immondizia di Napoli città. All'imprenditore della camorra Vassallo,
pluri-inquisito, lo Stato concede ricchi risarcimenti: quasi due milioni e mezzo
di euro. E altra monnezza seppellisce così il sarcofago dei veleni, creando un
danno ancora più grave. "I rifiuti del Commissariato furono collocati in
sopra-elevazione; la zone è stata poi 'sistemata', anche se sono rimasti
sotterrati rifiuti speciali (includendo anche i tossici), senza che fosse stata
realizzata alcuna impermeabilizzazione. Non è mai stato fatto uno studio serio
in ordine alla qualità dell'acqua della falda. E quella zona è ad alta vocazione
agricola". L'import di scorie pericolose fruttava al clan 10 lire al chilo. "In
quel periodo solo da me guadagnarono due miliardi". Il calcolo è semplice:
furono nascoste 200 mila tonnellate di sostanze tossiche. Questo soltanto per
l'asse Vassallo-casalesi, senza contare gli altri i boss napoletani che si erano
lanciati nell'affare, a partire dai Mallardo. "Una volta colmate le discariche,
i rifiuti venivano interrati ovunque. In questi casi gli imprenditori venivano
sostanzialmente by-passati, ma talora ci veniva richiesto di concedere l'uso dei
nostri timbri, in modo da 'coprire' e giustificare lo smaltimento dei produttori
di rifiuti, del Nord Italia... Ricordo i rifiuti dell'Acna di Cengio, che furono
smaltiti nella mia discarica per 6.000 quintali. Ma carichi ben superiori
dall'Acna furono gestiti dall'avvocato Chianese: trattava 70 o 80 autotreni al
giorno. La fila di autotreni era tale che formava una fila di circa un
chilometro e mezzo". Un'altra misteriosa ondata di piena arriva tra la fine del
2001 e l'inizio del 2002: "Si trattava di un composto umido derivante dalla
lavorazione dei rifiuti solidi urbani triturati, contenente molta plastica e
vetro". Decine di camion provenienti da un impianto pubblico: a Vassallo dicono
che partono da Milano e vanno fatti scomparire in fretta.
Il patto con la politica. Uno dei capitoli più
importanti riguarda la società mista che curava la nettezza urbana a Mondragone
e in altri centri del casertano. E' lì che parla dei fratelli Michele e Sergio
Orsi, imprenditori con forti agganci nei palazzi del potere: il primo è stato
ammazzato a giugno. I due, arrestati nel 2006, si erano difesi descrivendo le
pressioni di boss e di politici. Ma Vassallo va molto oltre: "Confesso che ho
agito per conto della famiglia Bidognetti quale loro referente nel controllo
della società Eco4 gestita dai fratelli Orsi. Ai fratelli Orsi era stata fissata
una tangente mensile di 50 mila euro... Posso dire che la società Eco4 era
controllata dall'onorevole Nicola Cosentino e anche l'onorevole Mario Landoldi
(An) vi aveva svariati interessi. Presenziai personalmente alla consegna di 50
mila euro in contanti da parte di Sergio Orsi a Cosentino, incontro avvenuto a
casa di quest'ultimo a Casal di Principe. Ricordo che Cosentino ebbe a ricevere
la somma in una busta gialla e Sergio mi informò del suo contenuto". Rapporti
antichi, quelli con il politico che la scorsa settimana ha accompagnato
Berlusconi nell'ultimo bagno di folla napoletano: "La mia conoscenza con
Cosentino risale agli anni '80, quando lo stesso era appena uscito dal Psdi e si
era candidato alla provincia. Ricordo che in quella occasione fui contattato da
Bernardo Cirillo, il quale mi disse che dovevamo organizzare un incontro
elettorale per il Cosentino che era uno dei 'nostri' candidati ossia un
candidato del clan Bidognetti. In particolare il Cirillo specificò che era stato
proprio 'lo zio' a far arrivare questo messaggio". Lo 'zio', spiega, è Francesco
Bidognetti: condannato all'ergastolo in appello nel processo Spartacus e, su
ordine del ministro Alfano, sottoposto allo stesso regime carcerario di Totò
Riina e Bernardo Provenzano. L'elezione alla provincia di Caserta è stata invece
il secondo gradino della carriera di Cosentino, l'avvocato di Casal di Principe
oggi leader campano della Pdl e sottosegretario all'Economia. "Faccio presente
che sono tesserato 'Forza Italia' e grazie a me sono state tesserate numerose
persone presso la sezione di Cesa. Mi è capitato in due occasioni di
sponsorizzare la campagna elettorale di Cosentino offrendogli cene presso il
ristorante di mio fratello, cene costose con centinaia di invitati. L'ho
sostenuto nel 2001 e incontrato spesso dopo l'elezione in Parlamento". Ma quando
si presenta a chiedere un intervento per rientrare nel gioco grande della
spazzatura, gli assetti criminali sono cambiati. Il progetto più importante è
stato spostato nel territorio di 'Sandokan' Schiavone. Il parlamentare lo riceve
a casa e può offrirgli solo una soluzione di ripiego: "Cosentino mi disse che si
era adeguato alle scelte fatte 'a monte' dai casalesi che avevano deciso di
realizzare il termovalorizzatore a Santa Maria La Fossa. Egli, pertanto, aveva
dovuto seguire tale linea ed avvantaggiare solo il gruppo Schiavone nella
gestione dell'affare e, di conseguenza, tenere fuori il gruppo Bidognetti e
quindi anche me". Vassallo non se la prende. E' abituato a cadere e rialzarsi.
Negli ultimi venti anni è stato arrestato tre volte. Dal 1993 in poi, ad ogni
retata seguiva un periodo di stallo. Poi nel giro di due anni un'emergenza che
gli riapriva le porte delle discariche. "Fui condannato in primo grado e
prosciolto in appello. Ma io ero colpevole". Una situazione paradossale: anche
mentre sta confessando reati odiosi, ottiene dallo Stato un indennizzo di un
milione 200 mila euro. E avverte: "Conviene che li blocchiate prima che i miei
fratelli li facciano sparire...".
Impunità di frode. Sconti di pena, patteggiamenti,
benefici: così chi contamina gli alimenti se la cava sempre. E soltanto ora il
ministero divulga la lista nera dei condannati. I soliti sospetti della frode
alimentare hanno la vita facile. Perché l'impunità è sostanzialmente
garantita:basta patteggiare per tornare in fabbrica, nella stalla o in cantina e
ricominciare con i trucchi. Nessuno finisce in carcere e quasi mai gli italiani
vengono informati sulla malafede di chi produce, confeziona, custodisce o cucina
quello che mangiano e bevono. Lo Stato è di manica larga con chi mette a rischio
la salute dei cittadini o inganna la fiducia dei consumatori: sconti di pena o
libertà condizionale per tutti, fedine sbiancate con la "non menzione" delle
condanne. Eppure lo choc per le 19 persone uccise dal metanolo, con il blocco
delle esportazioni e la crisi dei vini italiani, aveva impartito una lezione
unica: pochi criminali erano riusciti a distruggere la credibilità di un'intera
categoria. Subito venne varata una legislazione severissima, che introduceva
anche la gogna per i banditi del cibo. Sì, la legge metteva al primo posto la
salute rispetto alla tutela di marchi, aziende, ristoranti e negozi. Un
principio fondamentale, che poi è stato costantemente disatteso anche di fronte
a situazioni di grande allarme sociale: i nomi delle ditte coinvolte diventano
sempre una sorta di segreto di Stato, esponendo così l'intero settore alla
psicosi e i consumatori al pericolo di bocconi indigesti. Dopo il metanolo, il
Parlamento aveva scelto una strada diversa. Dal 1986 per legge il ministero
della Sanità è stato incaricato di rendere noto ogni anno "l'elenco pubblico"
dei condannati per frode o sofisticazione. Una lista nera che però i governi si
sono guardati bene dal propagandare. Finora si è trattato di un documento
introvabile: veniva inserito nella "Gazzetta ufficiale", senza scadenze fisse.
Con un aspetto beffardo: i dati risalivano in genere a cinque anni prima. Nel
2003, per esempio, sono state rese note le sentenze diventate definitive del
1998. Nel frattempo le ditte potevano avere cambiato nome, logo, titolare. Per
tornare a colpire come e più di prima. Nei giorni scorsi il ministero della
Sanità ha deciso -anche dopo la richiesta formale de "L'espresso" - di rendere
disponibile sul suo sito web la lista degli ultimi verdetti. Una scelta di
trasparenza, a cui si è aggiunto un elenco sugli anni precedenti. Si tratta però
di informazioni molto parziali. Anzitutto le comunicazioni più rapide riguardano
le infrazioni minime, che diventano subito esecutive con il pagamento della
multa: sono soprattutto trattorie, bar e banchi con cibi mal conservati. I
processi veri richiedono invece anni prima della Cassazione. C'è poi il problema
del ritardo nella trasmissione da parte dei giudici. Le punizioni recenti
riguardano in massima parte il tribunale di Milano e poche altre sedi
giudiziarie: non c'è nulla su Roma e sulla Sicilia, per esempio. Ma la colpa non
è del dicastero guidato da Livia Turco, dove spiegano che spesso la magistratura
fornisce l'elenco «ad intervalli pluriennali ed ha per oggetto provvedimenti
emessi nell'arco di 3-4 anni». Insomma, anche questo deterrente introdotto dal
legislatore contro i sofisticatori è stato soffocato dalla disastrosa condizione
della burocrazia italiana. Ecco perché non sorprende scoprire che la cantina di
Veronella, punto di partenza dell'ultima maxiinchiesta sul "vino contaminato",
era già stata coinvolta nello scandalo al metanolo. Oggi patteggiare di fatto
significa farla franca: pena sotto i due anni, niente carcere né servizi
sociali, nessuna menzione sul certificato penale. Insomma, nulla di nulla. Lo
rivela in modo impressionante uno studio condotto da cinque ricercatori
dell'Università di Parma, dipartimento di salute animale, che evidenzia tutti i
lati oscuri della nostra industria più ghiotta. In cinque anni, tra il 1995 e il
'99, ci sono state 2.540 sentenze definitive. In massima parte, però, si tratta
di alimenti conservati male, sporchi, corretti con sostanze proibite: minacce
secondarie alla salute, sanzionate con una multa. Ma anche quando il tribunale
ordina la reclusione, pochi scontano la pena. In 207 casi è stata concessa la
sospensione condizionale. Per non parlare dell'ultimo indulto, un'ondata di
piena nello spazzare via gli effetti di questi crimini. La statistica diventa
paradossale quando si esamina la "non menzione", ossia i condannati a cui non
viene nemmeno macchiata la fedina penale: ben 1.215 che quindi restano
totalmente impuniti. Sono colpevoli di avere lucrato su carne, latte, verdura o
altri cibi fuorilegge, ma all'indomani della sentenza possono addirittura
partecipare alla gara per rifornire un asilo o un ospedale. C'è persino la
beffa: vengono sostenuti con denaro pubblico tutti i produttori di un settore
danneggiato dall'effetto delle truffe, ma non si risarciscono le vittime. E'
quello che è accaduto con l'eccidio del metanolo, che uccise 19 persone e ne
rese cieche altre 15. Dopo più di 22 anni le vittime non hanno visto una lira e
nemmeno un euro. Lo schema è lo stesso: gli arrestati diventano nullatenenti
prima del giudizio, le aziende falliscono e al momento della sentenza i
quattrini si sono dissolti. Ricorda Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo
e al tempo rappresentante legale delle famiglie: «Al processo ottenemmo
provvisionali alte, anche 300 milioni di lire, ma rimasero sulla carta.
L'incredibile è che lo Stato stanziò decine di miliardi per aiutare il settore
vitinicolo, duramente provato dallo scandalo. Furono spesi pacchi di denaro per
campagne pubblicitarie, per potenziare i controlli, perfino per riparare i danni
subiti dai supermercati stranieri, ma nemmeno una lira fu destinata alle
vittime». Nella macchina impazzita della giustiza si scoprono altri due
incentivi a delinquere. Il primo è la clemenza automatica, con sconti
elargielargiti anche a chi non risarcisce i danni o non mostra nemmeno rimorso:
il principale responsabile della strage da metanolo, da una pena iniziale di 16
anni alla fine ne ha passati in cella meno della metà. E c'è la questione delle
analisi di laboratorio. Perché il gioco dei parametri sulle sostanze chimiche e
la valutazione dei livelli di pericolosità diventano complessi da valutare in
tribunale, animando guerre di perizie. Spesso, poi, sul banco degli imputati ci
sono multinazionali che possono schierare collegi di luminari. La vicenda del
latte all'inchiostro è paradigmatica. L'Asl di Ascoli Piceno nell'agosto 2005
scoprì nel latte per l'infanzia quantità non previste di Itx, una sostanza usata
(e grazie a questa indagine successivamente vietata in tutta l'Ue) per fissare
l'inchiostro sulle confezioni di cartone. Il pm di Ascoli Piceno, avvertito il
ministero della Salute, dispose il sequestro in tutta Italia di milioni di
litri, tutti i lotti che scadevano nel settembre 2006. Ma per due mesi non
succede nulla: solo quando la vicenda arriva sui giornali il prodotto
incriminato viene ritirato. Una costante: gli organismi di controllo non si
muovono finché non scoppia lo scandalo o interviene un magistrato. Il processo
per l'Itx finisce a Milano, sede legale della Nestlé. A dicembre l'Europa getta
acqua sul fuoco: l'Efsa, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, esclude
la possibilità che l'Itx interagisca con il Dna delle cellule. Non si espone su
eventuali altri rischi tossici: non ci sono studi sufficienti. La procura di
Milano chiede dunque al farmacologo Silvio Garattini una perizia, che di fatto
chiude l'inchiesta. Il gip la ricalca nelle sue conclusioni: «Non esiste prova
che l'assunzione di Itx per via alimentare rappresenti, da subito, un pericolo
significativo in termini di tossicità». Tutti assolti perché non è provata la
minaccia alla salute. Giusto. Il gip non può non sottolineare però che Garattini
non ha nemmeno escluso che «la tossicità possa essere rilevata in caso di
assunzione per lunghi periodi, essendo necessari ulteriori studi per valutare
gli effetti del bioaccumulo». Quel latte era l'alimento principale dei neonati:
chi li tutelerà dagli eventuali effetti futuri che non sono mai stati studiati?
PARLIAMO DI DISASTRI AMBIENTALI
Case crollate, strade ridotte ad un cumulo di
fango e detriti, auto accartocciate, oggetti sparsi ovunque e morti, tanti
morti. Un inferno d'acqua colpisce periodicamente i territori italiani. Alla
rabbia e al dolore per la perdita di vite umane si aggiungono i tanti, troppi
danni materiali, quantificabili in milioni e milioni di euro. Sono quelli che
servono alla ricostruzione di case e ponti crollati, alla rimozione dei detriti,
al ripristino degli ambienti danneggiati e speriamo, alla messa in sicurezza dei
fiumi. Ma tutto questo si può evitare? Difficile dirlo ma certo, si può fare
molto per prevenire quei danni, dovuti certo alla portata straordinaria delle
piogge, ma soprattutto alla grave incuria di territori sottoposti addirittura a
stretto regime di tutela, spesso entro i confini di un parco nazionale. Sul web,
in particolare su Facebook e Twitter, censurati dai media si formano gruppi
improvvisati di cittadini che protestano inascoltati per le gravi mancanze
istituzionali. Per esempio il parco delle “Cinque Terre” è stato nell'occhio
del ciclone per l'arresto del presidente e di alcuni funzionari, accusati di
intascarsi i fondi destinati alla protezione.
Ma quello che tanti cittadini denunciano, al di là
delle responsabilità individuali e di quelle governative (lo Stato destina
pochissimi fondi a questo scopo), è il sistema protezionista italiano affidato a
pseudo tutele ambientaliste di ideologia sinistroide: capace di sbraitare per le
piccole questioni di abusivismo edilizio, ma assente su fronti importanti come
quello della manutenzione dei corsi d'acqua e della messa in sicurezza di zone a
rischio frane e smottamenti. “Fra un anno staremo qui a piangere ancora i morti
– scrive Piero I. sul gruppo No alluvione del Magra – Altri morti immolati alla
verde ecologica follia dell'impatto antropico!”. Il suo giudizio è drastico “la
gente crepa affogata – scrive – perché ovunque si devono salvare i passerotti”.
“Il fiume va pulito – scrive ancora - questa estate si vedevano ancora i
"relitti" della scorsa alluvione.. pare che sia vietato andare a prendere i
tronchi.. non ci posso credere”. Lo conferma Giampiero B., geometra di una ditta
rimasta sotto il fango, che commenta: “anni e anni fa lavoravamo anche noi nel
fiume estraendo ghiaia e tutti questi problemi come oggi non c'erano....
sicuramente la pulizia e l'estrazione non sono le uniche soluzioni ma ci
vogliono varie opere a sostegno, iniziamo a fare qualcosa perchè la prossima
volta sarà ancora peggio”.
Uno dei luoghi comuni più ricorrenti ogni volta
che capita un’esondazione e che questa sarebbe dovuta all’accumulo di ghiaia nei
fiumi e nei torrenti, da dove non verrebbe più rimossa. In consiglio regionale
del Piemonte è stato approvato il 30 marzo 2011 un ordine del giorno per
‘rendere i fiumi dragabili e per finanziare la pulizia dei torrenti’. Contro
questo ordine del giorno insorge Sinistra Ecologia e Libertà, nelle parole del
coordinatore regionale, il casalese Fabio Lavagno, e Vanda Bonardo responsabile
ambiente della segreteria.
Questo è: tutto uno schierarsi per ideologie.
Esemplare è quello che è successo a Genova. Tutta
una città martoriata, e non certo una città costruita abusivamente. Ma non dite
che non si poteva fare niente. Ma non dite che non era prevedibile. Da giorni di
sapeva che una violenta perturbazione avrebbe colpito di nuovo la Liguria, dopo
la catastrofe delle Cinque Terre, e ci siamo specializzati in meteorologia
spicciola, isobare e cumulonembi, sapevamo tutto della pioggia che sarebbe
caduta, del rischio idrogeologico, del pericolo frane. Si sono riempite pagine
di giornali annunciando ogni singola goccerella attesa dal cielo e spiegando le
ragioni dell'inevitabile allarme. Dopo l’alluvione sulle Cinque Terre con morti
e disastri si annunciava una nuova perturbazione, forse più grave. E poi che
cos'è successo? È successo quello che era stato previsto. E il sindaco di
Genova, Marta Vincenzi, invece, salta subito fuori a dire che «non era
prevedibile». E che dunque «non si poteva fare niente».
Ma come non era prevedibile? L'evento
meteorologico più previsto e annunciato dell'era contemporanea non era
prevedibile? Con tutti quei “giuliacci” che pontificano in ogni angolo della Tv,
le protezioni civili riunite in seduta permanente, le centrali operative
attrezzate con satelliti che scrutano ogni acquazzone e anticipano ogni refolo
di vento, come si fa a dire che un evento simile non era prevedibile? Con che
coraggio, di fronte a quei sette morti, di fronte al dolore dei loro famigliari,
di fronte alla devastazione di una città colpita al cuore, si dice che «non si
poteva fare niente»? Non è un po' troppo comodo?
Mettiamola in modo ancor più crudo: gli
amministratori usano l'acqua dei fiumi in piena per lavarsi le mani, come tanti
Ponzio Pilato in versione nubifragio. E pazienza se quell'acqua in cui si lavano
le mani è la stessa che trascina via i cadaveri dei loro concittadini. Non hanno
ritegno, non hanno pudore. Si presentano davanti alle telecamere, davanti ai
microfoni, davanti ai taccuini. E dicono che loro non c'entrano, che è uno
tsunami, un fatto straordinario. Oppure iniziano il gioco dello scaricabarile:
il Comune attacca la Provincia, la Provincia attacca la Regione, tutti attaccano
il governo, che a sua volta attaccherà non si sa chi. Non vi sembra ora di
mettere fino all'assurdo giochino? È inaccettabile che si ripetano le tragedie.
Soprattutto è inaccettabile che le tragedie non abbiano mai un responsabile.
Ma che ci lamentiamo, se siamo solo e sempre noi a
rivotare sta gente.
Per esempio: Marta Vincenzi è stata la prima donna
a ricoprire l'incarico di presidente della Provincia di Genova; se non bastasse,
non trovando nessun altro, poi l'hanno eletta sindaco della città di Genova.
Non è questione di sinistra, destra,
amministratori di qua o di là. Non se ne deve fare una speculazione politica,
non se ne deve fare una polemica di parte. Nessuno può permettersi di
sciacallare sui corpi di due bambine trascinate via dal fiume in piena. Ma c'è
una questione di dignità, c'è una questione di responsabilità. Davanti a quei
due bambini, così come davanti alle altre vittime di Genova o quelle delle
Cinque Terre o quelle di ogni territorio italiano per ogni tempo, non possiamo
rispondere ancora una volta che «non era prevedibile», che «non si poteva fare
niente». Non lo può fare la classe dirigente di questo Paese perché altrimenti
che diavolo ci sta a fare nel ruolo di classe dirigente? Se «non si può mai fare
niente», se «non ci sono mai responsabili», se «non era compito mio», perché mai
dovremmo mantenere un esercito di politici e amministratori che, come numero,
non ha pari nel mondo? Per sentirci dire ogni volta che "non si poteva fare
niente"?
Ai funerali ad Aulla i parenti delle vittime non
hanno voluto politici. E la scelta la dice lunga su quale sia il sentimento
diffuso nel Paese. Nessuno ne può più di persone che giocano a nascondino, di
rimpalli su fax mandati o non mandati, distinguo di lana caprina sulle
competenze. Perché a Genova le scuole ieri erano aperte? Perché i fiumi non
erano stati puliti? Le foto pubblicate dai giornali mostravano il Bisagno
sporco, bisognoso di interventi e di cura. Perché nessuno li ha fatti? A chi
toccavano? Perché la città di New York è stata chiusa e si è salvata da un
uragano violentissimo e a Genova, nonostante i precedenti e gli avvisi, nessuno
s'è preso la responsabilità di fare altrettanto? La gente era stata informata
dei rischi? Ad Aulla era arrivato un fax di pericolo della Protezione civile, ma
ai cittadini non gliel'aveva comunicato nessuno: e a Genova? Quali iniziative
erano state prese per spingere la gente all'«auto protezione»? Quali strade sono
state chiuse? Quali torrenti sono stati monitorati?
Non si tratta di fare polemiche ciniche. Il vero
cinismo è di chi dice: «Non si poteva fare nulla». Il vero cinismo è di chi
dice: «Non era prevedibile». Il vero cinismo è di coloro che continuano a
nascondersi dietro frasi di circostanza, per cercare di scaricare la loro
coscienza che gronda fango e lutto. Il vero cinismo è di chi usa lacrime per
nascondere scuse, di chi assume incarichi dimenticando che sono incarichi di
responsabilità. E la responsabilità è una cosa seria. Per evitare le tragedie ci
vogliono i soldi, è vero. Se dalla Finanziaria 2012, come denuncia il Wwf, sono
spariti i 500 milioni previsti per la prevenzione del dissesto idrogeologico,
ebbene si tratta di una bischerata. Ma i soldi bisogna anche usarli bene: se
davvero il problema è la mancanza di fondi, perché a Genova si sta costruendo
per 17,8 milioni di euro un nuovo palazzo amministrativo per i dirigenti della
Asl 3? È più importante sistemare i letti dei fiumi o le scrivanie dei
burocrati?
Per rispetto delle vittime dell'alluvione bisogna
evitare in ogni modo di trasformare la tragedia in una rissa, la solita rissa,
Regione contro governo, centrodestra contro centrosinistra, berlusconiani contro
antiberlusconiani. Ma bisogna dire, con la stessa chiarezza, che nessuno si può
sottrarre alle sue responsabilità....
Che non permetteremo di ripetere a tutti che «non
si poteva fare niente» e che «non era prevedibile». Ci sono sette persone a
Genova trascinate via dal fango nel mezzo della loro città, ci sono bambine
strappati alla vita mentre passeggiavano nel loro quartiere. Le due piccole
pensavano che quei posti fossero sicuri come la loro casa, invece erano a
rischio. Lo sapevano tutti, qualcuno ora deve risponderne.
«L'Italia del fango sta mostrando la sua faccia,
il suo ghigno, il suo sberleffo. L'Italia senza giustizia che manda in galera
chi denuncia. L'Italia senza legge con un Parlamento incostituzionale,
presidenti di Regione illegittimi, al terzo e al quarto mandato consecutivo,
come Formigoni, Errani, Iorio. Dove sono i magistrati? Dove la Corte
Costituzionale? Il cittadino è solo, senza riferimenti, senza informazione,
senza rappresentanti. L'Italia del cemento lo sta seppellendo vivo. Non c'è
governo, non c'è opposizione, ma un comitato di affari che si spartisce il Paese
senza vergogna». Parole di Beppe Grillo, ligure doc, di fronte alla tragedia di
Genova e nei giorni precedenti in altre zone della regione. Parole affidate alla
rete dal suo blog: «Oggi mi sento impotente - dice l'esponente politico - la
distruzione di Genova era annunciata. E io non ho potuto fare nulla. Ho visto la
mia città trasformata in fanghiglia con le auto che cadevano sul porto insieme
alla pioggia e ai morti sapendo che si poteva evitare». Per Grillo «nel prossimo
Parlamento non uno di questi senatori e deputati deve presentarsi. Camera e
Senato vanno svuotati come secchi di merda».
C'è anche un attacco al capo dello Stato: «Il
Colle ha detto su Genova "Capire le cause!". La causa - dice Grillo - è una
classe politica di cui Napolitano fa parte dal dopoguerra, da 66 anni!». E nel
ricordare che proprio oggi «a Roma il Pdmenoelle va in piazza per "Ricostruire
l'Italia" insieme all'Idv e con la partecipazione straordinaria dell'ebetino di
Firenze (il sindaco Renzi)», Grillo sottolinea: «Ricostruire? Bersani dovrebbe
cambiare nome alla manifestazione, chiamarla 'Distruggere l'Italia. Questa finta
opposizione che vuole la Tav, la Gronda, che ha cementificato la Liguria, che ha
in Regione Burlando e come sindaco di Genova Marta Vincenzi, ci prende pure per
il culo? Il senso di estraniamento, di solitudine del cittadino che non ha più
nessuno dalla sua parte non so a cosa porterà. In Val di Susa hanno arrestato
due ragazze incensurate che prestavano soccorso ai manifestanti. Donne che erano
lì, a Chiomonte, per evitare lo sfacelo del territorio. Erano lì anche per i
morti di Genova e della Lunigiana. Chi arresteranno ora per disastro colposo? I
meteorologi?».
LA TRUFFA DEL FOTOVOLTAICO.
Gas ed Elettricità: gli italiani aprono
le bollette, ma solo 1 su 10 le sa leggere, scrive
Giovedì 06 Luglio 2017 "Sienafree.it". Più del 50% della popolazione pensa che
la liberalizzazione del mercato dell’energia porti a una riduzione dei costi, ma
il 90% ritiene che l’efficientamento energetico delle case sia la soluzione per
contenere i costi della bolletta. I risultati di una ricerca Estra – Lorien
Consulting.
Aprono le bollette, ma non le conoscono o le
conoscono poco. E solo il 12% degli italiani sa leggere la bolletta del gas o
dell’elettricità. Credono nel libero mercato ma ancor di più
nell’efficientamento energetico. E’ la fotografia scattata da Estra,
multiutility tra le prime in Italia nel settore dell’energia, nel corso di
un’indagine condotta per conto dell’azienda toscana da Lorien Consulting,
Istituto di Ricerca di Milano. Dall’indagine emerge che il 59% degli italiani
controlla le proprie bollette ogni volta che le riceve e che il 40% sa indicare
l’importo esatto di quella della luce, mentre solo il 28% conosce i costi di
quella del gas. Il 59% degli italiani si dichiara anche a conoscenza della
differenza tra costi fissi (imposte) e costi variabili (valore unitario per
utilizzo effettivo). Credere di sapere non è tuttavia sinonimo di conoscenza,
tanto che in realtà gli intervistati che sanno effettivamente indicare una
percentuale affine a quella corretta rappresentano solo il 12% della
popolazione, circa un italiano su dieci. I dati della ricerca evidenziano
inoltre come il 66% della popolazione ritenga che il peso delle imposte sulle
bollette debba essere ridotto mentre il 14% degli italiani giudica il peso dei
costi fissi inevitabile per il mantenimento del welfare nazionale. In generale
per la riduzione dei costi fissi in bolletta si auspicano misure di
efficientamento energetico (88%) - in particolare l’isolamento termico (49%), la
sostituzione della caldaia (17%), l’installazione di pannelli fotovoltaici
(16%), l’uso di elettrodomestici intelligenti (14%) - ma si distinguono anche i
fiduciosi nel libero mercato (55%). Il 63% degli italiani sa inoltre
dell’esistenza del Bonus Energia da applicarsi in base al reddito ma casualmente
chi non conosce tale strumento è proprio chi ha diritto ad usufruirne. “Gas ed
elettricità continuano a pesare sulle tasche di famiglie e imprese proprio a
causa delle elevate imposizioni fiscali - ha sottolineato il Presidente di
Estra, Francesco Macrì. I costi fissi sono infatti in crescita dal 2008 e sono
superiori alla media europea. Per questo lo Stato deve attuare una riduzione di
tale tassazione partendo dall’eliminazione dell’IVA su imposte, accise e
addizionali affinché i costi si riducano con benefici evidenti. La
liberalizzazione del mercato dell’energia, da attuarsi alla data prevista dal
Ddl Concorrenza, ovvero a partire dal 1° luglio 2019, è una strada utile se
attuata in modo chiaro e trasparente. Il percorso di liberalizzazione avrà
l’effetto di stimolare una maggiore concorrenza sia a livello di prezzo, che di
qualità del servizio offerto, a patto che il consumatore sia posto al centro.”
Le famiglie e le imprese cercano un vantaggio economico nelle offerte sul
mercato libero dei vari venditori. E infatti il 12% degli intervistati ha
dichiarato di aver cambiato fornitore di gas o energia elettrica negli ultimi 12
mesi a causa di costi ritenuti troppo alti. Questo dato dimostra una certa
mobilità in funzione della ricerca di un risparmio che tuttavia, a causa di
imposizioni fiscali che nel nostro Paese incidono dal 35% al 45% sul costo
finale, può risultare vana.
Quanto risparmio in bolletta con il
fotovoltaico? Scrive "Luce-Gas Selectra". In Italia
negli ultimi anni abbiamo assistito a grandi trasformazioni in questo settore,
dettate soprattutto dai ripetuti cambiamenti normativi e dallo sviluppo del
mercato mondiale dei produttori dei pannelli fotovoltaici. Gli eventi hanno
contribuito ad una crescita esponenziale del fotovoltaico, purtroppo in alcuni
casi anche con l’apporto degli speculatori. Ultimamente il mercato si
è stabilizzato ed a livello normativo si è cercato di favorire i piccoli
impianti e la generazione distribuita, bloccando gli incentivi agli impianti a
terra.
Come funziona un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico produce energia elettrica
utilizzando la radiazione solare attraverso i moduli fotovoltaici in grado di
convertire appunto l'energia solare in elettrica. La corrente prodotta
è continua e quindi è necessario collegare l'impianto ad un inverter, elemento
che trasforma la corrente in alternata per poterne permettere l'uso in
un'abitazione. L’impianto è in genere connesso sia all’utenza finale, ossia
l’impianto elettrico della casa, che alla rete elettrica nazionale in bassa
tensione attraverso un contatore bidirezionale. In questo modo è possibile
consumare direttamente l'energia autoprodotta per alimentare gli i consumi
dell'abitazione, oppure immetterla in rete quando è in eccedenza.
Si risparmia con l’installazione di un impianto
fotovoltaico?
Il guadagno per una famiglia non è sempre
scontato, perché le variabili in gioco sono molte ed il calcolo non è immediato.
Per essere sicuri di guadagnarci, l'importante è di scegliere un impianto
dimensionato correttamente rispetto ai consumi. Il primo fattore di risparmio:
l’autoconsumo. L'autoconsumo consiste nel consumare istantaneamente l’energia
che produce l'impianto. In questo modo non si preleva dalla rete la
corrente necessaria al fabbisogno, e si evita di pagarla al fornitore. Il primo
risultato è quindi una sostanziale riduzione (non eliminazione!) della bolletta
della luce. Ovviamente l'entità del risparmio dipende da quanto si paga
l'energia elettrica al fornitore e del costo dell'impianto fotovoltaico. Grazie
all'autoconsumo si risparmia sia sul costo dell'energia consumata che
sugli oneri di rete, oneri di sistema e le tasse legati al consumo di energia
elettrica. Al giorno d'oggi gli impianti fotovoltaici sono economicamente molto
più accessibili rispetto a prima, poichè il prezzo di un impianto si è ridotto
di quasi un terzo rispetto a qualche anno fa. Per analizzare il possibile
risparmio derivante da un fotovoltaico bisogna calcolare tutti i costi da
sostenere esposti di seguito:
Fornitura dell’impianto: moduli, inverter, quadri,
connettori, struttura ... circa il 50% della spesa totale;
Installazione: progettazione, messa in opera,
collaudo ... circa il 30% della spesa totale;
Costi amministrativi: gestione pratiche per
l’allacciamento con il distributore e per gli incentivi con il GSE, circa il 20%
della spesa totale;
Naturalmente le percentuali sopra espresse sono
indicative e dipendono dalla taglia dell'impianto e dalla qualità dei prodotti.
I parametri essenziali per la valutazione
dell'impianto fotovoltaico:
Potenza dell'impianto;
Qualità degli elementi: principalmente dei moduli
e dell'inverter;
Producibilità dell'impianto in base alla
localizzazione geografica, l'orientamento ed l'inclinazione dei moduli;
Modalità di consumo dell'energia prodotta: più
alto sarà l'autoconsumo, più alti saranno i risparmi;
Per stimare quanto possa produrre il tuo
impianto, ti consigliamo questo sito gestito dalla Commissione Europea. E' molto
completo e preciso!
Durata di un impianto fotovoltaico.
E' importante sottolineare che i costi
sovraesposti devono essere ammortizzati su un periodo di almeno 20 anni. Quasi
tutti i produttori offrono una garanzia sul rendimento e quindi sulla produzione
dei pannelli per 20 o 25 anni, dopo questo periodo il nostro impianto continuerà
a funzionare tranquillamente ed a produrre energia elettrica solamente in misura
minore. La vita di un impianto fotovoltaico è caratterizzata da una bassa
manutenzione per l'assenza di organi in movimento. L'elemento più delicato
dell'intero sistema è l'inverter, che al suo interno ha una parte elettronica e
generalmente dopo circa 10 anni deve essere sostituito.
Quali sono le agevolazioni dello Stato per il
fotovoltaico domestico?
Per il 2014 le agevolazioni previste dallo Stato
per le fonti rinnovabili in ambito domestico-residenziale, ossia per impianti di
bassa potenza (fino a 20 kW), installati su proprietà ad uso abitativo sono due:
Lo scambio sul posto;
La detrazione fiscale;
Lo scambio sul posto. Attualmente il sostegno
previsto per gli impianti domestici è lo scambio sul posto (SSP), gestito
dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Tale meccanismo dà la possibilità di
immettere in rete l'energia elettrica in eccesso per poi prelevarla in un
secondo momento, differente da quando avviene la produzione. La rete viene
considerata come se fosse un accumulatore di energia virtuale e il GSE eroga un
"contributo in conto scambio" per l'energia immessa in rete. Il contributo viene
calcolato con una specifica formula che tiene conto sia dell'energia immessa che
prelevata, con una buona approssimazione una valutazione di massima è di circa
0,15 €/kWh immesso.
La detrazione fiscale. E' possibile usufruire
inoltre anche della detrazione fiscale, nel 2014 fissata al 50% ma che già nel
2015 diminuirà forse al 36%, che coinvolge il costo totale dell'impianto
comprese le relative spese. Questa porta in pratica al dimezzamento del costo
complessivo dell'impianto, attraverso le riduzione dell'imposta Irpef nei 10
anni consecutivi all'installazione. Lo sgravio fiscale riguarda quindi soltanto
le persone fisiche (o condomini o soci di cooperative) contributori Irpef.
Come leggere il contatore con un impianto
fotovoltaico?
Con l'installazione di un impianto fotovoltaico
il contatore verrà sostituito dalla società di distribuzione competente con
un contatore bidirezionale. Questo tipo di contatore, riconoscibile da due
frecce poste sul fronte dello stesso, è sempre elettronico e misura quindi i
consumi in tutte le fasce orarie. La differenza sostanziale è che questo
misura sia l'energia prelevata dalla rete, che quella immessa, ossia quella
prodotta dal nostro impianto e che non viene direttamente consumata
dall'abitazione. Premendo più volte il pulsante sarà facile leggere i prelievi e
le immissioni suddivisi nelle fasce orarie A1, A2 e A3, che sommati daranno il
totale dell'energia prelevata ed immessa.
Per impianti incentivati col "Conto Energia",
terminati a luglio del 2013, era presente un secondo contatore subito a valle
dell'impianto con lo scopo di misurare tutta l'energia prodotta dall'impianto
che veniva incentivata con particolari tariffe.
Un esempio reale. Poniamo ad esempio il caso reale
di una casa indipendente assumendo le seguenti ipotesi:
Contratto di fornitura di 3 kW di potenza e
consumo annuale standard di 2700 kWh (3 persone);
Tariffa adottata: D2 residente monoraria (spesa
annua di 521€);
Impianto da 2 kW di picco, con una produzione
stimata di circa 2600 kWh all'anno;
Abitazione situata in centro Italia;
Pannelli con esposizione ed orientamento ottimali;
Percentuale di autoconsumo del 60%:
L'autoconsumo corrisponde all'energia elettrica
che produce l'impianto e che viene istantaneamente consumata dall'abitazione per
le nostre necessità. Il risparmio è maggiore quando autoconsumiamo l'energia,
una volta installato l'impianto quindi dovremmo cercare di spostare i nostri
consumi, ad esempio fare lavatrice e lavastoviglie nelle ore diurne, quando la
corrente viene dal sole!
UN CONSIGLIO!
Il risparmio è maggiore con l'autoconsumo.
Conviene quindi autoconsumare il più possibile l'energia prodotta dall'impianto
che immetterla in rete!
I restanti kWh prodotti dall'impianto e non
direttamente consumati saranno immessi in rete ed il GSE prevede un contributo,
(emesso in una o due rate annuali) calcolato mediante una specifica formula. Per
l'esempio indicativo abbiamo ipotizzato il contributo pari a 0,15 € a kWh
immesso.
Costo dell'impianto.
Un impianto di questo tipo di media qualità ha un
costo sul mercato di circa 5.000 € tutto incluso. Ma se consideriamo
la detrazione fiscale, questo costo si dimezza e per 10 anni avremo un entrata
fissa di 250 € ogni anno, a rimborso della spesa effettuata. Questa agevolazione
da un contributo notevole all'analisi dei costi/benefici e diminuisce di molto
il tempo di rientro dell'investimento. Da sottolineare che in questo esempio i
consumi sono bassi e di conseguenza anche il risparmio, che aumenterebbe se i
consumi fossero maggiori. Ovviamente in tal caso anche l'impianto sarà
dimensionato di conseguenza con produzione e costi maggiori.
ATTENZIONE! QUANDO SI FANNO I CONTI SUL
RISPARMIO IN BOLLETTA BISOGNA SEMPRE AGGIUNGERE LA COMPONENTE FISCALE FISSA E
PROGRESSIVA, CHE RENDE UN BLUFF IL RICORSO AL FOTOVOLTAICO ED AL COSTO DI
ISTALLAZIONE…UN AFFARE SOLO PER LE IMPRESE FOTOVOLTAICHE.
Tasse e oneri parafiscali: quanto pesano sulla
bolletta? Scrive "Luce-Gas Selectra".
Il peso delle tasse sulla bolletta. La bolletta
dell'energia elettrica e del gas può essere molto salata. Ti sei mai chiesto
quanto pesano le tasse e gli sconosciuti oneri parafiscali sulla bolletta? Se da
una parte è possibile scegliere un prezzo dell'energia conveniente, magari
bloccato per uno o due anni, dall'altra ci sono tanti altri oneri, definiti
dallo Stato e applicati a tutti i clienti. In occasione del convegno “Il mercato
dell’energia, un nano sotto i piedi del gigante fiscale e parafiscale”,
organizzato dall'Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader (AIGET)
e I-Com, sono emersi dei numeri molto interessanti sul tema delle tasse e
dell'energia.
Sommario:
Qual é la differenza tra tasse e oneri
parafiscali?
Il peso di tasse e oneri sul prezzo finale
dell'energia elettrica
Il peso di tasse e oneri sul prezzo finale del gas
Gli oneri parafiscali all'interno della bolletta
elettrica
Gli oneri parafiscali all'interno del gas
Qual è la differenza tra tasse e oneri
parafiscali?
Le tasse sull'energia si dividono in IVA, accisa e
addizionale regionale (applicata solo al gas) e vengono pagate in funzione del
tipo di utente, la differenza principale è tra i clienti domestici e quelli
industriali. Per prelievo parafiscale si intende invece l'introito derivante
dagli oneri generali di sistema, cioè quella parte della bolletta della luce che
va a coprire gli incentivi per le energie rinnovabili, gli sgravi elettrici per
le agevolazioni alle imprese, per il finanziamento del bonus elettrico... Anche
gli oneri generali vengono applicati dallo Stato ma sono distinti dalle imposte
vere e proprie come l'accisa e l'IVA. Il gettito delle imposte sull'energia
elettrica e sul gas metano sul totale delle tasse a carico degli italiani è in
crescita dal 2008 ed è sempre stato superiore al valore medio dei paesi europei.
Il peso di tasse e oneri sul prezzo finale
dell'energia elettrica.
Questa crescente imposizione fiscale si riflette
naturalmente sul prezzo finale di energia elettrica che paga l'utente. In Italia
nel settore domestico la percentuale delle tasse e degli oneri parafiscali sul
prezzo di vendita dell'energia elettrica è pari al 35%, poco al di sopra della
media UE. La Danimarca e il Regno Unito hanno rispettivamente le tasse
sull'energia elettrica (oneri fiscali e parafiscali) più alte e più basse in
Europa (in percentuale).
Il peso di tasse e oneri sul prezzo finale del
gas.
In Italia le tasse e gli oneri parafiscali, nel
settore domestico, arrivano a circa il 34% del prezzo finale del gas, ben 10
punti sopra la media europea. Nel settore del gas gli oneri parafiscali sono
meno importanti rispetto al settore elettrico ma vengono compensati da una
tassazione più pesante. Le tasse e gli oneri che gravano in Italia sul prezzo
finale, sono superiori alla media europea in entrambi i settori dell'energia
elettrica e del gas. Nel nostro Paese, le componenti parafiscali della bolletta
condizionano pesantemente il mercato libero dell'energia, anche se hanno poco a
che fare con esso.
Gli oneri parafiscali all'interno della
bolletta elettrica.
Negli ultimi anni gli oneri parafiscali sono
aumentati considerevolmente in primo luogo grazie alle politiche incentivanti
per le fonti rinnovabili di energia. Il peso degli oneri all'interno della
bolletta dell'energia elettrica dei clienti (la parte rossa) ha ormai superato
la componente fiscale costituita dalle imposte. Confrontando il peso delle varie
componenti di costo, la principale differenza con gli altri paesi europei è
rappresentata dall'onere della componente A3 (oneri generali di sistema)
destinata appunto alle energie rinnovabili. L'aumentare degli oneri di sistema
ha inoltre diminuito il peso dei servizi di vendita all'interno della bolletta,
che rappresentano la leva commerciale dei fornitori nel mercato libero. Questa
crescita ha una ricaduta negativa sul mercato libero dell'energia perché
rende meno percepibile il prezzo della materia prima energia (nei servizi di
vendita, la parte blu). La bolletta in questo modo non riflette il costo dei
prodotti e servizi resi e il mercato liberalizzato non riesce ad esprimere a
pieno la concorrenza tra i fornitori. Gli oneri generali di sistema, così come i
costi di rete, vengono applicati ai clienti domestici con tariffa D2 in maniera
progressiva. Questo significa che il costo della componente diventa più grande
all'aumentare dei consumi. Già da qualche tempo si discute della riforma della
tariffa dell'energia elettrica, che ha come obiettivo proprio il superamento
della struttura progressiva della tariffa e l'adeguamento della componente degli
oneri generali di sistema ai costi effettivi del servizio.
Gli oneri parafiscali all'interno della
bolletta del gas.
Gli oneri parafiscali per il gas sono: la
componenti RE, per progetti di risparmio energetico e lo sviluppo di fonti
rinnovabili nel settore del gas, la componente Rs per l'incentivazione della
qualità, le quote Ug1, Ug3 (per squilibri e interruzioni) e GS (bonus gas). Come
già accennato questi oneri costituiscono solo una minima parte del totale dei
servizi di rete e non influiscono in modo così evidente come per l'energia
elettrica.
Imprese energivore, il bluff di sconti e
sussidi: a pagarli sono i contribuenti. Il
sottosegretario allo Sviluppo economico Simona Vicari ha detto: “La stagione
dell’assalto agli incentivi o alle esenzioni è chiusa". Ma una deliberazione
dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas ha stabilito che la compensazione
sarà “a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle agevolazioni”. Cioè dei
consumatori privati, cittadini e imprese, scrive Davide D'Antoni il 27 novembre
2013 su "Il Fatto Quotidiano". Chi paga e a quanto ammontano i nuovi aiuti
sull’energia? Il 30 ottobre 2013, durante un convegno organizzato dall’Enel, il
sottosegretario allo Sviluppo economico Simona Vicari dichiarava: “La stagione
dell’assalto agli incentivi, ai sussidi di qualunque natura o alle esenzioni è
chiusa”. Forse non sapeva che sei giorni prima l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas approvava una deliberazione (la numero 467) che disciplina i
nuovi aiuti alle imprese energivore voluti da Corrado Passera in zona Cesarini,
quando cioè il governo Monti disbrigava gli ‘affari correnti’. A pagina 9 della
deliberazione, infatti, si scopre il bluff. Il sussidio verrà compensato da una
componente tariffaria che troveremo in bolletta, la Ae che sarà “a carico di
tutte le utenze non beneficiarie delle agevolazioni”, cioè consumatori privati e
imprese non energivore. Insomma, molti aiutano pochissimi per un valore che –
stima il coordinamento Free – potrebbe aggirarsi attorno a 4 miliardi di euro.
Il decreto 5 aprile 2013 partorisce la nozione di ‘imprese energivore’. Si
tratta di aziende obese di energia che, per loro stessa natura, ne mangiano più
delle altre: almeno 2,4 GWh/a con un costo che deve superare il 3% del
fatturato. Il censimento presso la Cassa conguaglio è iniziato il 21 ottobre e
finirà il prossimo 30 novembre. In pochissimi giorni si sono registrate più di
600 imprese, ma solo alla scadenza del bando sarà possibile quantificare lo
‘sconto’ sulla base delle bollette storiche delle stesse aziende candidate.
Così, con un costo dell’energia superiore rispetto agli altri Paesi
europei lo Stato, ha deciso di saziare le industrie, come quella chimica e
metallurgica, la cui sopravvivenza dipende dall’alto consumo. “Se
interrompessimo i sussidi dall’oggi al domani – spiega Giovan Battista Zorzoli,
portavoce di Free, coordinamento di 25 associazioni attive nelle fonti
rinnovabili – condanneremmo quelle aziende a chiudere. Lo Stato fa bene a
difenderle ma sbaglia metodo: al posto dello sconto sul troppo consumo, dovrebbe
realizzare l’aiuto a consumare meno grazie alla riconversione industriale e
all’autoproduzione di energia, cosicché in pochi anni le stesse aziende non
abbiano più bisogno di un sostegno per campare”. E’ la filosofia del ‘più mangi,
più ti do da mangiare’ che vince su quella del mettere a dieta l’obeso, farlo
consumare meno, spingendo le imprese energivore a innovare i loro processi
produttivi e risparmiare energia. Se i sussidi non diminuiscono nel tempo e se
non sono a termine, si è in presenza di un ‘aiuto’ di Stato pagato dai
contribuenti. A essere seriamente preoccupata è Rete Imprese Italia che ha
rivolto “un pressante invito” all’Autorità per l’Energia “affinché possa
intervenire nell’ambito del proprio compito di soggetto regolatore”. Rete
Imprese teme “la previsione di nuovi rincari sulle bollette elettriche che le
piccole e medie imprese saranno costrette a subire a partire dal primo gennaio
per un insieme eterogeneo di misure”. “A partire dal 2014 – continua la nota –
le Pmi subiranno in bolletta l’aggravio di un’altra componente, la
cosiddetta Ae, che pagheranno sia famiglie che le piccole imprese destinata a
coprire le nuove agevolazioni a favore delle grandi industrie, alla quale si
aggiungeranno ulteriori aumenti su voci già esistenti, relative, per esempio,
alla distribuzione e al dispacciamento. Quest’ulteriore rischio di aggravio
delle bollette – prosegue la maggiore associazione delle Pmi – che si aggiunge a
un sistema di distribuzione degli oneri energetici già sperequato a danno delle
piccole imprese, aumenterà ancora di più il divario competitivo tra le Pmi
italiane e le loro concorrenti estere”.
Il bluff delle tasse ecologiche: solo
l'1% usato per l'ambiente. Lo Stato incassa quasi 44
miliardi l'anno, ma finiscono tutti in "spese" varie. Un tesoro che invece,
investito in sicurezza, avrebbe potuto evitare questi morti, scrive Paolo
Bracalini, Giovedì 21/11/2013, su "Il Giornale". C'è una montagna di soldi per
prevenire disastri ambientali, quando piove più del solito (può capitare, a
novembre) e gli argini cedono, i ponti crollano, le montagne si squagliano. Li
versiamo noi, allo Stato, ogni volta che facciamo benzina, paghiamo il bollo,
saldiamo la bolletta elettrica, immatricoliamo l'auto o lo scooter, e poi li
assicuriamo. Miliardi di euro in «tasse ambientali», che l'ambiente non lo
vedranno mai, perché si fermano prima, inghiottite dallo stomaco onnivoro dello
Stato per finanziare altre spese. Tasse sulle emissioni di combustibili, sulla
produzione di energia elettrica, sull'utilizzo di veicoli a motore, altre
eco-tasse (sui sacchetti di plastica, pile, oli lubrificanti, imballaggi,
materiale per costruzioni), imposte sui rifiuti, sulle fognature, sui biglietti
aerei. Che fanno tutte insieme 44 miliardi di euro, riscossi ogni anno dallo
Stato, enti locali inclusi, con lo scopo (ma solo sulla carta) di proteggere
l'ambiente e chi ci vive dentro. Che fine fanno? Soltanto l'1% delle imposte
ecologiche, pari a 448 milioni euro, serve davvero all'ambiente, calcola la Cgia
di Mestre su dati dell'Istat. Significa che 43,4 miliardi circa, prelevati
attraverso le imposte cosiddette «green», vengono presi e usati per fare altro
(coperture finanziarie varie). Con l'aggravante che quando c'è il disastro, la
soluzione classica è aumentare le accise, com'è stato fatto nel 2011 dopo
l'alluvione in Liguria e Toscana (più 0,89 centesimi di euro al litro di
carburante). «Non si può sostenere che le sciagure accadono anche perché non ci
sono le risorse finanziarie disponibili per la tutela e la manutenzione del
nostro territorio - lamenta Bortolussi, segretario dell'associazione artigiani
di Mestre -. I soldi ci sono, peccato che ormai da quasi un ventennio vengano
utilizzati per fare altre cose». Se si guarda alle tavole storiche dell'Istat si
vede che dal '90 ad oggi è aumentato il gettito dalle tasse ambientali, ma la
quota destinata agli investimenti sull'ambiente si è spostata di poco dallo
zero. Nell'ultimo ventennio (1990-2011) abbiamo pagato circa 800 miliardi di
imposte ambientali. Nel triennio 1990/92, dei quasi 80 miliardi di gettito
frutto delle tasse ambientali, ben 0 sono stati destinati al finanziamento di
spese per la protezione dell'ambiente. Ci si assesta attorno all'1% del gettito
destinato effettivamente alla protezione ambientale a partire dal '95, e da lì
non ci si schioda più. Alcune imposte sono gestite dagli enti locali. Come il
tributo provinciale per la tutela ambientale o l'«imposta sulle emissioni sonore
degli aeromobili», riscossa dalle Regioni, introdotta nel 2001 per il
«completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e il disinquinamento
acustico e l'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell'intorno
aeroportuale». Altre tasse, di pertinenza statale, neppure sappiamo di pagarle,
come la «sovrimposta di confine sul Gpl» o l'«imposta sugli oli minerali e
derivati» (incide sul costo della benzina), altre le conosciamo benissimo, come
l'imposta di bollo per registrazione al Pra, il Pubblico registro
automobilistico istituito nel 1927 (giace in Parlamento una proposta per
abolirlo). Se i 44 miliardi di tasse ambientali annue fossero usati per mettere
in sicurezza fiumi, argini e valli, è probabile si risparmierebbero disastri.
Anche perché, secondo stime Eurostat, in Italia le tasse ambientali valgono il
2,4% del Pil, contro una media europea del 2,3%. Pesano soprattutto quelle
sull'energia, pari al 78,3% (contro il 72% della media europea). Senza calcolare
tra queste la Tares, nuova imposta sullo smaltimento dei rifiuti, che ha preso
il posto della Tarsu e della Tia (tariffa di igiene ambientale). Un'altra
mazzata «verde».
Fotovoltaico, croci e delizie
dell’energia rinnovabile, scrive Angelo Pennacchioni
il 4 luglio 2017 su "Italiaambiente.it". L’Italia è la terza al mondo, ma la
conflittualità per l’impatto produce ricorsi e controricorsi. Lo credereste? Il
nostro Paese è il terzo al mondo per numero di impianti fotovoltaici: a fine
2014 – secondo la stima AneiRinnovabili – risultavano registrate 648.180
richieste di concessione. Con la produzione di 18,325 Mgwt, equivalenti ai 15%
della produzione. Siamo dietro soltanto alla Cina ed agli Usa. Il 90% delle
installazioni è considerata di piccola dimensione. Dunque si tratta di un parco
energetico enorme che però produce conflittualità finanziaria, economica,
ambientale e sociale. Perché fin quando si procurano risparmi sulla bolletta da
pagare il consenso è unanime, mentre diverso è l’atteggiamento quando entriamo
nei labirinti delle insostenibilità ambientali delle insofferenze sociali e dei
danni al paesaggio. Non per niente i tribunali di tutta l’Italia, i Tar, la
Corte di Cassazione ed anche la Suprema sono costantemente sottoposti a
richieste di giudizi, appelli, convalide e revoche, la cui definizione si
protrae per decenni. Una delle sentenze più recenti è stata emessa dal Tribunale
di Perugia che ha accolto la lamentala degli abitanti del borgo di Morcella, in
comune di Marsciano, contro la molestia provocata ai cittadini dalle emissioni
dei pannelli di un impianto a terra. Secondo il giudice Michele Moggi: “Una
modestia intollerabile in riferimento al fenomeno di abbagliamento che si
verifica principalmente nelle ore pomeridiane e che impone di tenere chiuse le
finestre per evitare la rifrazione della luce e considerato che nemmeno la
modifica dell’inclinazione dei pannelli ed altri accorgimenti tecnici, barriere
antiriflessi, pellicole e vetri particolari hanno diminuito o attenuato
immissioni moleste provenienti dai pannelli...” Il giudice ha ordinato la
rimozione dell’impianto, mentre successivamente deve pronunciarsi contro o pro
l’installazione di due impianti a biomasse per la produzione di 400Mkw. Siamo
però soltanto al primo giudizio di un contenzioso iniziato nel 2011. Per quanto
riguardo l’invasione del fotovoltaico sui terreni coltivabili i dati ufficiali
risalenti all’anno 2011 non mostrano indici particolari di rischio anche se
nell’ultimo quinquennio il settore ha avuto una forte crescita. L’ingombro sul
territorio rappresenta uno 0,026 della superficie agricola utile, l’invasione
non deve essere superiore al 10% del terreno del proponete e la potenza
dell’impianto non superiore ad un MW. Risultano misure, codici e coefficienti
ben definiti riportati anche nella direttiva della Comunità Europea del 2001.
Molto difficile invece valutare l’impatto paesaggistico che, secondo uno studio
di ingegneristica ed architettura. “ …non può essere affrontato solamente da un
punto di vista quantitativo ma necessita di un approccio volto a rendere la
diffusione degli impianti compatibile con il paesaggio naturale, con l’impatto
visivo dei parchi fotovoltaici, con la storia e le tradizioni del territorio e,
nel tempo, delle conseguenze che gli impianti potrebbero provocare alla salute
dell’uomo ed alla redditività e struttura dei terreni”.
L'impianto fotovoltaico domestico: breve
guida all'acquisto. Avete deciso di installare un
impianto solare fotovoltaico sul tetto di casa per produrre la vostra energia
elettrica? Ecco qualche consiglio su come scegliere l'impianto giusto, come
valutare prezzi e offerte che ci vengono presentate e i criteri da adottare per
scegliere un installatore competente, scrive la Redazione di QualEnergia.it. il
17 agosto 2016. Articolo già pubblicato l'8 giugno 2016. Avete deciso di
installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa per produrre la vostra
elettricità? Qualche consiglio su come scegliere l'impianto giusto, come
valutare prezzi e offerte che ci vengono presentate e i criteri da adottare per
scegliere un installatore competente.
Il dimensionamento.
Ai tempi del conto energia, quando tutta la produzione
dell'impianto era incentivata, con tariffe diverse a seconda della taglia, per
gli utenti domestici si installavano di solito impianti da 3 kWp, la soglia
massima dello scaglione di potenza incentivato più generosamente. Ora non è più
così: la scelta più conveniente è dimensionare l'impianto su misura dei propri
consumi. Impianti di taglia residenziale in genere vanno tra i 2 e i 6 kWp, ma
possono anche avere una potenza maggiore. Conviene, infatti, che l’impianto non
produca più energia di quella consumata, perché l’eccedenza immessa in rete
verrebbe sì retribuita, ma a valori inferiori di quelli pagati per i kWh
prodotti fino al raggiungimento dei consumi. Inoltre, queste entrate sarebbero
tassate (secondo la propria aliquota fiscale), in quanto le eccedenze generano
appunto ricavi soggetti a imposizione fiscale. Dato che l'impianto va "cucito su
misura" dell'utente, a parità di consumi basterà un impianto più piccolo e
dunque meno costoso per chi vive dove c'è più sole. Ad esempio, una famiglia che
consumi 4.000 kWh/anno, se vive al Sud dovrebbe optare per un impianto da circa
2,75 kWp, mentre la stessa utenza al Nord dovrebbe preferire un impianto da 3,5
kWp. Nello stimare la produzione dell'impianto, oltre che della latitudine e
della radiazione solare disponibile il progettista terrà conto di altri fattori.
Ad esempio bisogna vedere se il vostro tetto è esposto perfettamente a Sud e se
permette di installare i moduli con la giusta inclinazione. Uno scostamento di
90° a Est o Ovest causa una riduzione del 20% della produzione su base annuale.
Alle nostre latitudini, moduli inclinati oltre i 30° producono meno di quelli
inclinati meno di 30°: più i moduli sono inclinati e meno producono. Moduli
inclinati a 90°, quindi verticali, perdono il 30% rispetto alla condizione
ottimale. Spesso si dimensiona l’impianto in modo da coprire anche consumi
elettrici previsti per il futuro, ad esempio l'installazione di condizionatori o
di piastre ad induzione per la cottura.
Massimizzare l'autoconsumo.
La convenienza del FV è più alta per chi consuma più elettricità. Per questo una
buona idea potrebbe essere abbinare al fotovoltaico l'installazione di pompe di
calore elettriche. Questa applicazione, spesso molto efficiente, fornisce sia
raffrescamento che calore, sposta i consumi per il riscaldamento dalla bolletta
del gas a quella elettrica, con grande convenienza per chi l'elettricità se la
produce in proprio con il solare. Altro fattore che aumenta la convenienza del
fotovoltaico è la massimizzazione dell'autoconsumo, cioè il fatto di riuscire ad
utilizzare direttamente, senza farla passare per la rete, quanta più possibile
dell'energia prodotta dall'impianto. L'energia usata direttamente, infatti,
sostituisce quella prelevata dalla rete ed è conveniente perché su questa non si
pagano oneri di rete e di sistema, tasse e costi di dispacciamento e
commercializzazione. Queste voci pesano per quasi il 60% del prezzo del kWh che
si compra dalla rete. È molto più conveniente dunque usare sul momento tutta
l'energia prodotta dal solare, anziché immetterla in rete, visto che non
consumiamo abbastanza di giorno, e poi dover acquistare altra elettricità dalla
rete alla sera. Ciò nonostante il meccanismo dello Scambio su posto, che
funziona come una sorta di batteria virtuale, rimborsa una parte degli oneri, di
cui sopra, quando paga l'energia non consumata direttamente e che viene immessa
in rete. L’autoconsumo tipico di una famiglia italiana è dell’ordine del 30-40%.
Ma si può aumentare questa quota, e dunque risparmiare di più grazie al
FV, spostando nelle ore di sole tutti quei consumi elettrici 'gestibili', come
lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici. Esistono anche dei sistemi di domotica
capaci di coordinare i carichi con la produzione dell'impianto FV (si veda anche
il nostro Speciale Tecnico: "Fotovoltaico e autoconsumo: tecniche e strategie
per incrementare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dall'impianto").
Aggiungere le batterie?
Altra soluzione per usare l'energia del FV senza farla passare per la rete è
dotarsi di batterie per accumularla. Attualmente i costi sono elevati, ma le
batterie, come l'impianto FV godono della detrazione fiscale del 50% per cui si
riesce a rientrare dell'investimento in tempi accettabili, anche se più lunghi
rispetto al caso di un semplice impianto FV senza storage. Ci attendono nei
prossimi anni significative riduzioni dei costi dei sistemi di accumulo: ad
esempio Deutsche Bank prevede che il costo aggiuntivo per dotare di storage un
impianto fotovoltaico in 5 anni calerà di 7 volte. Per questo una buona idea può
essere installare già ora sul nuovo impianto FV un inverter con
predisposizione per utilizzo con storage.
Il prezzo dell'impianto.
Una volta che avete capito che impianto volete, dovrete valutare le offerte sul
mercato. In genere un impianto residenziale oggi si può acquistare a circa 2.000
euro per kW di picco (esclusa Iva al 10%). Ogni kWp richiede una superficie di
circa 7 m2. Si tratta di un prezzo onnicomprensivo, che include non solo
materiali, progettazione e installazione, ma anche le consulenze necessarie per
richiedere le autorizzazioni e la connessione elettrica. Sul mercato si
trovano prezzi sia molto più alti che molto più bassi. Sappiamo ad esempio di
offerte che scendono fino a 1.700 euro al kWp: su un impianto da 3 kWp in questo
caso si andranno a spendere ben 1.500 euro in meno per il sistema, accorciando
non di poco il tempo di ritorno dell'investimento. Nel valutare le offerte va
verificato se siano inclusi tutti i servizi di consulenza, oltre che verificare
le garanzie, i livelli qualitativi dei materiali usati e last but not least, il
rispetto delle normative di sicurezza nell'installazione, che può essere molto
costoso per l'azienda, dato che solitamente si tratta di un lavoro "in quota",
sul tetto.
Gli incentivi: detrazione fiscale e Iva
agevolata. Il fotovoltaico gode della detrazione
fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie: porta cioè in detrazione
dall'Irpef su 10 anni, con quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta.
Vale solo per le persone fisiche. Possono goderne non solo i proprietari, ma
anche gli inquilini o i familiari, a patto che siano loro a sostenere le spese.
Non è necessario effettuare una ristrutturazione contestuale (a differenza che
per il bonus mobili), ma si può godere di questo incentivo solo per interventi
in unità immobiliari residenziali o parti comuni di edifici residenziali. In
quanto “bene significativo”, l'impianto FV gode dell'aliquota Iva agevolata del
10%. Questa però si applica solo sulla differenza tra il valore
complessivo della prestazione (costo installazione compreso) e quello dei
beni stessi.
L'installatore.
Per la progettazione e l'installazione si consiglia di preferire
quelle ditte specializzate che possono dimostrare di aver realizzato tanti
impianti, anche e soprattutto nell’ultimo anno: significa che sono rimaste
aggiornate sia dal punto di vista tecnico (nuovi prodotti) che normativo (tante
le nuove regole tecniche e amministrative).
I materiali. Se
possibile preferire prodotti di marche internazionalmente riconosciute, sia per
l’esperienza acquisita negli anni che per la solidità delle aziende. Aspetto da
considerare per eventuali interventi in garanzia. Giusto sottolineare che un
componente FV cinese non significa prodotto di scarsa qualità, anzi, spesso sono
di gran lunga i più grandi produttori di moduli FV al mondo, con affidabilità e
standard qualitativi ai massimi livelli.
Si consiglia di richiedere dispositivi di
ottimizzazione della produzione energetica. Si tratta di “scatolette” da
installare dietro i moduli (in certi casi sono già preinstallati nella
scatoletta di giunzione dei moduli) che consentono a ogni modulo di lavorare
indipendentemente dallo stato di quelli adiacenti, garantendo quindi maggiore
continuità nella produzione e consentendo il monitoraggio di ogni singolo
modulo. Ricordiamoci che è bene chiedere che l'inverter sia predisposto a
gestire i sistemi di accumulo, in modo che non lo si dovrà cambiare se in
seguito si deciderà di installare una batteria.
Manutenzione.
Si consiglia di sottoscrivere un contratto di manutenzione che preveda come
minimo il monitoraggio dell’impianto fotovoltaico e un sopralluogo nei primi 2
anni, meglio se all’inizio del periodo di funzionamento dell’impianto: i
problemi, a volte, si verificano soprattutto nella fase iniziale.
Garanzie. Sui
componenti valgono le garanzie offerte dai costruttori. Per i moduli la
copertura è tipicamente di 10 anni sulla parte meccanica e 25 anni sulle
prestazioni. Genericamente la riduzione delle prestazioni è graduale e potrebbe
essere del -10% dopo 10 anni e del -20% dopo 25 anni. Per gli inverter la
garanzia più comune è 5 anni, ma sempre più aziende offrono 10 anni di
copertura. Si consiglia di preferire quest'ultima soluzione. L’impianto
fotovoltaico nella sua interezza ha per legge la classica garanzia di 2 anni,
che deve essere fornita da chi realizza l’impianto. Se si verifica un problema
che dipende da un singolo componente, la responsabilità è del fornitore. Se
invece il motivo del malfunzionamento è legato all’installazione o alla
progettazione, la responsabilità è della ditta installatrice/venditrice. In
alcuni casi, per ora rari, la ditta venditrice offre una garanzia di prestazioni
per il primo anno.
Fotovoltaico domestico: come proteggersi
dalle offerte fuori mercato. Molti venditori in giro
per l'Italia offrono alle, spesso ignare, famiglie, impianti fotovoltaici
sovradimensionati rispetto ai loro consumi elettrici e a costi molti elevati per
kW installato. Un approccio che rischia di danneggiare il mercato. Come
difendersi da questi "piazzisti" di energia solare, scrive Leonardo Berlen il 12
giugno 2017 su "Quale Enegia". È bene che i consumatori prestino grande
attenzione alle proposte di realizzazione di impianti fotovoltaici domestici sui
loro tetti da molti venditori in giro per l’Italia. Sappiamo ormai da tempo che
vengono fatte alcune offerte "standardizzate" a potenziali acquirenti che
considerare “fuori mercato” è un eufemismo. Acquirenti ignari dei reali prezzi
in discesa di questa tecnologia possono realmente incappare in offerte, spesso
corredate da qualche collegamento con marchi energetici celebri, che vanno solo
a vantaggio del "venditore". Non possiamo chiamare altrimenti questi soggetti, o
queste società cui fanno capo, perché non possiamo considerarli corretti
professionisti del settore, com'è la stragrande maggioranza degli operatori
presenti in Italia. Un professionista dovrebbe invece prestare attenzione non
solo ai consumi annuali elettrici del cliente, ma anche ai loro profili di
consumo giornaliero e mensile e ad altri diversi particolari, prima di
presentare un’offerta. Uno dei diversi esempi significativi di come operano
queste imprese è quello relativo a una proposta (di cui possediamo peraltro
l'originale) per un impianto FV da 4,5 kWp per una famiglia che abita in una
bifamiliare in centro Italia, con consumi elettrici intorno ai 2mila kWh/anno e
che soddisfa il proprio fabbisogno di riscaldamento e acqua calda sanitaria con
una caldaia a biomasse. Il “modico” prezzo dell’impianto? Oltre 15mila euro (Iva
inclusa)! Dal documento non si capisce però se il prezzo includa il
finanziamento rateizzato. Infatti nel modulo sottoscritto c’è riportato
“finanziaria” nella voce sulla modalità di pagamento, ma nel contratto, firmato
dal cliente, poi si spiega che il pagamento dell’opera sarà effettuato per il
50% alla firma del contratto e il saldo restante il giorno prima
dell’installazione. I moduli che verrebbero utilizzati (18 da 250 Watt) sono
italiani, di una azienda in verità poco conosciuta, mentre nel contratto
(preliminare?) non viene nemmeno indicata la tipologia e la marca di inverter.
Già da queste poche righe si capisce che l’unico obiettivo della società e del
suo venditore è poter piazzare un prodotto, chiudere il contratto, e uscirne
dopo aver spuntato un bel guadagno. Poi per quanto riguarda la fase di
installazione, prevista dal contratto, si spera solo che venga eseguita da
qualche ditta con buone professionalità. Ma possiamo dubitarne se questo è
l'approccio iniziale. Questi "venditori" che raccontano un po’ di tutto ai loro
potenziali committenti (ad esempio, “la tua bolletta è troppo cara e con il FV
non la pagherei più", “ti ripaghi l’investimento in due o tre anni", eccetera),
non fanno altro che mettere in cattiva luce una tecnologia che è sempre più
matura e che ha ridotto in questi anni in maniera drastica i suoi costi. In una
parola rischiano di danneggiare il mercato, così come aziende e professionalità
serie, oltre che le tasche di alcune famiglie. In quell’offerta ci sono due
aspetti tanto stridenti, quanto fondamentali in fase di progettazione:
La scelta della taglia dell’impianto. Un impianto
da 4,5 kWp (per circa 32 m2 di moduli) è esageratamente sovradimensionato per le
esigenze di quella tipologia di famiglia: ha una producibilità in quella zona di
almeno 6mila kWh/anno (contro i 2.000 consumati ogni anno). Una scelta di questo
tipo allungherebbe i tempi di ammortamento dell’impianto, visto che la gran
parte della produzione non andrebbe all’autoconsumo (aspetto principale da
valutare), ma verrebbe ceduta alla rete elettrica con un conseguente introito
molto ridotto. Forse ne basterebbe uno da 1,5-2 kWp, quindi meno della metà (e
un piccolo solare termico per la produzione di acs).
Il prezzo dell’impianto. Premesso che non capiamo
realmente se in questo caso vi siano inclusi i costi di finanziamento, dobbiamo
però dire che per un impianto di quella potenza il costo chiavi in mano dovrebbe
essere compreso tra 8000 e 9000 euro (iva inclusa).
Come proteggersi allora da queste proposte
indecenti? Riassumiamo alcuni concetti basilari. Oggi la scelta più conveniente
è sempre dimensionare l'impianto su misura dei propri consumi elettrici.
L'impianto fotovoltaico va quindi "cucito su misura" dell'utente: a parità di
consumi, basterà un impianto più piccolo, e dunque meno costoso, per chi
vive dove c'è più sole. Ad esempio, una famiglia che consumi 4.000 kWh/anno, se
vive al Sud dovrebbe optare per un impianto da circa 2,75 kWp, mentre la stessa
utenza al Nord dovrebbe preferire un impianto da 3,5 kWp. Nello stimare la
produzione dell'impianto, oltre che della latitudine e della radiazione solare
disponibile il progettista terrà conto di altri fattori. Ad esempio bisogna
vedere se il tetto è esposto perfettamente a Sud e se permette di installare i
moduli con la giusta inclinazione. Uno scostamento di 90° a est od ovest causa
una riduzione del 20% della produzione su base annuale. Per l’inclinazione del
tetto una buona produzione è garantita, in media, da una del 30%. Consideriamo
anche che si può dimensionare l’impianto in modo da coprire i consumi elettrici
previsti per il futuro, ad esempio con l'installazione di pompe di calore
elettriche, di condizionatori o di piastre ad induzione per la cottura. Altro
aspetto da considerare, come detto, è massimizzare l'autoconsumo: utilizzare
direttamente, senza farla passare per la rete, quanta più possibile dell'energia
prodotta dall'impianto FV. L'energia usata direttamente, infatti, sostituisce
quella prelevata dalla rete ed è conveniente perché su questa non si pagano gli
oneri di sistema e di rete. L’autoconsumo di una famiglia italiana è dell’ordine
del 25-40%. Ma si può aumentare questa quota, e dunque risparmiare di più grazie
al FV, spostando nelle ore più soleggiate tutti quei consumi elettrici
'gestibili', come lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici. Esistono anche
sistemi di domotica capaci di coordinare i carichi (consumi) con la produzione
istantanea dell'impianto FV. Ricordiamo, infine, che per le persone fisiche il
fotovoltaico gode della detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni
edilizie: porta cioè in detrazione dall'Irpef su 10 anni, con quote di pari
importo, il 50% della spesa sostenuta. Per concludere, ricordiamo a tutti
di diffidare da chi offre preventivi standard senza un vero sopralluogo e
un'attenta analisi dei consumi presenti e futuri dell'utenza.
Pannelli fotovoltaici a rischio incendio.
Tutto quello che non vi hanno mai detto, scrive Angela
Puchetti su "it.businessinsider.com" il 12 luglio 2017. Per chi suona la sirena?
Basta inserire su Google due parole: fotovoltaico e incendio, poi cliccare
“notizie” (e magari, anche “immagini”) per rendersi di conto di persona
del numero d’incendi apparsi sulle cronache locali italiane in cui sono
coinvolti impianti fotovoltaici. Dall’inizio nel 2017 a oggi d’incendi di
questo tipo su Google se ne contano parecchi: a essere colpiti sono
state abitazioni, fabbriche, industrie, campi e allevamenti. L’energia generata
dagli impianti fotovoltaici è energia pulita ma gli impianti necessitato di
un’attenta manutenzione. Cosa che non sempre viene segnalata con la dovuta
solerzia da chi monta gli impianti: rappresenta comunque un costo, motivo per
cui a volte è lo stesso proprietario che tende a trascurarla, mentre invece
deve diventare un’abitudine. Secondo fonti confidenziali parecchie vendite sono
state fatte con la promessa che per vent’anni anni i pannelli avrebbero generato
solo profitti, senza doversi preoccupare di manutenzione. In più, per battere la
concorrenza, c’era chi tendeva ad abbassare i prezzi tagliando sui costi: questo
è successo soprattutto nei primi anni di diffusione del fotovoltaico sulla scia
della corsa agli incentivi per installare gli impianti. «La logica commerciale
superava le scelte del progettista. – spiega Massimiliano Sassi, ingegnere
esperto d’impianti di energia rinnovabili – In sostanza rispetto al progetto
originale venivano tolti quei componenti che garantivano maggiore sicurezza e
controllo ma non erano resi obbligatori dalle normative». Non sempre le cause
dell’incendio sono accertate in questi articoli di cronaca, scritti appena il
fatto è avvenuto, però colpiscono due costanti: la presenza di impianti
fotovoltaici e spesso la rapidità con cui si propaga l’incendio. Mancano
dati ufficiale ufficiali sul numero, sappiamo però che nel 2011 gli incendi con
presenza d’impianto fotovoltaico sono stati 298: allora gli impianti erano
330mila circa, mentre già nel 2015, secondo il Rapporto statistico 2015 su
energia da fonti rinnovabili in Italia (vedi pag. 35 del rapporto), erano saliti
a 688.398. Per venire a capo del problema abbiamo interpellato un certo numero
di tecnici, esperti e vigili del fuoco.
«Quando sono partite le istallazioni degli
impianti c’era poca conoscenza, che con il tempo è maturata – spiega Michele
Mazzaro, ingegnere e Comandante del Nia, Nucleo Investigativo Anticendi (ndr. il
Nia dipende dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza tecnica del
Ministero dell’Interno – Corpo nazionale Vigili del fuoco) – Oggi c’è una
maggiore attenzione ma con gli anni è cresciuto anche il numero degli impianti.
E non è sempre facile accertare da dove sia partito un incendio. Ad esempio, nel
periodo invernale non è semplice riscostruire se un incendio è partito da una
canna fumaria o da un impianto fotovoltaico. In entrambi i casi bisogna tener
conto che il materiale bituminoso isolante che impermeabilizza il tetto aiuta la
propagazione delle fiamme». Per classificare gli incendi sarebbe utile compilare
un modulo (tipo quello nelle ultime pagine di questo documento) per identificare
l’origine dell’innesco. Questa proposta è parte del lavoro di una commissione
creata ad hoc per valutare e prevenire i rischi di elettrocuzione (scarica
elettrica) per gli operatori dei Vigili del Fuoco che si trovano a
dover intervenire usando l’acqua su incendi di vaste proporzioni e per
individuare le principali cause d’incendio in presenza di impianti
fotovoltaici. «Non ci sono dati certi riguardo agli incendi in presenza di
impianti fotovoltaici, ma c’è una proposta di rilevazione statistica del Comando
dei Vigili del Fuoco di Milano pubblicato dal Nia (Nucleo Investigativo
Anticendi). – spiega Sassi – In pratica compilando il modulo si possono avere
informazioni utili e rendersi conto se esiste una correlazione diretta, per
esempio, tra gli incendi e chi ha fatto l’impianto, la marca dei pannelli, la
marca degli inverter (l’inverter è un apparecchio che ha la funzione di
trasformare la corrente continua prodotta dai pannelli in corrente alternata da
mettere in rete o da utilizzare per gli usi domestici ndr.), i progettisti, gli
installatori e i montatori, in modo da poter fare prevenzione.» «Chi ha
installato pannelli fotovoltaici su attività soggette al DPR 151 del 2011, deve
sapere che l’installazione deve rispettare le norme di sicurezza elettrica e
antincendio previste dai regolamenti italiani per il rischio antincendio (due
circolari sicurezza incendio del 2010 e del 2012)» – spiega Mazzaro. «Con queste
circolari si è cercato di arginare i pericoli (esempio, il rischio
folgorazione) anche per gli operatori, i soccorritori che devono intervenire in
caso d’incendio. – continua Mazzaro –Sono norme importanti, per esempio, per
impedire la propagazione dell’incendio fin dentro la struttura sotto cui sono
posti i pannelli ed evitare il coinvolgimento dei pannelli in caso di incendio
nella zona sottostante dell’edificio».
Oltre alle norme dei Vigili del Fuoco esistono
anche le disposizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI: le principali
che utilizzano gli installatori per montare gli impianti. «In passato all’epoca
dell’istallazione dei primi impianti nel 2009 – per via del boom di
installazioni dovuto agli incentivi statali – l’utente è stato poco
sensibilizzato sulla necessità di fare manutenzione. – afferma Andrea
Foggetti, caposquadra dei Vigili del Fuoco in servizio a Milano – Sarebbe
stato meglio se gli impianti fossero stati venduti con un pacchetto di
manutenzione incluso nel prezzo. Oggi gli impianti sono più sicuri, in generale
li installano meglio. E attualmente la manutenzione è più caldeggiata dagli
installatori e dal commerciale: ciò avviene più o meno dal 2014». «Le ditte
installatrici dovrebbero aver evidenziato l’importanza della manutenzione nei
loro manuali. – continua Mazzaro – Invece, molte volte l’utente non conosce i
rischi a cui va incontro non provvedendo a una corretta manutenzione. Abbiamo
avuto incendi innescati dal fatto che i pannelli non erano stati puliti, per
esempio, da foglie e sporcizia. Ciò crea sul pannello effetti
di surriscaldamento localizzato e questo può aver dato origine agli incendi».
«La causa più frequente d’innesco d’incendio sono le connessioni allentate.
– aggiunge Foggetti – Una corretta manutenzione prevede il serraggio di tutte le
viti per evitare viti lente che possano creare un arco elettrico da cui parte la
scintilla che può provocare l’incendio». «L’impianto va controllato almeno una
volta l’anno da personale specializzato: è importante fare un esame
termografico con una termocamera (l’esame va fatto con la luce solare in modo
che l’impianto fotovoltaico possa essere in funzione), per individuare eventuali
anomalie tecniche che se tralasciate possono essere causa scatenante di incendi.
– spiega Mazzaro – Va fatta anche un’ispezione visiva: se un topo, per esempio,
ha rosicchiato un cavo è importante individuarlo e sostituirlo». Lo scoglio
principale per i possessori di impianti è che si deve pagare una persona
competente e affidabile per effettuare questa manutenzione: e magari era una
spesa non prevista ai tempi dell’istallazione. Si tratta però di un investimento
che va fatto. «In primis vanno monitorate le connessioni, poi una verifica
visiva sui pannelli, osservando se sono presenti segni strani, ammaccature o
“effetto grandine”, se il vetro è danneggiato dall’interno, magari per via di
una piccola sfiammatura. – spiega Foggetti – E ancora se ci sono ossidazioni e
perdita d’integrità del telaio (in sostanza: una dilatazione termica delle
cornici); poi va controllata l’integrità dei cavi soprattutto quelli esposti
alle intemperie, la scatola di giunzione, il quadro di stringa o gli inverter
non opportunamente ventilati o posti in locali non idonei, per esempio,
nel sottotetto in legno o in una soffitta stipata di oggetti (dall’albero di
Natale ai giocattoli) facilmente infiammabili. Invece, attorno all’inverter è
richiesto uno spazio completamente libero e pulito, senza tende o altri
materiali che facilmente possano prendere fuoco. Bisogna anche provvedere a
un efficace ricambio d’aria dove ci sono le apparecchiature elettriche come gli
inverter, di solito, invece, posizionati in locali angusti e poco ventilati.
L’ideale, è puntare su locali dedicati opportunamente areati o compartimentati».
Anche la pulizia dell’impianto non è da
sottovalutare e va fatta in modo corretto. «D’estate, con le alte temperature i
pannelli non vanno lavati a mezzogiorno come molti fanno, ma al mattino presto,
quando le temperature sono più contenute. – spiega Foggetti – Infatti,
effettuando il lavaggio a metà giornata, nelle ore più calde, si crea uno shock
termico che provoca una perdita di integrità del telaio del pannello. Questo può
portare a infiltrazioni d’acqua e poi a ossidazioni dell’impianto». Come può
avvenire l’innesco di un incendio. «L’innesco che può portare all’incendio può
avvenire per diversi motivi. – spiega Foggetti –
1) Fenomeno di hot spot, punto caldo all’interno
di una cella oscurata o sporca, magari per mancata di pulizia dei pannelli o a
causa di un’errata progettazione dell’impianto (es. cono d’ombra di un camino o
di una parabola).
2) All’interno della scatola di giunzione nel
pannello.
3) Se c’è una perdita d’isolamento si può creare
un arco elettrico tra cella e cella del pannello e quindi una scintilla.
4) Altro innesco può avvenire nei cavi di
connessione, se si verifica una perdita d’isolamento, e dato che il pannello
continua sempre a funzionare con il sole può crearsi un arco elettrico.
5) Arco elettrico dovuto a temperature elevate.
6) In presenza di un tetto in legno (sono
preferibili da un punto di vista della sicurezza i tetti in cemento armato).»
«La canna fumaria posta vicino al pannello non va
bene ed è sconsigliata per due motivi: per l’aumento del calore che provoca in
prossimità del pannello e per la fuoriuscita di fuliggine che si depositerà sul
pannello creando il fenomeno di hot spot» spiega Foggetti. Dal 2012 il Ministero
dell’interno ha emesso una circolare chiarendo che le attività soggette a
controllo dei Vigili del Fuoco per istallazione di un impianto devono: tenere
conto che l’impianto fotovoltaico è una modifica rilevante al rischio
antincendio della struttura che può produrre aggravio alle preesistenti
condizioni di rischio gli impianti devono essere almeno a un metro o ad una
distanza comunque sufficiente secondo la valutazione dei professionisti dagli
EFC (evacuatori di fumo e calore), dai lucernai, dagli elementi di
compartimentazione verticale.
Che fare se scoppia un incendio? «La priorità è
chiamare il numero di soccorso, e, se si è in grado, staccare il
contatore generale, infatti, bisogna ricordare che finché c’è luce i pannelli
continuano a essere in tensione e a produrre energia elettrica. – spiega
Mazzaro – Staccando il contatore si isola tutta la parte dove circola la
corrente alternata facendo in modo che gli inverter si spengano senza più
convertire la corrente continua proveniente dai pannelli». Il consiglio è
comunque chiamare il numero di soccorso dei Vigili del fuoco e richiedere
l’intervento anche se l’incendio sembra risolto. «Se c’è stato un principio
d’incendio va fatta una valutazione più approfondita dello scenario, bisogna
capire perché è successo. Infatti, se non si comprende il problema
all’origine può succedere di nuovo» dice Mazzaro.
Come si sviluppa un incendio sul tetto in presenza
di pannelli. «Ipotesi uno: poniamo che su un tetto in legno, si crei un arco
elettrico causato da due cavi. Ci possono essere mille variabili ma in media in
mezz’ora una porzione di tetto prende fuoco, poi il fuoco si sposta verso i
piani sottostanti. Conclusione: per i tetti in legno ventilati il monitoraggio
deve essere ancora maggiore» spiega Foggetti. «Ipotesi due: se l’incendio si
sviluppa su un tetto di cemento il fuoco cammina sul tetto e lungo la guaina
bituminosa o materiale isolante (entrambi infiammabili). Se non trova un
lucernaio o evacuatori di fumo, si limita a camminare sul tetto». «Fino al 2011
si installavano i pannelli fotovoltaici esterni rispetto alla superfice del
tetto. – spiega Sassi– Così si scaldavano meno perché veniva lasciata
un’intercapedine tra pannello e tetto. Negli anni successivi il Gestore Servizi
Elettrici ha incentivato maggiormente gli impianti di tipo integrato ovvero
realizzati all’interno dei tetti stessi». «I nuovi pannelli integrati sono a
filo del tetto il che vuol dire ricavare una vasca nel sottotetto che, se non
prevista con opportuna ventilazione, provoca un surriscaldamento anomalo, che
non incide tanto sul problema incendio quanto sulla rendita energetica del
pannello. – spiega Foggetti – Dal punto di vista della composizione quelli in
silicio cristallino e policristallino dentro contengono sabbia: non sono
rischiosi. Quelli in amorfo (i pannelli neri o blu scurissimo), invece, non
hanno maggiori rischi nell’utilizzo, ma presentano più rischi per gli operatori,
per via delle sostanze che contengono: arseniuro di gallio e telluluro di
cadmio, due sostanze tossiche. Se prendono fuoco rilasciano fumi tossici e
polveri di cadmio che se respirate provocano edema polmonare».
Chi ha un impianto fotovoltaico e legge queste
cose per la prima volta, può comunque «lavorare sulla prevenzione, nel senso di
fare un’analisi preventiva in modo da capire se l’impianto è a rischio incendio
o produce meno delle attese. – spiega Sassi – Si tratta di un’analisi super
partes fatta da professionisti che come risultato rivela i punti deboli
dell’impianto, quindi può essere molto utile. Anche se questa verifica ha costi
bassi (per un impianto di casa da 6 kW richiede un paio ore di lavoro), spesso,
i possessori d’impianti non ricorrono a questa possibilità o perché non sanno
che esiste o perché comunque non era prevista nel loro piano iniziale di
investimento». «Nessuno si aspettava che un impianto fotovoltaico nella sua
totalità potesse avere un’evoluzione così problematica, cioè che si
verificassero così tanti incendi» ha dichiarato un esperto del settore a
Business Insider Italia in via confidenziale. «Il rischio zero non esiste.
Neanche per il fotovoltaico. – aggiunge Sassi – Col tempo si è capito che
impianti e pannelli potevano prendere fuoco, c’è voluta l’esperienza, perché non
c’era letteratura: l’applicazione di produzione concentrata di energia da fonte
fotovoltaica era nuova. Le normative si sono evolute nel tempo ed erano sempre
in ritardo. I progettisti non riuscivano ad aggiornarsi velocemente. Gli
installatori avevano poca esperienza. E anche tante dichiarazioni di conformità
in realtà non sono a norma, perché nel momento in cui sono state stampate non
era già più valide le norme a cui facevano riferimento. In tutto questo gli
incentivi sono stati dei catalizzatori creando pressione e fretta su tutti: chi
comprava, chi vendeva, chi progettava, chi installava, chi doveva produrre e
tanti sono stati anche i materiali difettati».
In certi casi si crea un circolo vizioso di cose
non chiare dall’inizio, alimentato da paura, improvvisazione, disinformazione,
sfida ai rischi: come in una roulette russa. «I possessori di fotovoltaico in
certi casi hanno paura di chiamare i Vigili del Fuoco per il timore di ricevere
sanzioni. – spiega Sassi – Infatti, hanno paura di non essere in regola rispetto
all’impianto fotovoltaico e così rischiano consapevolmente. Oppure chiamano
quando l’incendio è in stato avanzato: hanno aspettato troppo. Questo capita,
soprattutto, nei capannoni industriali e agricoli». Succede anche che tante
chiamate ricevute dalle centrali operative siano fatte da persone che vedono
l’incendio, ma non dai proprietari dell’impianto. «Gli incendi in presenza di
impianti e pannelli fotovoltaici sono incendi più veloci. – spiega Sassi-Quando
c’è sole c’è corrente e dove c’è corrente elettrica, l’incendio continua a fare
scintille, quindi la propagazione del fuoco è molto più veloce. Un capannone
coperto da pannelli fotovoltaici di classe 2, ampio quattro-cinque mila metri
quadrati, può bruciare in due o tre ore. I Vigili del Fuoco, di solito per come
sono organizzati arrivano entro 30 minuti, ed è necessario che elementi con
resistenza al fuoco garantiscano la tenuta delle strutture fino all’intervento
dei soccorsi. Invece, se gli impianti sono installati su strutture non adeguate
possono compromettere la sicurezza anche di eventuali persone presenti
all’interno dell’edificio». «Nel 2012 si è registrato il boom d’installazioni e
sempre nel 2012 si è toccato il picco d’incidenti per difettosità del materiale.
– spiega Sassi – Il difetto viene fuori subito, così come i problemi legati
all’errata installazione. Poi il numero d’incidenti è diminuito. Ma con il tempo
l’impianto invecchia e quindi ci possono essere problemi dovuti a determinati
componenti che vanno correttamente mantenuti facendo una attività di
manutenzione periodica e anche di lavaggio, annuale o semestrale (anche di più
se necessario).» Possiamo prevedere qual è il trend degli incendi legati agli
impianti fotovoltaici? «Il trend degli incendi è in ascesa, il numero degli
incendi deve ancora crescere: ora inizia la fase critica perché gli impianti
cominciano ad avere sette-otto anni: è una fase delicata. Chi non ha mai fatto
manutenzione rischia più degli altri».
In caso d’incendi come si regolano le
assicurazioni? «Le assicurazioni hanno chiarito che se non fai manutenzione loro
non ti pagano: nelle clausole la manutenzione è obbligatoria. – continua Sassi –
Di solito negli incendi non si registrano morti, quindi si tratta di un danno
amministrativo, non viene considerato un problema per la collettività e finisce
per essere, invece, un problema solo tra assicurazione e utente che poi deve
avere a che fare con la burocrazia». «Nel 2014 a un certo punto il Governo ha
ridotto gli incentivi su tutti gli impianti di fascia medio-grande, anche se
c’era un contratto con lo Stato della durata di vent’anni. Questo ha portato a
un calo delle rendite previste per i possessori di impianti. Sul versante
vendita energia analogamente i titolari degli impianti venderanno l’energia
prodotta e immessa in rete a un prezzo quattro volte inferiore rispetto a quello
atteso all’epoca della realizzazione dell’impianto, seguendo un borsino
elettrico come fossero grossi operatori. Risultato: chi ha fatto dei mutui al
100% in vent’anni, adesso è in difficoltà perché non riesce a guadagnarci e in
certi casi si trova dover vendere l’impianto. E, infatti, sta aumentando il
mercato secondario del fotovoltaico da un paio di anni». Ma a chi si vendono gli
impianti? Secondo fonti confidenziali a fondi privati che stanno sfruttando il
momento di difficoltà degli operatori a pagarsi i mutui in essere. Mentre la
lobby delle energie tradizionali rema contro il fotovoltaico, questi fondi
stanno comprando e comprano a poco: hanno convenienza a prendere gli impianti di
seconda mano per vari motivi. Questi impianti, infatti, continuano ad avere gli
stessi incentivi, in più i nuovi proprietari potranno vendere energia elettrica
con un netto bilancio in positivo avendo pagato meno gli impianti. E in questi
casi, tali fondi sono strutturati per gestire gli impianti con una corretta
manutenzione riducendo al minimo tutti i rischi correlati agli impianti
fotovoltaici. Inoltre, il decreto Spalma-incentivi attualmente riconosciuto
costituzionale dalla Corte Costituzionale Italiana potrebbe essere, invece,
dichiarato incostituzionale dalla Corte europea. In questo caso il Governo
italiano dovrà ridare ai titolari delle convenzioni i soldi che fino ad adesso
non ha erogato e magari a quell’epoca la maggioranza dei vecchi titolari avrà
già venduto: a incassare saranno i nuovi proprietari. Secondo il rapporto del
GSE, Gestore Servizio Elettrici, sono emersi casi in cui sono stati sospesi gli
incentivi in casi non chiari. C’è stato anche chi ha provato a garantirsi gli
incentivi senza avere fatto l’impianto o averlo fatto solo in piccola parte.
L’obbiettivo era quello di prendere incentivi alti e fare l’impianto in ritardo
sfruttando minori costi di acquisto e d’installazione.
La truffa del fotovoltaico.
La psicosi del risparmio energetico ha scatenato
la disperata ricerca della fonte energetica alternativa che consente di liberare
i cittadini da questa schiavitù. Tra gli investimenti maggiormente pubblicizzati
da una rete di imprese, associazioni e banche figura come primario quello
dell'impianto fotovoltaico, godendo di un sistema di incentivazione particolare:
il conto energia. Il caro petrolio ha lanciato la psicosi del risparmio
energetico e ha scatenato la disperata ricerca della fonte energetica
alternativa per uscire dal circolo vizioso dei rincari insostenibili. Cominciano
così ad accreditarsi sempre più le fonti di energia alternative, sostenute da
una politica promossa dall'Unione Europea e dagli stessi governi di incentivi
per abbattere le emissioni di CO2 nell'atmosfera, come sancito dal Trattato di
Kyoto. Tra gli investimenti maggiormente pubblicizzati da una rete di imprese,
associazioni e banche figura come primario quello dell'impianto fotovoltaico,
godendo di un sistema di incentivazione particolare. In particolare, il Decreto
Ministeriale del 19 febbraio 2007, ha previsto una procedura amministrativa in
virtù della quale viene concesso una forma di finanziamento, mediante il
pagamento ad una tariffa fissa, l'energia prodotta mediante il proprio impianto
fotovoltaico. In tal modo, il Ministero dell'Ambiente decide di trasferire al
proprietario dell'impianto, nonché assegnatario del progetto di finanziamento,
una cifra annuale commisurata alla capacità energetica dell'impianto,
remunerando l'elettricità prodotta dall'impianto per un certo numero di anni.
Stiamo parlando del progetto "conto energia" che va a ripagare con un piano di
ammortamento l'acquisto degli impianti già acquistati, funzionanti e connessi
alla rete elettrica di distribuzione della casa, predisponendo degli appositi
contatori che indicano non solo l'energia consumata ma anche quella prodotta.
Ovviamente viene prevista anche la possibilità di poter vendere alla rete
nazionale energetica il surplus prodotto, acquistando un credito nei confronti
dell'Enel. La norma in sé sembra conveniente e allettante, considerando che
riconoscerebbe ad una famiglia media di 4 componenti, che costruisce un impianto
di 4 Kw, un finanziamento di 2500€ all'anno, a cui occorre aggiungere il
risparmio energetico derivante dal mancato pagamento di bollette energetiche e
gas.
Di fatto, per applicare tale norma è stato
costruito un contorto sistema che vede imprese, banche e assicurazioni coinvolte
in una rete viziosa allo scopo di trarre ovviamente un guadagno
dall'incentivazione statale ad acquistare impianti fotovoltaici. I soggetti
promotori del progetto sono il più delle volte società, spesso con una struttura
multilevel, che si fanno carico delle pratiche di progettazione ingegneristica e
civile dell'impianto, nonché del montaggio e del collegamento dello stesso alla
rete di distribuzione interna e nazionale. Costruiscono a tal fine una rete di
agenti che - come i nostalgici rappresentanti degli elettrodomestici e
casalinghi - propongono al cliente la costruzione di un impianto fotovoltaico a
costo pari a zero, grazie alla possibilità di usufruire degli incentivi statali.
In realtà, in una seconda fase del colloquio, l'agente spiega che al momento
dell'acquisto dell'impianto, viene sottoscritto un "mutuo chirografario" di 20
anni, ad un tasso del 5-6%, grazie al quale la Banca anticipa l'intera somma del
costo dell'impianto e poi si rifà sulle somme trasferite dal Ministero.
Il punto critico viene allo scoperto proprio
esaminando questo "piccolo" particolare, in quanto l'acquisto dell'impianto
implica direttamente la sottoscrizione del mutuo, ma non necessariamente
l'attribuzione degli incentivi statali, la cui concessione si ha solo dopo che
l'impianto diventa funzionante e deve comunque scontare la valutazione delle
condizioni esistenti. Nel momento in cui, dunque, acquistate l'impianto verrà
subito acceso il mutuo, che non sarà collegato alla pratica inoltrata presso il
Ministero: i due contratti vengono ad esistere in momenti diversi, e le vicende
dell'uno non posso influire l'esito dell'altro. In altre parole, qualora lo
Stato non conceda il finanziamento o interrompa il trasferimento perché "le
quote energetiche" sono state tutte aggiudicate, il mutuo non cesserà di
esistere e incomberà sul soggetto che lo ha sottoscritto, unico e solo debitore
"chirografario", ossia responsabile personalmente e con i suoi beni. Nel
meccanismo è stata prevista anche una forma di "copertura assicurativa" in caso
di furto o di guasto dell'impianto, che potrebbero portare all'interruzione dei
trasferimenti dello Stato: in questo caso occorre aggiungere l'ulteriore costo
della componente assicurativa. Stesso discorso vale per la manutenzione e per la
garanzia dell'impianto, in quanto l'impresa dà una copertura di oltre 20 anni
per alcune componenti, mentre per altre la garanzia non può essere superiore a
10 anni considerando che alcuni componenti - come l'inverter che consente di
convertire l'energia continua in energia alternata come necessita al sistema
elettrico. Allo stesso modo, la garanzia non è collegata al mutuo, in quanto
qualora il guasto non rientri nelle clausole previste né dall'assicurazione né
dalla garanzia, il debito della banca resta lì, e deve essere pagato in ogni
caso.
Infine, stiamo parlando di impianti che
costituiscono una tecnologia "vecchia", risalente agli sessanta, e che in quanto
tale dovrebbe essere venduta ad un prezzo di mercato ragionevole, oltre ad aver
coltivato esperienza e conoscenza tale da poter far fronte ad ogni
inconveniente. Nella realtà gli impianti fotovoltaici vengono venduti a prezzi
molto elevati, per circa 7 mila euro ogni Kw di potenza, senza tuttavia
garantire che la potenza dell'impianto rimanga nel tempo immutata e non sia
sottoposta a degrado, e molto spesso le società comprano dei materiali scadenti
per rivenderli ad alte tariffe, con costi che vanno alle stelle se si considera
che dovranno alimentare la multilvel, le Banche e le assicurazioni. È chiaro
che, dietro al fotovoltaico - entrato nell'immaginario collettivo come una fonte
di energia alternativa ed ecologica - hanno costruito un sistema
intenzionalmente contorto e complesso per fare, ancora una volta, dell'energia
un business, ai danni dei cittadini e dello Stato stesso.
Per quanto possa essere giusta e solida la
motivazione di fondo della norma, il modo in cui viene applicata è sbagliato, è
poco trasparente e potrebbe rivelarsi una vera e propria truffa, per far girare
la macchina bancaria e delle multilevel. Poteva essere elaborato un qualsiasi
altro sistema, come un diretto coinvolgimento dell'Enel, che avrebbe beneficiato
degli incentivi, oppure avrebbe messo nel conto di ammortamento il risparmio
delle bollette, senza richiedere così l'intervento di una banca. D'altronde se
il sistema era davvero conveniente, funzionale ed efficiente, avrebbe avuto una
pubblicità su larga scala, e avrebbe preso piede tra la popolazione in poco
tempo. Invece sono anni che non si muove nulla, e in questi ultimi mesi l'unica
cosa che sono riusciti a muovere sono stati - come sempre d'altronde - i mutui,
i debiti, i finanziamenti. Allora ci chiediamo perché l'Enel non comincia già da
domani a fornire ad ogni famiglia un impianto fotovoltaico, acquistando dai
cittadini l'energia, investendo così della "produzione diffusa" e non in quella
concentrata in obsolete centrali termoelettriche. Molto spesso abbiamo risposto
a questa domanda dicendo che "vi sono grandi interessi delle lobbies
petrolifere" che impedisce il diffondersi di tecnologie differenti. La triste
realtà tuttavia fa capire che questo è un grande alibi, che il problema di base
siamo noi stessi, i nostri governi, le nostre imprese, che complicano una cosa
così semplice solo per speculare, per lucrare sulla speranza dei cittadini di
uscire dall'incubo del petrolio e del gas. I mutui, le multilevel: non sono
questi i mezzi che porteranno i popoli ad ottenere energia libera, perché sono
strumenti di potere.
I clan pugliesi mettono le mani sul business della
«green economy». Se fino a poco tempo fa c’erano dubbi, ora c’è più di un
indizio che ha superato lo step del mero sospetto, arrivando a un passo dalla
«prova». L’allarme arriva direttamente dal presidente della commissione
parlamentare antimafia, Beppe Pisanu, al termine della «missione» di due giorni
in Puglia del 10 dicembre 2010. Il senatore parla per oltre mezz’ora, in
Prefettura, rispondendo a una serie di domande dei giornalisti.
Un argomento suscita subito l’attenzione ed è il
riferimento agli affari nell’energia pulita. I clan acquistano e rivendono
terreni dove collocare la pale eoliche o un parco fotovoltaico che gestiscono
anche in proprio attraverso società prestanome: «Non chiedetemi altro, sono
vincolato al segreto istruttorio», taglia corto Pisanu che conferma l’esistenza
di indagini sulla piovra dell’energia da fonti rinnovabili. Il presidente non
indica aree specifiche, ma è evidente che il fenomeno non può riguardare solo il
Gargano, zona regina per l’eolico, e dove «la criminalità tende ad assumere
forme più oculate di controllo del territorio e caratteristiche di vera e
propria mafia». Del resto, la Puglia è la regione italiana con la più alta
potenza di eolico, quindi va da sè che la criminalità fiuti l’affare e cerchi di
approfittarne, chiosa il presidente dell’organismo bicamerale. Ma di eolico e
fotovoltaico a iosa vi è anche nel Salento. Come a iosa sono le polemiche in
fazioni contrapposte nello stesso marasma ambientalista salentino.
Pisanu ha parlato anche di borghesia mafiosa
facendo riferimento a quel salto di qualità che vede la regione proiettata
nell’olimpo di quei territori dove i colletti bianchi trovano terreno fertile. È
il caso del riciclaggio di denaro sporco alimentato da connivenze e collusioni
con una platea di professionisti che hanno ammodernato il modus operandi delle
organizzazioni criminali, sempre più propense a far tacere le armi per poter
operare sottotono.
PARLIAMO DI ENERGIA ALTERNATIVA.
Nr.: 3433 del 27/09/2018 18:30 Puglia Notizie.
Commissioni. Proposta di legge su idrogeno,
rinnovabilie e decarbonizzazione, Colonna: proficue audizioni in commissione.
Puglia avanguardia in Europa.
Nota di Enzo Colonna (consigliere regionale,
gruppo “Noi a Sinistra per la Puglia”). "È stato molto partecipato, interessante
e proficuo il confronto svolto oggi nel corso delle audizioni nelle Commissioni
IV e V del Consiglio regionale in merito alla proposta di legge regionale “Norme
in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il
rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte
eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare”, di cui mi sono fatto
promotore nei mesi scorsi. Sono stati ascoltati diversi rappresentanti di
organizzazioni del mondo economico, sociale e accademico. Hanno seguito i lavori
l’assessore allo sviluppo economico, Antonio Nunziante, l’avvocato Rocco De
Franchi, consigliere del Presidente della Regione per la tutela ambientale, lo
sviluppo sostenibile e la decarbonizzazione, e l’ing. Carmela Iadaresta,
dirigente della sezione regionale “Infrastrutture energetiche e digitali”. Tutti
gli intervenuti si sono espressi favorevolmente rispetto alla necessità e
all’impianto di questa iniziativa legislativa. Ne hanno sottolineato i tratti
innovativi (tanto da essere stata segnalata ad altre assemblee legislative
regionali da una delle organizzazioni intervenute) e hanno fornito spunti
interessanti per un ulteriore approfondimento relativamente ad alcune
disposizioni. Due, ricordo, sono gli obiettivi della proposta di legge:
1) incoraggiare un’economia basata sulla chiusura
dei cicli produttivi mediante la produzione di idrogeno da energia rinnovabile;
2) favorire l’ammodernamento degli impianti eolici
e fotovoltaici esistenti, prevedendo una disciplina dei procedimenti
amministrativi che offra certezza regolamentare e semplificazione
amministrativa, condizionata alla riduzione delle ripercussioni negative
sull’ambiente.
A tale riguardo la proposta di legge: a) prevede
la redazione del Piano Regionale dell’Idrogeno; b) istituisce un osservatorio
per monitorare l’efficacia delle politiche attivate; c) individua azioni mirate
alla realizzazione di impianti cogenerativi alimentati ad idrogeno per la
produzione di energia elettrica e calore al servizio di edifici pubblici e
privati e di impianti di produzione e distribuzione di idrogeno; d) favorisce il
rinnovo del parco rotabile, su gomma e su ferro, del servizio di trasporto
pubblico con mezzi dotati di celle a combustibile alimentate ad idrogeno e
l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli autoveicoli alimentati
ad idrogeno; e) sostiene la ricerca applicata sull’idrogeno come vettore
energetico per la mobilità sostenibile e forma di accumulo di energia, favorendo
partnership tra Università, centri di ricerca pubblici e privati; f) promuove la
costituzione di comunità locali dell’energia per la produzione e generazione
distribuita di energia elettrica sul territorio. Superando le contraddizioni e
criticità emerse negli anni dovute al susseguirsi di disposizioni legislative e
regolamentari, la seconda traccia della proposta legislativa punta a dotare la
Puglia degli strumenti normativi necessari per affrontare il tema, ormai attuale
e ineludibile, del “fine vita” degli impianti eolici e fotovoltaici, segnati
dall’usura, dalla scadenza delle autorizzazioni e dalla conclusione del
programma di incentivi.
In questo senso, la proposta di legge intende
favorire:
1) l’ammodernamento degli impianti eolici e
fotovoltaici esistenti e la prosecuzione del loro esercizio, a condizione che
gli interventi riducano il numero di aerogeneratori o, per gli impianti
fotovoltaici, la superficie occupata, nonché prevedano misure di compensazione
ambientale in favore dei comuni nei cui territori ricadono gli impianti;
2) le iniziative finalizzate alla delocalizzazione
di impianti esistenti su terreni agricoli, con contestuale ripristino dello
stato dei luoghi, in aree industriali dismesse, cave esaurite, siti inquinati e
siti di interesse nazionale (SIN).
Come ho già evidenziato, si tratta di una
iniziativa legislativa che si pone in linea con gli intendimenti della Giunta
regionale, che, poche settimane fa, ha avviato il procedimento di revisione del
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). In tal modo, tra l’altro, la
nostra Regione si collocherebbe in perfetta sintonia - anzi anticipandoli (come
si è sottolineato oggi in alcuni interventi) - con gli indirizzi strategici
definiti a livello europeo, finalizzati a sostenere processi di
decarbonizzazione, puntando allo sviluppo dell’idrogeno come fonte di energia
sostenibile. L’Unione Europea, infatti, ha fissato, tra gli obiettivi da
conseguire entro il 2030, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di
almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 e una quota di energia prodotta da
fonte rinnovabile pari ad almeno il 27%. Da parte sua, l’Italia, con la
Strategia Energetica Nazionale (SEN) adottata nel novembre 2017, si è posta
l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 la quota del 28% di produzione di
energia da fonti rinnovabili rispetto ai consumi complessivi. Peraltro, appena
pochi giorni fa, nell’ambito dell’incontro informale tra i Ministri dell’Energia
dell’Unione Europea, svoltosi a Linz il 17 e il 18 settembre, è stato
sottoscritto il documento “Hydrogen Initiative” contenente le politiche
strategiche che l’UE intende sviluppare per sostenere il progressivo abbandono
delle fonti combustibili fossili e la loro sostituzione con l’idrogeno
sostenibile. In tal senso, la Puglia, anche con questa iniziativa legislativa, è
in condizione di porsi all’avanguardia nell’ambito di questa strategia, sia a
livello nazionale che europeo, favorendo un aggiornato modello di sviluppo
avanzato nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e
nell’innovazione orientata alla riduzione della dipendenza dai combustibili
fossili. Ringrazio i presidenti della quarta e quinta commissione e i colleghi
per l’attenzione riservata a questa iniziativa legislativa. "
Energie rinnovabili. Con la sinistra
bollette aumentate del 40%. Ricordatevelo prima di votare,
scrive il 4 marzo 2018 Enrico Salvatori su "Il Giornale". Quando a Novembre
Gentiloni, Calenda e Galletti hanno presentato la nuova Strategia energetica
nazionale (Sen), i giornali filogovernativi ne hanno parlato come un progetto
straordinario studiato per far risparmiare soldi in bolletta agli italiani
incentivando le energie rinnovabili, ma in realtà scopriremo come -per
compiacere l’Onu e qualche ambientalista da strapazzo- favorisce al contrario un
aumento delle tasse per famiglie e imprese. Nel documento del governo è infatti
spiegato chiaramente che uno degli obiettivi è quello di aumentare al 2030 di
oltre un terzo la produzione di energia elettrica rinnovabile. “Noi ad oggi”,
spiega Rosa Filippini degli Amici della Terra, “per raggiungere l’obiettivo del
33% di produzione elettrica da rinnovabili, abbiamo sussidiato gli impianti di
eolico e fotovoltaico per circa 12 miliardi di Euro l’anno (con aumenti fino al
40% in bolletta)”. Quanto ci costerà dunque arrivare al 55% di produzione di
energia elettrica al 2030 come indicato dalla SEN? Difficile ora fornire stime
specifiche ma “una cosa è certa”, spiega ancora Filippini, “nonostante uno degli
obiettivi generali sia quello di ridurre il costo dell’energia, in realtà questa
SEN comporterà un aumento del prezzo in bolletta, non una sua riduzione”; “per
incentivare, in media, la produzione di appena il 20% dell’energia elettrica
consumata in Italia che, a sua volta, costituisce poco più del 20% del totale
dei consumi finali di energia”, ci tiene a precisare Monica/ Tommasi, presidente
della stessa associazione, di recente espulsa dalla federazione internazionale
degli ambientalisti (Friends of Earth), con una accusa dal sapore vagamente
“sovietico”, ovvero quella di non essersi allineata alle “direttive comuni”.
Siamo di fronte, quindi, a quello che forse è il più consistente programma di
sussidi del dopoguerra, nonostante il ministro Calenda, appena tre mesi fa abbia
dichiarato che “la scelta (degli incentivi esagerati) fatta (negli anni scorsi)
con le rinnovabili elettriche” sia stata “una scelta dissennata”.
Altra scemenza l'”impegno politico alla cessazione
della produzione termoelettrica a carbone al 2025″. Nessun paese europeo
rinuncia infatti ad una base di produzione elettrica a basso costo e abbondante
come quella derivante dal carbone. La stessa Germania, secondo dati Eurostat,
mentre si presenta al mondo come paladina degli Accordi ONU di Parigi contro il
Cambiamento climatico e possiede oggettivamente il parco rinnovabile più grande
d’Europa, non rinuncia a questa risorsa (proprio per mantenere bassi i costi
delle bollette). Anzi, continua ad usare la lignite (la forma più inquinante del
Carbone fossile) con cui produce il 42% del proprio fabbisogno energetico a
fronte di una produzione “verde” del 26%. Stesso discorso per il Regno Unito
(non per la Francia, che comunque genera il 77% del suo fabbisogno energetico
elettrico dal nucleare e non dalle energie rinnovabili). Dunque l’Italia,
nonostante sia il paese con la produzione più alta di energia elettrica da
rinnovabile (che si attesta al 39% compreso l’idroelettrico, rispetto al 30%
della Germania), decide con questa SEN, di smantellare le nostre centrali a
carbone (appena costruite, ecologiche e con un sistema di filtri avanzato),
solamente per compiacere le frange più estreme dell’ambientalismo ideologico, a
casa nostra e presso le Nazioni Unite (a spese nostre). Ma vedrete che “la tassa
occulta sull’energia elettrica diventerà presto palese insieme alle
responsabilità di chi l’ha imposta”, commenta Oreste Rutigliano di Italia
Nostra. E questa volta non reggerà neanche il ritornello “ce lo chiede
l’Europa”. Perché le politiche energetico-climatiche UE per il 2030 non
prevedono più obiettivi obbligatori di fonti rinnovabili per i singoli stati
membri. Altro aspetto deleterio, la necessità auspicata dalla SEN che le norme
di tutela del paesaggio siano addirittura ammorbidite per triplicare gli attuali
impianti installati di fotovoltaico e raddoppiare quelli di eolico. “In questo
modo”, spiega ancora Monica Tommasi, “raddoppierà anche il sacrificio di
ulteriori territori fra i più belli e delicati del nostro Paese per conseguire
in pochi anni un incremento di 15 punti percentuali nel solo comparto elettrico
e che si tradurrà in appena il 4% di contributo sul fabbisogno energetico
complessivo”. “Un suicidio”, chiosa Oreste Rutigliano di Italia Nostra, “a
favore di indeterminate lobby e fuori da ogni razionalità”.
Bollette della luce: la “burla” delle
tasse nascoste, ecco chi sono i morosi. Non si placano
le polemiche sulle bollette non pagate dai morosi e la tassa nascosta relativa
agli oneri di sistema, scrive Chiara Lanari il 23 Febbraio 2018 su "Investire
oggi". Ormai è cosa nota. Le bollette della luce non pagate dai morosi
ricadranno sui cittadini che puntuali hanno sempre provveduto a saldare la
fattura, 37 milioni di consumatori pagheranno cifre aggiuntive, un sistema che
ricorda molto quello sulle accise della benzina. Quello che forse è difficile da
accettare è che nelle bollette dell’energia vengono spalmate voci, oneri di
sistema, che poco o nulla hanno a che fare con l’energia e invece di essere a
carico della fiscalità ricadono sul cliente. Un esempio è stato riportato da Il
Sole 24 ore secondo cui su una bolletta non residente da 183 euro, solo 42 euro
si riferiscono agli oneri di sistema mentre per una bolletta residenti di 662
euro, 166 sono riferiti agli oneri.
Cosa paghiamo nella bolletta della luce? Gli oneri
di sistema vengono stabiliti dall’Arera e tra questi una voce importante è
riferita agli incentivi alle rinnovabili, componente A3. C’è poi l’onere A2
ossia lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse, in parte destinato al
bilancio dello Stato, l’A5 è invece riferito alla ricerca svolta nell’interesse
del sistema elettrico nazionale, l’Ae per agevolazioni alle imprese
manifatturiere con elevati consumi, la voce UC4 si riferisce ai costi di piccole
aziende elettriche che operano sulle isole minori. Altri voci sono legate allo
smaltimento delle scorie nucleari, le agevolazioni per la fornitura di energia
elettrica al sistema ferroviario, il bonus elettrico per chi è in una situazione
di disagio economico etc. Tutti questi oneri dal 1 gennaio sono stati unificati
in oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e
cogenerazione (Asos) e i rimanenti oneri generali (Arim). In ogni caso nelle
bollette che paghiamo solo il 19% del totale è riferito proprio a questi oneri,
a cui si aggiunge anche il Canone Rai e conseguenti rincari. La notizia di per
sè non è una novità ma lo diventa quando viene stabilito che agli oneri di
sistema che già non c’entrano quasi o poco nulla con l’energia si aggiungono le
cifre non pagate dai morosi.
Ecco chi sono i morosi. Una verità arriva
dall’associazione Codici che avrebbe svelato chi sono questi odiati morosi: “dai
dati dell’Autorità per l’energia, più nello specifico dal monitoraggio retail
sui morosi, appare lampante come in questo Paese a non pagare sono
sostanzialmente: la pubblica amministrazione e le imprese e comunque tutti
colori che consumano in media tensione (MT) altri usi, quindi non gli utenti
domestici, ovvero non i privati cittadini”. A pagare di meno sono le aziende e
le Pa e a rimetterci i cittadini secondo Codici che promette di impugnare
davanti al Tar il provvedimento. Il conto ammonta infatti a 200 milioni ma
potrebbe essere molto di più. Oltre a Codici, a scandalizzarsi ci sono anche
Adusbef e Federconsumatori, che conferma le parole di Codici sui morosi: “stando
ai dati dell’Autorità per l’energia, le utenze che risultano morose sono in
larga parte relative alle piccole e medie imprese. Proprio per questo appare
ancora più assurdo ed improponibile far pagare ai cittadini i costi a cui le
imprese non riescono a far fronte”.
Bollette della luce non pagate: saremo noi a
sborsare per i morosi. Un meccanismo poco chiaro. Bisogna anche sottolineare
come è nato questo meccanismo. I grandi distributori di energia avevano
anticipato alcuni degli oneri ma il gran numero di morosi aveva messo in
ginocchio parecchie società che avrebbero dovuto raccogliere le cifre per
riconsegnarle ai big che avevano anticipato le suddette quote. Una volta fallite
le società non hanno più potuto pagare e ora il buco lasciato dovrà essere
colmato dai consumatori. Ora l’Autorità sta ancora calcolando a quanto dovrà
ammontare l’aumento ma sembra trincerarsi dietro un: “non pensiamo che l’impatto
sulle bollette sarà così allarmante”. In ogni caso a pagarle sarà chi, in fondo,
non ha colpe.
Perché la “rivolta” di chi non vuole
pagare 35 euro di aumento della bolletta elettrica è inutile.
Molti cittadini indignati propongono di non pagare l'aumento da "35 euro" della
bolletta elettrica perché "non è giusto pagare per chi non paga". Ovviamente non
è possibile farlo. Ma il problema è un altro: come mai nessuno propone azioni
simili nei confronti degli evasori fiscali, che costano senza dubbio di più al
singolo cittadino? Scrive Giovanni Drogo giovedì 22 febbraio 2018 su "Next".
L’Internet italiano è in fibrillazione per colpa di 35 euro. Questa volta non
sono i famosi 35 euro che lo Stato spende per mantenere i migranti in alberghi a
cinque stelle con WiFi gratuita, piscina riscaldata e tavoli da black jack. Si
tratta invece dell’aumento della bolletta dell’energia elettrica. Un rincaro
dovuto non tanto ai costi dell’energia ma ai mancati pagamenti da parte degli
utenti morosi. Tutto è nato in seguito alla pubblicazione di un articolo del
Sole 24 Ore che dava conto di una delibera dell’Autorità dell’energia (ARERA)
che prevede di “spalmare” sugli utenti il costo delle bollette non pagate.
Cosa sono gli oneri generali elettrici? Il tutto è
la conseguenza di una serie di ricorsi e sentenze del Tar e del Consiglio di
Stato che hanno avuto come conseguenza la decisione di redistribuire fra tutti i
consumatori una parte degli “oneri generali” (come spiegato qui da ARERA)
elettrici pari a circa 200 milioni di euro arretrati non pagati dai titolari
delle utenze “morose”. Gli oneri generali non corrispondono alla fornitura di
energia elettrica ovvero a quanto effettivamente consumato dall’utente che non
paga. Nelle bollette dell’energia elettrica, oltre ai servizi di
vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di
rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si
pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse
generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri
generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.
Tra questi ci sono quelli per il decommissioning nucleare, gli incentivi alle
fonti rinnovabili, le agevolazioni alle industrie ad alto consumo di energia,
quelli per la promozione dell’efficienza energetica oppure le compensazioni
territoriali per quegli enti locali che ospitano impianti nucleari. In buona
sostanza gli oneri generali sono all’incirca il corrispettivo delle accise sui
carburanti. Soldi che ogni utente paga ma che vengono “girati” poi allo Stato I
fornitori dell’energia elettrica che non riescono a farsi pagare le
bollette hanno già versato gli oneri e quindi ora si trovano nella spiacevole
(per loro) situazione di dover coprire questa perdita che però non ammonta al
totale degli insoluti la cui cifra secondo alcune stime è superiore al miliardo
di euro.
L’aumento delle bollette elettriche e il solito
annoso problema di chi non paga le tasse. A nessuno naturalmente fa piacere
pagare per gli altri soprattutto quando il conto viene presentato direttamente
in bolletta. Se non fosse per quello, ovvero per il fatto che ogni utente vedrà
di persona quanto pesa la morosità, probabilmente nessuno si sarebbe lamentato
troppo. Non si sono mai viste sollevazioni popolari (a mezzo Facebook) contro
aumenti delle tasse dovuti ad esempio all’evasione fiscale. Eppure per
consentire il funzionamento dei servizi pubblici (dei quali usufruiscono
quotidianamente anche gli evasori) chi paga le tasse lo fa anche per coloro che
non pagano. Una parte dell’aumento della tassazione è necessario per coprire il
minor gettito dovuto all’evasione. Succede a tutti i livelli, di recente a Roma
è emersa l’esistenza di dodicimila “scrocconi” che non pagano la tassa sui
rifiuti. Servizio di cui usufruivano lo stesso di fatto danneggiando i loro
concittadini che erano costretti a pagare di più. Il paradosso è che da molte
persone l’evasione fiscale viene vista addirittura come una cosa giusta. Non
serve ricordare qui chi era quel politico che qualche anno fa diceva che era
“moralmente giustificato” evadere le tasse. La differenza naturalmente è che in
seguito alla privatizzazione del settore elettrico i gestori sono società
private e quindi il “sopruso” è più sentito. Ma il punto è che già ora paghiamo
i costi dell’evasione, sia delle tasse che delle tariffe. Non è giusto, ma
indignarsi perché gli “oneri generali” (ovvero la componente parafiscale delle
bollette) viene fatta pagare a chi è in regola non fa altro che mettere in luce
un problema generale. Senza contare ovviamente che se le aziende saranno
costrette a chiudere probabilmente alcune persone perderanno il lavoro. E di
nuovo lo Stato (ovvero i cittadini) dovrà aprire il portafoglio per pagare
eventuali ammortizzatori sociali.
La bufala del messaggio WhatsApp che invita a non
pagare i 35 euro. Insomma è un serpente che si morde la coda, ma essendo i
cittadini la parte più debole (ma al tempo stesso i colpevoli, visto che a non
pagare sono altri cittadini) il pagamento è particolarmente odioso. Ecco che
quindi i soliti rivoluzionari da tastiera propongono fantasiosi metodi per non
pagare, ad esempio scorporando autonomamente i “35 euro” dall’importo della
propria bolletta. Il problema è che l’entità dei rincari non è ancora stata
definita e quella dei 35 euro, cifra quanto mai evocativa in Italia, non
corrisponde alla reale entità dell’aumento. ENEL ha fatto sapere infatti che “il
relativo impatto sulle bollette dei consumatori finali non è ancora stato
quantificato da ARERA, ma in ogni caso l’Autorità ha precisato che sarà molto
contenuto (all’incirca il 2% degli oneri di sistema, e non certo 35 euro)”. Così
come il messaggio-catena che circola su WhatsApp e invita tutti a pagare “solo
quanto mi spetta” (semmai il dovuto) non ha alcun senso e non funzionerà nemmeno
se lo faranno tutti i consumatori. Non solo perché i gestori si rifaranno su
ciascuno degli utenti ma anche perché, e questo è l’aspetto interessante, quegli
oneri servono per finanziare altre voci di spesa delle quali usufruiscono i
cittadini. Alcune – come quelle per il decomissioning delle centrali nucleari
sono la diretta conseguenza delle decisioni dei cittadini stessi (il referendum
sul nucleare) altre invece finiscono nel calderone degli incentivi per le
rinnovabili (ovvero anche gli sgravi fiscali).
Via dal vento, se ancora si può. Via da questo
pazzo vento di incentivi scandalosi per quantità e durata, via da questa corsa
forsennata all’ultima pala che qualcosa frutterà anche se per ora non gira, via
da questi “sviluppatori” - nuova sofisticata figura di mezzani - che stravolgono
e offendono la quieta esistenza dei piccoli comuni giocando a nascondino con le
royalties, via da questi sprechi, da queste mafie in agguato, da queste bollette
ogni giorno più care perché il Balletto dell’Eolico ha i suoi costi. E che
costi, per produrre poco o nulla. Sono installati in questo momento in tutta la
Penisola 4.236 “aerogeneratori”.
Le pale eoliche - il 98 per cento al Sud, e questo
la dice lunga - producono 4.849 megawatt, tanto da porre l’Italia al terzo posto
in Europa, ben distanziata da Germania (25.800) e Spagna (19.100) e inseguita da
vicino da Francia (4.500) e Gran Bretagna (4.000). Bene, l’installazione e la
manutenzione di una pala media in Danimarca - lo Stato che ha investito più
sull’eolico - in 15 anni di vita costa un milione, mentre da noi, in Sicilia,
viene il quadruplo. E sono pale che girano davvero poco: 1.880 ore sempre in
Danimarca, 2.000 in Svizzera, 2.046 in Spagna. 2.066 in Olanda, 2.083 in Grecia,
2.233 in Portogallo e da noi soltanto 1.466 ore l’anno. Ma perché? «Una terra di
vento e di sole -titolò il Financial Times la sua inchiesta sull’energia eolica
in Italia - ma senza regole adeguate». Nessuno se ne accorse, o forse fecero
tutti finta di non accorgersene.
Ma non s’è levato un moto di reazione neppure il
18 settembre 2010 quando il ministro dell’Economia Giulio Tremonti, parlando da
Cortina, ebbe a dire: «Il business dell’eolico è uno degli affari di corruzione
più grande e la quota di maggioranza francamente non appartiene a noi».
Silenzio. E invece lo sconcio è sotto gli occhi di tutti. Uno sconcio che
provocherà guasti anche sociali, non solo economici, stravolgerà l’esistenza di
borghi preziosi e di colture rare, produrrà un punto di non ritorno per questa
nostra Italia con cui bisognerà fare i conti. Per comodità di ragionamento,
lasciamo per un attimo da parte il primo dilemma, piace, non piace. Facciamo
finta che questi giganti abbelliscano davvero l’Appennino Dauno e la piana di
Mazara, le più belle zone archeologiche della Puglia e le gole più nascoste
delle Marche. E passiamo ai dilemmi successivi: chi ci guadagna, come ci
guadagna, se questi benefici arrivano in tutto o in parte al Paese Italia. Le
prime cifre sono sconvolgenti, purtroppo. Ci sono domande di connessione alla
rete in Italia (2010) pari a 88.171 megawatt. L’Anev, l’Agenzia che raggruppa le
aziende del settore dell’Energia del vento stima che entro il 2020 la produzione
potrà raggiunge al massimo 16mila megawatt. Che senso ha quindi, se non quello
di puntare a una spaventosa speculazione, presentare domande per una quantità di
energia cinque volte superiore? Il mercato dell’eolico è anche e soprattutto un
mercato di carta, il mercato dei famigerati “certificati verdi”, che possono
essere comprati dalle grandi aziende al piccolo produttore se queste grandi
aziende non hanno prodotto, di loro, la percentuale di energia rinnovabile
prevista dalla legge. Che poi queste aziende continuino con le vecchie
produzioni inquinanti, questo sembra non interessare davvero a nessuno. Di
fatto, con i certificati verdi si fanno grandi cose. Lo dice l’Authority per
l’energia, rivelando che nel solo 2008 il Governo ha sborsato 1.230 milioni in
certificati verdi, pagati grazie all’addizionale sulle nostre bollette, e che la
metà di questa somma è stata tirata fuori per rimborsare un «eccesso
dell’offerta». Ecco cosa vuol dire: che si produce più energia di quella che si
vuole immettere o si riesce a immettere e che questo surplus viene comunque
pagato. E ovviamente le nostre bollette restano le più care d’Europa. Ci sono
studi recenti anche sui posti di lavoro, ventottomila nell’eolico nel solo 2008.
Considerando che i sussidi erogati sono stati pari a 2,3 miliardi di euro, ogni
posto di lavoro creato è costato 55mila. Un altro calcolo: comprendendo tutte le
energie rinnovabili, quindi anche il fotovoltaico, si calcola che un nuovo posto
di lavoro venga a costare almeno sette volte di più rispetto all’industria. C’e
da rimanerci seppelliti sotto questa valanga di cifre. Se non ci fosse da
rimettere insieme, ancora, alcune tessere del mosaico. A cominciare dagli
incentivi sulla produzione di energia, garantiti per quindici lunghi anni come
le pale e i più alti d’Europa come le bollette. Partiamo dal fatto che un kwatt
di energia al povero cittadino costa oggi 6,5 centesimi. Ebbene, chi produce
eolico ne intasca intorno al doppio (dipende dai valori un poco oscillanti della
Borsa elettrica) e chi invece si butta sul fotovoltaico, che poi è la vera nuova
inesplorata (può arrivare a cinque sei volte il valore iniziale, intorno ai
39-40 centesimi di euro).
Ma perché il Far West dell’eolico conosca uno
stop, ci vogliono almeno i piani regionali. Per ora, chi si alza per primo mette
la pala. Per sfuggire persino alla Valutazione di Impatto Ambientale, tedeschi,
spagnoli e americani hanno già scoperto il trucco: spaccano un progetto di parco
eolico in quattro-cinque spezzoni, scendono sotto la soglia prevista, e così se
la cavano con una semplice, unilaterale Dichiarazione di impatto ambientale al
comune che li ospita. Non c’è piano regolatore da rispettare, c’è solo da
avvicinare il famoso “sviluppatore” in loco, che ha già scelto l’area, ha già
valutato i vincoli paesaggistici e soprattutto ha già contattato gli
amministratori locali. E comincia così il valzer del terreni scelti, quello sì,
questo no, per distese infinite come solo il nostro Appennino regala. Ma la
gente si ribella. Contro i parchi eolici spuntano comitati a ogni piazza, a ogni
tavolino di bar, a Nardò, a Mazara, a Cosenza, a Crotone, a Otranto. E con i
comitati spuntano le inchieste delle magistratura. A parte quella famosa aperta
in Sardegna - quella di Flavio Carboni, per intenderci - è tutto un fiorire di
nuovi fascicoli: ancora a Crotone, a Sant’Agata di Puglia, in Molise, a Trapani,
dove allo “sviluppatore” Vito Nicastri, re del vento di Sicilia e Calabria e
ritenuto longa manus del boss Matteo Messina Denaro, hanno sequestrato un
patrimonio di 1.5 miliardi. E’ un mare di sporco che avanza, non se ne vede la
fine. ''L'eolico nelle regioni meridionali è stato favorito e sostenuto dalla
mafia. Questo è un dato inconfutabile; tacere è una forma di complicità''. Lo ha
detto Vittorio Sgarbi.
Se ai pastorelli della collina di Giuggianello -
come racconta Ovidio - capitò di essere trasformati in alberi solo per aver
avuto l’ardire di danzare con le Ninfe, cosa potrà mai capitare agli
amministratori della Regione Puglia se un giorno gli Dei decidessero di tornare
qui: di trasformarsi tutti in pale eoliche da 80 metri l’una, alte quanto un
palazzo di 25 piani? O quale altro sortilegio sarà loro riservato come
punizione, per aver consentito non in un mese e neppure in un anno, ma in lunghi
mesi e lunghi anni, che la loro splendida terra si trasformasse in un Far West,
che il sogno del business ad ogni costo - una Corsa all’Oro in piena regola -
attirasse qui ogni genìa di cow boy senza scrupoli a devastare, a inquinare, a
corrompere? Ecco, la Puglia. Partiti con il sole e con il vento, con il sogno
dell’energia pulita, si è finiti dieci anni dopo a fare i conti con un disastro:
i conti con le inchieste penali aperte dalla magistratura, i conti con i ricorsi
al Tar e al Consiglio di Stato, i conti con le pressioni, con le intimidazioni
che hanno dovuto subire i contadini proprietari dei terreni, con le giravolte di
società partite con diecimila euro e poi pronte a sparire, i conti con una
Puglia che non è più la stessa.
Tanto per riepilogare, il meccanismo è questo:
arriva lo “sviluppatore”, contatta piccole amministrazioni con le casse vuote e
contadini che ormai delle loro terre non vivono più, presenta il progetto delle
pale, impacchetta tutto e aspetta la grande azienda. Per rivendersi a milioni di
euro quell’autorizzazione e perché cominci un altro affare, questo alla luce del
sole, ma altrettanto discutibile: un kw di energia che vale 6,5 centesimi di
euro verrà pagato a chi la produrrà con queste pale praticamente il doppio, e
per quindici lunghissimi anni. Chi ci rimette, sempre per riepilogare, è il
povero cittadino che paga la bolletta: c’è una voce che gli viene addebitata
proprio perché partecipi anche lui (ma solo da spettatore pagante) a
quest’abbuffata, una voce che in questo 2010 vuol dire, come incentivo su scala
nazionale a carico degli utenti, 3 miliardi di euro, 5 miliardi nel 2015 e 7
miliardi nel 2020. Bell’affare.
Ma torniamo alla Puglia, dove davvero è successo
di tutto e di più. Dove l’Anev, l’Agenzia delle imprese del settore, dice che
fino al 2009 sono state installate 916 pale eoliche per un totale di 1.158
megawatt, Puglia prima in Italia, s’intende. Ma le cifre dell’Anev sono superate
da quelle dell’assessorato all’Energia: fra impianti installati e autorizzati
c’è già in campo una produzione di 2.300 megawatt, quindi intorno alle 1.800
pale e c’è un piano energetico regionale che consente di arrivare entro il 2016
a 4.000 megawatt. Una follia, la Puglia da sola che pretende (e a questo punto
dovrebbe riuscirci) di produrre un quarto dell’energia eolica italiana prevista
dall’Anev per il 2016. Come è potuto accadere?
«Ma se vuole – confida l’assessore all’energia -
le offro un dato che può consegnare la Puglia alla fantascienza...». E lo offre:
ci sono domande giacenti in Puglia per altri 30mila megawatt, per almeno altre
12mila torri eoliche da disseminare sul territorio, «una specie di Foresta del
Mato Grosso», chiosa l’assessore. E che succederà? «Succederà che approveremo
solo progetti altamente qualificati, quindi pochissimi». Richieste per 30mila
megawatt vuol dire che i pescecani dell’eolico pensavano di produrre qui il
doppio dell’energia prevista per tutta l’Italia dalle “rinnovabili” entro il
2020. Una stalla che nessuno si è preoccupato di chiudere né quando, nell’estate
del 2008 arrestarono il sindaco di Ascoli Satriano, provincia di Foggia, Antonio
Rolla, per abusi commessi proprio nella realizzazione di un parco eolico, né
quando a febbraio 2009 si mosse la Procura Antimafia di Lecce con un’inchiesta
su quel che resta della Sacra Corona, sul clan Bruno, e sul parco eolico di
Torre Santa Susanna, provincia di Brindisi, che finì con dieci arresti, e
neppure quando un anno dopo tutta la giunta di Sant’Agata di Puglia finì sotto
inchiesta per le pale del Sub Appennino Dauno che sul terreno del sindaco
valevano il doppio. Tanto meno ha senso chiuderla oggi, questa stalla, oggi che
la Procura di Napoli ha messo gli occhi anche sul parco eolico di Castellaneta,
provincia di Taranto, uno dei più grandi d’Europa con le sue 276 pale, e che sta
frugando tra le carte della Green Engeneering and Consulting, di Napoli appunto,
la stessa azienda che si potrebbe ritrovare negli archivi del comune di Vicari,
provincia di Palermo, l’intero consiglio sciolto nel 2005 per «infiltrazioni
mafiose». Ma non è la sola connection siciliana che si nota qui in Puglia: nelle
pagine dell’inchiesta di Raccuja, parco dei Nebrodi, provincia di Messina, che
ha portato all’arresto del sindaco, si può ritrovare il nome della Api Holding,
la stessa ditta delle pale di Sant’Agata di Puglia. Insomma, un bell’intreccio.
Si diceva dei pastorelli e delle Ninfe perché
anche qui c’è un casus belli, un po’ come le rovine di Altilia a Sepino, in
Molise. La differenza è che mentre le pale di Sepino sono previste a una decina
di chilometri dalle rovine e già danno fastidio, le 14 pale di Giuggianello,
invece, dovrebbero sorgere praticamente tra i resti megalitici che raccontano
quella leggenda. Quattordici belle pale che qui hanno una loro peculiarità:
essendo piazzate sulle Serre Salentine, cioè sui crinali più alti del Tacco
d’Italia, a 200 metri di quota, possono essere ben viste dai due mari, sia
dall’Adriatico sia dallo Jonio. Come ha potuto la regione Puglia consentire che
si arrivasse a tanto? Perché, poi, il Salento è un caso nel caso. E’ qui che c’è
stato l’assalto più sfrenato. Pale come se piovesse, a Lecce stessa, a Soleto, a
Martignano, a Surbo, a San Pancrazio, a Martano, a Ugento, a San Donato. Solo a
Nardò, nelle bellissima Nardò, non sono arrivati. Una specie di rivolta di
popolo ha impedito che il parco eolico si realizzasse. Ma per il resto è stata
una specie di marcia trionfale dei Guastatori. E poi c’è l’off shore, le pale a
mare. Quattordici progetti presentati, uno approvato dalla Regione Puglia,
quello di Tricase, in provincia di Lecce, con le torri a una ventina di
chilometri dalla costa. Una specie di zattere che comunque infastidiscono
parecchio gli ambientalisti: sostengono che interromperebbero la migrazione
degli uccelli fra Italia e Albania. Gli altri tredici progetti, perché nel
frattempo la normativa è cambiata, sono tutti sul tavolo del ministero a Roma.
La Regione, per quanto di sua competenza, si è già dichiarata contraria alle
torri alle Isole Tremiti e davanti al Gargano. E la partita non è chiusa. Con i
pannelli fotovoltaici stanno succedendo cose turche per queste contrade. E il
fotovoltaico rende come incentivi almeno tre volte l’eolico, scatena, quindi,
appetiti ancora più sfrenati. E’ la nuova frontiera, perché questo brutto Far
West non finisce mai. Tutta ancora da raccontare.
«Italia Nostra auspica una nuova prima vera “mani
pulite in Puglia”, che riporti la legalità ed il diritto, dove oggi sembra
regnare solo l’interesse di pochi! Dove si devasta il paesaggio, lì c’è la
mafia! Non cercatela altrove! - Queste le parole di Marcello Seclì, presidente
Italia Nostra, Sud Salento. - I telefoni di Italia Nostra squillano come
centralini ospedalieri durante un’epidemia: è gente allarmata che denuncia la
desertificazione, la morte del Salento sotto i “lager dei pannelli fotovoltaici”
dove prima crescevano fiori e prodotti agricoli. E’ una “metastasi
incontrollata” che soffoca le nostre vite uccidendo il nostro paesaggio, un
“cancro”, non lo si può definire diversamente, cui la Regione deve porre rapido
rimedio, fermando con una moratoria il fotovoltaico in tutte le zone agricole e
autorizzandolo solo nelle aree industriali e sui tetti e tettoie di strutture ed
edifici recenti! Tutti gli impianti industriali prossimi alle strade del Salento
che stiamo vedendo sorgere ormai dappertutto comportano, sotto la luce del sole,
un effetto riverbero che acceca gli automobilisti provocando incidenti che
possono rivelarsi anche fatali! Nessuno ha mai tenuto conto di questo?! Eppure
altri impianti fotovoltaici a terra stanno sorgendo su ettari ed ettari ai
margini della provinciale Castrignano dei Greci-Martano, della
Corigliano-Galatina, lungo lo scorrimento veloce Maglie-Galatina, qui
addirittura senza che siano rispettate nemmeno le fasce di rispetto di almeno 50
m previste per le strade di tipo B, ecc. ecc. Scempi a danno del paesaggio, del
suolo agricolo e del nostro ambiente (si consideri solo l’inquinamento da
diserbanti utilizzati!), tutti incostituzionali, che amministratori dall’animo
corrotto e bugiardi presentano pure come occasione di sviluppo per il
territorio, pur nella consapevolezza della nulla tecnologia locale impiegata e
della esigua manodopera che sarà occupata a regime; amministratori che si
arrampicano sugli specchi per cercare di giustificare le autorizzazioni concesse
ai nuovi colonizzatori stranieri dell’energia, che tutto prenderanno,
deprederanno, dal territorio, persino i nostri stessi incentivi per le
rinnovabili, senza nulla poter dare in cambio. Siamo arrivati veramente alla
spudoratezza! Ciò che finora si è fatto e tentato di fare illegittimamente e nel
più assoluto riserbo, ora si tenta di continuare a fare cercando di legittimarlo
attraverso la pubblica ostentazione, in extremis, nel crollo rovinoso di
immagine e delle norme del castello immorale con cui si era permessa questa
speculazione, quella delle rinnovabili industriali e della Green Economy,
praticamente la più grave speculazione della storia del Sud Italia, come l’ha
definita tra le righe lo stesso Ministro Tremonti! Dove sono le forze
dell’ordine che dovrebbero intervenire in forze per porre i sigilli di sequestro
a queste strutture totalmente industriali realizzate in piene zone agricole e
contro la Costituzione Italiana ed ogni buon principio di pianificazione urbana?
Infatti, la legge regionale 31/08 è stata dichiarata incostituzionale, già in
marzo 2010, dalla Corte Costituzionale, ed è in nome di questa legge che si sono
aperti successivamente cantieri per realizzare gli impianti, i più, di potenze
inferiori a 1MW, ciascuno di circa tre ettari di verde fertile suolo ricco di
biodiversità, che viene desertificato e coperto, sepolto di pannelli, pugnalato
da migliaia di pali e martoriato con chilometri di cavidotti, ed il tutto con la
presentazione di una semplice Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) al solo
comune interessato; una procedura che non offre alcuna garanzia per l’ambiente e
la pubblica sicurezza e prevenzione sanitaria. Scopriamo poi, che stesse ditte,
magari mal celate sotto nomi diversi, tentano di realizzare più impianti nello
stesso feudo comunale! Ma questo è assolutamente illegale, non solo per
l’incostituzionalità già citata; si tratta, infatti, di frazionamenti realizzati
ad hoc, con dislocazione di uno stesso mega impianto di più megawatt in più
sotto impianti, anche non necessariamente contermini, ma nello stesso feudo, o
in feudi vicini, per poter con lo strumento delle semplici DIA, evitare, con un
illecito escamotage, le più complesse strade burocratiche dell’autorizzazione
unica regionale, che per legge devono percorrere impianti superiori ad 1MW! A
volte il frazionamento mira ad evitare le incerte, nell’esito autorizzativo,
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per i grandi impianti!
Intervengano allora le forze dell’ordine per riportare l’ordine e la legalità,
per controllare come sia possibile tutto ciò, ma anche per verificare come sia
stato possibile inaugurare altri nuovi cantieri alla luce della retroattività
della sentenza di incostituzionalità! Ci chiediamo, senza volere fare polemica,
ma come appello estremo e disperato: dove sono le forze dell’ordine, il NOE, i
Carabinieri, la Polizia, la Finanza, la Forestale, la Polizia Provinciale? Non
vedono, come tutti noi cittadini invece vediamo quotidianamente, quanto si sta
compiendo illegalmente ai danni di noi tutti, del nostro paesaggio, della nostra
Costituzione? E’ un esercito stipendiato a difesa del territorio che pare
sonnecchiare, o a cui le mani sono state legate da interessi di terzi poteri,
che hanno soffocato anche la loro libertà?! C’è sempre tempo per sequestrare
piscine e case abusive, ma oggi vi è l’impellenza di fermare sul nascere lo
scempio ben più grave e catastrofico delle rinnovabili industriali, da mega
eolico e mega fotovoltaico, denunciato dagli stessi direttori generali pugliesi
di ARPA (Agenzia per la Prevenzione l’Ambiente) e della Soprintendenza ai Beni
Culturali e Paesaggistici! Non avallino i magistrati e le nostre forze
dell’ordine, con il silenzio e la non azione, quanto sta avvenendo!»
Quei miliardi al vento. A Report la grande truffa
dell'importazione dell'energia verde. Le garanzie fornite dai venditori esteri
non danno sicurezza sulla provenienza. È un meccanismo complicato, ma si può
riassumere così: comprare un certificato verde costa a un’azienda italiana molto
di più che importare dall’estero energia dichiarata pulita, anche se non c’è
alcuna vera garanzia che sia davvero tale, come ammette il sottosegretario
Stefano Saglia. Conseguenza per il contribuente italiano: lo Stato si è
impegnato a comprare tutti i certificati verdi invenduti, per garantire un
sostegno al nascente business dell’energia pulita. E questo (come spiega Milena
Gabanelli nella puntata di Report in onda in 28 novembre 2010 su Raitre) nel
2009 è costato alle casse pubbliche un miliardo di euro. Che pagano tutti gli
italiani in bolletta.
C’è fame di energie rinnovabili in Italia. Nella
puntata di Report Giovanni Buttitta, direttore delle relazioni esterne di
Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, conta e riconta le
richieste per allacciare i nuovi impianti: “Un numero molto alto: 120 mila
megawatt”. Il doppio del fabbisogno annuale dell’Italia. Perché spuntano panelli
fotovoltaici ovunque e pale eoliche giganti sostituiscono alberi in montagna e
coprono la terra rossa in riva al mare? L’inchiesta di Alberto Nerazzini
racconta il vero business che si nasconde dietro le richieste ambientaliste
dell’Europa: entro il 2020 l’Italia deve abbattere le emissioni di anidride
carbonica e consumare il 17 per cento dell’energia da fonti rinnovabili. I
cittadini, in gran parte a loro insaputa, contribuiscono a una rivoluzione verde
pagando in bolletta 3,2 miliardi di euro l’anno. Nerazzini si occupa anche di
Green Power, società di Enel appena sbarcata in Borsa. L’azienda non si affida
solo al boom dell’economia verde, ma anche al regime fiscale degli Stati Uniti:
oltre 60 società di proprietà di Green Power hanno sede a Wilmington, nel
Delaware, Stati Uniti. Come mai? L’amministratore delegato, Francesco Starace,
spiega a Report senza imbarazzo: “Perché lì, in America, noi abbiamo una società
che si chiama Enel North America, residente nel Delaware, che all’interno degli
Usa ha un regime fiscale positivo. È un modo per generare meno tasse”. Commenta
Nerazzini: “Tutto legittimo. E sappiamo quanto sia difficile restare competitivi
sul mercato internazionale. Ma visto che Enel è ancora una società controllata
dal Ministero del Tesoro, che ne possiede più del 30 per cento, uno si domanda
quale sia la percentuale di tasse che Enel sta evitando di scaricare sul fisco
italiano”.
L’altro punto su cui si concentra Report è il
traffico di energia rinnovabile importata dall’estero dai produttori di energia
sporca (gas, petrolio) che sono tenuti a ripulirsi, comprando “certificati
verdi” da chi produce usando fonti rinnovabili (un complicato sistema per
trasferire soldi da chi inquina a chi è più “verde”). Il 31,6 per cento di tutta
l’energia elettrica consumata in Italia proviene da fonti rinnovabili, cioè da
centrali idroelettriche, biomasse, geotermia, eolico e solare. Questo dato è lo
stesso che è comunicato ai consumatori: compare nella tabella del mix energetico
che da maggio scorso le aziende fornitrici di elettricità, come l’Enel, devono
pubblicare sui loro siti e sulle bollette. Un dato che sembra descrivere
un’Italia sulla buona strada nel raggiungimento dell’obiettivo concordato con
l’Europa per il 2020. Peccato però che la quantità di energia (32mila gigawatt)
importata che il Gse (Gestore Servizi Energetici) considera verde possa essere
computato dall’Italia come energia da fonte rinnovabile per il raggiungimento
degli obiettivi europei del 2020. “Le garanzie d’origine non sono sufficienti
per il conteggio del target italiano”, ammette Gerardo Montanino, direttore
operativo di Gse.
La direttiva europea che stabilisce gli obiettivi
del 2020 prevede infatti che uno Paese possa conteggiare l’energia verde
importata solo se c’è uno specifico accordo con il Paese esportatore. Questi
accordi per il momento non ci sono e quindi l’energia verde di cui parla il Gse,
ai fini degli obiettivi del 2020, conta zero. E questo per i prossimi anni,
visto che secondo il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili,
stilato dal ministero dello Sviluppo economico, i primi giga verdi
d’importazione saranno computabili come consumati in Italia solo nel 2016: dei
9mila Gwh previsti, 6mila arriveranno dal Montenegro. Sempre che venga
realizzato un cavo di interconnessione attraverso l’Adriatico. Insomma per gli
obiettivi del 2020 le garanzie d’origine non contano nulla. E ora sembra avere
dubbi sulla loro reale utilità anche il sottosegretario del ministero dello
Sviluppo economico Stefano Saglia, che a Report dice: “Importiamo energia ed è
quasi tutta con certificato di garanzia da fonte rinnovabile, ma invece non lo
è”. Perché, quindi ci si affida tanto all’estero? Come sempre è questione di
soldi.
Un'inchiesta di Report rivela come il cippato per
le centrali a biomasse spesso proviene dall'estero, con notevoli costi
ambientali. Le centrali a biomasse sono utili all'ambiente e all'economia se di
piccole dimensioni e se bruciano residui di boschi e di segherie, in un'ottica
di filiera corta, per rendere autosufficienti i piccoli paesi. La stessa cosa
non si può dire per le centrali di grandi dimensioni, che per essere alimentate
devono acquistare biomasse fuori provincia, fuori regione e perfino all'estero.
A tracciare un quadro di luci e ombre sulle centrali a biomasse è stata
un'inchiesta della trasmissione Report di Milena Gabanelli, che ha riconosciuto
la bontà per il territorio e l'ambiente di un modello basato sulla filiera corta
e, per quanto riguarda le centrali alimentate a legno cippato, basate
sull'utilizzo degli scarti delle segherie locali e del legname recuperato dalla
pulizia dei boschi. Il problema evidenziato è la grande diffusione su tutto il
territorio nazionale delle centrali a biomassa, dovuta anche agli incentivi
statali (certificati verdi, che però a partire dal 2011 non dovranno più pesare
sulla finanza pubblica), con il rischio che in una stessa zona (come in
Garfagnana) ce ne siano troppe. La conseguenza è che in molti acquistano il
legname fuori regione e all'estero, non solo in Europa ma anche da Cile,
Nigeria, Indonesia, Brasile, Argentina, alla faccia della filiera corta.
Trasportare su distanze così grandi il legname comporta alti costi energetici e
ambientali, per non parlare poi dell'aumento dei gas serra causato dal
disboscamento del suolo. Ma i costi diventano anche economici: la carenza di
legno causa l'aumento dei costi dei pannelli per l'arredamento, calano i consumi
e l'industria dei produttori del legno semilavorato rischia di entrare in crisi,
insieme a tutta la filiera dell'arredamento. “Le centrali a biomasse sono
un'ottima idea – ha riassunto la Gabanelli chiudendo la trasmissione - se di
piccole dimensioni e se bruciano residui di boschi e di segherie e utilizzano
tutta l’energia prodotta per riscaldare magari piccoli paesi. Il fine dovrebbe
essere quello di diventare autosufficienti e non di lucrare. Diversamente si
rischia di compromettere un patrimonio, di mettere in crisi un settore
dell’economia, a noi costa di più, e alla fine magari si inquina, quanto con il
gasolio”.
PARLIAMO DI INQUINAMENTO DI STATO.
Il governo italiano con una legge ad hoc ha dato
il via libera al superamento delle soglie di inquinamento dell'aria. Fino al 31
dicembre 2012, nelle città italiane con più di 150mila abitanti, il
benzoapirene, sostanza altamente cancerogena, potrà superare la soglia europea
fissata ad un nanogrammo per metro cubo. Tale livello è stato abrogato con il
Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, approvato, secondo il governo, in
attuazione della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Vediamo nel dettaglio cosa dicono le carte legislative.
Nella realtà dei fatti, la direttiva europea non
parla affatto di Benzoapirene, potente cancerogeno che viene veicolato nei
polmoni dalle polveri sottili e che si origina dalle combustioni delle industrie
e delle auto, ma di altre sostanze. A dircelo è l'articolo 5 comma 1 della
stessa direttiva: "Le soglie di valutazione [...] si applicano al biossido di
zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato (PM10 e
PM2,5), al piombo, al benzene e al monossido di carbonio". Nessuna traccia,
dunque, del Benzoapirene. Solo un pretesto per modificare le normative già in
vigore.
Infatti, tornando indietro nel tempo, risaliamo
alla Direttiva 2004/107/CE, nella quale all'articolo 3 comma 1 si legge: "Gli
Stati membri prendono tutte le misure necessarie, che non comportano costi
sproporzionati, per assicurare che, a partire dal 31 dicembre 2012, le
concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene,
quest'ultimo usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi
policiclici aromatici, valutate ai sensi dell'articolo 4, non superino i valori
obiettivo di cui all'allegato I". Secondo quanto contenuto nell'allegato I, tale
valore è per il Benzoapirene di un nanogrammo per metro cubo.
Il termine del 31 dicembre 2012 era stato
anticipato dal Governo Prodi con il Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152
recante: "Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il
cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente ". Con tale decreto veniva recepita la Direttiva europea e veniva
fissato il limite di concentrazione del Benzoapirene a un nanogrammo per metro
cubo. Qualcosa però deve aver convinto il Governo Berlusconi a tornare suoi
propri passi visto che con l'ultimo decreto in ordine cronologico, vale a dire
il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, vengono concessi ancora due
anni di tempo per adeguarsi alla soglia limite per il benzoapirene. A dircelo è
l'articolo 9 comma 2: "Se, in una o più aree all’interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2 (fra Cui
Il Benzoapirene) superano, sulla base della valutazione di cui all’articolo 5, i
valori obiettivo di cui all’allegato XIII (un nanogranno per metro cubo), le
regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi
espressi dal Coordinamento di cui all’articolo 20, le misure che non comportano
costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione
aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento
dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012". Alla luce dei fatti, le
industrie potranno inquinare il paese, superando la soglia suddetta, fino al 31
dicembre 2012.
Troppo arsenico nell'acqua potabile di 128 Comuni
italiani, soprattutto del Lazio. A nulla è valsa la richiesta del Governo di
derogare ai limiti di legge: la Commissione europea ha negato il permesso e
impone ordinanze per vietarne l’uso alimentare. La Commissione europea ha
respinto la richiesta di deroga ai limiti di legge inoltrata dall'Italia per la
concentrazione di arsenico presente nell’acqua destinata ad uso potabile. In
particolare per quanto riguarda l'arsenico, scrive la Commissione Ue, “occorre
autorizzare unicamente deroghe per valori di arsenico fino a 20 microgrammi al
litro”. Al contrario, finora si poteva derogare fino 50 microgrammi al litro.
Una decisione che riguarda 128 Comuni. Se l’Italia non rispetterà il divieto,
rischia un procedimento davanti alla Corte di Giustizia europea. L'Italia è il
paese europeo dove più frequentemente si è permesso ad alcuni acquedotti di
erogare acqua con valori fino a 5 volte superiori alla legge, in particolare per
arsenico, boro e fluoro. Una pessima abitudine, che ha più volte suscitato
polemiche e creato allarmismi sui potenziali rischi sulla salute. Preoccupazioni
non certo affievolite - come è giusto che sia - dal fatto che le deroghe
riguardino pochi comuni e località che si trovano nelle regioni Lazio, Campania,
Toscana, Umbria, Lombardia e nelle province di Trento e Bolzano (per inciso in
tutti i casi si tratta di sostanze presenti naturalmente nelle falde cui gli
acquedotti attingono). Lo stop ufficiale è arrivato il 28 ottobre 2010, ma già
nei mesi scorsi a pronunciarsi era stato il comitato scientifico della
Commissione europea, lo SCHER (Scientific Committee on Health and Environmental
Risks), che ha in parte confermato le preoccupazioni che riguardano la salute
dei più piccoli, mentre per quanto concerne la popolazione adulta il rischio
sulla salute derivante dalla proroga dei valori derogabili per questi tre
elementi sarebbe molto basso. Nello specifico, per i bambini sotto i 3 anni il
boro assunto bevendo acqua potrebbe facilmente raggiungere il limite massimo
tollerabile, mentre per i bambini e i ragazzi fino a 18 anni non è escluso che
gli effetti negativi dovuti all'arsenico si manifestino già a partire dai 20
microgrammi per litro.
PARLIAMO DI TUTELA DEI DIRITTI
Il Presidente dell’Associazione Contro Tutte le
Mafie, Dr Antonio Giangrande, segnalando il fatto che nel mondo da anni vi sono
sentenze di risarcimento danni da inquinamento, sia esso atmosferico, delle
acque, ambientale o acustico. Addirittura sono stati riconosciuti indennizzi
stratosferici a favore di fumatori consenzienti, come vi sono divieti di fumare
all’aperto per difendersi dal fumo passivo.
Non capisce come si possa continuare a rimanere
succubi di una politica ed amministrazione pubblica inconcludente e subire da
anni un incremento di sofferenza e disagio riconducibile all’inquinamento.
Purtroppo, l’incremento delle malattie
riconducibili a questa tematica, riguarda tutti, anche perché gli effetti, con
il vento o con le correnti, raggiungono distanze inimmaginabili.
Naturalmente ogni iniziativa deve tendere a
salvaguardare gli interessi delle aziende, dei lavoratori, dei cittadini.
INSOMMA: LE AZIENDE NON CHIUDONO, MA PAGANO.
L’azione giudiziaria civile di risarcimento danni
all’ambiente (in forma specifica o per equivalente), ovvero alla persona
(biologici, morali e per “il patema d’animo”), e l’obbligo per le
amministrazioni locali ad emettere ordinanze attinenti oneri per le grandi
aziende a titolo di indennità di ristoro civico e di servitù industriale, dovuto
al loro esercizio, quantunque l’inquinamento sia o fosse al di sotto del limite
legale, porterà un senso di legalità in un territorio martoriato. Resta fermo
l’obbligo per le aziende di adeguarsi ai limiti di emissioni inquinanti, pena il
risarcimento del maggior danno.
Il DANNO AMBIENTALE
Il concetto di danno ambientale ha trovato un suo
chiaro riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico con la L.349/86
("Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale"). In particolare, l’art. 18 della suddetta legge dispone che:
"Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di
disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che
comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento
nei confronti dello Stato" (comma 1).
"Il giudice, ove non sia possibile una precisa
quantificazione del danno, ne determina l’ammontare in via equitativa, tenendo
comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per
il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo
comportamento lesivo di beni ambientali" (comma 6).
"Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone,
ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile"
(comma 8).
La portata delle disposizioni di cui alla L.349/86
non può essere compresa appieno se non attraverso un puntuale riferimento alle
decisioni giurisprudenziali e alla dottrina, che, non di rado, hanno
interpretato tali disposizioni in maniera difforme dalla lettera della legge.
Danni ambientali reversibili
Danni patrimoniali.
Danno emergente: in conformità alla giurisprudenza
e alla dottrina maggioritaria, può essere calcolato come costo per la messa in
sicurezza, bonifica ed ripristino dei siti danneggiati (ex D.M. 471/99);
Lucro cessante: non vi è altro modo di calcolarlo
se non quello di valutare i danni che deriveranno ai richiedenti dalla mancata
realizzazione di profitti in conseguenza dell’evento dannoso. Bisognerà tener
conto anche dei danni ulteriori connessi ai tempi di realizzazione degli
interventi di ripristino dei siti danneggiati, nonché dei c.d. danni indiretti
(danni derivanti dall’alterazione degli ecosistemi).
Danni non patrimoniali.
Danno estetico: può essere calcolato come
percentuale del danno patrimoniale complessivo (danno emergente e lucro
cessante) e va in ogni caso rapportato ai tempi necessari per il ripristino dei
luoghi danneggiati.
A tal fin si può utilizzare un coefficiente (B)
che chiameremo "coefficiente di bellezza e significatività del sito
danneggiato", il cui valore sarà compreso tra 0 e 1.
Danno all’immagine: nelle ipotesi di valutazione
del danno ambientale, abbiamo preferito non creare una voce di danno autonoma
per questo tipo di lesione.
Anzitutto perché non crediamo opportuno
"appesantire" la quantificazione del danno ambientale e la conseguente richiesta
risarcitoria con voci di danno che non hanno ancora trovato unanime
riconoscimento in dottrina e in giurisprudenza (ne risentirebbe la credibilità
dell’intero sistema di valutazione del danno ambientale).
E poi perché il danno all’immagine è comunque
riconducibile a quello da lucro cessante, per le sue componenti patrimoniali, e
al danno estetico per quasi tutto il resto. E’ indubbio che il danno
all’immagine sia altra cosa rispetto al danno estetico, ma il risarcimento del
secondo farebbe senz’altro giustizia anche del primo, soprattutto se nella
determinazione del valore del citato coefficiente B si tiene conto delle
possibili ripercussioni della lesione ambientale sull’immagine dell’ente
richiedente.
Danni ambientali irreversibili
Danni patrimoniali.
Danno emergente: trattandosi di danno ambientale
irreversibile e non potendo ipotizzarsi un ripristino dello status quo ante, può
essere calcolato come costo per la creazione di un habitat simile a quello
preesistente o come costo per la creazione dell’habitat danneggiato in altro
sito.
Lucro cessante: v. danni reversibili. Ovviamente,
qui i danni ulteriori andranno proporzionati ai tempi di realizzazione degli
interventi precedenti.
Danni non patrimoniali.
Danno estetico; vedi danno reversibili;
Danno all’immagine: vedi danni reversibili.
IL DANNO PERSONALE: LEGITTIMAZIONE ALL’AZIONE DEL
SINGOLO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE
Sentenza 2 maggio 2007, n. 16575
Il danno ambientale presenta una triplice
dimensione:
- personale (quale lesione del diritto
fondamentale dell'ambiente di ogni uomo);
- sociale (quale lesione del diritto fondamentale
dell'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana,
ex art. 2 Cost.);
- pubblica (quale lesione dei diritto-dovere
pubblico delle istituzioni centrali).
In questo contesto persone, gruppi, associazioni
ed anche gli enti territoriali non fanno valere un generico interesse diffuso,
ma dei diritti, ed agiscono in forza di una autonoma legittimazione.
Integra il danno ambientale risarcibile anche il
danno derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilità di una risorsa
ambientale intatta, ossia le c.d. "perdite provvisorie", perché qualsiasi
intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può mai
eliminare quello speciale profilo dì danno conseguente alla perdita di
fruibilità della risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita, danno che
si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuta e che perdura per
tutto il tempo necessario a ricostituire lo status quo.
La Cassazione, con un sentenza che vi consiglio
vivamente di leggere d’un fiato (potere liberamente scaricare la sentenza della
Corte di Cassazione Civile n. 11059/09 ha statuito, invece, e per fortuna
giuridico-ambientale, che è giuridicamente corretto inferire l’esistenza di un
danno non patrimoniale, ravvisato nel patema d’animo indotto dalla
preoccupazione per il proprio stato di salute e per quello dei propri cari, ove
tale turbamento psichico sia provato in via documentale.
Il danno non patrimoniale può essere provato anche
per presunzioni e la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto
ignoto da dimostrare sia l’unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo
sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell’uno in dipendenza
dell’altro, secondo criteri di regolarità causale.
Si tratta, del resto di principi affermati già in
passato (Cass. Sez. Un. civ. n. 2515/2002, in caso di compromissione
dell’ambiente a seguito di disastro colposo - art. 449 c.p.) nel caso del
verificarsi di un delitto di pericolo presunto a carattere plurioffensivo: qui
la Cassazione sottolineava che alla lesione dell’interesse adespota all’ambiente
ed alla pubblica incolumità, si affianca il pregiudizio causato alla sfera
individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i
luoghi interessati dall’evento dannoso, in ragione della loro residenza o
frequentazione abituale. Ove sia dimostrato che tale relazione è stata causa di
uno stato di preoccupazione è configurato il danno non patrimoniale in capo a
detti soggetti, danno risarcibile in quanto derivato da reato.
In armonia con un’altra decisione della Cassazione
(Cass. Sez. Un. civ. n. 26972/2008) il giudice di legittimità delle leggi ha,
inoltre, stabilito che va esclusa l’autonomia del c.d. danno esistenziale, il
quale non rappresenta altro che una delle voci del danno non patrimoniale.
Nel caso in cui il fatto illecito, da cui è
derivato il danno, si configuri come reato, il danno non patrimoniale è
risarcibile nella sua più ampia accezione di danno determinato da lesioni di
interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
INDENNIZZO PER SERVITU’ INDUSTRIALE
In diritto si definisce servitù (o servitù
prediale) un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, consistente in
"un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a
diverso proprietario" (art. 1027 del codice civile).
L'utilità del fondo dominante, presente o futura,
è estremo essenziale della servitù: può consistere nella maggiore comodità del
fondo, può anche essere inerente alla sua destinazione industriale. Per questo
si parla di Servitù Industriale. Tuttavia, deve sempre essere utilità di un
fondo, non quello personale del proprietario. In quest’ultima ipotesi si ha un
un diritto personale di godimento, la cosiddetta servitù aziendale.
INDENNITA’ DI RISTORO CIVICO
Tributo locale a carattere amministrativo per
speciali prestazioni (servitù atipica).
PARLIAMO DI DISASTRI IDROGEOLOGICI.
La natura non fa sconti. Prima o poi, gli errori
ricadono addosso a chi li ha compiuti. Seminando la morte, come a Messina.
Ciò che riceve, restituisce. Nel bene come nel
male. Una terra tutelata restituisce una sicura protezione idrogeologica.
Una terra violentata non può far altro che
produrre altra violenza. Non perché sia matrigna, ma perché l’uomo le ha
sottratto gli strumenti per proteggere proprio se stesso.
Non c’è bisogno di evocare lo spettro di Sarno,
con le sue 140 frane e i suoi 137 morti nel maggio 1998. Basta guardare il 2009.
Frane e quattro morti al Nord, due a Borca di Cadore (18 luglio). Due vittime
nel Trapanese per un nubifragio (2 febbraio). Due operai morti sotto una frana a
Caltanissetta (28 gennaio). Frane in tutto il Sud, chiusi 60 chilometri di
autostrada (29 gennaio). Due morti e quattro feriti per una frana sulla
Salerno-Reggio Calabria (25 gennaio). Poco prima, alla fine del 2008, gli
spettacolari danni e l’autentico terrore di Roma per la clamorosa piena del
Tevere (dicembre 2008). Inferno d’acqua a Cagliari, tre morti (22 ottobre).
Maltempo: due morti, Valtellina isolata (13 luglio). Po e Dora, rotti gli
argini, ponti bloccati e scuole chiuse. E si potrebbe continuare tristemente
così, con titoli sempre uguali, lì a dimostrare che la natura non fa sconti.
La ricetta del disastro è precisa. Si prende un
territorio come l'Italia, con 7 Comuni su 10 a rischio idrogeologico. Si
spargono case abusive a profusione, possibilmente nelle aree in cui si espandono
fiumi e torrenti in piena. S'immettono in atmosfera gas serra, quanto basta per
modificare il ciclo idrico e produrre piogge interminabili e violente. Poi si
aspetta. Non a lungo.
Case dichiarate inagibili e nessun controllo.
Scarsa manutenzione e fondi investiti male. Così, la tragedia di Messina del 1
ottobre 2009 passa sotto inchiesta e diventa disastro colposo con decine di
morti.
Il rischio frane e alluvioni interessa
praticamente tutto il territorio nazionale. Come ben documentato in "Ecosistema
a rischio", edizione novembre 2008, secondo l'indagine a cura di Legambiente e
la Protezione civile sono ben 5.581 i comuni a rischio idrogeologico, il 70% del
totale dei comuni italiani, di cui 1.700 a rischio frana, 1.285 a rischio di
alluvione e 2.596 a rischio sia di frana che di alluvione.
Il nostro territorio è reso ancora più fragile
dall’abusivismo, dal disboscamento dei versanti e dall’urbanizzazione
irrazionale. Sono la Calabria, l’Umbria e la Valle d’Aosta le regioni con la più
alta percentuale di comuni classificati a rischio (il 100% del totale), subito
seguite dalle Marche (99%) e dalla Toscana (98%). Sebbene in molte regioni la
percentuale di comuni interessati dal fenomeno possa apparire ridotta, la
dimensione del rischio è comunque preoccupante. In Sardegna e in Puglia, ad
esempio, nonostante la percentuale dei comuni a rischio sia tra le più basse
d’Italia, le frane e le alluvioni degli ultimi anni hanno provocato vittime e
notevoli danni.
Oltre a tanti piccoli comuni, anche molte delle
grandi metropoli e città italiane sono considerate a rischio idrogeologico come
risulta dallo studio del Ministero dell’Ambiente e dell’UPI.
Questi dati mettono in luce chiaramente la
fragilità di un territorio in cui semplici temporali, provocano continui
allagamenti e disagi per la popolazione. Una situazione che deriva soprattutto
dalla pesante urbanizzazione che ha subito l’Italia, in particolare lungo i
corsi d’acqua.
Complessivamente sono ancora troppe le
amministrazioni comunali italiane che tardano a svolgere un’efficace ed adeguata
politica di prevenzione, informazione e pianificazione d’emergenza. Appena il
37% dei comuni intervistati svolge un lavoro positivo di mitigazione del rischio
idrogeologico. Un comune su quattro non fa praticamente nulla per prevenire i
danni derivanti da alluvioni e frane. Sono ben 787 le amministrazioni comunali
che risultano svolgere un lavoro di prevenzione del rischio idrogeologico
complessivamente negativo.
Si chiedono in molti come sia possibile che gli
organi preposti non comprendano ciò che Legambiente o semplici cittadini
denunciano... Potremmo rispondere che è la normalità se l'avversario è un
potente.
E per potente non si intende il capo del governo,
tanto per citare uno che va per la maggiore... Per essere intoccabili basta
possedere terreni edificabili, frequentare circoli nautici o casinò, aver
frequentato gli stessi istituti di un magistrato... Potente è colui che
costruisce palazzine anche in luoghi impossibili per costruttori "normali" e
che può mettere a disposizione agli amici degli amici, appartamenti a prezzo
stracciato o imprese per lavori gratuiti in ville; potente è il medico che cura
gli interessi e la salute di altri potenti e all'occasione può aiutare a
eliminare anche gravidanze scomode; potente è quel personaggio che mette in
contatto universi apparentemente lontani (lecito con l'illecito); potente è
colui che ha conoscenze al Fallimentare o alla Commissione Tributaria...
Dunque abbiamo dimostrato come fare chiudere gli
occhi a qualche controllore. Il sacco edilizio ha precisi responsabili, che,
grazie alle coperture e complicità di cui godono tutt'ora, non hanno mai pagato
in Tribunale per le loro colpe.
E che vengano oggi certi inviati nazionali a farci
la morale - dopo che hanno omesso per anni di scrivere su talune vicende
giudiziarie per non avere problemi - ci fa indignare ancora di più: tenetevi i
vostri trenta denari di Giuda e non parlate agli italiani onesti che combattono
ogni giorno in trincea, di etica e morale.
Sommersi da frane e fango. Dalla Toscana alla
Sicilia, il dissesto continua a uccidere. Ma gli interventi per sanare il
territorio restano fermi, tra sprechi e scandali. Ecco perché, raccontato
dall'Espresso.
Acqua e fango continuano a uccidere indisturbati.
Dopo Messina, è toccato a Ischia. Nel 2009 le alluvioni hanno cancellato il
Natale di migliaia di famiglie e tenuto prigionieri del mare centinaia di
turisti a Capodanno, da Capri alle Eolie. In Toscana l'attesa del 2010 è stata
scandita dalla piena del lago di Puccini, il Massaciuccoli, un conto alla
rovescia per scongiurare un disastro annunciato. Stessa scena in Liguria,
Sardegna, Lazio e Campania. Addirittura i botti hanno lasciato posto a tuoni e
tempeste, morti e feriti sono stati quelli dell'acqua e non più dei fuochi
d'artificio. E quando è finita la pioggia sono arrivati neve e gelo. I
meteorologi lo chiamano "tempo estremo" ma ormai di estremo ha davvero poco. È
sempre la stessa tragedia italiana che si ripete quando il cielo diventa nero.
Carmine Abate aveva 44 anni, era lo chef di un
ristorante della Costiera amalfitana e stava preparando il pranzo quando il
costone roccioso l'ha travolto. Qualche settimana prima era toccato ad Anna,
aveva 15 anni e stava andando a scuola. È annegata dentro l'auto ai piedi del
monte Epomeo sotto gli occhi dei genitori. Ma la lezione sembra non servire.
Basta ritornare a Sarno, dove il fango fece 160 vittime e i lavori sono finiti
al 90 per cento. Progetti alla mano, ci sarebbe da stare tranquilli. Si vedono i
canali di cemento pronti a imprigionare l'acqua e grandi vasche capaci di
raccogliere la terra lavica sciolta in fango. Mancano ancora le case, c'è gente
che aspetta da quel 5 maggio 1998, ma nell'Italia delle cattedrali nel deserto
averci messo un decennio è considerato un record.
Eppure non è così. È sufficiente spostarsi di
qualche chilometro, a San Felice a Cancello sull'altro versante dell'Appennino,
e guardare in alto. La montagna franò quella stessa notte, ma i lavori in quota
non sono nemmeno cominciati e quelli a valle non sono finiti. Il vecchio alveo
Arena che dal Seicento faceva defluire le acque dalla collina Cancello è ridotto
a un rigagnolo. Erbacce, detriti e rifiuti ne ostruiscono il corso. L'effetto di
un appalto da 23 milioni lasciato a metà. Muri come totem eretti nel bel mezzo
della campagna, finché c'erano i soldi e poi abbandonati: puoi correrci in
macchina dentro la conduttura di scolo che scende dal monte Sant'Angelo. Passa
in mezzo a case, giardini, strade comunali per poi finire nel nulla. L'acqua si
accumula nella cava di San Felice, una di quelle descritte in "Gomorra",
coprendo immondizia, copertoni, eternit, carcasse di cani e gatti uccisi dai
topi. Il sindaco Pasquale De Lucia ha scritto all'Arcadis, l'Agenzia che dal 30
aprile ha sostituito il commissario per l'emergenza di Sarno: «Rileviamo con
sconcerto e vergogna che i lavori sono in corso di realizzazione e, fatto ancora
più grave, non è dato sapere in che tempi e in che modi gli stessi si
concluderanno». Ma i responsabili sono già cambiati, i vecchi uffici
smantellati, gli operai scomparsi.
Questa è solo una delle tante storie, dell'Italia
che non fa prevenzione. L'ultima denuncia in ordine di tempo arriva dalla Corte
dei conti, che ha censito i cantieri fantasma del piano idrico nazionale. Sono
opere che oltre a mettere in sicurezza il territorio dovrebbero trasformare quei
fiumi d'acqua killer in riserve per i periodi di siccità. Eppure nel Paese dove
sette comuni su dieci sono a rischio alluvioni e dove il caldo incenerisce
migliaia di ettari di bosco, restano un miraggio. Sono stati approvati progetti
per 1,1 miliardi di euro, i fondi del Cipe ci sono, ma i lavori non partono. E
se partono, non finiscono mai.
Lo scenario peggiore è al Sud, dove sono arrivati
330 milioni: «Dei 21 decreti di concessione emessi, ne risulta collaudato uno
soltanto», scrive la Corte dei conti. Non va molto meglio nella pianura Padana,
dove i milioni messi sul piatto sono 770: «Su 45 opere finanziate, ne risultano
poste in esercizio 24». Poco più della metà. Per misurare la gravità della
situazione, basterebbe un raffronto: l'ex Cassa del Mezzogiorno, che spese 140
miliardi di euro in decenni di sprechi e ruberie, oggi è quella che grida allo
scandalo: «Al Sud la situazione è tragica », dice il commissario ad acta Roberto
Iodice, l'ingegnere con le lenti spesse che ha ereditato il ramo irrigazione del
vecchio baraccone (diventato Agensud e poi soppresso nel 1993 da Giuliano
Amato), col compito di attuare in fretta il piano nazionale e poi fare le
valigie. Bene, lui è ancora al suo posto e non ci riesce proprio a sbrigare le
pratiche. Nel ginepraio di enti che si rimpallano le competenze, spesso i soldi
di canali e dighe non fanno in tempo ad arrivare ai consorzi di bonifica,
incaricati di indire le gare, che già si sono volatilizzati. La cosa incredibile
è che il meccanismo è perfettamente legale. Ecco come fanno.
Dei 60 enti che operano nel Meridione (su 120 in
tutto), circa il 25 per cento è oberato dai debiti e firma bilanci in rosso, fra
bonifiche mai completate e impianti fatiscenti. Non appena Bankitalia gira i
fondi per le opere, a riscuoterli si presentano i creditori con i documenti in
mano: «A volte arrivano pochi minuti dopo l'erogazione. Ma ci rendiamo conto?»,
dice il commissario. Così i soldi pubblici finiscono in tasca ai privati, a
Equitalia, all'Inps con la copertura delle stesse leggi che li avevano stanziati
per opere di interesse nazionale. «Questo al di là che i debiti dichiarati siano
reali, le manutenzioni descritte nei consuntivi siano davvero avvenute e i costi
per l'irrigazione siano conformi. Spesso le gestioni sono disinvolte », ammette
Iodice, che da anni chiede al Parlamento di vietare i pignoramenti per quei
fondi senza che Roma abbia mai varato una legge.
Quando i soldi arrivano finalmente a destinazione,
spesso l'iter si ferma di nuovo. La ditta che ha vinto dichiara, pochi mesi
dopo, di non avere abbastanza quattrini per finire il lavoro e invoca una
variante, poi un'altra e un'altra ancora. I contenziosi sono tanti. Ci sono
pendenze di fronte ai tribunali di Salerno, Eboli, Potenza, Campobasso,Vallo
della Lucania, Avellino, Bari e Pescara. Decine di istruttorie, revoche di
appalti già concessi (ne sono in corso 93), ricorsi contro ditte inadempienti
(ce ne sono 38 già aperti), procedure di recupero per oltre 50 milioni di euro.
Al Sud sette appalti su dieci vengono aggiudicati con ribassi del 35-40 per
cento in Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna quando nel Nord si
scende al massimo del 20 per cento. «Significa che c'è un risparmio », si
giustificano le imprese in gara. Non è così.
I prezzi ritoccati servono ad aggiudicarsi il
lavoro ma non a finirlo. E la lista è lunga. A Olbia è tutto fermo: la rete
idrica che doveva unire il nuovo depuratore al distretto nord della cittadina è
rimasta sulla carta, con la risoluzione dei contratti a gara avvenuta. A Nurra
piove, ma il progetto da oltre 12 milioni per il recupero delle acque di Sassari
è stato assegnato a una ditta che non ha mai nemmeno montato le impalcature.
Strano per una delle regioni più a rischio, dove a settembre è morto Andrea
Pira, pastore di 38 anni, travolto dalle acque di un torrente. Anche in Puglia
ci sono i progetti, ma non si lavora. La vasca di accumulo a Lama di
Castellaneta è rimasta sulla carta, pur con 11 milioni già erogati e un
bollettino di strade allagate, ferrovie interrotte e ospedali fuori uso per le
alluvioni di ottobre. A Catania non è mai partita la sistemazione del canale
Cavazzini, un cantiere da 25 milioni vinto con un ribasso del 32 per cento.
Troppo: «La ditta che si è aggiudicata il lavoro ci ha chiesto prima ancora di
partire di modificare il materiale della condotta principale, perché quello
previsto dal loro stesso progetto costava troppo», spiegano all'ex Agensud.
«Sono cose incredibili, che avvenivano in passato. Oggi la legge Merloni lo
vieta, l'iter si ferma per anni e si deve ricominciare da zero».
Piemonte, Veneto e Lombardia stanno un po' meglio.
Hanno avviato tutte le procedure, anche se si lavora a rilento. Le opere in
funzione sono ancora troppo poche, secondo i giudici contabili. Così pure in
Toscana e in Emilia Romagna: «Nella maggior parte dei casi non sono rispettate
le date di consegna, dilatate dalle proroghe concesse e dalle varianti», dice la
Corte dei conti. Che nella pratica significa che ci sono cantieri ancora aperti
lungo l'Adda o il Po, che gli impianti irrigui in prossimità di fiumi e laghi
non sono pronti, pur progettati da anni, che molta acqua è fuori controllo o
viene sprecata, con danni all'agricoltura e rischi per gli abitanti. Dei quattro
interventi da 127 milioni classificati come urgenti dal piano idrico, nessuno è
stato ancora collaudato. Si tratta di dighe, come quella di Montedoglio in
Valdichiara. Ma c'è anche il dolo. Come a Genova dove il torrente Bisagno è
coperto da viale Brigate Partigiane, proprio dove le acque invasero la città
durante l'alluvione del 1970 che uccise 44 persone. Il Comune sta spendendo 170
milioni per aumentare la portata eppure a monte si continua a edificare.
A La Spezia, a pochi chilometri dalla foce del
Magra, l'Anas progetta uno svincolo stradale: «Più del 70 per cento dei Comuni
realizza opere di messa in sicurezza che aumentano la fragilità del territorio
invece che diminuirla », denuncia Legambiente. Addirittura i controlli
anti-mafia finiscono per bloccare gli appalti.
Capita che in gara ci siano aziende con tutte le
carte in regola che poi lasciano i lavori a metà, fuggendo con i quattrini.
Mentre le ditte che hanno sempre portato a termine i cantieri si trovano
eliminate a causa di ricorsi ad hoc, che si appigliano a timbri e vizi di forma.
È successo a Salerno con un'impresa veneta: «Alcune dichiarazioni emesse per
ottenere i requisiti certificavano lavori non effettuati, che tuttavia nulla
centravano col tipo di opera messa a gara. Così abbiamo dovuto bloccare tutto e
ricominciare. Con l'assurdo che, chi le carte le ha in regola spesso non
costruisce », denuncia il commissario: «È giusto fare i controlli, ma devono
essere finalizzati a far meglio e non peggio ». Metteteci anche l'Ance,
l'associazione dei costruttori, che sempre più spesso al Sud si rivolge al Tar
se il bando non contiene l'aggiornamento dei prezzi a carico delle Regioni e
perennemente in ritardo. Un problema che al Nord si supera alzando le offerte ed
evitando così di perdere anni per una manciata di euro. E che in Sicilia finisce
davanti al giudice. Gli ultimi tre casi a Catania, Trapani e Caltanissetta con
altrettanti canali mai realizzati. «Qualcuno ci marcia», tuona Iodice: «Ora
dovremo aggiornare i progetti, ripetere i bandi, le assegnazioni e i pareri. Con
costi enormi e tempi lunghissimi». Come se fango e frane possono attendere le
lungaggini della giustizia italiana per tornare a colpire.
ECOMAFIE
ECOMAFIE: 70 REATI AL GIORNO E UN BUSINESS DA 20
MILIARDI DI EURO
Una montagna di rifiuti speciali alta come l’Etna
(3.100 metri, pari a 31 milioni di tonnellate) inghiottita dalla terra. 28mila
edifici abusivi, interi quartieri, costruiti in un anno. E 25.776 reati
accertati contro l’ambiente, per un giro d’affari complessivo sopra i 20
miliardi di euro, un quinto circa del fatturato globale delle mafie. Cifre e
immagini evocative date dall’ultimo rapporto sulle ecomafie in Italia stilato da
Legambiente. Crescono le agromafie, il racket degli animali, il traffico di
rifiuti pericolosi. Altro grande business delle ecomafie è poi l’abusivismo
edilizio e i reati contro il patrimonio naturale.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Nelle otto maggiori città italiane l'inquinamento
atmosferico urbano è stato responsabile nell'anno 2000 di 3.472 decessi, 4.597
ricoveri ospedalieri, decine di migliaia di casi di disturbi bronchiali e
asmatici ogni anno, 10 morti al giorno per smog.
I dati, che vennero discussi da Legambiente e Oms
nel corso di un seminario su "Inquinamento urbano e salute in Italia e in
Europa: dall'evidenza dei dati all'urgenza delle politiche", appaiono
drammaticamente gravi.
Lo studio del Centro Europeo Ambiente e Salute
dell'Oms mette infatti in evidenza l'impatto sulla salute dei cittadini delle
alte concentrazioni di inquinanti nell'aria delle città italiane calcolando le
morti, i ricoveri ospedalieri ed i casi di malattia imputabili alle
concentrazioni medie di PM10 (la frazione respirabile delle polveri che grazie
al piccolo diametro può arrivare sino alle vie più profonde portandosi dietro
sostanze altamente inquinanti e spesso cancerogene come il benzoapirene.
L'attuale normativa europea che si pone così
all'avanguardia in Italia e in Europa, stabilisce provvedimenti di limitazione
della circolazione quando il limite di attenzione di 50 microgrammi per metro
cubo di polveri giornalieri viene superato per più giorni di seguito, e il
blocco totale della circolazione in caso di superamento del livello di allarme
pari a 100 microgrammi per metro cubo.
Per quanto riguarda la media annuale, invece, la
normativa europea fissa un limite di 40 microgrammi per metrocubo che si prevede
di portare ad uno standard (entro il 2010) di 20m g/m3. L'impatto
dell'inquinamento da PM10 sulla salute dei residenti stimato nelle 8 maggiori
città italiane, ha rivelato che nella popolazione di oltre trenta anni, il 4.7%
di tutti i decessi osservati nel 1998, pari a 3.472 casi, è attribuibile al PM10
in eccesso di 30m g/m3. Se ne desume che riducendo il PM10 ad una media di 30m
g/m3 si potrebbero prevenire circa 3.500 morti all'anno soltanto nelle otto
città più grandi.
Si aggiungono inoltre stime di migliaia di
ricoveri per cause respiratorie e cardiovascolari, e decine di migliaia di casi
di bronchite acuta e asma fra i bambini al di sotto dei quindici anni, che
potrebbero essere evitati riducendo le concentrazioni medie di PM10 a 30m g/m3.
"La salute pubblica va salvaguardata con ogni mezzo, dichiarò durante il
convegno il presidente uscente nazionale di Legambiente Ermete Realacci,
"Amministratori e sindaci dovrebbero impegnarsi in maniera decisiva affinché
quello dell'inquinamento non sia più il principale male delle nostre città.
Migliorare la mobilità, rendere più veloci i percorsi degli autobus proteggendo
le corsie preferenziali, sostenere l'uso di mezzi alternativi: dal car-sharing
all'auto in multiproprietà, fino alla sperimentazione di veicoli alimentati con
tecnologie più moderne e ecocompatibili, sono tutti possibili interventi per
contenere l'inquinamento atmosferico e per ottenere importanti ricadute in
termini di salute e di costi sociali. In merito si potrebbe dare la parola ai
cittadini con i referendum consultivi in tema di traffico e mobilità".
"I nostri dati", spiegava Roberto Bertollini,
direttore del Centro Europeo Ambiente e Salute dell'OMS, "dimostrano la gravità
dell'inquinamento atmosferico nelle città italiane. Questo studio non considera
che una parte del problema (alcuni effetti delle polveri fini) e fornisce
verosimilmente una sottostima, ma è ormai evidente che migliaia di cittadini
italiani di tutte le età che vivono nelle grandi città si ammalano e muoiono a
causa dell'inquinamento urbano che si somma e moltiplica gli effetti di altri
fattori di rischio per la salute. Decine di migliaia di attacchi d'asma e casi
di bronchite acuta nei bambini sono evitabili.
E sfortunatamente il problema è condiviso dalle
città italiane con altre metropoli europee, come dimostrato da un recente studio
pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet ed effettuato con la stessa
metodologia da noi impiegata in Italia. Occorre promuovere politiche di
contenimento delle emissioni che coinvolgano i cittadini, e che mirino ad una
effettiva e duratura riduzione dell'inquinamento atmosferico che nelle città
italiane è principalmente e per gran parte dell'anno associato al traffico
veicolare". I benefici potenzialmente raggiungibili dipendono naturalmente da
quanto si riducono le concentrazioni. Con abbassamenti più o meno accentuati, i
benefici sarebbero in proporzione. Ad esempio per la mortalità (ma analoghe
considerazioni valgono per tutti gli esiti sanitari) riducendo l'inquinamento a
40m g/m_ sarebbe possibile evitare circa 2000 morti; riducendolo a 30m g/m
sarebbe possibile evitarne circa 3500; riducendo l'inquinamento a 20m g/m_
sarebbe possibile evitare circa 5500 morti.
Uno studio condotto nel 2000 in Austria, Francia e
Svizzera sui costi sanitari dell'inquinamento atmosferico ha evidenziato che il
numero dei casi di bronchite acuta nei bambini attribuibili all'inquinamento
atmosferico (PM10 in totale) sono ben 543.300, di cui 300.000 dovuti proprio
allo smog generato dal traffico veicolare. Dei 37.800 ricoveri ospedalieri
determinati dall'inquinamento atmosferico, ben 25.000 sono dovuti ai veleni
prodotti dal traffico, così come 162.000 casi di attacchi di asma nei bambini
(sul totale di 300.900).
Su 30.5 milioni di giorni lavorativi ridotti a
causa di malattie respiratorie, ben 16 milioni sono generati dall'inquinamento
da traffico, mentre per la mortalità nei tre paesi, lo studio fornisce oltre
40.500 casi di cui 21.000 attribuibili sempre allo smog da traffico. Nei tre
Paesi l'inquinamento atmosferico riconducibile al traffico veicolare produce
costi per 27 miliardi di Euro l'anno, pari a 360 Euro pro capite.
INQUINAMENTO DELLE ACQUE
Contaminazione dell’acqua causata dall’immissione
di sostanze quali prodotti chimici e scarichi industriali e urbani, che ne
alterano la qualità compromettendone gli abituali usi.
Alcuni dei principali inquinanti idrici sono: le
acque di scarico contenenti materiali organici che per decomporsi assorbono
grandi quantità di ossigeno; parassiti e batteri; i fertilizzanti e tutte le
sostanze che favoriscono una crescita eccessiva di alghe e piante acquatiche; i
pesticidi e svariate sostanze chimiche organiche (residui industriali,
tensioattivi contenuti nei detersivi, sottoprodotti della decomposizione dei
composti organici); il petrolio e i suoi derivati; metalli, sali minerali e
composti chimici inorganici; sabbie e detriti dilavati dai terreni agricoli, dai
suoli spogli di vegetazione, da cave, sedi stradali e cantieri; sostanze o
scorie radioattive provenienti dalle miniere di uranio e torio e dagli impianti
di trasformazione di questi metalli, dalle centrali nucleari, dalle industrie e
dai laboratori medici e di ricerca che fanno uso di materiali radioattivi.
Anche il calore liberato nei fiumi dagli impianti
industriali e dalle centrali elettriche attraverso le acque di raffreddamento
può essere considerato un inquinante, in quanto provoca alterazioni della
temperatura che possono compromettere l’equilibrio ecologico degli ecosistemi
acquatici e causare la morte degli organismi meno resistenti, accrescere la
sensibilità di tutti gli organismi alle sostanze tossiche, ridurre la capacità
di autodepurazione delle acque, aumentare la solubilità delle sostanze tossiche
e favorire lo sviluppo di parassiti.
Le sostanze contaminanti contenute nell’acqua
inquinata possono provocare innumerevoli danni alla salute dell’uomo e
all’equilibrio degli ecosistemi. La presenza di nitrati (sali dell’acido
nitrico) nell’acqua potabile, ad esempio, provoca una particolare condizione
patologica nei bambini che in alcuni casi può condurre alla morte. Il cadmio
presente in certi fanghi usati come fertilizzanti può essere assorbito dalle
colture e giungere all’uomo attraverso le reti alimentari; se assunto in dosi
elevate, può provocare forti diarree e danneggiare fegato e reni. Tra gli
inquinanti più nocivi per l’uomo vi sono alcuni metalli pesanti, come il
mercurio, l’arsenico, il piombo e il cromo.
Gli ecosistemi lacustri sono particolarmente
sensibili all’inquinamento. L’eccessivo apporto di fertilizzanti dilavati dai
terreni agricoli può avviare un processo di eutrofizzazione, cioè di crescita
smodata della flora acquatica. La grande quantità di alghe e di piante
acquatiche che si viene a formare deturpa il paesaggio, ma soprattutto, quando
si decompone, consuma l’ossigeno disciolto nell’acqua, rende asfittici gli
strati più profondi del lago e produce odori sgradevoli. Sul fondo del bacino si
accumulano sedimenti di varia natura e nelle acque avvengono reazioni chimiche
che mutano l’equilibrio e la composizione dell’ecosistema (quando le acque sono
molto calcaree si ha, ad esempio, la precipitazione di carbonato di calcio).
Un’altra fonte di inquinamento idrico è costituita dalle cosiddette piogge
acide, che hanno già provocato la scomparsa di ogni forma di vita da molti laghi
dell’Europa settentrionale e orientale e del Nord America.
Gli inquinanti delle acque provengono soprattutto
dagli scarichi urbani e industriali, dai processi di percolazione, dai terreni
agricoli e dalle aziende zootecniche.
Le acque di scarico urbane e industriali
rappresentano una delle fonti principali di inquinamento idrico. Finora
l’obiettivo primario dei programmi di smaltimento degli scarichi urbani è stato
quello di ridurre la concentrazione delle sostanze solide in sospensione, dei
materiali organici, dei composti inorganici disciolti (soprattutto quelli
contenenti fosforo e azoto) e dei batteri nocivi presenti nei liquami immessi
negli impianti di depurazione, per potere, poi, scaricare le acque depurate
nell’ambiente. Da qualche tempo, tuttavia, una maggiore attenzione viene rivolta
anche al delicato problema del trattamento e dello smaltimento dei fanghi che si
producono nei processi di depurazione.
Nei moderni depuratori i liquami passano
attraverso tre fasi distinte di trattamento. La prima, detta trattamento
primario, comprende una serie di processi fisici o meccanici di rimozione dei
detriti più grossolani, di sedimentazione delle particelle in sospensione e di
separazione delle sostanze oleose. Nella seconda fase, detta trattamento
secondario, si ossida la materia organica dispersa nei liquami per mezzo di
fanghi attivi o filtri biologici. La terza fase, il trattamento terziario, ha lo
scopo di rimuovere i fertilizzanti per mezzo di processi chimico-fisici, come
l’assorbimento su carbone attivo. In ogni fase vengono prodotte notevoli
quantità di fanghi, il cui trattamento e smaltimento assorbe il 25-50% dei costi
di impianto e di esercizio di un comune depuratore.
Gli scarichi industriali contengono una grande
varietà di inquinanti e la loro composizione varia a seconda del tipo di
processo produttivo. Il loro impatto sull’ambiente è complesso: spesso le
sostanze tossiche contenute in questi scarichi rinforzano reciprocamente i
propri effetti dannosi e quindi il danno complessivo risulta maggiore della
somma dei singoli effetti. La concentrazione di inquinanti può essere ridotta
limitandone la produzione all’origine, sottoponendo il materiale a trattamento
preventivo prima di scaricarlo nella rete fognaria o depurando completamente gli
scarichi presso lo stesso impianto industriale, recuperando, eventualmente, le
sostanze che possono essere reintrodotte nei processi produttivi.
I fertilizzanti chimici usati in agricoltura e i
liquami prodotti dagli allevamenti sono ricchi di sostanze organiche (contenenti
soprattutto azoto e fosforo) che, dilavate dalla pioggia, vanno a riversarsi
nelle falde acquifere o nei corpi idrici superficiali. A queste sostanze si
aggiungono spesso detriti più o meno grossolani che si depositano sul fondo dei
bacini. Pur contenendo spesso organismi patogeni, i liquami di origine animale
vengono scaricati a volte direttamente sul terreno e da qui sono trasportati
dall’acqua piovana nei fiumi, nei laghi e nelle falde sotterranee. In questo
caso, per limitare l’impatto degli inquinanti si possono adottare semplici
soluzioni, come l’uso di bacini di decantazione o di vasche per la depurazione
dei liquami.
L’inquinamento del mare è dovuto alle immissioni
accidentali o intenzionali di petrolio e oli combustibili, all’apporto di
sostanze inquinanti trasportate dai corsi d’acqua e agli scarichi degli
insediamenti costieri. Questi ultimi, in particolare, contengono ogni sorta di
contaminanti (metalli pesanti, sostanze chimiche tossiche, materiale
radioattivo, agenti patogeni) e spesso sono all’origine di epidemie di tifo,
colera, salmonellosi e altre malattie infettive. Gli inquinanti vengono
trasportati dalle correnti marine lungo le coste e in alto mare, a media e lunga
distanza. Ovviamente, la contaminazione dei mari varca le frontiere delle acque
territoriali dei singoli stati ed è oggetto di trattati internazionali che
mirano a limitarne l’entità.
Il petrolio e gli oli combustibili riversati in
mare formano sulla superficie dell’acqua pellicole oleose che, impedendo
l’assorbimento dell’ossigeno atmosferico, provocano morie di organismi marini.
Nel petrolio, inoltre, sono presenti anche idrocarburi aromatici che possono
costituire un grave pericolo per la salute dell’uomo, al quale giungono
attraverso la catena alimentare marina. La fonte dell’inquinamento, in questo
caso, è data dai riversamenti di grandi quantità di greggio dalle petroliere
coinvolte in incidenti, dal deliberato rilascio di piccole quantità di derivati
del petrolio da navi di vario tipo e dalle perdite di petrolio che si verificano
nel corso delle operazioni di trivellazione presso le piattaforme petrolifere
marine. Si calcola che per ogni milione di tonnellate di petrolio trasportate
via mare, una tonnellata vada dispersa a causa di riversamenti di varia natura.
Il pericolo maggiore è rappresentato dagli
incidenti che non di rado interessano le superpetroliere. Nel 1978 la petroliera
Amoco Cadiz riversò in mare, al largo delle coste francesi, 1,6 milioni di
barili di greggio; nel 1979 dal pozzo petrolifero Ixtoc I, nel golfo del
Messico, fuoriuscirono 3,3 milioni di barili. I 240.000 barili di greggio
riversati dalla Exxon Valdez nella baia di Prince William, nel marzo del 1989,
si estesero in tutta l’insenatura formando una macchia oleosa di ben 6770 km²
che compromise l’esistenza di molte specie marine e danneggiò gravemente non
solo gli ecosistemi locali, ma anche l’attività di pesca nella zona. Viceversa,
i 680.000 barili di greggio riversati dalla Braer lungo le coste delle isole
Shetland nel gennaio del 1993 furono subito dispersi dal moto ondoso, poiché al
momento dell’incidente il mare era in burrasca.
IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN ITALIA
Scarsa conoscenza degli impianti, controlli
insufficienti, inosservanza della normativa: sono le principali irregolarità
emerse dalle acque impure degli impianti di depurazione italiani. La nostra
inchiesta non lascia dubbi: la situazione è disomogenea, ma sono comunque troppi
i casi limite del servizio idrico. Mentre si spendono inutili miliardi per
impianti mai collaudati, la siccità avanza. I depuratori (e quindi la
possibilità di reintrodurre l’acqua inquinata nell’ambiente) sono, insieme al
risparmio delle risorse idriche, gli unici rimedi efficaci contro la mancanza di
acqua. Invece nel nostro Paese il funzionamento degli impianti di depurazione è
quanto mai critico.
Lo denuncia anche un’indagine del Nucleo operativo
ecologico dei Carabinieri.
Per la nostra indagine ci siamo rivolti alle Arpa,
le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Purtroppo, le Regioni che
hanno collaborato restituendoci il questionario sono solo otto. Di queste non
solo abbiamo apprezzato la disponibilità, ma abbiamo avuto modo di verificare
l’efficienza. Al contrario, il silenzio di chi non ha risposto rivela la scarsa
attenzione di gran parte del Paese alla gestione delle acque e agli impianti di
depurazione: mancano conoscenze, che sarebbero indispensabili per una corretta
gestione delle acque reflue. Pensiamo che in molte realtà importanti (è il caso
di Milano, per esempio, città nota per non aver mai avuto un depuratore…)
l’emergenza acqua dovrebbe essere affrontata più seriamente.
È un’Italia ancora con molte carenze quella che
esce da una disamina ad hoc sui servizi idrici, messi questa volta sotto la
lente del “Blue Book 2009”: se da una parte i costi affrontati ogni mese da una
famiglia media arrivano a sfiorare appena i 20 euro, molto meno delle spese
affrontate ad esempio per bollette telefoniche e combustibili, dall’altra emerge
un Paese ancora alle prese con una rete fognaria tuttora non all’altezza, con
picchi negativi, dal punto di vista della copertura, in Sicilia, Toscana e
Campania.
A livello territoriale, informa il Rapporto, il
record per il costo più alto per i servizi idrici se l’è aggiudicata Agrigento
(con una spesa annua di 440 euro), seguita da Arezzo (410) e Pesaro e Urbino
(409); diversamente i costi più contenuti sono stati quelli sopportati da Milano
(103 euro), Treviso e Isernia (108 e 109 euro).
Altro capitolo dolente analizzato dal Blue Book è
quello, purtroppo annoso, degli impianti di fognatura e di depurazione, di cui
sarebbe privo rispettivamente il 15 e il 30% del Paese. A fronte infatti di una
rete totale di 337.452 chilometri di acquedotti, il servizio di fognature, con
una rete complessiva di poco meno di 165 mila chilometri, coprirebbe soltanto
l’84,7% dei cittadini, quota che scende al 70% per quanto riguarda i sistemi di
depurazione. A livello regionale, quest’ultimo capitolo vede la Sicilia maglia
nera per gli impianti di depurazione, con una copertura del 53,9%, seguita da
Toscana (62,7%), Campania (67%) e Sardegna (68%). Quanto alla rete fognaria, le
situazioni più critiche riguardano Sardegna e Liguria (entrambe 75%), Umbria
(77,1%) e Veneto (78,1%).
INQUINAMENTO AMBIENTALE
L'inquinamento del suolo non può essere
considerato come un fenomeno autonomo:è sempre strettamente collegato
all'inquinamento dell'acqua perché è provocato spesso dallo scarico di liquami
oppure perché può produrre come contaminazione l'inquinamento della falda
acquifera sotterranea.
Nel terreno si verifica il ciclo dell'azoto,molto
importante perché tutti i tipi di vita hanno bisogno d'azoto, che è uno dei
componenti essenziali della materia vivente. per aumentare la produzione
agricola l'uomo, invece,ha introdotto spesso la monocoltura, che ha spezzato gli
equilibri biologici ed impoverito la fertilità naturale del terreno, richiedendo
l'uso dei diserbanti, insetticidi concimi azotati prodotti dall' industria
chimica. un'altra grave causa d'inquinamento del suolo è costituita dalla massa
di rifiuti solidi prodotti dalla città(in Italia 0,7Kg al giorno per abitante)e
dalle industrie. i rifiuti urbani sono formati da scarti organici alimentari,da
carta, materie plastiche, bottiglie di vetro, contenitori metallici ecc. ed
anche da fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua.
I rifiuti industriali contengono materiali
speciali e tossici come scarti o sottoprodotti dei processi di lavorazione
chimica o meccanica. per evitare l'inquinamento del suolo, i rifiuti urbani
devono essere convogliati nelle discariche controllate, ovvero in aree opportune
in cui i rifiuti d'origine organica possano decomporsi. Sarebbe meglio fare una
raccolta differenziata dei rifiuti al fine di recuperare e riciclare taluni
materiali come la carta e il vetro.
Si alternano strati di rifiuti e stati d'inerte,
in modo che in assenza d'aria si realizzi un processo di decomposizione
riduttivo con trasformazione finale dei rifiuti.
Le discariche devono essere localizzate in
posizioni caratterizzate da grandi spessori di strati impermeabili, e distanti
dalle falde acquifere sotterranee. talvolta può essere vantaggioso usufruire di
cave abbandonate di pietra, argilla o sabbia, contribuendo cosi anche al
recupero delle aree degradate; quando la cava viene riempita con i rifiuti si
può procedere al recupero finale, ricoprendo la distanza con uno strato di
terreno su cui realizzare prati o boschi. per i rifiuti industriali e'
necessario invece adottare sistemi di smaltimento adeguati, evitando ogni
pericolo di contatto con le falde acquifere sottostanti.
Le eventuali aree di raccolta devono allora avere
fondi resi impermeabile nel tempo con argilla, catrame o cemento. si può
ricorrere all'eliminazione dei rifiuti mediante altri metodi: IL COMPOSTAGGIO,
cercando di trasformare i rifiuti in composti utilizzabili come concimi LA
COMBUSTIONE con semplice incenerimento,oppure con produzione d'idrocarburi
liquidi o gassosi.
Fra i tanti veleni che contaminano la nostra Terra
quasi esausta, uno dei più subdoli è l’amianto. Questo minerale appartenente al
gruppo dei silicati possiede caratteristiche fisiche speciali e ricercate
(resistenza, refrattarietà al fuoco e straordinaria duttilità: una sua fibra è
1300 volte più sottile di un capello umano). Ma l’inalazione anche di una sola
fibra può causare patologie mortali. Mesotelioma pleurico, asbestosi o fibroma
polmonare, lesioni pleuriche e peritoneali, carcinoma bronchiale: sono questi i
nomi, davvero spaventosi, dei mali incurabili inequivocabilmente collegati
all’esposizione ad amianto.
Ogni anno in Italia sono circa 4000 i morti per
mesotelioma e asbestosi. Nel mondo, circa 100.000. In questi numeri da brivido
(il picco mondiale dovrebbe raggiungersi fra decina d’anni) è il sunto di una
storia: “Amianto, storia di un killer”.
È una storia che andrebbe ascoltata, se non altro
perché ci riguarda tutti da vicino. La racconta Stefania Divertito, scrittrice e
giornalista già premiata dall’Unione cronisti italiani nel 2004 per l’inchiesta
sull’uranio impoverito, abbinando metodo scientifico rigoroso e fine
sensibilità, e un tono piacevole mai sopra le righe.
Su e giù per l’Italia, visitando porti cantieri
discariche e poi aule di tribunali e stanze d’ospedale, bussando a tanti portoni
per raccogliere testimonianze dirette dalle famiglie delle vittime e dei
lavoratori che ancora lottano per un risarcimento, o semplicemente per veder
riconosciuti i propri diritti.
L’Italia è uno dei paesi mondiali che ha fatto un
uso più massiccio di amianto, a partire dagli anni ‘50 del secolo scorso e fino
alla sua messa al bando nel 1992. Molte delle case popolari degli anni ‘50 ne
sono ancora imbottite, ma è presente anche in scuole, università, ristoranti,
uffici pubblici, magazzini, autorimesse, alberghi, stabilimenti balneari,
aziende, perfino ambulatori medici.
C’è di sicuro nelle tantissime discariche abusive
a cielo aperto, a contatto dei cittadini che lì vicino vi transitano.
Le bonifiche sono state, a seconda delle regioni,
più o meno parziali. In ogni caso nel 17,65% degli istituti scolastici italiani
è stata accertata la presenza di amianto, secondo uno studio di settore della
Cgil compiuto nel 2008. Studi recenti testimoniano che per ammalarsi potrebbe
essere sufficiente aver respirato anche solo una volta la polvere nociva.
Visto che fino a poco tempo fa l’amianto era
onnipresente nelle nostre vite e il rischio riguarda anche i semplici cittadini,
inconsapevolmente troppo vicini a qualche discarica abusiva o a una tettoia di
Eternit, la prevenzione dovrebbe essere capillare. Invece è disturbante
individuare ancora una volta tra le pieghe di questa storia la regia
dell’inquinamento globalizzato, dal primo anello della catena – i produttori di
materiali pericolosi ma a basso costo come l’amianto, con le loro politiche
centrate sull’economia a discapito della salute – all’ultimo, cioè lo
smaltimento illegale dei rifiuti tossici.
In Italia il diritto al risarcimento per le
malattie ad esso collegate è stato ed è ostacolato, oltre che dai vertici delle
lobby guidate a livello mondiale dall’industria canadese, da normative
incomplete e confuse, cavilli che sfidano il buon senso: per esempio, i
lavoratori del settore marittimo non riescono ad accedere ai benefici
previdenziali perché per dimostrare di aver lavorato in ambienti contaminati con
l’amianto dovrebbero farsi firmare il curriculum da armatori che nella maggior
parte dei casi sono falliti, fuggiti, deceduti.
“Come l’esportazione e il consumo di questo
materiale non ha confine, anche le battaglie contro di esso non lo hanno”,
scrive l’autrice.
INQUINAMENTO ACUSTICO
Nell’annuario dei dati ambientali 2006 l'ISTAT ha
rilevato che il 37,8% delle famiglie italiane segnala problemi relativi
all'inquinamento acustico. Un dato questo certamente preoccupante, conseguenza,
in parte, della scarsa attenzione che, fino ad oggi, è stata riservata alla
materia.
Le cause di tale disfatta sono molteplici, a
partire da quelle socio-culturali, giacché una qualche sensibilità ai temi
ambientali si è diffusa nel nostro Paese solo in tempi abbastanza recenti,
allorquando abbiamo potuto “toccare con mano” i danni causati dall’inquinamento.
Questo modo di operare ha impedito di avviare una vera e propria programmazione,
propedeutica a una politica di prevenzione, affiancata a interventi su singoli e
specifici casi come, di regola, è necessario fare.
Quando parliamo di interventi di riduzione del
rumore non esistono soluzioni efficaci che siano attuabili dall’oggi al domani.
E’ necessario, invece, partire da lontano, per mezzo di direttive atte a
regolamentare, ad esempio, lo sviluppo delle aree abitate, a promuovere e
incentivare una mobilità sostenibile e razionale, attraverso il graduale
passaggio dal trasporto su gomma a quello su ferro, specie per quel che riguarda
il traffico delle merci, settore che negli ultimi anni ha conosciuto un elevato
tasso di crescita. In altre parole, bisogna avere il coraggio di cambiare, di
adottare soluzioni innovative che, oramai da tempo, sono utilizzate in numerosi
Paesi europei.
Non basta promulgare nuove leggi per cambiare il
modo di agire e di pensare della popolazione, anche perché quelle presenti sono
già tante, forse troppe. Piuttosto, si deve passare da una politica del “dire” a
una politica del “fare”, attraverso lo sviluppo di idee chiare, muniti di una
buona dose di determinazione, nell’interesse di un Paese che è tanto amato dagli
italiani, quanto dai numerosi stranieri che, ogni anno, giungono in Italia
attirati dall’ospitalità, dalla buona cucina, dai suggestivi paesaggi, dalla
cultura e, speriamo presto, dal poter vivere in un ambiente silenzioso.
L’Italia in passato ha saputo sollevarsi da
situazioni molto difficili, grazie al lavoro e all’impegno di un popolo
generoso. Ci auguriamo che un ulteriore sforzo possa essere compiuto per rendere
la nostra vita un tantino migliore, almeno per quel che riguarda il rumore.
INCENDIOPOLI IN ITALIA.
Roghi sul Vesuvio, le fiamme sono
iniziate mesi prima del grande incendio. Chi sarà il
nostro capro espiatorio? La causa dell'incendio è dovuta alla malavita o alla
negligenza dello Stato? Scrive Frank D'Amore, curato da Domenico Camodeca, il 16
luglio 2017 su "it.blastingnews.com". Mesi prima del grande incendio del 12
luglio si innalzano nubi tossiche dal Vesuvio. I fumi neri presuppongono rifiuti
in fiamme e un'aria irrespirabile si sparge per tutti i paesi Vesuviani. I
cittadini gridano aiuto eppure i roghi si sono ripetuti per diversi mesi. Se ci
sono stati segnali di fumo evidenti che hanno comunicato l'emergenza del
pericolo per tutta l'area che circonda Napoli e le sue province vesuviane,
perché la Regione non ha fatto alcuna prevenzione? Il Mattino riporta la notizia
che il sindaco Luigi de Magistris denuncia la negligenza del nostro paese, il
quale ha perso di vista le vere priorità del territorio, continuando a investire
in spese militari e per salvare le banche, dimenticando invece di fare
prevenzione contro gli incendi. Il presidente della regione Vincenzo De Luca
adesso è determinato a risolvere il problema dei roghi, specialmente sul
Vesuvio. 400 mila euro investiti per pagare gli straordinari ai Vigili del
Fuoco, aumentando i controlli anche notturni. Gli investimenti hanno permesso
anche di agevolare gli elicotteri nel trasporto dell’acqua, di mettere in
sicurezza cave e zone abitate. Ma perché aspettare un incendio lungo due
chilometri per mandare i soccorsi? Il web e i giornali si scatenano contro il
presidente della Regione ritenuto responsabile di negligenza.
Le indagini svolte dal web. Le indagini sono
ancora in corso per capire chi sia l’artefice dell’incendio. Sono in molti a
pensare che la colpa sia della malavita che ha bruciato la montagna per disfarsi
delle discariche di rifiuti tossici. Saviano in un suo video postato su Facebook
ha ragione di credere che l'incendio abbia avuto scopi edilizi. Su un terreno
bruciato, non si può costruire per 15 anni. La camorra quindi avrebbe lanciato
il messaggio che solo loro hanno potere decisionale sul territorio campano.
Altri invece pensano che la causa sia di un ignoto piromane con manie di
grandezza. Quello che sappiamo è che l’incendio è doloso. Sul Corriere della
sera, il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola afferma che l’incendio
non ha nulla a che vedere con i rifiuti tossici. La teoria dell’edilizia
annunciata da Saviano potrebbe essere valida, ma per legge, sul Vesuvio è
vietato edificare dato che è considerata una zona rossa ad alto rischio. Le
teorie sono incerte e coperte da mezze verità, alcune in parte smentite. Quello
che possiamo immaginare è che, dato i molteplici segnali di fumo evidenti mesi
prima del 12 luglio, l’incendio poteva essere evitato. Il Vesuvio è un simbolo
riconosciuto in tutto il mondo. Quella terra che dovrebbe essere protetta,
trattata con rispetto e riguardo è da anni vessata, soggetta ad abusi e ora
completamente distrutta.
I roghi e la banalità del male,
scrive Nicola Quatrano il 15 luglio 2017 su "Il Corriere del Mezzogiorno".
L’immagine del Vesuvio che brucia, il fumo che si leva alto nel cielo come fosse
un’eruzione, visibile da ogni parte, da Posillipo al Vomero, da Portici a
Sorrento. È un’immagine stavolta più angosciosa, ma tutt’altro che inedita. Si
ripete più o meno ogni anno, porta caldo al caldo, angoscia e senso di
smarrimento, rilanciata ogni anno da redazioni estive a corto di notizie,
destinata a spegnersi con lo spegnersi delle fiamme. Fino all’anno successivo.
Il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, vorrebbe essere rassicurante:
«Faremo di tutto per prendere i colpevoli». Ma non ci dice cosa è stato dei
colpevoli dell’anno scorso. E di quelli degli anni precedenti. Né chi sono in
realtà questi colpevoli. A vedere i pochi che hanno beccato, quasi ci deludono:
solo semplici agricoltori, intenti a bruciare le sterpaglie, o rom che danno
fuoco all’immondizia. Roberto Saviano non si fa incantare da simili dettagli.
Per lui ci sono solo mostri (è il suo brand) e anche i roghi sono opera della
camorra che impone il pizzo sulle aree edificabili e, se non paghi, brucia
tutto. Peccato che sulle falde del Vesuvio non siano tante le aree edificabili,
e che distruggere del tutto l’oggetto dei propri potenziali guadagni assomiglia
un po’ troppo al proverbiale marito che si mutila per fare dispetto alla moglie.
Stavolta però c’è chi è stato più fantasioso: la bufala dei gatti incendiati,
lanciati nei boschi per diffondere il fuoco, è già al top delle classifiche. Ma
ha davvero senso questa ricerca di trame e complotti, questo immaginare piovre
coi tentacoli armati di fiammiferi? La ragione di questa tragedia non potrebbe
essere più semplice, più banale e, proprio per questo, ancora più drammatica? È
vero, gli incendi possono essere un affare. Ci vogliono uomini e mezzi per
spegnerli, e quindi appalti, assunzione di stagionali ecc. E poi bisogna pensare
al rimboschimento, e quindi altri appalti, altre assunzioni di stagionali, altro
denaro pubblico che entra in circolo. Negli anni scorsi c’era chi giurava che
gran parte degli incendi in Calabria e in Sicilia fossero opera degli stessi
forestali per scongiurare i rischi di riduzioni del personale. E poi ci sono le
discariche abusive, qualcuna certamente gestita dai clan, ma tante altre frutto
perverso dei costi elevati degli smaltimenti legali. C’è insomma un «clima» che
favorisce gli incendi. A ciò si aggiunga il pessimo stato di manutenzione dei
boschi, i decreti sbagliati, i ritardi clamorosi, gli scarsi mezzi, le
operazioni assurdamente interrotte di notte, il caos provocato dall’assorbimento
del Corpo forestale dello Stato da parte dei Carabinieri, e infine il caldo
torrido di questi giorni, la siccità. C’è veramente bisogno di trovare altre
cause? Di immaginare disegni perversi, entità spaventose e impalpabili, l’uomo
nero o il babau che tessono le fila di improbabili complotti? Non si finisce in
questo modo per concedere alibi e giustificare una ancora più spaventosa
ragnatela di omissioni, inerzie, incompetenze, irresponsabilità, gretti
interessi? È la banalità del male. Agricoltori irresponsabili se ne infischiano
dei divieti e appiccano il fuoco alle sterpaglie per ripulire il campo; piccole
imprese sversano illegalmente i rifiuti per evitare i costi dello smaltimento
legale; turisti e cacciatori disseminano i sentieri di immondizia, proprietari
di abitazioni abusive tentano di evitarne l’abbattimento. Dall’altro lato,
funzionari incompetenti, politici e amministratori irresponsabili omettono di
predisporre i mezzi per lo spegnimento, non provvedono alla manutenzione dei
boschi, fanno errori organizzativi e scelte urbanistiche irragionevoli. E così
via, in un circolo vizioso di gesti banali suscettibili di conseguenze
disastrose. Non è progetto criminale, piuttosto indifferenza, somiglia a quella
dei rappresentanti istituzionali locali, assenti in questi giorni perché forse
impegnati a disegnare gli scenari delle prossime elezioni, a collocarsi e
ricollocarsi per conservarsi un ruolo, a perseguire il proprio interesse più
immediato, proprio come il contadino che brucia le sterpaglie senza curarsi
delle conseguenze. È la banalità del male, come nel crollo di Torre Annunziata,
tanti piccoli gesti di assassini inconsapevoli.
Della serie: come godono i barbari padani delle
disgrazie del sud Italia.
Chi proferisce ingiurie ad altri o a se stesso
con il termine terrone non resta che rispondergli: SEI SOLO UN COGLIONE.
Il Vesuvio e la scarsa stima di Vittorio
Feltri per i (pochi) lettori di Libero, scrive il 13
luglio 2017 "Il Napolista". Perdonateci, non riusciamo a prendere sul serio
questa prima pagina che ci intristisce soltanto. La pernacchia eduardiana
sarebbe troppo onore. Quando la redazione è a corto di idee. A Libero, quando
sono a corto di notizie e di idee, inseriscono il pilota automatico che può
scegliere due strade: un titolo con riferimenti sessuali, preferibilmente
discriminatorio nei confronti delle donne oppure omofobo, oppure un’intemerata
contro Napoli. Vai così che non ti sbagli mai. Certo anche Vittorio Feltri deve
fare i conti con l’emorragia di copie. Il suo Libero ormai ne venderà qualcuna
nei famosi Territori, sempre poca roba. Ieri, evidentemente, è stata una
giornata fiacca per i cronisti di Libero. E allora cosa c’è di meglio per un
titolo e un paio di articoli insultanti nei confronti dei napoletani per il
Vesuvio che brucia? Feltri ha scritto un articolo tra l’imbarazzante e il
ridicolo. Il titolo è tutto un programma: “Si bruciano da soli” e poi c’è un
lungo passaggio che francamente non immaginavano potesse avere più cittadinanza
su un quotidiano italiano, sia pure Libero. Ecco cosa scrive Feltri in un ampio
passaggio che Lombroso avrebbe giudicato eccessivo: Non c’entra l’antropologia,
bensì la sociologia. La gente del Mezzogiorno è più portata a collaborare con i
delinquenti, temuti e venerati, che non con le Forze dell’ordine, poco
rispettate. Infatti i meridionali che vivono a Milano sono diventati più
milanesi dei milanesi, si sono perfetta- mente inseriti e sono i primi a
comportarsi osservando le regole. Parecchi di quelli rimasti in Terronia,
invece, influenzati dalla comunità storta in cui campano, ne adottano le cattive
abitudini e sono guai. I peggiori di essi sono addirittura piromani e
danneggiano i compaesani. Avranno la loro bella convenienza. E allora è inutile
e ridicolo che il sindaco di Napoli quereli Libero perchè analizza i costumi
partenopei senza ipocrisia, focalizzandone i difetti maggiori. Qui non c’entra
il razzismo e altre simili stupidaggini. Si tratta soltanto di prendere atto di
ciò che è sotto gli occhi di chiunque ne abbia due aperti. Il disastro del
Vesuvio, dove non è sorto un edificio che non sia abusivo (complimenti alle
amministrazioni cieche), non è stato provocato da calamità naturali: i
napoletani – non tutti per carità – si sono bruciati da sé. Si guardi- no allo
specchio e sputino. Non sbagliano bersaglio. Non riusciamo nemmeno a indignarci.
Ci si può indignare, si può chiedere all’Ordine dei giornalisti della Campania
di far sentire la propria voce. Ma ci si può anche imbarazzare per Feltri e
soprattutto per l’idea che ha dei propri lettori. Dev’essere triste dirigere un
giornale pensando di dover abbeverare persone che condividono questi
pensieri. Non riusciamo a prendere sul serio Libero, non è possibile nemmeno
indignarsi. Con queste poche righe abbiamo versato il nostro obolo alla
celebrità quotidiana di Vittorio Feltri. Di più non siamo riusciti a fare.
L’eduardiana pernacchia sarebbe francamente troppo onore.
COLPA DELLO STATO? A Napoli si bruciano da soli.
Vesuvio, spuntano le foto: la prova definitiva. Vesuvio in fiamme, le foto
dall'altro che dimostrano come i roghi siano studiati scientificamente, scrive
il 13 Luglio 2017 "Libero Quotidiano". Da tre giorni ormai il Vesuvio è in
fiamme, e ora al Parco nazionale sono al lavoro anche gli uomini
dell'esercito che hanno già individuato un nuovo focolaio in una zona boschiva a
ridosso di San Sebastiano. Sul posto sono impegnati al momento tre canadair e
diversi elicotteri per provare tutti gli incendi ancora attivi. Una situazione
gravissima ma non casuale. "Ci troviamo di fronte a una organizzazione criminale
complessa e ben organizzata, queste due foto fatte dall'alto dai corpi
speciali dimostrano come nel caso degli incendi del Parco del Vesuvio sia stato
fatto un lavoro scientifico che richiede impegno e coordinamento di non poche
persone", denuncia sul suo profilo Facebook Massimiliano Manfredi del Pd.
Gli inneschi, spiega, "vengono messi agli estremi e nel mezzo di questo arco
virtuale al centro di cui c'è il Parco del Vesuvio. Questo vuol dire che per
spegnere il fuoco bisogna raggiungere i due estremi dall'esterno che stanno agli
antipodi, il centro impedisce il collegamento e a sua volta deve essere
aggredito da destra e sinistra. Che vuol dire? Che servono almeno il doppio, se
non il triplo, di mezzi e uomini e il doppio del tempo, dando la possibilità a
chi si trova dal lato opposto di continuare ad appiccare fuoco perché nel
frattempo brucia la Campania e mezzo Paese e non solo il Parco. Più tempo passa
e poi si può alzare vento. Qualcuno crede ancora all'autocombustione dopo queste
foto?".
Può ritenersi attendibile ed intelligente un tal
commentatore barbaro padano, (anche televisivo su tv nazionali ed elevato,
addirittura, al rango di direttore di quotidiano) che spara certe idiozie, tutta
farina del suo sacco fondata su pregiudizi e luoghi comuni razzisti?
"Guardatevi allo specchio e poi
sputatevi": Vittorio Feltri il 13 Luglio 2017 su
"Libero Quotidiano", lo schiaffo a (certi) napoletani. Il Vesuvio è in fiamme.
Chi ha appiccato il fuoco? Persone del posto, ovviamente, criminali che nessuno
ha ostacolato e dei quali non si scoprirà mai l'identità per un motivo banale:
essi agiscono grazie a una rete di complici che pascolano nella malavita locale,
attiva più che mai, e sono al servizio di boss potenti. Lo stesso fenomeno si
registra in Sicilia dove non c' è verso di scoprire né gli autori materiali
degli incendi né i loro mandanti, i quali non agiscono a capocchia, ma sono
mossi da loschi interessi. Di fronte al fuoco che si propaga a grande velocità e
su vasti territori, la maggior parte dei cittadini punta il dito accusatore
sullo Stato, dice che l'autorità è inesistente, assente. Non c' è anima che si
chieda cosa facciano le migliaia di guardie forestali, pagate dalla pubblica
amministrazione, per sorvegliare le zone loro affidate ed evitare che siano
incenerite. Il sospetto, anzi la certezza, è che si grattino il ventre e non
svolgano neanche distrattamente i compiti loro assegnati in cambio di una buona
retribuzione. Secondo la vulgata meridionale la colpa di ogni sfacelo è sempre
del mitico Stato, quasi che questo fosse una divinità demiurgica. In realtà lo
Stato che manifesta le proprie forze, o debolezze, a Napoli o a Palermo, è lo
stesso presente a Pordenone e a Conegliano Veneto, per altro incarnato
prevalentemente da funzionari del Mezzogiorno emigrati per questioni alimentari,
i quali se al Nord sono efficienti significa che non sono stupidi e indolenti.
Se sono bravi quassù perché laggiù sono asini? Evidentemente il problema nasce
dal condizionamento ambientale. Non c' entra l'antropologia, bensì la
sociologia. La gente del Mezzogiorno è più portata a collaborare con i
delinquenti, temuti e venerati, che non con le Forze dell'ordine, poco
rispettate. Infatti i meridionali che vivono a Milano sono diventati più
milanesi dei milanesi, si sono perfettamente inseriti e sono i primi a
comportarsi osservando le regole. Parecchi di quelli rimasti in Terronia,
invece, influenzati dalla comunità storta in cui campano, ne adottano le cattive
abitudini e sono guai. I peggiori di essi sono addirittura piromani e
danneggiano i compaesani. Avranno la loro bella convenienza. E allora è inutile
e ridicolo che il sindaco di Napoli quereli Libero perché analizza i costumi
partenopei senza ipocrisia, focalizzandone i difetti maggiori. Qui non c' entra
il razzismo e altre simili stupidaggini. Si tratta soltanto di prendere atto di
ciò che è sotto gli occhi di chiunque ne abbia due aperti. Il disastro del
Vesuvio, dove non è sorto un edificio che non sia abusivo (complimenti alle
amministrazioni cieche), non é stato provocato da calamità naturali: i
napoletani - non tutti per carità - si sono bruciati da sé. Si guardino allo
specchio e sputino. Non sbagliano bersaglio. Vittorio Feltri.
Non di solo caldo e fuoco si riempiono la bocca
i barbari padani.
Gaffe e bufera in rete sul Tg5.
Il telegiornale Mediaset è finito nell'occhio del ciclone
perché la giornalista Elena Guarnieri ha pronunciato queste parole durante la
diretta del 12 novembre 2014 parlando del maltempo: «Il peggio sembra essere
passato, la perturbazione adesso si è spostata al Sud». È doveroso ricordare che
la perturbazione che era in "movimento" verso il Sud aveva causato enormi danni
ad alcune regioni del Nord Italia. Sui siti e sui social si possono leggere
numerosi commenti dei lettori. C'è chi attacca e chi difende la giornalista:
«Non ho parole, umanità zero. Siamo tutti uguali nord e sud» scrive
Martina. Dello stesso parere Francesca: «Se fossi in lei mi scuserei perchè
siamo tutti sulla stessa barca». La pensa diversamente un altro utente: «Si ha
sbagliato... si è' espressa male... di certo non mi sembra che sia un caso
nazionale». Altri scrivono: “Pericolo scampato per chi? Per voi?”, o ancora
“Questo è il livello delle reti Mediaset”. Molti, sul web e non solo, si
domandano perché trovare confortante il fatto che sia il Sud ad essere colpito
dalle prossime perturbazioni. Noi speriamo credere che la frase incriminata sia
stata pronunciata inconsciamente, ma lo sdegno dei telespettatori è così forte
che non riescono proprio a perdonare la terribile gaffe.
Fiorella Mannoia contro Feltri: «A Napoli
non si bruciano da soli», scrive il 13 luglio 2017 “Il
Mattino”. Fiorella Mannoia contro Libero e Feltri. La cantante ha pubblicato
sulla sua pagina Facebook una foto della città, sullo sfondo il Vesuvio avvolto
dal fumo. In alto, la scritta: «Maledetti!!! Napoli non ve la meritate!». E,
sotto, il commento accanto alla foto della prima pagina del giornale: «A Napoli
non si bruciano da soli Idiota! Indagate per sapere il perchè hanno bruciato
quell'area, quali interessi ci sono, e chiedetevi da dove proviene la spazzatura
che viene interrata, fate le inchieste, che sarebbe il vostro lavoro, invece di
sparare titoli infamanti per un'intera città. Lo avete scritto anche per la
Liguria quando qualche anno fa un incendio, l'ennesimo doloso, ha distrutto
ettari e ettari di vegetazione? Lo avete scritto per tutti i roghi d'Italia? No,
lo scrivete per Napoli. Questo sindaco vi da proprio fastidio vero? Io penso che
un po' di vergogna non vi starebbe male».
Incendi in Italia, molte regioni a
rischio. A Capalbio allarme per "Ultima spiaggia". Il
fuoco sta devastando tre regioni del centro sud: Toscana, Lazio e Campania. I
boschi in fiamme diventano un caso politico: Arturo Scotto (Mdp) ha chiesto che
il ministro dell'Ambiente Galletti riferisca in Parlamento. Paradosso a Scilla:
da pericolo fuoco a emergenza bomba d'acqua, scrive Alberto Custodero il 16
luglio 2017 su "La Repubblica". Ancora fiamme sull'Italia. Evacuato lo
stabilimento balneare "Ultima spiaggia", il più famoso di Capalbio
(Grosseto), il club marino della cosiddetta sinistra radical chic. Il sindaco di
Capalbio, Luigi Bellumori, ha poi precisato che l'ordine di evacuazione "è
rientrato". Colpita la zona del centro sud Toscana, Lazio e Campania. Per
facilitare le operazioni di riempimento dei serbatoi dei Canadair impegnati in
Toscana, è stato chiuso alla balneazione il lago di Bilancino. A Capalbio per
precauzione sono stati evacuati due campeggi. Il forte vento ha riacceso il
fuoco a Piancastagnaio (Siena), mentre le fiamme stanno bruciando un bosco
all'Isola d'Elba. In fiamme anche i boschi nel Napoletano, da Torre del
Greco all'area vesuviana: sono entrati in azione tre Canadair. Dopo giorni di
incendi, su gran parte della Calabria è arrivata la pioggia. Molto intensa nel
reggino, con una bomba d'acqua su Scilla che ha allagato le strade del paese, e
più lieve nelle altre parti della Calabria. L'Italia che brucia diventa un caso
politico: il deputato Mdp Arturo Scotto ha chiesto che il ministro
dell'Ambiente Gian Luca Galletti "riferisca in Parlamento facendo il punto sulla
strategia nazionale per tutelare il patrimonio naturale boschivo".
Nord di Roma. Un vasto incendio di sterpaglie è
divampato ad Anguillara, comune a nord di Roma, a ridosso di una comunità per
disabili. La struttura è stata evacuata. Due disabili sono stati trasportati
all'ospedale di Bracciano intossicati dal fumo. Un vasto incendio boschivo si è
sviluppato nella zona del Lago di Martignano, sempre a nord di Roma. In azione
cinque squadre con 20 volontari, due elicotteri, ed è stato richiesto
l'intervento di un Canadair.
Paestum. Un incendio di vaste proporzioni sta
divampando nella zona di Paestum. Evacuati per motivi precauzionali un
caseificio e alcune abitazioni. Del rogo scrive su Facebook il direttore
dell'area archeologica di Paestum, Gabriel Zuchtriegel: "I vigili del fuoco
stanno intervenendo. Sentito il sindaco che ha attivato la protezione civile. I
templi per ora fuori pericolo ma grande preoccupazione per il borgo di Santa
Venera a sud. Molto vento che peggiora la situazione".
Fauglia (Pisa). Un incendio di un'area boschiva
(domato nei giorni scorsi) si è riattivato nei pressi di Fauglia (Pisa). Le
fiamme si stanno estendendo verso la sede dell'istituto Stella Maris che assiste
minori con disturbi neuropsichici. Il centro è stato evacuato per precauzione.
Sul posto vigili del fuoco e protezione civile.
Civitavecchia. Un incendio, alimentato da un forte
grecale, ha bruciato la campagna alla periferia di Civitavecchia lambendo alcune
case: gli abitanti hanno tentato di spegnere il fuoco che si avvicinava
pericolosamente usando i tubi da giardino come manichette antincendio. Il fumo
ha invaso l'autostrada nei pressi di Civitavecchia su un fronte di un
chilometro.
Capalbio. Un incendio nel territorio del comune di
Capalbio (Grosseto), nella zona del Padule del Chiarone, al confine tra Toscana
e Lazio, ha comportato a scopo precauzionale l'evacuazione del campeggio Costa
Selvaggia in località Pescia Romana (Viterbo). E lo sgombero del camping
'Capalbio'. Interrotte per alcune ora la statale Aurelia e, a Viterbo, 11
chilometri della statale 'Umbro Laziale' per fumo in carreggiata. Il sindaco di
Capalbio, Bellumori, ha spiegato che il "forte vento" ha spinto velocemente le
fiamme lungo il canale del Chiarone e che poi, "saltata" la ferrovia, hanno
attaccato la pineta. Al lavoro sono impegnate le squadre di Grosseto, Livorno e
Viterbo, supportate da un elicottero dei vigili del fuoco decollato dal nucleo
di Ciampino. E da personale volontario Aib (antincendio boschivi). "A creare
problemi è stato il fumo - ha spiegato ancora il primo cittadino - in tanti
hanno preferito lasciare la spiaggia creando problemi al traffico: per questo
sono intervenuti polizia municipale e carabinieri". Sono impegnati due
elicotteri nelle operazioni di spegnimento di un incendio partito lungo il
canale del Chiarone, e di un secondo lungo l'Aurelia". Sempre a Capalbio è stata
bloccata la linea ferroviaria Tirrenica per alcune ore. La circolazione dei
convogli è ripresa regolarmente verso le 17,30. Fs ha spiegato che il transito
dei treni era stato fermato alle 12.10 e poi alle 13.50 era stato dato il via
libera alla ripresa della circolazione su un binario, ma è stato poi nuovamente
interrotto. A supporto del lavoro dei vigili del fuoco, la Regione Lazio ha
messo in campo 5 squadre della Protezione civile, circa venti volontari. Da
qualche minuto si è anche alzato in volo un elicottero regionale. Al momento non
risultano abitazioni evacuate. Due i mezzi aerei in azione.
Piancastagnaio (Siena). Il forte vento sta
causando la ripresa di alcuni focolai dell'incendio che è scoppiato ieri a
Piancastagnaio (Siena). La Sala operativa della protezione civile ha già inviato
un elicottero della flotta regionale e, a seconda degli sviluppi, si sta
valutando la possibilità di mandarne altri due e di chiedere un mezzo alla
protezione civile nazionale. A terra stanno operando squadre di volontari
antincendi, di operai forestali e di vigili del fuoco.
Montale (Pistoia). Un vasto incendio è divampato
nel primo pomeriggio di oggi nei boschi sopra Montale (Pistoia), in località
Fognano. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Pistoia e un
elicottero che ha cercato di spegnere il rogo dall'alto. Le operazioni di
spegnimento sono particolarmente difficili anche per il vento che alimenta le
fiamme, che stanno raggiungendo un agriturismo. Il fumo dell'incendio è visibile
anche dalla vicina autostrada A11, dall'aeroporto di Firenze e dalle colline
intorno al capoluogo.
Isola d'Elba. Un altro incendio è scoppiato questa
mattina all'Isola d'Elba, a Marina di Campo, interessando una zona a macchia
mista, con pineta. Sul posto sono stati inviati due elicotteri della flotta
regionale.
Torre del Greco. Dalle prime ore del giorno si è
registrata la ripresa di un focolaio a Torre del Greco in zona Montedoro,
traversa Garzilli. Le operazioni sono rese più complesse dalla presenza di venti
settentrionali forti che, a tratti, hanno impedito agli elicotteri di alzarsi in
volo. Sono entrati in azione sul posto tre Canadair nazionali insieme a squadre
da terra. Altri fronti si registrano a Sant'Anastasia, Barano d'Ischia, Conca
dei Marini e a Napoli in zona Astroni dove, al momento, si sta intervenendo con
due aerei. Le condizioni atmosferiche sia in Costiera che in provincia di Napoli
rendono difficile l'intervento con gli elicotteri.
Napoli. "Brucia ancora il cuore selvaggio di
Napoli. L'incendio nella riserva naturale dello stato nel cratere degli astroni,
oasi wwf, che sembrava domato, stamattina ha riacquistato vigore". Dalla
mattina, spiega una nota del wwf, "gli elicotteri hanno ripreso ad operare
incontrando, però, notevoli difficoltà a causa del forte vento". Per queste
ragioni è stato richiesto l'intervento di un Canadair, inviato da Lamezia Terme.
Sulle fiamme è stato inviato anche un elicottero più potente, meno sensibile al
vento. Il Canadair prima di intervenire sulla riserva ha effettuato lanci fuori
dal cratere perchè le fiamme, propagatesi anche esternamente all'area dell'oasi,
mettevano in pericolo alcune abitazioni vicine alla riserva.
Tremiti. Tornano a divampare le fiamme nel bosco
di San Domino sulle Isole Tremiti (Foggia) a causa del vento forte: alcuni
focolai spenti l'altro ieri hanno ripreso a bruciare. Sul posto, dopo le
segnalazioni degli isolani, sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco di cui
una partita da Termoli. Un Canadair sta effettuando più lanci per cercare di
arginare il fuoco.
Scilla. L'Unità di crisi istituita dal
prefetto Michele Di Bari lo scorso 9 luglio per fronteggiare l'emergenza
incendi, oggi ha coordinato anche le attività di soccorso per l'allarme
nubifragi. Una frana e diversi allagamenti, soprattutto nella zona tirrenica,
sono stati causati dal violento nubifragio che si è abbattuto stamani sulla
provincia di Reggio Calabria. A Scilla per qualche ora è stato chiuso il tratto
sulla statale 'Tirrena Inferiore' tra Scilla e Bagnara Calabra a causa di una
frana, successivamente l'Anas ha riaperto a senso unico alternato il primo
tratto a Bagnara, mentre resta chiuso a Villa San Giovanni un tratto di 3
chilometri.
Ministro Ambiente: "Situazione complessa, ma
rispondiamo all'emergenza con le misure necessarie". Una situazione la cui
complessità non si verificava da anni, aggravata, oltre che dalla mano dei
piromani, da una siccità troppo prolungata. Ma, "di fronte all'emergenza incendi
la protezione civile, l'esercito, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali,
assieme alle istituzioni locali competenti, stanno facendo un grande lavoro", ha
detto il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. "Per quanto riguarda le aree
dei Parchi nazionali, di diretta competenza del ministero dell'Ambiente, i mezzi
sono in campo, abbiamo attivato avanzati sistemi di monitoraggio come il
satellitare Copernicus e nelle scorse settimane ho emanato una direttiva che
velocizza l'iter degli interventi, dal cosiddetto "primo fuoco" allo
spegnimento", ha spiegato il ministro, che ha ribadito che "la situazione è
complicata e oggi stiamo dando le risposte possibili e necessarie all'emergenza,
anche con un impianto normativo rafforzato dagli ecoreati nel codice penale, che
possono portare a oltre 20 anni di carcere per i piromani".
Incendi, non solo elicotteri fermi: con
“l’estinzione” della Forestale non c’è più neanche la prevenzione dei boschi.
Tra gli effetti della riforma Madia che ha voluto l'accorpamento con carabinieri
e vigili del fuoco non ci sono solo i velivoli antincendio bloccati a terra. Ma
anche figure professionali dequalificate, presidio del territorio smantellato,
pasticci burocratici e Regioni depotenziate. I sindacati: "Rivoluzione?
Piuttosto una soppressione affrettata", scrive Valerio Valentini il 14 luglio
2017 su "Il Fatto Quotidiano". Direttori operativi dequalificati, presidio sul
territorio smantellato, complicazioni burocratiche
interminabili e Regioni depotenziate. Mentre l’Italia brucia, tutte le storture
e i ritardi della riforma Madia vengono a galla: non riguardano soltanto
gli elicotteri dell’antincendio boschivo costretti a restare a terra, che già è
paradossale. A distanza di 7 mesi dalla sua entrata in vigore, la “rivoluzione”
voluta dalla ministra della Pubblica amministrazione si rivela un sostanziale
flop. Causato, soprattutto, dalla soppressione del Corpo Forestale dello Stato.
“Una soppressione affrettata, fatta in nome della semplificazione, che non ha
tenuto conto delle prevedibili complicazioni che si sarebbero verificate. E che
puntualmente sono emerse in tutta la loro evidenza proprio nel momento della
verità” commenta Gabriele Pettorelli, coordinatore nazionale dei Forestali per
il Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco. Il pasticcio della
riforma arriva nell’annus horribilis dell’ultimo decennio per le emergenze
incendio. Dal primo gennaio ad oggi sono state 764 le richieste di soccorso
aereo: nel 2007 erano state 722 nello stesso periodo nel 2007, nel 2012 458. Non
è un caso, secondo Pettorelli: “Sopprimendo la Forestale si è notevolmente
indebolita quell’opera di presidio sul territorio e di prevenzione che era
propria dei nostri uomini”. Erano 8mila, fino al 31 dicembre 2016: poi sono
stati distribuiti tra i vigili del fuoco (360 appena) e la Pubblica
amministrazione (circa 1240). Ma è ai carabinieri che sono stati destinati in
modo massiccio: ben 6400. Ed è stato un passaggio che ha lasciato conseguenze
pesanti. Soprattutto per quanto riguarda il ruolo dei cosiddetti Dos, ovvero i
direttori operativi degli spegnimenti: sono coloro che sono in grado
di coordinare i lavori in caso di emergenza. La Forestale era particolarmente
preparata in questo compito e le ex guardie trasferite tra i pompieri speravano
di vedersi riassegnare automaticamente quell’incarico (i carabinieri non operano
nell’antincendio). Così non è stato. E così da un lato i vigili del fuoco sono
stati costretti a una corsa contro il tempo per formare il proprio personale in
questa difficile mansione, dall’altro molti ex forestali specializzati si sono
ritrovati relegati in ruoli di minore responsabilità o parcheggiati senza
mansioni, nell’attesa di decreti attuativi previsti nella riforma. E
nell’attesa, chissà, della prossima emergenza. Poi c’è la storia dei mezzi aerei
di soccorso. “Qui il cortocircuito nasce dalle difficoltà legate al passaggio di
proprietà dei mezzi della Forestale” racconta il coordinatore del Conapo. Fino
all’anno scorso, la Forestale poteva mettere a disposizione dello Stato una
flotta di 32 elicotteri, di cui ben 30 in grado di intervenire per spegnere gli
incendi. Al primo gennaio 2017 sono transitati tutti sotto la proprietà dei
carabinieri. Che ne hanno trattenuti per sé la 13, convertendoli però ad altre
finalità. Cinque dei 18 Ab412, velivoli di dimensione media capaci di
trasportare fino a 1000 litri d’acqua, e tutti gli 8 nh500, piccoli ma
maneggevoli, utilissimi in situazioni critiche. Tredici elicotteri che fino
all’anno scorso operavano in casi d’incendio, e quest’anno no. Ma non è finita
qui. Perché dei 17 mezzi aerei assegnati ai vigili del fuoco per effettuare
operazioni di spegnimento, in questi giorni ne vengono impiegati appena 7. Si
tratta dei 4 S-64, enormi “gru volanti” in grado di sganciare fino a 9mila litri
per volta, e di 3 Ab412. Solo 3, a fronte dei 13 modelli finiti nella
disponibilità dei pompieri. Com’è possibile? Secondo Pettorelli, il motivo è
semplice. “La riforma Madia ha provocato tutta una serie di complicanze
burocratiche e ora, nel momento della verità, i nodi arrivano al pettine”. Da un
lato i problemi legati ai protocolli di volo. “Quelli dei forestali erano
diversi da quelli adottati dai vigili del fuoco: per cui molti piloti hanno
dovuto rivedere le procedure e questo ha prodotto ritardi”. Poi c’è il problema
della manutenzione. “Sembra assurdo – prosegue Pettorelli – ma si è arrivati a
luglio, cioè al mese più critico dell’anno, con vari elicotteri non autorizzati
a volare”. La prima parte del 2017 ha visto una corsa contro il tempo per
riassegnare ruoli e competenze un tempo svolti dai Forestali: così anche
la manutenzione è stata ritardata. Risultato? Elicotteri parcheggiati negli
hangar, in attesa di un certificato, mentre i boschi sono in fiamme. Quelli che
fino al 2016 appartenevano alla Forestale non sono gli unici velivoli di cui
dispone lo Stato. La flotta italiana conta anche su 16 Canadair, dislocati su 14
diverse basi sul territorio nazionale, più altri mezzi – privati, talvolta, o
messi a disposizione dalle Capitanerie di porto – cui ci si affida attraverso
delle convenzioni ad hoc. Ma è evidente che i problemi connessi alla riforma
Madia si fanno sentire. Soprattutto per le Regioni, cui compete la gestione
dell’antincendio boschivo, per il quale sono obbligate a mettere a punto ogni
anno un piano specifico. Alcune – come il Veneto e la Toscana – hanno deciso,
nel tempo, di organizzarsi in maniera sempre più autonoma, facendo affidamento
sui propri dipendenti o sui volontari della Protezione Civile. La maggior parte,
però, continua a scegliere la soluzione più canonica delle convenzioni. Che,
fino all’anno scorso, venivano stipulate sempre con la Forestale e i vigili del
fuoco. Ora che il primo di questi corpi è stato soppresso e il secondo è
costretto a fare i salti mortali per coprire tutti gli interventi, la situazione
è molto più complicata. Soprattutto perché a non essere operativi sono appunto i
mezzi aerei. Un esempio su tutti riguarda la regione più martoriata dalle fiamme
in questi giorni. La Sicilia, fino a tutto il 2016, ha potuto contare su 4
Ab412: li utilizzava praticamente come propri, ma di fatto appartenevano alla
Forestale. Non è più così, da quest’anno. E i risultati sono nelle pagine della
cronaca.
Elicotteri fermi, ex Forestali senza
formazione e caos burocratico: "Nella lotta agli incendi la macchina dello Stato
si è inceppata". Cgil Vigili del Fuoco: "Dopo la legge
Madia il caos". Bonelli: "Solo 4 elicotteri ex CFS in uso su 32", scrive il
13/07/2017 Claudio Paudice, Giornalista, su L'Huffington Post". Elicotteri a
terra senza manutenzione, personale bloccato dalla burocrazia, convenzioni
regionali che mancano. È in queste condizioni che la macchina dello Stato si è
presentata all'appuntamento con l'emergenza incendi. Il Sud Italia brucia ormai
da giorni. Sicilia e Vesuvio, Gargano e Salento, Calabria e Sardegna sono le
aree più colpite: da ore i vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per
spegnere le fiamme. A Napoli il comitato per la Sicurezza ha disposto l'invio
dell'esercito per presidiare il Parco Nazionale del vulcano e contrastare la
mano criminale che si nasconde dietro i roghi. Perché sulla natura dolosa della
gran parte degli incendi non ci sono dubbi. "Quello che è mancato in questa
emergenza è stato il controllo del territorio. Quel controllo capillare che
aveva il Corpo Forestale dello Stato è venuto meno", dice all'HuffPost Mauro
Giulianella, coordinatore nazionale Cgil Vigili del Fuoco. "Ora i risultati
della legge Madia che ha disposto l'accorpamento della Forestale sono sotto gli
occhi di tutti". È la legge, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, che ha
disposto l'accorpamento del CFS con Carabinieri e Vigili del Fuoco a finire
sotto accusa di sindacati e ambientalisti. "L'iter burocratico necessario al
passaggio di uomini e mezzi della Forestale agli altri corpi si è bloccato.
Abbiamo elicotteri fermi perché non è stata fatta manutenzione. Quanti sono? Non
lo sappiamo perché nonostante le richieste che abbiamo fatto, l'amministrazione
non ci voluto fornire i numeri". Secondo la Protezione Civile la flotta statale
è così composta: 16 Canadair e 20 elicotteri, ai quali vanno aggiunti altri 34
in dotazione alle Regioni. È infatti in capo alle Regioni la competenza dello
spegnimento, a cui lo Stato centrale fornisce supporto. Tuttavia non ci sono
informazioni certe sul loro numero dei mezzi effettivamente dispiegato in questi
giorni di emergenza. "Abbiamo chiesto informazioni ma non ci sono state date",
dice Giulianella. Tra questi, ci sono i 32 elicotteri che erano in dotazione al
Corpo Forestale. Secondo il leader dei Verdi Angelo Bonelli (che su questo ha
presentato un esposto alla Corte dei Conti e alla procura di Roma), per effetto
della legge Madia che ne ha decretato lo scioglimento "16 sono andati ai
Carabinieri e 16 ai Vigili del Fuoco. Ma quelli che sono andati ai Carabinieri
non possono essere utilizzati perché devono rispondere a criteri diversi
rispetto al precedente corpo d'appartenenza. E poi chi deve guidare quegli
elicotteri deve fare degli aggiornamenti per assolvere ai criteri di volo
previsti. Solo quattro, ma un quinto sta per essere attivato, sono in utilizzo",
denuncia Bonelli. Un problema che riguarda anche il personale ex CFS. "Degli
ottomila Forestali, 6400 sono andati a Carabinieri ma non svolgono attività di
spegnimento perché la legge non lo prevede. Circa 1200 sono stati collocati in
diverse strutture della Pubblica amministrazione, e solo 360 sono stati
trasferiti ai Vigili del Fuoco". Non solo: secondo Bonelli "prima il CFS
assolveva alla funzione di Dos (direttori operazioni spegnimento) mentre ora le
attività di spegnimento sono in capo solo ai Vigili del fuoco che sono sotto
organico di tremila unità. C'è una grande confusione, e la cosa allucinante è
questo buco nero che si è aperto a causa della riforma Madia, pensata solo in
ottica di spending review senza una stima previsionale degli effetti che avrebbe
potuto causare sul territorio". Parole che trovano conferme nella denuncia di
Giulianella: "Il personale ex Forestale non è impiegato a pieno regime in tutto
il territorio perché non tutte le unità sono state sottoposte alla formazione
necessaria prevista dalla legge. A Rieti, per esempio, uno dei Comandi con il
numero più alto di Forestali, il personale ha enormi difficoltà a essere
operativo: per la questione dei mezzi, per gli hangar contesi con l'Arma dei
Carabinieri, per la manutenzione". Anche i mezzi di terra per lo spegnimento
sono in condizione precarie: "Guardi, quando è scoppiata l'emergenza incendi
sono stati inviati 16 convogli dal Nord al Sud Italia. Ma molti sono vetusti, di
vecchissima generazione. E sa quanto ci hanno impiegato per raggiungere le aree
colpite? Venti ore", scandisce Giulianella. I problemi però sono innumerevoli.
Come le Convenzioni regionali che non tutte le regioni hanno predisposto. Una su
tutte la Sicilia - la più colpita dai roghi - già al centro di un duro botta e
risposta tra il capo della Protezione civile Curcio e il Governatore Rosario
Crocetta a inizio luglio. Il problema principale discende dalla 'Direzione delle
operazioni di spegnimento', il Dos, che veniva garantita in convenzione con le
Regioni dal personale specializzato del Corpo Forestale. "Oggi non tutte quelle
convenzioni, che devono essere stipulate con il Corpo dei Vigili del Fuoco, sono
state ancora firmate. E del personale Dos confluito nei Carabinieri, l'Arma non
sa cosa farsene".
Sicilia brucia, costo canadair: 15mila
euro l’ora. Ecco chi ci guadagna, scrive Patrizia Vita
il 12 luglio 2017 su “L’Eco del Sud". C’è una chiave di lettura diversa da
quella sin qui sposata dall’opinione pubblica, riguardo i roghi che ogni estate,
ma mai come questa, hanno devastato migliaia di ettari di terreno in Sicilia.
Una pubblica opinione suffragata dalla politica, regionale e dei vari Comuni:
“C’è la mano dell’uomo dietro gli incendi. La mano di pecorai, mafiosi,
forestali con ansia da contratto”. Così, dall’alto delle loro poltrone, loro, i
politici, si mondano da ogni responsabilità. E nel pensiero comune, dunque,
dagli all’untore. Eppure, arriva su un blog, quello dei forestali ‘incriminati’
a furor di popolo, l’altra chiave di lettura, quella che mette a posto, come in
un mosaico che non trova perfezione, il tassello giusto al posto giusto: c’è
tanto business dietro i roghi. Partiamo dai costi dei canadair e degli
elicotteri: 15mila euro l’ora i primi, 5000 l’ora i secondi. “La Regione
Siciliana spende mediamente una decina di milioni per gli elicotteri e circa tre
milioni per i Canadair – si legge nel blog – e la Protezione Civile intasca
circa 13 milioni di euro l’anno, puliti-puliti. Chi ha interesse a che questo
business vada avanti?” –Chiedono i forestali -. Ed ancora: “cominciano a sorgere
gruppi privati di flotte aeree antincendio – spinte dal numero sempre crescente
di incendi. Altro che “mafie pecoraie” e “forestali piromani”, che recitano solo
da utili comparse in questa tragicommedia coloniale della “Terra bruciata”.
Senza tralasciare la ‘denuncia’ più importante, vale a dire che la Sicilia ha
‘regalato’ foreste ennesi dell’AFOR a una multinazionale tedesca che le
trasforma, bruciandole, in biomasse (corrente elettrica ‘pulita e rinnovabile’).
La regione paga il triplo nella bolletta coloniale più cara d’Europa. Un fiume
di milioni sufficiente a comprarci una intera flotta di canadair antincendio.
Anche l’alibi della mafia pecoraia e vaccara, che brucia boschi per farne
pascolo, viene sapientemente, intelligentemente, smontato: “Pascoli per farne
che? – si obietta – Visto che la Sicilia importa dalla Padania e l’UE – in
valore – il 95% di carni & derivati. E anche nel ciclo agroindustriale dei
latticini non gode di buona salute.” A tirare di somma, dunque, abbiamo capri
espiatori che rispediscono al mittente le accuse; una politica sciatta e
inadempiente che preferisce pagare milioni di euro invece di spendere, magari la
stessa cifra una sola volta e non annualmente, per dotarsi di squadre
antincendio, dotate di mezzi e strumenti propri. Una politica non in grado di
affrontare le emergenze e che risolve sempre tutto con la dichiarazione di stato
di calamità. Ma i piromani esistono? Ovvio che sì, ma nessuno pensi che siano
geni del male, strategici pianificatori, inarrestabili nella loro follia
criminosa. E soprattutto non ci si voglia far credere che a fronte di una spesa
da 13 milioni di euro l’anno destinata alla protezione Civile, a fronte di danni
ad aziende, agricoltura, paesaggi, ci si possa lasciare spaventare da un pastore
di pecore o vacche.
Chi ha interesse a incendiare la Sicilia?
Il dopo-fuoco e il grande business di elicotteri e Canadair,
scrive il 12 luglio 2017 "I Nuovi Vespri". Da sempre sul banco degli imputati
come possibili piromani, si scopre che operai della Forestale e pastori non
hanno nulla da guadagnare dal fuoco. Ad avere possibili interessi con la Sicilia
in fiamme potrebbero essere altri soggetti. Gli interventi per la ricostituzione
delle aree verdi. E il grande giro di affari su elicotteri e Canadair. Mentre la
Sicilia continua a bruciare (dopo Messina, dove i danni sono ingentissimi, è la
volta della provincia di Trapani: il fuoco ha fatto la propria apparizione nel
villaggio turistico di Calampiso, con la gente che è fuggita via mare, fiamme
a San Vito Lo Capo e una nuova minaccia per la Riserva Naturale dello Zingaro,
negli anni passati già incenerita da un incendio), forse perché sulla vicenda
sta intervenendo la magistratura, si comincia a cercare di capire chi ci
guadagnerà con il fuoco che si sta mangiando buona parte del verde della
Sicilia. Interessi legati agli elicotteri? O ai Canadair? O c’è ancora
dell’altro? Sulla rete i soliti noti – quelli sempre pronti ad attaccare “gli
oltre 20 mila operai della Forestale della Sicilia che non fanno niente” – sono
in netta diminuzione. Ed è anche logico: ci sono fatti oggettivi che sono sotto
gli occhi di tutti:
come ignorare il fatto che gli operai della
Forestale, quest’anno, sono stati inviati al lavoro dopo il 15 giugno?
come ignorare il fatto che le opere di prevenzione
degli incendi non sono state effettuate?
come si fa a ignorare le erbe secche e le
sterpaglie abbandonate in tutte le aree verdi dell’Isola?
Insomma, le accuse gratuite contro gli operai
della Forestale non convincono più. In questa storia degli incendi che, ormai da
quasi una settimana, stanno mandando in fumo anni e anni di lavoro (un bosco non
si sviluppa in un paio di anni), contribuendo a desertificare la Sicilia,
giocano tanti fattori. Il primo elemento che salta agli occhi è la capillarità
degli incendi di questi giorni: un mozzicone di sigaretta gettato in un bosco
con un sottobosco pieno di erbe secche e sterpaglie, complice il vento, può
causare il finimondo. Ma da quasi una settimana il fuoco è in tutte le aree
verdi dell’Isola. Il caso c’entra poco. Si tratta, con molta probabilità, di
incendi dolosi, dietro ai quali c’è una strategia. Sulla pagina facebook
del Si.F.U.S. (Sindacato Forestali Uniti per la Stabilizzazione) ci sono tanti
post che affrontano il tema da tante sfaccettature. Abbiamo già parlato delle
possibili speculazioni sulle opere successive agli incendi. Ma c’è un altro
filone: i mezzi di soccorso. E poiché gli incendi sono stati tanti e sono ancora
tanti – e quasi tutti con ampio raggio di fuoco – sono intervenuti e continuano
ad intervenire elicotteri e Canadair. Sempre nella pagina facebook è
interessante un articolo pubblicato da l’ecodelsud.it quotidiano indipendente di
informazione della Sicilia e della Calabria. In questo articolo – che riprende
alcune considerazioni degli operai della Forestale – si parla proprio di
elicotteri e Canadair. “La Regione siciliana – si legge nell’articolo – spende
mediamente una decina di milioni per gli elicotteri e circa tre milioni per i
Canadair e la Protezione Civile intasca circa 13 milioni di euro l’anno,
puliti-puliti. Chi ha interesse a che questo business vada avanti?” chiedono i
forestali. In realtà, proprio oggi abbiamo cercato – senza riuscirci – di
saperne di più dei Canadair. E’ noto che un’ora di volo di questo aereo anfibio
costa circa 14 mila euro. Noi pensavamo che il costo dei Canadair fosse a carico
della Protezione civile nazionale. Ci siamo sbagliati. E’ la Regione siciliana
che paga il servizio dei Canadair. E poiché, da oltre una settimana, in Sicilia
questi aerei anfibi svolgono un servizio quasi h 24, non possiamo non porre una
domanda: si risparmia sugli operai della Forestale, sulla vigilanza degli stessi
operai nelle aree verdi della Sicilia e poi spendiamo un sacco di soldi per i
Canadair? E quanto stanno costando, quest’anno, i Canadair? E infatti l’articolo
pubblicato da l’ecodelsud.it arriva alle nostre stesse conclusioni: “A tirare di
somma, dunque, abbiamo capri espiatori che rispediscono al mittente le accuse;
una politica sciatta e inadempiente che preferisce pagare milioni di euro invece
di spendere, magari la stessa cifra una sola volta e non annualmente, per
dotarsi di squadre antincendio, dotate di mezzi e strumenti propri. Una politica
non in grado di affrontare le emergenze e che risolve sempre tutto con la
dichiarazione di stato di calamità”. E poi? “Cominciano a sorgere gruppi privati
di flotte aeree antincendio – leggiamo sempre nell’articolo – spinte dal numero
sempre crescente di incendi. Altro che mafie pecoraie e forestali piromani, che
recitano solo da utili comparse in questa tragicommedia coloniale della Terra
bruciata”. E ancora: “Anche l’alibi della mafia pecoraia e vaccara, che brucia
boschi per farne pascolo, viene sapientemente, intelligentemente, smontato:
Pascoli per farne che? – si obietta – Visto che la Sicilia importa dalla Padania
e l’UE – in valore – il 95% di carni & derivati. E anche nel ciclo
agroindustriale dei latticini non gode di buona salute”. Ultima considerazione:
in forza di una campagna di stampa discutibile è stata fatta passare la già
citata tesi che “gli oltre 20 mila operai della Forestale siciliana non fanno
nulla e si sprecano un sacco di soldi”. Peccato che gli operai della Forestale
la Regione siciliana li paga con i soldi dei Siciliani, cioè con le proprie
entrate. Ma grazie alla campagna di stampa non certo casuale lo Stato ha
tagliato alla Regione anche una parte dei fondi per le attività di tutela delle
aree verdi. La Regione amministrata dal centrosinistra – protagonisti
l’assessore-commissario all’Economia, Alessandro Baccei, l’assessore
all’Agricoltura, Antonello Cracolici, e l’assessore al Territorio e
Ambiente, Maurizio Croce – ha risparmiato sulle attività di prevenzione degli
incendi: ma i risparmi stanno in buona parte servendo per elicotteri e Canadair.
Servono – gli elicotteri e i Canadair – per spegnere gli incendi, non certo per
prevenirli: così, al danno ambientale gravissimo, si somma la beffa di pagare
anche elicotteri e aerei anfibi. Per avere, alla fine, terre bruciate. Peggio di
così – almeno per ciò che riguarda i boschi – una Regione non può essere
amministrata.
…E poi scopri che i Canadair e gli elicotteri
antincendio sono gestiti da privati! …E Ti rendi conto che gli incendi fanno
girare tanti, ma proprio tanti soldi…! Incendi/ Sorpresa: i Canadair e gli
elicotteri antincendio sono gestiti da privati!
Lo scrive sulla propria pagina facebook Gherardo
Chirici, professore associato di Inventari forestali e telerilevamento presso
Università degli Studi di Firenze. Contratti sempre alle stesse ditte. Chiede il
docente: “E se non ci fossero più incendi queste ditte che vendono i loro
servizi di antincendio otterrebbero ancora i loro appalti milionari?”
Sorpresa: i Canadair che in questi giorni
sorvolano il Sud Italia, e in particolare la Sicilia, al costo di 14 mila euro
l’ora, per spegnere gli incendi sono gestiti da privati. La stessa cosa riguarda
gli elicotteri per il salvataggio e la lotta agli incendi. Lo scrive sulla
propria pagina facebook Gherardo Chirici, professore associato di inventari
forestali e telerilevamento presso Università degli Studi di Firenze. Post
riportato sulla pagina facebook del SI.F.U.S., il Sindacato Forestali Uniti per
la Stabilizzazione. “Tutti forse lo sanno già… – scrive il docente universitario
– ma vorrei ricordare che la nostra famosa flotta di 19 Canadair così come la
maggior parte della flotta di elicotteri per il salvataggio e la lotta agli
incendi è privata. Ogni anno i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e gli
altri enti danno in appalto questi servizi di soccorso dal cielo. I contratti se
li aggiudicano sempre le stesse ditte”. Possibile? A quanto pare sì: Tant’è –
scrive sempre il professore Gherado Chirici – che dopo aver osservato un
campione di 18 gare d’appalto, è intervenuta l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. Amaro il commento del docente universitario: “E se
non ci fossero più incendi queste ditte che vendono i loro servizi di
antincendio otterrebbero ancora i loro appalti milionari? Quando vedete un bel
Canadair che sgancia la sua bomba d’acqua di 6000 litri pensateci…”.
Elicotteri e Canadair, il soccorso dal
cielo nelle mani dei privati. Sono sette aziende sulle
quali indaga l'Antitrust, scrive Corrado Zunino il 19 luglio 2017 su "La
Repubblica". La flotta aerea — Canadair ed elicotteri — che ancora ieri lanciava
acqua e ritardante sugli incendi del Vesuvio, della Maremma grossetana, sopra
Castelfusano pineta di Roma, in venti municipi del Cosentino, su un parco
pubblico di Catanzaro e tra Genova e Arenzano (ventisette i roghi più gravi), è
gestita dai vigili del fuoco e dalle Regioni. Ma è nelle mani — e nei profitti —
di sette aziende private. Sei italiane, la settima è una multinazionale
britannica con capitale spagnolo. Dallo scorso marzo i sette gruppi sono sotto
inchiesta da parte dell’Antitrust e oggi l’Autorità garante del mercato deciderà
come portare avanti un procedimento che ha già fatto emergere anomalie plateali
e «alterazioni dei costi pubblici» (aumenti, quindi). Con la crisi della
Protezione civile post Bertolaso (a partire dal 2012) e la legge Madia vigente
da gennaio 2017 (il Corpo forestale diluito nell’Arma dei carabinieri), molte
cose sono cambiate nell’affrontare gli incendi in Italia. Sui roghi boschivi ora
i vigili del fuoco hanno operatività totale, a terra e in cielo. La flotta aerea
dello Stato, una delle più grandi al mondo, è costituita da 19 Canadair di
proprietà della Repubblica italiana (sedici sono attivi) e messi a disposizione
dei vigili più dodici elicotteri. I 31 mezzi sono dislocati su quattordici basi,
da Comiso a Genova. Solo il costo dell’utilizzo dei Canadair pesa 55 milioni
l’anno, a cui vanno aggiunte le ore di volo. Quest’anno nel periodo 15 giugno-13
luglio i Canadair hanno fatto interventi per 2.146 ore (+378% rispetto al 2016)
costando fin qui quattro milioni e mezzo di euro. Ecco, gli uffici
dell’Antitrust, sollecitati nel maggio 2016 da un pilota e dirigente di
un’azienda piemontese estromessa dal business, hanno verificato che almeno dal
Duemila i sette gruppi si sono mossi in modo da far vincere l’azienda scelta
all’interno del loro cartello prendendo la gara con ribassi risibili (massimo
l’un per cento). Una «spartizione collusiva» su tutto il territorio «con ipotesi
di turbativa d’asta». Le gare d’appalto indicate dalla fonte sono 32 (16 per
l’emergenza incendi, 16 per il soccorso aereo), l’istruttoria dell’Autorità per
ora ne ha riscontrate diciotto in dieci regioni, tutte allestite tra il 2009 e
il 2016. E ha trovato conferme alla denuncia. Tra questi bandi c’è il
contrattone nazionale della Protezione civile del 2011 — l’utilizzo dei 19
Canadair — vinto dalla Babcock Italia (ex Inaer), corporation, quotata al London
Stock Exchange che per ogni aereo offre due piloti suoi. Quindi, diciassette
appalti regionali per elicotteri di pronto intervento. Questi li hanno vinti sei
società italiane, tutte del Nord, per gare allestite dalle Regioni Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli, Toscana, Lazio, Sardegna, Campania e
Sicilia. Il Lazio, nel 2016, ha assegnato l’appalto alla Heliwest di Isola
d’Asti: 10 milioni, 10 elicotteri a disposizione. La Finanza ha sequestrato i
documenti. In Valle d’Aosta l’unico offerente nel 2009 e nel 2014 è stato
Airgreen di Robassomero (Torino). In Friuli nel 2015 unico partecipante (e
vincitore) dopo un’asta andata deserta è stata Elifriulia di Ronchi dei
Legionari. L’Antitrust ipotizza che le sette sorelle del soccorso dal cielo (ci
sono anche Eliossola di Domodossola, Elitellina di Sondrio e Star Work Sky di
Strevi, Alessandria) abbiano condizionato «in senso anticompetitivo le procedure
pubbliche di affidamento». Tutte e sette le aziende sono nell’Associazione
elicotteristica italiana, a sua volta responsabile «di un’intesa restrittiva
della concorrenza». La multinazionale Babcock allo spegnimento degli incendi
italiani offre 19 Canadair, gli altri sei gruppi sotto inchiesta 90 elicotteri e
3 aerei Cessna.
Le stranezze sugli appalti per i
Canadair: ecco la decisione del Garante della Concorrenza.
Tutto è partito dalla segnalazione di possibili illeciti fatti da
un pilota di elicotteri che opera nel settore e "legge" dal di dentro, le
stranezze delle partecipazioni alle gare d'appalto, scrive "Globalist" il 17
luglio 2017. Quindicimila euro l’ora per l'intervento di un canadair, 5000 l’ora
per quello di un elicottero. Alla vigilia di questa estate di fuoco, l'Autorità
Garante della Concorrenza ha iniziato ad occuparsi del business dello
spegnimento degli incendi legato alla flotta dei Canadair. Di seguito,
integrale, il documento con il quale il Garante ha deciso di aprire
un'istruttoria. Tutto parte dalla denuncia di un pilota che ben conosce
l'ambiente e chi si muove in questa ricca fetta di mercato. Fase istruttoria che
si dovrà chiudere entro l'ottobre del 2018. Questo per quel che riguarda il
Garante, se nel frattempo non intervenisse la magistratura ordinaria, adesso
impegnata, in diverse Procure a fare luce sulle responsabilità e sulla regia
degli incendi. Ricordiamo che in Italia, la flotta di 19 Canadair cosi come la
maggior parte della flotta di elicotteri per il salvataggio e la lotta agli
incendi è privata. Il Garante si muove ed apre una istruttoria - come detto -
dopo la denuncia di un pilota che parla degli attori di questo business. Mercato
che apparirebbe segnato da accordi che non sono proprio sul binario del rispetto
della concorrenza.
I contratti se li aggiudicano sempre le stesse
ditte. A ricordarlo, nella sua pagina Facebook, in questi giorni è anche
Gherardo Chirici, professore associato di inventari forestali e telerilevamento
presso Università degli Studi di Firenze. Il passato dell'affaire Canadair è
travagliato e segnato da qualche "stranezza". Non solo nel passato, visto che il
Garante dopo aver osservato un campione di 18 gare d'appalto, ha ritenuto "che
le condotte poste in essere dalle società Babcock Mission Critical Services
Italia S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A.), Airgreen S.r.l., Elifriulia
S.r.l., Heliwest S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Star Work Sky
S.a.s. e dall’Associazione Elicotteristica Italiana sono suscettibili di
configurare un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo
101 del Tfue.". Ma andiamo a leggere l'integrale del Garante per la Concorrenza:
"In data 13 maggio 2016 è pervenuta una segnalazione volta a denunciare asserite
condotte illecite, anche di natura anticoncorrenziale, perpetrate in relazione
all’affidamento e all’esecuzione di appalti pubblici aventi ad oggetto la
prestazione di servizi di antincendio boschivo e di elisoccorso. Tale
segnalazione è stata integrata con ulteriore documentazione prodotta in data 30
maggio 2016. La segnalazione proviene da un operatore del mercato interessato,
quale pilota di elicotteri e titolare di un’impresa con sede in Piemonte, che
lamenta condotte di condizionamento e turbativa di numerose gare pubbliche
bandite a livello regionale – per una complessiva ampiezza nazionale del
fenomeno denunciato – e riconducibili a sette operatori del settore appartenenti
all’Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) nel cui ambito si sarebbe
realizzata la contestata spartizione degli appalti pubblici.
Le parti - Il segnalante è un pilota
professionista di elicotteri, titolare di qualifiche riconosciute dall’ENAC ed
EASA di dirigente e responsabile di attività di trasporto aeronautico ed opera
da svariati anni, anche come titolare di imprese, nel settore del trasporto
aereo e di antincendio ed elisoccorso. - I partecipanti all’intesa: Babcock
Mission Critical Services Italia S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A., di
seguito, in breve, “Babcock MCS” già “Inaer”) è una società con sede legale a
Milano e sede operativa in provincia di Lecco ed attiva nel settore del
trasporto aereo di passeggeri e merci e dei servizi di soccorso aereo ed
antincendio. Il capitale sociale è interamente posseduto da una società di
diritto spagnolo. Il valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari a circa
duecento milioni di euro. Nel marzo 2017 la società ha mutato la precedente
denominazione sociale Inaer Aviation Italia S.p.A. in Babcock Mission Critical
Services Italia S.p.A. Airgreen S.r.l. (di seguito, in breve, “Airgreen”) è una
società con sede legale in provincia di Torino ed attiva nel settore del
trasporto aereo non di linea e dei servizi di soccorso aereo ed antincendio. Il
valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari a circa venti milioni di euro.
Elifriulia S.r.l. (di seguito, in breve, “Elifriulia”) è una società con sede
legale in provincia di Gorizia ed attiva nel settore del trasporto aereo non di
linea e dei servizi di soccorso aereo ed antincendio. Il valore di fatturato
dell’esercizio 2015 è pari a circa dieci milioni di euro. 7. Heliwest S.r.l. (di
seguito, in breve, “Heliwest”) è una società con sede legale in provincia di
Asti ed attiva nel settore del trasporto aereo non di linea e dei servizi di
soccorso aereo ed antincendio. Il valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari
a circa nove milioni di euro. Eliossola S.r.l. (di seguito, in breve,
“Eliossola”) è una società con sede legale in provincia di Verbania ed attiva
nel settore del trasporto aereo non di linea e dei servizi di soccorso aereo ed
antincendio. Il valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari a circa cinque
milioni di euro. Elitellina S.r.l. (di seguito, in breve, “Elitellina”) è una
società con sede legale in provincia di Sondrio ed attiva nel settore del
trasporto aereo non di linea e dei servizi di soccorso aereo ed antincendio. Il
valore di fatturato dell’esercizio 2015 è pari a circa dieci milioni di euro.
Star Work Sky S.a.s. di Giovanni Subrero & C. (di seguito, in breve, “Star
Work”) è una società in accomandita semplice con sede legale in provincia di
Alessandria ed attiva nel settore del trasporto aereo non di linea e dei servizi
di soccorso aereo ed antincendio. Associazione Elicotteristica Italiana (di
seguito, in breve, “AEI”) è un’associazione senza fini di lucro finalizzata ad
individuare le esigenze presenti e future dell’elicottero, promuoverne l’impiego
presso gli enti governativi, le amministrazioni regionali e locali, le aziende
private e il pubblico in genere. Allo stato AEI è composta da soci manutentori
/venditori di aeromobili e operatori aerei. In particolare, dei 15 attuali soci
di AEI, sette (le Parti sopra riportate) sono operatori aerei titolati a
svolgere attività di trasporto e lavoro aereo commerciale, gli altri soci sono
imprese che si occupano di manutenzione e/o vendita di aeromobili. La presidenza
e gli organi direttivi dell’associazione sono composti da esponenti e
rappresentanti delle imprese socie.
Il fatto - Le vicende oggetto di segnalazione
concernono ipotesi di condotte anticompetitive volte a condizionare lo
svolgimento e l’esito di svariate gare pubbliche concernenti l’affidamento di
servizi di elisoccorso (HEMS, Helicopters Emergency Medical Service, secondo un
acronimo anglosassone) ed anti-incendio boschivo (fire-fighting o AIB). 13. Nel
dettaglio, il segnalante delinea uno scenario fattuale in cui le Parti si
sarebbero spartite a livello nazionale il mercato relativo ai riferiti servizi,
secondo meccanismi di turbativa d’asta realizzati, per quanto rileva sotto il
profilo antitrust, combinando in modo sistematico i seguenti ordini di condotte
illecite di coordinamento nelle strategie partecipative: - partecipazione alle
gare singolarmente o in raggruppamenti variabili tra le medesime imprese in modo
che per ciascuna gara figuri un solo offerente (in forma singola o associata)
che riesce ad aggiudicarsi l’appalto senza ribasso o con ribassi risibili
(sovente inferiori all’1%); - mancata partecipazione alle gare sì da farle
andare deserte e indurre la stazione appaltante a riaffidare in trattativa
privata la commessa al precedente assegnatario. Il segnalante dichiara che tali
condotte sono state poste in essere in modo sistematico e da svariati anni (sin
dai primi anni del 2000) su gran parte delle gare bandite, a livello regionale,
dalle amministrazioni competenti per l’affidamento dei due servizi menzionati,
oltreché, per l’appalto AIB – flotta aerea della protezione civile, a livello
nazionale e ha prodotto una tavola riepilogativa in cui individua per ciascuna
regione e servizio i vari aggiudicatari (singolo o in ATI), secondo una
mappatura ripartitoria in cui figurano quasi esclusivamente i sette operatori
facenti parte dell’AEI individuati quali parti del presente procedimento. In
particolare, la tavola riepilogativa riporta un totale di 32 affidamenti – che
il segnalante definisce “contratti” – in essere tra le stazioni appaltanti e i
suddetti operatori, distinti tra servizi AIB (16 contratti) e servizi HEMS (16
contratti). Il segnalante sostiene che la condotta collusiva contestata avrebbe
condizionato anche più gare d’appalto (cronologicamente consecutive) per ciascun
affidamento elencato nella tavola riepilogativa. Secondo la ricostruzione resa
dal segnalante, la ripartizione del mercato nei descritti termini sarebbe
avvenuta tra le Parti anche nell’ambito dell’Associazione AEI, alcuni dei cui
esponenti risultano riconducibili alle società partecipanti all’intesa qui
ipotizzata. In esito ad un preliminare vaglio preistruttorio, dalla
documentazione prodotta in sede di segnalazione e dagli ulteriori dati acquisiti
dall’ANAC3 e trasmessi dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza,
si sono ricostruite le dinamiche partecipative di un campione esemplificativo di
diciotto procedure ad evidenza pubblica sopra soglia (intendendosi per tali sia
singole gare che lotti autonomi di una medesima gara) bandite da dieci
amministrazioni regionali e, a livello nazionale, dalla protezione civile, in un
arco temporale che va dal 2009 al 2016. Dall’analisi delle procedure di gara sin
qui ricostruite emergono, prima facie, elementi di conferma delle modalità
partecipative segnalate con riferimento sia a servizi AIB che HEMS.
Si riporta, di seguito, la sintesi del preliminare
screening condotta su alcune delle gare oggetto di segnalazione, recante
l’evidenza degli elementi informativi utili a dare contezza delle condotte
partecipative contestate, ricostruiti sulla base della documentazione
disponibile. L’anno indicato è quello di aggiudicazione dell’affidamento,
ciascuno dei quali ha durata pluriennale. Committenza anno ribasso
aggiudicatario Piemonte Eliossola (unica offerta e operatore uscente del
precedente appalto) Lotto 2 Airgreen (operatore uscente del precedente appalto -
due offerte) AIB. Lotto 3 Star Work (due offerte. L’altra è stata presentata da
Heliwest, operatore uscente del precedente appalto) AIB 2012 1,2% ATI
Airgreen/Inaer (ora Babcock MCS, unica offerta) Hems Sardegna 2015 0,04% ATI
Airgreen/Eliossola/Elifriulia/Star Work/Elitellina (unica offerta) AIB 2012
0,01% ATI Airgreen/Eliossola/Elifriulia/Star Work/Elitellina (unica offerta) AIB
Liguria 2015 - Heliwest (procedura negoziata, riaffidamento al precedente
aggiudicatario) AIB 2012 0,5% Heliwest (due offerte. L’altra è stata presentata
da Star Work) AIB Lazio 2016 0,86% Eliossola (unico offerente) AIB 2012 0,75%
ATI Eliwest/Eliossola (unico offerente) AIB Veneto 2013 0,01% ATI con mandataria
Elifriulia AIB Valle d’Aosta 2014 0,43% Airgreen (unico offerente) HEMS 2009
0,16% Airgreen (unico offerente) HEMS Friuli Venezia Giulia 2015 25% Elifriulia
(unico offerente. In precedenza vi era stata una gara andata deserta) AIB
Campania 2012 0,25% ATI Heliwest/Eliossola/Elifriulia (unico offerente) AIB
Toscana 2011 0,7% ATI Elifriulia/Eliossola (unico offerente) AIB Sicilia 2011
0,84% ATI Heliwest/Elitellina/Elifriulia (unico offerente. Nella precedente gara
i tre operatori avevano partecipato in due raggruppamenti concorrenti) AIB
Protezione Civile Nazionale 2011 0,02% Inaer (ora Babcock MCS, unico offerente)
AIB
Invero, lo scrutinio di tali gare restituisce un
pattern partecipativo connotato da aggiudicazioni all’unico offerente in gara
(in forma singola o associata) con ribassi sovente prossimi allo zero o comunque
di entità ridottissima che potrebbe essere stato applicato anche ad altre
procedure ad evidenza pubblica oggetto di segnalazione. Gli aggiudicatari
coincidono con le parti del procedimento, che si alternano nelle varie gare,
singolarmente o in compagini collettive, distribuendosi in misura abbastanza
omogenea nelle varie regioni italiane (anche a distanza rispetto la loro
localizzazione aziendale) e tendendo, per quanto è possibile osservare dai dati
in possesso, a mantenere, anche sotto il profilo diacronico, il pregresso bacino
di dominanza o ad alternarsi per conservare la propria quota di mercato. La
documentazione agli atti offre, altresì, talune evidenze concernenti fattispecie
partecipative delle Parti di analogo segno a quelle sopra riportate anche in
relazione a procedure di gara concernenti altri servizi di trasporto aereo o
altri servizi aerei vari, bandite da amministrazioni o soggetti aggiudicatori
differenti dagli enti o organi della protezione civile. Da ultimo, il segnalante
rimarca come la costituzione dei raggruppamenti temporanei in cui risultano
talvolta figurare le Parti nelle gare censite non risulterebbe giustificata “da
un’ipotetica carenza di aziende qualificate e/o di dimensioni sufficienti a
concorrere singolarmente, perché praticamente tutte le sette aziende
appartenenti ad AEI hanno il potenziale ed il numero di elicotteri sufficiente
per concorrere singolarmente alla quasi totalità delle gare d’appalto”.
Valutazioni - Le condotte oggetto del presente
procedimento interessano il settore dei servizi di elisoccorso (HEMS) e
anti-incendio boschivo (AIB). I servizi HEMS si caratterizzano per attività di
soccorso sanitario effettuate mediante l’impiego di elicotteri dedicati, svolte
in favore di pazienti che versano in situazioni critiche e necessitano di
assistenza medica in tempi rapidi e in tutte le circostanze in cui una normale
ambulanza non è in grado di operare. Per altro verso i servizi anti-incendio
(fire-fighting o AIB) possono essere svolti sia mediante l’utilizzo di
elicotteri che attraverso altre tipologie di aeromobili. Dalla segnalazione
pervenuta emerge che gran parte delle imprese operanti nel settore svolge
entrambi i servizi di elisoccorso e anti-incendio. Per contro, risulta che solo
una delle società attenzionate (Inaer, ora Babcock MCS) si sia aggiudicata un
appalto AIB da espletarsi mediante utilizzo di aerei (di proprietà della
Protezione civile nazionale), mentre tutte le altre società risultano
affidatarie di contratti da eseguirsi con l’utilizzo di elicotteri. La domanda
dei descritti servizi viene espressa tramite gare pubbliche d’appalto, distinte
per tipologia di servizio (AIB o HEMS), bandite di regola a livello regionale
dai dipartimenti locali della protezione civile. Solo la gara concernente l’AIB
da effettuarsi con la flotta aerea della protezione civile è stata disposta su
base nazionale. Da una prima disamina di taluni capitolati di gara predisposti
dalla committenza regionale per l’affidamento dei descritti servizi, le
procedure a evidenza pubblica vengono aggiudicate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa o con il criterio del prezzo più basso, e tra i
requisiti di partecipazione viene richiesto, oltre a dati di fatturato generale
e specifico per servizi analoghi, la disponibilità, sia a titolo di proprietà
che in leasing, di un certo numero di elicotteri caratterizzati da puntuali
caratteristiche tecniche e determinato equipaggiamento. Secondo costante
orientamento giurisprudenziale, in materia di intese, la definizione del mercato
rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto
economico e giuridico nel quale si colloca l’accordo o la pratica concordata tra
imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell’ambito nel
quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla
decifrazione del suo grado di offensività. Nel caso in esame, in via di prima
approssimazione, il mercato può circoscriversi nell’ambito geografico e
merceologico delle gare condizionate mediante l’ipotizzata intesa di
ripartizione del mercato. Tali gare, in particolare, afferiscono ad affidamenti
pubblici, disposti a livello nazionale, regionale e locale, di servizi HEMS e
AIB. Non si esclude, inoltre, che la concertazione possa avere un perimetro più
ampio ed estendersi anche a gare pubbliche aventi ad oggetto l’affidamento di
altri servizi di trasporto aereo o altri servizi aerei vari. La qualificazione
dell’intesa. Il complesso degli elementi sopra descritti consente di ipotizzare
un coordinamento tra le Parti, che potrebbe risalire al 2000, al fine di
limitare il reciproco confronto concorrenziale nelle procedure pubbliche di
affidamento dei servizi HEMS e AIB attraverso un’intesa, nella forma di un
accordo e/o di una pratica concordata, avente ad oggetto la ripartizione del
mercato finalizzata all’aggiudicazione degli appalti oggetto di concertazione
con ribassi di ridotta entità, sovente prossima allo zero. Tale condotta
collusiva e spartitoria sarebbe stata posta in essere anche nell’ambito e per il
tramite dell’AEI, di cui tutti gli operatori Parti del presente procedimento
risultano essere soci. Invero, la documentazione agli atti restituisce elementi
segnaletici di possibili condotte concertative aventi ad oggetto il
condizionamento in senso anticompetitivo delle procedure ad evidenza pubblica.
Il pattern partecipativo che pare emergere, coerente a quanto prefigurato dal
segnalante, risulta caratterizzato da assenza di sovrapposizione e sincronismo
partecipativo delle Parti da cogliersi trasversalmente su un’ampia gamma di gare
ed affidamenti pubblici (che pare includere tutte le procedure ad evidenza
pubblica poste in essere a livello nazionale e regionale o locale per affidare
servizi AIB ed HEMS).
Infatti, le anomalie partecipative sintomatiche di
coordinamento nella presentazione dell’offerta per spuntare ribassi esigui, a
volte prossimi allo zero, risultano investire svariate procedure di gara su una
dimensione cronologica e geografica vasta. Le evidenze fattuali paiono
tratteggiare un’ipotesi di intesa anticoncorrenziale idonea a neutralizzare i
rischi di un effettivo confronto competitivo tra le Parti teso a stabilizzare
artificiosamente le rispettive quote di mercato. La descritta, ipotizzata,
condotta anticompetitiva pare essersi realizzata anche attraverso l’uso distorto
dei raggruppamenti temporanei di imprese, impiegati dalle Parti al fine precipuo
di spartirsi le commesse disinnescando il meccanismo competitivo tipico di una
gara pubblica. Attraverso siffatta, ipotizzata, condotta concertata, le Parti
potrebbero aver alterato sensibilmente la libera formazione dei prezzi
nell’ambito delle gare pubbliche in esame, riducendo al minimo i ribassi offerti
e determinando così un innaturale innalzamento del valore economico delle
commesse. Le evidenze, anche documentali, prodotte dal segnalante e gli
ulteriori elementi agli atti consentono di ipotizzare un’ampia latitudine delle
possibili condotte concertative, tale da eventualmente ricomprendere tutte le
gare bandite da qualunque stazione appaltante ed aventi ad oggetto non solo i
servizi HEMS e AIB ma anche altri servizi di trasporto aereo o altri servizi
aerei vari. In tal senso, il presente procedimento è volto a verificare ed
eventualmente acclarare ipotesi di collusione anche in siffatto, più esteso,
ambito operativo. In considerazione della rilevanza comunitaria delle procedure
di gara in questione e del fatto che i servizi oggetto delle medesime
interessano l'intero territorio nazionale, l’intesa ipotizzata appare idonea,
laddove accertata, a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza,
la fattispecie oggetto del presente procedimento verrà valutata ai sensi
dell’articolo 101 del TFUE.
Ritenuto, pertanto, che le condotte sopra
descritte poste in essere dalle società Babcock Mission Critical Services Italia
S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A.), Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l.,
Heliwest S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Star Work Sky S.a.s. e
dall’Associazione Elicotteristica Italiana sono suscettibili di configurare
un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del
TFUE;
Delibera.
a) l'avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo
14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Babcock Mission Critical
Services Italia S.p.A. (già Inaer Aviation Italia S.p.A.), Airgreen S.r.l.,
Elifriulia S.r.l., Heliwest S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Star
Work Sky S.a.s. e dell’Associazione Elicotteristica Italiana per accertare
l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE;
b) la fissazione del termine di giorni sessanta
decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da
parte dei legali rappresentanti delle Parti, o di persone da essi delegate, del
diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà
pervenire alla Direzione “Manifatturiero e Servizi” di questa Autorità almeno
quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è il dott.
Massimo Lupi;
d) che gli atti del procedimento possono essere
presi in visione presso la Direzione “Manifatturiero e Servizi” di questa
Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi
delegate;
e) che il procedimento deve concludersi entro il
31 ottobre 2018. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 10 Il presente
provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel
Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il segretario generale Roberto Chieppa
Il presidente Giovanni Pitruzzella
L’Italia brucia. La colpa è dei piromani?
Scrive il 15 luglio 2017 Salvo Vitale su "Tele Jato".
ORMAI È DIVENTATO UN LUOGO COMUNE: SONO I PIROMANI A DARE FUOCO, LE CAUSE
NATURALI E LE RESPONSABILITÀ DEL DEGRADO AMBIENTALE SONO ELEMENTI SECONDARI E
TRASCURABILI. Secondo qualche improbabile statistica i piromani sarebbero
responsabili del 90% degli incendi. E quindi caccia al piromane che, nella quasi
totalità dei casi si risolve in un nulla di fatto, vallo a trovare, sia perché
non c’è, sia perché, se ce n’è qualcuno, non è così scemo da farsi prendere.
Qualche volta si becca qualche stupidotto brucia qualcosa per sbarazzarsi di
qualche carta, o qualche coltivatore che vuole liberarsi dalle sterpaglie
bruciandole, e magari poi non riesce a tenere sotto controllo le fiamme. Poi, i
nostri giornalisti bravi a dire tutti sempre le stesse cose, si scatenano,
provando a fare inchieste, sul “cui prodest”, cioè a chi può convenire che
un’area bella, dove sia stato bruciato il verde che c’era attorno, e quindi
desertificata, acquisti valore soprattutto dopo che, per i prossimi dieci anni
non si potrà porre in atto alcuna speculazione edilizia, per legge. E giù di lì
a ipotizzare interessi nascosti, le mani della criminalità sulla terra, piani
regolatori a lunga prospettiva con aree agricole che potrebbero diventare
edificabili. Nel momento in cui c’è poi da andare a concretizzare queste accuse
con nomi, cognomi, proprietari, piani di lottizzazione, non si trova nulla o, se
si trova qualche debole indizio se ne approfitta per utilizzarlo come prova che
giustifica il tutto. Conclusione? Di piromani non se ne trovano molti, ma la
fervida immaginazione deduttiva dei giornalisti ne genera in quantità sempre
maggiori, ascoltando le indicazioni dei signori dell’informazione, dietro i
quali si nasconde chi vuole coprire la propria l’inettitudine nel non sapere o
non aver voglia di occuparsi della gestione del territorio, in modo da prevenire
gli incendi. Nessuno è tanto idiota, a meno di un autentico idiota, da appiccare
il fuoco nelle giornate di scirocco per distruggere porzioni d’ambiente e
mettere in pericolo la vita delle persone. Perché poi? Per il piacere di dare
fuoco? Forse per emulare Apollodoro, il pazzo che diede fuoco al tempio
di Delfi per rimanere famoso nell’eternità? Ebbene, si è rimasto famoso, ma come
un imbecille. Tanto quanto il califfo Omar, che fece bruciare la biblioteca di
Alessandria perché era sufficiente un solo libro, il Corano. E per restare nel
tempio di Delfi, va ricordato l’altro imbecille di re Flegias, che, per
vendicarsi di Apollo, che gli aveva sedotto la figlia, diede fuoco allo stesso
tempio, ma venne scaraventato da Apollo nel Tartaro e condannato a stare sotto
un grosso masso che minacciava di cadergli addosso. E visto che siamo nel mondo
mitologico, non possiamo che dare la colpa a Prometeo, il primo dei piromani,
che rubò il fuoco agli dei per portarlo agli uomini: Zeus, il padre degli dei,
lo incatenò a una roccia del Caucaso, inviando un’aquila che gli mangiava il
fegato ogni volta che gli ricresceva. Da quel giorno Zeus scaglia i suoi fulmini
quando si arrabbia perché gli uomini non l’ascoltano, e quindi è lui il
responsabile degli incendi o, o se vogliamo cambiargli nome, la colpa è di Dio
che punisce con le fiamme gli uomini che vogliono rubargli la sua potenza e che
sono diventati perversi e peccatori: è il caso degli abitanti di Sodoma e
Gomorra, le due città che vennero distrutte dal fuoco divino. È in un cespuglio
di rovi che brucia che Dio si manifesta a Mosè, è in una catasta di legna in
fuoco che Abramo sacrifica il figlio Isacco, per ordine divino, prima di essere
fermato dallo stesso Dio che, crudelmente, ne vuole mettere alla prova
l’obbedienza. Ma queste sono storie d’altri tempi. Se vogliamo fare un salto
nella filosofia il fuoco, per Eraclito è il “principio” che regola la vita
dell’universo, mentre per Empedocle e per Budda è uno dei quattro elementi,
assieme all’aria, all’acqua e alla terra, dalla cui commistione nasce e si
sviluppa il mondo. In tempi più recenti il fuoco purifica, come per le anime
finite nel Purgatorio, o serve a lavorare e forgiare i metalli. E comunque è
espressione di una grande potenza causa di distruzioni e di rigenerazioni. Per
non parlare del più grande piromane della storia, che brucia Roma per
ricostruirla nuova e accusa i cristiani di essere stati loro i piromani. Pare,
da studi recenti che Nerone non fosse un piromane, ma siamo sempre là, si è
trovato il colpevole. Negli Stati Uniti terribili incendi hanno devastato
immensi parchi, come quello di Yellowstone o come i boschi della California,
ancora in fiamme, ma non c’è questa tendenza tipicamente italiana a scaricare
responsabilità su qualche capro espiatorio e a cercare il responsabile delle
catastrofi naturali. In Sicilia abbiamo un gran numero di forestali, si dice che
siamo la regione con il numero più alto, pare siano sei mila, ci sono quelli
addetti persino a spalare la neve d’estate: secondo la logica sicula del “non è
compito mio” gli addetti alla prevenzione degli incendi sono solo una minima
parte di questi, rimuovono qualche sterpaglia dai bordi delle strade una volta
l’anno, muniti di attrezzature d’avanguardia, dimenticando che l’erba cresce
sempre e che le cunette sono il posto migliore dove buttare i sacchetti della
spazzatura, che non è compito loro raccogliere: poi ci vuole un po’ di riposo,
il caldo fa stancare. Dall’alto dei loro uffici i governi, da quello regionale a
quello nazionale rilevano, comodamente seduti davanti all’aria condizionata, che
bisogna fare dei tagli e tagliano non sul personale, che non si tocca, neanche
quello precario, ma sui mezzi di sorveglianza e di soccorso, a partire dai
Canadair, il cui numero è diminuito nelle finanziarie di quest’anno, mentre non
si toccano le spese per l’acquisto di aerei militari, quelli che ormai per gli
americani sono superati, ma che per gli Italiani vanno benissimo. Dopodichè
dagli “all’untore”, anzi al piromane, che è responsabile di tutto, compresa la
mancata cura e sorveglianza del territorio, dagli alla mafia dei pascoli, dagli
ai pastori che danno fuoco perché bruciando le sterpaglie sperano che cresca
erba più buona e, con l’occasione, bruciano anche i campi vicini per poterci
portare pecore e vacche, dagli al lupo mannaro, anzi al mascalzone che lega alla
coda di un animale, possibilmente un cane, un mazzetto di legna ardente
lasciando correre l’animale in mezzo alla boscaglia. Il caldo? Va bbè, capita
ogni anno, quello ci deve essere; le cicche non spente? Vabbè!!! E che fumano
tutti? I barbecue lasciati accesi? Vabbè, quelli si spengono da soli. Le
sterpaglie che ogni proprietario di terra non coltivata dovrebbe preoccuparsi di
rimuovere? Vabbè, quelle fanno parte del territorio e della sua bellezza, e poi
chi non coltiva la terra, deve anche farla tratturare? Che discorsi!!! Per non
parlare poi di questi extra-comunitari che si aggirano tra paesi e campagne
senza aver nulla da fare, che già sono anneriti, forse perché hanno preso fuoco
nella loro terra e ai quali si può gettare addosso una bella accusa di
responsabili di tutti i mali possibili, compresi gli incendi.
Allegato B Seduta n. 204 del 13/9/2007
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazione a risposta in Commissione:
FASOLINO. - Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro della
difesa, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. - Per sapere
-premesso che:
gli incendi in Italia calcolati dal 1 gennaio
2007, al 19 agosto 2007, hanno raggiunto il numero record di ben 5735 eventi,
con oltre 95.000 ettari colpiti di cui ben 44.000 ad essenze boschive;
dopo il 19 agosto 2007, con un'impennata
eccezionale giovedì 23 agosto allorché si è raggiunta, in una sola giornata, la
cifra di 304 episodi, il numero degli incendi è progressivamente lievitato con
danni incalcolabili alla salute, all'economia, all'immagine internazionale e
alla bellezza naturale del nostro Paese;
sono andati distrutti boschi di valore
inestimabile, con piante di alto fusto, come pini, lecci, querce, castagni e
faggi oltre a macchia mediterranea ricca di lentischi, mirti, ginepri,
corbezzoli e ginestre insieme con arbusti vari tipici dei territori colpiti;
sono stati arsi vivi e uccisi uccelli, spesso
ancora implumi, e animali da pelo, insetti e creature di ogni tipo;
gli animali scampati al fuoco hanno perduto il
loro habitat naturale e sono stati costretti a stanziarsi in ambito diverso, con
gravi ripercussioni per l'ecosistema e turbativa alla stessa attività umana;
purtroppo, a Patti in Sicilia hanno perduto la
vita anche 5 persone. Numerosi gli intossicati, molte le case distrutte dalle
fiamme;
i danni causati all'atmosfera sono di
straordinario rilievo;
un albero di alto fusto assorbe ogni giorno circa
60 kg di anidride carbonica e libera 50 kg di ossigeno. Da un incendio si
sprigionano notevoli quantità di anidride carbonica, ossido di carbonio e altre
sostanze tossiche a fronte di un consistente consumo di ossigeno per cui viene a
prodursi, fra le altre conseguenze negative, un notevole aumento dell'effetto
serra;
fino al 19 agosto, la Calabria è risultata la
regione più colpita con 1.175 eventi, seguita a ruota dalla Campania con 1.056
eventi. Sono queste, anche, le regioni con il maggior numero di operai
stagionali forestali alle dipendenze delle Comunità montane. Puglia e Basilicata
seguono con 345 e 246 incendi. Sembrano pochi, rispetto ad altre regioni molto
più estese, come la Toscana ed il Lazio e invece sono dati che rivaleggiano con
quelli di Calabria e Campania. Nella Puglia i boschi collinari e montani sono
rari e nella Basilicata la superficie regionale è di molto inferiore a quella di
Calabria e Campania;
Puglia e Basilicata, manco a dirlo, danno lavoro
ad un alto numero di operai stagionali forestali. La Sicilia offre la prova del
nove dello stretto rapporto intercorrente tra corposità dell'organico di operai
stagionali delle Comunità montane e numero di incendi. Sempre fino al 19 agosto
2007, si sono registrati in Sicilia solo 214 incendi. La Sicilia, pare, abbia
soltanto pochi operai stagionali forestali. Va comunque notato che in Sicilia il
98 per cento della superficie incendiata appartiene a privati;
a tutt'oggi, mese di Settembre 2007, è dato
registrare, rispetto al 2006 un incremento di quasi il 60 per cento nel numero
degli incendi in Italia, e di un incremento del 300 per cento di superficie
colpita e di oltre il 300 per cento di boschi distrutti;
in provincia di Salerno l'interrogante è stato
spettatore oculare di un episodio gravissimo. È bene esporlo: martedì 21 agosto
ore 23 vengono avvistati i primi fuochi sulle colline di Montecorice e di
Castellabate. Mercoledì 22 agosto ore 15, nei due Comuni, a 16 ore di distanza
non è comparso ancora un elicottero o un canadair. Si faranno vedere solo verso
le 16,30. Naturalmente quando è ormai troppo tardi. Sarebbe bastato che
intervenissero nelle prime ore del mattino, già dalle ore 7,30, per evitare il
disastro;
dopo pochi giorni sul Monte Calpazio, in
territorio di Capaccio-Paestum patrimonio mondiale dell'UNESCO, sono intervenuti
gli elicotteri, come suol dirsi, solo a babbo morto, dopo ore di attesa e di
trepidazione;
risultato: è andato in fumo uno dei boschi più
pregiati del mondo intero. Di contro bisogna registrare che gli aiuti terrestri
coordinati da vigili del fuoco e Forze dell'ordine, sono stati sempre efficienti
ed encomiabili. In conclusione all'interrogante sembra sia clamorosamente
mancata una strategia di coordinamento tra Governo nazionale, Regioni,
Prefetture e Protezione civile. È mancata un'attenta valutazione di cause e
concause, non si ha notizia di alcun allarme preventivo scattato quando le
previsioni meteo annunciavano caldo torrido e forte vento;
le dichiarazioni del Ministro Parisi per un
intervento dell'Esercito valgono solo a memoria futura, semmai per il 2008 e per
i prossimi anni, se saranno onorate;
in realtà più volte, da più parti è stato
sollecitato l'intervento dell'esercito ma, poi, non se ne è fatto mai nulla;
l'impiego dell'Esercito va ritenuto come lo
strumento indispensabile per combattere efficacemente questa vera e propria
forma di terrorismo che non appartiene solo al nostro Paese, ma, con modulazioni
diverse, è diffusa in tutto il mondo;
chi meglio dell'esercito può presidiare con
efficacia un territorio, controllarne accessi e vie di fuga, intervenire con
prontezza per qualsiasi evenienza? Gli speranzosi dicono: se son rose
fioriranno;
l'intervento dell'esercito verrebbe anche a
tacitare una vulgata diffusissima nelle regioni meridionali: fronteggiare le
escalation degli incendi con un'escalation di assunzioni di stagionali e
l'impinguamento dei ranghi della Protezione Civile. Va seguita esattamente la
strada opposta. Analogo discorso va tenuto per le ditte affidatarie di appalti
dei mezzi aerei. Il nemico si può annidare anche lì; vanno verificate le
risposte alle chiamate, l'efficacia degli interventi, i tempi impiegati;
il silenzio, peraltro doveroso, osservato dalla
Magistratura sulle indagini compiute negli anni passati e sulle condanne
irrogate ai colpevoli al termine dei procedimenti relativi ai numerosissimi
incendi appiccati in ogni parte d'Italia, può avere indotto, anche per lo scarso
rilievo dato dai media alle decisioni, all'errata convinzione di una impunità
diffusa che può aver conferito nuova linfa alla criminalità incendiaria -:
quale sia, almeno rispetto agli eventi degli
ultimi dieci anni, il numero dei procedimenti aperti e delle condanne inflitte,
se le pene sono state scontate, se lo Stato, le regioni e i privati siano stati
risarciti dai colpevoli per i danni subiti e se risulti che, in occasione di
nuovi eventi, almeno nell'ambito dei territori specifici, i colpevoli di
precedenti incendi siano stati sentiti dalla Magistratura inquirente e dalle
Forze dell'ordine e se ne siano verificati gli eventuali alibi;
se tutte le Forze dell'ordine siano in possesso di
un elenco degli incendiari;
se il Governo intenda esperire un'indagine urgente
sul clamoroso episodio denunciato dall'ANCI regionale siciliana secondo cui nei
caldi giorni di agosto oltre la metà dei dipendenti della Protezione civile era
in ferie. (5-01438)
"Facciamo scoppiare una bomba". La banda
dei vigili incendiari, scrive "Live Sicilia" Lunedì 7
Agosto 2017. "Loro sanno tutto, sanno che abbiamo dato fuoco". Era questo il
commento dei 15 volontari dei vigili del fuoco che, condotti negli uffici della
squadra mobile della Questura di Ragusa, venivano intercettati in alcuni
colloqui tra loro ammettendo le circostanze di cui erano accusati e scambiandosi
reciproche accuse per fatti risalenti al 2013-2015. Le indagini della polizia
erano mirate a chiarire il motivo di eventuali richieste simulate. Nel
distaccamento dei Vigili del fuoco di Santa Croce Camerina (Ragusa) prestavano
servizio, suddivisi in 4 turni, decine di volontari e tra gli altri i 15
indagati tutti nella stessa squadra. Anche se volontari, gli uomini del
distaccamento percepiscono delle indennità ma solo quando effettuano gli
interventi; diversamente, se restano presso la caserma, non hanno diritto ad
alcun rimborso. La prima anomalia riscontrata che ha permesso l'avvio delle
indagini era da individuare sul numero degli interventi effettuati dal turno
"D". Rispetto agli altri volontari, gli indagati operavano per 3 volte in più. A
dispetto di 40 interventi di una squadra, loro ne effettuavano 120, creando
malumore per alcuni e volontà di aggregarsi in altri, così da ottenere più
denaro. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, con l'aiuto dei Vigili del
Fuoco, hanno permesso di appurare quale fosse il modus operandi del gruppo
criminale. I componenti del turno "D" agivano mettendo in pratica tre modalità:
la prima era quella di simulare degli interventi mediante segnalazioni
inesistenti alla centrale operativa del 115. La seconda chiedere "aiuto" a
parenti ed amici, ottenendo così segnalazioni da parte loro del tutto
inesistenti, così da percepire le indennità previste per gli interventi. La
terza e più grave tipologia di truffa ai danni dello Stato era quella di
appiccare incendi a cassonetti e terreni. "Quasi tutti i 15 volontari dei vigili
del fuoco del Ragusano indagati nell'operazione Efeso della polizia di Stato
hanno ammesso le proprie responsabilità durante gli interrogatori, delineando,
in modo ancora più chiaro, quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile. La
Procura aveva chiesto provvedimenti cautelari, ma il Gip ha ritenuto passato
troppo tempo (2013-2015) dai fatti contestati. Il capo gruppo è stato sottoposto
agli arresti domiciliari perché "ha continuato a reiterare il reato".
Addirittura, sostiene la polizia di Stato "in una occasione, ha asserito di
voler 'fare scoppiare una bomba' pur di prendere le indennità spettanti". Gli
indagati sono stati allontanati dal distaccamento e sono tutti residenti in
provincia di Ragusa, parte a Vittoria, Santa Croce, Ragusa e Modica. Quasi tutti
svolgono un'attività lavorativa anche se spesso non assunti regolarmente. Il
capo gruppo è stato arrestato durante l'attività lavorativa come addetto
all'assistenza tecnica di impianti refrigeranti. (ANSA). Le indagini hanno
portato oggi all'arresto del caposquadra, Davide Di Vita, 42 anni, di Vittoria e
alla denuncia di 14 componenti della sua squadra.
Pavia, vigile del fuoco appiccava roghi
«Volevo imitare le serie tv americane». Un volontario
di 28 anni filmato dai carabinieri durante una delle sua azioni e denunciato. Si
è giustificato: «In Lomellina ci sono pochi incendi», scrive Ermanno Bidone l'11
agosto 2017 su "Il Corriere della Sera". Da pompiere a incendiario di rifiuti,
cassonetti e sterpaglie, tanto per provare l’«adrenalina» di un intervento
perché «nelle campagne della Lomellina non succede mai niente». Nelle scorse ore
P.M., vigile del fuoco volontario di 28 anni residente a Palestro, nel Pavese, è
stato denunciato dai carabinieri di Pavia per incendio doloso e truffa
aggravata. Sette episodi tra il 2014 e il 2017 sono stati documentati tra
Robbio, Palestro, Confienza e Rosasco e Palestro, mentre altri sono in corso di
accertamento. A far scattare le indagini è stata un serie di roghi sospetti
accaduti sempre nella stessa zona, ai danni di cassonetti e depositi per i
rifiuti e, soprattutto, il fatto che a intervenire per primo era sempre lo
stesso pompiere. Ma le immagini delle telecamere di sorveglianza delle piazzole
dei rifiuti lo hanno incastrato. Nei video si vede chiaramente P.M. che arriva
in auto, scende, e dà fuoco ai cassonetti. Poi riparte e si precipita al comando
per essere il primo a prendere la chiamata di allarme. Quando i carabinieri
l’hanno interrogato, il 28enne ha ammesso ogni addebito, spiegando che appiccava
gli incendi «per provare il brivido di giungere sul posto a sirene spiegate».
Trovava l’incarico noioso perché «in Lomellina, zona di pianura dove ci sono
solo risaie e pochi boschi, non succede mai niente». Il volontario, hanno
spiegato i carabinieri, «voleva emulare i suoi idoli, protagonisti di una
recente serie televisiva in cui sono “raccontati” gli interventi di una squadra
di vigili del fuoco in una metropoli degli Usa, e così aveva pensato di creare
l’occasione adrenalinica». Oltre che per incendio doloso, il pompiere piromane è
stato denunciato anche per truffa aggravata: ad ogni intervento il personale
volontario percepisce infatti un’indennità sulla base delle chiamate ricevute e
degli interventi effettuati. Il giovane si è dimesso spontaneamente
dall’incarico a seguito delle contestazioni dei carabinieri.
Vigevano (Pavia), pompiere in cerca di
adrenalina appiccava incendi e poi li spegneva: "Imitavo le serie tv Usa". Denunciato
da carabinieri. Ai militari ha detto che in Lomellina si verificavano pochi
incendi e lui voleva il brivido di una famosa serie tv Usa, scrive "La
Repubblica" l'11 agosto 2017. Un vigile del fuoco (volontario) in cerca di
adrenalina e di un rimedio alla noia appiccava egli stesso degli incendi per poi
dare l'allarme e intervenire con i compagni per spegnerlo. L'uomo, 28 anni, di
Palestro (Pavia), è stato filmato e denunciato dai carabinieri di Vigevano,
insospettiti per una serie di roghi circoscritti in una stessa zona. I militari
stavano investigando su una serie di "inspiegabili" incendi, tutti concentrati
in una zona circoscritta e ai danni di cassonetti dei rifiuti e sterpaglie, dopo
aver notato che ad intervenire sul posto, per primo, era sempre lo stesso vigile
del fuoco volontario, avevano deciso di effettuare degli accertamenti sul suo
conto, riuscendo così a scoprire che lo stesso 28enne era l'autore degli
incendi. Ad aiutare le indagini dei carabinieri alcune telecamere posizionate
nei pressi delle "aree di stoccaggio dei rifiuti" colpite. Le immagini hanno
immortalato il piromane proprio mentre appiccava il fuoco, per raggiungere
subito dopo il proprio comando e così essere il primo a ricevere la chiamata e
dare il "via" operativo all'intervento della squadra. Proprio il "brivido" di
poter giungere sul posto con le sirene "spiegate" è risultata la ragione per la
quale l'uomo appiccava gli incendi. Il volontario denunciato ha spiegato che
aveva trovato l'incarico "noioso" in quanto, in Lomellina, zona pianeggiante,
coltivata a riso e quindi quasi priva di boschi, capitava di rado di dover
intervenire operativamente. Stanco di questo e sempre più desideroso di poter
emulare i protagonisti di una serie televisiva americana che parla di una
squadra di vigili del fuoco eroi, si era quindi ingegnato per procurarsi da sè
il brivido dell'intervento. In seguito agli interventi il giovane aveva ricevuto
la retribuzione prevista, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative che
prevedono un pagamento mensile per i volontari sulla base delle chiamate e degli
interventi effettuati. il vigile del fuoco è stato quindi indagato anche per il
reato di truffa aggravata. Il giovane, dopo essere stato scoperto, oltre ad aver
ammesso le proprie responsabilità si è dimesso spontaneamente dall'incarico.
Sette sono per ora i casi che gli vengono
contestati (su altri incendi tra avvenuti tra il 2016 e 2017 si sta ancora
indagando): il 25 febbraio 2014 e il 28 marzo 2014 un cassonetto per i rifiuti a
Robbio Lomellina; il 24 aprile 2014 un deposito per i rifiuti a Palestro; il 15
maggio 2014, sterpaglie a Rosasco; il 23 settembre 2014, un'area per lo
stoccaggio dei rifiuti a Palestro; il primo gennaio 2015 un cassonetto per i
rifiuti, ancora a Palestro, e il 28 marzo 2017 un cassonetto a Cofienza.
CHI TUTELA LA SALUTE DEI CITTADINI ???
RIFIUTI IN ITALIA. RACCOLTA DIFFERENZIATA: SI
PARLA BENE, SI RAZZOLA MALE
Nei sacchi neri del Palazzo del potere finiscono
carte intestate, caffè e avanzi di salame
Gigi D’Alessio, mito pop della cultura musicale
partenopea, t-shirt gialla in posa davanti al Castel dell’Ovo di Napoli,
esortava «Anche tu fai come me» e prestava così il suo volto alla campagna per
la raccolta differenziata che il ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo
aveva fortemente voluto insieme al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
Da lì è ripartita «Striscia la notizia», che il 22 settembre 2008, per
inaugurare la 21ª serie, ha mandato in onda lo «scoop» dell’inviato Valerio
Staffelli proprio sul comportamento dei palazzi del potere in materia di
differenziata.
Le telecamere nascoste frugano nei sacchi di
immondizia davanti a Palazzo Chigi (sede del Governo) e Palazzo Madama (Senato):
ne escono pomodori, salame, caffè, bottiglie di plastica, carta intestata
«Governo italiano». E il camioncino dell’immondizia riversa il suo contenuto in
un camion più grande; di differenziata neanche l’ombra.
EMERGENZA RIFIUTI
Gestione ''arretrata'' dei rifiuti, ''grave
emergenza'' in cinque regioni (Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia),
produzione boom con 32 milioni di tonnellate nel 2005 contro i 26 milioni del
'96, ancora primato assoluto della discarica con il 54% dei rifiuti urbani
raccolti. Intanto la raccolta differenziata divide l'Italia in tre con il 38,1%
al nord, il 19,4% al centro e l'8,7% al sud. Grave il quadro sulla gestione dei
rifiuti speciali e pericolosi: ''Ben 26 milioni sono scomparsi nel nulla nel
2004''. Commissariati per l'emergenza ''un fallimento costato 1,8 miliardi dal
'97 al 2005''.
Questa la fotografia scattata in un dossier al
centro dell'VII Congresso nazionale di Legambiente presentato a Roma il 4
dicembre 2007 al convegno dal titolo ''Emergenza rifiuti, fuori dal tunnel - Le
luci, le ombre e le proposte per superare la crisi''.
In particolare dal Congresso di Legambiente
emergerebbe un'Italia con molte ombre e qualche luce. Ecco il
pacchetto-immondizia che contraddistingue il nostro Paese:
Produzione: 32 milioni nel 2005 contro poco meno
di 26 milioni nel '96.
Gestione: 54% dei rifiuti urbani prodotti finisce
in discarica.
Raccolta differenziata: Italia a tre velocità. Nel
2005 il nord a 38,1% con punte record in Veneto con 47,7% e in Trentino Alto
Adige con il 44,2%; il centro al 19,4% e solo in alcune aree allo standard del
nord; il sud all'8,7%. Per le città, la prima su 103 capoluoghi di provincia è
Novara con 66,9%, ultima con 1,8%. Milano è 43° con il 30,5%, Roma 64° con
16,2%, Napoli 94° con 6,1%.
Rifiuti pericolosi: 26 milioni di tonnellate
scomparsi nel nulla nel 2004.
Ombre: in 4 anni la novità negativa più importante
è il Codice ambientale (ora in revisione dall'attuale Governo); mancato avvio
operativo per il sistema di raccolta dei rifiuti hi-tech; "incomprensibili
proroghe" sul divieto di smaltire in discarica rifiuti indifferenziati non
pretrattati, divieto previsto inizialmente dal 1° gennaio 2000.
Luci: crescita del numero dei comuni "ricicloni".
Quelli con oltre il 35% di differenziata premiati nel 2007 sono stati 1.150
contro i 300 del 2000.
Emergenza: ancora in 5 regioni, Calabria,
Campania, Lazio, Puglia e Sicilia.
In Puglia e Sicilia il regime commissariale non è
stato prorogato.
Commissariamenti: "Un fallimento da 1,8 miliardi
di euro" spesi tra il 1997 e il 2005 senza alcun sostanziale miglioramento della
gestione dei rifiuti.
Proposte: modifica del Codice ambientale; ecotassa
con aumento dei costi smaltimento in discarica; raccolta porta a porta per
spingere su differenziata; politiche e incentivi per riduzione di rifiuti e
imballaggi; regime ordinario nelle regioni commissariate; premio economico all'
attività dei Consorzi per il riciclaggio dei rifiuti.
CHI COMBATTE L'ABUSIVISMO EDILIZIO ???
VIDEO INCHIESTA PRESUNTI ABUSI EDILIZI
VIDEO PUNTA PEROTTI: ABBATTIMENTO E CONDANNA
WATERFRONT, IL MARE RUBATO. Inchiesta di “La
Repubblica”.
Dalla Liguria alla Sicilia, sulle coste italiane
proliferano i progetti di nuovi porti turistici che portano con sé una cospicua
dote di appartamenti, residence, alberghi, centri commerciali, e via
cementificando. Italia Nostra, Legambiente e Wwf sono sul piede di guerra. Ma
alcune battaglie sembrano ormai perdute. Vediamo quali, porto per porto... Così
un business miliardario conquista le spiagge "inedificabili". Santa Margherita
Ligure, Marina di Massa, Napoli, Siracusa, Lipari... Stando alle leggi e ai
piani regolatori non è possibile costruire alcunché a meno di centocinquanta
metri dal mare. Ma ecco che una nuova parola magica, "Waterfront", sta spianando
la strada a opere edilizie che, da sole, valgono al momento un miliardo e mezzo
di euro. Nella Liguria devastata dall'alluvione c'è chi è pronto a mettere altro
cemento su una costa che non regge più all'urto dell'acqua che scende dai monti.
In Sicilia invece il cemento si vuole depositare direttamente davanti al mare,
nel cuore di un sito Unesco. Ecco le mani sulle coste d'Italia. Le ruspe di
colossi delle costruzioni e dell'impiantistica, di magnati del petrolio o di
imprenditori sconosciuti, hanno già acceso i motori. Vogliono prendersi le rive
del Belpaese, che in teoria - cioè secondo la legge - sono inedificabili. Per
metterci palazzoni, alberghi, ristoranti e centri commerciali. La parola magica
che consente di aggirare il divieto assoluto di costruire entro i 150 metri
dalla battigia è "waterfront", declinata in sigle del tipo "rifacimento della
costa" o "nuovo porto turistico".
Da Santa Margherita Ligure a Siracusa, passando
per Marina di Massa, Cecina, Fiumicino, Napoli, Brindisi o Lipari, ecco i grandi
affari in riva al mare. In campo imprese e società pronte a gettarsi a capofitto
su un business che solo di opere edilizie vale al momento 1,5 miliardi di euro,
che si moltiplicano a dismisura se si aggiungono gli affari commerciali
collaterali una volta ultimate le costruzioni. Per cercare di arginare quelle
che gli ambientalisti definiscono "le mille Val di Susa in riva al mare" si
battono giornalmente associazioni come Italia Nostra, Wwf e Legambiente, e
sparuti comitati di cittadini spesso lasciati soli dalla politica locale a
fronteggiare poteri forti, anzi fortissimi, visto che in tempi record riescono a
farsi approvare varianti urbanistiche su misura come non accadeva nemmeno nella
Palermo o nella Napoli del sacco edilizio.
Il viaggio nei waterfront d'Italia parte dalla
Liguria, da Santa Margherita. Qui la società Santa Benessere, guidata da
Gianantonio Bandiera, imprenditore ligure noto per il rifacimento del teatro
Alcione e per il progetto del contestato porticciolo a Punta Vagno, ha
presentato al Comune un progetto da 70 milioni di euro e la richiesta di
concessione demaniale dell'area portuale per i prossimi 90 anni. Cosa vuole
realizzare? Un centro di talassoterapia da 30 mila presenze annue e
l'allungamento del molo e della diga foranea per chiudere il golfo e consentire
anche a megayacht di 50 metri di poter attraccare a Santa Margherita. Dal Fai ad
archistar come Renzo Piano, in tanti contestano il piano della Santa Benessere,
che dietro di sé ha soci e finanziatori più o meno occulti. L'azionista di
maggioranza della società che ha presentato il progetto è un trust inglese, la
Rochester holding, che a sua volta ha tra i finanziatori Gabriele Volpi, magnate
diventato miliardario con il petrolio nigeriano e che oggi guida un gruppo da
1,4 miliardi di fatturato con proprietà che vanno dalla logistica petrolifera
alla pallanuoto e al calcio: è proprietario della Pro Recco e dello Spezia. I
soldi insomma ci sono. Lui, Volpi, prende le distanze dicendo di non sapere
nulla di questo progetto e di avere investito "soltanto nel trust inglese". In
realtà nel cda della Santa Benessere siedono Bandiera e Andrea Corradino,
entrambi soci dello Spezia calcio. Il Comune ligure ha dato tempo fino a tutto
novembre per presentare osservazioni al piano. Una torre di otto piani sul mare
a guardia di un porto da 800 posti. Tra Marina di Carrara e Marina di Massa è a
buon punto un progetto, gradito alle amministrazioni comunali, che attorno al
nuovo "marina" prevede quaranta appartamenti, un residence a tre piani, uno
yacht club, una piazza da seimila metri quadrati e il piccolo "grattacielo".
Pochi chilometri più a Sud di Santa Margherita altre ruspe e altri costruttori
si stanno muovendo per realizzare alberghi sul mare laddove sulla carta non si
potrebbe piazzare nemmeno un palo della luce. Tra Marina di Carrara e Marina di
Massa il gruppo di Francesco Caltagirone Bellavista vuole costruire un porto
turistico da 800 posti. Peccato però che tra le strutture a supporto metta anche
"40 appartamenti, uno yacht club e un residence a tre piani". "E perfino una
torre di otto piani e una piazza da 6 mila metri quadrati", dice Antonio Delle
Mura, presidente di Italia Nostra Toscana. Le amministrazioni comunali guardano
con molto interesse all'iniziativa, in ballo ci sono investimenti per 250
milioni di euro e lavoro per molti concittadini. "Nessuno pensa alle conseguenze
ambientali e all'impatto devastante per quest'area, con il rischio di erosione
della spiaggia e occultamento della vista a mare: tutti sembrano essersi
dimenticati, inoltre, che il progetto presentato ricalca una iniziativa del 2001
presentata dall'Autorità portuale e bocciata allora dal ministero
dell'Ambiente", aggiunge Delle Mura. Italia Nostra in Toscana insieme al Wwf è
impegnata però anche su un altro fronte, quello di Cecina. In campo c'è una
cordata d'imprenditori locali raccolta nel Club nautico che vuole rivoltare come
un calzino il vecchio porticciolo, allargandone la capienza a mille posti barca.
Fin qui nulla di strano. Se non fosse che accanto al porto si vorrebbe
realizzare un parcheggio da 2 mila posti auto, 400 box attrezzati, 40 esercizi
commerciali, un hotel a 4 stelle, un centro benessere e 80 appartamenti. E,
ciliegina sulla torta, un padiglione esposizioni per la nautica e un mercatino
del pesce, con ristorante ed eliporto. "Cosa c'entra tutto questo con un porto
turistico?", si chiede la professoressa Roberta De Monticelli, che ha denunciato
quanto sta accadendo a Cecina alla Commissione Europea: "Spostare una foce e
realizzare un pennello a mare che cambierà le correnti, il tutto in una riserva
dello Stato, insomma è davvero incredibile", aggiunge la De Monticelli.
Ma è a una manciata di chilometri da Napoli che si
sta giocando una delle partite edilizie più importanti del Mezzogiorno. E
precisamente a Pozzuoli nell'ex area industriale Sofer-Ansaldo, oggi di
proprietà della Waterfront flegreo: società, questa, del gruppo dell'ingegnere
Livio Cosenza, settantenne, grande elettore dell'attuale sindaco di Pozzuoli
Agostino Magliulo, padre dell'onorevole Giulia e di Francesco, 35 anni,
amministratore delegato della Watefront. Nel board della società in questione
siede inoltre Carlo Bianco, consigliere d'amministrazione della Pirelli Re. La
partita inizia quando il Comune nel 2007 affida all'architetto Peter Eisenman un
piano di riqualificazione dell'area. Il piano viene consegnato
all'amministrazione, che a sua volta firma subito un protocollo d'intesa con la
Waterfront. Cosa prevede il mega progetto di Eisenman? Semplice, la
realizzazione di un polo turistico alberghiero con annesso centro commerciale,
un polo per la nautica da diporto con tanto di accademia della vela e un terzo
polo definito genericamente "polifunzionale". La Waterfront affida subito la
progettazione esecutiva a uno studio locale, nel quale lavora tra gli altri la
figlia del sindaco di Pozzuoli. Il Cipe, nel frattempo, stanzia 40 milioni di
euro per la bretella che collegherà l'area all'autostrada, con tanto di parere
positivo della commissione parlamentare Ambiente e territorio nella quale siede
l'onorevole Cosenza. Le ruspe sono pronte, visto che le carte ci sono tutte e
sono in regola. In arrivo 600 milioni di euro d'investimenti, con tanto di
anticipo già approvato da Intesa Sanpaolo. Per il professore d'economia
dell'Università di Napoli Ugo Marani si tratta "di un bel progetto che sarà
trasformato in scempio" e per questo "va fermato". E nel golfo incantato di
Ortigia si punta a costruire sull'acqua. Siamo nel cuore di uno dei luoghi
patrimonio dell'Unesco: l'isola che ospita l'antico centro di Siracusa. Qui i
progetti di nuovi porti sono due: il primo chiamato Marina di Archimede è già
avviato, mentre il secondo prevede una piattaforma a mare, da edificare, grande
come sette campi di calcio. L'opposizione di Pozzuoli, dal Pd a Rifondazione
protesta, ma al momento l'iter burocratico è già concluso e c'è poco da fare.
Altri affari sono in corso nelle grandi città. Sul litorale romano, a esempio,
il sindaco Gianni Alemanno ha in mente progetti in grande stile: attraverso
l'Eur spa punta a stravolgere il waterfront di Ostia, costruendo beauty farm,
alberghi, centri commerciali, ristoranti e perfino una scuola di surf, il tutto
con la scusa di raddoppiare il porto attuale. A Palermo, invece, il consiglio
comunale ha appena approvato il nuovo piano regolatore del porto, che prevede la
realizzazione di un ennesimo porticciolo turistico nella zona di Sant'Erasmo, a
due passi dal centro storico della città e nonostante vi siano già altri tre
porti turistici in funzione sul lungomare palermitano. Nel capoluogo siciliano
gli ambientalisti da anni contestano la riqualificazione di Sant'Erasmo, che
sarà affidata a una società privata che gestirà il porticciolo per i prossimi
trent'anni.
Le ruspe e le betoniere sono invece già in azione
nel cuore di un luogo protetto dall'Unesco: Ortigia, centro storico di Siracusa
che si affaccia sul bellissimo golfo aretuseo intriso di storia e leggende
greche. Qui il gruppo Acqua Pia Marcia del costruttore Francesco Caltagirone
Bellavista ha iniziato i lavori d'interramento per il nuovo porto turistico che
sarà chiamato Marina di Archimede. Il progetto da 80 milioni di euro, presentato
nel 2007 da una società locale, approvato dal Comune a tempo di record e
acquistato in corsa dal gruppo Caltagirone, prevede lavori su un'area di 147
mila metri quadrati, 50 mila dei quali in riva al mare: saranno realizzati 507
posti barca, ma anche "uffici, negozi ristorante, caffetteria, centro benessere
e un albergo", dice il deputato regionale del Pd, Roberto De Benedictis. Ma al
Comune è arrivata una seconda richiesta, questa volta da parte di una società
d'imprenditori locali, la Spero srl, che vuole realizzare un altro porto a
fianco di quello di Caltagirone. La Spero vuole investire 100 milioni di euro
per costruire un molo da 430 posti barca e sul mare una piattaforma - grande
quanto sette campi di calcio - da rendere edificabile per mettere in piedi
alberghi, centri commerciali, uffici pubblici, ristoranti, tabaccherie e anche
una libreria, per dare un tocco di cultura a un'operazione che, come sostiene il
deputato Pd Bruno Marziano, "realizzerebbe il sogno di qualsiasi costruttore:
cementificare il mare". Il Comune ha già approvato il progetto e l'ha inviato
alla Regione per l'autorizzazione integrata ambientale. "Ci si chiede però come
sia possibile costruire alberghi in riva al mare o sul mare, in un sito protetto
dall'Unesco. Sarebbe una follia", dice ancora De Benedictis. Intanto Legambiente
annuncia battaglia: "Difenderemo Ortigia da queste speculazioni", giura il
presidente regionale Domenico Fontana.
Santa Margherita, Massa Carrara, Napoli, Siracusa,
sono soltanto la punta di un iceberg fatto di speculazioni sulle coste in nome
dell'esigenza di nuovi posti barca che servono per attrarre turisti ma anche per
costruire in zone inedificabili. Italia Nostra ha in corso una ventina di
battaglie per bloccare la costruzione di nuovi porti, come quelli di Cecina, San
Vincenzo e Talamone in Toscana, o Fiumicino, Anzio e Civitavecchia nel Lazio e,
ancora, risalendo, quelli di Sarzana e Ventimiglia in Liguria. Soltanto in
Sicilia sono già stati varati, o stanno per essere approvati, progetti di
costruzione di ben 12 porti, da Menfi a Licata, da Marsala a Capo d'Orlando e
Lipari, benedetti da 24 milioni di euro dell'Unione europea. Soldi pubblici per
porti che saranno gestiti da privati scelti spesso senza alcuna procedura di
evidenza pubblica. "Il territorio costiero è evidentemente sotto attacco", dice
la presidente di Italia Nostra, Alessandra Mottola Molfino. Secondo Sebastiano
Venneri, presidente nazionale di Legambiente, si tratta di puri e semplici
affari perché basterebbe riqualificare i vecchi porti per ottenere migliaia di
nuovi posti barca senza ulteriori cementificazioni: "Abbiamo appena completato
uno studio che mette nero su bianco come sia possibile ottenere ben 39.100 nuovi
posti barca semplicemente riqualificando i porti abbandonati - dice Venneri -
circa 13 mila posti sono attivabili immediatamente con piccolissime opere di
restauro, 9 mila posti in tempi brevi e altri 15.800 con lavori che non vanno
oltre i 24 mesi". Ma in questo caso il business sarebbe molto meno appetibile.
Almeno per i signori del cemento. Incendi, bombe, buste con pallottole La
malavita all'attacco del Circeo. Pressioni e minacce contro chi è chiamato alla
tutela dei 22 chilometri di costa laziale praticamente intatta. L'abusivismo le
prova tutte in attesa delle sanatorie. La difesa di un modello economico che ha
al centro i valori della natura che possono essere messi a frutto Un ordigno
incendiario con 8 inneschi davanti alla sede del parco del Circeo. Due
pallottole inviate al presidente del parco del Pollino. Migliaia di richieste di
sanatoria pendenti nei territori sotto tutela. Villette travestite da serra che
spuntano fidando nel prossimo condono. E' dura la vita degli ambientalisti
nell'era delle norme edilizie fluttuanti e dei piani casa che suggeriscono
allargamenti fino a ieri proibiti. Ed è dura in particolare nelle regioni in cui
gli interessi della criminalità organizzata sono in espansione. "In alcune zone
la crescita della tensione è palpabile", spiega Giampiero Sammuri, presidente di
Federparchi. "Penso al Cilento, dove Angelo Vassallo, il sindaco che si opponeva
alla speculazione edilizia che premeva sul parco, è stato assassinato. Al
Pollino delle intimidazioni contro il presidente, che ha ricevuto una busta con
due pallottole. Ai roghi usati come arma di pressione. E a molti altri casi in
rispettare la legge diventa pericoloso" L'ultimo e più evidente di questi casi è
il Circeo, un parco pioniere che rischia di essere travolto dalla pressione di
chi vuole mettere le mani su quei 22 chilometri di costa quasi intatta. Nato nel
1933, terzo dopo il Gran Paradiso e il parco d'Abruzzo, il Circeo ha resistito -
sia pure con qualche fatica - all'assalto alla baionetta degli anni Sessanta: ha
perso il tratto più settentrionale, divorato dalle case, ma la controffensiva di
metà degli anni Settanta gli ha fatto guadagnare tre piccoli laghi
nell'entroterra. E' una storia che si può leggere anche senza un libro. Basta
arrampicarsi sul promontorio della maga Circe per ottenere un colpo d'occhio più
eloquente di un trattato. Il paesaggio è disegnato con precisione: la sagoma
regolare della grande foresta planiziale, 3.500 ettari che costituiscono
l'ultimo retaggio delle selve di pianura che coprivano l'Italia; il centro
urbano di Sabaudia, un agglomerato senza sbavature; la linea delle dune, che si
estende per 22 chilometri, spezzata solo da rarissime costruzioni. E poi, appena
lo sguardo esce da questo mondo ordinato, si comprende il significato del
termine "area protetta". Nei luoghi non tutelati lo sviluppo degli ultimi
decenni non ha concesso quartiere: l'assedio del cemento, dell'asfalto, delle
serre balza agli occhi. Il confine tra questi due mondi è netto, un tratto che
segue i contorni del parco circoscrivendolo con precisione. "Da queste parti la
storia dell'abusivismo è lunga", racconta Sergio Zerunian, responsabile
dell'ufficio territoriale per la biodiversità che la Forestale mantiene a
Fogliano, accanto al giardino botanico creato dai Caetani alla fine
dell'Ottocento. "Si è cominciato con gli interventi in aree molto delicate, con
tracce di storia millenaria, si è andati avanti con la proliferazione dei posti
barca e delle villette che alle volte vengono nascoste, durante i lavori, dietro
gabbie di granturco o pareti di una finta serra". E si va avanti ancora oggi con
la moltiplicazione dei roghi nelle aree più pregiate del promontorio - che come
ricorda il direttore del parco del Circeo Giuliano Tallone - hanno messo in
pericolo anche le case vicine; con la pressione che ha portato a 3.500 domande
di condono all'interno del parco; con l'attentato in pieno giorno che ha
distrutto i materiali didattici davanti alla sede del parco. Tanto che il
presidente della commissione urbanistica del Comune di Sabaudia, Francesco
Sanna, parla di "piano preordinato". Chi sono i nemici del parco? "Il
proliferare di incendi e l'attentato vanno letti come un sintomo, un malessere.
Un malessere che però è di pochi e nasce da un cambio di prospettiva non
accettato", risponde Gaetano Benedetto, il presidente del parco del Circeo.
"Proprio perché questo territorio si è salvato vale di più e gli investimenti
hanno una redditività maggiore. Ma per passare da un modello usa e getta a un
modello di valorizzazione bisogna rispettare le regole. A qualcuno dà fastidio?
Noi riteniamo di fare gli interessi di chi vive nel parco arginando il nuovo
cemento non previsto dai piani regolatori". La scommessa - continua Benedetto -
è costruire un sistema in cui la bellezza crea valore al di là dei vecchi
modelli economici: "Il piano casa della Regione Lazio agisce in deroga al piano
paesaggistico e blocca la legge salva coste, consentendo di aumentare le
cubature. Ma qui non è applicabile perché una legge nazionale di salvaguardia
non può essere vanificata da una legge regionale". Da una parte il tentativo di
realizzare un modello economico capace di far fruttare nel lungo periodo le
risorse della natura, dall'altra un coagulo di interessi in cui trovano spazio
anche i clan. "La malavita organizzata, come dimostrano le inchieste sui
Casalesi e sulla 'ndrangheta, ha deciso che questo territorio deve diventare uno
dei centri di riciclaggio del denaro sporco", precisa Marco Omizzolo, di
Legambiente. "Pressioni di tutti i tipi sono in aumento nel Lazio: molti parchi
vivono una fase di asfissia economica voluta, altri sono commissariati, altri
sono coinvolti nelle inchieste sul ciclo illegale dei rifiuti. Anche Ventotene,
nell'arcipelago di fronte al Circeo, un'isola con straordinarie potenzialità, da
anni è oggetto di speculazioni e di progetti proposti dalle amministrazioni
locali che vanno in senso contrario alla tutela sbandierata: l'ultimo è il
costosissimo tunnel che dovrebbe devastare l'isola per far più posto alle
macchine". Parliamo di un'area in cui è stato costituito un "vero sistema
criminale che Libera, l'associazione antimafia presieduta da don Ciotti, non ha
esitato a chiamare la Quinta mafia", aggiunge il deputato Pd Ermete Realacci in
un'interrogazione parlamentare in cui si elencano molti episodi di intimidazioni
e aggressioni contro funzionari di polizia e dirigenti del Comune di San felice
Circeo e di Sabaudia. "Una mafia che ha soprattutto nel ciclo del cemento la sua
manifestazione più eclatante. Basti pensare che stando ai dati delle forze
dell'ordine nel parco nazionale del Circeo sono 1 milione e 200.000 i metri cubi
fuori legge, 2 abusi edili per ogni ettaro. Secondo gli investigatori una parte
è imputabile, direttamente o indirettamente, a esponenti della malavita
organizzata e a quel sottobosco politico-economico che sta suscitando grande
attenzione negli inquirenti".
Case abusive e condoni edilizi
Mai dire mai. La Campania vuole un altro condono.
Parola di Gian Antonio Stella su “Il Corriere della Sera”. Ma certo che tocca il
cuore, vedere le ruspe abbattere la casa di Bacoli dove viveva Jessica, la
ragazza disabile presa a simbolo da tutti gli abusivi. Ed è vero che troppo
spesso le rare case buttate giù sono di poveracci che non hanno l'avvocato
giusto. Ma la soluzione qual è: un'altra sanatoria come vorrebbe la Regione
Campania? Giurando che stavolta sarà davvero l'ultimissimissima? È ipocrita e
pelosa, la solidarietà di troppi politici campani verso gli abusivi (pochi) che
in questi giorni, un sacco di anni dopo le prime denunce e le prime sentenze, si
sono ritrovati alla porta i caterpillar. Dove erano, mentre intorno a loro la
regione intera si riempiva di baracche e villini e laboratori e autorimesse
fuorilegge? Dov'erano mentre la nobile via Domiziana veniva stuprata da
fabbricati illegali costruiti perfino in mezzo all'antico tracciato sventrando
il meraviglioso basolato romano? Dov'erano mentre nella «zona rossa» dei 18
comuni vesuviani, assolutamente vietata, si accatastavano case su case a
dispetto degli allarmi su una possibile eruzione (« Hiiiii! Facimm' 'e corna! »)
e del piano di evacuazione di circa mezzo milione di sfollati che richiederebbe
12 giorni? Dice l'autore della proposta galeotta, il pidiellino Luciano Schifone
(«nomen omen», ringhiano gli ambientalisti) che si tratta solo di sanare i
«piccoli abusi» e cioè, come ha spiegato al Mattino, gli aumenti volumetrici non
oltre il 35% previsti dal piano casa regionale varato nel dicembre 2009 e
ritoccato nel 2010, ma realizzati prima che quel piano fosse approvato. Per di
più, dice, «è previsto un aumento del 20% degli oneri di urbanizzazione».
Sintesi: in fondo gli abusivi hanno abusato prima che l'abuso fosse legalizzato
dalla legge della Regione. Tornano in mente le assicurazioni di Giuliano Urbani,
allora ministro dei Beni Culturali davanti a chi temeva disastri dal condono
berlusconiano del 2003: «È solo per piccoli abusi, finestre aperte o chiuse, che
riguardano la gente perbene». Alla fine, dopo avere scatenato i peggiori istinti
cementieri, finì per essere parzialmente utilizzato anche dai palazzinari che ad
Acilia, ad esempio, avevano tirato su a due passi dalla tenuta presidenziale di
Castelporziano una selva di condomini per un totale di 283 mila metri cubi
totalmente abusivi. Sanati con 1.360 (milletrecentosessanta: uno per
appartamento) condoni individuali. Mettiamo che ogni appartamento avesse solo
una decina di finestre: 13.600 finestre. Piccoli abusi... I numeri sono
mostruosi. Secondo l'urbanista Paolo Berdini autore di una ricerca capillare su
tutta la penisola, «dal 1948 a oggi sono stati (...) compiuti oltre 4.600.000
abusi, più di 74.000 ogni anno, 203 al giorno». E l'Agenzia del Territorio, come
ricorda il dossier Legambiente del 2010, «dal 2007 a oggi ha censito più di due
milioni di edifici non accatastasti, per l'esattezza 2.076.250 particelle
clandestine». Nella grande maggioranza concentrati al Sud. E chi è in testa alle
regioni-canaglia secondo un'indagine del Cresme, con 19,8 case abusive su 100
esistenti? La Campania. Nonostante un dossier dell' Ispra dica che «l'Italia è
uno dei Paesi a maggiore pericolosità vulcanica» e che «le condizioni di maggior
rischio riguardano l'area vesuviana e flegrea, l'isola d' Ischia...». Non si
dica che si tratta solo di scelte sventurate di povera gente educata da una
cattiva politica ad arrangiarsi «perché tanto prima o poi con lo Stato ci si
mette d' accordo». Certo, questa è la tesi. Che non a caso ha scelto come
simbolo la famiglia di quella Jessica di cui dicevamo all'inizio, difesa l'altra
sera da una fiaccolata per le vie di Bacoli, in faccia a Pozzuoli, alla quale ha
partecipato («È solo per stare vicino alle famiglie che hanno fatto le case in
modo illegale, ma non per speculazione. Non hanno altro e una volta messi fuori
che faranno?») perfino il vescovo Gennaro Pascarella. No, c'è di più. Lo spiega
un recente rapporto di Legambiente: «In Campania ben il 67% dei Comuni che sono
stati sciolti per mafia dal 1991 a oggi, lo sono stati proprio per abusivismo
edilizio. A Giugliano, nell'hinterland napoletano, la Procura di Napoli procede
all'arresto di ben 23 vigili urbani e individua nel locale Comando dei vigili il
"covo" dal quale si gestiva il business dell' abusivismo sull'intero territorio
comunale. E ancora il triste primato detenuto dagli abitanti di quel luogo che
un tempo si definiva "agro" sarnese nocerino, tredici comuni per un totale di
158 chilometri quadrati e che di agricolo hanno conservato ben poco, dove circa
il 10% della popolazione residente, neonati compresi (ben 27.000 persone su
285.000), è stato denunciato almeno una volta per abusi edilizi». Vale per
Giugliano, vale per il Lago Patria devastato dal mattone illegale e selvaggio,
vale per Ischia che con 62 mila abitanti vanta il record di 28 mila abusi
edilizi, vale per San Sebastiano al Vesuvio dove il sindaco Giuseppe Capasso,
nel contempo presidente della Comunità del Parco del Vesuvio, si spinse a
lagnarsi con l'allora governatore Antonio Bassolino perché «i tanto attesi
effetti di una possibile ripresa economica» dovuti al «piano casa» spinto da
Silvio Berlusconi avrebbero potuto «non investire l'area vesuviana» a causa
proprio delle regole sulla «zona rossa». Zona ad alto rischio che sta nel gozzo
anche al sindaco di Sant' Anastasia, Carmine Esposito, che un paio di settimane
fa si è avventurato a sostenere che «la Regione Campania deve un ristoro
economico per aver bloccato i territori vesuviani in zona rossa». Parole che
Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato nel settembre 2010 perché
cercava di difendere il parco del Cilento dall'assalto del cemento camorrista,
non avrebbe mai pronunciato. Mai. Ma lui cercava di spiegare ai suoi cittadini
che la difesa dell' ambiente era innanzitutto un interesse «loro». Non ammiccava
alle cattive abitudini per raccattare voti...
I diversi tipi di abusivismo edilizio
Il fenomeno complessivo di devastazione ambientale
mista a inefficienza e corruzione che dall'ultimo dopoguerra sta distruggendo il
territorio italiano non può essere semplicemente ascritto alla voce "abusivismo"
E' di grande attualità in questo momento il tema
dell'abusivismo. Quarant'anni di edilizia selvaggia ha arrecato gravi danni al
territorio, all'ambiente, alla convivenza civile e al concetto stesso di
legalità. Ma il fenomeno complessivo di devastazione ambientale mista a
inefficienza e corruzione che dall'ultimo dopoguerra sta distruggendo il
territorio italiano non può essere semplicemente ascritto alla voce
"abusivismo".
Il quadro delle illegalità e delle devastazioni è
assai variegato, e un tentativo di riassumerlo con tutti i necessari "distinguo"
comporterebbe la stesura di un trattato. Si possono porre una serie di "punti
fermi": catalogare cioè in forma necessariamente telegrafica le varie situazioni
e tipologie di quel che oggi genericamente viene indicato come "abusivismo" tout
court, ovvero "mostri di cemento" o simili. Ecco dunque in breve sintesi:
1) ABUSIVISMO VERO E PROPRIO. Trattasi
essenzialmente di edifici realizzati in totale assenza di concessione edilizia,
in genere su aree dove gli strumenti urbanistici non ne consentirebbero comunque
il rilascio. E' un fenomeno esploso nelle periferie cittadine nel dopoguerra, ed
è innegabile che, in buona misura, abbia costituito una risposta emergenziale
alla necessità di abitazioni degli strati più poveri della popolazione inurbata.
Indagare sulle cause dell'inefficienza pubblica di fronte all'espansione
demografica porterebbe assai lontano. Qui basti dire che in molti casi
l'abusivismo è stato un "sottoprodotto" della grande speculazione edilizia e
fondiaria, in certo modo ad essa funzionale, e che tutti i tentativi di dare in
tempo utile al Paese una normativa urbanistica capace di porre un freno
all'abuso dello jus aedificandi sono falliti di fronte alla coalizione di forze
politiche ed economiche variamente assortite (v. il "caso legge Sullo" dei primi
anni '60!).
Ma era nella logica stessa del fenomeno che -
sistemate in qualche modo le folle di senza tetto - esso si volgesse verso
obiettivi più remunerativi. In epoca più recente è quindi iniziato il fenomeno
dell'assalto alle coste, alle spiagge, ai boschi delle località turistiche,
sovente con la copertura "morale" di presunte necessità abitative, di fatto
inconsistenti.
Questo tipo di abusivismo - quello totale- ha
colpito l' Italia in modo assai discontinuo. Sarebbe un grosso errore dire che
il territorio -anche solo quello costiero- è stato devastato dagli "abusi"
edilizi; in realtà danni enormi sono stati arrecati da quella che si potrebbe
definire edilizia semilegale, o solo formalmente legale (di cui si dirà ai punti
successivi). Resta tuttavia innegabile che l'abusivismo, concentrato soprattutto
in alcune zone di ogni Regione, ha avuto effetti devastanti: le campagne intorno
alle grandi città, la via Prenestina a Roma, l' area Vesuviana, Ischia e Capri,
i Campi Flegrei, l'agro nocerino-sarnese e mille altri luoghi, a volte carichi
di bellezza e di storia, sono stati massacrati, insieme a centinaia di Km. di
coste, da questo fenomeno incivile. Caso paradigmatico quello del Monte
Argentario - luogo mitico e supervincolato della "civile Toscana"- laddove nel
'74 le denunce del WWF portarono alla scoperta di centinaia di edifici abusivi
(o falsamente legali, ad esesmpio per essere stato autorizzato il "restauro" di
manufatti inesistenti!), che nell'insieme stavano trasformando il Promontorio in
una sola lottizzazione abusiva. E qui più che altrove è apparsa con chiarezza la
mistificazione demagogica messa in atto da chi - politici e amministratori in
primo luogo- ha cercato di spacciare per "piccolo abusivismo dei contadini
locali" quel che invece era la costruzione di vere e proprie ville (o embrioni
di esse), da rivendere ad alto prezzo ad acquirenti esterni....
2) ABUSIVISMO LEGALIZZATO. Ci si riferisce,
ovviamente, al frutto dei vari condoni, sempre più simili nei loro effetti a
un'incivile "sanatoria permanente" (rischio inutilmente fatto presente dal WWF
fin da quando si cominciò a parlare di un condono). Per come è stata gestita
tutta l'operazione condono non ha fatto che rafforzare la diffusa convinzione
che, prima o poi, tutto sarebbe stato sanato, anche gli abusi a venire. Oltre a
ciò, il gravissimo problema dei controlli, affidato in toto a amministrazioni
locali sovente corresponsabili e a Soprintendenze dai mezzi irrisori, aveva
fatto temere il peggio, che puntualmente si è verificato.
Leggiamo oggi (stime del CRESME) che dal
31/12/1993 (ultima data utile per l'ammissione di immobili al condono) ad oggi
sono state realizzate oltre 200.000 nuove abitazioni abusive. Ed altre 230.000
case erano sorte nel giro di appena due anni (1983/4) come conseguenza del primo
condono. E' dunque chiarissimo che gli abusivi incalliti non hanno mai creduto
nel "giro di vite" annunciato al termine della sanatoria, ma che al contrario
hanno approfittato dei condoni per realizzare sempre nuove costruzioni, anche a
termini di condonabilità scaduti, contando di riuscire in qualche modo a sanarle
(per successiva riapertura dei termini, ovvero truccando le denunce per quanto
concerne le date di costruzione).
A riprova del caos venutosi a creare, due casi
limite: la rivolta (apertamente spalleggiata da certi sindaci) degli abusivi
organizzati in Sicilia - quelli di speculazione ben mascherati dietro quelli "di
necessità"- i quali semplicemente non volevano pagare per nessun tipo di
condono, e il tentativo di far condonare perfino.....il "Mostro di Fuenti". Anni
addietro infatti l'allora Ministro dei Beni CC.AA. V. Bono Parrino, sul finire
del proprio mandato si accingeva a firmare un parere positivo preliminare al
condono (essendo la zona vincolata), in quanto il Mostro "non sembrava in
contrasto con rilevanti interessi ambientali...". Una macroscopica svista,
almeno si spera, ma che dimostra la superficialità e l' improvvisazione con le
quali tutta la sciagurata vicenda dei condoni è stata gestita.
3) EDILIZIA SEMILEGALE, O SOLO FORMALMENTE LEGALE.
Qui il discorso si fa ben più complesso. Infatti se per edifici "semilegali" si
possono intendere quelli realizzati in grave difformità dai progetti approvati,
ovvero sulla base di progetti che non avrebbero potuto essere approvati (esempio
classico: villette munite di "regolare" concessione edilizia, ma che
nell'insieme formano una lottizzazione), per edifici "formalmente legali" si
debbono intendere invece quelli muniti di tutti i "pezzi di carta" necessari, ma
che ugualmente hanno sul territorio un impatto devastante.
Ed in quest' ultima categoria rientrano proprio le
colate di cemento più inconsulte ed oltraggiose dall' ultimo dopoguerra. Dalle
orrende periferie urbane degli anni '60 alle lottizzazioni negli ultimi boschi e
pinete costiere (vedi il "caso Capocotta"). Da certi squallidi villaggi
turistici sulle Alpi e sugli Appennini ai tentativi scellerati di costruire
ville di lusso lungo tutta l'Appia Antica (chi, tra gli "addetti ai lavori" non
ricorda le vibranti invettive di Antonio Cederna?) dai vari "mostri" come quello
di Fuenti (che in effetti era sostanzialmente dotato di varie autorizzazioni)
alle ignominiose lottizzazioni che hanno cancellato in gran parte la morfologia
stessa delle nostre coste. Tutto questo, ed altro ancora, è stato fatto almeno
in gran parte dei casi nel sostanziale rispetto della legalità formale, e di
conseguenza spesse volte confortato da sentenze dei vari TAR, del Cons. di
Stato. Quante volte, dietro edifici che costituiscono un insulto alle regole del
buon gusto e del viver civile, e di cui ci si domanda chi sia stato così folle
da progettarli e autorizzarli, c'è una sentenza emessa "nel nome del popolo
italiano"....
E qui per essere più chiari occorrerebbe rifare la
storia delle leggi sull' urbanistica e sul paesaggio (teoricamente
interfacciate, secondo il legislatore degli anni '30 e '40; di fatto tenute
ermeticamente separate, e conculcata fino a tempi recenti la seconda). Il
"tradimento" delle leggi urbanistiche si è consumato attraverso il rifiuto di
considerare il paesaggio e l'ambiente come invarianti del territorio e limiti
naturali all'edificabilità. Attraverso le fallimentari vicende della legge
"Ponte" n° 765 (che, nata per mettere un argine allo scempio, grazie al
vergognoso "anno di moratoria" sulle licenze edilizie e alla sopravvivenza degli
anacronistici Programmi di Fabbricazione si risolse in un colpo di acceleratore
per tutte le lottizzazioni), attraverso il rifiuto di porre alcun serio vincolo
all'edificabilità almeno nelle aree extraurbane di maggior pregio. O attraverso
la permissività irresponsabile con la quale sono stati approvati pessimi
strumenti urbanistici locali (tra i quali i Programmi di Fabbricazione,
concepiti su misura per le esigenze della proprietà fondiaria e delle
lottizzazioni), ecc.
Oggi il quadro generale è indubbiamente mutato:
costruita gran parte del costruibile l'attenzione va fatalmente spostandosi
verso la salvaguardia di ciò che è rimasto, e verso un parziale recupero
dell'ambiente - laddove possibile- che passa per la demolizione degli abusi
peggiori e la "decostruzione" di manufatti anche legali ma ambientalmente
insostenibili (riconversione di aree industriali obsolete, difesa dei terreni
agricoli, ecc.). Qui molto altro ci sarebbe da dire sul sistema dei Parchi e
Riserve (nazionali e regionali) faticosamente avviato, sui Piani Paesistici che,
con forti ritardi e molte incongruenze, sono ovunque in via di approvazione,
ecc. Tuttavia affrontare anche questi aspetti pur fondamentali porterebbe a
sviluppi eccezionali. Emerge invece una nuova preoccupante tendenza fra molte
Regioni, le quali, nella perdurante assenza di un Testo Unico statale
sull'urbanistica e sulla scia dell'esempio della Toscana, stanno dotandosi di
una propria legislazione urbanistica fortemente innovativa (cosa non esente da
critiche sul piano della costituzionalità), ed improntata a criteri di
"elasticità", flessibilità e completa valorizzazione delle autonomie locali.
Cosicchè, ad esempio sarebbero gli stessi Comuni ad approvare i propri strumenti
urbanistici (ribattezzati "Piani Strutturali", anzichè "Regolatori", a
sottolinearne il valore programmatico e non vincolante), spettando alle varie
autorità "di controllo" solo il potere di presentare delle "osservazioni", ecc.
Anche questo è un discorso che porterebbe lontano,
ed è quindi il caso di fermarsi a un accenno. Resta tuttavia l'ineludibile
esigenza di fare ordine e chiarezza nella materia urbanistico/edilizia,
cominciando con l'approvare quella legge-quadro (o Testo Unico) nazionale di cui
si parla inutilmente fin dal dopoguerra. Altra questione di grande portata ed
attualità, certamente non risolta da Tangentopoli, è quella della moralizzazione
di tutta la politica, e conseguentemente della pubblica Amministrazione. Non c'è
infatti il minimo dubbio che gran parte della devastazione territoriale che si è
cercato finora di descrivere sia stata provocata dalla pura e semplice
corruzione (e in vaste aree da veri e propri interessi di mafia), il territorio
essendo stato ridotto a merce di scambio tra politici, mercanti di aree e
costruttori.
E allora, tornando al tema delle demolizioni,
oltre a casi emblematici quali ad esempio il "Mostro di Fuenti" e suoi
consanguinei, occorrerebbe cominciare a pensare seriamente - stabilendo una
scala di priorità a seconda della gravità ambientale - alla demolizione almeno
di una buona parte di quegli oltre 18.000 abusi non sanabili verificatisi a
partire dall'entrata in vigore della legge 47/1985 nelle aree vincolate
paesaggisticamente, nei Parchi e sul Demanio.
ll fenomeno è molto complesso.
C'è quello che viene definito abuso di necessità,
proprio di chi ha costruito una casa per abitarci, cioè una "prima casa" e non
una casa di villeggiatura o "seconda casa". In ogni caso questi abusivi hanno
infranto la legge e non sembra giusto "condonare" perché agli italiani onesti
(la maggioranza) che la casa l'hanno costruita in modo legale (naturalmente
pagando le tasse relative, cosa che gli abusivi non fanno) può sembrare un
premio ai "furbi".
E c'è poi l'abusivismo legato alla grande
criminalità organizzata (Mafia, Camorra, 'Ndrangheta), che non di rado si
intreccia con il primo. Orientarsi è difficile, ma qui di seguito riportiamo
alcuni dati, ufficiali.
GLI ECOMOSTRI
Gli ecomostri sono le enormi costruzioni di
cemento che deturpano siti archeologici, spiagge e oasi naturalistiche (da qui
il nome, mostro ecologico). Si tratta di costruzioni abusive nate dalla
"collaborazione" tra imprenditori disonesti e politici locali corrotti. In
Italia i mostri di cemento erano 14, ora ne sono rimasti 11 perché il Governo ha
finalmente cominciato la guerra contro l'abusivismo edilizio.
Il primo mostro abbattuto è stato il FUENTI, un
mega albergo costruito alla fine degli anni '70 sulla costiera amalfitana: 34
mila metri cubi di cemento, 24 metri di altezza (sette piani), 2000 metri
quadri di superficie. Tutto questo in un'area che l'Unesco aveva dichiarato
patrimonio dell'umanità. È stato definito un "misfatto ecologico esemplare".
LE TAPPE DELLA STORIA DEL "FUENTI"
1968 Il 5 agosto del 1968 il Comune di Vietri sul
Mare concede la licenza edilizia e la Sovrintendenza della Campania dà il
nulla-osta paesaggistico. L'area è già sottoposta a vincolo
1971 L'edificio viene terminato nel 1971, dopo
polemiche e sospensioni dei lavori. Nello stesso anno la Sovrintendenza revoca
il nulla-osta poiché la costruzione non corrisponde ai progetti presentati.
Anche il Comune annulla la licenza e i provvedimenti sono confermati dal
Consiglio di Stato nel 1981.
1985 Con il condono edilizio del 1985 la società
proprietaria chiede la sanatoria dell'edificio: la Regione Campania dà parere
favorevole, ma il Ministero dei Beni culturali annulla il nulla-osta della
Regione.
1992 Una sentenza del Tar (Tribunale
amministrativo regionale) della Campania conferma la decisione del Ministero dei
Beni Culturali.
1997 Una sentenza del Consiglio di Stato
(dicembre) stabilisce che l'albergo non può essere condonato. L'Hotel Fuenti è
stato utilizzato solo per i terremotati dell'Irpinia.
Il secondo ecomostro abbattuto è stato PUNTA
PEROTTI - Complesso residenziale costituito da due edifici di 11 e 13 piani sul
lungomare di Bari. Il complesso è stato realizzato nell' ambito di due piani di
lottizzazione che prevedono la realizzazione di 290.000 metri cubi
complessivi. La struttura è stata edificata ad una distanza inferiore a 300
metri dal mare e posizionato in modo da nascondere totalmente la vista del
lungomare a sud di Bari.
02/04/2006 - Conclusa la prima fase della tanto
attesa demolizione dell'ecomostro Punta Perotti a Bari. Tutto come previsto: 350
chilogrammi di tritolo hanno fatto implodere i due terzi della saracinesca che
da oltre dieci anni taglia il lungomare barese.
23/04/2006 - Seconda esplosione: crolla anche la
seconda parte dell'ecomostro. Il 24 aprile è attesa l'ultima esplosione che
demolirà interamente la costruzione.
Nel gennaio 2001 il Ministro dell' Ambiente e il
Ministro dei Beni Culturali hanno presentato un disegno di legge per la tutela
ambientale ed il recupero dei siti compromessi dalla speculazione. È previsto
l'abbattimento degli 11 ecomostri ancora esistenti. Eccone l'elenco:
SPALMATOIO DI GIANNUTRI - Complesso edilizio
destinato a mini-appartamenti grande complessivamente 11.000 metri cubi,
realizzato in una zona ad elevato pregio paesaggistico all' interno del Parco
nazionale dell' Arcipelago Toscano.
SCHELETRO DI PALMARIA - Complesso edilizio
destinato ad albergo e miniappartamenti, alto circa 25 metri e con un volume di
10.000 metri cubi. L' area si trova nel territorio del Parco nazionale delle
Cinque Terre.
CONCA DI ALIMURI - Struttura edilizia destinata ad
uso alberghiero realizzata a ridosso della battigia, non ancora ultimata. Il
complesso ricade all' interno del Piano urbanistico territoriale della penisola
sorrentino-amalfitana.
BAIA PUNTA LICOSA - Si tratta di 53 edifici
destinati a residenza, costruiti, ma non ancora ultimati, all' interno di un'
area caratterizzata dalla presenza di alberi di particolare pregio (pino d'
Aleppo). L' area si trova all' interno del territorio del Parco nazionale del
Cilento e Vallo di Diano.
PIETRA DI POLIGNANO A MARE - Complesso turistico
costituito da una struttura alberghiera ed alcuni villini, per un volume
complessivo di 34.000 metri cubi. Il complesso ricade nella fascia di 300 metri
dalla battigia, in area soggetta a vincolo paesistico di tutela assoluta.
FOSSA MAESTRA - Complesso edilizio vicino Massa
Carrara destinato ad accogliere 65 mini appartamenti e locali accessori. Si
trova in un' area classificata come zona di valore paesaggistico ed ambientale
da sottoporre a conservazione.
BAIA DI COPANELLO - Complesso edilizio costituito
da albergo ed abitazioni a schiera, realizzato in assenza di concessione
edilizia.
VILLAGGIO SINDONA - Complesso costituito da 12
edifici a schiera realizzato in località Cala Galera e non ancora ultimato. L'
area ricade nella riserva naturale di Lampedusa, soggetta a vincolo
paesaggistico ed idrogeologico. È inoltre sottoposta a vincolo di
inedificabilità assoluta.
CAPO ROSSELLO - Complesso di edifici residenziali
per complessivi 9.000 metri cubi, realizzato in prossimità della battigia.
CALA DEI TURCHI - Complesso alberghiero vicino
Agrigento di circa 15.000 metri cubi. L' edificio non è stato ancora completato.
IL CONDONO EDILIZIO
Il condono edilizio non è mai stato una soluzione
positiva al problema. Anzi. Non appena si comincia a parlare di condono
edilizio, il numero di edifici abusivi cresce enormemente: tutti sperano di
essere "condonati", cioè di vedersi riconosciuti legittimi proprietari di una
casa costruita illegalmente. Ad esempio, l'anno precedente al condono edilizio
del 1985 voluto dal Governo Craxi, cioè il 1984, è stato l'anno peggiore per
l'abusivismo: su un totale di 270.000 nuove abitazioni circa un terzo (80.000
unità) erano abusive. Le cose recentemente vanno un po' meglio, ma i dati sono
sempre gravi.
Secondo gli studi di Legambiente e dell'Istituto
di ricerca Cresme, nel quinquennio 1994-1998, cioè dopo il condono approvato dal
"Governo Berlusconi-Radice", sono state realizzate 232.000 nuove case abusive,
per una superficie complessiva di 32.5 milioni di metri quadrati e un valore
immobiliare di 29.000 miliardi di lire. L'evasione fiscale è di 6.700 miliardi
di lire.
Solo nel corso del 1998 sono stati costruiti ben
25.000 stabili abusivi (3,5 milioni di mq, un valore di mercato stimato
superiore ai 3.000 miliardi di lire e una evasione fiscale pari a 730 miliardi).
Il 76,3% delle costruzioni illegali (vedi tabella a fianco) è concentrato nelle
regioni meridionali e nelle isole; al Centro la percentuale scende al 9,7%
mentre al Nord risale al 14%.
Le regioni più corrette sono per lo più al Nord
(la Valle D'Aosta con lo 0%, il Trentino con lo 0,5 %, l' Umbria con lo 0,6 % e
la Liguria con lo 0,9%). Il mattone illegale è invece ancora abbastanza
presente nel Lazio (4,8%), in Lombardia (3,8%) ed in Veneto (3,9%).
Al Sud, in particolare il fenomeno è concentrato
in Campania (19,8%), Sicilia (18,2%), Puglia (12,8%) e Calabria (8,8%), dove
esiste quasi il 60% del totale nazionale delle costruzioni illegali. Ciò
dimostra che il fenomeno dell'abusivismo è legato al fenomeno delle
organizzazioni criminali e mafiose, che sono particolarmente radicate nelle
quattro regioni citate.
Concludiamo con una novità sulla "tipologia
dell'abusivo" come è emersa da un'indagine di Legambiente sull'abusivismo a Roma
e nel Lazio negli ultimi anni: i "costruttori spontanei" hanno abbandonato le
periferie per spostarsi su aree pregiate. La maggior parte degli abusivismi,
infatti, è stata individuata all'interno dei parchi: 33 lottizzazioni su un
totale di 74, estese per 209 ettari su un totale di 314. I restanti abusi si
registrano nelle aree adiacenti ai parchi e in zone esterne agli stessi.
Si vede che anche gli abusivi romani, come quelli
agrigentini della Valle dei Templi, sono sensibili alle bellezze naturalistiche
e archeologiche. Popolo di poeti, di artisti, di pensatori, di santi, di
scienziati....
Norme antisismiche violate. Abruzzo lunedì 6
aprile 2009, ore 3,32
Gli allarmi inascoltati. La scossa devastatrice.
Le vite spezzate. La disperazione dei sopravvissuti. Il dramma dei bambini. Eroi
e vecchi camion. Un reportage da “Il Corriere della Sera” a “L’Espresso” e
“Panorama”.
I vigili del fuoco arrivati da tutto il Paese sono
stati costretti a portare in Abruzzo anche vecchi camion scassati.
Bestioni appesantiti da venti anni di servizio o
ancora di più. Che a volte, dopo un rantolo del motore, si sono fermati in
autostrada e, come certi muli di una volta, non han voluto saperne di ripartire.
Eccole qui, la faccia dello Stato. L’Italia dei vetusti «Fiat Om 90», «AF Combi»
o «APS Eurofire» in servizio dai tempi lontani in cui il centravanti della
nazionale era Paolino Rossi. Carrette di lamiera che dopo essere state lasciate
«dieci anni nei capannoni» (parole di un comunicato ufficiale del sindacato di
base Rdb-Cub) sono finite «fuori uso per problemi di ribaltamento e rotture ai
supporti del serbatoio dell’acqua» e abbandonate lungo il percorso. Non puoi
sentirti orgoglioso di come sgobbano i carabinieri e i poliziotti, le guardie di
finanza e i forestali e tutti gli altri, senza ribollire d’insofferenza a
guardare la mattina dopo, tra le macerie di Onna, la delusione dei volontari
della Protezione civile del Friuli, che sono venuti giù coi loro cani e le loro
tende e le loro attrezzature e stanno lì impotenti nelle loro divise nuove di
zecca che non riescono a sporcare: «Sono già le dieci, siamo qua da ieri sera e
nessuno ci ha ancora detto come possiamo renderci utili. Che modo è?».
È l’Italia. La «nostra» Italia. Piccoli egoismi e
fantastica dedizione, efficienza e sciatteria, ripiegamenti individualisti e
straordinario altruismo di uomini e donne accorsi da tutte le contrade a dare
una mano.
Il gran Sasso, lassù in alto, domina severo.
L’impresario edile Bruno Canali, ai margini di quella Onna in cui le ruspe
scavano solchi tra le montagne di macerie per ricostruire il tracciato delle
vecchie strade, mostra il suo villino: «Non c’è una crepa ». Spiega che l’ha
costruita seguendo «tutti i criteri antisismici». A pochi metri, le altre case
si sono sgretolate. Da lui non è caduto un soprammobile. Come fai a non
arrabbiarti, a guardare le fotografie della biblioteca della scuola elementare
crollata a Goriano Sicoli o, peggio ancora, dell’ospedale (l’ospedale!)
dell’Aquila? Sono anni che si sa come si dovrebbe costruire, nelle aree a
rischio. Non sono serviti a niente la durissima lezione del terremoto ad
Avezzano né gli avvertimenti degli esperti che da decenni ricordano come le zone
più esposte siano quella a cavallo dello Stretto di Messina, la Sila in
Calabria, il Forlivese, la Garfagnana e la Marsica né il disastro di qualche
anno fa in cui morirono i piccoli di san Giuliano. A niente. «Dopotutto non è la
natura che ha ammucchiato là ventimila case di sei-sette piani», disse furente
Jean-Jacques Rousseau a proposito del catastrofico terremoto di Lisbona del
1755. L’uomo non può sfidare impunemente la natura: questo voleva dire. Non può
contare, spensieratamente, solo sulla buona sorte. Eppure così è sempre stato,
da noi. E decine di migliaia di persone hanno continuato ad ammucchiarsi
disordinatamente intorno al Vesuvio nonostante siano passati solo pochi decenni
dall’ultima eruzione del 1944 quando la gente pazza di paura prese a girare con
la statua di San Gennaro perché fermasse la lava già bloccata quarant’anni prima
dal santo a un passo da Trecase. E migliaia di sindaci e assessori e vigili
urbani hanno chiuso gli occhi per anni sul modo in cui, anche nelle zone più
pericolose, venivano tirati su spesso con cemento scadente e piloni gracili i
condomini e le scuole e gli edifici pubblici. Per non dire di chi aveva le
responsabilità più gravi. Ma, come accusava Il Sole 24 ore del 7 aprile 2009, il
varo delle nuove regole si è via via impantanato di ritocco in ritocco, di
rinvio in rinvio, di proroga in proroga. Colpa della destra, colpa della
sinistra. Basti ricordare che fu solo la Corte Costituzionale, nel 2006, tra i
lamenti e gli strilli dei costruttori («Siamo molto preoccupati per il rischio
di paralisi nei cantieri, si potrebbe bloccare l’edilizia!») a bloccare una
legge troppo permissiva della Regione Toscana spiegando che no, «in zona
sismica, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico».
Ed è sbalorditivo, oggi, tornare indietro soltanto
di qualche giorno dal sisma. E trovare la conferma che mai, prima
dell’apocalisse del 6 aprile 2009, erano state nominate parole come sisma o
terremoti nella proposta edilizia del governo Berlusconi alle Regioni del giugno
2008, mai nella prima bozza del «piano casa», mai nell’intesa del 31 marzo
2009. Mai. Con il terremoto in Abruzzo Claudio Scajola detta alle agenzie che il
piano casa «dovrà essere utile anche per le protezioni antisismiche» e il nuovo
documento dato alle Regioni, ritoccato in tutta fretta, ha un «articolo 2» nuovo
nuovo. Dove si spiega, sotto il titolo «misure urgenti in materia antisismica»
che «gli interventi di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione di
immobili e gli interventi, che comunque riguardino parti strutturali di edifici,
non possono essere assentiti né realizzati e per i medesimi non può essere
previsto né concesso alcun premio urbanistico sotto alcuna forma ed in
particolare come aumento di cubatura, ove non sia documentalmente provato il
rispetto della vigente normativa antisismica».
Evviva. Ci sono voluti i lutti di Onna e la
distruzione dell’Aquila e quelle file di bare allineate, però, per cambiare il
testo originale dato alle Regioni solo una settimana prima. Dove l’articolo 6,
precipitosamente soppresso dopo il cataclisma abruzzese, era intitolato
«Semplificazioni in materia antisismica». Meglio tardi che mai. Purché dopo una
settimana, un mese, un anno, non torni tutto come prima.
Qualcuno adesso dovrà indagare. Una volta sepolti
i morti e sistemati gli sfollati, dovrà spiegare perché a L'Aquila il cemento
impastato dieci o vent'anni prima già si sbriciola come pane secco. Dovrà dire
perché queste travi si sono spezzate e hanno fatto un massacro. Come in Abruzzo,
con il brivido delle scosse di assestamento e il vento del Gran Sasso che spazza
le macerie di via Luigi Sturzo, centro città, cento per cento di morti nelle
case nuove là in fondo alla strada. Nuove. Eppure sono venute giù.
Se due mesi di sciame sismico riducono così il
cemento, allora l'allarme lo dovevano dare molto prima. Invece questo passerà
alla storia come il primo terremoto previsto in Italia. E, purtroppo, anche come
il primo snobbato dalle autorità. Hanno ignorato l'annuncio del disastro molti
sindaci della provincia per finire, su su, agli esperti della Protezione civile.
Eppure la previsione di Giampaolo Giuliani,
tecnico del laboratorio scientifico del Gran Sasso insultato e denunciato per
procurato allarme, non è uno scoop da premio Nobel. Che la liberazione di gas
radon dagli strati profondi delle rocce riveli l'arrivo di un forte terremoto,
lo si impara al primo anno di Geologia all'università. Anche in Italia. È vero
che non è possibile conoscere con precisione quando colpirà la scossa. Ma a
L'Aquila e lungo l'Appennino la terra tremava e da fine febbraio. Avere un
laboratorio di fisica proprio dentro il Gran Sasso, la montagna attraversata
dalle faglie e dalle tensioni geologiche di questo disastro, era poi una immensa
opportunità. Forse bastava sfruttarla. Nessun preallarme nemmeno per i soccorsi
in una regione fatta di antichi paesi di sassi e pietre.
Lunedì 6 mattina a Civita, una frazione a pochi
chilometri da Onna, vicino all'epicentro in provincia, gli abitanti hanno dovuto
sbarrare la strada a un convoglio dei vigili del fuoco per chiedere loro di
estrarre due persone. Le hanno tirate fuori che erano già morte. I pompieri son
ripartiti subito per L'Aquila. I cadaveri sono rimasti a Civita, per terra, fino
alle quattro del pomeriggio: "Quando è arrivata un'auto delle pompe funebri",
raccontano i testimoni. Sono le priorità a stabilire dove si devono fermare i
convogli. I primi sono stati inviati dove c'erano più cadaveri: a L'Aquila, a
Onna, a Paganica. Così gli abitanti delle piccole frazioni hanno dovuto
aspettare. Non c'erano alternative. Da martedì, secondo la Protezione civile,
con l'arrivo dei rinforzi da tutta Italia, anche i centri più piccoli sono stati
raggiunti. Nonostante la previsione del terremoto, però, gli abitanti della
città e di tutta la provincia avevano creduto alle rassicurazioni degli esperti
della commissione Grandi rischi, riprese dal capo della Protezione civile, Guido
Bertolaso, dal governo e dalle autorità locali. Nessuno immaginava che perfino
le costruzioni più moderne di L'Aquila fossero trappole. Non lo sapevano i
ragazzi italiani e stranieri morti e feriti nel pensionato universitario,
nemmeno i quattro studenti sepolti in due stanze prese in affitto in un'altra
villa in via Sturzo. Non lo poteva immaginare.
Gran parte delle strade di L'Aquila in quei giorni
era al buio. In molte case però non mancava la luce. Vedi le finestre illuminate
dentro le tapparelle abbassate. Credi che ci sia qualcuno lassù. Invece è la
fotografia di lunedì 6 aprile, ore 3,32, il momento esatto della scossa, 5,9
gradi della scala Richter, nemmeno un record in Italia.
A metà di via Sturzo la fuga di una famiglia su
un'Alfa Romeo è rimasta bloccata al cancello, quando un grosso pezzo di
cornicione l'ha colpita in pieno. In una camera da letto spogliata dai muri
perimetrali è ancora accesa l'abat-jour sul comodino. Sui balconi sopravvissuti
al crollo, il bucato steso la domenica sera. I libri negli scaffali. Le sveglie
che ancora suonano la mattina presto. Persiane semichiuse che ricordano le ville
calcificate di Pompei. Istantanee di vita quotidiana. Al buio si intuisce la
sagoma di quattro donne avvolte nelle coperte di lana. Si fanno coraggio insieme
e dormono sulle sedie davanti alla casa di una di loro. Non hanno voluto
andarsene al centro di raccolta. Pochi passi più avanti, in fondo a via Sturzo,
le fotoelettriche illuminano il vuoto. Due ruspe rimuovono il groviglio di
tondini di ferro. L'armatura a queste costruzioni non manca. Stupisce
l'apparente fragilità del cemento. Tre o quattro ville, tutte uguali, si sono
accasciate sui loro piani. Resta soltanto il tetto di due. In una sono morti due
anziani. Nella seconda almeno quattro studenti tra i quali un ragazzo della zona
di Vasto, in Abruzzo. La sua mamma sostenuta da un'amica piange da ore. «Ho
provato a far suonare il suo telefonino», sussurra, «risulta irraggiungibile. Un
collega di università di mio figlio ha invece chiamato il telefonino di un suo
compagno di stanza sepolto là sotto. Quello suona ancora, ma da domenica notte
nessuno risponde».
Subito più avanti il cumulo di macerie nasconde la
bimba di tre anni e tutta la sua famiglia. Rimossi i blocchi di cemento, trovano
prima il piccolo materasso del lettino. Si vede subito che apparirà un bambino.
Non ci sono più bare. Nemmeno bodybag, i sacchi utili per trasportare le vittime
delle emergenze, che l'Italia ha regalato negli anni scorsi alla Libia. I
soccorritori liberano dai calcinacci una coperta di lana. La ripiegano per
usarla come barella. Avvolgono la piccola nella lana e la adagiano sulla terra.
Vigili del fuoco e guardia forestale interrompono per qualche minuto il lavoro a
mani nude nei detriti. Li guida un abitante del quartiere in tuta blu, grigio di
polvere fin nei capelli. «Adesso restano da trovare un'altra bambina, la sua
mamma e il suo papà», spiega l'uomo al capo operazioni dei pompieri: «Poi
dobbiamo tirare fuori gli anziani che abbiamo visto nella casa accanto. Ma non
so quanti sono». Arriva finalmente l'ambulanza, allontanata per caricare le
macerie su due grossi camion. «Come si chiama questa bambina?», chiede
un'infermiera della Croce rossa. Nessuno sa rispondere. Non ci sono parenti. Non
ci sono vicini. Tutti sotto le macerie. Forse una quindicina di morti. Tutti
sepolti dal crollo di case relativamente nuove. Intorno le costruzioni più
vecchie e i condomini sono rimasti in piedi. Hanno danni strutturali. La
facciate bombardate. Ma i loro abitanti hanno almeno avuto il tempo di
svegliarsi e fuggire.
In via Sant'Andrea all'angolo con Generale
Francesco Rossi, prega la mamma di Armando Cristiani. Per arrivare fin qui
bisogna sfidare i calcinacci che le scosse sparano come cecchini dalle cime dei
palazzi. Antonio Rossi, il papà, cammina su e giù con un piccolo ombrello in
mano e un sacchetto di biscotti sottobraccio. Era la cena che un vigile urbano
gli ha regalato. Sulla montagna di macerie continua il lavoro di altri eroi.
Rischiano la vita e altri crolli per salvare Marta, un'altra studentessa tradita
dalle norme antisismiche dei palazzi dell'Aquila. Una ragazza raggiunta nel
pomeriggio dagli speleologi e dai soccorritori del Club alpino italiano. «Marta
ci ha detto di aver sentito delle grida salire dalla tromba delle scale. Una
voce molto più sotto di lei», racconta uno speleologo: «Abbiamo chiamato,
abbiamo provato ma non ci ha risposto nessuno». Antonio Cristiani è convinto che
suo figlio sia lì ad aspettare che qualcuno lo tiri fuori. Erano sei studenti in
affitto, in un appartamento al terzo piano. Tutti dispersi. «Ho sentito mio
figlio sabato sera», racconta la mamma, «mi ha detto che c'era appena stata una
forte scossa. Eravamo preoccupati, ma lui diceva che poi passava».
Trema ancora la terra. Scosse forti che fanno
crollare i muri che ormai non si reggono più. Gli speleologi portano in
superficie Marta, la avvolgono, la caricano su un'ambulanza. «La ragazza era
incastrata accanto a un armadio», racconta il soccorritore che l'ha liberata:
«Sotto c'era il vuoto e dovevamo stare molto attenti a non farla cascare più in
basso». Questi soccorritori sono ragazzi di poche parole. Lo speleologo dice
solo che di mestiere fa il carpentiere- saldatore: «Niente nomi, non servono». E
se ne va sulla montagna di macerie a cercare Martina, studentessa di Ingegneria
gestionale. È la grande Italia dei volontari, quanto mai uniti da Nord a Sud. I
genitori di Martina aspettano avvolti in una coperta. Il padre è rassegnato:
«Ormai mi devo mettere il cuore in pace». In via Persichetti, altro quartiere,
altra strage. I condomini sono sbrecciati. Le case dell'Ottocento sembrano quasi
indenni. In mezzo il crollo delle palazzine più nuove ha spianato l'isolato. Due
bare attendono in mezzo alla strada che qualcuno le recuperi. “L'Aquila - Visa
Persichetti, non identificata", scrive un soccorritore con il pennarello sul
nastro adesivo. L'assenza di funzionari dell'anagrafe impedisce al momento di
sapere chi sono i residenti a ogni indirizzo. L'identificazione verrà fatta nei
prossimi giorni. Anche se la mancanza di numero civico sul nastro adesivo non
sarà d'aiuto. Appare nel buio Pasqua E., la mamma di Alice Dal Brollo. È
arrivata da Cerete in provincia di Bergamo e scopre che nessuno sta scavando
nella casa di sua figlia. Poco fa c'è stata una scossa oltre il quarto grado
Richter. Per questo i vigili del fuoco si sono allontanati. Tornano poco dopo
con la guardia forestale. «Alice è sicuramente lì. Una sua compagna di stanza
l'hanno già trovata morta. Un'altra, ritornata a L'Aquila da Sora poco prima del
terremoto, è riuscita a scappare. Forse mia figlia è bloccata». La quarta
studentessa, anche lei di Sora, deve ringraziare l'influenza che si è presa. E
domenica sera non è tornata a L'Aquila. Alle nove del mattino i genitori
scoprono che Alice è morta. Come Luigi Giugno, 34 anni, guardia forestale,
ucciso nell'unica camera da letto crollata nel loro palazzo. L'hanno trovato
sopra il lettino del suo bimbo, Francesco, 2 anni, che ha tentato inutilmente di
proteggere. Accanto il cadavere della moglie e la valigia già pronta per il
ricovero al reparto maternità. Francesco questa settimana avrebbe avuto una
sorellina. Anche la loro casa sembrava sicura. Dovremmo costruire case
antisismiche, come in Giappone e in California dove i palazzi tremano ma pochi
si fanno male. Invece spenderemo quei soldi per un grande ponte a Messina.
Silvio Berlusconi l'ha ripetuto in questi giorni. Dove? Dopo aver visto le
macerie a L'Aquila.
Il crollo della prefettura. L'ospedale lesionato.
La questura inagibile. Così i soccorsi sono rimasti senza testa. Perché
nonostante le scosse nessuno aveva verificato gli edifici ?
Giù la Prefettura: quello che doveva essere il
centro nevralgico della gestione dell'emergenza è completamente fuori uso e
ridotto a un cumulo di macerie. Inutilizzabile anche la questura, altro luogo
considerato fondamentale per affrontare le grandi calamità. E poi si sbriciolano
anche gli impianti dell'ospedale San Salvatore, inaugurato dieci anni fa,
costruito con colonne in cemento armato e sale operatorie di cartapesta. Così il
terremoto spazza via tre dei pilastri dei soccorsi: obbliga la Protezione civile
a rivedere da zero i piani di intervento, in una zona che da sempre si conosce
come sismica e che da settimane vive una sciame di scosse. Ma dove nessuno si
era preoccupato di verificare la robustezza dei capisaldi per affrontare la
crisi più drammatica: fino a domenica il palazzo ottocentesco della Prefettura
era il fulcro di ogni strategia.
Davanti al collasso di queste strutture, il
professor Franco Barberi, vulcanologo e presidente vicario della Commissione
grandi rischi, non usa mezzi termini. "È desolante vedere un simile spettacolo
di inefficienza e imprevidenza in un paese come il nostro che a misurarsi con le
conseguenze dei forti terremoti dovrebbe essere abituato da sempre". E accusa:
"Le responsabilità sono diffuse a tutti i livelli, purtroppo siamo un paese che
non impara le lezioni". Invece l'emergenza è stata doppia, trasformando la
pianificazione in improvvisazione.
Guido Bertolaso, sottosegretario e commissario
straordinario per questo disastro, è stato persino costretto a sdoppiare la sala
operativa, il cervello di tutte le operazioni. Una parte è finita nei locali
della scuola sottufficiali delle Fiamme Gialle, una parte ha dovuto addirittura
chiedere ospitalità a una struttura privata come la Reiss Romoli: un centro di
alta formazione per le telecomunicazioni appartenente a Telecom Italia. Eppure,
mai come questa volta si poteva essere pronti a scattare. Bastava rispettare la
legge e ascoltare i segnali della natura, usando buon senso.
Dopo la strage di San Giuliano di Puglia, dopo
l'assurdità di un terremoto che rade al suolo soltanto la scuola ossia
l'edificio che doveva essere più solido, dopo la morte di quei ventisette
bambini erano state varate nuove regole. Ma sono passati sette anni da quel
sisma, scioccante ma di dimensioni limitate, e i controlli sui palazzi pubblici
non sono ancora diventati operativi: rinvio dopo rinvio, l'entrata in vigore
delle norme continua a slittare. La legge ignora i tempi della terra. E così in
Abruzzo tanti sono morti per colpa di verifiche che i legislatori hanno
preferito rimandare. Con oltre 70 mila edifici da esaminare, finora in tutta
Italia di verifiche ne sono state fatte sette mila, appena il dieci per cento
del totale. In Abruzzo la media è ancora più bassa. Quanto, nessuno lo sa
esattamente. Un alto responsabile della Protezione civile che preferisce
mantenere l'anonimato confessa con rabbia a “L'Espresso” di avere chiesto questi
dati alla Regione Abruzzo senza riuscire ad ottenerli. Quello che è sicuro
invece è che nessun intervento è stato fatto negli ultimi anni sugli edifici
crollati all'Aquila, nonostante la Protezione civile disponesse di 280 milioni
di euro per l'analisi della vulnerabilità e la messa in sicurezza delle
strutture strategiche.
Il palazzo della Prefettura, per esempio, per la
sua storica usura, secondo il professor Barberi andava pesantemente rinforzato.
Oppure, in mancanza di volontà o di risorse, abbandonato a favore di un'altra
sede sicura che ospitasse il quartiere generale dei soccorsi. Altre strade da
seguire non ce n'erano. Non aver fatto né una cosa né l'altra apre un delicato
capitolo sul fronte delle responsabilità che, secondo Barberi, "vanno comunque
individuate". Il crollo della Prefettura ha infatti fatto perdere ore chiave.
Subito dopo quella maledetta scossa delle 3.32 la macchina dell'emergenza a
L'Aquila è rimasta senza testa: nessuna centrale, nessuna rete di collegamenti
per coordinare il territorio con le strutture nazionali. Per indirizzare i
soccorsi verso i paesi più colpiti, per orientare i mezzi a seconda delle
necessità. "C'era un gravissimo problema di reti telefoniche e non riuscivo a
contattare, dirigenti della provincia e sindaci", denuncia il presidente della
Provincia, Stefania Pezzopane: "La gravità di quello che stavamo vivendo non è
stata percepita subito".
I vertici delle operazioni si sono prima
installati nella scuola di Telecom Italia, poi si sono trasferiti nella base
della Guardia di Finanza, che disponeva di spazi per i veicoli e di connessioni
con tutti gli apparati dello stato. Per ore c'è stato incertezza su come
rintracciare i responsabili delle operazioni e sulla gestione delle
informazioni. Ore preziose, in cui altre persone potevano essere salvate: altri
superstiti oltre ai cento estratti dal coraggio di abitanti e soccorritori.
Perchè nessuno ha verificato la stabilità della Prefettura? I piani di
intervento, che la indicavano come centrale dell'emergenza, ricadono sotto la
responsabilità della Protezione civile. Ed è incredibile che nonostante lo
sciame di scosse che da giorni sia mancata la minima precauzione. Stefania
Pezzopane parla di "tragedia annunciata": "Soprattutto dopo quello che succedeva
da due mesi con numerosissime scosse come quella forte del 30 marzo che ci aveva
portato alla chiusura di scuole". A più di dieci ore dal sisma, dichiara sempre
la presidente della Provincia: "Ho l'impressione che la situazione del
circondario sia stata sottovalutata".
La scossa del 30 marzo poteva essere un segnale
d'allarme per mettere la macchina della Protezione civile in posizione di
lancio. L'area interessata dai fenomeni sismici dista pochissimo da Roma, da
Pescara e da Ancona, con una rete autostradale celebre per la sua estensione. Ci
sono a distanze ridotte aeroporti civili e militari, ci sono basi di elicotteri,
ci sono caserme dell'esercito e delle forze dell'ordine. C'era tutto per essere
ineccepibili. E invece sono venuti a crollare i pilastri per la gestione
dell'emergenza, lasciando nella confusione le prime ore, quelle più importanti
per salvare le persone intrappolate tra le macerie.
Ancora più grave il caso dell'ospedale San
Salvatore, entrato in funzione nel 1994 e che avrebbe dovuto resistere ad ogni
genere di sisma. Invece è stato addirittura evacuato per le pesanti lesioni
strutturali registrate anche nell'armatura del cemento. "E pensare che è costato
tantissimo", afferma il suo direttore generale Roberto Merzetti: "In più,
secondo le carte di cui disponiamo era stato a suo tempo garantito per resistere
a terremoti addirittura più forti di quello che abbiamo appena registrato".
Non si sa quali garanzie siano a suo tempo state
date per la Casa dello studente crollata e costata la vita di alcuni ragazzi.
Anch'essa però era stata realizzata in cemento armato puntualmente spappolatosi
sotto la spinta del sisma. Cemento del tutto particolare e inadatto alla bisogna
e sul quale, sospettano in Regione, costruttori disonesti potrebbero avere
speculato realizzando armature di scarsa qualità. Su tutto questo già si invoca
l'intervento della magistratura. Perché i soccorritori arrivati sul posto lunedì
si sono prodigati per tirare fuori dalle macerie quante più persone possibili,
ma quelle ore chiave perse nell'assenza di un quartiere generale possono avere
determinato la fine per molte altre vite imprigionate tra le travi. Nella
speranza che almeno questa volte la lezione serva a evitare altri disastri
futuri.
“Qui sono cadute anche le case nuove”. Parole di
allarme del sindaco de L’Aquila a conferma che non sono crollate soltanto le
vecchie case in pietra del centro storico: il terremoto del 6 aprile ha
distrutto o danneggiato in modo tale da renderli inabitabili anche palazzi
moderni. L’ospedale, un presidio che non dovrebbe solo restare in piedi ma anche
funzionare in emergenza, è stato evacuato e dichiarato inagibile (per il 90%).
Come l’hotel “Duca degli Abruzzi”, che non era in un palazzo di pietra antica e
si è accartocciato su se stesso. O la chiesa di Tempera, a sette chilometri
dall’Aquila, che era un edificio moderno, fino alla ormai tristemente nota Casa
dello studente, in via XX Settembre, costruita a metà degli anni sessanta e
crollata su se stessa.
Un problema non solo dell’Abruzzo, che pure è zona
ad elevato rischio sismico. La Protezione civile calcola che in Italia siano 80
mila gli edifici pubblici “vulnerabili”: scuole, ospedali, uffici, caserme. A
essi vanno aggiunte le infrastrutture presenti in zona (strade, ferrovie,
ponti). Le scuole costituiscono una vera emergenza: quelle edificate in zone a
rischio sarebbero 22 mila, 16 mila delle quali in aree ad alto rischio; di
queste circa novemila sarebbero prive di criteri antisismici e potrebbero subire
danni in caso di scosse. Si calcola che gli ospedali da mettere a norma siano
invece 500. Ma a chi tocca intervenire? Chi decide le priorità, anche
economiche? Un’autorità centrale specifica non esiste e gli enti responsabili
sono una quantità enorme: le regioni hanno competenza per ospedali e strutture
sanitarie, province e comuni per le scuole, lo Stato per prefetture e caserme.
Dal 2003 la Protezione civile dirama con regolarità ordini di verifica, i
controlli però sono impossibili, così come capire quali siano le priorità:
bisognerebbe pianificare interventi in un lungo arco di tempo, almeno un
decennio. Lo stesso discorso andrebbe fatto per il patrimonio edilizio privato.
Un monitoraggio completo su scala nazionale non è stato fatto, ma soltanto una
mappatura in alcune aree particolarmente a rischio.
Secondo statistiche Istat elaborate dall’
Associazione Nazionale dei Costruttori Edile (ANCE), le case costruite in base
alla normativa del 1974 sono un terzo del totale in quanto gli immobili a uso
abitativo costruiti prima di quell’anno sono 7,2 milioni, il 64 per cento. Si
stima che tre milioni di italiani vivano in zone a elevata sismicità,
soprattutto lungo la dorsale appenninica del Centro e Sud Italia (dalle Marche
alla Calabria fino alla Sicilia), quasi 21 milioni in aree a media sismicità,
più di 15 milioni e mezzo in aree a bassa sismicità e circa 20 milioni in aree a
sismicità minima. Oltre un terzo del territorio nazionale presenta un rischio
terremoti medio - alto.
Il presidente del Consiglio nazionale degli
ingegneri, Paolo Stefanelli, è stato molto netto: “Non stupisce affatto che
della Casa dello studente sia crollata la parte più giovane. Tutti gli edifici
costruiti negli anni ‘50 e ‘60, a causa del tipo di cemento armato usato, sono a
rischio sismico in un tempo tra i 5 e i 30 anni”. E, a proposito del piano casa
presentato dal Governo, dice: “Questo piano potrebbe rappresentare uno stimolo
importante per ricostruire edifici a rischio a costo zero per lo Stato. Chi
demolisce un edificio per ricostruirlo ampliato del 35 per cento potrebbe dare
in permuta la volumetria aggiuntiva all’impresa che fa l’intervento ed avere
un’abitazione sicura praticamente a costo zero con la consapevolezza che tanto
prima o poi quell’edificio avrebbe richiesto un intervento radicale ai fini
della sicurezza”.
A oggi, dice Stefanelli, manca ancora una norma
che renda obbligatorio il monitoraggio sul tempo di vita delle costruzioni.
Forse solo quella, perché di norme sull’edilizia antisismica l’Italia ne ha
quattro, tutte contemporaneamente in vigore. Il decreto ministeriale 16 gennaio
1996 (”Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”) seguito, dopo il
terremoto del 2003 in Molise, dall’Ordinanza della Protezione Civile 3274, che
ha rimappato il territorio nazionale, aggiungendo zone sismiche o elevandone la
classe. E poi altri due decreti, uno del 2005, l’ultimo del 2008, denominato
“Nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”. Scienziati e
tecnologi parlano chiaro: serviranno strutture antisismiche. Così a mettere le
proprie competenze a disposizione delle popolazioni colpite dal sisma scende in
campo il CNR che ha progettato, e testato con successo un anno fa in Giappone,
una casa antisismica in legno, capace di resistere all’onda d’urto di magnitudo
7,2 della scala Richter, pari al sisma di Kobe che uccise, nel 1995, oltre
seimila persone. Il progetto si chiama Sofie, Sistema costruttivo fiemme, ed è
un prototipo messo a punto dall’Istituto per la valorizzazione del legno e delle
specie arboree del Consiglio nazionale delle ricerche (IVALSA CNR), insieme alla
Provincia di Trento.
A convalidare il progetto italiano, spiega il CNR,
“sono stati i laboratori dell’Istituto nazionale di ricerca sulla prevenzione
disastri (NIED) di Miki, in Giappone, dove, alla fine del 2007, la casa di legno
di sette piani e 24 metri di altezza realizzata dall’Ivalsa-Cnr di San Michele
all’Adige ha resistito con successo al test antisismico considerato il più
distruttivo per le opere civili: la simulazione del terremoto di Kobe di
magnitudo 7,2 sulla scala Richter”. “Il legno è una valida alternativa ai metodi
costruttivi tradizionali, in acciaio o muratura, e soprattutto un’alternativa
economica, visto che, a parità di costi, le prestazioni e i rendimenti sono
migliori”, dice una nota del Cnr. Attualmente, il primo esempio di rigorosa
applicazione della tecnologia Sofie a un edificio pubblico è in fase di
realizzazione a Trento, con un collegio universitario di 5 piani che ospiterà,
in piena sicurezza, circa 130 studenti.
XILELLA FASTIDIOSA: RESPONSABILITA' DI STATO.
Xylella: responsabilità di Stato.
L’inettitudine e l’imperizia dei governanti, la
demagogia, l’ignoranza e la falsità di un certo mondo ambientalista e gli
appetiti di coloro che ne vogliano fare un business sono più dannosi della
malattia. Si vuol desertificare il Salento sterminando tutte le piante in loco.
Come dire: c’è una persona malata, si annientano tutti i conviventi e tutti i
suoi compaesani. E' l'Isis europea che si abbatte sul patrimonio ambientale
salentino.
Il grido
d’aiuto lanciato dagli alberi salentini che possono avere una
vita millenaria comincia ad espandersi e diffondersi, purché non si affronti la
questione con un allarmismo
che non solo sarebbe inutile, ma rischia di essere dannoso. Certo, nemmeno il
complottismo può
funzionare quasi che i salentini siano stati vittime di chissà quale trama
ordita da chi lo vuol vedere piegato agli interessi extralocali.
All’inizio il progressivo ammalarsi delle piante
venne riferito ad una molteplicità di fattori tra i quali figurava anche un
batterio parassita, la Xylella fastidiosa. Con il corollario della
prospettazione di un pericolosissimo
rischio di contagio. Quasi che il Salento fosse diventato una
bomba pronta ad esplodere contaminando il resto del Paese e persino l’Europa.
Ed ecco allora che si cerca di capire chi è il
responsabile.
Parlare di responsabilità dello Stato italiano: di
questo sì che si può parlare.
Il dr Antonio Giangrande, scrittore e presidente
della “Associazione Contro Tutte le Mafie”, autore del libro
Agrofrodopolitania”, imputa al Governo la responsabilità della diffusione della
malattia degli ulivi salentini e ne spiega analiticamente i motivi.
La Procura di Lecce apre un’inchiesta - al momento
a carico di ignoti - per diffusione colposa della malattia degli ulivi nel
Salento? I responsabili ci sono e non sono ignoti: è il Governo centrale e tutti
quelli ambientalisti da strapazzo che si sciacquano la bocca con il termine
“tutela dell’ambiente e della natura”, ma che in realtà sono più dannosi dei
germi patogeni della Xylella. Non è una tesi campata in aria o di stampo
complottistico. Ma la consapevolezza che i responsabili tanto ignoti non sono.
Di sicuro vi è che il patrimonio
olivicolo del Salento ha registrato un attacco grave ad opera di
un processo chiamato CoDiRo (Complesso del disseccamento rapido degli ulivi).
Precisiamo che gli ulivi del Salento hanno
centinaia di anni. Molti di loro erano centenari già all’epoca di Dante. Queste
creature tante ne hanno viste e tanto ne avrebbero da raccontare sugli umani. «I
miei ulivi stanno bene - precisa a Leccenews24 l'anziano agricoltore con
gli occhi lucidi che lasciano trapelare una certa preoccupazione - ma ci
sono campagne vicino alla mia dove è arrivata "quella cosa"». «Io non
ci credo che non ci sia una cura, è impossibile. Guardi quest'albero, è storto,
piegato su se stesso, sembra sul punto di spezzarsi da un momento all'altro.
Eppure sono settant'anni che lo trovo sempre lì. Così mio padre. E mio nonno,
non è bello?». Per un attimo stentiamo a capire come si fa a definire un
albero "bello" poi basta guardarlo con un occhio diverso per rendersi conto che
non esiste altro termine per descrivere quel tronco massiccio e contorto, che
affonda le sue radici nel terreno puntellato di pietre e che si dirama verso il
cielo con le sue chiome argentee e rigogliose. Queste lo sono ancora. Non una
foglia marrone, non un ramo secco. Niente. A pensarci bene persino un genio
della pittura come Renoir se
n'era accorto, in una lettera datata 1889 scriveva testualmente «L'olivo,
che brutta bestia! Non potete sapere quanti problemi mi ha causato. Un albero
pieno di colori, neanche tanto grosso, e le sue foglioline, sapeste come mi
hanno fatto penare! Un soffio di vento, e tutta la pianta cambia tonalità perché
il colore non è nelle foglie ma nello spazio tra loro.
Un artista non può essere davvero bravo se non
capisce il paesaggio». L'anziano che abbiamo incontrato non
sarà il maestro dell'impressionismo, ma il messaggio è più o meno lo stesso: la
terra è un patrimonio naturalistico di
inestimabile valore che deve essere tutelato, protetto. E i
primi che dovrebbero farlo sono i contadini. Eppure sembrano essere diventati
l’ultima ruota del carro, semplici spettatori di un dramma diventato ormai
inarrestabile. «Le malattie ci sono da sempre, perché questa sarebbe
diversa? Possibile che si possa combattere solo con l'eradicazione? Ma quando
mai? - prosegue il contadino convinto che una soluzione ci sia e che basta
solo trovarla – prima di prendere qualunque decisione bisogna fare molta
attenzione perché i nostri ulivi, millenari e non, sono stati ottenuti mediante
l’innesto della varietà (Cellina di Nardò e Ogliarola) su ceppo di selvatico
resistente a ogni tipo di malattia. Non a caso i nostri uliveti sono
soprannominati “uliveti reali”
(così come classificate nelle carte geografiche dell’IGM) per la bellezza delle
piante e la bontà delle olive e degli oli prodotti». «Non bisogna dimenticare
poi che questa tipologia di alberi è riuscita anche a resistere all’incuria
grazie al suo legame con la terra da cui estrae la linfa vitale per
sopravvivere». «L’unico torto di questi alberi ultra secolari e alcuni
addirittura millenari che sono gli unici testimoni viventi della storia
dell’uomo è che non hanno mai
chiesto niente a nessuno, nemmeno alle istituzioni che
investono fior di milioni per un edificio storico, dove per edificio storico si
intende anche un fabbricato con meno di cento anni, e delle piante non si sono
mai interessati. Adesso devono pensare pure agli ulivi, che sono veri e propri
monumenti. Glielo dobbiamo». «Queste cose succedono da quando abbiamo
smesso di rispettare la terra – ci dice – gli ulivi sono stati
dimenticati in primis dall’uomo, sono stati
bistrattati, sono stati
relegati in uno stato di
assoluto abbandono, che solo l’inversione di rotta degli
ultimi anni, forse salverà…». «Lei è favorevole all’eradicazione?» chiediamo al 70enne
pur conoscendo la risposta e, infatti, perentorio, pronuncia un secco NO «al
massimo si più tagliare tanto dalla radice. Usciranno dei polloni che nel giro
di pochi anni possono diventare nuovi alberi di pregio, mantenendo così facendo
la varietà autoctona nel nostro territorio». E poi usa un termine che
strappa quasi un sorriso “scattunare”,
questo bisogna fare. Prima di salutarci ci dice una frase che ci
lascia un po’ l’amaro in bocca «dai
batteri dobbiamo difenderci, ma se dobbiamo difenderci anche dagli uomini, siamo
davvero spacciati». Quando si dice vecchia saggezza contadina.
Attenzione!!! Lo Stato Italiano, genuflesso al
potere degli altri Stati europei, Francia in primis, gli ulivi li vuole
eradicare, cioè sdradicare. Basterebbe tagliare il tronco in modo che germoglino
nuove piante su quelle radici e in pochi anni tutto ritornerebbe allo status
quo. Ma ciò non si può fare. Sarebbe troppo semplice e nessuno speculerebbe
sulla disgrazia.
Eppure la strage degli ulivi
in Salento diventa un caso internazionale con l'inerzia del
Governo italiano che non difende il suo territorio.
Nel Consiglio dei 28 ministri dell’agricoltura Ue del 16 marzo 2015, la sentenza
per la Puglia: “Abbattere tutti gli alberi infettati dal batterio Xylella
fastidiosa”. La richiesta è stata comunicata dal Commissario alla Salute Vytenis
Andriukaitis, al
Ministro italiano dell'Agricoltura, Maurizio Martina. L'eradicazione degli ulivi
resta al centro della strategia Ue per contrastare la Xylella fastidiosa, il
batterio killer che sta distruggendo gli ulivi del Salento. I paesi europei che
si sentono più vulnerabili all'espansione del batterio Xylella, in particolare
Francia, Grecia e Spagna, chiedono di abbattere almeno un decimo dei circa 9
milioni di alberi dell'area del Salento, mentre l'Italia ritiene sufficiente il
piano del commissario Giuseppe Silletti, che prevede interventi più contenuti.
In Italia, invece, lo scontro si è già spostato sul piano legale, dopo che la
sezione di Lecce del Tar di Puglia ha accolto il ricorso di due avvocati
proprietari di un uliveto a Oria, la località da cui dovrebbero partire le
misure di emergenza. L’Europa ce lo chiede: “Prima di tutto dobbiamo essere
molto chiari, tutti gli alberi colpiti dal
batterio Xylella fastidiosa devono
essere rimossi e questa è la
prima cosa”. Colpi di accetta e motoseghe, dunque, su migliaia di ulivi e non solo. Anche su lecci, mandorli,
ciliegi, albicocchi e tutte le altre piante, appartenenti ad almeno
150 specie, che risulteranno
attaccate dal patogeno
da quarantena arrivato dalle Americhe. Una raccomandazione che avrà come
contraltare, in caso di mancato adempimento, l’avvio di una
procedura di infrazione
comunitaria. Non ha usato mezze misure il commissario europeo alla Salute e
sicurezza alimentare, Vytenis
Andriukaitis, al termine del Consiglio dei 28 ministri
dell’agricoltura. Per Bruxelles,
il contagio va contenuto dentro i confini della
Puglia meridionale, a costo di
applicare la soluzione più “dolorosa”. Come dire: gli abbattimenti dovranno
essere ovunque, pure nei diecimila ettari intorno a Gallipoli, epicentro del
contagio originario, e non solo mirati nei dodici focolai individuati e nella
“fascia di eradicazione”. È questa striscia la prima sorvegliata speciale, lunga
50 chilometri e profonda 15, una sorta di fossato immaginario a cavallo tra le
province di Lecce, Brindisi e Taranto. Le ruspe entreranno in azione
innanzitutto lì, a tutela di una “fascia cuscinetto” al momento indenne. Tutta
la penisola salentina, invece, è dichiarata “zona infetta”, sebbene sia
interessata dal fenomeno solo in parte, in quaranta comuni. Spetterà agli stessi
proprietari l’obbligo di tagliare le piante colpite, concetto al limite della
discrezionalità, visto che sono ritenute tali quelle identificate “sia con
analisi di laboratorio che con riscontro dei sintomi ascrivibili all’infezione
di Xylella fastidiosa”, ma anche quelle “individuate come probabilmente
contagiate”. Per chi si opporrà? Sanzioni amministrative e interventi in
sostituzione da parte dell’agenzia regionale Arif. Così anche per chi non
effettuerà le arature entro aprile e per chi si rifiuterà da maggio di usare
insetticidi chimici.
Eppure la strage degli ulivi
in Salento ha delle chiare responsabilità dello Stato italiano
che ha legiferato sotto la spinta di un pseudo ambientalismo da strapazzo senza
sentire i contadini. Ma andiamo per ordine. Oggi, il
tanto decantato prodotto biologico profuso dagli ambientalisti ha portato i
proprietari dei terreni a non trattare con prodotti naturali o chimici terreni e
piante. Questa neo cultura impedisce di lavorare i terreni o le piante, con
arature e concimazioni. Dietro lo spirito ambientalista, spesso, però, si
nasconde la grave crisi dell’agricoltura. Non si curano i terreni e le piante
per mancanza di liquidità e, perciò, si abbandonano. L’abbandono provoca
l’essiccamento delle piante. Per quanto riguarda la potatura delle piante e la
produzione delle stoppie i nostri antenati bruciavano in loco quanto si era
potato. Ciò produceva concime e, di fatto, impediva che si propagasse
l’infezione da parte di qualche pianta malata. Ma i nostri governanti, spinti
dai soliti ambientalisti, ha ribaltato secolari sistemi di coltivazioni.
Ricordiamo che l’art. 13 del D.Lgs. 205/2010, modificando l’art. 185 del D.Lgs.
152/2006, stabiliva che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in
agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi
o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana
devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati. Accendere
falò in campagna per bruciare questi residui è quindi contro la legge poiché
integrerebbe il reato, non solo amministrativo ma anche penale, di illecito
smaltimento dei rifiuti. Sono già accaduti casi di verbali molto importanti a
carico di agricoltori, sanzionati ai sensi dell' art. 256 del D.Lgs 152/2006 che
prevede: “la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi”
come sono considerate stoppie e ramaglie.
Eppure la strage degli ulivi
in Salento diventa un caso legislativo.
Con il decreto legge del 24 giugno 2014 n. 91, in vigore dal 25 giugno, si
risolve il problema della bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali che ha
creato tanti problemi negli ultimi anni in quanto considerati rifiuti speciali.
Il comma 8 dell’art. 14 del decreto legge modifica l’articolo 256 – bis del
decreto legislativo 152/2006 ( “Codice Ambientale”) relativo alla
combustione illecita di rifiuti, prevedendo che tali disposizioni “non si
applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o
ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale
materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità
giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e
orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle
regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre
vietata.”. Ergo: Il Parlamento riconosce di aver emanato una legge sbagliata.
Dalla nuova norma si capisce che il legislatore aveva fatto una gran boiata
nell’alterare il naturale smaltimento dei residui di potatura. Si riconosce,
inoltre, che lo spostamento di quei residui in altre aree di smaltimento ha
prodotto il propagarsi del contagio.
Eppure la strage degli ulivi
in Salento diventa un caso giudiziario.
La procura di Lecce indaga sull’origine del batterio Xylella fastidiosa che sta
decimando gli alberi di ulivo salentini. L’inchiesta, secondo quanto riferiscono
alcuni quotidiani, starebbe seguendo due possibili strade. La prima è che il
batterio sia arrivato in Puglia in occasione di un convegno scientifico che fu
organizzato nel settembre 2010 dall’Istituto agronomico mediterraneo. Con una
particolarità. Uno dei possibili indiziati,
l’Istituto agronomico mediterraneo
di Valenzano (Bari), “gode per legge di immunità assoluta”, spiega il pm di
Lecce, titolare dell’inchiesta Elsa
Valeria Mignone in un’intervista a Famiglia
Cristiana. “L’autorità giudiziaria italiana non può violare il domicilio
dell’istituto, non può effettuare sequestri, perquisizioni o confische”,
spiega il magistrato. La seconda pista ipotizza che il batterio killer sia stato
introdotto con le piante ornamentali importate dall’Olanda
e provenienti dal Costa Rica.
Ergo: Mancato controllo dello Stato o di Organi pubblici sull’introduzione di
organismi dannosi nel territorio nazionale.
Eppure la strage degli ulivi
in Salento diventa un caso finanziario.
Tredici milioni di euro a disposizione del commissario
straordinario per l’emergenza-ulivi. Lo ha annunciato il direttore dell’area
Politiche per lo sviluppo rurale della Regione, Gabriele Papa Pagliardini. Le
attività riguarderanno prevalentemente la lotta ai vettori del batterio,
attraverso arature, sfalciature, potature e utilizzo di principi attivi che
dovranno impedire ai cicadellidi di diffondere Xylella. Ovviamente si dovrà
investire anche sulla ricerca, per sconfiggere il batterio là dove ha già
attecchito (si parla di circa 40mila ettari infetti su un totale di 95mila
coltivati a uliveto). Ma sulla ricerca di somme di denaro non si è parlato.
Ergo: lo Stato finanzia l’estirpazione delle piante, ma non finanzia la ricerca
per debellare la causa. Eppure basta poco. Basta dar credibilità a chi di piante
se ne intende ed aiutarli finanziariamente a praticarne la cura.
Eppure la strage degli ulivi
in Salento diventa un caso mediatico.
L’idea è nata sul web, per iniziativa dello scrittore Pino
Aprile, scrive Flavia Serr. Su La Gazzetta del Mezzogiorno. E dopo una valanga
di «post», «tweet» e «ri-tweet», ecco che la grande mobilitazione promette di
portare in piazza migliaia di persone (11mila le adesioni raccolte sulla rete).
Tutti uniti sotto lo slogan «Difendiamo gli ulivi». Lo stesso grido di battaglia
che è diventato un hashtag e ha inondato i social network (Facebook, Twitter e
Instagram), fino a coinvolgere decine di artisti e volti noti dello spettacolo,
salentini e pugliesi di nascita o «de core», mobilitati da Nandu Popu dei Sud
Sound System, agguerritissima «sentinella» degli ulivi. Fra gli altri, sono
scesi in campo (e ci hanno messo la faccia) Federico Zampaglione dei
Tiromancino, Claudia Gerini, Emma Marrone, Samuele Bersani, Marco Mater azzi,
Elio degli Elio e le Storie Tese, Fabio Volo, Raffaele Casarano, Après la
classe, solo per citarne alcuni. E nelle scorse ore, anche Giuliano Sangiorgi
dei Negramaro, direttamente da New York dove sta ultimando il nuovo disco del
gruppo, ha pubblicato su Fb una sua foto con il cartello in mano «#Difendiamo
gli ulivi». Allo scatto, ha aggiunto anche un messaggio: «Queste straordinarie
creature che stanno per essere eradicate, questi alberi secolari, chiamati
“ulivi”, rappresentano centinaia, per non dire migliaia, di anni della storia e
della vita di un popolo, come il nostro. So poco di agricoltura o di botanica.
Ma so per certo una cosa: loro (le straordinarie creature) meriterebbero una
riflessione ampia e consapevole e tutti noi abbiamo diritto di conoscere, di
sapere se e perchè “nostri simili” stanno per lasciare la vita terrena. Abbiamo
diritto alla verità». Sangiorgi in piazza ci sarebbe venuto oggi, e col pensiero
c’è. Ed è vicino a quel movimento che chiede maggiore chiarezza sulle cause del
disseccamento rapido degli ulivi e su tutte le possibili cure per affrontarlo.
Insieme a Sangiorgi, il resto della «famiglia » Negramaro sposa la battaglia,
con il batterista Danilo Tasco e il chitarrista «Lele» Spedicat o. Già nei
giorni scorsi, un fiume di altre «star» pugliesi si sono dette pronte a
mobilitarsi in difesa degli ulivi: dal regista Edoardo Winspeare allo stilista
Ennio Capasa, passando per i comici Nuzzo e Di Biase, i fotografi Flavio&Fr ank,
fino ad arrivare al rapper Caparezza che su Twitter ha scritto: «Arruolatemi tra
le sentinelle degli ulivi. Urge chiarezza sulla xylella». Così,
Le Iene il 2 aprile 2015 hanno mandato in onda un
servizio con Nadia Toffa
sull'argomento. Fabio Ingrosso e Nadia
Toffa si sono recati nel
Salento dove moltissime
coltivazioni di ulivi sono state infettate da un
batterio molto pericoloso
originario della California, di cui in Europa in precedenza non si era
riscontrata alcuna traccia. Il parassita si chiama "xylella" e rischia di
decimare migliaia di ulivi secolari. La UE ha chiesto misure drastiche di
intervento che prevedono l'eradicazione degli alberi malati seguendo una precisa
mappatura. Ma l'eradicazione, per la quale sono stati stanziati diversi milioni
di euro, è davvero l'unica soluzione? La Iena lo chiede ad un gruppo di
ricercatori e, in seguito, ad alcuni contadini del posto che hanno adottato
delle cure naturali per provare a salvare gli ulivi. Testimonial del servizio
Caparezza a
Albano Carrisi, due musicisti
che, come molti altri artisti si stanno schierando contro l'eradicazione
degli ulivi. Toffa ha spiegato con parole molto semplici qual è
la situazione, dal punto di vista geografico (cioè per quali zone si sta
prevedendo l'eradicazione), ma anche dal punto di vista storico: «Fino a oggi la
Xylella non aveva mai colpito gli ulivi, e non è detto che sia la Xylella a far
ammalare gli ulivi» sono state le sue parole, che contribuiscono a sollevare
molti dubbi su quello che sta accadendo. Sono meno di 300, ha detto Toffa, gli
ulivi malati: e allora perché l'eradicazione si preannuncia tanto massiva? Il
servizio de Le Iene suggerisce un metodo per risanare gli ulivi dalle parole di
un agricoltore, che ha curato le sue piante malate, oggi in salute, in alcuni
mesi, irrorandole con una mistura di
calce e solfato di rame,
un rimedio della nonna
che a quanto pare, nel caso dell'agricoltore intervistato, ha sortito il suo
effetto. La parola degli ulivicoltori è al momento molto importante nel Salento:
un'eradicazione massiva li getterebbe sul lastrico.
Eppure la strage degli ulivi
in Salento diventa una denuncia per la mancanza di volontà di
trovare un rimedio curativo naturale per le piante.
Quelli del movimento 5 Stelle di Tuglie hanno intervistato un agricoltore.
Domanda: Poltiglia bordolese, suggestione o via
percorribile?
Risposta. Noi non interveniamo sul batterio,
rafforziamo le autodifese della pianta con rimedi naturali. Non è affatto una
suggestione, io curo ancora molte patologie dell’apparato respiratorio con i
rimedi della nonna a base di erbe. Abbiamo solo utilizzato vecchie pratiche
agronomiche, il solfato di rame è un antibatterico e un antifungino, l’idrossido
di calcio (calce) è un disinfettante naturale usato da secoli. La vecchia
poltiglia bordolese autoprodotta non porta ricchezza alle casse delle
multinazionali dell’agrochimica. Successivamente siamo intervenuti alla radice,
con un prodotto naturale a base di aglio, che alcuni ricercatori spagnoli venuti
fin qui ci hanno gratuitamente consegnato per la nostra sperimentazione
empirica. Ci siamo accertati che fosse un prodotto naturale e registrato e lo
abbiamo usato alla base della pianta, intervenendo sulle radici.
D. Quali i sintomi della malattia?
R. La sintomatologia si nota dall’alto della
chioma per poi diffondersi su tutta la branca, sino al basso della pianta.
Proprio come una verticillosi.
D. Che fare appena si sospetta che l’uliveto
potrebbe essere stato contaminato?
R. Noi non ci sostituiamo agli organi preposti, di
certo non ci atterremo a quelle norme scellerate previste dalla quarantena che
prevedono l’uso massiccio di diserbanti e insetticidi per uccidere i fantomatici
insetti “vettori”.
D. E in termini di prevenzione?
R. Curare la terra e gli olivi. Una buona potatura
aiuta la pianta a rivegetare, ossigenare il terreno con un leggero coltivo,
ritornare alle buone pratiche dell’innerbimento e del “sovescio”: così facendo
si restituisce alla pianta sostanza organica a costo zero. Disinfettare la
pianta con la solita poltiglia bordolese autoprodotta (grassello di calce e
solfato di rame). All’occorrenza, disinfettare e nutrire i tronchi con solfato
di ferro e calce alle dosi consigliate.
D. Come si trasmette il batterio?
R. Non capisco il perché alcuni soggetti si
accaniscono sul batterio e non sulla moltitudine di funghi tracheomicosi
presenti sulla pianta e sulla radice. Credo che si stia facendo cattiva
informazione: abbiamo perso il contatto con la realtà, e quindi dobbiamo tornare
a essere più umili, prima con noi stessi e poi con madre Terra. Con la
rivoluzione “verde” dettata dall’agrochimica sponsorizzata da alcune Università,
abbiamo contribuito a distruggere la biodiversità e rotto quell’equilibrio
biologico perfetto, frutto del creato. Io non uccido nessun essere vivente!
D. La falda inquinata, magari da rifiuti tossici,
da percolato, può essere una spiegazione alla xylella?
R. Una cosa è certa: la nostra Terra è martoriata.
D. L’uso scriteriato della chimica e la smania di
far produrre ogni anno le piante può aver influito sulla diffusione del
batterio?
R. L’altro giorno leggevo la retro etichetta di
una nota multinazionale dei diserbanti, recita così: “Buona Pratica Agricola nel
controllo delle malerbe, l’applicazione degli agrofarmaci non è corretta se
viene realizzata con attrezzature inadeguate”. Come possiamo ben notare, le
stesse multinazionali dell’agrochimica, che prima ci avvelenano e poi ci
“curano”, stravolgono il senso delle parole.
Domenica 5 Ottobre 2014 a Trani abbiamo concluso
la 3 giorni del 2° meeting “Terra e Salute”, tra i relatori spiccavano alcuni
nomi noti del mondo accademico, il prof. Cristos Xiloyannis e il prof. Pietro
Perrino, ed erano entrambi a conoscenza della drammatica situazione in cui
versano i nostri olivi, ne abbiamo parlato a lungo, sono concordi con le nostre
analisi e con i nostri metodi naturali di intervento. La flora batterica è
completamente assente, le sostanze nutritive di origine organica sono granelli
di sabbia, la chimica non aiuta certo la pianta, anzi, contribuisce ad abbassare
le autodifese.
D. L’eradicazione di cui si parla può fermare il
batterio?
R. Che facciamo, applichiamo l’eutanasia agli
olivi viventi? Di olivi completamente morti non ce ne sono e l’eradicazione non
è una via percorribile e non risolve il problema batterio. Con i batteri e altri
patogeni dobbiamo convivere, Dio non ha creato animali per essere uccisi,
dobbiamo cercare il giusto equilibrio. Gli olivi sono la bellezza del nostro
paesaggio agro-culturale. I nostri olivi non si toccano!
D. Posto che si eradichi, il pollione che nascerà
crescerà sano?
R. Nelle zone più interessate all’essiccamento, Li
Sauli, Castellana, ecc., possiamo notare che l’arbusto olivo reagisce, ma non ha
la forza per mantenere tutto il peso della chioma, perché mancano le sostanze
nutrienti naturali. Quindi, è la pianta che lascia morire parte di se stessa.
Quando viene potata e quindi alleggerita dal suo carico, l’olivo reagisce,
perché concentra le proprie energie nutritive sui pochi rami rimasti.
D. Cosa pensa dell’ipotesi che la xylella sia
stata portata per boicottare l’olio di Terra d’Otranto?
R. Se sia stata importata o no, non sta a noi
verificarlo, avevamo dei dubbi e per questo presentammo un esposto in Procura.
Una cosa è certa: questa nostra martoriata Terra è sotto attacco, e gli avvoltoi
sono troppi, la nostra Terra fa gola a molti speculatori, fa gola pure alle
mafie del cemento.
D. Che interessi si giocano sul nostro olio?
R. La nostra Regione era la terra più vitata
d’Italia, poi ci convinsero a estirpare circa il 30-40% deiDSC_1301 nostri
vitigni, con punte del 50% nel Salento in cambio di 10-12 milioni delle vecchie
lire per ha, quote cedute alle Regioni del Nord. Non vorrei che si praticasse lo
stesso parassitismo per i nostri olivi: il Sud ha già dato troppo al Nord.
D. La raccolta 2014 è iniziata, la produzione
calerà. Dall’estero arrivano disdette di ordini: può rassicurare il consumatore
che nonostante il batterio l’olio prodotto è di ottima qualità?
R. L’attuale annata è scarsa in tutto il Bacino del Mediterraneo, e non a causa
del batterio. La nostra preoccupazione è per le prossime annate, fin quando i
nostri olivi non si riprenderanno. Quest’anno la produzione non sarà sufficiente
a soddisfare tutte le richieste, e l’essiccamento non incide minimamente sulla
qualità del prodotto. Siamo preoccupati dell’invasione di olio proveniente dagli
impianti ultra-intensivi dell’Australia.
Eppure la strage degli ulivi
in Salento diventa una denuncia sugli aspetti speculativi
dell’ambiente. Scrive Antonio Bruno. La speculazione
della Green Economy Industriale, la stessa che sta devastando impunemente il
nostro Paese con pannelli e pale eoliche nelle campagne! La stessa lobby
politico-imprenditoriale trasversale che ha devastato la campagna di Puglia con
mega torri eoliche e che falcidia uccelli e stupra paesaggio, e con deserti
sconfinati di pannelli fotovoltaici. Non un solo albero è stato piantato contro
il “climate change” in Salento, contro la desertificazione, ma i suoli sono
stati strappati all’agricoltura e alla vita, e desertificati artificialmente al
fotovoltaico. E’ quello della Green Economy Industriale un mercato drogato da
iperincentivazione pubblica e di rapina! A partire dalla costituzione della
Banca Mondiale a Washington (accordi di Bretton Wood), uno dei primi obiettivi
fissati fu quello di riportare ricchezza nel Salento a beneficio dei salentini,
attraverso proprio l’ampio progetto di riforestazione del Salento, mediante la
piantumazione massiccia di piante autoctone, ma non fu mai portato a termine! Il
paradosso è che se ogni giorno sul Financial Times o sul The Guardian si parla
di riforestazione inglese per combattere il “climate change”, non si riesce a
capire come sia possibile che Governo, Regione e province ignorino del tutto
questa necessità per il Salento, terra d’Italia con il minor numero di boschi, a
causa di artificiali disboscamenti selvaggi. Mentre un tempo non lontano era tra
le più verdi e pittoresche regioni d’Italia, ed era anche più ricca d’acqua in
superficie, proprio grazie alla presenza del fitto manto boschivo! Una foga
economica degenerante, sviluppatasi purtroppo a partire dal Protocollo di Kyoto,
trasformato ingiustamente in cavallo di Troia della frode. Ora, con la scusa dei
fuochi accesi stupidamente nei campi dai contadini per smaltire le ramaglie, si
son giustificati inceneritori di biomasse-ramaglie, ed in realtà anche rifiuti,
a fini termoelettrici, di potenze fino ad 1MW, realizzabili attraverso la
incostituzionale L.R. 31/2008 della Puglia, con una semplice DIA Dichiarazione
di Inizio Attività presentata al comune interessato! Un intero nocivo e
pericoloso opificio industriale realizzato con una DIA! Tutto questo quando
invece bastava un’ordinanza dei sindaci per vietare quei fuochi inutili fumosi
ed indiscriminati nei campi, ed invitare i contadini a triturare le ramaglie e
altri scarti in loco, al fine di farne compost. Non a caso nel mercato vi sono
biotrituratori che triturano e spargono sminuzzati scarti vegetali e organici in
generale sui suoli, che in piccolissime pezzature vanno incontro a rapidissimi
processi di compostaggio naturale al suolo. Serviva alimentare queste centrali a
biomasse solide con scarti locali, secondo la filiera corta, quale allora
migliore trovata delle ramaglie e degli scarti di potatura dei prossimi uliveti
e vigneti per giustificarne l’autorizzazione, spiegando che si sarebbe eliminato
il problema dei fuochi nei campi! Problema risolto portando tutta la biomassa in
uno stesso luogo, magari alle porte di una città, e accendendo lì nelle fornaci
di quell’industria elettrica un fuoco perenne, 24 ore su 24! Questa l’hanno
chiamata soluzione ecocompatibile! Ma allora non era meglio lasciar accendere
quei fuochi sparsi nei campi, con un effetto di diluizione dei fumi anziché
concentrarli tutti a danno di una comunità? E poi c'è il business del Pellet.
Perché questo combustibile - definito eco - è ormai un business da diversi zero,
vista l'enorme richiesta di questo combustibile. Mentre le analisi sui Pellet
provenienti dalla Lituania della NaturKraft continuano ad essere eseguite nei
laboratori dei reperti speciali dei Vigili del Fuoco di Roma, alcuni organi di
stampa hanno riportato la notizia di altre anomalie riscontrate in Pellet
prodotti da una decina di aziende italiane. Ricordiamo che i pellet devono
essere prodotti con lo scarto della lavorazione di legno vergine. Ossia, è
vietato il riutilizzo di legno già impiegato per altri scopi o altri prodotti.
Quindi, per dirla in altre parole, deve trattarsi di materiale di scarto
proveniente dalle industrie che producono e trasformano il legno vergine. Nel
caso riportato da organi di stampa nazionale, sembrerebbe che questo non stia
succedendo. Anzi, nei pellet si troverebbero tracce di legno utilizzate da
mobilio vario, tra cui anche bare funerarie. Non solo. Il Nucleo operativo
ecologico (Noe) di Treviso ha denunciato 14 persone di 10 aziende delle province
di Treviso e Vicenza per la produzione di pellet da residui di lavorazione del
legno di provenienza illegale. Gli investigatori hanno precisato che l’indagine
non ha attinenze con i controlli sull’esistenza di presunto materiale
radioattivo nei pellet in atto da alcuni giorni. La Procura di Treviso ha posto
sotto sequestro un’azienda di San Michele di Piave (ritenuta la maggiore
produttrice di pellet in Italia) assieme a oltre 20 mila tonnellate di legno
trattato che sarebbe stato trasformato in combustibile per stufe e bruciatori.
Insomma, in questi pellet si troverebbero residui di lavorazione di mobili,
cornici, bare e altri prodotti trattati con vernici e colle. Perché questo?
Perché gli scarti di legno trattato costano all’incirca la metà del legno
vergine. Contaminato.
Ecco dimostrato. Responsabile di tutto è lo Stato
e un certo ambientalismo speculativo.
Terremoto xylella. La Procura blocca le
eradicazioni: dieci indagati (anche Silletti), ulivi sequestrati,
scrive “Il Quotidiano di Puglia” del 18 dicembre 2015. Terremoto sul piano di
contenimento della diffusione della xylella fastidiosa. La Procura di Lecce esce
allo scoperto con un decreto di sequestro preventivo che blocca le eradicazioni
degli ulivi. E mette sott’inchiesta i protagonisti della lotta contro
l’essiccamento rapido. Primo fra tutti il colonnello della Forestale, Giuseppe
Silletti, 62 anni, commissario per l'emergenza xylella e responsabile dei due
piani di intervento che portano il suo nome. I nomi. Le 58 pagine di
decreto di sequestro preventivo a firma del procuratore capo Cataldo Motta,
dell’aggiunto Elsa Valeria Mignone e del sostituto Roberta Licci sono in corso
di notificazione in queste ore e riguardano anche Antonio Guario, 64 anni, nel
ruolo di ex dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale di Bari;
Giuseppe D’Onghia, 59 anni, dirigente del Servizio Agricoltura area politiche
per lo sviluppo rurale della Regione Puglia”; Silvio Schito, 59 anni, dirigente
dell’Osservatorio fitosanitario regionale di Bari, Giuseppe Blasi, 54 anni, capo
dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello Sviluppo rurale
del Servizio fitosanitario centrale; Nicola Vito Savino, 66 anni, docente
universitario e direttore del centro di ricerca, sperimentazione e formazione in
agricoltura Basile Caramia” di Locorotondo; Franco Nigro, 53 anni, micologo di
Patologia vegetale dell’università di Bari; Donato Boscia, 58 anni, responsabile
della sede operativa del Cnr dell’istituto per la Protezione sostenibile delle
piante; Maria Saponari, 43 anni, ricercatrice del Cnr dell’istituto per la
Protezione sostenibile delle piante; e Franco Valentini, 44 anni, ricercatore
dello Iam di Valenzano. I reati contestati. L’inchiesta dell’aggiunto
Mignone e del sostituto Licci contesta violazioni colpose e dolose delle
disposizioni ambientali, diffusione di una malattia delle piante, falso
ideologico, turbativa violenta del possesso di cose immobili in merito
all’obbligo delle eradicazioni, nonché deturpamento o distruzione di bellezze
naturali. Gli sviluppi. La Procura di Lecce che indaga dopo gli esposti
presentati nella primavera dell’anno scorso dalle associazioni ambientaliste,
ribalta le certezze sull’efficacia del piano Silletti annunciate dall’Unione
europea e dal Ministero delle Politiche agricole: non vi sarebbe prova - secondo
la Procura - che la Xylella fastidiosa sia stata importata dal Costarica. Come
non vi sarebbe prova dell’efficacia delle eradicazioni, anzi l’essiccamento non
ha fatto altro che aumentare. Ci sarebbe invece un concreto pericolo per
l’incolumità della salute pubblica con l’uso massiccio di pesticidi, alcuni dei
quali vietati ed autorizzati in via straordinaria: già nel 2008, quando ancora
non si parlava ufficialmente di Xylella, nel Salento ne furono impiegati 573mila
465 chili su 2 milioni 237mila 792 chili in tutta Italia. L’attenzione è tutta
sui campi di sperimentazione della lebbra dell’ulivo: gli stessi dove si è poi
diffusa la Xylella. Fra questi la zona fra Gallipoli, Alezio e Taviano, Lecce
nel parco Rauccio, il Nord Salento fra Sud e Trepuzzi ed il Sud di Brindisi. Le
istituzioni sono state accusate di aver avuto un approccio scientifico univoco
che non ha fermato il disseccamento ed ha invece messo in pericolo la salute
della popolazione. Gli avvisi di garanzia sono legati al provvedimento di
sequestro preventivo, provvedimento che rende necessario informare le persone
coinvolte nelle indagini. L'inchiesta prosegue.
Xylella, sequestrati tutti gli ulivi da
abbattere: 10 indagati. C’è anche commissario straordinario Silletti.
Il provvedimento della Procura di Lecce riguarda gli esemplari destinati
all’abbattimento secondo il piano di contenimento del batterio. Iscritti nel
registro degli indagati anche i ricercatori di Cnr e Iam. I reati contestati
vanno dalla diffusione colposa di una malattia delle piante alla distruzione o
deturpamento di bellezze naturali, scrive Tiziana Colluto il 18 dicembre 2015 su
"Il Fatto Quotidiano". Svolta nell’inchiesta della Procura di Lecce sulla
diffusione del batterio Xylella fastidiosa. Sono dieci i nomi che sono stati
iscritti sul registro degli indagati. Tra loro, oltre a funzionari della Regione
Puglia, ricercatori del Cnr e dello Iam e componenti del Servizio Fitosanitario
centrale, c’è anche Giuseppe Silletti, comandante regionale del Corpo Forestale,
nelle vesti di commissario straordinario per l’emergenza
fitosanitaria. Rispondono dei reati di diffusione colposa di una malattia delle
piante, inquinamento ambientale colposo, falsità materiale e ideologica commessa
dal pubblico ufficiale in atti pubblici, getto pericoloso di cose, distruzione o
deturpamento di bellezze naturali. I nomi sono riportati nel decreto con cui
le pm Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci dispongono il sequestro preventivo
d’urgenza di tutte le piante di ulivo interessate dalle operazioni di rimozione
immediata come previsto dal Piano Silletti e individuate nell’ordinanza del
commissario del 10 dicembre scorso. Sotto chiave sono finiti anche tutti gli
ulivi interessati dalla richiesta di rimozione volontaria “sulla base del
verbale dell’Ispettore fitosanitario, in cui si rileva la presenza di sintomi
ascrivibili a Xylella fastidiosa”, in esecuzione alle previsioni della nota di
Silletti del 3 novembre scorso. Inoltre, sono sequestrate tutte le piante di
olivo già destinatarie dei provvedimenti di ingiunzione e prescrizione di
estirpazione di piante infette emessi dall’Osservatorio fitosanitario regionale.
Su quei terreni, ad ogni modo, si consente qualunque intervento colturale che
non sia il taglio degli alberi al colletto del tronco o la loro eradicazione. Il
decreto è stato notificato a Silletti nel pomeriggio del 18 dicembre dagli
agenti del Nucleo ispettivo del Corpo Forestale dello Stato. Gli altri indagati
sono l’ex e l’attuale dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale,
Antonio Guario e Silvio Schito; Giuseppe D’Onghia, dirigente del Servizio
Agricoltura Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia; Giuseppe
Blasi, capo dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale del Servizio fitosanitario centrale; Vito Nicola Savino, docente
dell’Università di Bari e direttore del Centro di ricerca Basile Caramia di
Locorotondo; Franco Nigro, docente di Patologia vegetale presso Università di
Bari; Donato Boscia, responsabile della sede operativa dell’Istituto per la
protezione sostenibile delle Piante del Cnr; Maria Saponari, ricercatrice presso
lo stesso istituto del Cnr; Franco Valentini, ricercatore presso lo Iam di
Valenzano. Nelle 58 pagine di decreto, viene ripercorsa l’intera vicenda, a
partire dalla prima segnalazione dei sintomi di disseccamento degli ulivi, già
dal 2004-2006 e poi nel 2008. All’inizio, però, si attribuirono le cause solo
alla lebbra dell’olivo, per la quale, tra il 2010 e il 2012, sono stati anche
avviati campi sperimentali “per testare prodotti non autorizzati” per combattere
la malattia e per il diserbo degli oliveti con fitofarmaci Monsanto. Nelle varie
tappe anche i primi convegni italiani su Xylella, come quello nell’ottobre 2010
presso lo Iam di Bari. Infine, le analisi, fatte svolgere dalla Procura su ulivi
di San Marzano (Ta) e Giovinazzo (Ba), con gli stessi sintomi delle piante
salentine. Hanno dato esito negativo. E per gli inquirenti questa è la prova per
cui “la sintomatologia del grave disseccamento degli alberi di ulivo non è
necessariamente associata alla presenza del batterio, così come d’altronde non
è, ancora allo stato, dimostrato che sia il batterio, e solo il batterio, la
causa del disseccamento”.
Xylella, procura di Lecce: “Ue tratta in
errore. Batterio presente in Salento da 20 anni. Indagheremo su fondi
emergenza”. “Non voglio dire che l’Unione Europea sia
stata ingannata, ma ha ricevuto una falsa interpretazione dei fatti - ha detto
il procuratore capo Cataldo Motta in conferenza stampa - l'inchiesta non è
conclusa", continua Tiziana Colluto il 19 dicembre 2015 su "Il Fatto
Quotidiano". “L’Unione Europea è stata tratta in errore da quanto rappresentato
dalle istituzioni regionali con dati impropri sulla vicenda Xylella”: è la
stoccata lanciata dal procuratore capo di Lecce, Cataldo Motta, all’indomani del
sequestro di tutti gli ulivi salentini destinati all’estirpazione e dell’avviso
di garanzia a dieci indagati, tra cui il commissario straordinario Giuseppe
Silletti. “Non voglio dire che l’Ue sia stata ingannata, ma ha ricevuto una
falsa interpretazione dei fatti – ha ribadito Motta durante la conferenza stampa
convocata in mattinata in Procura, a Lecce –. Uno dei dati non esatti è legato
proprio alla diffusione recente del batterio sul territorio, ciò che è stato
dato per scontato e ha motivato i provvedimenti di applicazione dei protocolli
da quarantena”. Viene capovolta, così, l’intera prospettiva: secondo la
ricostruzione fatta dalle pm Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci, Xylella è
presente nel Salento “da almeno 15 o 20 anni”. Cosa significa? Che “la
quarantena per un batterio che sta sul territorio da tanto tempo dovrebbe essere
assolutamente inutile” e, quindi, non sarebbe giustificata la proclamazione
dello stato di emergenza fatta dal governo. “Ben altre sarebbero state le misure
da attendersi anche a livello europeo a tutela dello Stato italiano e della
Regione Puglia”, scrivono gli inquirenti. Sono bollate, infatti, come “inidonee”
le drastiche misure di contenimento del parassita, quali l’uso massiccio di
pesticidi e il taglio di migliaia di ulivi, tra l’altro senza la necessaria e
preventiva valutazione di impatto ambientale. “I tentativi fatti in tutto il
mondo – hanno spiegato i magistrati –hanno dimostrato l’inutilità
dell’estirpazione. I rimedi vanno studiati e attuati con gradualità”. È quello
che si ritiene sia mancato. E di fronte all’assunto, più volte ribadito
dall’Osservatorio fitosanitario regionale, per cui basta la semplice rilevazione
dell’esistenza di Xylella per applicare il regime di quarantena, la Procura ha
ribattuto: “Quelle misure hanno un senso se l’introduzione è recente. È poi
anche una questione di gradualità dei mezzi di contenimento. Se avete
l’influenza non vi fate abbattere. A maggior ragione in un territorio che fonda
non solo l’economia ma anche la propria immagine sugli oliveti, questo
contemperamento di interessi doveva essere tenuto presente”. I test di
fitofarmaci non autorizzati per combattere la lebbra dell’olivo e per diserbare
i terreni sono i principali indiziati del disseccamento che ha colpito le
piante. Tra il 2010 e il 2012, sono stati avviati dei campi sperimentali
appositi nelle campagne intorno a Gallipoli, cuore del primo focolaio
dell’infezione. In particolare, in quel periodo è stato concesso per due volte
l’utilizzo in deroga, nel secondo caso prolungato, di un fitofarmaco di nome
Insigna della Basf, distribuito in grossi quantitativi dai consorzi agrari ai
coltivatori. “E’ possibile – scrivono i pm – che questo secondo impiego del
prodotto per un periodo così lungo e senza limitazioni di trattamenti abbia
scatenato l’esplosione della sintomatologia che ha poi portato alla ricerca di
altri patogeni. Altamente probabile è dunque l’ipotesi che prodotti impiegati,
unitamente ad altri fattori antropici e ambientali, abbiano causato un drastico
abbassamento delle difese immunitarie degli alberi di olivo, favorendo la
virulenza dell’azione dei funghi e batteri, tra i quali Xylella fastidiosa”. A
questi si sono aggiunti i test del Roundup Platinum di Monsanto. “Quel che è
dato acquisito – è riportato nel decreto – è che le due società interessate alle
sperimentazioni in campo nel Salento sono collegate tra loro da investimenti
comuni, avendo la Monsanto acquisito sin dal 2008 la società Allelyx (specchio
di xylella…) dalla società brasiliana Canavialis ed avendo la Basf a sua volta
investito 13,5 milioni di dollari in Allelyx nel marzo 2012”. Il workshop tenuto
presso l’Istituto agronomico mediterraneo di Bari, nell’ottobre 2010, è una
delle strade indicate dalla Procura per l’introduzione in Italia del batterio da
quarantena “in violazione della normativa di settore”. Oltre al muro di gomma
che i magistrati avrebbero, almeno all’inizio, riscontrato a causa del
particolare regime di immunità giurisdizionale di cui gode lo Iam, gli occhi
sono puntati sull’importazione di campioni di Xylella a fini di studio, in parte
su vetrini e in parte tramite piantine già inoculate. I materiali, provenienti
da Belgio e Olanda, avrebbero dovuto viaggiare scortati da specifici passaporti,
di cui in parte, secondo gli inquirenti, si è persa traccia, tanto da parlare di
“gravi irregolarità nella documentazione di accompagnamento”. “L’inchiesta non è
conclusa”, ha specificato Motta. Sono almeno tre i filoni su cui si continuerà
ad indagare. Il primo attiene alla destinazione dei finanziamenti piovuti sulla
Pugliadopo la proclamazione dello stato di emergenza da parte del governo. Il
secondo, invece, riguarda gli “inquietanti aspetti relativi al progettato
stravolgimento della tradizione agroalimentare e della identità territoriale del
Salento per effetto del ricorso a sistemi di coltivazione superintensiva e
introduzione di nuove cultivar di olivo”. Il riferimento è all’accordo tra
l’Università di Bari, “che ha gestito in maniera monopolistica lo studio” del
batterio, e la spagnola Agromillora Research srl. L’intesa, approvata dal senato
accademico nell’ottobre 2013, riguarda la valutazione e commercializzazione di
nuove selezioni di olivo, nate dall’ibridazione di due
cultivar, Leccino (considerata resistente a Xylella) e Ambrosiana. L’ateneo
barese incasserà il 70 per cento delle royalties sul fatturato annuo derivante
dallo sfruttamento del brevetto. Il terzo filone d’indagine riguarda la ricerca.
“Da notizie in corso di verifica giunte alla polizia giudiziaria operante – è
riportato nel decreto di sequestro – sembrerebbe che il Comitato (di natura
tecnico-scientifica, istituito dal Ministero delle Politiche agricole e composto
da 16 esperti, ndr) compia mera attività di facciata con poca possibilità di
entrare nel merito dei fatti per i quali è stato istituito, in quanto i membri
appartenenti al gruppo di ricerca di Bari non forniscono chiari risultati di
ricerca da poter essere valutati in seno alle riunioni del Comitato”. È certo
che su questo ci saranno nuovi ascolti. Ed è certo anche che ciò apre la porta
all’individuazione di eventuali nuove responsabilità sull’omesso controllo in
capo al Ministero delle Politiche agricole.
Ulivi malati, ricercatori sotto accusa.
Motta: «Ingannata l’Unione europea». Il procuratore di
Lecce parla dopo il sequestro delle piante malate. Dieci indagati, scrive
Antonio
Della Rocca il 19 dicembre 2015 su “Il Corriere della Sera”.
«L’Unione Europea è stata tratta in errore da quanto è stato rappresentato con
dati impropri e non del tutto esatti», ha spiegato il capo della Procura di
Lecce, Cataldo Motta, illustrando
i punti salienti dell’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Xylella fastidiosa,
il patogeno considerato concausa del disseccamento rapido degli ulivi salentini.
La Procura ha disposto il sequestro degli ulivi malati e tra gli indagati, oltre
a studiosi, ricercatori e funzionari della Regione, vi è anche Giuseppe
Silletti, il commissario governativo per l’emergenza Xylella. «Ci siamo trovati
di fronte a direttive europee, in parte molto rigorose, come l’eradicazione
degli ulivi, che sono state emesse dall’Unione europea sulla falsa
rappresentazione della situazione», ha specificato Motta. La Procura, che nel
corso delle indagini, peraltro ancora in corso, si è avvalsa della
collaborazione di un pool di periti, ha anche emanato un decreto di sequestro di
tutti gli ulivi che, in base alla più recente ordinanza commissariale,
dovrebbero essere abbattuti nell’ambito delle misure di contrasto alla
batteriosi scoperta nel 2013 nelle campagne di Gallipoli. Secondo la Procura,
inoltre, non ci sarebbe stato finora il necessario «confronto allargato» tra
organismi scientifici per poter stilare adeguate strategie di contenimento della
diffusione del batterio. Piuttosto, lo studio si sarebbe concentrato in un
regime quasi monopolistico nelle mani di pochi ricercatori. Inoltre, ha
sottolineato Motta, «non è stato accertato il nesso di causalità tra il batterio
Xylella fastidiosa e la malattia», e malgrado si possa ipotizzare che il
fenomeno del disseccamento sia presente nel Salento da almeno 15 anni, si è
deciso, in modo inappropriato, di procedere con l’abbattimento delle piante. Un
metodo che, a giudizio della Procura, non rappresenta la soluzione più idonea
per combattere un fenomeno ormai diffuso e radicato da molti anni.
Xylella, il procuratore di Lecce accusa:
"Europa ingannata, lucrano sull'emergenza". Per il
capo dei pm Cataldo Motta alla base del caos ci sarebbe una conoscenza
incompleta del problema: "Il commissario ha privilegiato solo ipotesi che
portavano all'eradicazione", scrive
chiara Spagnolo il
19 dicembre 2015 su “La Repubblica”)"L'Unione
europea è stata tratta in inganno con una falsa rappresentazione dell'emergenza
xylella fastidiosa, basata su dati impropri e sull'inesistenza di un reale nesso
di causalità tra il batterio e il disseccamento degli ulivi". Per questo
l'inchiesta della Procura di Lecce "indagherà anche sui finanziamenti stanziati
e usati per l'emergenza, considerato che di emergenza non si tratta". Il giorno
dopo il sequestro di tutti gli ulivi salentini per cui è stata disposta
l'eradicazione e l'invio di avvisi di garanzia al commissario di governo e a
nove fra dirigenti e ricercatori che si sono occupati del caso, è il capo della
Procura leccese, Cataldo Motta, a spiegare il motivo di un provvedimento che ha
posto fine ai tagli di alberi e forse anche all'esperienza del commissario
Giuseppe Silletti. Alcuni ambientalisti, entrati nella stanza del procuratore
poco prima della conferenza stampa, hanno applaudito e mostrato un cartello di
ringraziamento ai pm che hanno condotto l'inchiesta. Sul cartello la scritta:
"C'è un giudice a Lecce, anzi due. Grazie". A quest'ultimo viene contestato di
avere disposto Piani inappropriati e addirittura dannosi per l'ambiente
salentino, a causa del massiccio uso di fitofarmaci. E di eradicazioni a
tappeto, che non sembrano affatto risolutive. Il nodo sta tutto nel fatto che la
xylella è presente in Puglia "da almeno venti anni" e che allo stato esistono
ben nove ceppi diversi, che ne mostrano la mutazione genetica. "Ciò escluderebbe
la necessità di interventi emergenziali - ha chiarito Motta - e la stessa
legittimazione della quarantena, che è stata la base da cui l'Europa è partita
per imporre misure drastiche". Secondo quanto hanno accertato gli uomini del
Corpo forestale (di cui fra l'altro il commissario Silletti è comandante
regionale), alla base del caos xylella ci sarebbe innanzitutto una conoscenza
incompleta del problema, "determinata dalla scarsità di confronto scientifico e
dall'aver privilegiato solo alcune ipotesi, che portavano inevitabilmente alle
eradicazioni". Per questo il sostituto procuratore Elsa Valeria Mignone - che ha
coordinato l'indagine assieme alla collega Roberta Licci - si è augurata che
"inizi proprio da ora un confronto scientifico vero sulla materia", al fine di
individuare la strada giusta per combattere il disseccamento rapido degli ulivi.
Sul fatto che i tagli non siano la scelta migliore, i magistrati non hanno
dubbi: "l'eradicazione del batterio non si fa con l'estirpazione delle piante -
ha chiarito il procuratore capo - E anche l'Unione europea non ha mai imposto di
abbattere immediatamente tutti gli alberi malati ma di contenere la malattia,
provando prima altre soluzioni". Tentativi che, a quanto pare, non sono stati
fatti. E sui quali, a questo punto, bisogna ragionare perché l'Ue chiede
comunque risposte che fino a pochi giorni fa si pensava dovessero pagare dalle
eradicazioni. Intanto gli indagati penseranno a difendersi. I reati contestati
sono diffusione colposa della malattia delle piante, falso ideologico e
materiale in atto pubblico, inquinamento ambientale e deturpamento delle
bellezze naturali.
Procuratore di Lecce: «Falsi i dati sulla xylella
inviati all'Europa», scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 19 dicembre 2015.
«L'Europa ha ricevuto una falsa interpretazione dei fatti sulla Xylella, così
come realmente accaduto nel Salento. E’ stata tratta in errore da quanto
rappresentato dalle istituzioni regionali con dati impropri». Lo ha detto il
procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta nel corso di una conferenza
stampa che si è tenuta stamattina per illustrare i presupposti dell’inchiesta
che ha portato al sequestro di tutti gli ulivi delle province di Brindisi e
Lecce interessati da provvedimenti di abbattimento decisi nel corso dell’ultimo
piano redatto dal commissario straordinario Giuseppe Silletti. «L'indagine non è
compiuta» ha specificato poi il procuratore Motta in riferimento all’inchiesta
sulla gestione dell’emergenza Xylella fastidiosa che ha portato ieri
all’emissione di un decreto di sequestro d’urgenza a firma dei magistrati Elsa
Valeria Mignone e Roberta Licci che indagano su dieci persone tra cui anche il
commissario straordinario per l'emergenza Xylella, Giuseppe Silletti.
Accertamenti sarebbero in corso - a quanto si è appreso - anche sulla modalità
di concessione e utilizzo dei finanziamenti pubblici. L’inchiesta parte dal
presupposto, ha spiegato Motta: «che non è stato accertato il nesso di causalità
tra il complesso del disseccamento rapido degli ulivi e la Xylella Fastidiosa».
«Abbiamo trovato alberi non colpiti da disseccamento che sono però risultati
positivi alla Xylella - ha detto Motta - e alberi secchi che non sono invece
risultati contagiati». Hanno applaudito e mostrato un cartello di ringraziamento
ai due pm che hanno condotto l'inchiesta, Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci,
alcuni ambientalisti che hanno fatto ingresso nella stanza del procuratore della
Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, poco prima della conferenza stampa. Sul
cartello mostrato c'è scritto: "C'è un giudice a Lecce, anzi due. Grazie".
Terremoto xylella, il governatore
Emiliano: "Il provvedimento è una liberazione", scrive
“Lecce Sette” sabato 19 dicembre 2015. Il commento del governatore di Puglia,
Michele Emiliano, in relazione alla svolta nelle indagini della Procura di Lecce
sull'affaire Xylella. “La notizia del provvedimento di sequestro da parte della
Procura della Repubblica di Lecce è arrivata come una liberazione. Finalmente
avremo a disposizione dati tecnici ed investigativi per discutere con l’Unione
Europea della strategia finora attuata per contrastare la Xylella, fondata
essenzialmente sull’eradicazione di massa di alberi malati e sani”. Così in una
nota il governatore Michele Emiliano, a poche ore dalla notiza della clamorosa
svolta nelle indagini della Procura di Lecce sull'affaire xylella. “Questa
strategia viene messa totalmente in dubbio dalle indagini effettuate da
magistrati scrupolosi, prestigiosi e notoriamente stimati per la prudenza che li
ha sempre contraddistinti nell’esercizio delle funzioni – commenta - Credo anche
che possiamo considerare chiusa la fase della cosiddetta emergenza. La malattia
è ormai insediata, e non può più essere totalmente debellata. Dobbiamo dunque
riscrivere da zero le direttive da impartire agli agricoltori e a tutti gli
altri soggetti interessati, che potranno consistere in tutti quegli atti e
quelle azioni che non comportino l’eradicazione delle piante”. “In questi mesi
la Regione Puglia ha sempre ribadito alla Procura della repubblica di Lecce la
sua disponibilità a fornire collaborazione alle indagini in corso. E anche oggi
ribadisco questa disponibilità assieme alla piena fiducia negli uffici
giudiziari leccesi. Mi sento di dire che questo intervento è l’equivalente di
quello della magistratura tarantina nel caso Ilva”, si legge nella nota e
conclude: “La Regione Puglia è persona offesa degli eventuali reati commessi si
riserva di indicare elementi di prova che possano contribuire all’accertamento
della verità. In caso di rinvio a giudizio si costituirà parte civile nei
confronti di tutti gli imputati”.
Xylella, M5S: Emiliano chieda scusa agli
agricoltori, scrive “Inchostro Verde” il 19 dicembre 2015. Accolgono con estrema
soddisfazione la decisione della Procura di bloccare le eradicazioni i
Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Le indagini dei magistrati si
incardinano infatti sulle stesse tesi che i pentastellati ribadivano da tempo
sia in Consiglio regionale che nelle piazze pugliesi e che sono state oggetto di
una mozione votata all’unanimità dal Consiglio solo qualche giorno fa. In merito
alle dichiarazioni di Emiliano replicano così: “Oggi, Emiliano, con la sua
Giunta, dovrebbe solo tacere” dichiarano Rosa Barone, Gianluca Bozzetti,
Cristian Casili, Mario Conca, Grazia Di Bari, Marco Galante, Antonella Laricchia
e Antonio Trevisi “proprio lui che aveva promesso di scatenare l’inferno in
campagna elettorale contro la Xylella e che non ha fatto nulla se non limitarsi
ad istituire un tavolo multidisciplinare sul tema identico a quello proposto dal
M5S. Addirittura usando le stesse parole per definirlo e convocando gli stessi
esperti che il M5S aveva dichiarato di voler coinvolgere. Proprio lui Presidente
di una Regione che ha osato arrivare a costituirsi contro quei poveri
agricoltori che hanno dovuto subire passivamente la distruzione dei loro terreni
e che si “erano azzardati” a fare ricorso. Dopo aver deliberato per le
eradicazioni, aver richiesto al Ministero l’accelerazione di queste procedure,
questo dovrebbe essere il giorno della vergogna. Quelle parole che oggi usano
per guadagnare qualche titolo sulla stampa piuttosto le usino per porgere le
loro scuse agli agricoltori e ai cittadini nei comitati, con le loro decisioni
li hanno soltanto umiliati. Oggi Emiliano parla di “soddisfazione perchè
finalmente qualcuno ha portato delle prove” ma mente sapendo di mentire perchè
quelle stesse prove le aveva portate il Movimento 5 Stelle in Regione Puglia da
mesi, aveva convocato addirittura esperti che ripetevano le nostre stesse tesi
ed aveva presentato una mozione votata all’unanimità dall’intero Consiglio
Regionale (su cui Emiliano e la sua Giunta si erano invece vergognosamente
astenuti) ed incardinata sulle stesse identiche tesi che oggi anche i magistrati
portano avanti. Quali altre prove aspettava Emiliano che il Movimento 5 Stelle
non gli avesse portato sotto gli occhi da tempo?”. I 5 Stelle non risparmiano
una stoccata neanche le altre forze politiche: “Non possiamo non ricordare
inoltre che, affinchè fosse votata in Consiglio Regionale, la nostra mozione ha
dovuto subire delle modifiche perchè per i vecchi partiti ‘i nostri termini
erano troppo forti’. Oggi invece tutti si spellano le mani nell’applaudire i
magistrati. Saremmo felici di constatare che non è mai troppo tardi per cambiare
idea se non fosse che la loro incoerenza ha lasciato morire migliaia di alberi e
le speranze degli agricoltori. Se fossimo stati noi ad amministrare questa
regione, tutto ciò non sarebbe mai successo”.
Xylella, la denuncia di "Nature": in
Italia ricercatori sotto accusa come per il sisma a L'Aquila.
La prestigiosa rivista scientifica dedica sul proprio
sito un articolo sull'inchiesta della Procura di Lecce che ha chiamato in causa,
insieme col commissario straordinario Silletti, anche nove ricercatori, scrive
“La Repubblica” il 22 dicembre 2015.
Indice puntato contro i ricercatori ancora una volta in Italia: lo rileva la
rivista scientifica internazionale Nature, che sul suo sito dedica un articolo
alla diffusione della xylella in Puglia e ai nove ricercatori sospettati di
avere avuto un ruolo nella diffusione del batterio che ha gravemente danneggiato
gli uliveti. Nell'inchiesta è coinvolto anche il commissario
straordinario Giuseppe Silletti. Non è la prima volta che in Italia i
ricercatori salgono sul bando degli accusati: è già accaduto nella vicenda
giudiziaria seguita al terremoto dell'Aquila, con
sette ricercatori sul banco degli accusati (sei
dei quali assolti dalla Cassazione nel novembre
scorso). Nella conferenza stampa del 18 dicembre scorso, citata anche da Nature,
i magistrati avevano additato l'attività scientifica effettuata da ricercatori
di Università di Bari, Istituto agronomico mediterraneo (Iam) di bari e Centro
di ricerca e sperimentazione in agricoltura Basile Caramia di Locorotondo
(Bari). Per i magistrati, come ha ampiamente riferito Repubblica nei
giorni scorsi, sono i "protagonisti assoluti e incontrastati nella storia
xylella". Nessuna dichiarazione in merito da parte dei ricercatori. Uno degli
accusati, il responsabile dell'unità di Bari dell'Istituto per la protezione
sostenibile delle piante del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Donato
Boscia, ha detto di essere "certo che emergerà quanto prima la nostra completa
estraneità". Il sospetto, per lui come per gli altri ricercatori, è di aver
diffuso il batterio e presentato false documentazioni alle autorità giudiziarie,
oltre che di inquinamento ambientale e deturpazione del paesaggio naturale.
"Sono accuse folli", ha detto a Nature Boscia, che non ha intenzione di
commentare una vicenda sulla quale è in corso un'indagine. Computer e
documentazione dei ricercatori erano stati confiscati nel maggio scorso e da
allora, osserva la rivista, "non è stata resa nota alcuna evidenza contro i
ricercatori". Eppure, prosegue Nature, permane il sospetto che la xylella
sia stata importata dalla California in occasione di uno workshop organizzato
nel 2010 dall'Istituto agronomico mediterraneo. Più volte in passato, tuttavia,
i ricercatori hanno affermato che in quell'occasione non era stata utilizzata la
xylella. Nature rileva che il ceppo di xylella diffuso in Puglia,
originario di Costa Rica, Brasile e California, è stato identificato per la
prima volta in Europa, nell'Italia meridionale, nel 2013. Per la maggior parte
dei ricercatori, conclude la rivista, è molto probabile che il batterio sia
arrivato in Italia con piante ornamentali importate dal Costa Rica.
Xylella, l'ombra del
complotto con le multinazionali. I pm: "Il batterio importato durante un
convegno". I magistrati leccesi
sono convinti che, al contrario di quanto sostenuto da Università e Istituto
agronomico del mediterraneo (Iam), il batterio sia stato importato dallo Iam nel
corso dell'evento nel 2010, scrive Giuliano Foschini su "La Repubblica" del 20
dicembre 2015. Mettiamola così: se ha ragione la Procura di Lecce, si tratta del
più grande complotto mai realizzato da attori istituzionali ai danni di un
territorio e della loro principale ricchezza: la natura. Università, politica,
centri di ricerca, multinazionali, tutti insieme per un piano diabolico e
infame. Se invece i magistrati di Lecce stanno sbagliando, si tratta di un
attacco violentissimo alla scienza. Per capire come stanno le cose sarà quindi
necessario aspettare le prossime settimane, quando altre istituzioni, a partire
dall'Unione europea passando dal governo italiano, dovranno evidentemente dire
qualcosa. Prendere una posizione. Perché mai come in questo momento è opportuno
sapere. La prima domanda da farsi è: il batterio della xylella causa
l'essiccamento degli ulivi? Su questo la comunità scientifica aveva pochi dubbi:
sì. E invece la Procura, sulla base di altre perizie, nel decreto di
sequestro spiega esattamente il contrario. "E' stata fornita una falsa
rappresentazione della realtà con riguardo all'asserito, ma assolutamente
incerto, ruolo specifico svolto dalla xylella fastidiosa nella sindrome del
disseccamento degli alberi di ulivo - si legge negli atti - e con riguardo
all'asserita, ma assolutamente incerta, presenza nel Salento di una popolazione
omogenea del batterio e della sua recente introduzione dal Costa Rica. I
magistrati sono convinti che, al contrario di quanto sostenuto da Università e
Istituto agronomico del mediterraneo (Iam), il batterio sia stato importato
dallo Iam nel corso di un famoso convegno del 2010. Che dai documenti che
attestavano l'ingresso in Italia della xylella "emergessero gravi irregolarità".
E che la documentazione originale non è mai stata ritrovata anche perché i
ricercatori dello Iam avrebbero finto di cercarle nel corso della perquisizione.
Ma non basta: la Procura, senza per il momento fare contestazioni formali, nota
due cose: la prima è che ci sono interessi nella diffusione del batterio. Chi,
per esempio, ha puntato su nuovi tipo di coltivazioni dell'olivo come la Sinagri
srl, spin off dell'Università di Bari, che lavora con Iam e Basile Caramia, gli
enti incaricati dei controlli sulla xylella. E che ha tra i suoi 'amici' i
professori Vito Savino, all'epoca preside della facoltà di Agraria; Angelo
Godini, "fautore dell'eliminazione del deviato degli alberi di ulivo e in
particolare di quelli monumentali ", e Giovanni Paolo Martelli, "lo stesso che
poi suggerirà, in base a una mera "intuizione" di fine agosto 2013, di indagare
la presenza della xylella quale causa dei fenomeni di disseccamento dell'ulivo".
"Savino, Godini e Martelli - scrive ancora la Procura - condividono peraltro un
medesimo approccio culturale nell'Accademia dei Georgofili, di cui fa parte
anche il professor Paolo De Castro, già ministro dell'Agricoltura e attualmente
eurodeputato, che ha riferito in commissione proprio sulla questione xylella".
Negli atti è poi raccontato uno strano episodio: nel 2010-2011 in Salento si
tengono "campi sperimentali di nuovi prodotti contro la 'lebbra dell'olivo',
epoca prima della quale - nota la Procura - non era esploso il fenomeno del
disseccamento rapido". Per questo motivo li ministero autorizza l'uso di alcuni
diserbanti particolari, per un periodo limitato di qualche mese, in zone
specifiche del Salento. La Forestale ha contattato alcuni dei proprietari dei
terreni e altri testimoni: raccontavano di aver visto in quel periodo persone
che "in abiti civili, con tute bianche modello 'usa e getta' in dotazione alla
polizia scientifica, si aggiravano fra gli olivi con in mano dei barattoli di
colore blu e bianco. Effettuavano anche alcune manovre, alla base degli alberi".
Gli alberi avevano dei cartelli. Bene: durante il sopralluogo della polizia
giudiziaria, si è notato che "la maggior parte degli alberi di olivo, sui quali
erano stati appesi i cartelli, erano quasi completamente bruciati: alcuni mesi
addietro si era sviluppato un incendio". Strano, perché aveva colpito alcuni
alberi e alcuni no. "Sembrerebbe che abbiano colpito - dice la procura soltanto
quelli legati alla sperimentazioni della "Lebbra dell'olivo" ovvero la prove in
campo del Roundpop Platinum della Monsanto. L'incendio dovrebbe essere dunque di
natura dolosa con finalità di eliminare ogni possibile traccia di quanto fatto
sugli alberi ". Che cos'è la Monsanto? E' un leader nella realizzazione dei
pesticidi. Ed è la stessa ditta che finanza un convegno sulla xylella nel 2010,
nel quale "presenta un progetto di nome Gipp per la buona pratica di diserbo
nell'oliveto di Puglia". La pratica prevede una serie di interventi compreso
l'uso di un diserbante totale che serve per mantenere "pulito da erbacce
l'oliveto". Bene, si tratta proprio del Roundpop, lo stesso che avrebbe potuto
bruciare quegli ulivi. E' la stessa società che nel 2007 ha acquisito la società
"Allelyx - scrive la Procura - Parola specchio di xylella...".
Xylella, Bruxelles a pm
di Lecce: “Dati non sbagliati, avanti con taglio degli ulivi”. Ma i test furono
condotti in serre bucate.
Enrico Brivio, portavoce dell'Esecutivo comunitario per l'Ambiente, la Salute e
la Sicurezza alimentare, risponde a Cataldo Motta, capo della procura salentina,
che sabato scorso aveva parlato di una "falsa interpretazione dei fatti". La
rimozione degli alberi, quindi, deve continuare. Ma dalle carte dell’inchiesta
emerge uno dei dettagli più pesanti: le prove di patogenicità sono state
condotte all’interno di vivai non a norma, scrive Tiziana Colluto il 22 dicembre
2015 su "Il Fatto Quotidiano". L’Ue tira dritto
sull’emergenza Xylella, nonostante l’alt della Procura di Lecce: la Commissione
europea “non ha al momento alcuna indicazione del fatto che l’Italia le avrebbe
comunicato dati sbagliati”, ha detto il portavoce dell’Esecutivo comunitario per
l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza alimentare, Enrico Brivio. Dunque, avanti
con le procedure di eradicazione del batterio, comprese quelle
di abbattimento degli ulivi. “Se gli alberi sono sotto sequestro, non si possono
toccare”, si mette di traverso il presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano, che ha chiesto ai pm di essere ascoltato come persona offesa e di
acquisire il decreto di sequestro e le consulenze allegate per inviarle a
Bruxelles. In quelle carte, tra le varie prove raccolte, c’è qualcosa di
clamoroso: i test di patogenicità, vale a dire la prova del nove del rapporto di
causa-effetto tra Xylella e disseccamento delle piante, sono stati condotti
in serre bucate, non a norma, e sono stati avviati cinque mesi prima
dell’autorizzazione rilasciata dall’Osservatorio fitosanitario nazionale. L’Ue:
“Le misure vanno attuate” – Quella di Brivio è la risposta implicita alle parole
del procuratore capo: “Non voglio dire che l’Ue sia stata ingannata, ma ha
ricevuto una falsa interpretazione dei fatti. E’ stata tratta in errore da
quanto è stato rappresentato con dati impropri e non del tutto esatti”, aveva
detto Cataldo Motta, nella conferenza stampa di sabato mattina. “La Commissione
europea non commenta le inchieste giudiziarie in corso”, ha replicato il
portavoce dell’Esecutivo comunitario, ricordando che due settimane fa l’Ue
ha messo in mora l’Italia per non aver pienamente realizzato il piano contro la
Xylella. “E’ molto importante che queste misure siano attuate”, ha ribadito,
poiché, laddove si è diffusa, “la Xylella è uno dei patogeni delle piante più
pericolosi, con un enorme impatto economico sull’agricoltura”. Come ammesso
dallo stesso Brivio, “resta da capire pienamente il ruolo specifico svolto dalla
Xylella e le sue implicazioni” nella diffusione della sindrome del disseccamento
rapido degli ulivi in Salento; tuttavia, il batterio “è stato trovato in piante
giovani che mostravano i segni della sindrome e che non avevano altri patogeni”.
Dunque, nessun passo indietro su quanto dettato da Bruxelles nella decisione di
esecuzione di maggio e recepito dal Ministero delle Politiche agricole e dal
commissario straordinario Giuseppe Silletti, anche lui tra i dieci indagati. I
provvedimenti prevedono la rimozione degli alberi infetti e delle piante
potenziali ospiti in un raggio di cento metri, nei focolai fuori dalla provincia
di Lecce, soprattutto nel Brindisino. Tagli congelati, per il momento, prima dal
Tar Lazio e ora dalla Procura. Sulla stessa sponda dell’Ue ci sono la Società
Italiana di Patologia Vegetale e la Società Entomologica Italiana, che si dicono
“sconcertate” dal decreto di sequestro degli ulivi. Per il tramite dei loro
rispettivi presidenti, Giovanni Vannacci e Francesco Pennacchio, entrambe
affermano di non essere a “conoscenza di nuove evidenze sperimentali, validate
dalla comunità scientifica, tali da modificare le linee guida già espresse nel
documento rilasciato al termine del convegno nazionale”, organizzato
sull’argomento il 3 luglio scorso a Roma. “Le motivazioni degli interventi di
contenimento – aggiungono – originano dal solo riscontro della presenza di un
organismo da quarantena qual è Xylella fastidiosa, e non dal nesso di causalità
tra questo e la sindrome di disseccamento rapido dell’olivo. Le solide basi di
conoscenza fornite dalla ricerca internazionale, recepite dall’Ue e dalle
organizzazioni fitoiatriche nazionali e internazionali, consentono di concludere
che la diffusione di X. fastidiosa sul territorio nazionale ed europeo aprirebbe
prospettive drammatiche per l’agricoltura. La misura del suo potenziale impatto
economico può essere stimata dal confronto con episodi precedenti, quale la
diffusione in Brasile di questo patogeno, ritenuto responsabile di danni per
circa 100 milioni di euro l’anno”. Eppure, per gli inquirenti a traballare è
l’impianto stesso su cui si fondano i piani di contenimento del batterio.
La consulenza allegata al decreto “ha posto in serio dubbio – hanno scritto i pm
– l’attendibilità delle conclusioni scientifiche rappresentate all’Europa e che
hanno costituito il presupposto delle determinazioni assunte sia a livello
europeo che a livello nazionale”. Il riferimento è soprattutto alla presenza di
più ceppi, e non di uno solo, di Xylella sul territorio: almeno nove, segno di
una presenza del patogeno sul territorio “da 15-20 anni”, così tanti da non
poter giustificare, secondo la Procura, lo stato di emergenza. I protocolli da
quarantena, a suo avviso, sono stati tradotti in un “piano di interventi
univocamente diretto alla drastica e sistematica distruzione del paesaggio
salentino, benché costituisca ormai dato inconfutabile che l’estirpazione delle
piante non è assolutamente idonea né a contenere la diffusione dell’organismo
nocivo né a impedire la diffusione del disseccamento degli ulivi né tantomeno a
contribuire in alcun modo al potenziamento delle difese immunitarie delle piante
interessate”. Cuore delle indagini resta l’assenza di un dimostrato nesso
di causalità tra Xylella e disseccamento degli ulivi. Ad appurarlo dovranno
essere i test di patogenicità svolti dal Cnr di Bari. Ma quali? È su questo che,
dalle carte dell’inchiesta, emerge uno dei dettagli più pesanti: quelle prove
sono state condotte all’interno di serre non a norma. Il5 novembre scorso,
infatti, la polizia giudiziaria e uno dei consulenti tecnici della Procura hanno
fatto un sopralluogo nel vivaio dell’Arif (Agenzia regionale per le risorse
irrigue e forestali), in contrada Li Foggi, a Gallipoli, culla dell’infezione. È
quello uno dei luoghi in cui sono state messe a dimora numerose piantine di
varie specie, nelle quali Xylella è stata veicolata mediante infezione naturale
da parte del vettore e inoculo artificiale del batterio. I risultati sono
destinati, molto probabilmente, ad essere invalidati: “La rete della serra
presentava una grossa fessura che ne permette il contatto diretto con l’esterno
e che pertanto non è garantito l’isolamento totale delle piante in essa allocate
per la sperimentazione”. Non una sottigliezza, dunque. Tra l’altro, quelle prove
sono iniziate a partire dal 4 luglio 2014, mentre il Cnr è entrato in possesso
della necessaria autorizzazione alla detenzione e manipolazione del patogeno da
parte del Servizio fitosanitario nazionale solo il 16 dicembre 2014.
«Xylella, attacco al
paesaggio», scrive Pino
Ciociola il 23 dicembre 2015 su “Avvenire”. Territorio sotto attacco. Affaire
Xylella: dai «protagonisti istituzionali e non», c’è stata «perseveranza
colposa, tale da sfiorare la previsione dell’evento se non il dolo eventuale,
nell’adozione di un piano d’interventi univocamente diretto alla drastica e
sistematica distruzione del paesaggio salentino». Si legge a pagina 51
dell’'Ordinanza di sequestro preventivo d’urgenza' degli ulivi, firmata dalle pm
Elsa Valeria Mignone e Roberta Licci e dal capo della Procura leccese, Cataldo
Motta. Altro «dato inconfutabile» (fra molti): «Proprio le misure imposte dai
Piani Silletti, ivi compreso l’uso massiccio dei pesticidi, rappresentano un
serio rischio per l’incolumità pubblica». E ancora, «è stata fornita una falsa
rappresentazione della realtà riguardo all’asserito, ma assolutamente incerto,
ruolo specifico svolto dalla Xylella nella sindrome del disseccamento degli
ulivi». Insomma, la realtà è «molto più articolata e complessa» di quella
riportata «alla Comunità Europea». E col «serio dubbio» sull’«attendibilità » di
quelle conclusioni scientifiche rappresentate all’Europa», ma che sono state «il
presupposto delle determinazioni assunte a livello europeo e nazionale». Il capo
della Procura leccese l’aveva spiegato sabato scorso: «Le indagini non sono
compiute» e ne appaiono chiari i motivi scorrendo l’ordinanza, emessa insieme a
10 avvisi di garanzia. Ricostruzione con prove e testimonianze (queste ultime a
volte false o contraddittorie) di quanto 'accade' dal 2009, cioè quando «appare
già indubbio sia databile il fenomeno del disseccamento degli ulivi in Salento».
Lunga storia dalla quale, per gli inquirenti, «emerge chiaramente la colposa
inerzia degli organi preposti al controllo fitosanitario nazionale e della
Regione Puglia nell’attenzionare l’ingravescente fenomeno del disseccamento
degli ulivi» e «l’assoluta imperizia dei suddetti organi e dei soggetti con essi
interfacciatisi quali unici interlocutori, vale a dire Iam, Università di Bari e
Cnr». Il lavoro della Procura appare certosino, le sue conclusioni anche. È
«ormai dato inconfutabile – scrivono i magistrati – che la estirpazione delle
piante non è assolutamente idonea né a contenere la diffusione del
disseccamento, né a contribuire al potenziamento delle difese immunitarie delle
piante», anzi dov’è stata realizzata, per esempio a Trepuzzi, «ha comportato una
esplosione del fenomeno del disseccamento!». Fra gli altri dati «acquisiti»,
poi, c’è che «almeno dal 2013» si sapeva come «al disseccamento rapido
dell’ulivo contribuissero diverse concause» e che «la manifestazione della
sintomatologia del disseccamento non sia necessariamente correlata alla presenza
della Xylella». Passo indietro. I primi anomali disseccamenti sugli ulivi
vengono notati nel 2008 nelle campagne fra Gallipoli, Racale, Alezio, Taviano e
Parabita. Ed è sempre «dato conclamato» che negli anni 2010/2011 e 2013 «sono
state condotte in territorio salentino sperimentazioni anche con l’uso di
prodotti fortemente invasivi». Torniamo ai giorni nostri. Da marzo scorso alcuni
agricoltori si accorgono che uomini in tu- ta bianca («Modello 'usa e getta' in
dotazione alla polizia scientifica», spiega la Procura) si aggirano fra gli
ulivi con barattoli di vernice blu e bianca, affiggono cartelli con la scritta
«Campo sperimentale». Accade che poi questi ulivi brucino e qualche volta
stranamente o miratamente. Morale? «Si ritiene – scrive la Procura – che
l’incendio di ulivi sui quali sarebbero avvenute le sperimentazioni legate alla
'lebbra dell’ulivo', ovvero le prove in campo del Roundop Platinum della
Monsanto, sia di natura dolosa con finalità d’eliminare ogni possibile traccia
di quanto fatto sugli alberi». Nuovo passo indietro: la multinazionale aveva
promosso a Bari nel 2013 il 'Progetto Gipp', con l’utilizzo del 'Roundup
Platinum' del Roundup 360 power con glifosato e l’'Area manager Centro Sud'
della Monsanto, Lino Falcone, raccontava che «il 'Progetto Gipp' non nasce dal
caso, abbiamo lavorato due anni per studiare la situazione malerbologica
nell’uliveto pugliese e individuare gli aspetti critici». Infatti il Roundup è
un diserbante totale – annota la Procura leccese – e il glisofato «si trasmette
nel terreno, predispone le piante a malattie e tossine» e provoca diverse altre
conseguenze. L’11 settembre 2014 c’è un’altra serata di presentazione del
Progetto Gipp e del Roundup platinum, stavolta nel leccese, in un resort a
Lequile. Detto che «non è pervenuta risposta» alla richiesta d’informazioni
«sulle aree interessate da campi di sperimentazione all’Osservatorio
Fitosanitario regionale», i magistrati vanno avanti: «Le due società interessate
alle sperimentazioni in Salento, Monsanto e Basf, sono collegate da investimenti
comuni, avendo la Monsanto acquisito dal 2008 la società Allelyx (leggete la
parola al contrario... ndr) dalla società brasiliana Canavialis e avendo la Basf
nel marzo 2012 investito 13,5 milioni di dollari nella 'Allelyx'». Contattata,
l’azienda rimanda al suo blog: «Non c’è nessuna ragione plausibile per cui
Monsanto, i cui prodotti servono ad aiutare gli agricoltori, farebbe qualcosa
che può causare problemi agli olivicoltori italiani», si legge ad esempio
sull’Affaire Xylella. La Procura non ha dubbi: dai primi disseccamenti e «senza
che ne fossero state individuate le cause – si legge nell’Ordinanza –, sono
state condotte in territorio salentino sperimentazioni anche con l’uso di
prodotti fortemente invasivi, tanto da essere vietati per legge, in un contesto
di grave compromissione ambientale» e senza «alcun previo studio sull’impatto
che avrebbero avuto sull’ambiente». Ma l’Affaire Xylella è appunto complesso. Ci
sono – sottolinea la Procura leccese – laboratori che «hanno effettuato analisi
e ricerche su campioni di ulivo senza il necessario accreditamento» e 10 mesi
prima di ottenerlo, come il Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in
agricoltura 'Basile Caramia' (a Locorotondo). L’Università di Bari che «ha
effettuato prove in campo e serra senza la necessaria autorizzazione» e 4 mesi
prima di ottenerla. A proposito. Pagina 35 fra le 59 dell’Ordinanza: «Ciò che è
emerso è che in Salento potrebbero esserci più ceppi differenti» di Xylella,
«per lo meno nove!» e «nonostante i ricercatori del Cnr di Bari Donato Boscia e
Maria Saponari in più occasioni ufficiali sostengano essercene uno solo».
NO TAP. VIOLENZA ED IPOCRISIA.
La coperta corta e l’illusione della
rappresentanza politica, tutelitaria degli interessi diffusi.
Di Antonio Giangrande Scrittore, sociologo
storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte
le Mafie. Antonio Giangrande ha scritto i libri che parlano delle caste e delle
lobbies; della politica, in generale, e dei rispettivi partiti politici, in
particolare.
La dittatura è una forma autoritaria di governo in
cui il potere è accentrato in un solo organo, se non addirittura nelle mani del
solo dittatore, non limitato da leggi, costituzioni, o altri fattori politici e
sociali interni allo Stato. Il ricambio al vertice decisionale si ha con
l’eliminazione fisica del dittatore per mano dei consanguinei in linea di
successione o per complotti cruenti degli avversari politici. In senso lato,
dittatura ha quindi il significato di predominio assoluto e perlopiù
incontrastabile di un individuo (o di un ristretto gruppo di persone) che
detiene un potere imposto con la forza. In questo senso la dittatura coincide
spesso con l'autoritarismo e con il totalitarismo. Sua caratteristica è anche la
negazione della libertà di espressione e di stampa.
La democrazia non è altro che la dittatura delle
minoranze reazionarie, che, con fare ricattatorio, impongono le loro pretese ad
una maggioranza moderata, assoggetta da calcoli politici.
Si definisce minoranza un gruppo sociale che, in
una data società, non costituisce una realtà maggioritaria. La minoranza può
essere in riferimento a: etnia (minoranza etnica), lingua (minoranza
linguistica), religione (minoranza religiosa), genere (minoranza di genere),
età, condizione psicofisica.
Minoranza con potere assoluto è chi eserciti
una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Con grande
influenza alla formazione delle leggi emanate nel loro interesse. Queste
minoranze sono chiamate "Caste".
Minoranza con potere relativo è colui che sia
incaricato di pubblico servizio, ai sensi della legge italiana, ed identifica
chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie
di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un
servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Queste
minoranze sono chiamate "Lobbies professionali abilitate" (Avvocati, Notai,
ecc.). A queste si aggiungono tutte quelle lobbies economiche o sociali
rappresentative di un interesse corporativo non abilitato. Queste si distinguono
per le battagliere e visibili pretese (Tassisti, sindacati, ecc.).
Le minoranze, in democrazia, hanno il potere di
influenzare le scelte politiche a loro vantaggio ed esercitano, altresì, la
negazione della libertà di espressione e di stampa, quando queste si manifestano
a loro avverse.
Questo impedimento è l'imposizione del
"Politicamente Corretto” nello scritto e nel parlato. Recentemente vi è un
tentativo per limitare ancor più la libertà di parola: la cosiddetta lotta alle
“Fake news”, ossia alle bufale on line. La guerra, però, è rivolta solo contro i
blog e contro i forum, non contro le testate giornalistiche registrate. Questo
perché, si sa, gli abilitati sono omologati al sistema.
Nel romanzo 1984 George Orwell immaginò un mondo
in cui il linguaggio e il pensiero della gente erano stati soffocati da un
tentacolare sistema persuasivo tecnologico, allestito dallo stato totalitario.
La tirannia del “politicamente corretto”, che negli ultimi anni si è
impossessata della cultura occidentale, ricorda molto il pensiero
orwelliano: qualcuno dall'alto stabilisce cosa, in un determinato frangente
storico, sia da ritenersi giusto e cosa sbagliato e sfruttando la cassa di
risonanza della cultura di massa, induce le persone ad aderire ad una serie
di dogmi laici spacciati per imperativi etici, quando in realtà sono solo
strumenti al soldo di una strategia socio-politica.
No, no e 354 volte no. La sindrome Nimby (Not in
my back yard, "non nel mio cortile") va ben oltre il significato originario. Non
solo contestazioni di comitati che non vogliono nei dintorni di casa
infrastrutture o insediamenti industriali: 354, appunto, bloccati solo nel 2012
(fonte Nimby Forum). Ormai siamo in piena emergenza Nimto – Not in my term of
office, "non nel mio mandato" – e cioè quel fenomeno che svela l’inazione dei
decisori pubblici. Nel Paese dei mille feudi è facile rinviare decisioni e
scansare responsabilità. La protesta è un’arte, e gli italiani ne sono
indiscussi maestri. Ecco quindi pareri "non vincolanti" di regioni, province e
comuni diventare veri e propri niet, scrive Alessandro Beulcke su “Panorama”.
Ministeri e governo, in un devastante regime di subalternità perenne, piegano il
capo ai masanielli locali. Tempi decisionali lunghi, scelte rimandate e
burocrazie infinite. Risultato: le multinazionali si tengono alla larga, le
grandi imprese italiane ci pensano due volte prima di aprire uno stabilimento.
Ammonterebbe così a 40 miliardi di euro il "costo del non fare" secondo le
stime di Agici-Bocconi. E di questi tempi, non permettere l’iniezione di
capitali e lavoro nel Paese è una vera follia.
NO TAV, NO dal Molin, NO al nucleare, NO
all’ingresso dei privati nella gestione dell’acqua: negli ultimi tempi l’Italia
è diventata una Repubblica fondata sul NO? A quanto pare la paura del
cambiamento attanaglia una certa parte dell’opinione pubblica, che costituisce
al contempo bacino elettorale nonché cassa di risonanza mediatica per politici o
aspiranti tali (ogni riferimento è puramente casuale). Ciò che colpisce è la
pervicacia con la quale, di volta in volta, una parte o l’altra del nostro Paese
si barrica dietro steccati culturali, rifiutando tutto ciò che al di fuori dei
nostri confini è prassi comune. Le battaglie tra forze dell’ordine e
manifestanti NO TAV non si sono verificate né in Francia né nel resto d’Europa,
nonostante il progetto preveda l’attraversamento del continente da Lisbona fino
a Kiev: è possibile che solo in Val di Susa si pensi che i benefici dell’alta
velocità non siano tali da compensare l’inevitabile impatto ambientale ed i
costi da sostenere? E’ plausibile che sia una convinzione tutta italica quella
che vede i treni ad alta velocità dedicati al traffico commerciale non
rappresentare il futuro ma, anzi, che questi siano andando incontro a un rapido
processo di obsolescenza? Certo, dire sempre NO e lasciare tutto immutato
rappresenta una garanzia di sicurezza, soprattutto per chi continua a
beneficiare di rendite di posizione politica, ma l’Italia ha bisogno di
cambiamenti decisi per diventare finalmente protagonista dell’Europa del futuro.
NO?
Il Paese dei "No" a prescindere. Quando rispettare
le regole è (quasi) inutile. In Italia non basta rispettare le regole per
riuscire ad investire nelle grandi infrastrutture. Perché le regole non sono una
garanzia in un Paese dove ogni decisione è messa in discussione dai mal di
pancia fragili e umorali della piazza. E di chi la strumentalizza, scrive
l’imprenditore Massimiliano Boi. Il fenomeno, ben noto, si chiama “Nimby”,
iniziali dell’inglese Not In My Backyard (non nel mio cortile), ossia la
protesta contro opere di interesse pubblico che si teme possano avere effetti
negativi sul territorio in cui vengono costruite. I veti locali e l’immobilismo
decisionale ostacolano progetti strategici e sono il primo nemico per lo
sviluppo dell’Italia. Le contestazioni promosse dai cittadini sono “cavalcate”
(con perfetta par condicio) dalle opposizioni e dagli stessi amministratori
locali, impegnati a contenere ogni eventuale perdita di consenso e ad
allontanare nel tempo qualsiasi decisione degna di tale nome. Dimenticandosi che
prendere le decisioni è il motivo per il quale, in definitiva, sono stati
eletti. L’Osservatorio del Nimby Forum (nimbyforum.it) ha verificato che dopo i
movimenti dei cittadini (40,7%) i maggiori contestatori sono gli amministratori
pubblici in carica (31,4%) che sopravanzano di oltre 15 punti i rappresentanti
delle opposizioni. Il sito nimbyforum.it, progetto di ricerca sul fenomeno delle
contestazioni territoriali ambientali gestito dall'associazione no profit Aris,
rileva alla settima edizione del progetto che in Italia ci sono 331 le
infrastrutture e impianti oggetto di contestazioni (e quindi bloccati). La
fotografia che emerge è quella di un paese vecchio, conservatore, refrattario ad
ogni cambiamento. Che non attrae investimenti perché è ideologicamente contrario
al rischio d’impresa. Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è la tendenza allo
stallo. Quella che i sociologi definiscono “la tirannia dello status quo”, cioè
dello stato di fatto, quasi sempre insoddisfacente e non preferito da nessuno. A
forza di "no" a prescindere, veti politici e pesanti overdosi di burocrazia
siamo riusciti (senza grandi sforzi) a far scappare anche le imprese straniere.
La statistica è piuttosto deprimente: gli investimenti internazionali nella
penisola valgono 337 miliardi, la metà di quelli fatti in Spagna e solo l’1,4%
del pil, un terzo in meno di Francia e Germania. Un caso per tutti, raccontato
da Ernesto Galli Della Loggia. L’ex magistrato Luigi de Magistris, sindaco di
Napoli, città assurta come zimbello mondiale della mala gestione dei rifiuti, si
è insediato come politico “nuovo”, “diverso”, “portatore della rivoluzione”.
Poi, dicendo “no” ai termovalorizzatori per puntare solo sulla raccolta
differenziata, al molo 44 Area Est del porto partenopeo, ha benedetto l’imbarco
di 3 mila tonn di immondizia cittadina sulla nave olandese “Nordstern” che, al
prezzo di 112 euro per tonn, porterà i rifiuti napoletani nel termovalorizzatore
di Rotterdam. Dove saranno bruciati e trasformati in energia termica ed
elettrica, a vantaggio delle sagge collettività locali che il termovalorizzatore
hanno voluto. Ma senza andare lontano De Magistris avrebbe potuto pensare al
termovalorizzatore di Brescia, dove pare che gli abitanti non abbiano l’anello
al naso. Scrive Galli Della Loggia: “Troppo spesso questo è anche il modo in
cui, da tempo, una certa ideologia verde cavalca demagogicamente paure e utopie,
senza offrire alcuna alternativa reale, ma facendosi bella nel proporre
soluzioni che non sono tali”.
Tante menzogne e tanta ipocrisia gira intorno alla
questione dei NO TAP.
Generalmente si dice “Le sentenze si rispettano”,
quando queste sono attinenti al culo degli altri. Invece nel basso Salento vige
l’anarchia. Magari hanno anche le loro ragione quelle comunità. Ma in un paese
ove vige il Diritto, la legge e le sentenze che la applicano, esige rispetto. E
comunque non si può usare violenza nascondendosi dietro un numero. Cioè il
numero di persone coinvolte loro malgrado in questioni più grandi di loro,
giusto per soddisfare le manie oniriche di grandezza di qualche personaggio in
cerca di visibilità. Usando i bambini, per giunta. Così come fa una certa
antimafia per le sue manifestazioni liturgiche.
Una società civile ha i suoi strumenti per
affermare il suo dissenso. Le vie per poterlo fare sono:
Adire le vie legali fino ai più alti gradi di
giustizia, anche per vedere se dietro i lavori si nascondono interessi mafiosi
che lucrano e che coprono anche giudiziariamente e politicamente i responsabili;
Rivolgersi a coloro che li rappresentano in sede
politica ed istituzionale locale e nazionale. Perché è da masochisti votare
sempre e comunque coloro che prendono per il culo l'elettorato.
Altro non si può fare e si passa dalla ragione al
torto se si usa violenza contro le Forze dell’Ordine con sassaiole e bombe carta
nel loro albergo; contro gli operai dei cantieri; contro i giornalisti che
documentano i fatti.
Inoltre si passa dalla ragione al torto se in nome
di una ideologica battaglia i NO TAP, a loro dire “in difesa degli Ulivi
secolari”, distruggono i muretti a secco, anch’essi secolari, per fare blocco
stradale, per impedire la libera circolazione e il proseguimento dei lavori.
Il solito autolesionismo. Adesso abbiamo
i No Tap, che sono peggio dei No Tav e s'affratellano con loro nel disordine
pubblico e nella politica di decrescita felice, anti capitalista,
scrive Francesco Forte, Mercoledì 29/03/2017, su "Il Giornale".
Adesso abbiamo i No Tap, che sono peggio dei No Tav e s'affratellano con loro
nel disordine pubblico e nella politica di decrescita felice, anti capitalista.
Non c'è più la stella rossa. In cambio ce ne sono 5 senza colore che li
sostengono e promettono loro il reddito di cittadinanza, con cui avranno più
tempo per protestare. L'opposizione alla Tap è peggio di quella alla Tav sia
perché colpisce la Puglia che ha molti più problemi di sviluppo del Piemonte e
sia perché mentre oltre alla linea Lione-Torino-Kiev esistono altri corridoi
ferroviari ad alta velocità, invece la Tap apre una linea di rifornimento
energetico del tutto nuova. Nonostante i danni che il blocco della Tav ha
arrecato al Piemonte e in particolare alla provincia di Torino, l'area in
questione ha molte altre opportunità economiche e legami internazionali tramite
Fiat Chrysler, Ferrero, Zegna. La Puglia non ha un'analoga situazione di
sviluppo economico e di internazionalizzazione e ha la crisi dell'Ilva. Questo
gasdotto le apre nuove prospettive di sviluppo e di internazionalizzazione. La
Tap lunga 870 km di cui 104 sotto il mare Adriatico, che inizia in Grecia a
Kipoi, al confine con la Turchia, e attraversa l'Albania arrivando a san Foca
nel Salento collega l'Italia con l'Azerbaijan, cioè con gli immensi giacimenti
petroliferi del Caspio, alternativi quelle russi e ai Mediorientali. La Tap non
passa né per la Russia né per l'Ucraina, aree con rischio di complicazioni
politiche, perché a Kipoi in Grecia si collega al gasdotto Scp (South Caucasus
Pipeline) che traversa il Mar Caspio e va a Baku nell'Azerbaijan. Essendo uno
dei corridoi energetici prioritari dell'Ue fruisce dei suoi finanziamenti
agevolati. L' Italia attualmente paga il gas il 20% di più che la Germania,
perché ha collegamenti meno facili e meno diversificati con i giacimenti di gas
delle are circostanti. Il nuovo hub salentino genererà concorrenza nel nostro
mercato del gas e ne favorirà la riduzione di prezzo in particolare nelle aree
vicine. L'opposizione degli ambientalisti è autolesionistica dal punto di vista
ambientale ed economico. Le analisi di impatto ambientale del ministero hanno
negato che la Tap generi un danno ambientale. Il ricorso della Regione al
Consiglio di Stato è stato respinto perché il riesame ha confermato il giudizio
delle autorità statali. Ora la Regione cerca di bloccare la Tap con un ricorso
alla Corte Costituzionale basato non sul danno ambientale ma su una presunta
violazione delle procedure riguardanti le competenze regionali. L'opposizione
alla Tap in nome dell'ambiente è autolesionistica perché essendo il gas meno
inquinante del petrolio, la sua sostituzione al petrolio migliora l'ambiente. Si
tratta anche di autolesionismo economico perché la Puglia, con questo gasdotto
avrà rilevanti vantaggi economici e occupazionali, sia nel periodo in cui si
faranno i lavori, sia in quello successivo dato che potrà utilizzare questo gas
nella produzione di acciaio all'Ilva, nelle imprese di lavorazione a valle,
nelle altre sue attività. Resta il presunto danno ambientale dell'abbattimento
degli ulivi. Il programma iniziale prevede l'abbattimento di 230 ulivi, per
quello complessivo il numero di piante è imprecisato. I No Tap sostengono che si
tratta di 2mila alberi. Ma gli ulivi abbattuti vengono indennizzati. E il
Salento ha la piaga della Xylella la cui diffusione si combatte diradandoli.
L'indennizzo può esser utilizzato per piantare ulivi non contaminati o altre
piante. Quanto al danno al turismo a San Foca non si capisce in cosa possa
consistere dato che i tubi passano sotto la superficie del mare e proseguono
sotto la costa. Ma ai No Tap come ai No Tav non si può chiedere di ragionare,
loro protestano contro il capitalismo e si sfogano contro polizia ed edifici in
nome della decrescita felice.
Gli ulivi e il fronte del «no» a priori.
Corriere della Sera, 29 mar 2017 di Pierluigi Battista Borrillo, Ducci,
Gramigna. Proteste e scontri tra polizia e manifestanti nel Salento per dire no
al gasdotto che costringerebbe a sradicare gli ulivi. Ieri erano i No Tav in
Piemonte, oggi i No Tap in Puglia. Proteste, spesso, venate di ideologia. A
opporsi alle forze dell’ordine anche alcuni sindaci. «Ragazzi, dai, facciamo il
nostro lavoro». Gli agenti di polizia sono abituati a farsi scudo con questa
frase. E anche ieri, nelle campagne del Salento, l’hanno ripetuta più volte
fronteggiando, tra spintoni e tafferugli, i NoTap, circa 300 persone che si
oppongono al gasdotto che approderà sul litorale di San Foca, frazione di
Melendugno. La differenza rispetto alle piazze e agli stadi è il «lavoro»:
presidiare il transito dei camion che trasportano ulivi espiantati. Ventotto
ulivi in tutto ieri (che si aggiungono ai 33 già trasferiti il 20 marzo, prima
del momentaneo stop), per i quali due agenti sono rimasti contusi a causa del
lancio di sassi da parte dei manifestanti. Due persone si sono sentite male: un
15enne e un 65enne in sciopero della fame da una settimana, soccorso da
un’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Galatina dopo la prima carica
degli agenti intervenuti a forzare il blocco del cantiere, tra fischi e urla e
un elicottero della polizia a controllare l’area. Tutti assicurano che non si
voleva arrivare al confronto violento: non volevano i manifestanti (un centinaio
quelli in prima linea), tra cui sindaci e consiglieri regionali, donne e interi
gruppi familiari; né
gli agenti che dovevano far passare i camion con gli ulivi. Ma per aprire un
varco, le fazioni contrapposte sono arrivate, inevitabilmente, a contatto. «Un
dolore enorme — sottolinea il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano —
per i sindaci che si sono trovati davanti ai manganelli. E per me, che con le
forze dell’ordine ho sempre lavorato. È stato un dramma constatare che per
obbedire agli ordini quegli uomini in divisa siano dovuti entrare in contatto
fisico con sindaci e cittadini per colpa di politici che non ascoltano». Il
governo — ha ribadito — «dà la misura della sua incapacità di ascoltare una
regione intera». La protesta di ieri è scoppiata alla riapertura del cantiere
dopo il doppio via libera di lunedì: l’ok del Consiglio di Stato, che ha
respinto gli appelli del Comune di Melendugno e della Regione Puglia sulla
valutazione di impatto ambientale, e quello del ministero dell’Ambiente che ha
inviato alla Prefettura di Lecce una nota per autorizzare l’espianto degli
ulivi, sospeso dal prefetto di Lecce (che nella serata di ieri ha convocato i
sindaci) in attesa di chiarimenti del ministero sull’iter autorizzativo. Nota
che la Le autorizzazioni Il cantiere è riaperto dopo gli ok di Consiglio di
Stato e ministero dell’Ambiente Regione ha deciso di impugnare dinanzi al Tar.
Il gasdotto Tap, Trans adriatic pipeline da 878 chilometri, rappresenta la parte
terminale del corridoio meridionale europeo del gas, 3.500 chilometri
dall’Azerbaijan all’Italia. Di questi, poco più di 8 chilometri saranno in
provincia di Lecce, dall’approdo sul litorale di San Foca al terminale di
ricezione nelle campagne di Melendugno. I lavori preliminari prevedono, per la
realizzazione di un microtunnel, l’espianto di 211 ulivi, da trasportare nel
sito di stoccaggio dal quale saranno riportati nel luogo di origine una volta
realizzato il tunnel. Ma la Regione Puglia, nonostante tutti gli ok avuti da
Tap, non demorde perché, come spiega Emiliano, «non diciamo no al gasdotto ma
che si faccia altrove, laddove lo vogliono. E poi pende ancora davanti alla
Corte costituzionale il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla
Regione nei confronti del governo». Insomma, per Emiliano la partita non è
chiusa: la Consulta si pronuncerà il 4 aprile. Il governo dà la misura della sua
incapacità di ascoltare un’intera regione. Noi non ci opponiamo al Tap, ma va
fatto altrove: dove lo vogliono.
Zuppa di Porro, 3 aprile 2017: I No Tap usano i
bambini per la protesta. Toglieteli come per la famiglia del Bangladesh.
Lo Stato ha il diritto di sradicare gli
ulivi. Poco più di un lustro fa, nell’azienda agricola
condotta da mio fratello Gian Michele, arriva una comunicazione ufficiale,
scrive Nicola Porro, su Il Giornale il 30 marzo 2017. Il mittente è l’acquedotto
pugliese. Spettabile Tenuta Rasciatano, è il nome della nostra azienda di
famiglia, dobbiamo fare passare un tubo anche nelle vostre terre. Inizieremo
presto gli scavi, l’espropriazione del terreno e tutte le opere utili
all’operazione. Punto. Noi siamo in Puglia, abbiamo uliveti secolari, facciamo
olio e vino. La faccio breve: nel giro di un paio di mesi arrivano le ruspe, un
po’ di cemento, e poco più di duecento olivi secolari vengono rasi al suolo.
Pubblica utilità. Quando lo Stato ti entra in casa e decide come arredare il tuo
appartamento, un po’ ti scoccia. Eppure lo stesso padre dei liberali, anzi oggi
si direbbe liberisti, Adam Smith, alla fine del 700, scriveva: «Lo stato serve
per tre cose. La difesa, la giustizia e per realizzare quelle opere pubbliche
che i privati da soli non farebbero mai». Non so se un acquedotto, gestito
all’epoca molto male, dalla Regione Puglia, era ciò a cui pensava l’economista
scozzese. Ma il principio che la proprietà privata, privatissima come la mia
terra, possa subire una ferita dall’intervento dello Stato, anche per un
liberista acceso come chi scrive, purtroppo si deve prendere in considerazione.
Mai mi sarei permesso di infastidire i lettori del nostro Giornale, con questa
piccola (per noi grande) vicenda domestica. Ma quando leggo del casino che
stanno facendo per 212 olivi salentini e secolari come i nostri, che vengono
momentaneamente spianati per fare arrivare un tubo fondamentale per i nostri
approvvigionamenti energetici, be’ mi viene il sangue al cervello. Questi
no-tap, dove erano quando la sinistrissima regione Puglia espropriava per il suo
acquedotto? Un nostro ulivo andriese, vale forse meno di una pianta simile nel
Salento? Invece di stare appresso a queste sciocchezze, quella salentina è
veramente roba da nulla, i fan della nostra identità enogastronomica e
paesaggistica, si occupassero delle cento follie con cui stanno distruggendo
l’agricoltura meridionale. Solo la Confagricoltura, con scarso seguito nella
politica, ha fatto il diavolo a quattro sulla norma del caporalato, un
kalasnikov giudiziario puntato su chiunque assuma un operaio. Si occupi del
fatto che hanno cancellato i voucher, che in agricoltura erano stabili nel loro
utilizzo. Siamo vittime del clamore agitato da pochi esaltati. Un caso di
cronaca nera diventa la regola su cui legiferare, duecento piante nel Salento,
una porzione di quelle distrutte per motivi pubblici negli ultimi anni,
diventano un caso nazionale. Non si difende la nostra identità, con gli
schiamazzi no-tap, ma rendendo le nostre aziende produttive. Liberandole dalla
mole di adempimenti burocratici che le sommergono. Utilizzando il buon senso nei
controlli, che sono diventati asfissianti. Insomma lasciandoci fare il nostro
lavoro. Rinuncerei ad altre cento piante, se solo una parte di queste richieste
venissero davvero esaudite. Ps. Tutti che si improvvisano agricoltori,
contadini, ma in un campo ci siete mai stati per più di una bella giornata di
sole?
Gasdotto Tap, sindaci in presidio davanti
al cantiere: "Andiamo a Roma, il governo ci ascolti".
Sindaci salentini pronti a marciare su Roma per fare sentire la voce di
contrarietà alla realizzazione del gasdotto Tap. La mobilitazione degli
amministratori locali cresce di pari passo con quella dei manifestanti, che dal
15 marzo presidiano il cantiere di Melendugno. Nella mattina di giovedì 23,
tredici sindaci hanno voluto esprimere sostegno al primo cittadino di
Melendugno, Marco Potì, facendosi fotografare uniti davanti al cancello chiuso
del cantiere, con le fasce tricolore. I lavori di espianto degli ulivi sono
fermi dal 21 marzo, in attesa di un parere del ministero dell’Ambiente,
sollecitato dalla Prefettura di Lecce. L’idea di una protesta sotto Palazzo
Chigi è stata lanciata dalla sindaca di Calimera, Francesca De Vito: “Auspico
che insieme ai miei colleghi decideremo di andare a Roma, perché se tanti
sindaci protestano il governo non potrà non ascoltarli. Queste scelte non
possono passare sulla testa del nostro territorio e delle nostre comunità”. (Di
Chiara Spagnolo, 23 marzo 2017 su Repubblica TV)
Gasdotto Tap, il presidente di
Confindustria Lecce: "Basta proteste, opera necessaria".
Giancarlo Negro commenta la protesta del fronte anti-Tap, che ha coinvolto anche
i bambini: "La situazione è insostenibile, perché non si sono fatte marce quando
la costa salentina è stata devastata?" Scrive Chiara Spagnolo il 2 aprile 2017
su "La Repubblica".
"Portare i bambini alla manifestazione contro il
Tap e piazzarli davanti ai camion significa avere oltrepassato la misura,
esasperare una situazione che è diventata insostenibile dal punto di vista della
responsabilità sociale".
E' duro il presidente di Confindustria Lecce,
Giancarlo Negro, nel giorno in cui la marcia dei cittadini ha fermato i camion
Tap.
Il territorio è contro questa infrastruttura,
non sarebbe il caso di fermarsi?
"Tap ha svolto tutte le procedure e ottenuto tutte
le autorizzazioni. Riconduciamo la questione nel sistema di regole che ci
governa e, se la decisione è presa, mettiamo l'azienda nella possibilità di
lavorare".
Ma la politica, regionale e locale, contesta la
scelta dell'approdo a Melendugno.
"Credo si siano svegliati tardi, in questo momento
non ci sono altri approdi possibili, dovevano pensarci prima. Ciò che ora
possono fare è mettere tutte le istituzioni attorno a un tavolo e capire che il
gasdotto è un'opportunità per il territorio".
In che termini lo ritiene un'opportunità?
"Esiste un fabbisogno energetico e il gas è una
fonte meno inquinante di altre, insieme alle energie rinnovabili. C'è anche un
impatto occupazionale che va considerato, anche se questo non significa
barattare il lavoro con l'ambiente. Inoltre credo che l'opera abbia un impatto
minimo sul territorio".
Ma le comunità locali lamentano proprio la
ripercussione sulla zona turistica.
"La costa salentina è stata devastata per decenni,
dai cittadini e anche dalle istituzioni, e non ho mai visto marce. Migliaia di
alberi vengono eradicati ogni anno in Puglia, come ha ricordato il manager Tap
anche per fare spazio ai tubi dell'Acquedotto, eppure non ci sono crociate in
difesa degli ulivi. Qui si sta alzando la tensione, anche con le bombe alla
polizia, le minacce agli operai, la situazione è insostenibile".
Tap, ecco la sentenza che affossa le
velleità della Regione Puglia retta da Michele Emiliano,
scrive Veronica Sansonetti su "Formiche.net" il 28 marzo 2017. Il Consiglio di
Stato ha dato il via libera alla realizzazione del Trans adriatic pipeline
(Tap), il gasdotto lungo 870 chilometri, parte terminale del corridoio
meridionale europeo del gas da 3.500 chilometri che attraverserà sei Paesi
dall’Azerbaijan all’Italia. Con una sentenza, pubblicata ieri, la IV Sezione del
Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dal Comune di Melendugno e
dalla Regione Puglia nei confronti della sentenza del Tar sul Tap. La sentenza
pone fine al contenzioso amministrativo sull’Autorizzazione unica rilasciata a
Tap il 20 maggio 2015 e sull’applicazione della direttiva Seveso sugli incidenti
rilevanti. Lo scorso 20 marzo i “No Tap” hanno bloccato i lavori di spostamento
degli ulivi dal punto di approdo sul litorale di San Foca (frazione di
Melendugno, provincia di Lecce).
IL RICORSO. L’amministrazione comunale di
Melendugno con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva
impugnato il decreto del ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e
del Mare (Mattm) n. 223 dell’11 settembre 2014 con cui era stata rilasciata la
valutazione di impatto ambientale sul progetto di realizzazione del gasdotto
denominato “Trans Adriatic Pipeline – TAP” e la delibera del 10 settembre 2014
con cui il Consiglio dei ministri aveva fatto propria la posizione del Mattm ed
aveva superato il parere negativo del Ministero dei bei e delle attività
culturali e del Turismo, nonché le note con cui il Mattm aveva sospeso la
procedura per circa un anno.
L’IMPATTO AMBIENTALE. In una nota dell’ufficio
stampa del Segretariato generale della giustizia amministrativa, il Consiglio di
Stato spiega che “ha ritenuto che la valutazione di impatto ambientale resa
dalla Commissione Via avesse approfonditamente vagliato tutte le problematiche
naturalistiche e che anche la scelta dell’approdo nella porzione di costa
compresa tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri (all’interno del Comune di
Melendugno) fosse stata preceduta da una completa analisi delle possibili
alternative (ben undici)”.
LA DIRETTIVA SEVESO. Il Tar ha ricordato che “la
problematica relativa alla applicabilità della normativa “Seveso” alla
contestata opera era emersa sin dall’inizio dell’esame del progetto Tap : ciò
era dimostrato dalla Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa –
circostanza che la stessa Commissione Via/Vas, nel parere del 29 agosto 2014,
aveva inserito la prescrizione (poi divenuta A13 nel decreto 223/2014 e
riguardante la preventiva acquisizione, con riferimento al Prt, del nulla osta
di fattibilità rilasciato, ai sensi del d.lgs n. 334 del 1999, dal comitato
tecnico regionale) in forma dubitativa ovvero “se ed in quanto prescritto e/o
previsto”. È stato infine riconosciuto “l’avvenuto rispetto del principio di
leale collaborazione tra Poteri dello Stato nella procedura di superamento del
dissenso espresso dalla Regione alla realizzazione dell’opera”.
CONCLUSIONE. Si tratta – notano gli addetti ai
lavori – dell’ennesima vittoria nelle aule di giusizia per Tap: nessuna
iniziativa legale contro il gasdotto strategico è stata avallata da un
tribunale.
No Tap, Assostampa: sconcerto per
violenza a troupe TgNorba, scrive il 21 marzo, 2017 la
Redazione di "Bat Magazine. Il Comitato di redazione di Telenorba e
l’Associazione della Stampa di Puglia esprimono sconcerto per la violenza con
cui è stata aggredita una troupe del TgNorba, inviata a Melendugno per
realizzare un servizio sull’espianto degli ulivi nell’ambito dei lavori in corso
sul gasdotto. «Uno dei manifestanti “No Tap” – spiega in una nota il sindacato
regionale – ha pensato bene di sfogare la sua rabbia contro i due colleghi
impegnati nel servizio, per fortuna provocando solo danni alla telecamera. Il
sindacato dei giornalisti pugliesi, nell’invitare i colleghi a proseguire il
loro lavoro senza farsi condizionare dalle intimidazioni, sollecita la
Prefettura e le forze dell’ordine a compiere tutti gli sforzi possibili per
consentire a tutti i giornalisti di esercitare con serenità il loro lavoro». Il
diritto di cronaca e il diritto dei cittadini ad essere informati su ciò che
accade nel loro territorio, conclude la nota, «non possono essere imbavagliati
dalla violenza e dalla intolleranza di pochi esagitati».
Ecco violenze e atti illegali contro il
gasdotto Tap. Avanti tutta verso l’abisso, scrive
Michele Arnese su "Formiche.net" il 30 marzo 2017. Ecco i non violenti. Ecco i
difensori della legalità. Ecco gli assertori dei metodi pacifici. Ecco gli aedi
dell’ambientalismo bucolico che non ammazzano neppure una zanzara. I signori
della non violenza sono entrati in azione in queste ore per seminare odio e
metodi incendiari in Puglia all’insegna del No Tap. Evidentemente non bastano
leggi che indicano come opera strategica per l’Italia l’infrastruttura, non sono
sufficienti le sentenze (ultima quella di due giorni fa del Consiglio di Stato)
che sbugiardano anni di contrapposizioni deleterie avallate pure da politici
locali e nazionali fra silenzi, tartufismi e pusillanimità. I fatti inducono
alla tristezza. O alla vergogna. Eccoli. Nelle ultime ore sono state registrate
minacce nei confronti di partecipanti ai progetti finanziati da Tap sul
territorio pugliese, di partner di questi progetti e persino nei confronti degli
operai che stanno facendo il proprio lavoro in cantiere nel pieno rispetto della
legge. “Altri comportamenti violenti – denuncia in una nota il consorzio – sono
stati registrati nell’area di cantiere. Questa notte è stata lanciata una bomba
carta contro la recinzione; uno striscione con esplicite minacce di morte a uno
dei nostri colleghi è esposto in cantiere tra i manifestanti senza che nessuno,
a partire dai soggetti istituzionali presenti da giorni in agro di Melendugno,
abbia preso le distanze da questi comportamenti. È stata inoltre lanciata una
torcia accesa all’interno dell’area di cantiere, mettendo a rischio l’incolumità
di chi sta lavorando al trasferimento temporaneo degli ulivi”. Non solo: sulla
pagina Facebook del presidio “No Tap” è stato riportato un elenco di tutte le
aziende e i soggetti che lavorano con Tap, con “fini non ben chiari” rispetto a
tutti coloro che collaborano con il progetto. Avanti tutta, avanti verso
l’abisso, avanti verso il declino economico, industriale, civile e legale.
Ed a proposito della distruzione dei muretti a
secco.
La non violenza paga: bloccate le strade
con barricate: cantieri fermi, scrive Lucilla Parlato;
in difesa dei No TAP, il 30 marzo 30 2017. La lotta non violenta dei no tap in
Puglia dovrebbe essere un esempio per i “rivoluzionari” o presunti tali del
resto del sud. Stanotte infatti i militanti hanno bloccato le strade
interpoderali con pezzi di muretti a secco, cassonetti della spazzatura e
materiale di risulta Il quattordicesimo giorno di protesta contro la
realizzazione del gasdotto Tap inizia così a Melendugno. I blocchi sono comparsi
nella notte sulle diverse vie che collegano l’area di cantiere in località San
Basilio alla marina di San Foca e alla strada regionale 8, dalla quale nei
giorni scorsi sono arrivati sia i blindati delle forze dell’ordine che i mezzi
delle ditte incaricate dell’espianto degli ulivi e del trasporto nel sito di
stoccaggio. Risultato: al momento il cantiere – come confermano dai Comitati no
tap – resta chiuso, oggi c’è meno disponibilità di forze dell’ordine e dunque lo
Stato non è in grado di fronteggiare i manifestanti, manganellati – insieme al
sindaco barricadero Marco Potì, primo cittadino di Melendugno e a altri primi
cittadini – lo scorso 28 marzo e che hanno fronteggiato, a mani alzate,
l’inusitata violenza dello Stato. Potì ha anche ribadito che non ha alcuna
intenzione di incontrare Tap né di accettare alcuna compensazione per la
realizzazione del gasdotto nel suo territorio.
Istituzioni in prima linea nella lotta, azioni di
boicottaggio non violente: dai No Tap un esempio da seguire. Oggi comunque il
presidio continua, i militanti non mollano e restano in guardia. Nonostante la
lotta incessante, la foto sopra indica lo scempio compiuto finora da tap, con lo
sradicamento di alcune decine di ulivi: un pugno nell’occhio, un buco nel cuore
per chi da anni si batte per salvare le piante secolari che producono l’oro
giallo di Puglia. Lucilla Parlato.
Ciò nonostante c’è la guerra delle
menzogne. No Tap accusa gli altri, abbattuti muretti a secco.
Ansa 2 aprile 2017. Secondo il comitato No Tap, che si oppone
alla realizzazione a San Foca di Melendugno dell'approdo del gasdotto, la
multinazionale Tap avrebbe abbattuto ieri alcuni muretti a secco delle strade
poderali della zona per consentire ai camion che trasportano gli ulivi
espiantati di aggirare i blocchi stradali. Lo Gianluca maggiore, il portavoce
del comitato che da giorni sta fronteggiando sul campo la multinazionale con un
presidio fisso che si rafforza con l'arrivo di decine di persone ogni volta che
riprendono il lavori nel cantiere. Il comitato si oppone all'espianto degli
ulivi lungo il tracciato del microtunnel che ospiterà il gasdotto. Le proteste e
le barricate alzate dai manifestanti hanno di fatto rallentato i lavori, ma
considerando gli ultimi espianti e trasferimenti eseguiti ieri (oggi i lavori
sono sospesi) Tap è riuscita a rimuovere 183 dei 211 ulivi previsti. Nel
pomeriggio è prevista una manifestazione M5s sul lungomare di San Foca.
Tap, 5 cose da sapere sul gasdotto della
discordia. Che cosa è, a che cosa serve, da dove passa il metanodotto al centro
delle proteste e degli scontri in Salento, scrive il
29 marzo 2017 Claudio Longo su Panorama.
I lavori di costruzione del gasdotto Trans
Adriatic Pipeline (TAP), che trasporterà gas naturale dalla regione del Mar
Caspio in Europa, sono cominciati nel 2016, ma solo negli ultimi giorni le
proteste del comitato "No TAP" contro l'espianto degli ulivi hanno riacceso i
riflettori sull'opera considerata strategica dal governo italiano. In Puglia i
comitati protestano per evitare l'espianto di circa 200 alberi di ulivo secolari
(che saranno ripiantati in un'altra zona della provincia), sui terreni del
Salento a Melendugno (Lecce) dove passerà il gasdotto. Ma che cos'è il gasdotto
che continua a causare proteste?
1- Il progetto. Collegando il Trans Anatolian
Pipeline (TANAP) alla zona di confine tra Grecia e Turchia, il metanodotto
attraverserà la Grecia settentrionale, l'Albania e l'Adriatico per approdare
sulla costa salentina di San Foca di Melendugno (Lecce) e collegarsi alla rete
nazionale. Una volta realizzato, TAP - secondo i progetti - costituirà il
collegamento più diretto ed economicamente vantaggioso per approvvigionarsi alle
nuove risorse di gas dell'area del Mar Caspio, aprendo il Corridoio Meridionale
del Gas.
2 - Il percorso. Il gasdotto TAP, progettato
dall'omonima multinazionale, si snoderà per 878 chilometri e porterà fino in
Italia il gas naturale estratto nel Mar Caspio (Azerbaijan). Tra i principali
azionisti di TAP ci sono le principali società del settore energetico: Socar,
Snam, Bp, Fluxys, Enagas ed Axpo. TAP raggiungerà la massima altitudine di 1.800
metri tra i rilievi albanesi e la massima profondità di 820 metri sotto il Mare
Adriatico. In Grecia il gasdotto sarà lungo 550 chilometri, partendo da Kipoi
al confine con la Turchia, per terminare al confine con l'Albania, a sud ovest
di Ieropigi. In Albania avrà un'estensione di 215 chilometri, da Bilisht Qender,
al confine con la Grecia, per approdare a 17 km a nord ovest di Fier, fino a 400
metri verso l'entroterra rispetto alla linea di costa.
3 - Il tratto sottomarino. Il tratto sottomarino
nelle acque albanesi misurerà circa 37 chilometri. Nell'attraversamento
dell'Adriatico percorrerà 105 chilometri di fondali dalla costa albanese a
quella italiana. In Italia TAP approderà in Salento, a San Foca, marina di
Melendugno. La condotta sottomarina che attraverserà le acque territoriali
italiane misurerà circa 25 chilometri, mentre il tratto sulla terraferma del
tracciato del gasdotto sarà di 8,2 chilometri fino al terminale di ricezione.
Nel punto di approdo di San Foca, la conduttura passerà in prossimità del
litorale dopo aver attraversato l'Adriatico, passando sotto la costa attraverso
un microtunnel di approdo lungo 1,5 chilometri. Il microtunnel verrà scavato
nell'entroterra, a circa 700 metri di distanza dalla spiaggia, e uscirà nel
fondale marino a circa 800 metri dalla riva, ad una profondità di 25 metri.
4 - La portata. Il metanodotto avrà una capacità
iniziale di 10 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno, equivalenti al
consumo energetico di circa sette milioni di famiglie in Europa. Considerando il
possibile incremento dei fabbisogni futuri, i progettisti hanno previsto che
l'opera possa trasportate volumi aggiuntivi rispetto a quelli iniziali. Con
l'aggiunta di altre due stazioni di compressione, la quantità trasportata potrà
essere, infatti, duplicata fino a 20 miliardi di metri cubi all'anno, a fronte
di ulteriori forniture disponibili nella più vasta area del Mar Caspio.
5 - Gli scenari alternativi. Il progetto Tap è
"un'opera importante per un duplice motivo. Da un lato concorre a spingere il
Paese nella direzione di un mix energetico più equilibrato, dall'altro
il gasdotto è un'infrastruttura che rende l'Italia meno dipendente, per esempio,
dal carbone. Vuol dire che il maggiore utilizzo di gas contribuirà a rispettare
gli impegni assunti con gli accordi di Parigi sul clima". Lo afferma in
un'intervista al Corriere della Sera il ministro dell'Ambiente Gian Luca
Galletti, sottolineando che "sono stati valutati 14 scenari alternativi, prima
di concludere che la soluzione corretta era stata individuata a Melendugno".
L'Alleato Azero: ora una graphic novel
racconta il grande affare del gasdotto Tap.
Anticipazione del libro curato dall'associazione Re: Common e disegnato da
Claudia Giuliani. Protagonista è la giornalista Khadija Ismaiylova, che ha
svelato gli affari segreti del regime di Baku e l'alleanza fra Italia e
Azerbaigian. Pagando con il carcere la sua voglia di libertà e giustizia, scrive
Stefano Vergine il 21 novembre 2016 su "L'Espresso". La protagonista de
“L'Alleato Azero”, pubblicato nella collana “Bolina” di Round Robin editrice, è
la giornalista investigativa Khadija Ismaiylova, uno dei simboli
dell'opposizione al regime che governa da decenni l'Azerbaigian. Con il suo
prezioso lavoro, Khadija svela gli intrighi e la corruzione del potere e per
questa ragione viene incarcerata sulla base di accuse inventate, stessa sorte
toccata negli ultimi anni ad almeno un centinaio di oppositori del governo. I
Panama Papers sono i protagonisti di uno degli snodi principali della storia. Le
carte della Mossack Fonseca confermano in pieno la veridicità dei reportage
scritti dalla giornalista sull'impero offshore del presidente Ilham Aliyev. In
particolare, come la proprietà della principale miniera d'oro del Paese del
Caspio sia riconducibile a tre società registrate a Panama e controllate dalle
due figlie di Aliyev, Leyla e Arzu. L'unico personaggio fittizio di questa
graphic è il giornalista Andrea Ulivieri, trait d'union con il versante italiano
della storia, quello della saga infinita del gasdotto Tap e della forte
opposizione che sin dal primo momento il progetto ha incontrato sul territorio
salentino, dove il tubo dovrebbe approdare. Non a caso gli altri protagonisti
sono i ragazzi del comitato No Tap. Il metano che si vorrebbe far passare per il
gasdotto arriva proprio dall'Azerbaigian, Paese che soffre di un evidente
deficit di democrazia e non ha molto a cuore la tutela dei diritti umani, come
dimostra la vicenda di Khadija.
Tap, gli affari sporchi degli uomini del
gasdotto. Il manager finito in mezzo a un caso di
riciclaggio mafioso, l'azero con la società offshore svelata dai Panama papers,
l'uomo d'affari scelto perché ha buoni agganci con la politica e il condannato
per furto di libri antichi. Ritratto dei nomi più importanti legati alla maxi
opera, scrivono Paolo Biondani e Leo Sisti il 3 aprile 2017 su "L'Espresso".
Mister Tap, la mafia calabrese, i narcos sudamericani, le valigie piene di
denaro nero, le casseforti anonime con la targa offshore, gli oligarchi russi,
gli affaristi italiani legati alla politica e altri misteriosi protagonisti e
comprimari. Alla base del Tap, il supergasdotto che minaccia di perforare le
coste del Salento, c’è una storia nera mai raccontata prima. Un intreccio di
vicende pubbliche e segreti privati che rilancia quel groviglio di interrogativi
che fanno da detonatore delle proteste esplose in Puglia contro lo sradicamento
dei primi 231 olivi: chi ha deciso l’attuale tracciato? È davvero necessario far
passare miliardi di metri cubi di gas tra spiagge meravigliose e oliveti
secolari, anziché dirottare i maxi-tubi in zone già industrializzate, che si
potrebbero disinquinare con una minima parte dei fondi del Tap? Come mai i
finanziamenti pubblici europei sono stati incamerati da una società-veicolo con
azionisti svizzeri? Se è vero che il gasdotto è strategico per molti Stati
sovrani, perché sono le aziende private a progettare dove, come e con chi
costruire una grande opera tanto costosa e controversa? Il Tap, che sta per
Trans Adriatic Pipeline, è la parte finale di un gasdotto gigantesco: quasi
quattromila chilometri di condotte per trasportare enormi quantità di metano
dall’Azerbaijan all’Italia. Il costo preventivato è di 45 miliardi. Il troncone
iniziale Sud-Caucasico parte dal giacimento azero di Shah Deniz 2 e attraversa
la Georgia. Il secondo tratto, chiamato Tanap, percorre tutta la Turchia. Il Tap
è l’ultimo pezzo, lungo 878 chilometri, che s’inerpica nel nord della Grecia
(fino a quota 1.800), scende sulla costa albanese, s’inabissa in mare (fino a
meno 820 metri) e arriva in Salento: l’approdo previsto è la spiaggia di San
Foca, a Melendugno, dove in questi giorni, tra rumorose proteste popolari, è
iniziato lo sradicamento degli olivi. La società capofila Tap Ag, che raggruppa
in Svizzera una cordata di multinazionali, assicura che il gasdotto sarà
interrato, tutti gli alberi verranno ripiantati e gli altissimi standard di
sicurezza azzereranno ogni rischio di inquinamento, incidente o disastro. In
Italia finora sono iniziati solo i lavori preparatori del micro-tunnel previsto
dal ministero dell’Ambiente per non devastare una costa che vive di turismo: una
galleria di cemento che parte in mare, a 800 metri dalla riva, passa sotto la
spiaggia e riaffiora nei campi, a 700 metri dalla battigia. Da lì il progetto
continua su terra, per altri 8,2 chilometri, fino a un nuovo terminale di
recezione: qui il consorzio Tap prevede di spostare 1.900 alberi secolari. Per
collegarsi alla rete nazionale del gas, poi, servono altri 55 chilometri di
condotte fino a Mesagne, vicino a Brindisi. Gli olivi a rischio, in totale,
salgono così a 10 mila. Contro questo tracciato, oltre ai cittadini del fronte
“No Tap”, si sono schierati i sindaci interessati e il governatore della Puglia,
Michele Emiliano, che ha chiesto più volte di «far approdare il gasdotto
direttamente a Brindisi, evitando 55 chilometri di scavi e tubi superflui». I
governi Monti, Letta e Renzi hanno però inserito il Tap tra le opere
strategiche, per cui si possono ignorare comuni e regioni: basta una valutazione
d’impatto ambientale gestita dal ministero, che in questi giorni è stata
convalidata dal Consiglio di Stato. Il super gasdotto, dunque, è un’opera
progettata, eseguita e gestita da imprese private, ma dichiarata di eccezionale
interesse pubblico, addirittura sovranazionale. L’Espresso ha potuto
esaminare una serie di documenti riservati della Commissione europea, che
svelano il ruolo cruciale di una società-madre, finora sconosciuta: l’azienda
che ha ideato il progetto e ha ottenuto i primi decisivi finanziamenti pubblici.
Si chiama Egl Produzione Italia, è una società per azioni con 200 mila euro di
capitale, ma è controllata dalla Egl lussemburghese, a sua volta posseduta dal
gruppo elvetico Axpo, che fa capo a diversi cantoni della Svizzera tedesca. Le
carte, ottenute grazie a una richiesta di atti dell’organizzazione Re: Common,
documentano che la Egl italiana ha ottenuto, nel 2004 e 2005, due finanziamenti
europei a fondo perduto, per oltre tre milioni, utilizzati proprio per i
progetti preliminari e gli studi di fattibilità del Tap. I ricercatori avevano
chiesto di esaminare tutti gli altri atti, ma la Commissione europea ha risposto
che devono restare riservati per rispettare i segreti industriali, la sicurezza
e la privacy delle aziende del gasdotto. Comunque ora è chiaro che il Tap è nato
con «fondi strutturali europei» concessi a un colosso svizzero dell’energia, in
teoria esterno alla Ue. Anche l’amministratore delegato di questa Egl Italia, la
società-madre del Tap, è un cittadino svizzero: Raffaele Tognacca, 51 anni, un
manager che ha fatto anche politica con i liberali in Canton Ticino. Tognacca ha
lavorato per anni tra Roma e Genova come dirigente del gruppo italiano Erg, che
ha diversificato dal petrolio agli impianti eolici e solari soprattutto al sud.
Tornato in Svizzera, ha aperto con la moglie la società finanziaria Viva
Transfer, che un’indagine anti-mafia italiana ha additato come una lavanderia di
soldi sporchi. Intervistato dalla tv svizzera italiana, il procuratore aggiunto
Michele Prestipino descrisse la vicenda come «un caso esemplare di riciclaggio
internazionale di denaro mafioso». Tutto parte nella primavera 2014, quando la
Guardia di Finanza di Roma scopre una presunta banda di narcotrafficanti
collegati alla ’ndrangheta. Il clan, capeggiato dal calabrese Cosimo Tassone, è
accusato di aver importato oltre mezza tonnellata di cocaina dal Sudamerica, con
altri 220 chili sequestrati a Gioia Tauro. In quei giorni, secondo l’accusa, il
clan calabrese deve versare un milione e mezzo di euro ai narcos sudamericani,
ma non può usare il previsto canale bancario brasiliano. Quindi il braccio
destro di Tassone recluta una famiglia di promotori finanziari toscani, il padre
e due figli, che accettano di «trasportare quei soldi in contanti, dentro due
trolley, a Lugano, nella sede della Viva Transfer», come confermano le
confessioni degli stessi corrieri poi arrestati. A ricevere tutte quelle
banconote, da mandare in Brasile, è stato «Raffaele Tognacca in persona».
Proprio il manager che ha tenuto a battesimo il Tap. Quando Tognacca entra in
scena, le intercettazioni captano una lite che rischia di degenerare: dal
Sudamerica i narcos si lamentano di aver ricevuto mezzo milione in meno. In
Italia Tassone, furibondo, pensa a un furto e manda i suoi uomini a terrorizzare
un figlio del corriere toscano: «Gli spacco la testa... Noi non siamo
imprenditori!». L’altro figlio intanto viene tenuto in ostaggio in Brasile, come
garanzia umana. Dopo altre violenze e intimidazioni, il boss calabrese si
convince che nessuno gli ha rubato i soldi mancanti: è la società di Tognacca
che ha incamerato una parcella-record di oltre 400 mila euro («il 30 per
cento!»). Proprio allora scattano gli arresti. Al processo, tutt’ora in corso, i
pm di Roma hanno formulato una specifica accusa di riciclaggio. E dopo la
retata, hanno incontrato i colleghi elvetici, competenti a valutare la parte
estera del presunto reato. Tognacca si è difeso pubblicamente dichiarando di
«non essere stato oggetto di nessuna misura penale né in Italia né in Svizzera».
Per i magistrati italiani resta assodato che il clan calabrese usò la Viva
Transfer per pagare la cocaina. Ma i giudici elvetici potrebbero aver archiviato
tutto per «mancata prova del dolo»: Tognacca poteva non sapere che erano soldi
di mafia. Magari pensava di aiutare onesti evasori fiscali. Certo è che mister
Tap non disprezzava le valigie di denaro nero. Oggi la Egl italiana non esiste
più: è stata assorbita da Axpo. Ma il Tap va avanti. Nel 2009 la Commissione
europea accetta pure di cambiare il beneficiario del residuo finanziamento a
fondo perduto, dirottato dalla Egl alla Tap Asset spa, un’altra filiale di Axpo
con sede a Roma, nello stesso palazzo della delegazione europea. La vicinanza
aiuta. La società-bis infatti eredita i contributi quando è già diventata una
scatola vuota: nove mesi prima, infatti, ha venduto il progetto del
supergasdotto, per almeno 12 milioni, all’attuale capofila Tap Ag. Pure questa è
una società svizzera, ma oggi è controllata da multinazionali dell’energia come
l’italiana Snam, l’inglese Bp, la belga Fluxys, la spagnola Enagas, l’azera
Az-tap e naturalmente Axpo. Nel 2013 il corridoio sud del gas, cioè l’intero
maxi-gasdotto, viene approvato dalle autorità europee, appoggiate dagli Usa, con
una dichiarata funzione anti-russa, per creare un’alternativa al metano della
Gazprom. Ma ora i documenti mettono in dubbio questa giustificazione
geo-politica: il gigante russo Lukoil, infatti, è entrato con il 10 per cento
nel consorzio guidato da Bp e dalla società azera Socar per sfruttare il
giacimento di Shah Deniz 2, proprio quello del Tap. Mentre alcune
intercettazioni italiane autorizzano a pensare all’esistenza di accordi
sotterranei anche con altre società russe. Controllate da oligarchi fedeli al
presidente Vladimir Putin. Nel febbraio 2009 l’imprenditore pugliese Giampaolo
Tarantini viene registrato al telefono, nell’inchiesta sulle escort di
Berlusconi, mentre parla con Roberto De Santis, un manager legato all’ex premier
Massimo D’Alema. Nel colloquio, già pubblicato dall’Espresso, De Santis chiede
aiuto a Tarantini per ottenere il via libera del governo Berlusconi a un
progetto «enorme», dove «la società capogruppo si chiama Tap». Ora è possibile
capire i retroscena di quell’intercettazione. Intervistato dalla tv pugliese
Telerama, De Santis ha giustificato così le sue parole sul gasdotto: «Ero
consigliere d’amministrazione della società Avelar, che aveva interesse nel Tap,
ma dal 2010 in poi non ne ha più avuto, perché non ha più ritenuto opportuno
continuare in quella avventura imprenditoriale... Avelar aveva degli accordi con
la svizzera Egl, che poi sono venuti meno nel 2010». Il problema è che Avelar
non è mai comparsa ufficialmente nel Tap. È una società svizzera creata dal
miliardario Viktor Vekselberg, titolare del colosso Renova e vicinissimo a
Putin, per investire nelle energie rinnovabili. Per sbarcare in
Italia, Vekselberg ha inserito nella Avelar due manager senza alcuna esperienza
nell’energia, ma con forti agganci politici a destra e a sinistra: il dalemiano
De Santis, appunto; e un grande amico di Marcello Dell’Utri, Massimo Marino De
Caro, come vicepresidente esecutivo. De Caro è stato poi arrestato e condannato
per il colossale furto di libri antichi nella biblioteca dei Girolamini a
Napoli. Quell’inchiesta nata a Firenze ha anche rivelato che De Caro, dopo aver
ricevuto un bonifico milionario dalla Avelar, ha girato oltre 400 mila euro a
Dell’Utri, per motivi rimasti oscuri, mentre l’ex senatore di Forza Italia era
ancora libero, in attesa della condanna definitiva per mafia. Finora si ignorava
che un oligarca amico di Putin, attraverso l’italo-svizzera Avelar, avesse
stretto accordi, mai rivelati, sul gasdotto anti-russo. Ad aumentare il tasso di
misteri attorno al Tappensano anche i Panama Papers . I documenti offshore
ottenuti dal consorzio giornalistico Icij, di cui fa parte L’Espresso in
esclusiva per l’Italia, mostrano che tra i clienti dello studio Mossack Fonseca
(i cui titolari nel frattempo sono stati arrestati a Panama) compare anche il
manager più importante della Tap Ag svizzera. Si chiama Zaur Gahramanov, è nato
nel 1982 in Azerbaijan e occupa ruoli cruciali in tutte le società chiave del
maxi-gasdotto: è dirigente di grandi aziende del gruppo Socar, il colosso
petrolifero dello Stato azero; consigliere d’amministrazione dei gasdotti Tap e
Tanap; e gestore di varie società estere, tra cui la cassaforte svizzera che
gestisce i profitti miliardari di gas e petrolio. Nella sua posizione di super
manager di Stato, dovrebbe avere qualche problema ad aprire società offshore,
cioè casseforti anonime utilizzabili per nascondere denaro nero e azzerare le
tasse (o peggio). Invece il 18 febbraio 2011 lo studio di Panama registra
proprio Gahramanov come azionista di una società offshore delle British Virgin
Islands, chiamata Geneva Commodities International Ltd. La società è gestita da
un fiduciario elvetico e tutti gli atti vengono trasmessi in Svizzera, spesso su
richiesta di una banca. Gli altri due soci della offshore sembrano fiduciari di
altri soggetti che vogliono restare nell’ombra: sono un professionista tedesco
residente in Svizzera e un russo con domicilio in Israele. Nello studio Mossack
Fonseca, accanto al certificato azionario, ci sono tutti i dati personali del
manager azero dei gasdotti. Il timbro della società anonima ha un disegno con
tre spighe di grano. Sembra quasi un programma: con le offshore c’è grano per
tutti. La cassaforte segreta delle Isole Vergini viene resa inattiva il 12
settembre 2014, con una singolare coincidenza di date: proprio quel giorno il
governo di Enrico Letta approva la valutazione d’impatto ambientale del Tap. La
stessa autorizzazione ministeriale ora convalidata da un’autorevole sentenza del
Consiglio di Stato. Che sarebbe stata ancora più autorevole se, a guidare il
collegio, fosse andato un togato diverso dall’espertissimo burocrate scelto dal
governo Renzi come presidente aggiunto del Consiglio di Stato: Filippo Patroni
Griffi, ex ministro e poi sottosegretario dello stesso esecutivo che ha
approvato il Tap.
Cos'è la Tap, il mega gasdotto che tanto
piaceva all'amico di D'Alema. Il parlamento sta per
dare il sì definitivo al progetto del gasdotto che dall'Azerbaijan arriverà in
Puglia. Ma ai sindaci e agli abitanti della costa salentina l'idea non piace:
temono infatti che la stutttura danneggi le coste. Tarantini e De
Santis parlavano dell'affare già nel 2009. Ma c'è chi protesta. E chi teme la
nascita di un altro movimento stile no-tav e infiltrazioni violente, scrivono
Emiliano Fittipaldi e Chiara Spagnolo il 29 novembre 2013 su "L'Espresso".
Gianpaolo Tarantini e Roberto De Santis sanno leggere nel futuro. Almeno così
sembra, a spulciare alcune intercettazioni del 2009, in cui il lenone di Silvio
Berlusconi e l’imprenditore che si autodefinì il «fratello minore» di Massimo
D’Alema chiacchieravano della guerra tra due gasdotti. «C’è un tubo che sbarca
dalla Grecia a Otranto, che è di Edison, e un altro tubo che sbarca dall’Albania
a Brindisi, che è quello su cui stavo lavorando io... La società capogruppo si
chiama Tap», spiegava De Santis parlando del progetto Trans Adriatic Pipeline,
un gasdotto che dovrebbe portare in Europa il metano dell’enorme giacimento
scoperto a Shah Deniz, in Azerbaijan. Tarantini si offre per parlarne con
Berlusconi: «Fammi uno schema di cinque righe, gliele do...al ministro
dell’Industria, a Scajola...Si mette a pecora quello». Era il febbraio 2009.
Quattro anni dopo, è chiaro che Giampi e De Santis avevano visto giusto: la
battaglia per il predominio sul cosidetto “Corridoio Sud” è stata vinta proprio
dal consorzio Tap a scapito del progetto Igi Poseidon, ideato da Edison
(controllata da maggio 2012 dalla francese Edf) e dai greci della Depa e
benedetto dal governo Prodi nel 2007. Se la Tap ha sempre smentito qualsiasi
rapporto con i due affaristi, di sicuro la politica ha fatto inversione a U.
Berlusconi ha appoggiato la Tap fin dall’inizio, ma anche Mario Monti prima ed
Enrico Letta poi si sono spesi con accordi intergovernativi e viaggi di lavoro a
Baku, capitale dello Stato caucasico. Così tra pochi giorni, dopo il sì del
Senato all’accordo italo-greco-albanese arrivato un mese fa con la sola
opposizione di Sel e M5S, la Camera dovrebbe dare l’ok definitivo al gas azero,
e i lavori per la costruzione del megacondotto che arriverà a Melendugno, in
Puglia, potrebbero iniziare già a gennaio 2015, in modo che l’impianto possa
essere operativo nel 2020. A patto - ovviamente - che il ministero dell’Ambiente
dia il beneplacito autorizzando la Via, la valutazione d’impatto ambientale
consegnata dal consorzio lo scorso 10 settembre.
ORO AZZURRO. In Salento si gioca una partita
gigantesca. Non solo da un punto di vista economico, ma anche geopolitico e
sociale. Nelle intenzioni di Palazzo Chigi la Tap contribuirà a trasformare
l’Italia in una sorta di “hub” europeo del metano, condizione che porterebbe -
questa la speranza - maggiore concorrenza sul mercato domestico e un
abbassamento dei prezzi al consumo: storicamente al Belpaese il metano costa
circa il 20 per cento in più rispetto quello che pagano i tedeschi. D’altra
parte, in Puglia il fronte del no è sempre più agguerrito: il gasdotto,
protestano decine di sindaci e il comitato “No Tap”, rischia di distruggere una
delle più belle coste dell’Adriatico. Fosse così, si farebbe a pezzi l’economia
di una zona che vive esclusivamente di turismo e eccellenze agroalimentari. Ma
quali sono davvero gli interessi e i player in campo? Tap è un acronimo che
nasconde una società anonima svizzera nata nel 2007 - il capitale sociale è di
149 milioni di franchi svizzeri - controllata oggi dalla compagnia di Stato
azera Socar, dalla British Petroleum, dalla norvegese Statoil (ognuna ha un
pacchetto pari al 20 per cento delle azioni), dalla belga Fluxys (16 per cento),
dalla francese Total (10 per cento), dai tedeschi di E.On (9 per cento) e dalla
svizzera Axpo (5 per cento). Colossi che da mesi stanno piazzando pubblicità su
siti Internet e giornali pugliesi per cercare di spiegare alla popolazione
locale la bontà del progetto. «Il percorso del gasdotto», ha spiegato il
sottosegretario allo Sviluppo economico Claudio De Vincenti, «dovrebbe
svilupparsi lungo la Grecia e l’Albania per approdare in Italia. Sarà lungo 800
chilometri circa, di cui 105 sottomarini nel mar Adriatico, e trasporterà 10
miliardi di metri cubi l’anno, ma la società prevede di raddoppiarli». Una volta
arrivato a San Foca, a poca distanza da Otranto, il progetto prevede la
costruzione di un «microtunnel per l’attraversamento della linea di costa lungo
circa un chilometro e mezzo, una condotta interrata in terraferma di 10
chilometri e un terminale di ricezione» da edificare a Melendugno. La pipeline
dovrebbe collegarsi infine alla rete nazionale gestita da Snam, in modo da poter
far arrivare il gas del caucaso anche nel resto d’Italia e d’Europa. Nel
progetto, però, non ci sono ancora dettagli sull’allaccio finale: ben 58
chilometri separano il terminal da Mesagne, che è il più vicino snodo di
raccordo di Snam. «Una carenza di unitarietà del progetto», attacca il comune di
Melendugno, che renderebbe «impossibile» ai vari uffici preposti quantificare le
reali ricadute ambientali sul territorio.
TUTTI CONTRO TUTTI. La Tap, conquistando i favori
degli azeri lo scorso giugno, in un solo colpo ha sbaragliato non solo la
vecchia ipotesi del gasdotto Igi Poseidon di Edison (che secondo il progetto
dovrebbe approdare nel porto di Otranto), ma anche l’altro concorrente del
“Corridoio Sud”, cioè il “Nabucco”, metanodotto che dal Mar Caspio sarebbe
dovuto arrivare fino in Austria. Un progetto fortemente appoggiato dagli Usa per
danneggiare il quarto progetto in gara, quello chiamato “South Stream”, promosso
da Gazprom per portare in Europa, passando sotto il Mar Nero con arrivo a
Tarvisio in Friuli, il combustibile made in Russia. Un mega gasdotto già in fase
di realizzazione a cui partecipa, con il 20 per cento, anche la nostra Eni, da
anni sponsor importante dell’azienda preferita da Vladimir Putin. È questo il
motivo, spiegano fonti interne dell’azienda guidata da Paolo Scaroni, «per cui
non siamo entrati nella Tap: anche se tra Baku e Mosca le relazioni sono buone,
il progetto è di fatto concorrente al “South Stream”, e noi non vogliamo far
innervosire i nostri soci russi». Sarà un caso, ma nessun colosso energetico
nostrano, nonostante i tentativi della Socar che si sentirebbe maggiormente
garantita da una partecipazione italiana, sembra interessata ad investire in
azioni Tap: l’ad della Snam Carlo Malacarne ha ripetuto che le uniche attività
che gli interessano sono quelle relative «al conferimento del gas nella rete di
trasporto», mentre Fulvio Conti di Enel ha annunciato che potrebbe acquistare la
materia prima, ma nulla di più. Un paradosso, visto che la Tap è un affare
miliardario che potrebbe far arrivare in Italia circa il 10 per cento del nostro
fabbisogno, oggi garantito dalle importazioni dall’Algeria (che pesa per il 35
per cento sul totale), dalla Russia (il 30 per cento) e - in misura minore -
dalla Libia.
VIVA LA TAP, ABBASSO LA TAP! La diversificazione
delle fonti d’approvvigionamento, secondo la Commissione europea, è fondamentale
da un punto di vista strategico. Anche gli Stati Uniti, che nel 2007 hanno
definito come loro interesse prioritario «impedire l’unione energetica di Russia
ed Europa», guardano con favore alla Tap: dopo il fallimento del “Nabucco” il
gasdotto azero è per ora l’unico concorrente di Gazprom rimasto in campo. Tutti
sembrano assai soddisfatti: Enrico Letta, che è andato ad agosto in Azerbaijan
per incontrare il chiacchierato premier Ilham Aliyev (succeduto nel 2003 al
padre), ha spiegato che «questo gasdotto è importante non solo per il futuro
dell’Italia ma per l’intera Ue». Per palazzo Chigi anche i pugliesi dovrebbero
mostrarsi felici: secondo il ministero dello Sviluppo economico non solo la Tap
investirà in progetti locali («Come un intervento di tutela della costa
dall’erosione costiera da 5 milioni di euro»), ma nella fase di costruzione
l’opera tra lavori diretti e giro d’affari dell’indotto porterà al Pil regionale
«290 milioni euro in più l’anno e circa 2 mila posti di lavoro». Che però
diventeranno appena 220 nella fase successiva, quella della semplice gestione
dell’infrastruttura. Se a Roma, Bruxelles e Baku sono in molti a mostrare
entusiasmo, altri nutrono invece alcuni dubbi sul reale impatto del metanodotto
sulla nostra economia: per Davide Tabarelli, direttore di Nomisma Energia, la
portata del gasdotto sarebbe «troppo bassa, mentre gli azeri non potranno fare
grossi sconti rispetto ai russi». L’effetto sulle bollette di cittadini e
imprenditori, in pratica, potrebbe essere minimo. I danni sull’ambiente e sul
business del turismo, temono invece i salentini, rischiano di essere enormi. La
Regione guidata da Nichi Vendola per ora nicchia spiegando di non avere voce in
capitolo sulle scelte di Palazzo Chigi, ma in provincia di Lecce 11
amministrazioni comunali e 35 tra associazioni e comitati si sono già schierate
con il movimento No Tap, che da mesi protesta contro la costruzione dell’opera.
Che, tra emissioni, condotte, tunnel e terminal, secondo un contro-studio
preparato da un pool di esperti coordinati dal professor Dino Borri, ordinario
del Politecnico di Bari, rischia di mettere a rischio migliaia di ulivi (che la
Tap dice di voler ripiantare), l’assetto idrogeologico della costa, una spiaggia
e un’oasi protetta, senza parlare dell’ecosistema che vede, tra le specie a
rischio, cetacei e tartarughe caretta caretta. Tra Ilva di Taranto e siti
d’interesse nazionale come Brindisi e Manfredonia la Puglia è una delle zone più
avvelenate d’Italia, e i residenti sono preoccupati per possibili nuove fonti
d’inquinamento, anche se sia Tap che il governo hanno promesso che l’impatto
ambientale sarà «praticamente nullo». Il movimento non ci crede, ed è deciso a
far saltare il progetto a ogni costo. O, quantomeno, a far cambiare l’approdo
finale. Finora manifestazioni e sit-in si sono svolti senza alcun problema di
ordine pubblico, ma la Digos teme che in futuro il fronte del no possa essere
infiltrato da gruppi anarchici provenienti dalla regione, ma non solo: negli
ultimi cortei anti-Tap si sono visti anche volantini dei No Tav piemontesi. La
lotta d’altronde è simile, e l’obiettivo comune. «Se si usa qui nel Salento la
stessa determinazione e la stessa unanimità della Val Susa», ha ragionato lo
scrittore Erri De Luca in visita a Melendugno, «non si farà neanche la Tap».
Tap: tutti d'accordo, ma chi ci guadagna?
Il premier Renzi dà l’ok al Trans Adriatic Pipeline,
che trasporterà il metano dall’Azerbaijan alla Puglia. I costi di realizzazione
peseranno sulle bollette e servirà soprattutto ai nostri alleati, scrive Stefano
Vergine il 25 settembre 2014 su "L'Espresso". Indipendenza dalla Russia e
risparmio sulle bollette. Sono questi i vantaggi promessi dal Trans Adriatic
Pipeline, meglio noto come Tap, il gasdotto che punta a portare in Italia il
metano dell’Azerbaijan. Un serpentone d’acciaio che attraverserà Grecia e
Albania prima di arrivare sulla spiaggia di San Foca, a Melendugno, il paesino
del Salento scelto come punto di approdo. Dopo mesi di attesa, venerdì 12
settembre il progetto ha ricevuto il via libera dal ministero dell’Ambiente
italiano. L’iter autorizzativo è ancora lungo, ma il governo sembra deciso a non
farsi fermare dall’opposizione di sindaci e comitati locali. Non a caso il
premier Matteo Renzi ha programmato per sabato 20 settembre una visita a Baku,
la capitale dell’Azerbaijan, per annunciare al presidente-padrone dello Stato
caucasico, Ilham Alyev, che l’opera si farà. Resta da capire se il tubo della
discordia ci renderà davvero più indipendenti dal gas di Vladimir Putin. E se i
consumatori beneficeranno di prezzi più bassi. Questioni rilevanti, poiché molti
pugliesi temono che l’infrastruttura possa rovinare l’ambiente e far fuggire
così i turisti. Insomma, la domanda è se gli eventuali danni sulla zona di
Melendugno saranno compensati dai benefici che il Tap porterà all’Italia.
Per giustificare la costruzione dell’opera, il
governo ha sempre puntato su un concetto: allentare la dipendenza dal metano
russo. Un’esigenza diventata ancora più pressante negli ultimi mesi, vista la
guerra combattuta a colpi di sanzioni economiche tra l’Unione europea e gli
Stati Uniti da una parte e Mosca dall’altra. Ma davvero l’Italia è così legata
alle forniture di Gazprom? E in che misura il Tap potrà contribuire ad allentare
questo vincolo? Meglio dirlo subito: se tutto andrà come previsto, il tubo sarà
pronto nel 2020, quindi non servirà se quest’inverno Mosca dovesse decidere di
lasciare tutti al freddo. Per capire come andranno le cose in futuro bisogna
invece guardare al passato. Snam, la società che gestisce quasi tutti i gasdotti
nazionali, dice che l’anno scorso l’Italia ha consumato 70 miliardi di metri
cubi di gas, di cui 25 provenienti dalla Russia. Il Tap, almeno inizialmente, ne
porterà in Italia 8. Dunque, l’oro azzurro dell’Azerbaijan potrebbe sostituire
al massimo un terzo di quello russo. Potrebbe, appunto. Perché la Strategia
energetica nazionale, disegnata nel 2013 dal governo Monti, immagina per
l’Italia il ruolo di hub europeo del gas. Vale a dire che il metano proveniente
dall’estero non resterà tutto qui, ma servirà in buona parte per scaldare le
case di tedeschi, austriaci e olandesi. «Quegli 8 miliardi di metri cubi
provenienti dall’Azerbaijan», fa notare Matteo Verda, ricercatore dell’Istituto
per gli studi di politica internazionale (Ispi), «sono esattamente la stessa
quantità che il nostro governo prevede di esportare nel 2023 in Nord Europa».
Certo, in situazione di emergenza - se cioè la Russia dovesse chiudere i
rubinetti - potremmo tenerci quel gas. Ma che cosa ci guadagna l’Italia
nell’immediato? Le tariffe di transito pagate a Snam. Che è una società a
controllo pubblico. E che, secondo Verda, per gli 8 miliardi di metri cubi
targati Azerbaijan dovrebbe incassare ogni anno 200 milioni di euro. Il gioco
sarebbe a somma positiva, non fosse che per portare verso le Alpi tutto quel gas
Snam deve ampliare il tubo che collega Brindisi alla Pianura Padana. Secondo
Giuseppe Rebuzzini, analista della società d’investimenti Fidentiis, «il
potenziamento della Dorsale Adriatica comporterà un investimento di circa 1
miliardo. Chi paga? Tutti, dato che il costo sostenuto da Snam finirà in
bolletta, ma sarà un aumento davvero basso: molto meno di un centesimo di euro
per metro cubo di gas». Dicono però i sostenitori del Tap che la piccola gabella
verrà compensata dalla riduzione delle tariffe energetiche. Vero? In teoria
sì. Il gas proveniente dall’Azerbaijan aumenterà infatti l’offerta sul mercato,
e questo dovrebbe portare a una discesa dei prezzi. Ma il sillogismo dipende da
una variabile: il costo del gas di Shah Deniz. Il giacimento azerbaigiano da cui
uscirà il metano è controllato da un consorzio i cui soci principali sono
l’azienda locale Socar e l’inglese Bp, che è anche l’operatore dei pozzi. Le
stesse società risultano tra gli azionisti di maggioranza del Tap. Fra spese per
l’estrazione e per la costruzione dei tubi fino all’Italia (non c’è solo il Tap
ma anche il Tanap, la condotta che attraverserà la Turchia), l’investimento
previsto è di 45 miliardi di dollari. Tutti soldi privati, assicurano le società
coinvolte nel consorzio. Che dicono di aver già stipulato con nove operatori,
tra cui l’italiana Enel, contratti della durata di 25 anni, e del valore totale
di 200 miliardi di dollari, per la vendita del gas in Europa. Ma alla fine
quanto costerà ai consumatori questo gas? Una stima l’ha fatta Luigi De Paoli,
docente di Economia dell’Energia alla Bocconi: «Considerando una remunerazione
del capitale investito del 10 per cento, il costo potrebbe arrivare a circa 0,3
dollari al metro cubo. Questo valore, a cui vanno aggiunti quelli operativi di
trasporto, non è molto diverso dal prezzo attuale del gas in Italia
all’ingrosso. Insomma, per vendere il proprio metano a un prezzo competitivo il
governo di Baku dovrebbe rinunciare quasi totalmente ai suoi guadagni, oppure
una parte significativa dei ricavi dovrebbe provenire dalla vendita dei
condensati che vengono recuperati con il metano». Come dire che i risparmi in
bolletta probabilmente non ci saranno. E poco importa se alla fine Azerbaijan e
soci riusciranno a trovare una formula per rendere l’investimento redditizio.
«La storia secondo cui qualcuno porta gas sul mercato e lo vende a prezzi bassi
è un falso mito», dice Rebuzzini, «una discesa significativa si avrebbe solo in
caso di eccesso di offerta, ma gli operatori non sono così stupidi da
distruggere il mercato». Viene allora da chiedersi perché l’Italia deve
rischiare di rovinare un’area a vocazione turistica. Per la sicurezza
energetica, è la risposta degli esperti. Non tanto quella dell’Italia, però, ma
quella dell’Unione europea. Che grazie al gas azero, a cui prima o poi potrebbe
aggiungersi quello del Medio Oriente, potrà diventare più indipendente dalle
forniture di Mosca. Una visione in cui il singolo Stato mette da parte
l’interesse particolare a beneficio dell’intera comunità. Non proprio quello che
succede da anni con la crisi del debito, dove i Paesi più in salute, Germania in
testa, si rifiutano di sacrificare il proprio benessere per sollevare le
economie più deboli. Chissà se il Tap diventerà un’arma per convincerli a
cambiare idea.
L’opposizione intransigente al gasdotto
Tap e i suoi molti motivi, scrive Jacopo Giliberto il
28 marzo 2017 su "Il Sole 24 ore". Sei mesi fa l’Acquedotto Pugliese completò
un’opera colossale: posò in mezzo all’intero Salento la conduttura del Sinni, la
meraviglia di 37,5 chilometri di tubo tra Salice Salentino e Seclì. Il diametro
della condotta è 1 metro e 40 centimetri, un adolescente potrebbe camminarci a
testa alta. La cerimonia avvenne a Seclì il 7 settembre e impugnando le forbici
inaugurali il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlò
entusiasta della grande tubazione. Per posare sotto il terreno quelle decine di
chilometri di condotta, la società guidata da Nicola De Sanctis ha dovuto
traslocare 2.500 olivi. In lettere: duemilacinquecento. Furono sradicati,
depositati in un vivaio, e poi richiuso lo scavo ripiantati dov’erano. Ora il
presidente della Regione ha sotterrato il nastro inaugurale e la forbice e
invece ha dissotterrato l’ascia di guerra. Il tubo questa volta porta non acqua
bensì metano dall’Asia all’Europa e Michele Emiliano sostiene i comitati nimby
contro il gasdotto Tap. Secondo Emiliano sarebbe assai meglio se la conduttura
che importerà il metano dall’Azerbaigian prendesse terra in Puglia altrove, a
Squinzano, devastando in mare una folta prateria di posidonia (una pregiata
pianta acquatica) e un’area protetta. Prima di scegliere il luogo dove far
approdare il tubo, è stata esaminata una ventina di diversi punti della costa
salentina, da Brindisi a Otranto. La spiaggia in contrada San Basilio — frazione
San Foca, comune di Melendugno, provincia di Lecce — pur delicata è la meno
vulnerabile fra tutte. La considerazione di Emiliano è che più a nord approderà
la tubazione, meno conduttura bisognerà posare attraverso il Salento per
allacciare il Tap alla dorsale nazionale della Snam. Se il tubo arriverà a
Melendugno, come da progetto, bisognerà posare un’altra cinquantina di
chilometri di condotta verso nord. Se la tubatura farà più strada in mare e
prenderà terra a Squinzano, come propone Emiliano, il metano sarà assai più caro
(posare in mare una tubazione costa uno sproposito in più) e saranno devastate
le zone più pregiate, ma poi ci sarà meno percorso fra gli olivi. Con ogni
probabilità, il presidente Emiliano ha più obiettivi. Non solamente vuole
indurre un ritardo e ridurre il percorso a terra (a scapito dei costi e dei
danni ambientali a mare) ma anche fare arrivare il metano alla centrale Enel di
Cerano e all’acciaieria Ilva di Taranto, oggi alimentate con il carbone. E
infine, il presidente vuole forse solleticare il consenso dei movimenti che
temono un modello di sviluppo più sostenibile.
I No Tap non li ferma neppure il
Consiglio di Stato. Questa mattina circa 300
manifestanti hanno tentato di nuovo di bloccare l'espianto degli ulivi e ci sono
stati momenti di tensione con le forze dell'ordine. Per Emiliano non è Nimby,
"basterebbe spostare l'approdo a Squinzano", scrive Maria Carla Sicilia il 28
Marzo 2017 su “Il Foglio”. Nella tensione generale dovuta ad un nuovo tentativo
di blocco del cantiere, sono ripresi questa mattina i lavori del gasdotto Tap a
Melendugno. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso
della Regione Puglia e del Comune di Melendugno contro la sentenza del Tar sul
Trans Adriatic Pipeline, è arrivata questa mattina anche una nota del ministero
dell'Ambiente. Chiamato in causa la scorsa settimana dalla Prefettura di Lecce,
il ministero ha chiarito con una lettera che l'operazione di espianto dei 211
ulivi è legittima. Gli alberi saranno infatti ripiantati non appena terminata la
posa del tubo, che approderà a Melendugno dall'Azerbaigian, attraversando
Geogia, Turchia e Grecia per approvvigionare l'Europa di gas. A tentare
nuovamente di bloccare l'avvio dei lavori questa volta erano circa 300
manifestanti, attivisti del movimento "No Tap" - cittadini e politici locali -
che hanno presidiato il cantiere dall'alba. Verso le 7,30 i lavoratori del
cantiere sono comunque riusciti ad entrare tra le urla e le proteste con
l'intervento della polizia, che staziona nella zona del cantiere con una decina
di mezzi. Nel corso della mattinata sono stati diversi i momenti di alta
tensione tra la polizia e i manifestanti. Secondo l'AdnKronos la polizia ha
liberato le vie di accesso spostando di peso le persone e avanzando con scudi
protettivi, dopo gli inviti inascoltati a non ostacolare le operazioni. È stata
poi ripristinata la calma anche se il presidio rimane e non c'è intenzione da
parte dei manifestanti di rimuovere il blocco. "Il dispiegamento di forze
sproporzionato che è presente sul territorio in questo momento è stato un modo
per dimostrare che si le opere si fanno anche passando sulla testa della
popolazione" ha detto il sindaco di Melendugno su RaiNews24. "Non c'è nessun
effetto Nimby - ha spiegato invece il governatore della Puglia Michele Emiliano,
ospite di RaiNews24 - tutti o quasi riconoscono l'utilità dell'opera. Spostare
l'approdo nei luoghi indicati dalle istituzioni locali avrebbe risolto il
problema, ma il governo non ha voluto concedere questa vittoria politica alla
Regione Puglia. A San Foca si stanno confrontando non i manganelli della polizia
e le fasce tricolori dei sindaci, ma due diverse concezioni della politica.
L'una servile rispetto agli interessi dei grandi gruppi economici e dura e
severissima con i diritti dei cittadini. L'altra, basata sulla connessione tra
istituzioni e popolo a tutela dell'ambiente e della bellezza". L'approdo
alternativo a cui si riferisce Emiliano è più a nord, nell'area del comune di
Squinzano, che ha dato il suo consenso ad utilizzare il proprio territorio per
accogliere il rigassificatore. Il governatore della Puglia ha poi spiegato che
la Regione porterà avanti la battaglia legale in tutte le sedi possibili.
"Ieri abbiamo dovuto incassare una pesante sconfitta giudiziaria da parte del
Consiglio di Stato. Pende ancora davanti alla Corte Costituzionale il ricorso
per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Puglia nei confronti del
Governo per non aver dato neanche una risposta alla Regione sulla richiesta
di revoca dell'autorizzazione unica, per non averla coinvolta sin dal momento
della presentazione del progetto da parte di Tap. In attesa della pronuncia
della Corte Costituzionale, che ove accogliesse le nostre richieste ci
consentirebbe di ridiscutere l'approdo Tap, abbiamo deciso di impugnare la nota
di ieri del ministero dell'Ambiente che "autorizza" Tap ad effettuare
le attività preparatorie alla effettiva fase di inizio dei lavori. La Regione
Puglia si riserva ogni ulteriore eventuale iniziativa giudiziaria finalizzata
alla modifica del punto di approdo. Aggiungo - ha concluso Emiliano - infine che
un'ulteriore battaglia si sta svolgendo a livello nazionale in sede di Via per
l'esame del progetto di microtunnel. In quella sede vigileremo con grande
determinazione per ottenere lo spostamento dell'approdo nell'area del comune di
Squinzano da noi indicata".
Tap, Vendola: “Protesta giusta, non è
sindrome nimby”, scrive Dire il 2 aprile 2017. “La
cosa che trovo più odiosa è che si classifichi la protesta della popolazione
salentina contro Tap come una insorgenza periferica della sindrome di Nimby.
Negli anni della mia presidenza alla Regione Puglia non siamo stati il
territorio del rifiuto, abbiamo detto sì alle energie alternative. Ma la
localizzazione di Melendugno l’abbiamo sempre ritenuta irricevibile, a questo
progetto io ho sempre detto no ponendo due paletti: la validazione
tecnico-scientifica e la validazione democratica”. Lo dice Nichi Vendola in
un’intervista sull’edizione pugliese di Repubblica. “Dopodichè non ci hanno dato
più la possibilità di esprimerci - prosegue l’ex governatore - Hanno cambiato
persino le leggi per togliere alle Regioni ogni possibilità di dire la propria.
L’elenco dei pareri negativi è lunghissimo. In realtà l’unico yes man è stato il
ministro dell’Ambiente, quello che avrebbe dovuto difendere il territorio.
All’epoca ha espresso pure parere negativo il Mibact”. “Il più grande esproprio
che governo e Tap stanno facendo è di tipo democratico. I loro sono solo atti di
autorità con sullo sfondo opacità da pelle d’oca, come quelle che si intuiscono
leggendo l’inchiesta de L’Espresso. La Regione fa bene a cercare vie legali e
politiche per riaprire la questione. E la protesta- conclude Vendola- è giusta:
c’è una comunità che si sente minacciata, e quello schieramento di polizia
contro le famiglie e le fasce tricolori è davvero una fotografia pessima”.
Schierati col “no” 94 sindaci, la
protesta continua. Replica di Tap alla lettera per Mattarella,
scrive Mauro Bortone su "Il Quotidiano di Puglia" Lunedì 3 Aprile 2017. Il
maltempo ha fermato ieri i lavori al cantiere ma non ha arrestato la protesta
dei No Tap a San Foca: la pioggia battente che dalla notte tra domenica e lunedì
è scesa sul Salento ha concesso una tregua alle operazioni di espianto degli
ulivi, sul tracciato dove dovrebbe sorgere il tunnel del gasdotto, ma non ha
scoraggiato gli attivisti del comitato “No Tap”, che, dopo il successo della
manifestazione di piazza Sant’Oronzo, si sono ridati appuntamento sin dalle
prime ore del mattino nella zona del presidio. La comunicazione che non
sarebbero ripresi i lavori è arrivata quasi subito, ieri mattina, ma è diventata
il pretesto per organizzare un nuovo corteo pacifico che dai cancelli del
cantiere ha raggiunto attorno a mezzogiorno la piazza di Melendugno: all’adunata
mattutina hanno partecipato almeno 500 manifestanti da ogni parte d’Italia, con
delegazioni della Campania, dell’Abruzzo, di Trieste, di Torino e della Val di
Susa coi rappresentanti del movimento “No Tav”, che da anni si oppongono al
progetto dell’Alta Velocità; c’erano studenti e bambini a dimostrazione di una
protesta, che supera le barriere generazionali. Sul cantiere di San Basilio non
mancano gli esponenti politici dai rappresentanti del Movimento Cinque Stelle a
quelli di Sinistra Italiana, col segretario nazionale, Nicola Fratoianni. Tra
loro anche Luca Casarini, storico leader del movimento “No global”. «È dovere
della politica e delle istituzioni – ha dichiarato Fratoianni - ascoltare il suo
popolo. Non si governa contro il popolo, si governa col popolo. Bisogna avere il
coraggio di fermarsi, riaprire un confronto, una discussione, non é troppo
tardi, come si va invece ripetendo». Uno striscione polemico è stato esposto
all’esterno del cantiere contro la viceministro per lo Sviluppo economico,
Teresa Bellanova, con un invito alle dimissioni. A livello istituzionale, sono
94 su 97 totali le amministrazioni comunali che hanno aderito alla lettera
inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al premier, Paolo
Gentiloni. All’appello mancano solo Galatina, Parabita (entrambi enti
commissariati) e Otranto, che ha approvato in passato un gasdotto alternativo a
Tap, ovvero l’Igi-Poseidon dell’Edison spa. Hanno firmato la missiva diversi
consiglieri regionali e parlamentari del territorio: «Sta crescendo in tutti –
ha puntualizzato il sindaco di Melendugno Marco Potì - una consapevolezza,
quella che ogni decisione debba passare necessariamente dall’ascolto della
comunità locale». Si parte, dunque, da una questione di metodo, per arrivare a
quella di merito, che, come ribadito in più occasioni, riguarda
l’incompatibilità dell’opera con la vocazione turistica del territorio. Sono
concetti ribaditi proprio nella missiva inviata al Capo dello Stato, in cui si
chiede la sospensione di ogni attività in corso e un passaggio tecnico-politico,
propedeutico all’individuazione di una soluzione alternativa. Ma Tap, in una
nota, replica proprio alla lettera dei sindaci indirizzata a Mattarella,
provando a confutare alcune delle critiche mosse nel testo, dove si legge che «i
gasdotti sono infrastrutture compatibili con i territori che attraversano e
rispettose dell’ambiente» senza «alcuna interferenza con le attività agricole e
turistiche» e che «l’uso del tunnel sotterraneo per l’attraversamento della
fascia costiera permette la realizzazione dell’opera senza alcuna interferenza
diretta sulla spiaggia, sugli ambienti protetti a mare e terra»; e ancora che
Tap, «nello studio di Impatto Ambientale e Sociale, ha preso in considerazione
tutti i siti di interesse ambientale e storico archeologico» dell’area e che il
«terminale di Ricezione non produce emissioni durante il suo normale
funzionamento» ma solo alcune definite «occasionali» per «un massimo di 160 ore»
e «ben al di sotto dei limiti di legge e comunque equivalenti alle emissioni
annuali di circa 96 caldaie domestiche». Inoltre, l’azienda respinge l’accusa di
non aver ascoltato le comunità locali, puntualizzando di aver affrontato oltre
1000 incontri con tutte le parti interessate dal progetto sul territorio: “Tra
questi – scrivono - purtroppo non è possibile annoverare incontri con
l’amministrazione comunale di Melendugno, che Tap ha sempre cercato per un
confronto serio, duraturo e costruttivo sul progetto”. Dall’azienda ribadiscono
di voler “esercitare un ruolo attivo nella crescita del territorio” di cui “si
sente già parte e farà parte per almeno i prossimi cinquant’anni”. Argomenti,
che non sembrano, però, far breccia nella comunità locale. Intanto arriverà oggi
il verdetto della Corte costituzionale sul ricorso per conflitto di attribuzione
presentato dalla Regione nei mesi scorsi: un’ulteriore tappa del complesso
incastro giudiziario che gravita attorno alla vicenda Tap.
Potì: «Si poteva cambiare ma Tap e
governo imposero San Foca», scrive Oronzo Martucci su
"Il Quotidiano di Puglia", Domenica 2 Aprile 2017. «La mobilitazione spontanea e
pacifica di semplici cittadini, anziani e donne accompagnate da bambini, senza
etichette politiche ha portato il prefetto a sospendere le attività. Ha prevalso
il buonsenso, perché le condizioni in cui si svolgeva la protesta, compresa
l’alta temperatura, potevano degenerare»: il sindaco di Melendugno, Marco Potì,
così racconta la mattinata di ieri, quando decine di poliziotti in tenuta
antisommossa erano schierati a San Foca, nella zona degli espianti degli ulivi,
dove Tap vuole realizzare l’approdo del gasdotto. Sindaco Potì, a proposito
della politica, i rappresentanti politici del Salento sono impegnati in queste
ore in un riposizionamento, per cui chi era a favore dichiara di essere
contrario e viceversa.
«Non so a chi si riferisce, però ho preso atto che
molti politici salentini non hanno sulla vicenda Tap il dono della coerenza. La
coerenza dovrebbe essere un valore, purtroppo non è così. Posso fare un
esempio?».
Lo faccia.
«Il viceministro Teresa Bellanova nel 2013
partecipò a una manifestazione per sostenere la sua avversione all’approdo di
Tap a San Foca. La sua posizione, come quella di tanti altri, era: sì al
gasdotto, ma non a San Foca. Dopo aver ottenuto incarichi governativi è per il
sì al gasdotto a San Foca. Vendola ed Emiliano sono rimasti sempre sulla stessa
posizione: sì al gasdotto, non a San Foca. Io, al contrario, sono per il no al
gasdotto a San Foca e in qualunque altro posto».
Vendola ed Emiliano sono contrari all’approdo
di San Foca, ma non sono riusciti a indicare un approdo alternativo.
«Le scelte relative all’approdo sono di competenza
della società, la quale sottopone il progetto ai diversi controlli per ottenere
ad esempio la Valutazione di impatto ambientale favorevole. La Regione ha sempre
detto no all’approdo di San Foca, sia con la Via regionale che nella Conferenza
di servizi e nel tentativo di conciliazione per superare il dissenso esperito da
Palazzo Chigi. Per la verità anche il Ministero dei Beni culturali disse no
all’approdo di San Foca. Ma Renzi diede il via libera».
Era possibile a suo parere individuare un sito
diverso? La società Tap ha ha sempre sottolineato che vi erano tempi da
rispettare per la realizzazione del gasdotto.
«Il punto è proprio questo. Il governo ha assunto
come riferimento solo e soltanto il punto di vista di Tap, la quale sottolineava
la impossibilità di esperire nuove indagini ed effettuare lo studio di una nuova
localizzazione perché ci sarebbero voluti almeno due anni per arrivare alla Via.
Ricordo che questi ragionamenti, condivisi dal governo, venivano sviluppati tra
il 2014 e il 2015. Sono passati quasi tre anni e il problema non è stato
risolto. Quindi il tempo per ragionare c’era».
Qualcuno sostiene che l’arrivo di Tap a
Melendugno è stato facilitato da Vittorio Potì, suo parente, anche lui sindaco
di Melendugno. Così si spiega l’abbandono dell’approdo di Lendinuso, sul quale
la società sembrava orientata sino al 2009.
«Mio zio, come quelli che lo hanno conosciuto
sanno, era persona disponibile ad esperire ogni tentativo per risolvere problemi
e per il bene della collettività. È vero che promosse un incontro tra esponenti
dei gruppi di maggioranza e di opposizione di Melendugno con i tecnici di Tap.
Ma la decisione di spostare l’approdo a Melendugno era stata già assunta,
abbandonando il sito di Lendinuso, come ha detto in più occasioni l’ex
vicepresidente della Regione Sandro Frisullo. Ricordo anche che mio zio un
giorno dell’estate del 2011 disse che il progetto di Tap gli sembrava troppo
grande e che lui non si sentiva le forze per contrastarlo. Due mesi dopo morì».
Resta il mistero sul trasferimento da Lendinuso
a San Foca.
«Nessuno mistero. Nel 2004 Tap aveva già studiato
il sito di San Foca e aveva trovato presenze di posidonia e altri habitat marini
che sconsigliavano l’uso di quel sito. Si cominciò allora a lavorare su
Lendinuso. Poi di nuovo su San Foca che fu scelto come sito di approdo perché
secondo le mappe presentate da Tap per ottenere la Via non vi era presenza di
posidonia, in caso contrario la localizzazione con minore impatto sarebbe stata
quella di Lendinuso. Ora, però, la stessa società ha depositato mappe dalle
quali risulta che anche a San Foca c’è posidonia. Con l’attuale documentazione
sarebbe stato scelto il sito di Lendinuso».
Potì, c’è il rischio che la protesta possa
degenerare?
«I cittadini sono pacifici, come le manifestazioni
di protesta. Ma il rischio, onestamente, c’è. In ogni caso voglio rassicurare i
turisti che sono affezionati a San Foca e alle altre sue marine che in ogni caso
qui durante l’estate non ci saranno cantieri, perché i lavori anche preparatori
da maggio a settembre non sono ammessi».
Bellanova: «L’approdo concordato con le
autorità locali. Emiliano parla solo ora», scrive
Vincenzo Maruccio su "Il Quotidiano di Puglia" Domenica 2 Aprile 2017.
Viceministro Teresa Bellanova, la protesta
contro l’individuazione del sito di San Foca-Melendugno è cresciuta e nel mirino
è finito il governo di cui lei fa parte. Perché nessuno ha fatto nulla per
cambiare approdo?
«Parto dai dati: in sede di autorizzazione
ambientale nazionale sono state valutate 11 alternative di località: San Foca è
risultato il sito meno impattante. Sempre in sede di Via nazionale, la Regione
Puglia, presieduta all’epoca da Nichi Vendola, non solo non ha proposto
alternative, ma è stata assente».
Eppure Lendinuso, a sud di Brindisi, è tra le
soluzioni indicate da subito, poi all’improvviso sparisce e spunta San Foca: un
giallo riferito ad un periodo di cui mancano atti e protagonisti. Cos’è
accaduto?
«Ricordo il plastico del tracciato di Tap con
approdo Lendinuso alla Fiera del Levante 2008. Non so cosa sia accaduto dopo,
non ero né a Melendugno né a Bari. So, però, che quando si firma il 27 settembre
2012 il memorandum italo-greco-albanese, presidente Monti, e successivamente ad
Atene il 13 febbraio 2013 l’accordo tra le Repubbliche di Albania, Grecia e
Italia, ratificato il 19 dicembre 2013 con atto dei ministri Bonino, Zanonato,
Saccomanni, nel glossario si indicano come approdo le vicinanze di Lecce. San
Foca è già cosa nota. Sono altri, ritengo, a doverci dire cosa sia accaduto».
Si è detto che cambiare sito avrebbe
compromesso l’intera opera: non le sembra un alibi?
«Senta, nel giugno del 2013 io e Salvatore Capone
interroghiamo il Governo. Il Mise, Ministro Zanonato, risponde così: “Anche
nella scelta della cabina terminale di approdo la società Tap ha studiato
insieme alle Autorità locali il miglior tracciato al fine di preservare il
territorio nella sua integrità paesaggistica. È prevalsa la scelta di collocare
la cabina nell’area del Comune di Meledugno, su terreno agricolo, al di fuori
dell’area vincolata”. Devo ripeterlo? Non mi risulta che sia mai stato
smentito».
Si fanno le varianti delle autostrade e delle
grandi opere ferroviarie. Perché non si poteva spostare di pochi chilometri
verso nord il gasdotto?
«Infatti tra il 2008 e il 2012, se stiamo ai fatti
conosciuti, l’approdo è stato spostato a sud, da Lendinuso a San Foca. In
accordo, diceva il Governo dell’epoca, con le autorità locali. Davanti a grandi
opere le comunità locali non cambiano idea continuamente».
Quando un territorio chiede di cambiare, chi
governa non dovrebbe trovare un nuovo punto di equilibrio tra le esigenze dello
sviluppo e quelle espresse dalla comunità? Ad esempio, la Tap a Lendinuso e la
riconversione di Cerano?
«Non c’è dubbio. Qui abbiamo avuto a disposizione
sei anni per discutere e negoziare. A un certo punto, però, le partite si
chiudono. Quella si è chiusa con la ratifica dell’accordo internazionale».
Al Governo Letta prima e al Governo Renzi si
imputa un comportamento pilatesco: ve ne siete lavati le mani?
«Rispondo solo di me. Io sono stata sempre vigile
e trasparente. Aver interrogato il Governo, essere andata a Melendugno guardando
negli occhi persone certo non benevole nei miei confronti, aver scelto da
parlamentare di non incontrare mai, pur tempestata di richieste e al contrario
di altri, l’azienda. Le sembrano atteggiamenti pilateschi? Io non direi».
Il fronte politico del no si è allargato e ora
include leader del suo stesso partito: cosa risponde al segretario Piconese che
parla di “silenzio preoccupante” dei parlamentari Pd sulla libertà violata dei
manifestanti?
«Se è per questo comprende anche autorevoli
rappresentanti di Forza Italia. Il partito dei “tengo famiglia” è l’unico, in
questo Paese, a non conoscere crisi».
Ma il Pd non è il partito che ha supportato per
primo le ragioni del gasdotto?
«Il Pd condivide la necessità di diversificazione
energetica e di abbandono delle fonti fossili. Il che significa servirsi del gas
nel periodo di transizione».
Michele Emiliano è schierato con il “no”: è
credibile o è solo una mossa per guadagnare consenso come dice qualcuno?
«Emiliano è stato presidente e segretario
regionale del Pd. Non ha mai convocato il partito con questo tema all’ordine del
giorno. Fuori tempo massimo fare i rivoluzionari non costa niente e rende molto.
Vale anche per i 5Stelle».
E i sindaci Pd anti-Tap che, per anni, sono
rimasti silenti?
«Capisco che in questo momento dire sì a Tap è
antipopolare. Il punto è questo. Qui non si tratta di difendere un’impresa
privata ma il fondamento stesso dell’idea di diritto e vorrei ricordare che se
un’azienda dimostra perfino nell’ultima sede di giudizio di avere tutte le
certificazioni in regola è quanto mai rischioso alimentare dubbi al proposito,
minando in questo modo la necessaria fiducia dei cittadini nei confronti delle
istituzioni e della magistratura. Il germe dell’antipolitica è qui. Chi lo
semina se ne assume tutte le conseguenze».
Il governo di Nichi Vendola aveva condiviso la
necessità del progetto e, ricostruzioni alla mano, era al corrente delle scelte
di Tap: oggi si smarca parlando di “sfregio a San Foca”. Che sinistra è questa:
di lotta e di governo?
«Appartengo alla vecchia scuola: per me la lotta è
una cosa seria e lo è anche il governo. Più passa il tempo e più mi riesce
difficile capire dove si inscriva Vendola».
Resta la domanda finale che si fanno tante
famiglie: il Salento, già terra di impianti siderurgici e di grandi centrali
elettriche, cosa ci guadagna dal gasdotto Tap?
«Aggiunga i campi di fotovoltaico, che
desertificano ettari ed ettari di terreno, e le pale eoliche anche dove le
valutazioni anemometriche non le giustificherebbero. Io mi sono battuta e sto
lavorando notte e giorno perché a Taranto salute, ambiente e lavoro si tengano.
Cerano è cosa più complessa di un tweet. Tap è considerata un’opera strategica
di interesse europeo e il Salento è Italia. Non è un caso se, ancora adesso, ho
enorme rimpianto ed enorme rispetto per Guglielmo Minervini che organizzò l’Open
Space Technology alle Cantelmo. Se, invece, di lavarsene le mani prima e
sventolare adesso slogan la Regione avesse svolto puntualmente il suo ruolo, il
Salento sarebbe stato meno solo e avrebbe discusso alla pari. Con Tap e con il
Governo nazionale. Senza svendersi né mercanteggiare ma, se necessario,
imponendo condizioni. Una classe dirigente fa questo».
Tutto quello che avreste voluto sapere
sul TAP (e non avete mai osato chiedere). Sradichiamo
alcuni dei pregiudizi su gasdotto pugliese. Che fine faranno gli ulivi
espiantati da TAP? Chi ha autorizzato la realizzazione del gasdotto? Rispetta le
norme di tutela ambientale del paesaggio? E soprattutto: ma alla fine questo TAP
serve o no? Scrive Giovanni Drogo venerdì 31 marzo 2017 su "Next Quotidiano”.
Due anni fa il progetto del tracciato del metanodotto SNAM Trans Adriatic
Pipeline (TAP) era al centro di fantasiose ipotesi di complotto secondo le
quali la Xylella era stata diffusa con lo scopo di rendere più facili le
operazioni di “sgombero” dei terreni che si trovano sul percorso del metanodotto
in modo da fornire una scusa agli operatori per poter abbattere gli ulivi. A
denunciare la strana coincidenza era proprio il Comitato NO Tap che aveva
scoperto che il metanodotto avrebbe attraversato alcune delle aree dove erano
stati registrati focolai di Xylella. Ma al di là delle ipotesi di complotto cosa
sta succedendo davvero in Puglia e perché si è arrivati allo scontro tra
manifestanti e forze dell’ordine in una delle aree dove la società sta
provvedendo all’espianto (quindi non all’abbattimento) di duecento ulivi?
Cos’è il TAP?
Il TAP è un metanodotto che fa parte del Corridoio
Meridionale del Gas – un concetto elaborato dalla Commissione Europea per
identificare nuove rotte di approvvigionamento di gas – l’opera quindi è la
parte finale di un progetto più ampio e che complessivamente è lungo quasi 4.000
chilometri. Il tracciato di TAP inizia al confine tra Grecia e Turchia dove il
gasdotto si collega Trans Anatolian Pipeline (TANAP) che a sua volta dopo aver
attraversato la Turchia si collega al South Caucasus Pipeline che attraversa
Georgia e Azerbaijan e ha origine dai giacimenti di metano sulla costa
azerbaigiana del Mar Caspio. TAP è lungo 878 km e attraversa Grecia, Albania, il
Mar Adriatico per arrivare in Italia dove si connette alla rete nazionale di
Snam. L’opera è realizzata completamente con contribuiti privati
(all’azionariato di TAP – che è un consorzio – partecipano SOCAR, Snam, BP,
Fluxys, Enagás ed Axpo). Lo scopo principale di TAP è quello di creare un nuovo
corridoio per l’approvvigionamento (italiano ed europeo) di gas metano in modo
da poter consentire una diversificazione degli approvvigionamenti energetici e
garantirne la sicurezza e la continuità. Il tracciato italiano del TAP sulla
terra ferma è lungo 8 chilometri per una larghezza massima della pista dei
lavori di 26 metri. TAP parte da San Foca per arrivare a Melendugno dove è stata
prevista la costruzione del Terminale di Ricezione. A scegliere tra le 15
varianti d’approdo proposte da TAP è stato il Ministero dell’Ambiente che ha
stabilito che il gasdotto avrebbe dovuto partire da San Foca, sulla costa
adriatica, per arrivare a Melendugno. TAP pagherà al Comune di Melendugno 500
mila euro l’anno di tasse per tutta la durata della concessione in cambio del
permesso a far passare il gasdotto sul suo territorio. Da Melendugno poi SNAM (e
non TAP) dovrà realizzare l’allaccio fino dal Terminale di Ricezione alla rete
nazionale di Snam a Mesagne. Il “progetto di interconnessione” però non è
compito di TAP ma della sola Snam ed inizierà solo una volta terminata la posa
del gasdotto di TAP, la lunghezza di questo secondo tracciato è di 56 km.
Chi ha autorizzato la costruzione dell’opera?
Il progetto è stato presentato nel 2012 e fino al
2014 le istituzioni locali hanno avuto la possibilità – nel corso di circa 167
incontri svoltisi con i vari rappresentanti locali – di fare una proposta
alternativa di approdo a TAP ma, fanno sapere da TAP, non è arrivata alcuna
proposta formale né dalla Regione Puglia né dai comuni interessati. Nell’agosto
del 2014 TAP ha ottenuto il via libera dalla Commissione Valutazione
dell’Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il
Ministero ha sottoposto a valutazione le varie soluzioni d’approdo proposte e ha
stabilito che TAP dovesse arrivare da San Foca. Durante la fase conclusiva della
Valutazione di Impatto Sociale e Ambientale (ESIA) è stato stabilito di limitare
l’impatto ambientale nel punto di approdo a San Foca, tra il lido di San Basilio
e lo stabilimento Chicalinda, tramite l’uso di un “micro tunnel” che partirà al
largo (quindi TAP non arriverà sulla spiaggia ma ci passerà sotto), lungo circa
1.500 metri, che passerà sotto la spiaggia a una profondità di 10 metri,
evitando qualsiasi interferenza sulle praterie di Posidonia oceanica e sul
cordone dunale, così come eventuali impatti visivi o interferenze con la
spiaggia e la ‘macchia Mediterranea’. Inoltre sono state stabiliti anche degli
interventi mirati a ridurre l’impatto del Terminale di Ricezione di
Melendugno sia dal punto di vista delle emissioni di CO2 sia per quanto riguarda
l’impatto visivo delle costruzioni sul tipico paesaggio pugliese. Tra le varie
opzioni è stato scelto Melendugno perché sul territorio del corridoio
all’interno del quale passerà il TAP non ci sono vincoli dovuti alla presenza di
Aree Protette naturali, Rischio idrogeologico (aree classificate PG3) o
Posidonia oceanica (per la parte costiera) e i vincoli PUTT/p (Piano Urbanistico
Territoriale Tematico “Paesaggio”) stabiliti dalla Regione Puglia nell’area sono
considerati compatibili con “gli aspetti costruttivi e operativi programmati per
il Progetto TAP”. A sancire la legittimità della realizzazione dell’opera e il
rispetto delle normative vigenti c’è la sentenza del Consiglio di Stato che ha
respinto i ricorsi presentati dal Comune di Melendugno e della Regione
Puglia contro la decisione della Commissione di Valutazione di Impatto
Ambientale.
Chi ha autorizzato l’espianto degli ulivi e che
fine faranno?
Sul tracciato del TAP nel quale sono in corso i
lavori attualmente sono stati individuati, nel corso delle indagini preliminari
condotte in questi mesi 211 alberi di ulivo che per consentire la posa del
metanodotto verranno espiantati (e non abbattuti), conservati in un luogo di
stoccaggio temporaneo appositamente preparato e al riparo da eventuali
contaminazioni da Xylella Fastidiosa e successivamente rimessi a dimora
nell’esatto punto in cui si trovavano in precedenza e che è stato appositamente
marcato e segnalato. Ad occuparsi dell’espianto e della messa a dimora
provvisoria delle piante, così come della cura e delle operazioni di
manutenzione è una ditta specializzata in operazioni agro-forestali il cui
progetto ha ricevuto il via libera dagli uffici dell’osservatorio fitosanitario
della Regione Puglia. TAP rende noto che si tratta di un’operazione che per le
ditte specializzate è ormai di routine visto che nella sola provincia di
Lecce ogni anno vengono espiantati e spostati 100 mila ulivi. Senza contare
tutti quegli ulivi secolari che vengono espiantati e venduti e finiscono per
diventare piante ornamentali nei giardini delle ville e delle case di cittadini
di altre parti d’Italia (e per i quali in pochi si stracciano le vesti). Va
anche sottolineato che la realizzazione dall’Acquedotto Pugliese – conclusasi un
anno fa – si è svolta con le stesse modalità ha richiesto lo spostamento e
ripristino di 2500 ulivi disposti lungo i 37 km del percorso della condotta
dell’acquedotto. Sull’intero tracciato del Tap dovrebbero essere spiantati, e
poi ripiantati a fine lavori, oltre 1.900 ulivi, su un totale in tutta la
Regione di circa 60 milioni.
Ma alla fine questo TAP serve o no?
Una volta capito che tutto si svolge secondo le
regole resta da chiedersi se TAP è un’opera utile o meno. Secondo TAP il
gasdotto renderà possibile il processo di decarbonizzazione della Puglia e una
transizione della produzione di energia elettrica verso l’utilizzo di fonti meno
inquinanti come appunto il gas. Secondo l’Unione Europea il Corridoio
Meridionale è di importanza strategica per affrancare il continente dalla
dipendenza dall’approvvigionamento di gas che proviene da paesi geopoliticamente
poco stabili. Per quanto riguarda il fabbisogno attuale del nostro Paese è pari
a 70 miliardi di metri cubi di gas all’anno, di cui 65 arrivano dalle
importazioni, in particolare da Algeria e Russia. TAP consentirà di aumentare di
9 miliardi di metri cubi la capacità massima di importazione (che è di 130 mld
di metri cubi) delle attuali linee di rifornimento. C’è quindi da chiedersi a
questo punto se questi nove miliardi di metri cubi in più siano davvero utili
all’Italia. Guardando le stime del fabbisogno di gas verrebbe da dire di no,
perché riusciamo ad importare tutto quello che ci serve. Questo però vale per
oggi e non per il futuro e non è chiaro quanto potrebbe incidere sul fabbisogno
l’abbandono dell’utilizzo del carbone nelle centrali elettriche. Secondo TAP il
gasdotto potrebbe far fronte al surplus della domanda dovuta alla
decarbonizzazione.
Tutti i complotti sul TAP.
Xylella, multinazionali dell'agribusiness, mafia calabrese, narcos sudamericani,
russi che "non vogliono il TAP" contro russi che possiedono quote dei
giacimenti. Il meraviglioso mondo dei TAP-complotti spiegato, scrive Giovanni
Drogo lunedì 03 aprile 2017 su "Next Quotidiano". Melendugno, in provincia di
Lecce, continua la battaglia contro il metanodotto TAP. Anche se i lavori di
espianto e trasferimento degli ulivi che si trovano lungo gli otto chilometri
del percorso del tratto italiano del progetto della Trans Adriatic Pipeline sono
interrotti da sabato le proteste non si fermano e i manifestanti continuano a
presidiare l’area del cantiere e la notte scorsa per impedire e rallentare il
passaggio dei mezzi del cantiere lungo le strade d’accesso all’area di San
Basilio sono stati posizionati numerosi blocchi stradali. Sul posto, al sostegno
dei No Tap si è recato anche il sindaco di Melendugno, Marco Potì, ed altri
primi cittadini salentini.
La settimana scorsa abbiamo spiegato che cos’è il
TAP, a cosa serve e come mai si è arrivati alla decisione di far passare il
tratto finale del metanodotto proprio dall’approdo di San Foca e alla posa delle
condutture che arriveranno al Terminale di Ricezione di Melendugno da cui poi
verrà fatto il raccordo con la rete nazionale Snam a Mesagne (in provincia di
Brindisi) che dista 56 chilometri da Melendugno. Abbiamo spiegato che il
progetto del TAP ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni e che ha
superato la Valutazione d’impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente che ha
scelto l’approdo di San Foca – dove il “micro tunnel” arriverà ad 800 metri dal
litorale passando sotto la spiaggia. Gli ulivi “sradicati” saranno messi in
un’area dedicata da dove, al termine dei lavori, verranno ripiantati nella loro
posizione originaria, proprio come è successo per i 2.500 ulivi che sono stati
espiantati e ripiantati lungo il percorso delle condutture dell’Acquedotto
Pugliese un anno fa. TAP verserà tre milioni di euro nelle casse del Comune per
la durata dei lavori e pagherà un canone d’affitto di 500 mila euro per tutta la
durata della concessione.
Questo è – a grandi linee – TAP per come lo
raccontano le carte del Ministero dell’Ambiente e per come lo conoscono gli
uffici dell’osservatorio fitosanitario della Regione Puglia che hanno
autorizzato i lavori di espianto temporaneo degli ulivi per consentire al
consorzio di aziende che partecipano a TAP (tra cui l’italiana Snam) di posare
le condutture del metanodotto. Non è insomma andata esattamente come racconta
l’ex Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola che sull’Huffington Post
parla di «una multinazionale che intende investire alcuni miliardi di euro per
un’opera di questa portata non ha i soldi per istruire un progetto sulla base di
molteplici studi di fattibilità che prevedano siti alternativi? Il governo
nazionale è solo il notaio che certifica la bontà dell’investimento?» in primo
luogo perché di varianti al progetto ne sono state presentate 15 e in secondo
luogo perché a decidere è stata una commissione tecnica, non politica. Infine
bisogna far notare che in questi mesi gli enti locali (comuni e Regione) non
hanno formalmente proposto soluzioni alternative. Anche chi dice che TAP (intesa
come società) sradicherà migliaia di ulivi sbaglia perché i lavori di
ricongiungimento con la rete nazionale (a proposito è illuminante guardare la
cartina con tutti i gasdotti in Puglia) verranno effettuati dalla sola Snam.
Per i No Tap però, che non vogliono la
realizzazione dell’opera, c’è dell’altro. È la solita storia delle
multinazionali e dei poteri finanziari malvagi che prevaricano gli interessi dei
cittadini e delle comunità locali in nome del profitto. A chi giova la
costruzione del TAP? Non certo ai pugliesi – sostengono – che di quel gas non
sanno che farsene anche se potrebbe coprire il fabbisogno della
decarbonizzazione delle due centrali elettriche di Cerano (Enel) e Costa Morena
(Edipower). E così torna prepotentemente alla ribalta la teoria del complotto,
già sollevata qualche tempo fa da Sabina Guzzanti e Nando Popu dei Sud Sound
System che all’epoca ci spiegavano che la Xylella era stata inventata per poter
sostituire gli ulivi salentini con ulivi OGM (quindi ulivi della multinazionale
malvagia Monsanto). In questi giorni l’ispettore Guzzanti sta cantando vittoria:
aveva ragione lei il complotto c’era e non era immaginario. Però a quanto pare
non è lo stesso (dettagli) visto che ora si scopre che la Xylella è stata
diffusa per consentire l’eradicazione degli ulivi e facilitare il passaggio del
TAP. Ma allora perché tante cure nell’espianto dei duecentoundici (211) ulivi di
Melendugno e tante attenzioni nel posizionarli temporaneamente in un’area al
riparo dall’infezione causata dalla Xylella fastidiosa? Questo non è dato di
saperlo per ora, ma senza dubbio a posteriori verrà trovata una spiegazione
anche per questo.
Ma TAP non è solo una questione locale, quegli
otto chilometri sono solo la parte terminale di un metanodotto che
complessivamente è lungo più di quattromila chilometri e sul quale –
denuncia L’Espresso – ci sono le mani della criminalità organizzata. I legami
sono quelli – non proprio limpidissimi – del manager che dirigeva una società
svizzera che ha ricevuto dei finanziamenti europei per il progetto che poi è
stato acquisto da TAP (il consorzio di aziende composto da SOCAR, Snam, BP,
Fluxys, Enagás ed Axpo) con la criminalità organizzata calabrese e i narcos
sudamericani. Una storia di traffico di droga e riciclaggio di denaro che però
non tocca direttamente TAP che ha deciso di querelare l’Espresso per aver
accostato alla mafia il progetto di realizzazione del gasdotto. Anche
perché dalla ricostruzione giornalistica di Paolo Biondani e Leo Sisti gli
interessi della criminalità organizzata nella realizzazione della parte italiana
del TAP sono tutt’altro che evidenti e si fermano molto prima della stesura del
progetto. A dirla tutta non è chiaro nemmeno che interessi avrebbero e i narcos
nel metanodotto, la ‘Ndrangheta. Diversa invece è la questione che vede il
coinvolgimento della Russia. Perché se credete che il complottismo sia
appannaggio di una sola parte (ovvero dei No Tap) vi sbagliate. Ad esempio Carlo
Vulpio sul Corriere della Sera scrive che bisognerebbe guardare chi non vuole la
realizzazione del gasdotto: E se invece ci chiedessimo: chi ha interesse a «non»
fare il gasdotto, che, guarda caso, non attraverserà la Russia e perlomeno non
farà di Italia e Ue una specie di Ucraina?
Bingo! I russi ovviamente che se venisse ultimato
TAP si vedrebbero levare dalle mani una delle leve per condizionare in loro
favore le politiche comunitarie: i rubinetti del gas russo che rifornisce
l’Unione Europea. Il complotto diventa implicito: chi sta protestando contro
TAP? Il MoVimento 5 Stelle che notoriamente ha un buon rapporto con la Russia e
che secondo alcuni sostiene “troppo da vicino” gli interessi russi. Siamo a
tanto così dal dire che i manifestanti No Tap sono l’equivalente italiano degli
hacker russi che hanno truccato il voto delle presidenziali americane. Il tutto
ovviamente senza prove. Anzi, come ci rivela la già citata inchiesta
dell’Espresso, la questione potrebbe essere più complicata di così (ovvero russi
cattivi contro europei buoni) perché la più grande società petrolifera russa,
Lukoil, che possiede anche lo stabilimento petrolchimico di Priolo Gargallo in
Sicilia è entrata a far parte del consorzio che gestisce il giacimento azero di
Shah Deniz: Nel 2013 il corridoio sud del gas, cioè l’intero maxi-gasdotto,
viene approvato dalle autorità europee, appoggiate dagli Usa, con una dichiarata
funzione anti-russa, per creare un’alternativa al metano della Gazprom. Ma ora i
documenti mettono in dubbio questa giustificazione geo-politica: il gigante
russo Lukoil, infatti, è entrato con il 10 per cento nel consorzio guidato da Bp
e dalla società azera Socar per sfruttare il giacimento di Shah Deniz 2, proprio
quello del Tap. Mentre alcune intercettazioni italiane autorizzano a pensare
all’esistenza di accordi sotterranei anche con altre società russe. Controllate
da oligarchi fedeli al presidente Vladimir Putin. L’intento anti-russo del TAP
c’è, e non è proprio un segreto che l’Unione Europea voglia cercare una fonte di
approvvigionamento alternativa, ma a quanto pare “i russi” avrebbero comprato il
dieci percento di uno dei “rubinetti” che alimentano il Corridoio Meridionale
del Gas, ma non il corridoio stesso. E nemmeno questa informazione è un segreto
visto che è proprio sul sito della BP. Insomma chi crede che chi si agita
contro TAP a Melendugno stia facendo un favore ai russi è un complottista mentre
chi sostiene che TAP sia anche dei russi non la racconta giusta.
Puglia, i No Tap e quella strana protesta
contro il gasdotto. Venerdì sera esplose bombe carta
davanti all’hotel a Lecce che ospita i poliziotti. All’alba di sabato ripresi i
lavori di espianto degli ulivi a Melendugno. La protesta degli ambientalisti e
gli interessi in campo, scrive Carlo Vulpio il 2 aprile 2017 su “Il Corriere
della Sera”. È strana questa protesta «ambientalista» contro il gasdotto
Azerbaigian-Italia. È strana perché il metano è il meno inquinante tra tutti i
combustibili fossili: non c'è paragone con il petrolio o con il carbone, che
alimentano, per esempio, le due centrali elettriche di Brindisi (tra le più
inquinanti d'Europa) e l'Ilva (la più grande acciaieria europea, produttrice
incontrollata di cancerogeni e di diossina). Il gasdotto - un tubo del diametro
di 90 centimetri, a 10 metri di profondità - sboccherà nell'entroterra, a 8
chilometri dalla costa. Ma ci sono gli ulivi sul tracciato e bisogna fare
attenzione. Giusto. Infatti ne sono stati espiantati 211, e saranno tutti
ripiantati. Ma fossero anche di più? È la Xylella il nemico degli ulivi, non il
gasdotto. Come non lo sono i 38 km del nuovo troncone Basilicata-Salento
dell'Acquedotto pugliese (diametro del tubo 1,40 metri), che ha comportato
l'eradicazione (provvisoria) di 2.500 ulivi e che è stato inaugurato proprio da
Michele Emiliano. Con un discorsetto opposto a quelli che egli fa per alzare la
temperatura del gas. Con Emiliano, contro il gasdotto, c'è anche Vendola, che
nel suo «decennio» ha regalato alla Puglia assurde discariche, pale eoliche e
pannelli fotovoltaici come da nessun'altra parte, con espianto (perenne) di
migliaia di ettari di uliveti e vigneti. Senza che Emiliano, e l'altro caballero
della protesta anti-gasdotto, Grillo, abbiano emesso un solo sospiro per le
campagne e il paesaggio scempiati. Si poteva far approdare il gasdotto a
Brindisi, dicono Emiliano & Co. Fingendo di non sapere che dire Brindisi
significa dire mai, dato che per la Direttiva Seveso III, la città è «area a
rischio di incidente rilevante». E allora ecco che «in Azerbaigian non vengono
rispettati i diritti umani». Come se Cina, Kazakhstan, Arabia Saudita, Nigeria,
Algeria e i tanti altri nostri partner commerciali fossero democrazie liberali.
Infine, la mafia. Poteva mancare la mafia del gas azerbaigiano, con un tubo che
attraversa Georgia, Turchia, Grecia, Albania? Certo che no. Ma se anche questo
non bastasse, ecco la domanda jolly: chi ha interesse a fare «quel» gasdotto? E
se invece ci chiedessimo: chi ha interesse a «non» fare il gasdotto, che, guarda
caso, non attraverserà la Russia e perlomeno non farà di Italia e Ue una specie
di Ucraina?
Vi racconto le bufale sul gasdotto Tap.
Parla Carlo Vulpio, scrive Francesco De Palo il 3
aprile 2017 “Formiche.net". Perché Vendola, Emiliano e Grillo non hanno detto
nulla contro il fotovoltaico, le pale eoliche e le discariche selvagge che hanno
scempiato la Puglia e invece oggi foraggiano una crociata contro il gasdotto
Tap? E perché la Regione Puglia ha detto no al Tap e sì al South Stream? Se lo
chiede da tempo il giornalista Carlo Vulpio, poliedrica figura di giornalista e
inviato, che sul Corriere della Sera di domenica 2 aprile ha firmato un commento
ficcante sulle stranezze della protesta anti Tap, sciorinando dati sui passati
interventi e conseguenze ben peggiori rispetto all’espianto di 200 ulivi come
nel caso relativo alla marina di Melendugno. Il Tap, lungo 878 km, porterà ogni
anno in Europa 10 miliardi di metri cubi di gas attraverso Turchia, Grecia,
Albania e Italia. I lavori in Albania e Grecia sono già stati avviati da tempo,
mentre in Puglia si registra la feroce mobilitazione di amministratori locali e
rete.
STRANEZZE. “La
protesta inscenata dai no Tap in questi giorni a Melendugno è strana – dice
Vulpio a Formiche.net – Se chi manifesta avesse fatto un accenno al merito dei
lavori con argomenti forti e basati, allora sarebbe stata una protesta normale.
Il punto riguarda invece l’origine di questi moti”. E cita il caso di quando tre
anni fa si recò personalmente in Azerbaijan per vedere e raccontare la nascita
del gasdotto realizzato dalla società azera Socar. Analizzò cosa fosse davvero
la via del gas, quanto potesse interessare l’Italia e l’Europa. E già allora,
dalle colonne de La Lettura, l’inserto domenicale del Corriere, scrisse come
fosse assurdo che proprio l’ultimo miglio del gasdotto, ovvero il tratto
pugliese, potesse condizionare la realizzazione dell’intera opera con in campo
40 sindaci e le istituzioni regionali. “E’ bastato che mi chiedessi il motivo di
quelle proteste e lo argomentassi con dati e valutazioni nel merito, per
raccogliere da quelle falangi organizzate in rete accuse di aver preso denaro da
qualche committente, cosa che mi vanto di non aver mai fatto in tutta la mia
carriera”.
PARALLELISMI.
“Strano che la Puglia, con l’ineffabile Vendola – continua Vulpio – abbia dato
parere negativo al Tap che sbarcherà a Melendugno, mentre invece diede l’ok ad
un altro progetto, il South Stream, che sarebbe dovuto sbarcare, via Grecia, ad
Otranto”. Quest’ultimo, poi, ha subìto uno stop dopo i noti contrasti tra Europa
e Russia a causa della guerra in Ucraina. Possibile che Otranto sia meno
delicata di Melendugno, si chiede? Una domanda che ha spinto Vulpio ad
approfondire la questione, andando anche al di là dell’apparenza di
mobilitazioni e campagne sui social. Quel corsivo sul Corriere della Sera di
domenica 2 aprile “nasce da lontano e rappresenta se vogliamo la logica
conclusione di un vero e proprio viaggio di inchiesta” tra attori, fautori e
ispiratori iniziato in tempi non sospetti, nel 2014. E utilizzando un piglio
lontano da certo anti industrialismo, come fatto sul caso Ilva a cui ha dedicato
il pamphlet “La città delle nuvole. Viaggio nel territorio più inquinato
d’Europa”, (Edizioni Ambiente 2009) vincendo il Premio “Magna Grecia Awards”
2012. “Il conflitto tra progresso e ambientalismo classico è roba vecchia –
sottolinea – e ce lo stanno insegnando gli indiani che riescono a costruire le
acciaierie in India meglio di come la mano pubblica abbia fatto con l’Ilva di
Taranto. Dimostra che, se si vuole, si possono fare le cose per bene e senza
incidenti legati al cattivo industrialismo come accaduto alla centrale a carbone
di Brindisi o nel rione tarantino Tamburi, che oggi andrebbe raso al suolo e
sostituito con un grande bosco”.
I SILENZI SUGLI SCEMPI.
C’è un altro elemento che ha fatto da propellente alle
riflessioni di Vulpio sul Tap e riguarda i silenzi della classe politica e delle
istituzioni sugli scempi che in Puglia si sono consumati negli ultimi due
lustri. “Curioso – aggiunge – che l’ex governatore Nichi Vendola, dopo aver
affittato i suoi uteri, scriva pochi giorni fa sull’Huffington Post che bisogna
tutelare i cittadini dai danni del gasdotto e dalla democrazia del manganello,
dimenticando i suoi scempi a danno della Puglia con pale eoliche, pannelli
fotovoltaici e discariche in luoghi sensibili: come quella che voleva realizzare
a Grottelline, vicino Spinazzola, su di un insediamento neolitico e a pochi
metri da una sorgente di acque minerale e da antiche masserie dei Templari.
Un’altra l’hanno fatta a Corigliano d’Otranto, in perpendicolo ad un grande
bacino d’acqua potabile che alimenta l’Acquedotto Pugliese. Lì davvero sono
stati tagliati uliveti e vigneti per sempre, non momentaneamente spostati come i
200 del Tap”. E racconta che tra l’altro in occasione della costruzione
massiccia di pannelli fotovoltaici si è utilizzato un consistente quantitativo
di diserbante affinché non crescesse più nemmeno l’erba. “Molto curioso che su
tutto questo Vendola, Emiliano e Grillo non abbiano detto nulla, mentre adesso
cavalcano la protesta del no Tap”. Troppe stranezze secondo Vulpio, al pari
della decisione del Governatore pugliese Emiliano di andare ad inaugurare lo
scorso settembre i 38 km della dorsale jonico-salentina di acquedotto che dal
fiume Sinni alimenterà proprio quell’area destinata all’approdo del gasdotto. E
si interroga: “Chi decide che sia lecito espiantare gli ulivi su quei 38 km e
che non lo sia farlo a Melendugno?”
MEDIA. Vulpio
ricorda anche una puntata di Report, condotta su Rai3 da Milena Gabanelli, che
mescolò in maniera disarticolata il gasdotto Tap, i riverberi paesaggistici, le
accuse ad alcuni politici come l’ex Udc Luca Volonté e i diritti umani in quel
paese. “Guardando quella trasmissione ecco che il pensiero va ad altri
interrogativi, legati alle pressioni di gruppi di potere, di lobbisti, di Stati
che non possiamo far finta di non sapere che esistono. Il fatto che avvengano
non è affatto una giustificazione, ma la domanda è: perché mischiare tutto per
far passare il messaggio che acquisteremo gas da dei criminali?”. Senza contare
anche una certa direzione impressa dalla stampa italiana, che ha assecondato gli
umori dei no Tap: “Non solo quella locale pugliese, ma anche quella nazionale
non mi pare sia brillata per obiettività, anzi, la bussola sembra essere il
riposizionamento in virtù di futuri scenari politici” aggiunge Vulpio. E
conclude: “Poi mi sono detto che è sufficiente osservare la cartina geografica e
scoprire che la geopolitica avrebbe molto da dire per chiarire qualcuna di
quelle stranezze”.
NO TAP E PROTESTA CONTRO IL DEPURATORE
CONSORTILE MANDURIA-SAVA AD AVETRANA. NON SONO FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA.
Avetrana. Manifestazione contro il
Depuratore consortile Manduria-Sava. 31 marzo 2017. Ad
Avetrana, nell’indifferenza dei media, migliaia di persone da ogni dove venuti a
dire no al depuratore consortile Manduria-Sava, da costruire al confine con la
zona turistica di Avetrana, ed al relativo scarico al mare prospicente delle
acque reflue di risulta.
L’opinione dr Antonio Giangrande. Scrittore,
sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione
Contro Tutte le Mafie.
A Sava e a Manduria va bene che si faccia scempio
di quelle zone, sostenute da politici locali tarantini e regionali pugliesi,
disinteressati agli interessi del posto. I media nazionali e locali, che se ne
infischiano della questione, potrebbero pensare di avere a che fare con una
cricca di ambientalisti comunisti anarchici, se non essere, addirittura, i
giornalisti asserviti al potere.
Se io non fossi di Avetrana, ma fossi un barbaro
leghista, però, me ne fotterei dell’aspetto ambientale, sì, ma non potrei
esimermi, però, dal chiedermi come cazzo si fa a sperperare dei soldi pubblici,
per perorare un’opera che dista una trentina di chilometri dal sito da servire.
Se il costo dell’opera rientra nei bilanci pubblici, è inaccettabile ed illogico
spendere soldi pubblici per chilometri di condutture, per portare la merda
manduriana e savese alle soglie di Avetrana. E poi il costo dei tanti terreni da
espropriare e dei tantissimi ulivi secolari da estirpare (se fossero autorizzati
a farlo). La questione Tap a Lecce, in confronto, sarebbe un’inezia. A questo
punto non sarebbe l’organo amministrativo ad essere interpellato, ma l’organo
contabile della Corte dei Conti, affinchè gli amministratori incapaci possano
pagare di tasca propria le nefandezze che combinano.
Depuratore di Specchiarica. I tanti padri
di un fallimento. Ricordo molto bene quando Emiliano
promise solennemente che lo scarico a mare imposto da Vendola non si sarebbe
fatto.
Il Pd di Avetrana abbandona la linea
Emiliano-Del Prete in tema di depurazione, scrive "La
Voce di Manduria" il 12 marzo 2017. Al partito democratico di Avetrana non
convince più il piano del governatore Michele Emiliano del depuratore con
scarico emergenziale sul terreno e chiede di spostare il sito altrove. Dicendosi
ora «da sempre contrari alla localizzazione nella località Urmo Belsito», appena
due settimane fa i piddini avetranesi, esprimevano «la massima soddisfazione in
merito alle decisioni che, in itinere, la Regione Puglia ed Acquedotto Pugliese,
con il prezioso contributo dei Comuni Interessati, dei Consiglieri Regionali del
territorio e quelli del Gruppo PD, e soprattutto del Prof. Mario Del Prete, sono
in fase di elaborazione, riguardo il Depuratore Consortile Manduria-Sava».
Evidentemente convinti a cambiare idea dall’onda di proteste della loro comunità
che vuole contrastare a tutti i costi il progetto Aqp-Del Prete-Emiliano, gli
esponenti del Pd di Avetrana scrivono ora che «i recenti sviluppi della vicenda,
che prevedono uno studio di fattibilità per il superamento dello scarico in mare
delle acque come recapito finale della depurazione, nonché il venir meno della
realizzazione della rete fognaria nelle località marine di Manduria, rendono
superata quella localizzazione. Si considera, infatti – aggiungono -, che un
depuratore posto presso il mare abbia dei costi molto maggiori rispetto ad una
struttura che dovrebbe servire solo ed esclusivamente i nuclei abitati di
Manduria e Sava». Per questo, secondo quanta nuova linea, «Il Circolo di
Avetrana del Partito Democratico chiede a gran voce che sia preso in
considerazione lo spostamento del sito del Depuratore per i motivi sopra
esposti, ovvero: la mancanza del servizio fognario presso le marine di Manduria,
il superamento dello scarico in mare, ed i costi eccessivi di una condotta che
da Sava dovrebbe arrivare fino a Urmo Belsito». Il Pd avetranese, infine,
«invita tutte le componenti politiche e sociali di Avetrana a ritrovare l’unità
per poter ottenere un risultato utile all’intera popolazione, piuttosto che
intraprendere lotte in solitaria che non fanno altro che dividere il fronte e
rendere vana la deliberazione unitaria del Consiglio Comunale del 17 febbraio
scorso, in cui si confermava la contrarietà di Avetrana all’ubicazione del sito
del depuratore».
SPECCHIARICA. Quando il turista malcapitato viene
a San Pietro in Bevagna, a Specchiarica o a Torre Colimena dice: “qua non c’è
niente e quel poco è abbandonato e pieno di disservizi. Non ci torno più!”. Al
turista deluso e disincantato gli dico: «Campomarino di Maruggio, Porto Cesareo,
Gallipoli, Castro, Otranto, perché sono famosi?» “Per il mare, per le coste, per
i servizi e per le strutture ricettive” risponde lui. «Questo perché sono paesi
marinari a vocazione turistica. Ci sono pescatori ed imprenditori e gli
amministratori sono la loro illuminata espressione» chiarisco io. «E Manduria
perché è famosa?» Gli chiedo ancora io. “Per il vino Primitivo!” risponde
prontamente lui. Allora gli spiego che, appunto, Manduria è un paesone agricolo
a vocazione contadina e da buoni agricoltori, i manduriani, da sempre i 17 km
della loro costa non la considerano come una risorsa turistica da sfruttare, (né
saprebbero come fare, perché non è nelle loro capacità), ma bensì semplicemente
come dei terreni agricoli non coltivati a vigna ed edificati abusivamente,
perciò da trascurare.
Specchiarica è Salento. Specchiarica è un
territorio costiero posto sul lato orientale della marina di Taranto. E' una
lontana frazione decentrata di Manduria, provincia di Taranto, attigua al
confine territoriale di Porto Cesareo, provincia di Lecce. Specchiarica confina
con altre frazioni manduriane: ad est con Torre Colimena; ad ovest con San
Pietro in Bevagna. Specchiarica è meno nota delle precedenti località pur se, in
periodo estivo, ospita il doppio dei loro villeggianti. Le sue spiagge sono
alternativamente sabbiose e rocciose ed il mare è incontaminato. Specchiarica è
delimitata da due importati risorse ambientali. Sul lato est di Specchiarica vi
è la Salina dei Monaci, sul lato ovest vi è il fiume Chidro. Specchiarica è
formata da 7 contrade: quota 10; quota 11; quota 12; quota 13; quota 14; quota
15; quota 16. Le contrade non sono altro che delle strade di campagna comunali
perpendicolari alle parallele strade provinciali e statali: la litoranea
Salentina e la Tarantina. Le strade contradaiole oggi asfaltate alla meno
peggio, sono bucate da tutte le parti. Ai lati di queste strade comunali da
sempre si è lottizzato e costruito abusivamente. Prima a ridosso della litoranea
e poi man mano, fino all'interno senza soluzione di continuità. Migliaia di case
e decine di strade che da private sono divenute pubbliche. Gli organi preposti
giudiziari ed amministrativi, anzichè regolare questo scempio, lo hanno
agevolato.
A Specchiarica è quasi impossibile arrivarci: non
ci sono vie di collegamento degne di un paese civile. Non vi è una ferrovia: i
treni si fermano a Taranto (50 km). Non vi è un aeroporto: gli aerei si fermano
a Brindisi (50 km). Non vi sono autostrade: l'autostrada si ferma a Massafra (60
km). Non vi sono porti: le navi si fermano a Taranto o Brindisi. Non vi sono
autolinee extraurbane: gli autobus si fermano a Manduria (20 km) e qualche volta
ad Avetrana (6 km).
Di questo diciamo grazie a chi ci amministra a
livello provinciale, regionale, statale, ma diciamo grazie anche alla
maggioranza di chi abita il territorio, abulici ad ogni autotutela e servili con
il potere per voto di scambio o altre forme di clientelismo. Compromessa con la
politica, la maggior parte degli abitanti di Specchiarica sono consapevoli del
fatto che tutte le abitazioni della zona (Specchiarica, ma anche San Pietro in
Bevagna e Torre Burraco e Torre Colimena) sono insalubri (mancanza di fogna e
acqua potabile) e quindi inabitabili, oltre che inquinanti la falda acquifera.
Devono solo ringraziare le omissioni delle Autorità preposte allo sgombero degli
immobili per sanità e sicurezza pubblica, se si può ancora usufruire di quelle
case.
Gli abitanti di Specchiarica sono degni e
meritevoli dell'irridenza e dello sberleffo dei "Polentoni" (mangia polenta
ovvero un pò lentoni di comprendonio) che definiscono i "Terroni" retrogradi ed
omertosi, anche se molti settentrionali abitano la zona e non si distinguono per
niente dalla massa. Gli specchiarichesi anziché ribellarsi, subiscono e
tacciono. In questo modo, per non pretendere quello che gli spetta, le loro
proprietà sono svalutate ed improduttive.
Percorrendo la litoranea Salentina, Specchiarica,
a guardarla dal lato del mare è un paradiso vergine ed incontaminato, ma
volgendo gli occhi all'interno ci si trova un ammasso di immobili, per lo più
seconde case, costruite tutte abusivamente nell'indifferenza delle istituzioni.
L'urbanistica del posto non esiste, e quello che c'è, di fatto, è mancante di
qualsivoglia servizio civico. Mancano: acqua potabile e sistema fognario, la cui
mancanza incide sull'inquinamento della falda acquifera; percorsi di viabilità
pedonale ed automobilistica; illuminazione pubblica e luoghi di svago e di
ritrovo. Assurdo, ma manca addirittura una piazza e perfino i marciapiedi per
camminare o passeggiare. Tempo fa a Specchiarica vi era un luogo di ritrovo. Un
bar-ristorante-pizzeria con annesso parcheggio roulotte, parco giochi e sala da
ballo all'aperto. Vi era movimento, luci, suoni, svago, intrattenimento.
Svolgeva altresì la funzione di ufficio informazioni. Era frequentato per lo più
dai turisti, ma era malvisto da molti locali, erosi dal tarlo dell'invidia,
abituati all'assistenzialismo e disabituati all'iniziativa imprenditoriale ed
all'emancipazione culturale ed economica. In precedenza quel luogo era usato
come campo di calcio da comitati estemporanei di gente locale, per lo più di
Avetrana, avendoselo appropriato illegalmente, senza ristoro economico per il
proprietario. Un intrattenimento gratuito per chi si accontenta di poco o di
niente e pretende che gli altri facciano lo stesso. Hanno perso il giocattolo
nel momento in cui chi ne aveva diritto ha creato un'azienda. Pur essendo
proprietà privata, dei "Pesare" noti possidenti di Avetrana prima di passare
all'attuale legittima proprietà, le malelingue diffamatorie divulgarono la
convinzione che il terreno fosse stato usurpato illegalmente a danno del
demanio. Il venticello della calunnia tanto soffiò forte che un giorno d'inverno
qualcuno appiccò il fuoco alla struttura. Un avvertimento del racket a chi non
voleva pagare il pizzo o una mano armata dall'invidia. La calunnia ancor oggi è
un venticello che non smette di soffiare. L'amministrazione pubblica non ha più
dato modo ai proprietari di ricostruire quello che la mafia o l'invidia aveva
distrutto. La mafia ti rovina la vita; lo Stato ti distrugge la speranza. Le
rovine di un passato sono ancora lì a ricordarci l'incapacità degli
amministratori pubblici di governare e gestire un territorio.
Il paradosso è che a Specchiarica ha più diritto
una pianta vegetale, pur non inserita in un sistema protetto di macchia
mediterranea, che un essere umano, la sua proprietà, la sua azienda.
Se tocchi una pianta o bruci le erbacce le
autorità ti distruggono con la delazione di pseudo ambientalisti. Vi è
indifferenza, invece, se si abitano case insalubri ed inabitabili, in zone prive
di ogni strumento urbanistico.
L'amministrazione comunale di Manduria è incapace
di dare un'immagine ed una regolamentazione affinchè il territorio sia una
risorsa economica e sociale per il territorio. Specchiarica è un luogo desolato
ed abbandonato a sè stesso. Posto nel limbo territoriale e culturale tra i
comuni di Avetrana e Manduria è un luogo di vacanze. Ambìto da entrambi i
Comuni, il territorio è oggetto di disputa sulla sua titolarità. Avetrana ne
vanta l'autorità per precedenti storici e per l'infima prossimità. L'argomento
ad Avetrana è l'unico tema per le campagne elettorali. I proprietari delle case
o i locatari che li occupano temporaneamente (pagando affitti in nero) sono
gente di varie origini anche estere o extra regionali o provinciali. I
specchiarichesi per lo più sono di origini autoctone, ossia sono cittadini di
Avetrana, ma anche di Erchie, Torre Santa Susanna, Manduria e di altri paesi
pugliesi limitrofi che si affacciano sulla costa ionica.
Specchiarica ha un solo ristorante, un solo bar,
un posteggio per roulotte: troppo poco per sfruttare economicamente la risorsa
del turismo. Ma i locali son contenti così. I saccenti amministratori locali ed
i loro referenti politici provinciali e regionali, anzichè impegnarsi a porre
rimedio ad un danno economico e d'immagine incalcolabile, nel deserto hanno
pensato bene di progettare lo sbocco a mare del depuratore fognario di Manduria
e Sava (paesi lontani decine di chilometri), arrecando addirittura un probabile
danno ambientale.
Un comitato si è formato per fermare quello che il
Comune di Manduria, l'Acquedotto Pugliese e la Regione Puglia vogliono fare in
prossimità della località "Ulmo Belsito", frazione turistica di Avetrana, ossia
il depuratore con lo scarico a mare nella marina incontaminata di Specchiarica,
frazione di Manduria; nessuno, invece, ha mai alzato la voce per obbligare a
fare quello che si ha sacrosanto diritto a pretendere di avere come cittadini e
come contribuenti che sul posto pagano milioni di euro di tributi.
Comunque i comitati in generale, non questo in
particolare, sono composti da tanti galletti che non fanno mai sorgere il sole e
guidati da personaggi saccenti in cerca di immeritata visibilità o infiltrati
per parte di chi ha interesse a compiere l'opera contro la quale lo stesso
comitato combatte. Questi comitati sono formati da gente compromessa con la
politica e che ha come referenti politici gli stessi che vogliono l'opera
contestata, ovvero nulla fanno per impedirlo. Valli a capire: combattono i
politici che poi voteranno alle elezioni. Spesso, poi, ci sono gli
ambientalisti. Questi a volte non sanno nemmeno cosa significhi amore per la
terra, la flora e la fauna, ma per ideologia impediscono il progresso e
pretendono che si torni all'Età della Pietra. Ambientalisti che però non
disdegnano i compromessi speculativi, tanto da far diventare le nostre terre
ampie distese desertiche tappezzate da pannelli solari e fotovoltaici che fanno
arricchire i pochi. Pannelli solari che offendono il lavoro dei nostri nonni che
hanno conquistato quei terreni bonificandoli da paludi e macchie. Sicuramente
non vi sono professionisti competenti a intraprendere le azioni legali e
giudiziarie collettive adeguate, anche con l'ausilio delle norme comunitarie. Di
sicuro i membri del comitato non vogliono sborsare un euro e si impelagano in
proteste infruttuose fine a se stesse. Se il singolo può adire il Tar contro un
atto amministrativo che lede un suo interesse legittimo (esproprio), la comunità
può tutelare in sede civile il diritto alla salute ed all'immagine ed alla
tutela del proprio patrimonio.
Per quanto riguarda la costruzione ed il
funzionamento del depuratore vi sono norme attuative regionali che regolano la
materia. A livello nazionale invece, si fa riferimento ai due decreti
legislativi il n. 152/06 (“Norme in materia ambientale”) e il n. 152/99 (recante
“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”) che,
recependo la normativa comunitaria allo scopo di tutelare la qualità delle acque
reflue, disciplinano che gli scarichi idrici urbani siano sottoposti a diverse
tipologie di trattamento in funzione della dimensione degli agglomerati urbani.
Altro è il controllo successivo rispetto ai parametri microbiologici di
riferimento, gli stessi fissati dal D. lgs. 116 del 30 maggio 2008 ad
integrazione del D.p.r. n. 470 dell’8 giugno 1982, norma emanata in recepimento
della direttiva 79/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione e ora
sostituita dalla più recente direttiva 2006/7/CE.
Il sindaco di Avetrana aveva firmato per il
depuratore a Ulmo, scrive il 10 settembre 2015 "La Voce di Manduria".
Scarico a mare no, depuratore in zona Ulmo Belsito sì. E’ scontro su questo tra
il vicesindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia e il consigliere regionale di
Torricella, Peppo Turco. Il numero due della giunta avetranese fomenta la
polemica postando su facebook gli atti deliberativi e i documenti attestanti la
contrarietà degli avetranesi non solo alla condotta sottomarina, ma anche
all’ubicazione delle vasche di raccolta e deposito previste a due passi dalla
zona residenziale di Ulmo Belsito. Il consigliere Turco, da parte sua, fa notare
la differenza di vedute di Scarciglia con il suo sindaco il quale, spiega Turco,
è invece favorevole al sito Ulmo. «Da sempre – scrive il vicesindaco di Avetrana
– siamo stati contro lo sversamento in mare delle acque reflue e contro
l’ubicazione del depuratore (collettore) nei pressi dell’unica località
turistica del nostro comune». Come prova di questo, l’amministratore avetranese
posta tutte le delibere prodotte negli anni che, in effetti, attestano
l’opposizione degli avetranesi sia alla condotta che alla sede delle vasche». Il
consigliere di Torricella che con il suo collega manduriano, Luigi Morgante
hanno preso a cuore la vicenda del «no scarico a mare», richiama l’amico
Scarciglia e fa emergere la contraddizione tra lui e il suo sindaco. «Gli atti –
scrive Turco – sono che stai facendo una figuraccia; per vincere una campagna
elettorale avresti dovuto dirci tutto prima e non dopo. Negli incontri –
continua il consigliere regionale – abbiamo sempre parlato di condotta». Infine
Turco smaschera il capo dell’amministrazione di Avetrana citando un documento da
lui sottoscritto. «Perché – chiede a Scarciglia – non posti il documento
sottoscritto dal tuo sindaco in cui accetta tutto?». Più imbarazzante, per
l’amministratore di Avetrana, l’intervento pubblico dell’ambientalista Nicolò
Giangrande che su Facebook ha pubblicato la lettera richiamata da Turco (con
tanto di firma del sindaco De Marco), con questo duro commento: «È semplice
sbraitare, oggi, contro un tavolo riannodato tra mille difficoltà – si legge nel
post – quando, invece, il Comune di Avetrana è stato il primo a firmare a Bari,
il 4 agosto 2014, un avallo all’AQP per la condotta sottomarina. Una firma che
ancora oggi pesa come un macigno nella ricerca di una soluzione condivisa tra
tutti gli attori coinvolti. E’ meglio rinfrescare la memoria a quegli
amministratori avetranesi – aggiunge Giangrande -, forse un po’ distratti o
smemorati, che ricostruiscono la vicenda del depuratore sempre in maniera
incompleta e sempre omettendo i documenti a loro più scomodi».
LA STORIA DEL DEPURATORE PUNTO PER PUNTO.
Intervento del 24 aprile 2015 di Nicolò Giangrande su "Viva Voce Web". Dopo aver
ascoltato molti degli interventi alla manifestazione di domenica 19 aprile,
reputo sia doveroso ricostruire brevemente la decennale vertenza “no scarico a
mare” per fare chiarezza sulle responsabilità del progetto al quale ci stiamo
opponendo. Uno sguardo all’indietro non per motivi nostalgici bensì per chiarire
alcuni elementi che, a mio avviso, stanno portando il dibattito, e il
conseguente scontro, ad una contrapposizione “locale” versus “regionale”. La
realtà è ben più complessa e chi vuole ridurla ad un banale schema del tipo
“noi” contro “loro” ha come obiettivo quello di nascondere le responsabilità e
confondere la situazione. Se vogliamo capire quanta responsabilità abbiano i
diversi attori istituzionali coinvolti, dobbiamo analizzare le “parole” e i
“(f)atti” che caratterizzano il loro discorso e le loro azioni.
Partiamo dal livello locale: Manduria.
Primo punto. L’Amministrazione Comunale di
Manduria (sindaco Francesco Massaro, centrosinistra) ha indicato una
localizzazione per il depuratore tanto lontana dal centro abitato cittadino
quanto vicino all’unica area turistico residenziale di Avetrana con la
motivazione di voler servire la marina manduriana. Una scelta miope che ha
portato, sì, l’impianto lontano dal naso dei cittadini-elettori di Manduria ma
lo ha avvicinato così troppo alla costa che l’unico scarico possibile dei reflui
era, e rimane, il mare.
Secondo punto. Quando è stata presentata la
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) vi era la disponibilità regionale alla
modifica del sito (leggere pag. 13 della VIA, febbraio 2011) e, quindi, del
conseguente scarico a mare. Il Comune di Manduria (sindaco Paolo Tommasino,
centrodestra) non ha colto quella preziosa occasione e la VIA è stata approvata
lasciando invariato il sito. Sei mesi dopo, nell’agosto 2011, lo stesso sindaco
Tommasino era in prima fila nella manifestazione di San Pietro in Bevagna ad
arringare la folla contro lo scarico a mare.
Terzo punto. L’attuale Amministrazione di Manduria
(sindaco Roberto Massafra, liste civiche) si oppone alla costruzione dello
scarico a mare ma non lo ha ancora dimostrato con degli atti amministrativi
rilevanti. Passiamo ora dal livello locale a quello regionale. Salto volutamente
i commissariamenti prefettizi della Città di Manduria e il livello provinciale
poiché le responsabilità in questi livelli, pur essendoci, sono minime. Metto di
lato anche l’AQP perché l’Acquedotto in questa partita è il braccio operativo
della Regione Puglia.
Quarto punto. Nichi Vendola – nel suo triplice
ruolo di Presidente della Regione Puglia, Commissario Straordinario all’Ambiente
nominato dal Governo e leader nazionale di “Sinistra, Ecologia e Libertà” - è
rimasto totalmente indifferente dinanzi alle richieste, provenienti da più
parti, di ascoltare le soluzioni alternative. Una persona come lui, tanto
impegnata nel mettere in luce le contraddizioni di alcune opere in altre regioni
italiane e pure sulla costa adriatica pugliese, avrebbe dovuto rivolgerci
un’attenzione particolare. Tra le incoerenze che voglio sottolineare vi è quella
lettera a firma di Luca Limongelli (dirigente del Servizio Idrico della Regione
Puglia), in cui si riconosce la netta contrarietà delle popolazioni interessate,
si citano le autorizzazioni mancanti e si chiede al Ministero dell’Ambiente di
inserire la costruzione del depuratore nel decreto “Sblocca Italia”. È
paradossale come la Regione Puglia di Vendola sia tanto impegnata ad opporsi
allo “Sblocca Italia” -poiché considerato un provvedimento calato dall’alto che
non permette alcun confronto con la popolazione locale- e poi un funzionario
della stessa Regione lo invoca, nel silenzio di tutti i vertici regionali, per
imporre una scelta ad un territorio nettamente contrario.
Quinto punto. Fabiano Amati e Giovanni Giannini -
rispettivamente l’ex e l’attuale assessore regionale ai Lavori Pubblici
(entrambi del Partito Democratico) - si sono rivelati strenui difensori delle
scelte e degli interessi dell’Acquedotto Pugliese. Infatti, tutti e due non
hanno mai voluto ascoltare le nostre proposte alternative allo scarico a mare.
Sesto punto ed ultimo. Gli attuali consiglieri
regionali eletti nella circoscrizione di Taranto -Anna Rita Lemma, Donato
Pentassuglia, Michele Mazzarano (PD), Alfredo Cervellera (SEL, oggi Misto),
Francesco Laddomada (La Puglia per Vendola), Giuseppe Cristella, Arnaldo Sala,
Pietro Lospinuso (PDL-Forza Italia), Antonio Martucci (Italia dei Valori, oggi
Moderati e Popolari) - sono stati tutti quanti, chi più chi meno, interpellati
per occuparsi della vertenza. Gli impegni presi, però, non sempre si sono
trasformati in atti tangibili. Tra di loro vi è qualcuno che negli ultimi giorni
ha pure espresso vicinanza alla nostra lotta. Questi atteggiamenti da convertiti
sulla via di Damasco, forse meglio dire “sulla litoranea di Specchiarica”, li
fanno apparire superficiali quanto quegli studenti che il 6 di gennaio si
ricordano di non aver fatto i propri compiti e pensano a quale giustificazione
usare il giorno dopo. Come vediamo le responsabilità della condotta sottomarina
non sono solo da un lato bensì interessano le Istituzioni di ogni livello e i
Partiti di ogni colore. Manduria e Bari sono accomunate entrambe dal dire una
cosa e farne un’altra. Una pericolosa separazione tra “parole” e “(f)atti” che
sta portando ad un progressivo allontanamento tra le Istituzioni e i cittadini e
tra i Partiti e gli elettori. Non ci si può, quindi, meravigliare se poi i
giovani presenti in piazza domenica scorsa contestano apertamente i simboli e
gli uomini delle Istituzioni e dei Partiti. Per risolvere questa vertenza non
c’è bisogno di alcun eroe pronto a immolarsi davanti alle ruspe. Sembrerà strano
ma è sufficiente che i rappresentanti che tutti noi abbiamo eletto, dal Comune
fino alla Regione, facciano semplicemente il proprio dovere. Il Coordinamento
Intercomunale deve quindi giocare su tre fronti: in piazza, nei tribunali e nel
Palazzo. È indispensabile continuare a tenere alta l’attenzione sulla nostra
lotta, spingere i rappresentanti delle Istituzionali locali a dare mandato ad
avvocati che possano predisporre una corretta azione legale e, infine, preparare
l’incontro con il Ministero dell’Ambiente. Una volta coinvolto il Ministero,
sarà compito di quest’ultimo decidere se affrontare la questione o rimandarla
indietro alla Regione Puglia che, a quel punto, avrà un nuovo Presidente, una
nuova Giunta e un nuovo Consiglio regionale.
CONTRO IL DEPURATORE CONSORTILE SAVA-MANDURIA AD
AVETRANA E SCARICO A MARE. LOTTA UNITARIA O FUMO NEGLI OCCHI?
Sentiamo la voce del dissenso dell’Associazione
Contro Tutte le Mafie e dell’Associazione Pro Specchiarica entrambe di Avetrana.
La prima a carattere nazionale e la seconda prettamente di interesse
territoriale. Il perché di un rifiuto a partecipare alla lotta con gli altri,
spiegato dal Dr Antonio Giangrande, componente del direttivo di entrambe le
associazioni avetranesi.
«L’aspetto da affrontare, più che legale (danno
emergente e lucro cessante per il territorio turistico di Avetrana) è
prettamente politico. La gente di Avetrana non si è mobilitata in massa e non vi
è mobilitazione generale, come qualcuno vuole far credere, perché è stufa di
farsi prendere in giro e conosce bene storia e personaggi della vicenda. Hanno
messo su una farsa poco credibile, facendo credere che vi sia unità di intenti.»
Esordisce così, senza giri di parole il dr Antonio Giangrande.
«Partiamo dalla storia del progetto. La spiega
bene il consigliere comunale Arcangelo Durante di Manduria: “Che la
realizzazione a Manduria di un nuovo depuratore delle acque reflue fosse
assolutamente necessario, era già scontato; che la scelta del nuovo depuratore
non sia stata fatta dall’ex sindaco Francesco Massaro, ma da Antonio Calò,
sindaco prima di lui, ha poca importanza. Quello che invece sembra molto grave,
è che il sindaco Massaro, in modo unilaterale, nel verbale del 12 dicembre 2005
in allegato alla determina della Regione Puglia di concessione della Via
(Valutazione d’Impatto Ambientale), senza informare e coinvolgere il consiglio
comunale sul problema, ha indicato il mare di Specchiarica quale recapito finale
del depuratore consortile”. Bene. Da quanto risulta entrambi gli schieramenti
sono coinvolti nell’infausta decisione. Inoltre questa decisione è mirata a
salvaguardare il territorio savese-manduriano ed a danneggiare Avetrana, in
quanto la localizzazione del depuratore è posta sul litorale di Specchiarica,
territorio di Manduria (a poche centinaia di metri dalla zona residenziale Urmo
Belsito, agro di Avetrana)».
Continua Giangrande, noto autore di saggi con il
suffisso opoli (per denotare una disfunzione) letti in tutto il mondo.
«L’unitarietà della lotta poi è tutta da verificare. Vi sono due schieramenti:
quello di Manduria e quello di Avetrana. Quello di Manduria è composto da un
coordinamento istituito solo a fine maggio 2014 su iniziativa dei Verdi e del
movimento “Giovani per Manduria” con il comitato “No Scarico a mare” di
Manduria. Questo neo coordinamento, precedentemente in antitesi, tollera il sito
dell’impianto, purchè con sistema di filtrazione in tabella IV, ma non lo
scarico in mare; quello di Avetrana si oppone sia alla condotta sottomarina che
alla localizzazione del depuratore sul litorale di Specchiarica. Il comitato di
Avetrana (trattasi di anonimo comitato ed è tutto dire, ma con un solo e
conosciuto uomo al comando, Pino Scarciglia) ha trovato una parvenza d’intesa
fra tutti i partiti, i sindacati e le associazioni interpellate, per la prima
volta sabato 17 maggio 2014, e si schierano compatti (dicono loro), superando
ogni tipo di divisione ideologica e ogni steccato, che sinora avevano reso poco
incisiva la mobilitazione. In mattinata del 17 maggio, il Consiglio Comunale di
Avetrana si è riunito per approvare, all’unanimità, la piattaforma di
rivendicazioni già individuata nella riunione fra il comitato ristretto e i
rappresentanti delle parti sociali. In serata, invece, maggioranza e minoranza
sono saliti insieme sul palco di piazza Giovanni XXIII per rivolgere un appello
alla comunità composta per lo più da forestieri. Si legge nel verbale
dell’ultima riunione del Movimento. “E’ abbastanza chiaro, inoltre, che le
Amministrazioni Comunali di Manduria, che si sono succedute nel tempo da 15 anni
a questa parte, non hanno avuto nè la volontà nè la capacità di modificare o di
bloccare questo obbrobrio, trincerandosi dietro a problematiche e a questioni
tecniche/burocratiche, a parer loro, insormontabili”. Il gruppo di lavoro
unitario avetranese è composto da consiglieri di maggioranza e minoranza (Cosimo
Derinaldis, Antonio Baldari, Pietro Giangrande, Antonio Lanzo, Emanuele Micelli
e Rosaria Petracca). “Vorrei innanzitutto far notare come, finalmente, si stia
superando ogni tipo di steccato politico o ideologico – afferma l’assessore
all’Agricoltura e al Marketing Territoriale, Enzo Tarantino. Steccato veramente
superato? A questo punto reputo poco credibile una lotta portata avanti da chi,
di qualunque schieramento, continui a fare propaganda politica contrapposta per
portare voti a chi è ed è stato responsabile di questo obbrobrio ai danni dei
cittadini e ai danni di un territorio incontaminato. Quindi faccio mia la
domanda proposta da Arcangelo Durante “Bisogna dire però, che il presidente
Vendola è in misura maggiore responsabile della questione, poichè di recente ha
firmato il decreto di esproprio, nonostante che, prima il consiglio comunale
dell’ex amministrazione Massaro e dopo quello dell’amministrazione Tommasino, si
siano pronunciate all’unanimità contrarie allo scarico a mare. Presidente
Vendola, ci può spiegare come mai, quando si tratta di opere che riguardano
altri territori, vedi la Tav di Val di Susa, reclama con forza l’ascolto e il
rispetto dei cittadini presenti sul territorio; mentre invece, quando si tratta
di realizzare opere che interessano il nostro territorio, (dove lei ha il
potere) non rivendica e utilizza lo stesso criterio, come l’ultimo provvedimento
da lei adottato in qualità di Commissario Straordinario sul Depuratore?”»
Monta la polemica per il divieto ai
sindaci di salire sul palco con Romina Power, scrive
il 9 aprile 2017 Nazareno Dinoi su “La Voce di Manduria”. Non ancora passati gli
echi della grande manifestazione unitaria di venerdì contro ogni forma di
scarico in mare del depuratore e per lo spostamento del costruendo impianto
previsto sulla costa, il dibattito s’infiamma ora nella polemica tra
organizzatori dell’evento e i sindaci e politici con cariche varie a cui l’altro
ieri è stato impedito di conquistare il palco. Mantenendo fede agli accordi
precedentemente presi da tutti i promotori della manifestazione, partiti,
associazioni, comitati ed enti, tra cui il comune di Avetrana, al termine del
corteo a cui hanno partecipato non meno di diecimila persone, gli esponenti
politici presenti, sindaci con il tricolore, consiglieri regionali e consiglieri
dei comuni di Manduria, Sava, Erchie, Lizzano ed Avetrana, hanno espresso la
volontà di salire sul piccolo palco dove, secondo i programmi, sarebbero dovuti
salire solo la cantante Romina Power, per un appello al presidente Michele
Emiliano, e il portavoce degli organizzatori il quale avrebbe letto (come ha
letto) un messaggio unitario indirizzato al sindaco di Manduria e alla struttura
tecnica della Regione Puglia. Il tentativo di intrusione non è piaciuta ai
coordinatori i quali avevano fatto di tutto per impedire qualsiasi
caratterizzazione politica, o peggio ancora partitica, all’importante e
riuscitissima manifestazione. Ne è nata un’accesa e verbalmente violenta
discussione dietro al palco con i sindaci e il loro codazzo di politici al
seguito che tentavano di conquistare la scaletta, e gli organizzatori che glielo
impedivano. Urla, minacce, improperi, alcuni dei quali davvero irripetibili,
hanno rischiato di rovinare la bella festa. I politici per convincere chi si
opponeva, hanno detto di avere bisogno di una deroga al divieto concordato
poiché quella mattina c’era stata a Bari un’importante riunione in cui si
sarebbero prese decisioni importanti in tema di depurazione. E che bisognava
riferire al popolo tali novità. Con uno sforzo alle regole, gli organizzatori
della manifestazione hanno dato mandato ad uno di loro di salire sul palco e
informare la folla di quanto stesse accadendo e chiedere il loro parere in
merito. Il rifiuto dei manifestanti è stato univoco e rumoroso: «Niente politici
sul palco». E così è stato. L’arrivo, finalmente di Romina Power, ha tolto ogni
speranza ai sindaci che hanno dovuto rinunciare all’eccezionale platea dei
diecimila assiepati sulla piazza. Tra le fasce tricolori che anelavano un posto
su quel palco c’era anche il sindaco di Manduria, Roberto Massafra, lo stesso
che una settimana prima aveva rifiutato il permesso di quella piazza che ora
desiderava avere, motivando il diniego con la concomitanza del consiglio
comunale che poi non si è più tenuto. Ieri, infine, è stato il giorno delle
arrabbiature. Il sindaco di Avetrana, Antonio Minò, che si era fatto garante con
gli altri suoi colleghi facendo lui stesso parte del comitato che ha organizzato
l’appuntamento, si è scusato pubblicamente con gli ospiti tricolore accusando
ancora una volta gli altri del comitato di aver privato i manifestanti delle
buone notizie che venivano da Bari. In effetti dagli uffici della Regione
Puglia, più che una soluzione (questo lo si è capito ieri quando le carte sono
cominciate a circolare), è venuta fuori una proposta, anzi tre. In sostanza la
Regione Puglia ha demandato ai consigli comunali di Manduria e Avetrana la
scelta su tre ipotesi progettuali: quella originaria con il depuratore in zona
residenziale Urmo e la condotta sottomarina; la seconda, proposta di recente con
il depuratore sempre a Urmo, i buffer per uso irriguo dei liquami, e lo scarico
emergenziale al suolo, tra le abitazioni e un hotel a 700 metri dal mare; infine
una terza ipotesi che prevede lo spostamento del depuratore nell’entroterra con
le vasche di drenaggio e senza scarico a mare ma in una lama che va a finire nel
fiume Chidro.
Noi ambientalisti colpiti dal fuoco
amico, scrive il 10 aprile 2017 Francesco Di Lauro su
“La Voce di Manduria". Un clamoroso caso di fuoco amico noi sul palco a parlare
di soluzioni condivise, di tavolo permanente per adottarle, ed Avetrana, che
tiene famiglia, pur avendo firmato quel documento va e propone (sarebbe meglio
dire si fa suggerire dall’aspirante sindaco geometra Coco) la soluzione
Serpente- Canale Rizzo-Chidro. Chapeau, tutto da decidere in due giorni, neanche
il tempo di prendere fiato dalla manifestazione di venerdì scorso. Alla faccia
delle ‘istanze’ che dovevano arrivare dalla gente ed essere recepite dai
politici, e tutto per consentire alla ditta Putignano di non perdere un appalto
già assegnato (che è, naturalmente riassegnabile, ma perché “lasciare il comodo
per lo scomodo?”). Non abbiamo nessun timore, da sempre, di dire quello che
pensiamo anche contro una dura realtà, e la dura realtà è che questo è
l’ennesimo colpo di mano a danno del territorio, ma soprattutto di un metodo che
permetta davvero soluzioni condivise. Questo accade ad esserci fidati dei
‘politici’, altri, ma pur sempre politici, questa volta avetranesi, che,
“giustamente ” secondo le logiche di questo raffinato ambiente, si portano a
casa un risultato anche se questo lo si è ottenuto con lo stesso metodo dei
savesi: per dirla con un eufemismo, “futti e camina…” Così, nello stesso istante
in cui Romina Power parla di tutela della bellezze naturali della Puglia a
10.000 persone, il geometra Coco firma e fa firmare il Comune di Avetrana, di
cui è neo consulente, per l’ipotesi Serpente-Chidro. Certo non rappresenta, mai
ha rappresentato e mai nemmeno potrebbe, nessuno di noi, convinti assertori di
quanto sia fondamentale avere un’idea di programmazione e vocazione del
territorio, di rispetto dell’ambiente e delle dinamiche ecologiche. Non ho
nessuna difficoltà ad esprimere l’assoluta contrarietà all’ipotesi Serpente:
burocrati che hanno passato la vita a mummificare nei retrobottega
amministrativi forse non sanno neanche dove sia e quanto sia intatto e pregevole
il contesto Serpente-Canale Rizzu-Chidro, a fronte di centinaia di ettari di
pietraie a nord di Manduria, lungo la direttrice Sava-San Pancrazio, la zona
industriale, insomma ovunque ci sia onestà progettuale e soprattutto politica.
Certo, restringe il campo all’obbligo dello scarico di emergenza in corpo idrico
superficiale, ma proprio per questo avevamo previsto nel documento congiunto,
firmato dai consiglieri di opposizione manduriani e dal sindaco di Avetrana,
l’abbandono della ipotesi consortile, ‘madre di tutte le magagne’. Noi ci siamo.
Tra un anno ci saranno le elezioni a Manduria, e qualcuno dovrà assumersi la
responsabilità di questa ennesimo deserto (di cemento e liquami) in una
cattedrale (naturalistica.) Tra pochi giorni invieremo una richiesta a Cantone
(Anticorruzione) di mettere finalmente il naso in questa maleodorante vicenda.
Alla magistratura contabile e penale, compresa quella ‘locale’, il compito di
tappare le voragini della politica, magari ponendosi una domanda semplice
semplice: se, alla luce del nuovo accordo, sarà Avetrana ad ospitare gli
scarichi delle reti fognanti dei centri costieri (quelli che saranno costruiti
…nel 3017) anche il progetto consortile che si vuole cominciare a tutti i costi
deve essere dimezzato o ridotto in proporzione. Così come l’importo
dell’appalto. Così come la necessità dello scarico emergenziale in corpo idrico,
quindi la presunta necessità di farlo lì. Per tutti coloro che credono ancora
nel valore di ciò che si firma e con chi lo si firma, e’ il momento di battersi
per le nostre proposte alternative. Francesco Di Lauro
La minoranza di Avetrana: «il nostro
depuratore in cambio di Colimena». Intervista del 10
aprile 2017 di Monica Rossi su "La voce di Manduria". Alla vigilia del consiglio
comunale di domani convocato ad Avetrana per approvare la disponibilità
dell’ente al futuro accoglimento dei reflui delle marine di Manduria nel proprio
depuratore quale condizione indispensabile per spostare il depuratore consortile
lontano dall’Urmo Belsito, il consigliere comunale di minoranza, Luigi Conte,
esprime tutti i dubbi in merito a tale proposta. E ci anticipa le mosse del
proprio gruppo.
In merito alla proposta partorita dall’incontro
a Bari tra rappresentanti del comuni di Manduria e Sava, rispettivi tecnici e la
Regione Puglia, lei l’ha definita: “dalla padella alla brace”. In che senso?
“Certo, un documento firmato con superficialità e
ora quel consiglio comunale convocato in tutta fretta per dare il consenso per i
reflui delle Marine…”
Ma se lei fosse stato sindaco lo avrebbe
firmato quel documento?
“Assolutamente no”
Ma come mai allora?
“L’amministrazione di Avetrana paga delle scelte
sbagliate fatte nel 2014, quando l’allora sindaco De Marco e assessore Minò,
firmarono il documento che prevedeva il depuratore in zona Urmo. Ora abbiamo sia
il depuratore che i reflui delle marine. Una idea geniale di Manduria…”
Ma la nuova collocazione del depuratore lo ha
scelto il comune di Avetrana se non sbaglio.
“Certo! Un paradosso! Un comune che sceglie un
luogo vicino a sè per un depuratore che servirà ad un altro comune e per di più
si prende in carico i reflui delle Marine! Ma dico io: almeno avessero chiesto
come contropartita Torre Colimena!”
Ma perché il sindaco e il vice sindaco hanno
firmato allora?
“Non stanno comprendendo cosa hanno firmato”.
Domani lei è il suo gruppo voterete il
consenso?
“Assolutamente no. Noi chiediamo che questa
proposta venga spiegata ai cittadini. Se loro diranno di sì noi ci adegueremo. È
grazie ai cittadini e al loro protestare e scendere in piazza che si sta
cominciando a parlare di delocalizzare il depuratore. Fino a pochi giorni fa in
molti dicevano che non era possibile, anche quel primo cittadino (di Manduria,
ndr) che ora sale sul carro dei vincitori. Il depuratore si deve spostare anche
da contrada Serpenti”.
Come mai anche questo luogo della terza ipotesi
non va bene secondo lei?
“Perché se il depuratore non deve più servire le
Marine, visto che vogliono dare i reflui ad Avetrana, allora perché continuarlo
a fare vicino alla costa e lontano da Sava e Manduria?”
Cosa propone il vostro gruppo?
“Di rescindere il rapporto con la ditta Putignano.
Di migliorare il depuratore a Manduria e farne uno a Sava. Che se proprio ce ne
deve essere uno consortile, va fatto tra Sava e Manduria. Che se le Marine
dovranno in futuro (ora non esiste rete fognaria e acqua) scaricare nel
depuratore di Avetrana, questo deve essere accettato con indennizzo (Torre
Colimena agli avetranesi). In ultimo che nessun depuratore va fatto vicino alla
costa”.
Ma perché secondo lei si parte a costruire dal
depuratore?
“Mistero. Mai visto costruire una casa partendo
dal comignolo. Sava non ha le fogne, Manduria le ha al 50 per cento, nonostante
questo che fanno? I lavori li fanno partire dal depuratore…”
E perché secondo lei si parla più volte nel
documento di sanzioni della commissione europea quando non sembra essere a
rischio di sanzioni questo depuratore?
“Non lo so. Forse bisogna spendere quei soldi e
basta”.
Di seguito Comunicato Stampa sul depuratore
Manduria-Sava del gruppo consiliare Avetrana Riparte. Avetrana Riparte durante
il Consiglio Comunale di Avetrana di lunedì 10 aprile, non ha preso parte al
voto che ha approvato un documento sottoscritto a Bari venerdì 7 aprile secondo
il quale si chiede lo spostamento del depuratore Manduria Sava in contrada
Serpente e asservimento del depuratore di Avetrana per la depurazione delle
acque reflue delle marine di Manduria.
I fatti. In data 7 aprile 2017, alla presenza del
Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche (tra le altre cose) ing. Barbara
Valenzano, il Sindaco di Avetrana sottoscrive un verbale in cui si prende atto
della proposta del Comune di Avetrana di localizzare il depuratore consortile
Manduria Sava non più in zona Urmo Belsito ma in contrada Monte Serpente. In
conseguenza dello spostamento Avetrana si impegna “a ricevere i reflui delle
Marine nel proprio depuratore consortile”. Detto verbale viene chiuso e
sottoscritto in tarda mattinata (primo pomeriggio) a Bari. Alle ore 15:00 a
Manduria inizia il corteo di protesta che sfila sulla base di una piattaforma
condivisa anche dal Comune di Avetrana, che ha come obiettivi:
l’immediata sospensione dei lavori;
la delocalizzazione del depuratore lontano dalla
costa;
la rinuncia alla scelta di un impianto di tipo
consortile;
la rinuncia formale dello scarico a mare, sia pure
di tipo emergenziale, da parte della Regione, attraverso atto deliberativo.
Al termine della manifestazione nulla si dice
circa il verbale sottoscritto in Regione. Detto verbale comincia a circolare sul
web.
Sabato 8 aprile nel primo pomeriggio siamo
convocati in consiglio comunale per lunedì (Consiglio Comunale già convocato
precedentemente) per approvare un deliberato che attesti la volontà del Comune
di Avetrana a ricevere i reflui delle marine. In tutto questo, il grande
assente, ancora una volta ignorato, è il cittadino. Il protagonista delle
proteste, quello invocato per riempire le piazze, quello vocato al sacrificio
perché cede parte del suo guadagno (con la serrata) alla causa, viene superato
dai propri rappresentanti. Considerato ormai inutile. Noi invece riteniamo che
questo tema non può essere liquidato in 24 ore.
Le favole. Lunedì 10 aprile alle ore 12:00 si
tiene il Consiglio Comunale in cui la realtà lascia il posto alla fantasia.
Scopriamo infatti che il deliberato del Consiglio è sostanzialmente diverso dal
verbale sottoscritto: infatti il Consiglio Comunale di Avetrana, pur richiamando
il verbale, dice che è disponibile “al recepimento dei reflui delle Marine di
Manduria e, comunque, fino al raggiungimento della capienza massima prevista dal
depuratore di Avetrana”. Quindi a Bari si sottoscrive una cosa e ad Avetrana se
ne approva un’altra. Alla richiesta dell’opposizione di Avetrana Riparte di
rinviare anche solo di 24 ore il Consiglio per avere il tempo di spiegare alla
cittadinanza questa novità e chiedere il relativo parere, la maggioranza e la
minoranza di Cambiamo Avetrana, vota contro, adducendo il fatto che la
cittadinanza è ampiamente rappresentata. Consigliere di maggioranze e ex Sindaco
grande scettico sulla possibilità di riaprire la partita con la Regione e
firmatario di un accordo con il Sindaco di Manduria in cui accettava il sito in
cambio di opere che fornissero accurata ambientalizzazione come risarcimento del
danno per la localizzazione, si permette ora di giudicare le osservazioni di
Avetrana Riparte con la solita arroganza. Certo è comprensibile perché l’attuale
Sindaco ha prodotto in pochi mesi più azioni concrete rispetto al suo decennale
inconcludente mandato. Consiglieri di maggioranza e minoranza poi millantano,
come specchietto per le allodole, la possibilità di accedere a finanziamenti per
servire con acqua potabile e impianto fognario le marine. Ricordiamo che le
marine sono territorio di Manduria e che Manduria è l’unica deputata a
partecipare all’assegnazione di fondi per le infrastrutture stesse.
Infrastrutture che sarebbero già state realizzate se il Comune di Manduria e la
Regione Puglia non fossero state così caparbie (precedente amministrazione
regionale) nel non voler risolvere la questione depuratore consortile.
Conclusioni. Avetrana Riparte non volendo
danneggiare il voto unanime del Consiglio e non potendo prendere a cuor leggero
decisioni gravi e importanti senza adeguato approfondimento e senza un serio
coinvolgimento popolare, decide di uscire dall’aula al momento della votazione.
Manduria, depuratore: troppi gli assenti
in Consiglio comunale, scrive il 12 aprile 2017 "Il
Corriere di Taranto". “Restiamo sconcertati da quanto accaduto in Consiglio
comunale: l’Amministrazione Massafra, la stessa che appena quattro giorni fa
proclamava al mondo di avere in tasca la soluzione definitiva al problema
depuratore, tanto da volerla ad ogni costo sbandierare in piazza, dimostra
ancora una volta tutta la sua inconsistenza, non riuscendo a racimolare i voti
necessari ad approvare l’ipotesi progettuale tanto caldeggiata”: è la dura
accusa del laboratorio politico Manduria Lab, al termine del Consiglio comunale
di ieri. “Maggiori perplessità suscita inoltre l’assenza dall’assise cittadina
dei due consiglieri che fanno riferimento al consigliere regionale Luigi
Morgante, principale fautore del tavolo tecnico apertosi in Regione e massimo
sostenitore dell’ipotesi C – aggiunge il movimento -. Non minore stupore
suscita, inoltre, la scelta dell’opposizione di abbandonare l’aula, facendo
venire meno il contraddittorio e rendendo possibile il rinvio ad una seconda
convocazione, che probabilmente perverrà all’approvazione del provvedimento da
parte di una risicatissima rappresentanza”. Il comportamento “degli uni e degli
altri rende evidente l’assenza di certezze in chi dovrebbe comunque
pronunciarsi, a favore o contro, rispetto alla problematica in esame e avvalora
la nostra convinzione della necessità di un approfondimento della questione,
attraverso un pubblico dibattito, con il contributo della cittadinanza e delle
categorie professionali e sociali”. Quanto all’ipotesi di spostare il depuratore
in Contrada Serpente (zona di grande pregio naturalistico e ricca di
insediamenti produttivi), “la nostra opinione è che tale soluzione al momento
non è sufficientemente motivata dal punto di vista tecnico-giuridico, per
poterne discutere con cognizione di causa, e risulta comunque vincolata
all’approvazione da parte di AQP e della ditta appaltatrice. Risulta tuttavia
difficile da comprendere la scelta di collocare l’impianto in tale località,
alla luce della accettazione da parte del Comune di Avetrana di accogliere i
reflui delle marine nel proprio depuratore: se proprio si vuole conservare la
soluzione consortile, in presenza di un dimensionamento proporzionato alle
effettive utenze, risulterebbe più logico collocare il depuratore in una
località compresa tra Sava e Manduria”.
Legambiente: giù le mani dal Monte dei
Serpenti, scrive il 12 aprile 2017 "La Voce di
Manduria". Noi soci del circolo Legambiente di Manduria, abbiamo sempre espresso
dei dubbi sulle criticità che si andavano di volta in volta evidenziando, ma
sempre con spirito collaborativo nel comune intento di conciliare la
salvaguardia dell’ambiente con la necessita di avere un moderno impianto di
depurazione. Adesso però, alla luce della pericolosa ed estemporanea proposta di
taluni di delocalizzare il sito spostandolo in una delle aree più belle e
pregevoli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, non possiamo
assolutamente restare in silenzio. All’interno di questa lunga vicenda, questa
proposta è sicuramente, di gran lunga, la peggiore fra tutte le ipotesi fino ad
ora formulate (non che le altre fossero idonee, sic!) ed è ovvio, che se dovesse
essere questo il sito, ci opporremo con tutti i mezzi che la legge ci mette a
disposizione. L’area individuata come nuovo sito del depuratore (monte dei
Serpenti) si trova circondata da innumerevoli vincoli paesaggistici ed ulteriori
contesti e a differenza, di quanto affermato da qualcuno, non si tratta di 10
ettari, ma di molto meno (probabilmente sarà sfuggito qualche vincolo). Inoltre
la bellezza incomparabile e l’unicità di tutta quella zona (ripeto una delle più
pregevoli di questa parte del Salento) la rende inidonea ad essere utilizzata
per questo scopo, infatti:
– si trova vicino a molte meravigliose masserie
(ad es. Masseria Marcantuddu, la stupenda masseria dei Potenti, ecc.);
– si trova vicino al famoso sito archeologico
messapico della città fortificata di Felline;
– è a fianco del meraviglioso bosco dei Serpenti
che con la sua ampia biodiversità costituisce un unicum in tutta l’area di
Manduria e paesi limitrofi (presenza di enormi esemplari di corbezzolo, presenza
di erica arborea e presenza unica di un nucleo di querce angustifolie
probabilmente ibridate con quercia virgiliana;
Inoltre si devono tener conto dei vincoli
derivanti dalla legge 353 del 2000 sulle aree percorse dal fuoco (vincoli che
scattano anche in mancanza di inserimento nel catasto delle aree percorse dal
fuoco, perché, come ha stabilito una sentenza del Tar Liguria confermata dal
Consiglio di Stato, tale inserimento ha solo valore dichiarativo e non
costitutivo del vincolo); proprio a tale scopo, la nostra associazione possiede
un vasto archivio documentale e video fotografico delle aree percorse dal fuoco
per fini probatori.
Per ultimo, ma non per importanza, segnaliamo che:
– la nuova localizzazione del buffer 2 andrebbe a
ricadere pienamente all’interno della Riserva Regionale del Litorale Tarantino
Orientale;
– anche il nuovo scarico emergenziale andrebbe a
finire all’interno della Riserva Regionale, proprio in una delle aree più belle
e suggestive di detta Riserva. (Tra l’altro anche area bosco).
– lo scarico emergenziale in questa area, oltre
che incompatibile per i motivi su esposti, lo sarebbe anche per la rarissima
presenza di tane di tasso e per la tipologia di vegetazione che predilige un
ambiente arido e non troppo umido (ambiente il cui microclima andrebbe stravolto
con uno scarico emergenziale, oltre che per i danni meccanici che tale scarico
potrebbe avere sulla flora).
Quindi proprio alla luce di quanto esposto sembra
incomprensibile la decisione di spostare il sito all’interno di questa area: se
le motivazioni erano quelle che il vecchio sito non era idoneo per motivi
paesaggistici e per motivi di vicinanza alle aree protette, a maggior ragione
questo sito risulta improponibile visto che questo progetto ricade in aree
sicuramente più pregevoli e , in parte, addirittura all’interno delle stesse
Riserve. Se si dovesse scegliere questo nuovo sito, risulta evidente che i
rischi di ricorsi al Tar da parte di più di qualcuno, sono molto alti e concreti
con un’inevitabile allungamento dei tempi per la realizzazione del depuratore
per Manduria. Sempre con lo stesso spirito collaborativo che ci ha
contraddistinto, restiamo a disposizione di tutte le istituzioni per
un'eventuale incontro per poter descrivere le motivazioni delle nostre
perplessità e soprattutto per individuare un sito idoneo che finalmente sia
privo di vincoli e che abbia un bassissimo impatto sull’ambiente, sul paesaggio
e sugli insediamenti turistico e produttivi. Legambiente Manduria
Depuratore, interviene anche Bruno Vespa.
Il giornalista ha investito nel Primitivo ma definisce scoraggiante il nuovo
progetto, scrive Nando Perrone su “la Gazzetta del
Mezzogiorno” il 12 Aprile 2017. «L’ubicazione del depuratore nell’area di
masseria “Serpenti” sarebbe, per me, un fortissimo disincentivo agli
investimenti compiuti e a quelli programmati». Dopo Romina Power, intervenuta in
una trasmissione di punta di Rai Uno (“L’arena” di Giletti) e alla mobilitazione
di venerdì scorso a Manduria, ecco un altro personaggio molto popolare che
esprime la propria opinione sull’ubicazione del depuratore consortile della
città messapica e di Sava. E’ Bruno Vespa, giornalista che conduce da anni la
trasmissione “Porta a porta”, che, da produttore vitivinicolo, invia una lettera
aperta al sindaco Roberto Massafra e all’intero Consiglio Comunale poche ore
prima della riunione, in prima convocazione, del consesso elettivo, che doveva
discutere di depuratore ma, mancando il numero legale, è stato aggiornato ad
oggi. Chiaro l’obiettivo: convincere i presenti a non approvare la
delocalizzazione del sito. «Caro signor sindaco, caro Roberto, cari signori
consiglieri» scrive Bruno Vespa nella lettera aperta del giornalista, «mi ha
chiamato allarmatissimo Gianfranco Fino (altro produttore vitivinicolo, ndr),
anche a nome delle altre masserie e delle altre strutture produttive della
nostra zona, sulla ipotesi dello spostamento del depuratore dalle aree già
indicate a quella della masseria Serpenti. Per le nostre strutture ricettive e
produttive sarebbe la rovina. Per me personalmente un fortissimo disincentivo
agli investimenti compiuti e a quelli programmati». Poi il giornalista e
scrittore entra nel merito della questione esprimendo un proprio parere. «Ho il
più alto rispetto per il comune di Avetrana, ma credo che sarebbe folle
penalizzare una delle aree più pregiate del Primitivo di Manduria» sostiene
Vespa. «Vi saremmo tutti assai grati se poteste scongiurare questo pericolo.
Grazie e un caro saluto a tutti». Parlando al plurale, Vespa interpreta
evidentemente la preoccupazione di tutti gli altri operatori vitivinicoli della
zona. Com’è noto, il giornalista ha acquistato, nell’area di Manduria, ampi
appezzamenti di vigneti (in cui produce il Primitivo di ottima qualità, già da
qualche anno sui mercati internazionali) e una masseria, che sta trasformando in
azienda in cui imbottigliare i propri prodotti. Nel progetto, Vespa ha pensato
altresì di destinare un’area dell’immobile per la ricettività degli eno-turisti.
Sin qui la posizione di Bruno Vespa. Molto meno facile quella del Consiglio
comunale di Manduria, che ha ora solo tre opzioni: la prima con lo scarico in
mare; la seconda con il depuratore in contrada Urmo e con il contestatissimo
“ruscellamento”; la terza con la localizzazione del depuratore in contrada
“Serpenti”. Non crediamo che la Regione possa ulteriormente pazientare. Non è un
caso, infatti, se venerdì scorso è stato concesso un termine ristrettissimo (una
settimana) per deliberare la scelta fra le tre opzioni. E temiamo che si sia
ormai innescata una spirale: ovunque si tenterà di spostare il depuratore, ci
sarà qualcuno che protesterà...
La replica il 12 aprile 2017 su “La Voce di
Manduria”. Ma… ma, è lo stesso Bruno Vespa che, con Michele Emiliano seduto nel
suo salotto televisivo, spalava merda sulla presunta sindrome Nimby dei
salentini che si oppongono alla Tap? Ed è sempre lo stesso Bruno Vespa che, ora
che la merda tocca a lui, sale sulle barricate sulla base – guarda un po’- della
vocazione turistica del territorio (ma soprattutto dei suoi personalissimi
investimenti)? Caro Vespa, e allora diciamola una volta tanto la verità. Per
alcuni illustri commentatori, onorevoli, eccellenze, cavalieri, monsignori, la
sindrome Nimby vale solo in un caso: quando il culo è degli altri. Danilo Lupo,
giornalista La7 (La Gabbia)
Perchè a Urmo? Tutta la storia sul
depuratore, scrive il 7 aprile 2017 Nazareno Dinoi su
"La voce di Manduria". L’idea di localizzare il depuratore sulla costa e non
nell’entroterra è nata da due fatti contingenti: il primo di natura giudiziaria,
il secondo per garantire una rete fognante nelle località marine completamente
(ancora) sprovviste. Percorrendo a ritroso tutti i passaggi, bisogna partire dal
2000 quando dalla Regione Puglia arrivò l’invito all’allora sindaco di
Manduria, Gregorio Pecoraro, ad adeguare il vecchio depuratore situato sulla via
per San Pancrazio (dov’è tuttora). L’impianto, inoltre, doveva essere potenziato
per permettere un recapito anche alla rete di Sava in virtù di un accordo
consortile tra i due comuni. L’amministrazione Pecoraro predispose le carte per
un nuovo depuratore che ebbe il primo intoppo. Il sito confinava con un centro
sportivo, regolarmente condonato, quindi incompatibile normativamente. Così gli
uffici individuarono un altro lotto più distante, sempre in quella contrada
«Laccello», ma i proprietari del terreno si opposero all’esproprio e il Tar gli
diede ragione.
Sindaco Antonio Calò. Non se ne parlò più sino
alla nuova amministrazione del sindaco Antonio Calò. Siamo nel 2003 e dalla
Regione continuavano ad arrivare solleciti per il nuovo depuratore. Bisognava
individuare un altro sito così l’allora sindaco Calò ebbe l’idea di spostare il
depuratore verso la costa. Avanzò la proposta dei terreni della Masseria Marina,
più vicini a San Pietro in Bevagna che avrebbe avuto la concreta possibilità di
una rete fognante. Un’opportunità che avrebbe eliminato il fenomeno degli
scarichi civili abusivi e nello stesso tempo dato più valore catastale a tutto
l’abitato. Si presentò però un altro problema: all’epoca gli scarichi dei
depuratori lungo la costa potevano avere solo il recapito in battigia per cui fu
improponibile pensare ad una cosa simile proprio al centro di San Pietro in
Bevagna così densamente abitato. Si doveva trovare una soluzione diversa, sempre
sulla costa, ma lontana dalla località balneare principale.
Sindaco Francesco Massaro. Cade il sindaco Calò e
viene eletto Francesco Massaro. Toccò a lui la scelta di un sito che non fosse
San Pietro in Bevagna, quindi o a destra, verso Torre Borraco e l’omonimo fiume,
o dall’altra parte, Torre Colimena con i corsi d’acqua della Palude del Conte, i
canali dell’Arneo e la Salina. La scelta cadde proprio qui, nel punto più
distante dei confini territoriali di Manduria ma più vicino a quelli di
Avetrana: zona Urmo Belsito, appunto. Fu allora che si cominciò a temere
l’infrazione comunitaria che aveva già puntato gli occhi sulla Puglia per i
troppi depuratori non a norma: non era più possibile scaricare in falda.
Bisognava fare in fretta e l’allora sindaco Massaro si preoccupò di evitare
almeno lo scarico in battigia. Presentò un ricorso al Tar di Lecce che gli diede
ragione. Secondo il tribunale amministrativo, uno scarico in battigia non
sarebbe stato concettualmente compatibile con la vocazione turistica della zona.
La soluzione alternativa fu trovata dai tecnici regionali: una condotta
sottomarina che scaricasse in mare i liquami frullati e non depurati come
prevedeva la normativa di allora.
Sindaco Paolo Tommasino. Dopo Massaro è stata la
volta del sindaco Paolo Tommasino. Il presidente della Regione era Nichi
Vendola. Le proteste degli ambientalisti e l’intervento dell’amministrazione
Tommasino ottennero un altro risultato: l’affinamento delle acque in tabella 4.
Acqua pulita da impiegare in agricoltura ma sempre con la condotta sottomarina
di emergenza. Solo promesse, senza progetti, però. E’ stato allora che
l’amministrazione Tommasino commissionò uno studio di fattibilità ai tecnici
Muscoguri-Dellisanti che ipotizzarono lo spostamento del depuratore in zona
Monte Serpenti e le vasche di drenaggio in zona masseria Marina. Progetto mai
preso in considerazione.
Sindaco Roberto Massafra. Finisce l’era Tommasino
e, dopo un periodo di commissariamento, entra in gioco l’attuale sindaco Roberto
Massafra che formalizza, in accordo con l’allora sindaco di Avetrana, Mario De
Marco, il progetto del depuratore all’Urmo con affinamento in tabella quattro,
le vasche di raccolta e drenaggio in contrada Marina e l’uso quasi esclusivo dei
liquidi depurati in agricoltura. Lo scarico emergenziale in mare, però, rimane.
Morgante-Turco-Del Prete. La storia diventa
recente. I due consiglieri regionali Luigi Morgante e Giuseppe Turco, con la
consulenza del geologo Mario Del Prete, convincono i tecnici regionali e
dell’Aqp alla soluzione dei buffer: depuratore sempre all’Urmo, vasche alla
Marina (buffer 1) e vasche a Specchiarica (buffer 2) con recapito emergenziale,
per almeno 15 volte l’anno e comunque quando l’impianto a monte non funzionerà
(impossibile fare ipotesi sulla frequenza e sulla durata dei guasti), sul
terreno tra le abitazioni di Specchiarica, in discesa verso il mare che dista
circa 700 metri. Secondo il sostenitore del famoso ruscellamento nel terreno, i
liquami di emergenza non arriverebbero mai al mare e anche se fosse, a bloccarle
ci penserebbero le dune. Iin realtà, proprio in quel tratto non ci sono più dune
ma la strada litoranea che taglia in due la zona del buffer con il mare.
L’ultima proposta, che piace al comune di Avetrana
e a molti manduriani (non al sindaco Massafra che accetta a malincuore), prevede
il depuratore in zona Monte Serpenti, a circa 4 chilometri dalla costa, con
impianti di dispersione e raccolta in loco, sempre uso irriguo delle acque, e
uno scarico emergenziale in una lama naturale. Il resto lo stiamo vivendo in
queste ore.
Il tema di nuove tecnologie per la depurazione
delle acque reflue e il loro riutilizzo c’è la Tecnologia MBR - Impianti per
acque di scarico municipali. C’è una grande richiesta di impianti moderni e più
efficienti nel trattamento delle acque reflue urbane. Dalla decarbonizzazione,
con ampia eliminazione di nutrienti, fino alla purificazione, i sistemi a
membrane a ultrafiltrazione offrono la soluzione ottimale per ogni esigenza.
La tecnologia siClaro®, una combinazione di comprovata tecnologia fanghi attivi
e processo a membrana innovativo, offre numerosi vantaggi rispetto al
tradizionale processo a fanghi attivi. Il filtri a membrana siClaro® sono
posizionati direttamente nelle vasche di aerazione o in camere di filtraggio a
valle di queste, dove assicurano un sicuro mantenimento dei fanghi attivi,
batteri e virus. Ciò significa che non occorre più il bacino per la
convenzionale decantazione secondaria. Vantaggi:
meno spazio richiesto, design compatto, nessuna
vasca di sedimentazione secondaria.
Il processo del depuratore rende un effluente di
qualità eccezionale.
immediata possibilità di riutilizzo del filtrato,
anche come acqua di processo industriale.
la robustezza del sistema di filtrazione siClaro ®
assicura un funzionamento di grande affidabilità.
Note Estese. L’inquinamento globale
delle acque superficiali e dei mari combinato con la costante diminuzione dei
depositi naturali di acqua potabile richiede un uso ecologicamente sensibile
delle risorse idriche. Le acque reflue scaricate provocano un disturbo notevole
per l’equilibrio naturale. Sempre più nuove sostanze tossiche vengono trasferite
all’uomo attraverso la catena alimentare e il ciclo dell’acqua minacciandone la
salute, per cui le conseguenze di ciò sul nostro attuale stile di vita moderno
non possono ancora essere pienamente previste. Le nuove norme europee
definiscono inequivocabilmente la qualità delle acque reflue destinate alla
dispersione sul terreno del stesso tipo di quelle destinate allo scarico nei
flussi di acque correnti. Le membrane a ultrafiltrazione siClaro ® separano le
particelle più piccole, fino ai colloidi, nei liquidi soltanto su base fisica
per le dimensioni dei pori <0,1 micron. Le membrana trattengono queste sostanze
senza modificarle in alcun modo, sia fisicamente che chimicamente, così che non
possano originarsi sostanze pericolose. Nella realizzazione dei filtri sono
usate membrane piane, derivanti da polimeri organici, ottimizzate e molto
efficaci che impediscono l’intasamento dovuto a capelli, fibre o altre sostanze
grossolane. Il filtrato prodotto dall’impianto soddisfa gli elevati standard
qualitativi richiesti per l’acqua di balneazione a norma del regolamento 75/160
/ CEE (“EWG” Comunità Economica Europea) del Consiglio dell’Unione europea.
La membrana a ultrafiltrazione costituisce una barriera assoluta per batteri e
larga parte di virus come quello responsabile della paralisi infantile. Piccole
molecole organiche, ioni metallici nonché sali solubili, in parte essenziali per
la vita, possono attraversare le membrane a ultrafiltrazione.
Comunque per quanto riguarda il tema depuratore
di Manduria-Sava rimane il controverso aspetto del costo di impianto delle
condutture e dell’esproprio dei terreni, con il conseguente espianto di migliaia
di alberi di Ulivi, pari ai trenta chilometri di distanza tra sito servito ed
impianto servente. Tema che fino ad oggi nessuno ha avuto la capacità di
trattare, impegnati tutti a contestare l'allocazione dell'impianto di
depurazione principale e dello scarico delle acque reflue.
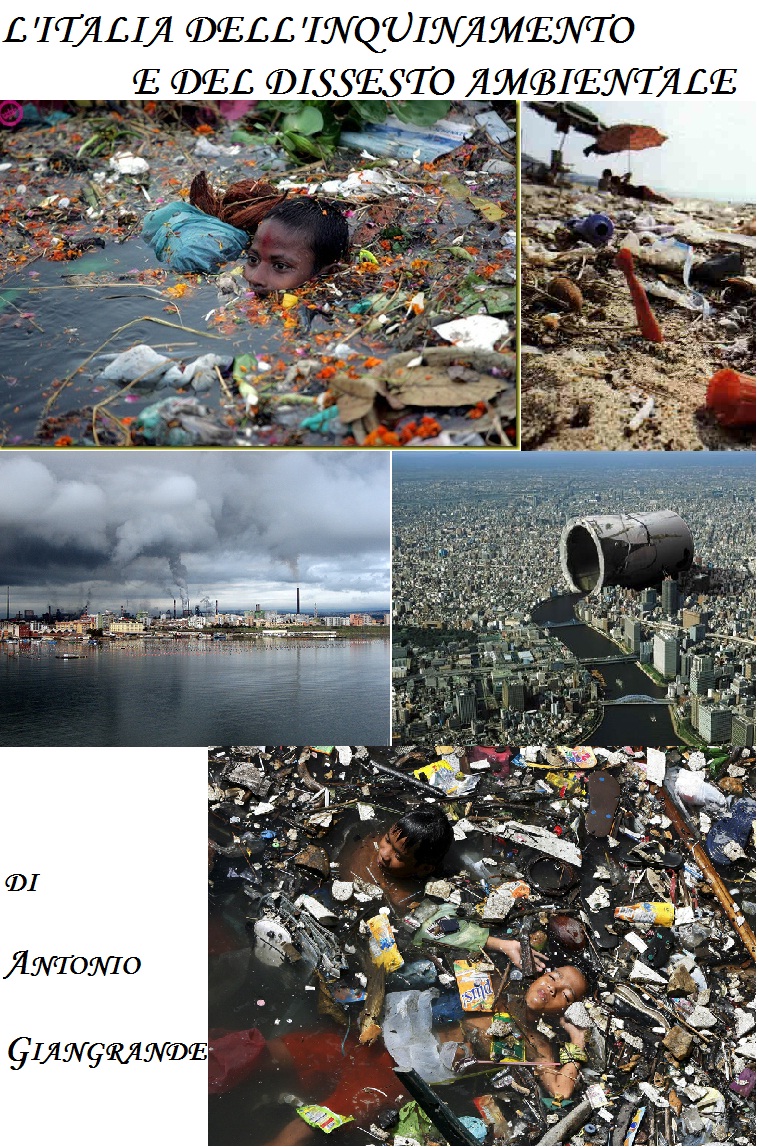



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: